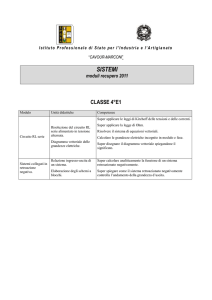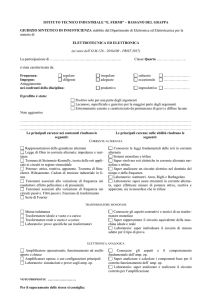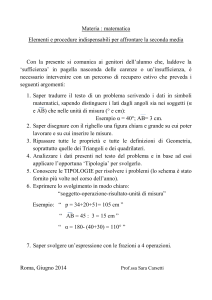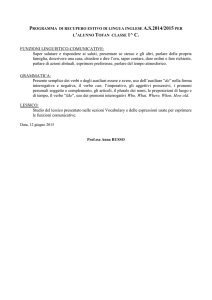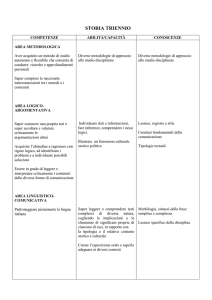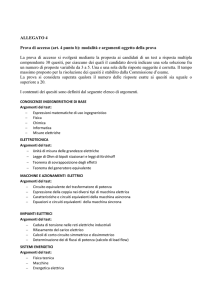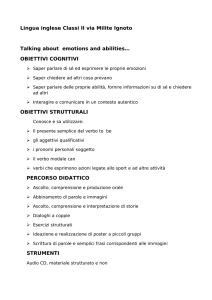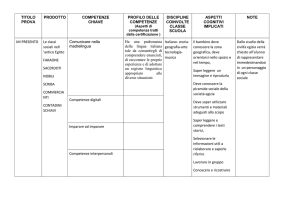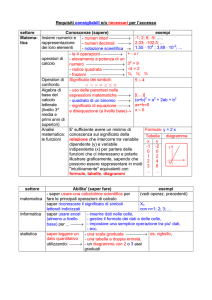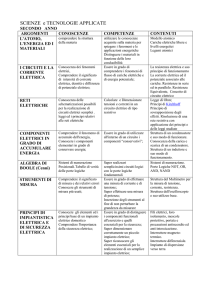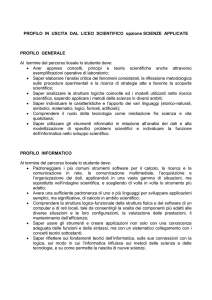DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(ART. 5 comma 2 DPR n. 323 del 23 luglio 1998)
CLASSE V D
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Anno scolastico 2015/16
INDICE
Premessa ......................................................................................... Pag. 2
Profilo del corso e quadro orario .......................................................... Pag. 2
Composizione del Consiglio di Classe .................................................... Pag. 6
Presentazione della classe .................................................................. Pag. 7
Elenco candidati della classe ............................................................... Pag. 10
Obiettivi ........................................................................................... Pag. 11
Metodi e strumenti ............................................................................ Pag. 11
Verifiche, Valutazione ........................................................................ Pag. 12
Tabella corrispondenza voti-livelli tassonomici………………………… ................. Pag 12
Griglie di valutazione prove……………………………………………………… ................. Pag. 14
Attività didattico-disciplinari ................................................................ Pag. 22
Simulazioni terza prova…………………………………………………………………………………. Pag.65
Allegato riservato( parte integrante del presente documento)
PREMESSA
Il documento è formulato in ottemperanza al DPR n. 323 del 23 Luglio
1998 ed ha lo scopo di mostrare il percorso formativo e didattico dell’ultimo anno di corso .
Vengono esplicitati :
-
i contenuti disciplinari ;
-
i metodi e i mezzi;
-
gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità;
-
i criteri e gli strumenti della misurazione e della valutazione
( indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi
e per l’attribuzione dei voti);
-
le tipologie delle prove utilizzate;
-
le attività curriculari ed extracurriculari, le visite guidate e i viaggi di istruzione.
Il documento è elaborato per la commissione di esame, anche per la
predisposizione della terza prova, in coerenza con l’azione educativa e
didattica realizzata in questo ultimo anno di corso.
PROFILO DEL DIPLOMATO IN ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA E
QUADRO ORARIO:
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL
SETTORE TECNOLOGICO
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di
seguito specificati in termini di competenze.
•
•
•
•
•
•
•
•
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai
fini dell’apprendimento permanente.
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro
corretta fruizione e valorizzazione.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere
individuale e collettivo.
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi
produttivi e dei servizi.
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni
sociali e naturali e per interpretare dati.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL
SETTORE TECNOLOGICO
Quadro orario
ore
DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e
Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative
Totale ore annue di attività e
insegnamenti generali
Totale ore annue di attività e insegnamenti
di indirizzo
Totale complessivo ore annue
1°
biennio
2° biennio
5° anno
secondo biennio e quinto anno costitui- scono un percorso
formativo unitario
1^
2^
3^
4^
5^
132
99
66
132
66
132
99
66
132
66
132
99
66
99
132
99
66
99
132
99
66
99
66
66
66
33
66
33
66
33
66
33
66
33
660 660 495
495
495
396 396 561
561
561
1056 1056 1056
1056
1056
3
indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”
Profilo
Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:
•
•
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei
sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione
e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione,
conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;
- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e
collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.
È in grado di:
•
•
•
•
•
•
- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici
complessi;
- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e
apparati elettronici;
- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;
- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in
grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese
relativamente alle tipologie di produzione;
- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti
alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli
impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;
- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed
Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di
competenze.
1– Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature
elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.
2 – Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura
per effettuare verifiche, controlli e collaudi.
3 – Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione
e interfacciamento.
4 – Gestire progetti.
5 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
6 – Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione. 7 – Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi
automatici.
4
Quadro orario
“ ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” : ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
OBBLIGATORI
ore
2° biennio
5° anno
1°
DISCIPLINE
biennio
secondo biennio e quinto anno costitui- scono un
percorso formativo unitario
1^
2^
3^
Scienze integrate (Fisica)
di cui in compresenza
Scienze integrate (Chimica)
di cui in compresenza
Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica
di cui in compresenza
99
66*
99
66*
99
99
99
Tecnologie informatiche
99
di cui in compresenza
Scienze e tecnologie applicate **
66*
4^
5^
99
66*
99
DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “ ELETTRONICA” , “ ELETTROTECNICA” ED
“ AUTOMAZIONE”
Complementi di matematica
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici
ed elettronici
33
33
165
165
198
231
132
198
165
198
165
231
132
165
198
165
198
561
561
561
1056
330*
1056
ARTICOLAZIONI “ ELETTRONICA” ED “ ELETTROTECNICA”
Elettrotecnica ed Elettronica
Sistemi automatici
ARTICOLAZIONE “ AUTOMAZIONE”
Elettrotecnica ed Elettronica
Sistemi automatici
Totale ore annue di attività e insegnamenti di
396 396
indirizzo
di cui in compresenza
264*
Totale complessivo ore
1056 1056
561*
1056
5
INSEGNANTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
IL CONSIGLIO DI CLASSE:
LINGUA E LETTERE ITALIANE-
MARRANCA ROSANNA
STORIA
LINGUA STRANIERA (INGLESE)
MULE’ AMALIA
MATEMATICA
FORNASERO RENATO
SISTEMI AUTOMATICI
FALZONE MICHELE
LABORATORIO SISTEMI AUT.
SACCO CARMELINDA
T.P.S.E.E.
BONSIGNORE SALVATORE
ANTONIO
LABORATORIO DI T.P.S.E.E
VALENZA VINCENZO
ELETTROTECNICA ED
ELETTRONICA
MARCIANO’ DAVIDE
LAB.
ELETTROTECNICA
ED
MEDICO ISIDORO
ELETTRONICA
RELIGIONE
LIPARI FRANCESCO
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
SARDO FERNANDO
SOSTEGNO
ALESSANDRO MARILENA
SOSTEGNO
CARLETTA GRAZIELLA
SOSTEGNO
CORVO MICHELE
SOSTEGNO
TRAMONTANA MICHELE
SOSTEGNO
CAMMARATA DARIO
COORDINATORE: MARRANCA ROSANNA
DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa ZURLI LAURA
6
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 25 alunni, 24 del nucleo originario della IV D dello scorso anno,
cui si è aggiunto un alunno diversamente abile che segue una programmazione differenziata e
ripete la quinta.
Dal punto di vista del corpo insegnante, gli alunni hanno potuto contare su una sostanziale
continuità didattica.
La classe, composta per lo più da pendolari, si è presentata eterogenea per livelli culturali e
per vissuto scolastico. Il comportamento in classe è stato caratterizzato da un atteggiamento
vivace ma generalmente responsabile.Il lavoro in classe per la maggior parte degli alunni è
stato influenzato da un interesse accettabile per le attività proposte: la motivazione positiva in
qualche caso ha stimolato approfondimenti concettuali e livelli di apprendimento soddisfacenti.
In altri casi le attività
svolte in classe non hanno dato seguito ad un puntuale studio delle
discipline e, pertanto, le conoscenze si sono limitate ad un livello generico e superficiale. I
contenuti proposti sono stati adeguati alle reali possibilità degli alunni e alcune parti di
programma sono state sintetizzate e semplificate al fine di consentire, anche a coloro che
mostravano maggiori difficoltà, di raggiungere gli obiettivi della programmazione.
Dal punto di vista didattico - formativo si è costruito un percorso di progressiva autonomia
nel metodo di studio. Un gruppo di alunni, non sempre organizzato, si è sottratto alle verifiche
o vi si è sottoposto tardivamente.
La frequenza è stata assidua e solo un paio di alunni sono stati richiamati per aver sfiorato,
in alcuni momenti dell'anno, il 20% del monte ore di assenze.
Un esiguo gruppo si è distinto positivamente per l’impegno nello studio e la partecipazione alle
attività
extracurriculari
ed
ha
consapevolmente
appreso
i
contenuti
presi
in
esame,
partecipando ad un dialogo critico.
I docenti hanno avuto modo di indirizzare gli alunni verso un’impostazione multidisciplinare con
l’individuazione di collegamenti tra i contenuti e con la trasversalità delle competenze.
Il docente di Matematica è stato
all'unanimità designato per il suo curriculum a svolgere il
modulo sperimentale CLIL in lingua inglese.
Nella maggior parte degli alunni è quasi sufficiente la capacità di comprensione autonoma del
messaggio testuale a livello di fruizione e la tecnica della produzione scritta di testi ed esercizi,
anche se molti di loro hanno limitate abitudini di lettura e usano spesso il dialetto per
comunicare tra loro:ciò penalizza le competenze linguistiche, se non a livello di comprensione,
certamente a livello espressivo. Per questo è stata linea comune del C.d.C. valorizzare la
coerenza del messaggio e la capacità di elaborarlo in modo personale. Risulta sufficiente la
capacità di progettare, realizzare e gestire il lavoro proposto nell’ambito delle discipline
7
tecniche.
Hanno frequentato la classe due alunni diversamente abili: uno ha frequentato assiduamente,
ha potuto contare sulle ore dell'insegnante
di sostegno ed ha seguito un Piano Educativo
Individualizzato non riconducibile ai programmi ministeriali e adottato ai sensi dell’art.14
dell’O.M. del21/5/2001 N°90. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e i voti riportati sono
relativi unicamente allo svolgimento del P.E.I. Un altro alunno diversamente abile con
programmazione differenziata ha frequentato saltuariamente per motivi di salute, pertanto non
ha, ad oggi, pienamente raggiunto tutti gli obiettivi del PEI. Le valutazioni di entrambi gli
alunni in questione sono riferite esclusivamente agli obiettivi del PEI, redatto ai sensi
dell'art.13 comma 4 O.M. 80 del 29/3/95. Secondo quanto stabilito dal D.P.R.N°323 del
23/7/98, art.13 e successive modifiche ed integrazioni, essi potranno acquisire un "Attestato di
credito formativo" previsto per gli alunni diversamente abili che non conseguono il diploma di
Esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria superiore. A tal fine il
C.d.C. chiede alla Commissione d'esame che vengano preparate per questi alunni delle prove
differenziate, coerenti con il percorso didattico realizzato durante l'anno, secondo le indicazioni
contenute nell'Allegato Riservato al presente documento.Inoltre si ritiene necessaria la nomina
degli insegnanti specializzati per mediare lo svolgimento delle prove scritte e della prova orale.
In allegato riservato sono descritte nel dettaglio le modalità di effettuazione delle prove
d’esame: queste accerteranno una preparazione idonea al rilascio di un attestato di crediti
formativi(DPR 323/98 art.3 e CM 125/01).
In allegato riservato,inoltre, si trova il PEI, che può fornire alla commissione elementi utili per
la definizione delle prove differenziate.
La presenza in classe degli alunni diversamente abili ha portato tutti gli alunni a promuovere il
successo del percorso di integrazione favorendo pratiche inclusive attraverso una
stretta
collaborazione fra tutte le componenti della classe.
Con il lavoro svolto negli anni precedenti e in quest’anno scolastico, gli alunni, in generale,
hanno dimostrato di avere acquisito gli strumenti minimi necessari
per affrontare lo studio
sistematico, ma non tutti hanno saputo utilizzare tali strumenti nella soluzione di problemi
proposti. Le loro capacità medie sono accettabili e, indirizzati verso uno studio più attento e
continuo, sono stati in grado di giungere a risultati positivi.
Tra le attività curriculari ed extracurriculari cui gli alunni hanno partecipato nel corrente anno
scolastico è stato particolarmente significativo e formativo il viaggio di istruzione nel
siracusano, con passeggiate naturalistiche. Alcuni alunni hanno inoltre seguito un corso
pomeridiano sul programma Arduino ed un gruppo ha partecipato agli incontri del progetto
Bootstrap sulle startup di impresa.Tutti hanno partecipato a vari incontri per l’orientamento
universitario, recandosi in visita alle Università di Palermo, Caltanissetta, Enna e Catania.
Sempre con finalità di Orientamento gli alunni hanno partecipato a due incontri con la Guardia
8
Finanza.
La Giornata della Memoria 2016 è stata celebrata con un incontro tenuto dalla prof.ssa Lipani
su Slomo Venezia e la sua testimonianza del SonderKommand. La partecipazione della classe
al Progetto Repubblicascuola ha offerto uno spazio per pubblicare i propri contributi sul
giornale online, ma anche la possibilità di leggere il quotidiano in diversi momenti dell'anno
scolastico. Lo scorso anno due alunni hanno conseguito la Patente Europea e la classe intera
ha effettuato due importanti visite guidate all'Expobit di Catania e alla Centrale Archimede di
Siracusa.
I risultati del percorso di studi della classe possono essere così sintetizzati: tre o quattro alunni
hanno raggiunto buoni risultati. Grazie alla propensione e assiduità nello studio, hanno
conseguito valide competenze conoscitive e adeguate capacità di rielaborazione, ottenendo
esiti apprezzabili in tutte le discipline, soprattutto in quelle relative all’area tecnica. Il metodo
di lavoro è risultato positivo, soprattutto in chi si è impegnato in maniera costante. Il suddetto
impegno si è manifestato con la frequenza regolare alle lezioni, con la capacità di ascoltare e di
intervenire in maniera coerente e/o critica al dialogo educativo, con la puntualità e la
precisione nel prendere appunti e con l’esecuzione del lavoro assegnato per casa.
La fascia
media, formata dalla maggior parte degli alunni, si è impegnata in modo più discontinuo e ha
partecipato non sempre attivamente, per cui ha acquisito conoscenze e competenze poco più
che sufficienti. Infine alla fascia medio-bassa appartengono pochi alunni che, partiti da una
preparazione lacunosa e piuttosto superficiale, hanno dimostrato impegno discontinuo e
interesse settoriale. In seguito a tutte le strategie messe in atto dalla scuola e grazie alla loro
volontà nel voler superare le difficoltà di studio, questi alunni hanno raggiunto una
preparazione generale nella quale permangono ancora delle fragilità. Questi ultimi alunni si
sono limitati a risultati appena sufficienti, senza approfondimenti.
9
ELENCO CANDIDATI DELLA CLASSE
1
ALAIMO FABIO
2
BARTOLI CALOGERO
3
BONTA' KEVIN
4
BORZI' ANTONINO
5
CARBONE GIOVANNI
6
CARLINO CALOGERO
7
D'ANCA RICCARDO
8
DI BILIO FILIPPO
9
FARRUGGELLO FRANCESCO
10
GIANNONE ANTONY
11
GIARRATANO VINCENZO
12
INGRAO DAVID
13
INTILLA ALESSANDRO
14
MAROTTA SALVATORE
15
MICCICHE' MARCO
16
OGNIBENE SIMONE
17
PAGNOTTA UMBERTO
18
PANTANO FRANCESCO
19
PATERNUOSTO AURELIO
20
PILATO RICCARDO
21
PORROVECCHIO GIUSEPPE
22
RAIMONDI JONATHAN
23
SALERNO FRANCESCO
24
SPINELLO FRANCESCO
25
TUZZE' PAOLO
10
OBIETTIVI
Il Consiglio di Classe ha determinato gli obiettivi generali desunti e sintetizzati dalle
programmazioni per assi culturali:
- acquisizione di un bagaglio culturale di base solido e ad ampio
spettro;
- comprensione, riorganizzazione ed esposizione di significati, fatti e
fenomeni;
- elaborazione di comunicazioni scritte e verbali corrette;
- formulazione di concetti e giudizi di valutazione in base a criteri dati;
- propensione culturale ad un aggiornamento continuo;
- capacità di adattamento ai cambiamenti rapidi;
- capacità di orientamento di fronte a nuovi problemi;
- capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.
METODI E STRUMENTI
I contenuti sono stati articolati nella loro globalità secondo una serie di domande e risposte in
rigorosa progressione, non isolati, ma esposti come parti di una struttura aperta alla
discussione e al confronto.
Strumenti
essenziali
sono
stati
schemi,
grafici,
tabelle,
in
grado
di
esplicitare
le
interconnessioni tra fattori e di definire un problema o un percorso (mappe concettuali e
mentali). Si sono utilizzati: strumenti multimediali, laboratori, nonché attività di tipo “problemsolving”.
Gli itinerari didattici delle materie tecniche sono stati percorsi attraverso lezioni teoriche tratte
da osservazioni di casi reali e attraverso esperienze di laboratorio , simulazioni, progetti.
Si è tentato di realizzare l’obiettivo della multidisciplinarità nel senso della coerenza didattica,
della circolarità dei contenuti, del collegamento concettuale, al fine di sollecitare negli allievi
collegamenti tra competenze e conoscenze diverse. Il processo didattico è stato suddiviso in
due periodi: un primo ed un secondo quadrimestre.
11
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Al termine di ciascun modulo si è verificato l’apprendimento attraverso accertamenti orali,
esercitazioni scritte, prove strutturate e/o semistrutturate. Le verifiche formative sono state
utilizzate anche per valutare l’efficacia dell’intervento educativo e per organizzare l’attività del
recupero in itinere svoltosi attraverso una pausa didattica. Il compito in classe, così come il
colloquio, ha consentito la quantificazione dei progressi in porzioni significative di moduli
(verifica sommativa).
Le verifiche, accanto ai risultati prettamente contenutistici, hanno tenuto conto di quelli
educativi. Pertanto non ci si è limitati a valutare le nozioni che lo studente ha appreso e la
capacità di comprenderle, esporle correttamente e correlarle tra loro, ma anche il suo
interesse, l’assiduità, la partecipazione, la motivazione, l’autonomia di giudizio. Tutto il
percorso formativo è stato modellato sulle abilità generali degli alunni e sui loro diversi ritmi di
apprendimento.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si fa riferimento alla seguente tabella nonché alle
griglie di valutazione inserite nella programmazione per assi culturali e nelle programmazioni
delle singole discipline :
TABELLA DI CORRISPONDENZA
TRA VOTI DECIMALI E LIVELLI TASSONOMICI
Voto 1: (NULLO)
L’alunno ignora gli argomenti proposti; non svolge le prove scritte/pratiche/ grafiche; non
risponde ad alcun quesito inerente la disciplina; non esercita alcuna abilità.
Voto 2: (NEGATIVO)
L’alunno non conosce gli argomenti trattati; avvia processi di svolgimento delle prove, che
tuttavia risultano solo abbozzati; non riconosce i temi proposti; non esercita abilità.
Voto 3: (GRAVEMENTE INSUFFICIENTE)
L’alunno ha conoscenze estremamente frammentarie sui temi proposti; commette
gravissimi errori di procedura e di collegamento; si esprime oscurando il significato del
discorso; non ha conseguito le abilità richieste.
Voto 4: (INSUFFICIENTE)
L’alunno possiede conoscenze molto lacunose e confuse; la comprensione dei temi
disciplinari è parziale; commette gravi errori negli elaborati; non è in grado di effettuare
alcuna analisi; abilità insufficienti per la risoluzione di compiti semplici.
Voto 5: (MEDIOCRE)
L’alunno ha conoscenze incerte e con lacune; commette errori non gravi nell’esecuzione di
compiti semplici; l’esposizione è poco fluida e non del tutto chiara; abilità mediocri.
Voto 6: (SUFFICIENTE)
L’alunno conosce i concetti base della disciplina; commette lievi errori non procedurali;
l’esposizione è essenziale, con una terminologia accettabile; abilità adeguate alla
risoluzione di compiti semplici.
Voto 7: (DISCRETO)
L’alunno si orienta correttamente sugli argomenti proposti; applica le procedure con
ordine anche se con qualche incertezza; conosce il significato dei termini tecnici e li usa in
12
modo appropriato, rendendo l’esposizione abbastanza fluida; abilità adeguate alla
risoluzione di compiti non particolarmente complessi.
Voto 8: (BUONO)
L’alunno ha conoscenze complete;applica le procedure senza incertezze; sa determinare
correlazioni ed effettuare processi di sintesi; incorre in qualche imprecisione nello
svolgimento delle prove. Espone in maniera corretta con proprietà linguistica. Abilità
adeguate alla risoluzione di compiti complessi.
Voto 9: (OTTIMO)
L’alunno ha conoscenze complete e approfondite, acquisite attraverso processi di analisi,
sintesi e rielaborazione autonomi; coglie subito suggerimenti per trovare propri percorsi
risolutivi; esposizione fluida con utilizzo del linguaggio specifico.
Voto 10: (ECCELLENTE)
L’alunno ha conoscenze complete, approfondite e ampliate; applica le conoscenze in modo
autonomo e corretto anche a problemi complessi e trova da solo soluzioni originali; sa
rielaborare correttamente e approfondisce in modo autonomo e critico situazioni
complesse. L’esposizione è fluida con utilizzo di un lessico ricco e appropriato
Per quanto riguarda i criteri di valutazione della condotta, si fa riferimento alla
tabella
inserita nel P.O.F. (All.2)
Le simulazioni della terza prova scritta si sono svolte il 4 Marzo e il 23 Aprile.
Per la terza prova scritta è stata scelta la tipologia C “test a risposta multipla” con 32 quesiti
divisi per 4 discipline( Storia, Matematica, TPSEE, Sistemi) più 2 quesiti a risposta aperta di
Inglese. Tra gli 8 quesiti di Matematica, 2 sono stati dedicati al CLIL. Ai quesiti a risposta
multipla sono stati assegnati punti 0,375 per ogni risposta esatta e punti 0 per ogni risposta
errata o non data. Le frazioni di punto sono state arrotondate per eccesso. Ai quesiti a risposta
aperta sono stati assegnati 1,5 punti ciascuno, secondo la griglia allegata.
La simulazione del colloquio è prevista per la prima settimana di giugno e sarà condotta a
partire dall’argomento prescelto dall’alunno, presentato in forma di mappa concettuale, con
eventuale ausilio multimediale, a richiesta dell’alunno stesso, con successivi interventi da parte
di ciascun insegnante, in modo da verificare le conoscenze e le competenze acquisite in
entrambe le aree disciplinari, come previsto dalla normativa vigente.
In sede di scrutinio finale del corrente anno scolastico, il Consiglio di classe procederà ad una
valutazione complessiva dello studente che tenga conto delle conoscenze e delle competenze
acquisite nell’ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli
sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a
consentirgli di affrontare l’esame.
In presenza di insufficienze nelle discipline la non ammissione sarà specificamente motivata.
Per ciò che riguarda la normativa che attiene agli Esami di Stato, il Consiglio di classe ha preso
visione di tutte le disposizioni di legge.
Gli alunni hanno tutti colmato i debiti pregressi, superando gli esami per le discipline con
giudizio sospeso alla fine del terzo e quarto anno, da come si evince dai verbali di ripresa dello
scrutinio.
13
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
Tipologia A: analisi di un testo letterario e non, in prosa o poesia
Indicatori
PUNTI
Descrittori
Comprensione pertinente, approfondita e sviluppata
5
Comprensione corretta, ma semplice
4
Comprensione essenziale e trattazione superficiale
3
Informazioni poco chiare e poco significative
2
Comprensione del testo, pertinenza e
completezza d’informazione
Parziale comprensione del testo proposto
Analisi organica, coerente e argomentata
1
5
Analisi semplice , chiara e significativa
4
Analisi accettabile, ma incompleta negli aspetti
formali
3
Analisi delle strutture tematiche e
formali
Analisi poco puntuale, incompleta
Correttezza ortografica, lessicale e
sintattica
Capacità di approfondimento critico e
contestualizzazione
2
Analisi priva di informazioni essenziali
Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato
1
3
Improprietà lessicali e sintattiche, pochi errori di
rilievo
2
Numerosi e gravi errori morfo-sintattici, lessico
improprio
1
Interpretazione originale, personale, criticamente
motivata
2
1
Non si riscontra autonomia di giudizio
TOT.
/15
14
Tipologia B: Saggio breve o articolo di giornale
Indicatori
Descrittori
PUNTI
Pertinenza, capacità di avvalersi del Informazione pertinente, approfondita e sviluppata
materiale proposto e coerenza rispetto
alla tesi
Aspetti trattati correttamente, ma in modo semplice
5
4
Idee essenziali e trattazione superficiale
3
Sviluppo poco chiaro e poco significativo
2
Impostazione incoerente e inconsistente
Contenuto organico, coerente e argomentato
1
5
Contenuto semplice , chiaro e significativo
4
Contenuto accettabile, ma argomentazioni non
motivate
3
Argomentazione, approfondimento
Correttezza ortografica, lessicale e
sintattica
Capacità di approfondimento critico e
originalità delle opinioni espresse
Contenuto non sempre coerente, argomentazione
poco chiara, banale
2
Contenuto incoerente, privo di informazioni essenziali
e motivazioni
Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato
1
3
Improprietà lessicali e sintattiche, pochi errori di
rilievo
2
Numerosi e gravi errori morfo-sintattici, lessico
improprio
1
Interpretazione originale, personale, criticamente
motivata
Non si riscontra autonomia di giudizio, opinioni
scontate
2
1
/15
TOT.
15
Tipologia C: Tema di argomento storico
Indicatori
PUNTI
Descrittori
Conoscenza esatta in senso diacronico Informazione pertinente, approfondita e sviluppata
e sincronico
Aspetti trattati correttamente, ma in modo semplice
Individuazione dei nessi cusali e della
complessità
dell’evento/personaggio/momento
storico
Correttezza ortografica, lessicale e
sintattica
Capacità di approfondimento critico e
originalità delle opinioni espresse
5
4
Conoscenze essenziali e trattazione superficiale
3
Sviluppo poco chiaro e poco significativo
2
Conoscenze in parte errate
Contenuto organico, coerente e argomentato
1
5
Contenuto semplice , chiaro e significativo
4
Contenuto accettabile, ma nessi non espliciti
3
Contenuto non sempre coerente, collegamenti poco
chiari
2
Contenuto disordinato, privo di informazioni
essenziali
Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato
1
Improprietà lessicali e sintattiche, pochi errori di
rilievo
2
Numerosi e gravi errori morfo-sintattici, lessico
improprio
1
Interpretazione originale, personale, criticamente
motivata
2
Non si riscontra autonomia di giudizio, opinioni
scontate
3
1
/15
TOT.
16
Tipologia D: Tema di carattere generale
Indicatori
PUNTI
Descrittori
Pertinenza
e
dell’argomento proposto
conoscenza Ideazione pertinente, approfondita e sviluppata
Argomentazione, informazione,
approfondimento
Correttezza ortografica, lessicale e
sintattica
Capacità di approfondimento critico e
originalità delle opinioni espresse
5
Aspetti trattati correttamente, ma in modo semplice
4
Idee essenziali e trattazione superficiale
3
Sviluppo poco chiaro e poco significativo
2
Impostazione incoerente e inconsistente
Contenuto organico, coerente e argomentato
1
5
Contenuto semplice , chiaro e significativo
4
Contenuto accettabile, ma argomentazioni non
motivate
3
Contenuto non sempre coerente, argomentazione
poco chiara, banale
2
Contenuto incoerente, privo di informazioni essenziali
e motivazioni
Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato
1
Improprietà lessicali e sintattiche, pochi errori di
rilievo
2
Numerosi e gravi errori morfo-sintattici, lessico
improprio
1
Interpretazione originale, personale, criticamente
motivata
2
Non si riscontra autonomia di giudizio, opinioni
scontate
3
1
/15
TOT.
17
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
PROBLEMA
PUNTI 9
Conoscenza dell’argomento
proposto
Da 0 a 3
punti
Analisi critica
Da 0 a 2
punti
Utilizzo delle formule
appropriate
Da 0 a 2
punti
Uso del linguaggio tecnico
specifico
Da 0 a 2
punti
QUESITO 1
PUNTI 3
Conoscenza dell’argomento
Da 0 a 1
punti
Analisi critica
Da 0 a 1
punti
Uso di formule e linguaggio
appropriati
Da 0 a 1
punti
QUESITO 2
PUNTI 3
Conoscenza dell’argomento
Da 0 a 1
punti
Analisi critica
Da 0 a 1
punti
Uso di formule e linguaggio
appropriati
Da 0 a 1
punti
18
GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA
Ciascun docente dispone di 3 punti da distribuire su 8 quesiti a risposta multipla (0,375).
Per la Lingua Inglese il docente dispone di 2 quesiti a risposta aperta da 1,5 punti ciascuno.
E' consentito l'uso del vocabolario di Inglese e della calcolatrice
QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA (non sono ammesse cancellature, correzioni, abrasioni)
QUESITI A RISPOSTA APERTA di INGLESE
DESCRITTORI
Risposta ottima o
eccellente
1,5
Risposta discreta
o buona
1,25
INDICATORI
Risposta
sufficiente
1
Risposta
insufficiente
0,75
Esecuzione del
compito
Sa rispondere alle
indicazioni del
compito in modo
completo e
articolato
Sa rispondere
alle indicazioni
del compito in
modo completo
Sa rispondere
alle indicazioni
del compito in
modo essenziale
Sa rispondere alle
indicazioni del
compito in modo
incompleto
Correttezza
morfosintattica
Usa le strutture
morfosintattiche in
modo articolato,
corretto ed
appropriato
Efficacia
comunicativa
Sa costruire un
discorso coerente e
coeso; padroneggia
l’argomento che
espone in maniera
personale e con
accuratezza
linguistica e
lessicale
Usa le strutture
morfosintattiche
in modo
abbastanza
articolato e
corretto, con
saltuarie
inesattezze
Sa costruire un
discorso
generalmente
coerente e
coeso, in modo
abbastanza
efficace e
personale seppur
con qualche
saltuaria
imprecisione
Usa le strutture
morfosintattiche
commettendo
errori che
tuttavia non
impediscono la
comprensibilità
globale del testo
Sa costruire un
discorso
comprensibile
ma a volte non
sempre
scorrevole;
risponde
sinteticamente e
senza apporti
personali
Usa le strutture
morfosintattiche
con difficoltà e
commette errori
che
compromettono la
comprensibilità del
testo
Non riesce a
costruire un
discorso coerente e
coeso per lo scarso
e/o inappropriato
utilizzo dei
connettori logici
Risposta
estremamen
te carente
0,50
Sa
rispondere
alle
indicazioni
del compito
in modo
scarso o
nullo
Non sa usare
le strutture
morfosintatti
che. Il testo
risulta non
comprensibil
e
Non sa
costruire un
discorso
comprensibil
e rispetto
allo scopo
19
GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DELLA PROVA
COGNOME _______________
NOME ________________
DISCIPLINA
Storia
Matematica
Elettrotecn.
Sistemi
Inglese
1
2
Quesiti
a risposta multipla
3
4
5
6
Approssimazione al voto successivo
per frazioni uguali o superiori a 0,5
7
8
Quesiti
a risposta aperta
1
2
VALUTAZIONE
PROVA
TOTALI
___ /
15
20
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO
Obiettivi
LIVELLO di prestazione
Punti
Trattazione originale o significativa
Capacità di discussione
Padronanza della lingua orale
Abbastanza interessante
2–3
Banale
1
Articolata, sicura, fluida, appropriata
3
Convincente solo a tratti
2
Impacciata, confusa, imprecisa, inespressiva
1
Elevata
Conoscenza degli argomenti
4
9 – 11
Media
3–8
Superficiale
1–2
Riflette, sintetizza, esprime valutazioni
2–3
Applicazione e competenza
Solo a tratti
Capacità di collegamento, di
discussione e di approfondimento
Aderente, efficace, pertinente
1
2–3
Solo a tratti
1
Consapevole, convincente, esaustiva
2
Incerta, parziale, nulla
1
Consapevole, convincente, esaustiva
2
Incerta, parziale, nulla
1
Consapevole, convincente, esaustiva
2
Incerta, parziale, nulla
1
Autocorrezione (Italiano)
Autocorrezione (seconda prova)
Autocorrezione (terza prova)
totale
/30
21
ATTIVITÀ DIDATTICO-DISCIPLINARI
classe V D indirizzo “Elettrotecnica”
anno scolastico 2015/2016
MATERIA:
Insegnamento della Religione Cattolica
DOCENTE:
Lipari Francesco
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
Michele Contadini, Itinerari di IRC, Volume unico,
Editore Elledici – Il Capitello.
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. 2015/16:
n. ore 26 su n. 33 previste dal piano di studi
CONTENUTI
MODULO 9
Il problema
di Dio
MODULO 10
La "via"
delle religioni
MODULO 6.3
Il fatto cristiano
nella storia dal
1870
ai giorni nostri.
Dio nelle culture.
Fede e cultura; Fede e progresso; Fede e scienza. Il ritorno di Dio?
1. Il dialogo tra le religioni perché e come;
2. La tradizione occidentale: l’Islamismo.
3. La tradizione orientale: l’Induismo, il Buddismo.
Le grandi correnti del pensiero contemporaneo;
La Chiesa del Concilio Vaticano II
La Chiesa cattolica dopo il Vaticano II
OBIETTIVI RAGGIUNTI
COMPETENZE
Quasi tutti gli allievi
sanno ormai
comprendere e
di una conoscenza oggettiva e
rispettare le diverse
sistematica dei contenuti essenziali del
posizioni che le
cattolicesimo,
persone assumono in
delle grandi linee del suo sviluppo
materia etica e
storico,
religiosa.
delle espressioni più significative della
sua vita.
CONOSCENZE
Gli alunni sono stati guidati
all’acquisizione:
METODI
Breve lezione frontale
per la trasmissione di
concetti, informazioni e
schemi interpretativi.
Esercitazioni individuali
e di gruppo per
rinforzare e stabilizzare
le nozioni trasmesse
durante la lezione.
MEZZI E STRUMENTI
La bibbia e altri
documenti del magistero
della Chiesa reperibili e
utilizzabili con l'uso del
cellulare e della LIM.
Visione e audizione di
piccoli filmati e canzoni
attinenti alle tematiche
svolte.
Esposizione dei moduli
della programmazione in
formato PPT con l'ausilio
della LIM.
ABILITÀ
Alla fine del percorso
educativo scolastico gli
studenti hanno maturato
la capacità di confronto tra
il cattolicesimo, le altre
confessioni cristiane, le
altre religioni e i vari
sistemi di significato.
STRUMENTI DI VERIFICA
Gli alunni sono stati valutati tenendo
conto dei seguenti criteri:
partecipazione al dialogo
educativo in classe;
capacità di ascolto e di
confronto con l’insegnante
capacità di ascolto e di
confronto con il resto della classe.
apertura e formazione
crescente ai valori etico-morali
fondamentali dell’esistenza e della
vita sociale quali l’educazione alla
legalità e il rispetto della cosa
pubblica.
22
ATTIVITA’ DIDATTICO-DISCIPLINARE
classe V D EL.
anno scolastico 2015/2016
MATERIA: ITALIANO
DOCENTE: MARRANCA ROSANNA
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: M. Materazzi, “ La parola letteraria”VOL
III( tomi A e B) ,LOESCHER
ORE 102/132
Contenuti
MODULO I : L’età del Realismo
Le poetiche romantiche: poetica della “realta” e poetica dell’”io”.
Dalle poetiche romantiche alle poetiche di fine secolo.
Baudelaire. L'albatro
Lo spleen di Parigi.” La perdita dell'aureola”
Dal Romanticismo al Realismo
Il Positivismo.Il Naturalismo.Comte, Darwin e Taine
Zola ed il romanzo sperimentale. Confronto Naturalismo- Verismo
La Questione meridionale e il Verismo di Verga
Novelle:“Rosso Malpelo”; “La roba”
Prefazione a L'amante di Gramigna
Il Ciclo dei Vinti
I Malavoglia “Dialogo tra nonno e nipote”
Mastro Don Gesualdo “ La morte di Mastro Don Gesualdo”
MODULO II: IL NOVECENTO
Dal Positivismo al Decadentismo
I presupposti filosofici del Decadentismo. La poetica decadente
Poetiche del Simbolismo
Pascoli: Poesie. “Lavandare”, “Nebbia”, “Il gelsomino notturno”
“Orfano” “Il X agosto”
“Il fanciullino” “La Grande Proletaria”
D’Annunzio:Panismo, Estetismo e Superomismo
23
“La pioggia nel pineto” e la poesia di Alcyone.
L’Estetismo e l'eroe decadente. Il romanzo decadente europeo
Wilde e Il ritratto di Dorian Gray.
“La presentazione di Andrea Sperelli” ne Il piacere di D’Annunzio
MODULO III: Ungaretti e il Futurismo
Il Futurismo e i Manifesti di Marinetti
Ungaretti tra Futurismo e poesia pura
Ungaretti: “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Soldati”,
“Sono una creatura”, “Commiato”, “Il porto sepolto” “I fiumi”
“ Natale”
“La madre”. Canto XXXIII Paradiso: preghiera alla Vergine.
La donna nella funzione di intermediaria.
MODULO IV LA CRISI DELL’UOMO CONTEMPORANEO
Il romanzo del Novecento
Pirandello:
“Comicità e umorismo” da L’umorismo
Novella: La giara
Film “Kaos” dei fratelli Taviani. Episodio: La giara( Il sistema dei personaggi)
Novella: Ciaula scopre la luna. (Analisi comparativa con Malpelo di Verga)
Il fu Mattia Pascal. “Il primo suicidio”
Uno, nessuno e centomila “ Il relativismo pirandelliano”
Il teatro: Così è (se vi pare): “La verità”
Svevo. La coscienza di Zeno:
“Il vizio del fumo”
“La vita come malattia universale”
MODULO V :Gli sviluppi della poesia lirica
24
L’Ermetismo
Quasimodo “Ed è subito sera”; “Alle fronde dei salici”.
Montale :
“Spesso il male di vivere ho incontrato”
“Non chiederci la parola”, “Ho sceso dandoti il braccio”
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
Conoscere i modelli culturali e
letterari dell’epoca studiata
Produrre testi scritti coerenti
secondo le tipologie d’esame
Conoscere il ruolo
dell’intellettuale e lo scopo
comunicativo dei testi del
periodo studiato
Formulare giudizi motivati in
un discorso orale
Conoscere elementi di
continuità ed innovazione tra
correnti letterarie
Riconoscere autonomie e
dipendenze tra diversi
linguaggi e diverse forme
d’arte(cinema e letteratura)
ABILITA’
Collocare l’opera nel contesto
del modello culturale
dell’epoca
Applicare elementari tecniche
di analisi testuale a livello
denotativo e connotativo
Evidenziare analogie e
differenze tra opere e autori
confrontabili
Conoscere la poetica e
l’ideologia dell’autore
attraverso i testi
maggiormente
rappresentativi
METODI
Centralità del testo, del tema
e della poetica
Dal testo al contesto e
viceversa
Dall’opera letteraria alla
visione del film e viceversa
MEZZI E STRUMENTI
Mappe concettuali e
schematizzazione
Materiali offerti dal manuale
(spunti operativi di
comprensione del testo)
STRUMENTI DI VERIFICA
Osservazione dei
comportamenti
(partecipazione, impegno,
applicazione)
Verifiche orali con analisi
testuale
Visione del film
Prove semistrutturate
Scheda di analisi
Audiolibro
Prove scritte secondo le
tipologie d’esame
25
ATTIVITA’ DIDATTICO-DISCIPLINARE
classe V D EL.
anno scolastico 2015/2016
MATERIA: STORIA
DOCENTE: MARRANCA ROSANNA
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: F. Bertini, Storia. Fatti e interpretazioni,
VOL.III, MURSIA SCUOLA
ORE 58/66
CONTENUTI
MODULO 0: Le trasformazioni sociali e culturali alla fine dell'Ottocento
La Questione Meridionale
MODULO I: L’Italia industriale e l’età giolittiana
La belle epoque
L’Italia Giolittiana
MODULO II: La Grande guerra e la Rivoluzione Russa
La Prima Guerra Mondiale: cause e dinamiche
La Rivoluzione Russa e la nascita dell’URSS
La politica economica durante la Rivoluzione Russa
MODULO III: Le tensioni del dopoguerra
Crisi economica e biennio rosso
Movimento fascista e squadrismo. Verso la dittatura
MODULO IV: L’età dei totalitarismi
Approfondimento: cos’è il totalitarismo.
La crisi del ’29 e il New Deal
Confronto tra Crisi del '29 e Crisi del 2008
Il regime fascista
Il regime nazista
26
Il regime staliniano
Confronto tra totalitarismi
MODULO V: Guerra e nuovo ordine mondiale
La Guerra civile spagnola
La Seconda Guerra Mondiale
Il dominio nazista in Europa e la Shoa
La propaganda nazista: il campo di Teresin
La Resistenza in Italia. Le foibe
MODULO VI: Il mondo bipolare
Guerra fredda: la divisione del mondo in due aree di influenza
Il muro di Berlino
Truman e Kruscev
La guerra di Corea
La corsa allo spazio
Il processo di decolonizzazione
MODULO VII: L’Italia nel secondo dopoguerra
L’Italia tra 1946 e 1948. Referendum e Costituzione
Il boom degli anni ‘60
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
Conoscere
i
periodi
COMPETENZE
storici
Individuare
connessioni
Usare fondamentali termini e
esaminati;
logiche e le linee di sviluppo
concetti storici per leggere e
individuare i molteplici aspetti
tra accadimenti storici;
interpretare la realtà.
di un evento;
utilizzare
riconoscere i nessi causali e le
allo
relazioni spaziali;
informazioni
le
scopo
le
CAPACITA’(ABILITA’)
testimonianze
di
produrre
attendibili
relativamente ad un tema.
27
METODI
MEZZI E STRUMENTI
STRUMENTI DI VERIFICA
Lezione frontale;
Esposizione;
Accertamenti orali;
Lezione aperta: problematica,
dibattiti;
questionari;
partecipata, formativa;
conversazioni;
prove strutturate;
lavori di ricerca;
commenti;
colloqui
lettura in classe sui contenuti
esercizi dal manuale;
delle unità didattiche;
didattici e su temi di interesse
documenti;
verifiche sommative alla fine
storico e di attualità;
schemi, grafici e tabelle;
di ogni modulo.
mappe concettuali.
carte tematiche.
informali
nel
corso
28
Attività didattico-disciplinari al 15 maggio 2016
classe V D indirizzo “Elettrotecnica ed
automazione” anno scolastico 2015/2016
MATERIA
Sistemi
DOCENTE:
Prof. Falzone Michele
LIBRO DI TESTO ADOTTATO Corso di sistemi automatici Hoepli
appunti scelti per argomento
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. 2015/16
n. ore 150
su 166
previste dal piano di studi
Contenuti
Modulo 1: Richiami della teoria degli schemi a blocchi
U.D.1.1 : Definizione di sistema
U.D.1.2 : Blocchi in serie e blocchi in parallelo
U.D.1.3: Concetto di funzione di trasferimento
U.D.1.4: La retroazione
U.D.1.5: Effetti della retroazione in un sistema, riduzione dello errore e
miglioramento della risposta
Modulo 2: Richiami sull’amplificatore operazionale
U.D.2.1:
U.D.2.2:
U.D.2.3:
U.D.2.4:
U.D.2.5:
L’amplificatore operazionale, principali caratteristiche
L’A.O. come amplificatore invertente
L’A.O come amplificatore non invertente
L’A.O. come amplificatore sommatore
L’A.O. come nodo sottrattore.
Modulo 3: Richiami sulla funzione di trasferimento nel dominio della frequenza
U.D. 3.1: Studio della F, di T. nel dominio della frequenza
U.D. 3.2: Diagrammi di Bode
29
U.D. 3.3: Uso della carta semilogaritmica
U.D. 3.4: Cenni sulla rappresentazione nel piano complesso, diagrammi di Nyquist
U.D. 3.5: Sistemi del primo e del secondo ordine
U.D. 3.6: Studio dei sistemi nel dominio del tempo
U.D. 3.7: Risposta ai segnali canonici, impulso gradini e rampa
Modulo 4: la Trasformata di Laplace
U.D. 4.1: Definizione della trasformata di Laplace
U.D. 4.2: Proprietà fondamentali
U.D. 4.3: Uso della trasformata di Laplace per la risoluzione delle equazioni differenziali
U.D. 4.4: Risposta ai segnali canonici, gradino e impulso
U.D. 4.5: Applicazione della T di L in alcune reti elementari per lo studio dei transitori
Modulo 5: la retroazione
U.D.5.1: Sistemi a catena aperte e sistemi retroazionati
U.D.5.2: La retroazione
U.D.5.3 : Effetti positivi della retroazione
U.D.5.4 : Miglioramento della risposta, aumento della banda e loro legame
U.D.5.5: Riduzione dei disturbi
30
Modulo 6: La stabilità nei sistemi retroazionati
U.D. 6.1: Concetto di stabilità nei sistemi retroazionati
U.D. 6.2: Cenni sui criteri di stabilità di Rhouth e di Nyquist
U.D. 6.3: Criteri di stabilità mediante i diagrammi di Bode
U.D. 6.4: Margine di guadagno e margine di fase
Modulo 7: Le reti correttrici
U.D. 7.1: Concetto di rete correttrice
U.D. 7.2: Correzione mediante rete attenuatrice
U.D. 7.3: Correzione mediante polo dominante
U.D. 7.3.: Correzione mediante rete anticipatrice
U.D. 7.4.: Correzione mediante rete ritardatrice
U.D. 7.5.: Correzione mediante rete a sella
U.D. 7.3.: Effetti delle reti correttrici sulla risposta e sulla riduzione dell’errore a regime
31
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
ABILITA’
- Principio di
funzionamento
degli operazionali
- Studio della F.di T.
nel dominio della
Frequenza
- Studio dei
Transitori
- Effetti della
retroazione sui
Sistemi
- la stabilità nei
sistemi con
Retroazione
- Elementari
progettazione di
reti di regolazione
Riuscire a
elaborare un
modello
matematico delle
funzioni di
trasferimento,
saperne dedurre i
diagrammi di Bode
ed i relativi studi
nei sistemi retro
azionati
Sapere applicare
correttamente i
concetti studiati in
applicazioni reali
METODI
MEZZI E
STRUMENTI
STRUMENTI DI
VERIFICA
- Lezione frontale
- Discussione
Guidate
- Libro di testo
- Lavagna
- Computer, per
simulazione
- Per problemi
logistici della
scuola sono
riuscito a usare il
laboratorio di
misure elettriche
solo in maniera
parziale.
- Verifiche orali
- Verifiche scritte
- Verifiche
pratiche: Limitate
per carenze del
laboratorio
- Discussioni dal
posto
32
ATTIVITÀ DIDATTICO-DISCIPLINARI
classe V D indirizzo “ELETTROTECNICO”
anno scolastico 2015/2016
MATERIA: Scienze motorie
DOCENTE: Fernando Sardo
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: MOVE
CONTENUTI
Conoscenza delle regole e delle tecniche di Pallavolo.
Conoscenza delle regole e delle tecniche di Pallacanestro.
Conoscenza delle regole e delle tecniche del calcio.
Miglioramento della forza: attività ed esercizi a carico naturale; attività ed esercizi con piccoli
e grandi attrezzi; importanza dell’allenamento.
Miglioramento della resistenza.
Miglioramento della velocità.
Miglioramento della mobilità articolare.
Atletica leggera :La corsa veloce: partenza dai blocchi, La staffetta: uso corretto del
testimone, Il salto in alto: le diverse fasi di un salto (rincorsa-stacco-fase di volo-atterraggio),
potenziamento delle capacità di salto con serie di esercizi mirati.
Apparato respiratorio ( Le vie respiratorie superiori e inferiori – i polmoni – gli scambi
respiratori dai polmoni alle cellule – i movimenti della respirazione – effetti dell’attività
sportiva sulla respirazione.
Apparato cardio-circolatorio (cuore – arterie – vene – piccola e grande circolazione – effetti
dell’attività sportiva sul cuore – i gruppi sanguigni).
Traumatologia e norme di primo soccorso:cosa bisogna sempre fare in caso di incidente;
Asfissia; Emorragie; Shock; Ustioni; Frattura; Colpo di sole e di calore; Avvelenamento.
Alimentazione: i principi nutritivi(carboidrati, proteine, vitamine, lipidi, sali minerali e acqua);
le calorie e il fabbisogno calorico.
Doping: le sostanze che stimolano il S.N.C. (Amfetamine, cocaina, caffeina, adrenalina); le
sostanze analgesiche narcotiche (morfina); le sostanze ormonali e farmaci che aiutano a
liberarle (testosterone, steroidi anabolizzanti).
33
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
1.Conoscere le regole e le
tecniche fondamentali delle
principali attività sportive
individuali e di squadra.
2.Conoscere
i
vantaggi
dell’allenamento.
3.Conoscenza relativa alle norme
elementari di comportamento ai
fini della prevenzione degli
infortuni ed alla prestazione dei
primi soccorsi.
4.Conoscenza di nozioni generali
di anatomia e fisiologia con
particolare
riferimento
all’apparato
respiratorio
e
cardio-circolatorio.
5.Conoscenza
delle
nozioni
fondamentali del rapporto con
l’alimentazione.
6.Conoscenze
delle
principali
droghe
e
loro
uso
nello
sport(Doping)
ABILITA’
Essere in grado di:
1.utilizzare
correttamente
1.Tollerare
gli
un
submassimale
carico
per
un
tempo
strumenti di lavoro.
prolungato.
2.Mettere
in
pratica
le
2.Vincere
resistenze
conoscenze teoriche acquisite.
rappresentate
dal
carico
3.Realizzare progetti autonomi
naturale o da un sovraccarico di
organizzando le conoscenze
entità adeguata.
acquisite.
3.Compiere azioni semplici nel
4.Acquisire una cultura delle
più breve tempo possibile.
attività sportive come costume
4.Eseguire
movimenti
con
di vita.
l’escursione
più
ampia
possibile.
5.Svolgere compiti motori in
situazioni
inusuali
tali
da
richiedere
la
conquista,
il
mantenimento ed il recupero
dell’equilibrio.
METODI
Ho adottato sia il metodo
I
analitico sia quello misto, che
raggiungimento degli obiettivi
non
consiste nel proporre e fare
sono stati: l’uso degli attrezzi,
motorie
eseguire globalmente il gesto,
sia codificati sia di fortuna; i
anche
creando
prima
giochi di squadra, che hanno
compagni
immagine motoria, per poi
creato numerose e diverse
ottenuti rispetto al livello di
passare
situazioni
partenza.
così
alla
una
scomposizione
MEZZI E STRUMENTI
mezzi adottati per
e
che
il
hanno
STRUMENTI DI VERIFICA
La valutazione si e’ basata
solo
sulle
degli
sui
alunni
rapporti
ed
i
ma
con
i
progressi
del gesto, alla sua analisi,
incrementato la capacità di
Quindi
precisandone i dettagli e poi
risolvere complessi problemi
considerato sia gli obiettivi
tornare
motori,il libro di testo, sussidi
generali
audiovisivi.
fisica,
Molte esercitazioni sono state
aspetti biologici, psicomotori
effettuate
ed espressivi, sia gli obiettivi
globalità.
al
gesto
nella
sotto
forma
di
percorsi ginnici, in modo da
la
capacità
valutazione
ha
dell’educazione
che
specifici,
riguardano
che
gli
riguardano
34
creare
situazioni
attività fisiche come l’atletica,
problematiche dal punto di
la ginnastica, ecc.
vista motorio ma libere da
La
vincoli
individualizzata ed ha tenuto
tecnica.
di
regolamentazione
valutazione
e’
stata
conto del risultato in rapporto
alla struttura dell’alunno, alla
sua
età,
sviluppo
al
suo
psicofisico
grado
ed
di
alla
sua personalità.
35
ATTIVITÀ DIDATTICO-DISCIPLINARI
classe V D indirizzo “Elettrotecnica”
anno scolastico 2015/2016
MATERIA: Inglese
DOCENTE: Mulè Amalia
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: fotocopie
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. 2015/16
n. ore 71 su n. 99 previste dal piano di studi
CONTENUTI
The electric motors-linear motors-types of electric motors
Three-phase
Transformers
The transistor
Different types of transformers
Alternators and generators
Electrical machines
Meters and measurements
Logic gates
Operational amplifiers
Operational amplifiers
Different types of amplifiers
Amplifiers
Electromagnetism
PLC
3 argomenti a scelta in riferimento all’attività laboratoriale
36
CONOSCENZE
•
•
•
•
Lessico di base su
argomenti di vita
quotidiana, sociale e
professionale.
Uso del dizionario
bilingue
Regole grammaticali
fondamentali
Corretta pronuncia di
un repertorio di parole
e frasi memorizzate di
uso comune
Semplici modalità di scrittura:
messaggi brevi
OBIETTIVI RAGGIUNTI
COMPETENZE
In complesso buona parte
degli alunni relaziona con una
certa facilità su argomenti
attinenti al proprio ambito
professionale. Lo studio è
legato al libro di testo e a
materiali didattici di volta in
volta forniti dalla sottoscritta:
il patrimonio linguistico è
sufficiente o mediocre in
alcuni casi; buono in altri
Nella comprensione dei testi e
nella produzione in lingua
scritta la classe non incontra
grosse difficoltà, in quanto
agli argomenti tecnici essi
vengono
ben
studiati
e
memorizzati.
La
partecipazione in classe è
stata discontinua, mentre il
lavoro
a
casa
è
stato
incostante
o
scarso.
La
preparazione
acquisita
si
attesta
su
valori
tra
sufficiente e discreto/buono.
•
•
•
ABILITÀ
Comprendere e
ricercare i punti
principali di messaggi
e annunci semplici e
chiari su argomenti di
interesse personale,
quotidiano, sociale o
professionale.
Descrivere in maniera
semplice esperienze
ed eventi, relativi
all’ambito personale e
sociale.
Interagire in
conversazioni brevi e
semplici su temi di
interesse personale
quotidiano, sociale o
professionale.
Scrivere brevi testi di
interesse personale
•
•
quotidiano, sociale o
professionale.
Scrivere correttamente
semplici testi su
tematiche coerenti con
i percorsi di studio.
Riflettere sul sistema e sugli
usi linguistici sui propri
atteggiamenti in rapporto
all’altro
METODI
Lezione frontale ed interattiva.
Svolgimento di attività volte a
potenziare le capacità di
comprensione ed analisi del
testo (traduzioni, riassunti,
esercizi di riempimento),
nonché di produzione in lingua
straniera per l’ ampliamento del
lessico
MEZZI E STRUMENTI
Libro di testo, fotocopie e
materiale scaricato da internet
durante
l’ora
settimanale
trascorsa in laboratorio.
STRUMENTI DI VERIFICA
La verifica tenderà ad
accertare l’appropriazione da
parte dello studente di
elementi cognitivi quali
lessico, strutture e contenuti,
la capacità di uso strumentale
degli stessi a livello
riproduttivo e a livello
creativo e reinterpretativo,
l’impegno costante. Tipologie
di verifica sommativa. Le
verifiche, simili per forma e
37
contenuto alle esercitazioni
utilizzate nello sviluppo delle
unità didattiche, potranno
assumere forme diverse,
secondo le conoscenze e le
abilità oggetto di verifica e
potranno comprendere
38
Attività didattico- disciplinari
classe V D indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”
anno scolastico 2015/2016
MATERIA:
ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA
DOCENTE: DAVIDE MARCIANO’
e
ISIDORO MEDICO
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: G. Conte - Macchine Elettriche - Hoepli
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. 2015/16
n. ore 150 su n. 198 previste dal piano di studi
Contenuti
RICHIAMI SU CIRCUITI IN C.A. e ELETTROMAGNETISMO
· Analizzare e studiare un circuito in c.a
· Grandezze magnetiche e loro legami
· Campi magnetici prodotti da correnti
· Forza magnetomotrice
· Permeabilità magnetica
· Isteresi magnetica
SISTEMI TRIFASE
· Generalità, generazione
· Tipi di collegamenti e proprietà: triangolo-stella con e senza neutro
· Tipi di regime: simmetrico equilibrato e squilibrato, dissimmetrico equilibrato e squilibrato
· Collegamenti: triangolo-stella con e senza neutro (proprietà, diagrammi vettoriali)
· Potenza: attiva, reattiva, apparente, fattore di potenza
· Rifasamento
· C.d.t. di una linea corta
· Risoluzione di reti
· Teorema dell’Invarianza della Potenza rispetto al centro stella
· Metodi di misura della Potenza Attiva, Reattiva e f.d.p. di un carico trifase: Generale – Aron
e Righi
TRASFORMATORE MONOFASE
· Generalità, applicazioni
· Caratteristiche costruttive
· Dati di targa del trasformatore
· Principio di funzionamento
· Circuito equivalente del trasformatore reale, circuito equivalente secondario
· Funzionamento a vuoto e in c.c.
· Variazione di tensione da vuoto a carico
· Potenze, bilancio delle potenze, perdite, rendimento
· Laboratorio: Misura della resistenza degli avvolgimenti di un trasformatore e del rapporto di
trasformazione a vuoto. Prova a vuoto e in corto circuito di un trasformatore monofase
39
TRASFORMATORE TRIFASE
· Generalità, applicazioni
· Caratteristiche costruttive
· Dati di targa
· Principio di funzionamento,
· Circuito equivalente, caratteristiche di funzionamento
· Variazione di tensione da vuoto a carico
· Potenze, perdite, rendimento
· Autotrasformatore monofase e trifase
· Collaudo di un Trasformatore Trifase
Prova a vuoto e in corto circuito
MACCHINA ASINCRONA
· Campi magnetici rotanti
· Generalità sulla macchina asincrona
· Caratteristiche costruttive del m.a.t.
· Dati di targa
· Principio di funzionamento, f.e.m. indotte, scorrimento
· Circuito equivalente, caratteristiche di funzionamento
· Potenze, perdite, rendimento
· Caratteristica meccanica
· Collaudo di un Motore Asincrono trifase
MACCHINA SINCRONA
· Generalità e applicazioni
· Caratteristiche costruttive
· Dati di targa
· Principio di funzionamento: Eccitazione esterna con raddrizzatore trifase
· Circuito equivalente di Behn Eschemburg
· Potenze, perdite, rendimento, variazione di tensione da vuoto a carico
MACCHINA IN C.C.
· Generalità e applicazioni
· Caratteristiche costruttive
· Dati di Targa
· Tipi di eccitazione
· Principio di funzionamento da generatore e da motore
· Circuito Equivalente
· Potenze, perdite, rendimento
40
CONOSCENZE
Caratteristiche e proprietà
magnetiche
Generazione e sequenza
delle fasi di un sistema trifase
Conoscere i tipi e le proprietà
dei collegamenti in trifase
Metodi di misura delle
potenze e del f.d..p. di un
sistema trifase simmetrico ed
equilibrato
· Saper calcolare le
grandezze elettriche di un
carico trifase equilibrato
Metodi di misura della
Potenza Attiva, Reattiva e
f.d.p. di un carico trifase
Caratteristiche generali delle
macchine elettriche
Caratteristiche costruttive
dei trasformatori e circuito
equivalent
Campi magneti rotanti
Caratteristiche costruttive del
motore asincrono trifase e
principio di funzionamento
· Conoscere i dati di targa
· Conoscere
Caratteristiche funzionali
· circuito equivalente
· prove tipiche di collaudo
· caratteristiche di
funzionamento del motore
asincrono trifase in base alle
condizioni di alimentazione e
di carico
· Saper eseguire le prove
tipiche di collaudo
Macchina sincrona e in c.c.::
· caratteristiche costruttive
· principio di funzionamento
· circuito equivalente
OBIETTIVI RAGGIUNTI
COMPETENZE
· Conoscere le
caratteristiche generali delle
macchine elettriche
· Saper risolvere un circuito
elettromagnetico
· Saper stilare la relazione
sulla misura effettuata
· Conoscere la generazione e
la sequenza delle fasi di un
sistema trifase
· Conoscere i tipi e le
proprietà dei collegamenti
· Conoscere i tipi di regime
elettrico
· Conoscere i metodi di
misura delle potenze e del
f.d..p. di un sistema trifase
simmetrico ed equilibrato
· Saper calcolare le
grandezze elettriche di un
carico trifase equilibrato
· Saper risolvere un sistema
trifase simmetrico ed
equilibrato con collegamento
a stella ed a triangolo
· Saper misurare le potenze:
attiva, reattiva ed il f.d.p. di
un circuito trifase tramite
metodo Aron
· Saper stilare la relazione
sulla misura effettuata
· Conoscere le
caratteristiche generali delle
macchine elettriche
· Conoscere i campi di
applicazione dei trasformatori
· Conoscere le
caratteristiche costruttive
· Conoscere i dati di targa
· Conoscere il principio di
funzionamento
· Conoscere le
caratteristiche funzionali
· Conoscere il circuito
equivalente
· Conoscere i criteri generali
di collaudo delle macchine
elettriche
ABILITA’
· Analizzare e studiare
fenomeni e circuiti magnetici
· Analizzare e studiare una
rete trifase simmetrica ed
equilibrata.
· Risolvere una rete trifase
simmetrica ed equilibrata.
· Effettuare semplici misure
su un circuito trifase
simmetrico ed equilibrato.
· Analizzare e studiare un
trasformatore monofase
· Risolvere problemi
riguardanti il trasformatore.
· Effettuare misure sul
trasformatore
· Analizzare e studiare un
trasformatore trifase
· Risolvere problemi
riguardanti il trasformatore
trifase
· Effettuare misure sul
trasformatore trifase
· Analizzare e studiare un
motore asincrono.
· Risolvere problemi
riguardanti il motore
asincrono.
· Effettuare misure sul
motore asincrono.
· Analizzare e studiare un
alternatore.
· Risolvere semplici problemi
riguardanti l’alternatore.
· Analizzare e studiare una
macchina in c.c.
· Risolvere semplici problemi
riguardanti la macchina in c.c.
41
· Conoscere le prove tipiche
di collaudo
· Conoscere e saper
applicare la normativa
· Saper risolvere reti
elettriche in c.a. contenenti
un trasformatore
· Saper eseguire le prove
tipiche di collaudo
· Saper stilare la relazione
sulla misura effettuata
· Conoscere le
caratteristiche generali delle
macchine elettriche
· Conoscere i campi di
applicazione dei trasformatori
trifase
· Conoscere le
caratteristiche costruttive
· Conoscere i dati di targa
· Conoscere il principio di
funzionamento
· Conoscere le
caratteristiche funzionali
· Conoscere il circuito
equivalente
· Conoscere i criteri generali
di collaudo delle macchine
elettriche
· Conoscere le prove tipiche
di collaudo
· Conoscere e saper
applicare la normativa
· Saper risolvere reti
elettriche in c.a. contenenti
un trasformatore trifase
· Saper eseguire le prove
tipiche di collaudo
· Saper stilare la relazione
sulla misura effettuata
· Conoscere i campi magneti
rotanti
· Conoscere i campi di
applicazione della macchina
asincrona
· Conoscere le
caratteristiche costruttive del
motore asincrono trifase
· Conoscere i dati di targa
· Conoscere il principio di
funzionamento
· Conoscere le
caratteristiche funzionali
42
· Conoscere il circuito
equivalente
· Conoscere le prove tipiche
di collaudo
· Saper determinare le
caratteristiche di
funzionamento del motore
asincrono trifase in base alle
condizioni di alimentazione e
di carico
· Saper eseguire le prove
tipiche di collaudo
· Saper stilare la relazione
sulla misura effettuata
Macchina sincrona e in c.c.
· Conoscere le
caratteristiche costruttive
· Conoscere i dati di targa
· Conoscere il principio di
funzionamento
· Conoscere il circuito
equivalente
METODI
MEZZI E STRUMENTI
- Lezione frontale
- Discussione
- Libro di testo
- Lavagna
STRUMENTI DI VERIFICA
- Verifiche orali
- Verifiche scritte
- Verifiche pratiche
43
MATERIA:
DOCENTE:
MATEMATICA
RENATO FORNASERO
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
IL PAESAGGIO MATEMATICO GIALLO – VOLUME I+M+N+O
AUTORE: M. FICO, G. CARIANI, S. MATTINA
EDITORE: LOESCHER
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 2015/16
(al 15 maggio 2016)
n. 77 ore su 99 previste dal piano di studi.
CONTENUTI
1. L’analisi matematica: studio di funzioni ad una variabile
Ripasso sulle derivate immediate
Derivate di funzioni composte
2. Gli integrali
Definizione di integrale indefinito e definito
Tabella degli integrali immediati
Integrazione per inserimento sotto il segno di differenziale
Integrazione per parti
Integrazione di funzioni razionali fratte
3. La statistica
Fasi dell’indagine statistica
Rappresentazioni grafiche dei dati
Diagramma ramo-foglia
Frequenza assoluta, relativa e percentuale
Variazione assoluta, relativa e percentuale
Media, moda e mediana
Campo di variabilità, scarto lineare
Scarto quadratico medio e varianza
4. La probabilità
Concetto di probabilità classica, frequenza e probabilità soggettiva
Eventi semplici ed eventi composti
Eventi dipendenti ed indipendenti, compatibili ed incompatibili
Teoremi di calcolo della probabilità di eventi composti
5. CLIL
Definite integrals, indefinite integrals. Antiderivative
Statistics: mean , mode, median. Variability
Probability: experiments, outcomes and sample space.
Simple event and compound event. Subjective probability
44
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
ABILITA’
Conoscere le derivate e gli
integrali immediati.
Conoscere le fasi di
un’indagine statistica.
Riconoscere i vari tipi di
rappresentazione grafica
Conoscere la frequenza
assoluta, relativa e
percentuale
Conoscere il significato di
media, moda e mediana di
una distribuzione di dati.
Conoscere la variazione tra
due dati (assoluta, relativa e
percentuale)
Conoscere la variabilità di una
distribuzione
Conoscere la probabilità
classica, frequentista e
soggettiva
Conoscere i vari tipi di eventi
Conoscere i teoremi sulla
probabilità
Saper riconoscere e quindi
derivare funzioni comuni;
saper derivare le funzioni
composte.
Saper distinguere i vari tipi di
integrali, utilizzando il
metodo più opportuno di
integrazione.
metodi di risoluzione
adeguati.
Saper distinguere le fasi di
un’indagine statistica
Saper distinguere ed usare in
maniera appropriata i vari tipi
di grafici per rappresentare i
dati
Saper distinguere tra
frequenza assoluta, relativa e
percentuale
Saper distinguere media,
moda e mediana
Saper distinguere tra
variazione assoluta, relativa e
percentuale
Saper distinguere campo di
variabilità, scarto lineare,
scarto quadratico medio e
varianza
Saper distinguere tra i vari
tipi di probabilità
Saper distinguere i vari tipi di
eventi
Saper svolgere derivate e
integrali delle funzioni più note
Saper costruire una tabella
semplice o a doppia entrata da
una serie di dati
Saper scegliere e disegnare un
grafico da una serie di dati
Saper calcolare la frequenza
nelle sue varie forme
Saper calcolare media, moda e
mediana da una serie di dati
Saper calcolare la variazione
assoluta, relativa e percentuale
Saper calcolare i più importanti
indici di variabilità
Saper commentare i vari indici di
una serie di dati effettuando
anche confronti
Saper calcolare la probabilità
classica, frequentista e
soggettiva
Saper applicare la probabilità ai
vari tipi di eventi
Saper applicare i teoremi della
probabilità ai vari tipi di eventi
45
METODI
MEZZI E STRUMENTI
STRUMENTI DI VERIFICA
L'insegnamento della
Sono stati utilizzati appunti,
Le verifiche formative sono
matematica è stato condotto
dispense e strumenti
state effettuate alla fine di
per problemi, cioè si è
multimediali. Ci si è serviti
ciascuna Unità Didattica. Gli
prospettata, ove possibile, una
anche dello strumento
alunni sono stati interpellati
situazione problematica che ha
Internet per effettuare
dal posto per accertare le
stimolato gli alunni a formulare
ricerche e seguire lezioni
difficoltà di comprensione, di
ipotesi di soluzione, a ricercare
universitarie in
analisi, dl ricerca e di
un procedimento risolutivo e
videoconferenza per poter
esposizione.
scoprire le relazioni
apprendere meglio
Le verifiche sommative hanno
matematiche che sottostanno al
determinati concetti e per
avuto luogo tramite i compiti
problema per poi generalizzare
constatare la differenza tra gli
scritti e le interrogazioni di
e formalizzare il risultato
argomenti proposti a livello
tipo tradizionale al fine di
conseguito e collegarle con le
scolastico ed universitario.
accertare per ogni singolo
nozioni teoriche già apprese. E’
allievo il grado di maturità
stato utilizzato anche il metodo
raggiunto, il grado di
deduttivo, partendo da regole
preparazione conseguito, la
generali che si sono
capacità di ragionamento, il
successivamente concretizzate e
metodo di studio. Sono state
applicate a casi particolari.
inoltre utilizzate le prove
I concetti sono stati introdotti
oggettive di verifica (test a
con gradualità e le lezioni
risposta multipla o vero-falso)
teoriche sono state integrate da
per abituare gli alunni ai nuovi
esercitazioni in aula per fare
metodi di valutazione e i
acquisire rapidità di calcolo e
compiti in gruppo per
sicurezza nei procedimenti.
stimolare in loro lo spirito
cooperativo.
46
PROGRAMMA CLIL
(MATEMATICA)
A.S. 2015/2016
1. Premessa
Le norme transitorie del 25 luglio 2014 MIURAOODGOS prot. n. 4969 prevedono l’avvio
in ordinamento dell’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera
secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto e quinto anno dei Licei linguistici e nel
quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici.
L’avvio graduale di tale metodologia può essere sperimentato anche dai docenti
comunque impegnati nei percorsi di formazione per acquisire il livello B2.
2. Scelte metodologiche e scelte di materiali
L’unità di apprendimento oggetto di questa programmazione è rivolta ad una quinta
classe di un istituto tecnico industriale ad indirizzo elettrotecnico e riguarda la disciplina
Matematica; essa nel corso dell’Esame di Stato sarà a carico del Commissario interno,
pertanto sarà oggetto della terza prova e del colloquio.
Il numero di ore previsto è pari al 20% del monte ore, corrispondente a 20 ore e gli
argomenti riguarderanno gli integrali, la statistica e la probabilità.
Per quanto riguarda la metodologia, si è optato per la visione di filmati tratti
dall’immenso archivio qual è YouTube oppure dai MOOC KhanAcademy, Coursera e
simili. L’unica difficoltà risiede nel fatto che la maggior parte dei materiali è in American
English mentre in misura inferiore si trovano in British English, ma quasi tutti sono con i
sottotitoli. In secondo luogo, la connessione internet non sempre è efficace per cui è
necessario avere scaricato il video preventivamente sul proprio pc prima di mostrarlo
alla classe.
La vastità del materiale presente non pone comunque problemi di scelta e, soprattutto
per la statistica e la probabilità, è possibile trovare un gran numero di video di livello
adeguato a questa classe quinta.
47
3. Sviluppo delle competenze linguistiche
Si è focalizzata l’attenzione sullo sviluppo delle abilità di comprensione del linguaggio
specifico, di quelle orali di interazione e di produzione di testi scritti.
Il ruolo principale del docente DNL è stato quello di facilitare le condizioni per
permettere allo studente di usare effettivamente e in maniera efficace le abilità
acquisite per veicolare non solo informazioni di base (BICS) ma in particolare contenuti
più articolati (CALP) essendo in una classe quinta ed in prossimità dell’Esame di Stato.
Il punto di partenza di queste Unità Didattiche è quello di visionare dei filmati che
coinvolgono le abilità di ascolto e di comprensione; alla base ci sta però la conoscenza
dell’argomento precedentemente sviluppato in lingua italiana e pertanto può essere
utile confrontare le definizioni e la modalità di spiegazione del concetto nonché l’uso di
termini specifici differenti.
Non è previsto l’intervento del docente di Lingua straniera in codocenza ma
eventualmente solo all’interno dell’ora di Inglese per chiarimenti su alcuni aspetti del
lessico, della grammatica o della pronuncia.
4. Schema dell’unità 1
GLI INTEGRALI
Lingua straniera
Inglese
Disciplina
Matematica
Tipo di scuola e classe
Istituto tecnico industriale
Classe Quinta
Prerequisiti linguistici
A2
48
Prerequisiti disciplinari
Prerequisiti trasversali
Argomenti specifici
Il docente della disciplina ha trattato i seguenti
argomenti prima dell’unità CLIL:
• Le derivate
• Calcolo delle derivate immediate
• Definizione di integrale indefinito e definito
• Calcolo degli integrali immediati
Conoscenze informatiche di base:
•
•
•
•
•
•
Saper navigare su internet
Saper creare una presentazione
Saper creare una mappa concettuale
Definizione di integrale indefinito
Definizione di integrale definito
Calcolo di semplici integrali
Tempi di attuazione
Secondo quadrimestre
Scansione dell’U.D.
4 ore suddivise in:
Lettura delle formule e delle espressioni
matematiche
• Visione di filmati
• Regole grammaticali da sottolineare
• Verifica scritta
• Pronuncia
Unità CLIL all’interno del modulo “Integrali”; il
docente DNL assume il ruolo di conduttore e fa da
supporto al docente di lingua straniera.
•
Modalità operative
Gestione della classe
Strumenti e materiali
Il docente di DNL in base alle tipologia di attività
previste fa da coordinatore o da veicolare delle
nozioni previste, suddividendo l’ora di lezione in una
prima parte esplicativa, una seconda parte con
l’attività vera e propria e l’ultima parte traendo le
conclusioni e chiarendo eventuali concetti rimasti
poco chiari.
•
•
•
•
•
•
•
•
Lavagna multitouch Philips con pc e
collegamento internet
Fotocopie di testi sull’alfabeto, sulla lettura
delle
formule
matematiche
e
sulle
espressioni
Materiale video YouTube, Khan Academy,
Coursera
Presentazioni PowerPoint
Software per mappe concettuali Mindomo
Lavagna normale
Dizionario monolingue Oxford
Dizionario Oxford Mathematics
49
Obiettivi specifici di LS
•
•
•
•
•
Obiettivi specifici di disciplina
Strategie e metodologie
Abilità linguistiche coinvolte
Obiettivi cognitivi trasversali,
abilità di studio e di
apprendimento
•
Comprendere i concetti di base sugli integrali
Saper distinguere tra integrali indefiniti e
definiti
Saper calcolare semplici integrali
•
•
•
•
•
•
•
•
Visione di video
Lezione interattiva
Lavoro individuale in classe e a casa
Lavori di gruppo in classe
Utilizzo di internet
Lavoro a coppie in classe
Comprensione e produzione scritta ed orale
Interazione orale
•
•
•
•
Prendere appunti
Schematizzare
Riassumere (scritto e orale)
Interpretare
e
focalizzare
meglio
un
argomento attraverso la visione di filmati
Dedurre lessico sconosciuto attraverso il
contesto
Decodificare
ed
analizzare
un
testo
attraverso
l’individuazione
di
concetti
fondamentali
Relazionare
Preparare e presentare mappe
Utilizzare costruttivamente gli strumenti
informatici e tecnologici
Apprendere a collaborare e negoziare con i
compagni
Prestare e ricevere aiuto nello svolgimento di
compiti
Domande di elicitazione
Visione mirata ed organizzata di brevi filmati
Confronti e discussioni tra i compagni di
classe
Lavoro a coppie con lettura e decodifica a
turno
Lettura e analisi di testi
Analisi del lessico (chunks) attraverso vari
tipi di esercizi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tecniche ed attività
Potenziare le abilità di ascolto e di
comprensione di formule matematiche e di
testi di tipo scientifico
Acquisire
abilità
orali
di
produzione,
comprensione ed interazione
Sviluppare e migliorare le abilità scritte di
produzione e comprensione
Arricchire il lessico specifico
Comprendere lo stile ed il contenuto di testi
scientifici
•
•
•
•
•
•
50
•
•
•
•
Verifica e valutazione
•
•
•
•
Domande aperte e chiuse
Attività
di
scrittura,
riscrittura
e
transcodificazione
Lavoro di ricerca e rielaborazione a casa
Preparazione di presentazioni, relazioni,
mappe
Verifica di produzione scritta
Verifica orale
Test scritto con risposte chiuse ed aperte
Verifica di ascolto con brani della durata di
pochi secondi
5. Schema dell’unità 2
LA STATISTICA
Lingua straniera
Inglese
Disciplina
Matematica
Tipo di scuola e classe
Istituto tecnico industriale
Classe Quinta
Prerequisiti linguistici
A2
Prerequisiti disciplinari
Il docente della disciplina ha trattato i seguenti
argomenti prima dell’unità CLIL:
• La statistica descrittiva
• Fasi dell’indagine statistica
• Media, moda e mediana
Conoscenze informatiche di base:
Prerequisiti trasversali
51
Tempi di attuazione
• Saper navigare su internet
• Saper creare una presentazione
• Saper creare una mappa concettuale
• Popolazione e campione
• Tabelle semplici e a doppia entrata
• Rappresentazioni grafiche dei dati
• Media, moda e mediana
Secondo quadrimestre
Scansione dell’U.D.
8 ore suddivise in:
Argomenti specifici
Spiegazione delle formule statistiche più
comuni ed esempi
• Visione di filmati
• Regole grammaticali da sottolineare
• Verifica scritta
• Pronuncia
• Relazione finale
Unità CLIL all’interno del modulo “Statistica”; il
docente DNL assume il ruolo di conduttore e fa da
supporto al docente di lingua straniera.
•
Modalità operative
Gestione della classe
Strumenti e materiali
Il docente di DNL in base alle tipologia di attività
previste fa da coordinatore o da veicolare delle
nozioni previste, suddividendo l’ora di lezione in una
prima parte esplicativa, una seconda parte con
l’attività vera e propria e l’ultima parte traendo le
conclusioni e chiarendo eventuali concetti rimasti
poco chiari.
•
•
•
Obiettivi specifici di LS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lavagna multitouch Philips con pc e
collegamento internet
Fotocopie di testi sull’alfabeto, sulla lettura
delle formule statistiche e sulle espressioni
Materiale video YouTube, Khan Academy,
Coursera
Presentazioni PowerPoint
Software per mappe concettuali Mindomo
Lavagna normale
Dizionario monolingue Oxford
Dizionario Oxford Mathematics
Potenziare le abilità di ascolto e di
comprensione di formule matematiche e di
testi di tipo scientifico
Acquisire
abilità
orali
di
produzione,
comprensione ed interazione
Sviluppare e migliorare le abilità scritte di
produzione e comprensione
Arricchire il lessico specifico
52
Obiettivi specifici di disciplina
•
Comprendere lo stile ed il contenuto di testi
scientifici
•
Comprendere cosa è e a cosa serve la
statistica
Capire le fasi di un’indagine statistica
Capire la differenza tra popolazione e
campione
Saper raggruppare i dati in tabelle
Saper leggere e rappresentare i dati
Saper calcolare media, moda e mediana
Saper interpretare i dati
Visione di video
Lezione interattiva
Lavoro individuale in classe e a casa
Lavori di gruppo in classe
Utilizzo di internet
Lavoro a coppie in classe
Comprensione e produzione scritta ed orale
Interazione orale
•
•
Strategie e metodologie
Abilità linguistiche coinvolte
Obiettivi cognitivi trasversali,
abilità di studio e di
apprendimento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tecniche ed attività
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prendere appunti
Schematizzare
Riassumere (scritto e orale)
Interpretare
e
focalizzare
meglio
un
argomento attraverso la visione di filmati
Dedurre lessico sconosciuto attraverso il
contesto
Decodificare
ed
analizzare
un
testo
attraverso
l’individuazione
di
concetti
fondamentali
Relazionare
Preparare e presentare mappe
Utilizzare costruttivamente gli strumenti
informatici e tecnologici
Apprendere a collaborare e negoziare con i
compagni
Prestare e ricevere aiuto nello svolgimento di
compiti
Domande di elicitazione
Visione mirata ed organizzata di brevi filmati
Confronti e discussioni tra i compagni di
classe
Lavoro a coppie con lettura e decodifica a
turno
Lettura e analisi di testi
Analisi del lessico (chunks) attraverso vari
tipi di esercizi
Domande aperte e chiuse
Attività
di
scrittura,
riscrittura
e
transcodificazione
Lavoro di gruppo con ricerca e rielaborazione
a casa
Preparazione di presentazioni, relazioni,
53
Verifica e valutazione
•
•
•
•
mappe
Verifica di produzione scritta
Verifica orale
Test scritto con risposte chiuse ed aperte
Verifica di ascolto con brani della durata di
pochi secondi
6. Schema dell’unità 3
LA PROBABILITA’
Lingua straniera
Inglese
Disciplina
Matematica
Tipo di scuola e classe
Istituto tecnico industriale
Classe Quinta
Prerequisiti linguistici
A2
Prerequisiti disciplinari
Il docente della disciplina ha trattato i seguenti
argomenti prima dell’unità CLIL:
• La probabilità
• Gli eventi
Prerequisiti trasversali
Conoscenze informatiche di base:
Tempi di attuazione
• Saper navigare su internet
• Saper creare una presentazione
• Saper creare una mappa concettuale
• Probabilità
• Vari tipi di probabilità
• Gli eventi
• Vari tipi di eventi
• Teoremi sulla probabilità
Secondo quadrimestre
Scansione dell’U.D.
8 ore suddivise in:
Argomenti specifici
54
Modalità operative
Gestione della classe
Strumenti e materiali
• Spiegazione del concetto di probabilità
• Spiegazione di evento e dei vari tipi di eventi
• Spiegazione dei teoremi sulla probabilità
• Visione di filmati
• Regole grammaticali da sottolineare
• Pronuncia
Unità CLIL all’interno del modulo “Probabilità”; il
docente DNL assume il ruolo di conduttore e fa da
supporto al docente di lingua straniera.
Il docente di DNL in base alle tipologia di attività
previste fa da coordinatore o da veicolare delle
nozioni previste, suddividendo l’ora di lezione in una
prima parte esplicativa, una seconda parte con
l’attività vera e propria e l’ultima parte traendo le
conclusioni e chiarendo eventuali concetti rimasti
poco chiari.
•
•
•
Obiettivi specifici di LS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obiettivi specifici di disciplina
•
•
•
•
•
Strategie e metodologie
•
•
•
•
•
•
Lavagna multitouch Philips con pc e
collegamento internet
Fotocopie di testi sugli enunciati della
probabilità
Materiale video YouTube, Khan Academy,
Coursera
Presentazioni PowerPoint
Software per mappe concettuali Mindomo
Lavagna normale
Dizionario monolingue Oxford
Dizionario Oxford Mathematics
Potenziare le abilità di ascolto e di
comprensione di formule matematiche e di
testi di tipo scientifico
Acquisire
abilità
orali
di
produzione,
comprensione ed interazione
Sviluppare e migliorare le abilità scritte di
produzione e comprensione
Arricchire il lessico specifico
Comprendere lo stile ed il contenuto di testi
scientifici
Comprendere cosa è e a cosa serve la
probabilità
Capire i vari tipi di probabilità
Capire la differenza tra i vari tipi di eventi
Saper distinguere i vari eventi
Saper applicare la probabilità ai vari tipi di
eventi
Conoscere e saper applicare i vari teoremi
Visione di video
Lezione interattiva
Lavoro individuale in classe e a casa
Lavori di gruppo in classe
Utilizzo di internet
55
Abilità linguistiche coinvolte
Obiettivi cognitivi trasversali,
abilità di studio e di
apprendimento
•
•
•
Lavoro a coppie in classe
Comprensione e produzione scritta ed orale
Interazione orale
•
•
•
•
Prendere appunti
Schematizzare
Riassumere (scritto e orale)
Interpretare
e
focalizzare
meglio
un
argomento attraverso la visione di filmati
Dedurre lessico sconosciuto attraverso il
contesto
Decodificare
ed
analizzare
un
testo
attraverso
l’individuazione
di
concetti
fondamentali
Relazionare
Preparare e presentare mappe
Utilizzare costruttivamente gli strumenti
informatici e tecnologici
Apprendere a collaborare e negoziare con i
compagni
Prestare e ricevere aiuto nello svolgimento di
compiti
Domande di elicitazione
Visione mirata ed organizzata di brevi filmati
Confronti e discussioni tra i compagni di
classe
Lavoro a coppie con lettura e decodifica a
turno
Lettura e analisi di testi
Analisi del lessico (chunks) attraverso vari
tipi di esercizi
Domande aperte e chiuse
Attività
di
scrittura,
riscrittura
e
transcodificazione
Lavoro di gruppo con ricerca e rielaborazione
a casa
Preparazione di presentazioni, relazioni,
mappe
Verifica orale
Verifica di ascolto con brani della durata di
pochi secondi
•
•
•
•
•
•
•
Tecniche ed attività
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verifica e valutazione
•
•
7. Bibliografia e sitografia
Unità 1
Brian s. Thomson, The Calculus Integral (www.classicalrealanalysis.com)
YOUTUBE: youtu.be/UN54rR4T4MQ (BASIC ANTIDERIVATIVES EXAMPLES)
KHANACADEMY: www.khanacademy.org (DEFINITE INTEGRALS)
COURSERA: www.coursera.org (CALCULUS ONE)
56
WIKIPEDIA: en.wikipedia.org
Unità 2 e 3
Prem. S. Mann, Introductory Statistics, John Wiley & Sons
YOUTUBE youtu.be/daIb2VF1i3M (STATISTIC LESSONS)
MIT:
http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-05-introduction-to-probability-andstatistics-spring-2014/
WIKIPEDIA: en.wikipedia.org
KHANACADEMY: www.khanacademy.org (STATISTICS)
COURSERA:www.coursera.org/learn/basic-statistics/home/welcome (STATISTICS)
57
Attività didattico- disciplinari
classe V D indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”
anno scolastico 2015/2016
MATERIA: T.P.S.E.E.
DOCENTI: Prof. Dott. Ing. Salvatore Antonio Ugo Bonsignore
Prof. P. I. Vincenzo Valenza
Classe V D Elettrotecnica ed Elettronica
SICUREZZA SUL LAVORO
- Concetti introduttivi
- La valutazione dei rischi, elementi definitori
- La valutazione dei rischi, metodologie operative
- Metodo semiquantitativo per la valutazione dei rischi
- Utilizzo delle liste di controllo
- Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori
- Il testo unico sulla sicurezza del lavoro
- La valutazione dei rischi ai sensi del testo unico sulla sicurezza del lavoro
- Altri importanti riferimenti normativi
- Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale
- Il datore di lavoro
- I dirigenti e i preposti
- I lavoratori
- I progettisti, i fabbricanti e gli installatori
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Il medico competente e la sorveglianza sanitaria
- Gli addetti antincendio e primo soccorso e la gestione delle emergenze
- Apparato sanzionatorio
- L’informazione, la formazione e l’addestramento
- I dispositivi di protezione individuale
- La segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- I principali tipi di rischi in ambiente lavorativo
- I rischi per la sicurezza dei lavoratori
- I rischi per la salute dei lavoratori
- Fattori ergonomici, organizzativi e gestionali
58
- Il rischio elettrico
CALCOLO ELETTRICO DI LINEE CON CARICHI CONCENTRATI E CONVENZIONALI
- Determinazione del carico convenzionale
- Diagramma di carico, potenza convenzionale e corrente d’impiego
- Fattore di utilizzazione
- Fattore di contemporaneità
- Potenza convenzionale dei gruppi di prese
- Potenza convenzionale dei motore elettrici
- Potenza convenzionale totale di un impianto
- Somma delle potenze convenzionali dei vari circuiti
- Applicazione di un coefficiente di riduzione globale
- Uso della potenza specifica
- Correnti d’impiego termicamente equivalente
- Condutture elettriche
- Definizioni e classificazione
- Parametri elettrici di una linea
- Parametri elettrici unitari
- Linee con parametri trasversali trascurabili
- Rendimento e variazione di tensione per le linee RL
- Rendimento di linea
- Variazione di tensione
- Caduta di tensione industriale
- Condotti sbarre
- Classificazione e struttura di cavi elettrici
- Caratteristiche funzionali dei cavi elettrici
- Tensioni nominali d’isolamento
- Temperature caratteristiche
- Portata in regime permanente
- Comportamento in caso d’incendio
- Parametrici elettrici dei cavi
- Modalità di posa delle condutture elettriche
- Portata dei cavi per bassa tensione posati in aria
- Portata dei cavi per bassa tensione con posa interrata
- Portata dei cavi con conduttori in alluminio
- Criteri di scelta dei cavi
- Metodi per il dimensionamento e la verifica delle condutture elettriche
- Calcolo di progetto e di verifica
- Calcolo della perdita di potenza ammissibile
- Metodo della temperatura ammissibile
- Caso del conduttore di sezione circolare
- Caso del conduttore di sezione rettangolare
- Metodo della caduta di tensione ammissibile
59
- Metodo della caduta di tensione unitaria
- Metodo dei momenti amperometrici: linea con carico di estremità
- Metodo dei momenti amperometrici: linea con carichi distribuiti
- Metodo dei momenti amperometrici: linea con carichi diramati
- Sezioni minime delle condutture elettriche
- Sovracorrenti
- Sovraccarico e cortocircuito
- Sollecitazione termica per sovraccarico
- Corrente di circuito
- Fattore di cresta
- Sollecitazione termica per cortocircuito
- Sforzi elettrodinamici
- Corrente continua
- Corrente alternata monofase
- Corrente alternata trifase, con conduttori disposti in piano
- Corrente alternata trifase, con conduttori disposti ai vertici di un triangolo equilatero
- Calcolo della corrente di cortocircuito
- Potenza di cortocircuito
- Impedenza della rete di alimentazione
- Impedenza del trasformatore
- Corrente di cortocircuito per una linea monofase
- Corrente di cortocircuito per una linea trifase
- Linea trifase alimentata da un trasformatore MT/BT
- Tabelle e diagrammi per la valutazione rapida della corrente di cortocircuito
- Corrente di cortocircuito minima convenzionale
- Linea con conduttore neutro non distribuito
- Linea con conduttore neutro distribuito
- Protezione delle sovracorrenti
- Classificazione degli apparecchi di manovra e di protezione delle sovracorrenti
- Modalità di estinzione dell’arco elettrico
- Caratteristiche funzionali degli interruttori
- Interruttori automatici per bassa tensione
- Sganciatori di sovracorrente
- Caratteristiche tecniche degli interruttori automatici per bassa tensione
- Fusibili e loro caratteristiche
- Protezione delle condutture elettriche contro il sovraccarico
- Installazione dei dispositivi di protezione del sovraccarico
- Protezione delle condutture elettriche contro il cortocircuito
- Protezione unica e distinta
- Selettività delle protezioni contro le sovracorrenti
- Applicazioni
- Determinazione delle potenze convenzionali e delle correnti d’impiego per un appartamento
- Determinazione delle potenze convenzionali e delle correnti d’impiego per un capannone
industriale
- Dimensionamento delle linee uscenti dal quadro f.m. di un impianto elettrico industriale e
scelta dei dispositivi di protezione contro le sovracorrenti
60
CALCOLO ELETTRICO DI LINEE CON CARICHI CONCENTRATI E CONVENZIONALI
-
linee aperte con carichi distribuiti
linee aperte diramate
linee alimentate alle due estremità
linee ad anello
fattore di utilizzazione e di contemporaneità
valutazione del carico convenzionale per utenze civili ed industriali
calcoli di progetto e di verifica
criterio della caduta di tensione ammissibile
criterio della temperatura ammissibile
criterio della perdita di potenza ammissibile
esercizi di applicazione
PROTEZIONE NEGLI IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI DI MESSA A TERRA
-
percezione della corrente elettrica
effetti fisiopatologici
limite di pericolosità della tensione
dispersione a terra della corrente
tensione di contatto e di contatto a vuoto
calcolo della resistenza di terra per vari tipi di dispersori
dispersori in parallelo
resistività del terreno
classificazione dei sistemi in relazione al collegamento a terra
impianti di terra e prescrizioni relative
esecuzione dell’impianto di terra. L’interruttore differenziale
protezione nel sistema TT
protezione nel sistema TN
protezione dei contatti indiretti e diretti
esercizi di applicazione
SOVRACORRENTI E SISTEMI DI PROTEZIONE
-
sollecitazione termica per sovraccarico
fattore di cresta
sollecitazione termica per c.to. c.to
sollecitazione elettrodinamica
classificazione degli apparecchi di manovra
arco elettrico e sue modalità d’estinzione
tipi d’interruttori
caratteristiche funzionali degli interruttori
sezionatori
classificazione dei relè
relè termico
relè elettromagnetico
interruttori automatici di bassa tensione
protezione delle condutture contro i sovraccarichi
61
-
installazione dei dispositivi di protezione
protezione delle condutture contro i corto circuiti
determinazione delle correnti di c.c.
protezione in serie
protezione unica per sovraccarico e c.c.
protezione distinta per sovraccarico e c.c.
protezione dei conduttori di fase e di neutro
la selettività nella protezione dalle sovracorrenti
protezioni dei motori asincroni trifasi
RIFASAMENTO
-
cause di un basso fattore di potenza
conseguenze di un basso fattore di potenza
situazione tariffaria
criteri di scelta del collegamento
modalità di rifasamento
caratteristiche delle batterie di condensatori
esercizi di applicazione
CABINE ELETTRICHE E SISTEMI DI DISTRIBUZIONE A MEDIA E BASSA TENSIONE
-
classificazione.
gruppo di misure.
lato media tensione. Dimensionamento dei componenti media tensione.
trasformatore media/bassa tensione.
lato b.t. Dimensionamento dei componenti b.t. Protezioni e loro scelta.
impianto di terra.
progetto di massima di una cabina.
baricentro elettrico di un impianto.
criteri di scelta del sistema di distribuzione a m.t.
distribuzione in b.t.
realizzazioni costruttive per la distribuzione in b.t. Quadri elettrici b.t.
ILLUMINOTECNICA
-
impianti elettrici per illuminazione interna
grandezze fotometriche
caratteristiche delle sorgenti luminose
lampade elettriche
calcolo degli impianti interni con il metodo del flusso globale
calcolo degli impianti interni con il metodo della curva fotometrica
62
NORME CEI, PROBLEMI DI AFFIDABILITA’ E SICUREZZA
Il CEI:
- Rischio, sicurezza e affidabilità
- effetti della corrente elettrica sul corpo umano
- prevenzioni infortuni
- soccorsi d’urgenza, ustioni, organizzazione del pronto soccorso.
PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI ACCIDENTALI
- Contatti diretti e indiretti, la messa a terra degli impianti elettrici, resistenza di terra, sistemi di
messa a terra, generalità sulle protezioni contro i guasti verso terra, le protezioni
amperometriche di terra, principio di funzionamento delle protezioni differenziali, sistemi di
protezioni passivi, protezione contro i contatti diretti.
PROGRAMMAZIONE DEL PLC
- L’algebra di Boole applicata all’automazione, fondamenti di STEP 5, istruzione del linguaggio
STEP 5, funzioni OR,AND,AND e OR ,OR preceduta da AND, AND preceduta da OR, funzione di
segnale di stato “O” ,funzione di memorizzazione: reset prevalente e set prevalente;
- Funzione di temporizzazione, funzione di conteggio, funzione di confronto. Esempi applicativi;
- Progettazione di quadri elettrici;
- Progettazione dell’impianto elettrico.
PROGETTO PERSONALE
- Progetto personale.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Conoscere i metodi di progettazione di una linea elettrica, gli aspetti teorici sul riscaldamento
dei conduttori e la normativa elettrica di settore.
Conoscere le problematiche inerenti la protezione delle linee e le problematiche inerenti la
protezione delle persone dai contatti diretti e indiretti. Conoscere i vari elementi di un impianto
63
di rifasamento. Progettare e proteggere una linea elettrica scegliendo le opportune protezioni
dai contatti diretti ed indiretti. Essere in grado di progettare un impianto (dalla fase di analisi
della normativa – calcoli – elettrici - produzione della relazione e dei disegni).
Conoscenza dei controlli macchina mediante l’utilizzo di software comandato da PLC.
Padronanza nella realizzazione di impianti elettrici, con particolare cura delle protezioni di
sicurezza di impianti di tipo speciale, quali automazione di cancelli azionati elettricamente ed
impianti semaforici;
Gestione impianti civili domestici, mediante il cablaggio strutturato demotico. Riconoscimento e
distinzione degli impianti elettrici, dei componenti, delle caratteristiche; utilizzo di strumenti di
verifica degli impianti.
64
SIMULAZIONI TERZA PROVA ESAME DI STATO
1^ SIMULAZIONE DI TERZA PROVA A.S. 2015/16
Classe Quinta Sez. D
TIPOLOGIA C(32 quesiti a risposta multipla)
DISCIPLINE:Storia, Matematica,TPSEE, Sistemi automatici, Inglese
DURATA DELLA PROVA: 90 minuti
COGNOME
NOME
DATA E FIRMA
VALUTAZIONE:quesiti a risposta multipla punti 0,375 per ogni risposta esatta e punti 0 per
ogni risposta errata o non data; quesiti a risposta breve max punti 1,5. Nelle risposte multiple
non sono ammesse correzioni, abrasioni, cancellature o risposte in numero superiore a uno.
E’ consentito l’uso della calcolatrice e del vocabolario di Inglese.
QUESITI A RISPOSTA APERTA
DESCRITTORI
INDICATORI
Risposta ottima o
eccellente
Risposta discreta
o buona
Risposta
sufficiente
Risposta
insufficiente
Risposta
estremamente
carente
1,5
1,25
1
0,75
0,50
Esecuzione del
compito
Sa rispondere alle
indicazioni del
compito in modo
completo e
articolato
Sa rispondere
alle indicazioni
del compito in
modo completo
Sa rispondere
alle indicazioni
del compito in
modo essenziale
Sa rispondere alle
indicazioni del
compito in modo
incompleto
Sa rispondere
alle indicazioni
del compito in
modo scarso o
nullo
Correttezza
morfosintattica
Usa le strutture
morfosintattiche in
modo articolato,
corretto ed
appropriato
Usa le strutture
morfosintattiche
in modo
abbastanza
articolato e
corretto, con
saltuarie
inesattezze
Usa le strutture
morfosintattiche
commettendo
errori che
tuttavia non
impediscono la
comprensibilità
globale del testo
Usa le strutture
morfosintattiche
con difficoltà e
commette errori
che
compromettono la
comprensibilità del
testo
Non sa usare le
strutture
morfosintattich
e. Il testo
risulta non
comprensibile
Efficacia
comunicativa
Sa costruire un
discorso coerente e
coeso; padroneggia
l’argomento che
espone in maniera
personale e con
accuratezza
linguistica e
lessicale
Sa costruire un
discorso
generalmente
coerente e
coeso, in modo
abbastanza
efficace e
personale seppur
con qualche
saltuaria
imprecisione
Sa costruire un
discorso
comprensibile
ma a volte non
sempre
scorrevole;
risponde
sinteticamente e
senza apporti
personali
Non riesce a
costruire un
discorso coerente e
coeso per lo scarso
e/o inappropriato
utilizzo dei
connettori logici
Non sa
costruire un
discorso
comprensibile
rispetto allo
scopo
65
GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DELLA PROVA
COGNOME _______________
DISCIPLINA
NOME ________________
Quesiti
a risposta multipla
1
2
3
4
5
6
7
8
Quesiti
a risposta aperta
1
2
TOTALI
Storia
Matematica
TPSEE
Sistemi
Inglese
Approssimazione al voto successivo
per frazioni uguali o superiori a 0,5
VALUTAZIONE
PROVA
___ /
15
66
SISTEMI
1
Il seguente diagramma di Bode delle fasi
ω
45º
90º
Rappresenta:
a. Un polo all’origine
□
b. Un polo qualunque
□
c. Uno zero qualunque
□
d. Uno zero all’origine
□
67
2 Il seguente diagramma di Bode dei modulo
ω
Rappresenta:
a. Un polo all’origine
□
b. Un polo qualunque
□
c. Uno zero qualunque
□
d. Uno zero all’origine
□
68
3
Un sistema del secondo ordine si hanno due poli complessi e coniugati per:
a:
per ζ=1
□
b:
per ζ>1
□
c:
per ζ<1
□
d:
per ζ grande
□
4. Per Il sistema con retroazione di fig.
A
B
AA
B
H
H
la funzione di trasferimento è:
a:
□
b:
□
c:
□
d:
□
5
Per Il sistema con retroazione unitaria di fig.
E
A
A
G
G
la funzione di trasferimento dell’errore è:
a:
□
b:
□
c:
□
d:
□
6. Per lo schema di figura:
C
R1
R2
Per frequenze prossime allo zero la funzione di trasferimento tende a:
a:
□
b:
□
c:
□
d:
□
7.
Per lo schema di figura:
C
R1
R2
Per frequenze prossime ad infinito la funzione di trasferimento tende a:
a:
□
b:
□
c:
□
d:
□
8. Per amplificatore operazionale di figura
L’amplificazione è
a.2
b.1
c.3
d.0
□
□
□
□
STORIA
1)Che cosa si intende per guerra di “posizione” sul fronte occidentale durante il Primo Conflitto
Mondiale?
□azioni velocemente infiltranti nel territorio nemico
□rapido successo dell’artiglieria e della fanteria
□battaglie sanguinose in campo aperto
□fronteggiarsi prolungato degli eserciti difesi dalle trincee
2)L’intervento degli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale fu motivato da:
□mire territoriali nella zona dei Balcani
□rivalità in campo coloniale con l’Impero austriaco
□prestiti erogati a Francia e Inghilterra
□scontro con la Germania per la supremazia sui mari
3)In termini militari, cosa evoca la località di Caporetto, dove si svolse lo scontro, nel 1917, tra
austriaci e italiani?
□Una clamorosa vittoria
□Un clamoroso tradimento
□Una clamorosa resa
□Una clamorosa sconfitta
4)Le tesi di Aprile di Lenin prevedevano:
□di affidare tutto il potere ai soviet
□di stipulare un accordo politico con la borghesia
□di fare intervenire l’armata rossa contro il governo
□di emarginare il popolo dalla vita politica del Paese
5)Nel primo dopoguerra in Italia si affermano i partiti di massa:
□Liberale e Giolittiano
□Popolare e Socialista
□Comunista e Bolscevico
□Giolittiano e Socialista
6)La “marcia su Roma” del 28 ottobre 1922 fu:
□L'avanzata delle sinistre in Parlamento dopo il successo elettorale
□La reazione dell'esercito agli scioperi socialisti nella Capitale
□Il tentativo delle “camicie nere” di forzare la mano al Re
□L'occupazione delle Camere da parte dei fascisti
7)Le leggi “fascistissime”
□Confermarono le libertà previste dallo Statuto Albertino
□Abolirono molte libertà tra cui quella di associazione
□Riconobbero la libertà sindacale e il diritto di sciopero
□Istituirono forme corporative di partecipazione politica
8)Il New Deal, promosso da Roosvelt per uscire dalla Crisi del '29, affermava:
□la necessità che il governo guidasse l’economia
□l’opportunità di puntare sulla ripresa dell’agricoltura
□il bisogno di sospendere i prestiti all’Europa
□l'aumento dei finanziamenti ai privati
MATEMATICA
1)Trovare la mediana della seguente distribuzione di dati:
23
25
22
24
22
25
24
20
21
23
24
25
23,5
2)Calcolare il seguente integrale:
2
"#
$
!"
#
2
2
+ 5' ( -' + *
+5
"#
$
"#
$
("#$ + &#" -()*#
!&
'
+5
+
"'
"&
'
-) + *
(
-1 + +
-) + *
3)Integrale definito sta ad area come integrale indefinito sta a…
Primitiva
Suddivisione in rettangolini
Derivata
Costante additiva
4)Come si calcola la media aritmetica di una serie di dati?
Sommando tutti i valori e dividendo il risultato per la moda
Sommando tutti i valori e dividendo il risultato per il numero dei valori
Sommando tutti i valori e moltiplicando il risultato per il numero dei valori
Moltiplicando i valori tra di loro e dividendo il risultato per il numero dei valori
26
5)In una serie di dati è possibile che media, moda e mediana coincidano?
No, mai
Si, sempre
Si ma solo se il numero dei dati è pari
Si ma solo in particolari casi
6)Dal seguente grafico ricavare, senza effettuare calcoli, un valore approssimato
della media.
22430
22390
22490
22300
CLIL
7)The following table provides the number of deaths due to different causes among
Minnesota residents for the year 1975:
Cause of death
Number of Deaths
Heart disease
12378
Cancers
6448
Cerebrovascular disease
3958
Accidents
1814
Others
8088
Calculate the relative frequency due to Accidents.
5%
0,121
0,055
0,011
8)The following data give the speeds (in miles per hour) of twelve cars that were
stopped on I-95 for speeding violations:
77
82
74
Find the mode.
77; unimodal
74; unimodal
82, 74; bimodal
82; unimodal
81
79
84
74
78
82
80
75
83
T.P.S.E.E.
1) La sigla N07V-K nei cavi elettrici significa che:
A)il conduttore non propaga l’incendio e la fiamma e contiene l’emissione di gas corrosivi
in caso d’incendio
B) il conduttore propaga l’incendio
C) il conduttore non conduce energia elettrica
D) il conduttore non è soggetto a tensioni
2) Le norme CEI si applicano:
A) a tutti gli impianti elettrici
B) soltanto agli impianti elettrici civili
C) a tutti gli impianti elettrici ed elettronici
D) soltanto agli impianti elettrici industriali.
3) L’interruttore differenziale assicura una protezione contro:
A) i contatti diretti
B) i contatti indiretti
C) i contatti diretti ed indiretti
D) le scariche atmosferiche
4) Le Norme CEI 64-8/7; V7 si applicano ai locali:
A) ad uso medico
B) tipografie
C) centrale termica
D) alle scuole
5) Il Decreto Ministeriale n. 37/08, si applica:
A) agli impianti elettrici ed elettronici
B) agli impianti termici
C) agli impianti idrici
D) a tutti gli impianti tecnologici
6) Gli ambiti di applicazione del D. Lgs. n. 81/08 sono:
A) locali per civile abitazione
B) luoghi di lavoro
C) luoghi di svago
D) sedi stradali
7) Gli ambiti di applicazione del D.P.R. n. 151/11 sono relativi a:
A) locali di pubblico spettacolo con capacità ricettiva > 100 persone
B) locali di pubblico spettacolo con capacità ricettiva < 100 persone
C) cantieri edili
D) civili abitazioni
8) La progettazione degli impianti elettrici per utenze commerciali, va eseguita quando:
A) la potenza impegnata supera i 4,5 kW e la superficie supera i 150 mq;
B) la potenza impegnata supera i 6,0 kW e la superficie supera i 200 mq;
C) la potenza impegnata supera i 3,0 kW e la superficie supera i 100 mq;
D) la potenza impegnata supera i 3,0 kW e la superficie supera i 400 mq.
INGLESE
Ansewer the following questions:
1)How does a linear motor work?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2)What are the basic parts of a bipolar transistor?_____________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2^ SIMULAZIONE DI TERZA PROVA A.S. 2015/16
Classe Quinta Sez. D
TIPOLOGIA C (32 quesiti a risposta multipla)
DISCIPLINE:Storia, Matematica,TPSEE, Sistemi automatici, Inglese
DURATA DELLA PROVA: 90 minuti
COGNOME
NOME
DATA E FIRMA
VALUTAZIONE:quesiti a risposta multipla punti 0,375 per ogni risposta esatta e punti 0 per
ogni risposta errata o non data; quesiti a risposta breve max punti 1,5. Nelle risposte multiple
non sono ammesse correzioni, abrasioni, cancellature o risposte in numero superiore a uno.
E’ consentito l’uso della calcolatrice e del vocabolario di Inglese.
QUESITI A RISPOSTA APERTA
DESCRITTORI
INDICATORI
Risposta ottima o
eccellente
Risposta discreta
o buona
Risposta
sufficiente
Risposta
insufficiente
Risposta
estremamente
carente
1,5
1,25
1
0,75
0,50
Esecuzione del
compito
Sa rispondere alle
indicazioni del
compito in modo
completo e
articolato
Sa rispondere
alle indicazioni
del compito in
modo completo
Sa rispondere
alle indicazioni
del compito in
modo essenziale
Sa rispondere alle
indicazioni del
compito in modo
incompleto
Sa rispondere
alle indicazioni
del compito in
modo scarso o
nullo
Correttezza
morfosintattica
Usa le strutture
morfosintattiche in
modo articolato,
corretto ed
appropriato
Usa le strutture
morfosintattiche
in modo
abbastanza
articolato e
corretto, con
saltuarie
inesattezze
Usa le strutture
morfosintattiche
commettendo
errori che
tuttavia non
impediscono la
comprensibilità
globale del testo
Usa le strutture
morfosintattiche
con difficoltà e
commette errori
che
compromettono la
comprensibilità del
testo
Non sa usare le
strutture
morfosintattich
e. Il testo
risulta non
comprensibile
Efficacia
comunicativa
Sa costruire un
discorso coerente e
coeso; padroneggia
l’argomento che
espone in maniera
personale e con
accuratezza
linguistica e
lessicale
Sa costruire un
discorso
generalmente
coerente e
coeso, in modo
abbastanza
efficace e
personale seppur
con qualche
saltuaria
imprecisione
Sa costruire un
discorso
comprensibile
ma a volte non
sempre
scorrevole;
risponde
sinteticamente e
senza apporti
personali
Non riesce a
costruire un
discorso coerente e
coeso per lo scarso
e/o inappropriato
utilizzo dei
connettori logici
Non sa
costruire un
discorso
comprensibile
rispetto allo
scopo
GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DELLA PROVA
COGNOME _______________
DISCIPLINA
NOME ________________
Quesiti
a risposta multipla
1
2
3
4
5
6
7
8
Quesiti
a risposta aperta
1
2
TOTALI
Storia
Matematica
TPSEE
Sistemi
Inglese
Approssimazione al voto successivo
per frazioni uguali o superiori a 0,5
VALUTAZIONE
PROVA
___ /
15
SISTEMI
1)
Per il blocco di fig.
A
A
B
D
D
B
C
C
La funzione di trasferimento è
□
□
□
□
2)
Per una generica funzione di trasferimento, solo una di queste affermazioni è vera:
Gli zeri sono maggiori o minore ai poli
□
Ha tanti zeri quanti poli
□
I poli sono maggiore o uguali agli zeri
□
Ha più poli che zeri
□
84
□
□
□
□
5) Il seguente diagramma di Bode delle fasi
90º
45º
ω
Rappresenta:
Un polo all’origine
□
Un polo qualunque
□
Uno zero qualunque
□
Uno zero all’origine
□
85
6)Un sistema del secondo ordine si hanno due poli reali e coincidenti per:
a:
b:
c:
d:
□
□
□
□
per ζ=1
per ζ>1
per ζ<1
per ζ grande
7)La trasformata di Laplace del gradino è:
a:
b:
c:
d:
s
1/s
1/s2
s2
8)
Per avere un sistema stabile si deve avere un margine di guadagno:
a:
b:
c:
d:
1 dB
5 dB
10 dB
20 dB
□
□
□
□
□
□
□
□
86
STORIA
1) Per “taylorismo” durante la Belle Epoque si intende:
□
□
□
□
la semplificazione dei vincoli commerciali con l’eliminazione delle dogane
la semplificazione delle operazioni lavorative con la catena di montaggio
la semplificazione dei rapporti tra imprenditore e operai con il sindacato
la semplificazione dell’accesso al credito bancario con agevolazioni statali
2) A seguito dei trattati di pace, alla fine della Prima Guerra Mondiale, la Germania dovette cedere
alla Polonia:
□
□
□
□
L’Alsazia e la Lorena
Il corridoio di Danzica
La regione dei Sudeti
Nizza e Savoia
3) Con l’espressione “vittoria mutilata” i reduci italiani intendevano:
□ Che l’Italia era stata privata della vittoria conquistata sui campi di battaglia
□ Che l’Italia non aveva saputo approfittare della superiorità militare
□ Che l’Italia, a causa dei neutralisti, era entrata in guerra troppo tardi
□ Che l’Italia non aveva espresso bene le richieste prima di entrare in guerra
4) Negli Stati Uniti vennero definiti “anni ruggenti” del boom economico:
□ quelli successivi alla Prima guerra mondiale
□ quelli successivi alla seconda guerra mondiale
□ quelli della grande depressione
□ quelli della lotta alla diffusione del socialismo
87
5) La caratteristica che fece del Nazismo un “ totalitarismo perfetto”, a differenza degli altri , fu:
□ la persecuzione degli ebrei e delle minoranze
□ il controllo della stampa e la propaganda
□ l’eliminazione fisica delle opposizioni
□ il controllo della società civile e della vita privata
6)I piani quinquennali di Stalin prevedevano:
□ lo sviluppo della piccola proprietà agraria
□ lo sviluppo dei commerci secondo i principi della NEP
□ l'industrializzazione forzata
□ la nascita del Soviet Supremo
7)Il Patto Molotov-Von Ribbentropp del 1939:
□ Era un patto di non aggressione fra Germania e URSS
□ Sanciva la rinuncia della Germania a invadere la Polonia
□ Obbligava l’URSS ad astenersi da alleanze anti-tedesche
□ Era un patto che impegnava le due nazioni all’invasione della Finlandia
8) Mussolini rispetto all’alleato tedesco :
□ Strinse relazioni con l’Inghilterra e Francia
□ Scelse di condurre una guerra parallela in Africa e Grecia
□ Inviò truppe sul fronte polacco
□ Riuscì ad evitare il coinvolgimento dell’esercito italiano
88
MATEMATICA
1) Lanciando quattro monete, qual è la probabilità di uscita di T T C C ?
a) 1/4
b) 4/8
c) 1/16
d) 4/16
2) Quale tra i seguenti numeri rappresenta la probabilità di un evento ?
a) 0,0001
b) 2
c) 4/3
d) -1
3) Quanti sono gli anagrammi della parola ESAMINATORI ?
a) 3.628.800
b) 40.320
c) 9.979.200
d) 39.916.800
4) Estraggo da un sacchetto, contenente numeri da 1 a 90, un numero e da una
scatola, contenente lettere dalla A alla Z, una lettera. Qual è la probabilità di
estrarre “5D” ?
a) 1/111
b) 1/1890
c) 5/111
d) 2/1890
5) In quanti modi posso condire tre pizze con un ingrediente scelto a caso tra
cinque ?
a) 60
b) 125
c) 243
d) 15
89
6) Ho lanciato un dado 500 volte ottenendo 100 volte ciascuna le facce 1-2-3, 50
volte la faccia 4, 75 volte ciascuna le facce 5 e 6. Qual è la probabilità di uscita
della faccia 4 ?
a) 1/6
b) 50/500
c) 4/6
d) 1/4
90
7) The total advertising revenues (printed version + online version) were highest in
which of the following months?
a) February
b) March
c) May
d) June
8) During the six-month period shown, the median number of copies printed per
month was most nearly
a) 30.000
b) 29.000
c) 28.000
d) 25.000
91
T.P.S.E.E.
1) Quale tra i seguenti non è un costo ambientale?
q
Costi di conversione
q
Costi operativi ambientali
q
Costi di difettosità interna
q
Costi ambientali esterni
2) Quale tra le seguenti non è una fase di progetto?
q
Implementazione
q
Chiusura
q
Realizzazione
q
Concezione
3) Quando due contati I0.0 e I01, collegati in AND come in figura 1, detrminano
l’attivazione della bobina di uscita Q0.0?
Figura 1
q
Quando I0.0 assume valore logico 1
q
Quando I0.1 assume valore logico 1
q
Quando sia I0.0 che I0.1 assumono valore logico 1
q
Quando sia I0.0 che I0.1 assumono valore logico 0
92
4) Quando due contatti I0.2 e I03, collegati in OR come in figura 2, determinano la
non attivazione della bobina di uscita Q0.1?
Figura 2
q
Quando I0.2 ha valore logico 1
q
Quando I0.3 ha valore logico 1
q
Quando si I0.0 che I0.1 hanno valore logico 1
q
Quando sia I0.0 che I0.1 hanno valore logico 0
93
5) Quando la bobina Q0.3 di figura 3 rimane attiva?
Figura 3
q
Quando I0.4 ha valore logico 0
q
Quando I0.4 ha valore logico 1
q
Quando I0.5 ha valore logico 1
q
Quando I0.6 ha valore logico 1
6) L’avviamento diretto di un motore consiste nel:
q
Collegare la morsettiera del motore direttamente alla linea di alimentazione in modo
che la tensione di rete sia quella a cui sono sottoposti gli avvolgimenti statorici della
macchina
q
Collegare la morsettiera del motore direttamente alla linea di alimentazione in modo
che la corrente attraversa gli avvolgimenti sia ¾ di quella per cui sono stati progettati
gli avvolgimenti statorici
q
Collegare la morsettiera del motore direttamente alla linea di alimentazione in modo
che la potenza erogata sia quella per il collegamento degli avvolgimenti statorici
connessi a triangolo
q
Collegare la morsettiera del motore direttamente alla linea di alimentazione in modo
che la velocità di scorrimento sia pari a quella designata per il collegamento a stella
94
7) Una delle connessioni sottoelencate tra i pulsanti in un sistema di controllo di
marcia/arresto è errata; quale?
q
Pulsanti di marcia in parallelo tra loro
q
Pulsanti di marcia in parallelo tra loro e in serie con i pulsanti di arresto
q
Pulsanti di arresto in parallelo tra loro e in serie con i pulsanti di marcia
q
Pulsanti di arresto in serie tra loro
8) A che cosa serve il relè Buchholz?
q
Per la protezione dai guasti interni dei trasformatori in olio
q
Per la protezione dei guasti interni dei trasformatori a secco
q
Per la protezione contro i cortocircuiti sul lato BT dei trasformatori in olio
q
Per la protezione contro i cortocircuiti sul lato MT dei trasformatori in olio
95
INGLESE
Ansewer the following questions
1)What is a PLC and how does it work?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2)How do electric motors work?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
96
IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA VD
15/05/2016
97
98