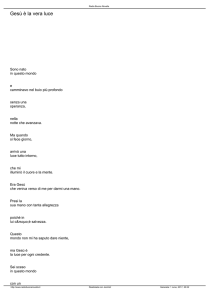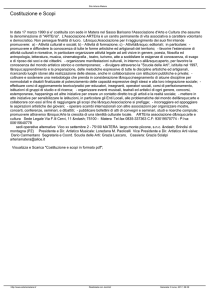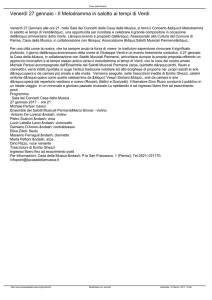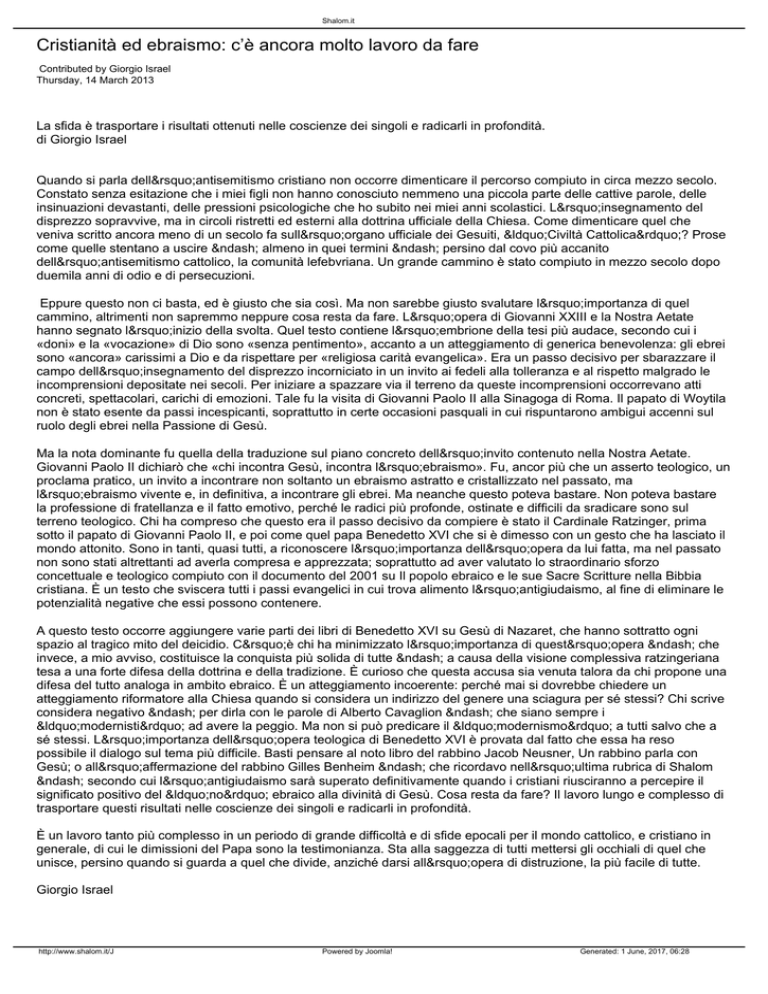
Shalom.it
Cristianità ed ebraismo: c’è ancora molto lavoro da fare
Contributed by Giorgio Israel
Thursday, 14 March 2013
La sfida è trasportare i risultati ottenuti nelle coscienze dei singoli e radicarli in profondità.
di Giorgio Israel
Quando si parla dell’antisemitismo cristiano non occorre dimenticare il percorso compiuto in circa mezzo secolo.
Constato senza esitazione che i miei figli non hanno conosciuto nemmeno una piccola parte delle cattive parole, delle
insinuazioni devastanti, delle pressioni psicologiche che ho subito nei miei anni scolastici. L’insegnamento del
disprezzo sopravvive, ma in circoli ristretti ed esterni alla dottrina ufficiale della Chiesa. Come dimenticare quel che
veniva scritto ancora meno di un secolo fa sull’organo ufficiale dei Gesuiti, “Civiltà Cattolica”? Prose
come quelle stentano a uscire – almeno in quei termini – persino dal covo più accanito
dell’antisemitismo cattolico, la comunità lefebvriana. Un grande cammino è stato compiuto in mezzo secolo dopo
duemila anni di odio e di persecuzioni.
Eppure questo non ci basta, ed è giusto che sia così. Ma non sarebbe giusto svalutare l’importanza di quel
cammino, altrimenti non sapremmo neppure cosa resta da fare. L’opera di Giovanni XXIII e la Nostra Aetate
hanno segnato l’inizio della svolta. Quel testo contiene l’embrione della tesi più audace, secondo cui i
«doni» e la «vocazione» di Dio sono «senza pentimento», accanto a un atteggiamento di generica benevolenza: gli ebrei
sono «ancora» carissimi a Dio e da rispettare per «religiosa carità evangelica». Era un passo decisivo per sbarazzare il
campo dell’insegnamento del disprezzo incorniciato in un invito ai fedeli alla tolleranza e al rispetto malgrado le
incomprensioni depositate nei secoli. Per iniziare a spazzare via il terreno da queste incomprensioni occorrevano atti
concreti, spettacolari, carichi di emozioni. Tale fu la visita di Giovanni Paolo II alla Sinagoga di Roma. Il papato di Woytila
non è stato esente da passi incespicanti, soprattutto in certe occasioni pasquali in cui rispuntarono ambigui accenni sul
ruolo degli ebrei nella Passione di Gesù.
Ma la nota dominante fu quella della traduzione sul piano concreto dell’invito contenuto nella Nostra Aetate.
Giovanni Paolo II dichiarò che «chi incontra Gesù, incontra l’ebraismo». Fu, ancor più che un asserto teologico, un
proclama pratico, un invito a incontrare non soltanto un ebraismo astratto e cristallizzato nel passato, ma
l’ebraismo vivente e, in definitiva, a incontrare gli ebrei. Ma neanche questo poteva bastare. Non poteva bastare
la professione di fratellanza e il fatto emotivo, perché le radici più profonde, ostinate e difficili da sradicare sono sul
terreno teologico. Chi ha compreso che questo era il passo decisivo da compiere è stato il Cardinale Ratzinger, prima
sotto il papato di Giovanni Paolo II, e poi come quel papa Benedetto XVI che si è dimesso con un gesto che ha lasciato il
mondo attonito. Sono in tanti, quasi tutti, a riconoscere l’importanza dell’opera da lui fatta, ma nel passato
non sono stati altrettanti ad averla compresa e apprezzata; soprattutto ad aver valutato lo straordinario sforzo
concettuale e teologico compiuto con il documento del 2001 su Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia
cristiana. È un testo che sviscera tutti i passi evangelici in cui trova alimento l’antigiudaismo, al fine di eliminare le
potenzialità negative che essi possono contenere.
A questo testo occorre aggiungere varie parti dei libri di Benedetto XVI su Gesù di Nazaret, che hanno sottratto ogni
spazio al tragico mito del deicidio. C’è chi ha minimizzato l’importanza di quest’opera – che
invece, a mio avviso, costituisce la conquista più solida di tutte – a causa della visione complessiva ratzingeriana
tesa a una forte difesa della dottrina e della tradizione. È curioso che questa accusa sia venuta talora da chi propone una
difesa del tutto analoga in ambito ebraico. È un atteggiamento incoerente: perché mai si dovrebbe chiedere un
atteggiamento riformatore alla Chiesa quando si considera un indirizzo del genere una sciagura per sé stessi? Chi scrive
considera negativo – per dirla con le parole di Alberto Cavaglion – che siano sempre i
“modernisti” ad avere la peggio. Ma non si può predicare il “modernismo” a tutti salvo che a
sé stessi. L’importanza dell’opera teologica di Benedetto XVI è provata dal fatto che essa ha reso
possibile il dialogo sul tema più difficile. Basti pensare al noto libro del rabbino Jacob Neusner, Un rabbino parla con
Gesù; o all’affermazione del rabbino Gilles Benheim – che ricordavo nell’ultima rubrica di Shalom
– secondo cui l’antigiudaismo sarà superato definitivamente quando i cristiani riusciranno a percepire il
significato positivo del “no” ebraico alla divinità di Gesù. Cosa resta da fare? Il lavoro lungo e complesso di
trasportare questi risultati nelle coscienze dei singoli e radicarli in profondità.
È un lavoro tanto più complesso in un periodo di grande difficoltà e di sfide epocali per il mondo cattolico, e cristiano in
generale, di cui le dimissioni del Papa sono la testimonianza. Sta alla saggezza di tutti mettersi gli occhiali di quel che
unisce, persino quando si guarda a quel che divide, anziché darsi all’opera di distruzione, la più facile di tutte.
Giorgio Israel
http://www.shalom.it/J
Powered by Joomla!
Generated: 1 June, 2017, 06:28
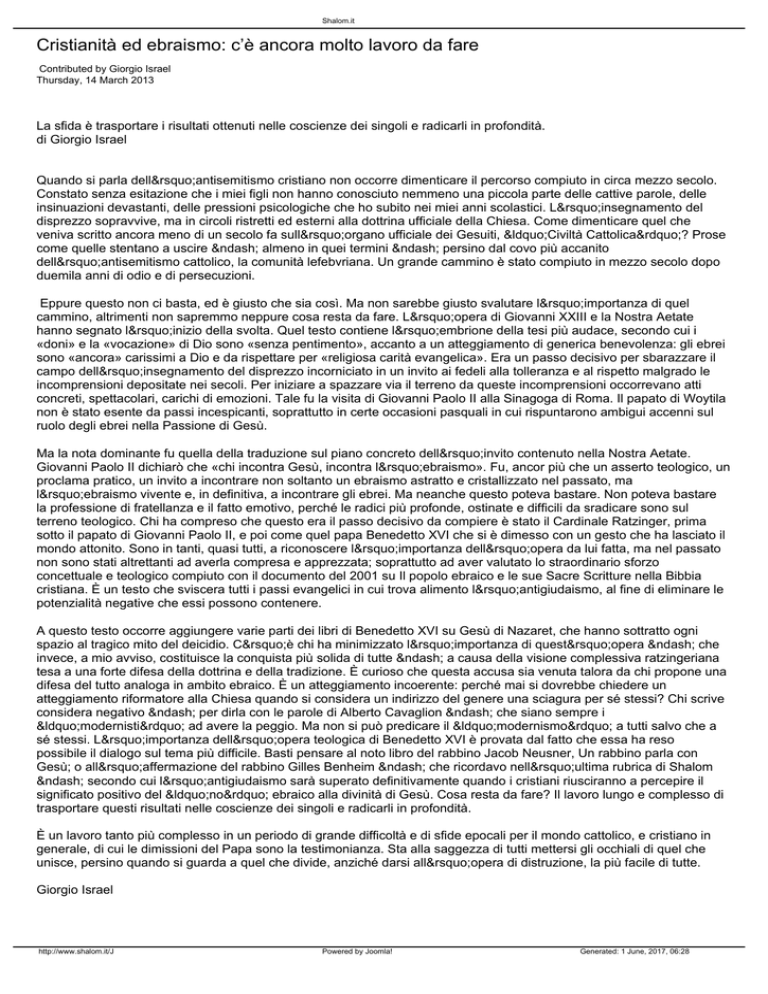
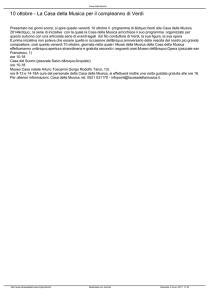

![Recensendo [cd]: "Mattoni" di Andrea](http://s1.studylibit.com/store/data/007525618_1-1525635c43b9484bf53d73b8a7da6ea3-300x300.png)
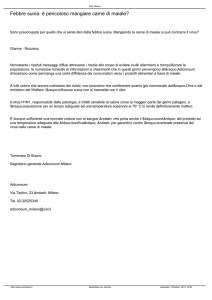
![Recensendo [cd]: "Calibrated thickness" di Uri Caine](http://s1.studylibit.com/store/data/003842205_1-7e3c5e4d085992dd2d8b768378f0a85c-300x300.png)