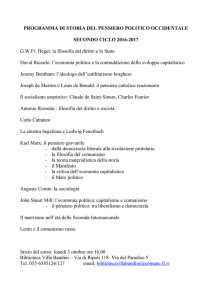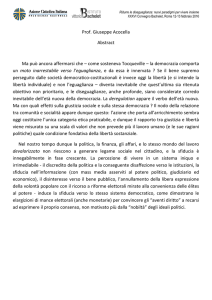Il volume costituisce una
sintetica introduzione alla
filosofia politica, presentata
attraverso i suoi concetti, i
suoi problemi e le principali
teorie. La prima parte del
libro traccia una mappa di
alcune delle domande fondamentali alle quali la filosofia
politica ha cercato di
rispondere nel corso della
sua lunga storia: qual è il
miglior ordine politico, che
rapportivisonotramoralee
politica, da un lato, e tra
politica e forza, dall’altro,
qual è la natura dell’agire
politico.
Nella seconda parte del
libro vengono presentati
quattro
paradigmi
del
pensiero politico che ne
hanno
profondamente
segnato la storia: il
paradigma
della
polis
(Platone e Aristotele), quello
del confronto tra città
dell’uomo e città di Dio (da
Agostino e Tommaso alla
Riforma),quellodelcontratto
sociale (Hobbes, Locke,
Rousseau, Kant), e quello
della dialettica tra stato e
società,vistacometerrenodi
conflitto tra i liberali che
insistonosuilimitidellostato
(come Constant, Tocqueville
e Mill) e i critici del
liberalismo come Hegel e
Marx.
Nellaterzapartevengono
illustrati alcuni concetti
politici fondamentali (libertà
e liberalismo, socialismo e
democrazia), si delinea una
panoramica delle principali
opzioni teoriche (da Rawls a
Habermas)chesicontendono
il campo nella discussione
contemporanea, per arrivare
infine ai nuovi temi con i
qualisiconfrontalafilosofia
politica
oggi,
dalla
globalizzazione
alla
biopolitica.
Sommario:
Premessa. - Parte prima.
Prologo, I. Territori e
domande della filosofia
politica. - Parte seconda.
Paradigmi della filosofia
politica, II. Lordine della
«polis», III. La città
dell'uomo e la città di Dio.
IV. Il paradigma del
contratto, V. Società civile e
stato.-Parteterza.Concettie
teorie della filosofia politica,
VI. Concetti della teoria
politica,VII.Teoriepolitiche
a confronto, VIII. Questioni
per la filosofia politica. Letture consigliate. - Indice
deinomi.
Ocreconversionea
curadiNatjus
LadridiBiblioteche
INDICE
Premessa
Ringraziamenti
Modelli di
politica
filosofia
Parteprima.Prologo
I. Territori e domande
dellafilosofiapolitica
1.Filosofiapolitica:uno
sguardopreliminare
2. Filosofia e filosofia
politica
3. Le domande della
filosofiapolitica
Parte seconda. Paradigmi
dellafilosofiapolitica
II.L’ordinedellapolis
1.Polisedemocrazia
2. La visione platonica
delBenepolitico
3. Aristotele e il
pluralismodelBene
4. Dalla polis alla
cosmopolis
III.Lacittàdell’uomoela
cittàdiDio
1. La rivoluzione
cristiana.PaoloeAgostino
2.Ilpoteredelpontefice
eilpoterepolitico
3.Tommasod’Aquino
4. La rottura della «res
publica christiana» e la
Riformaprotestante
IV. Il paradigma del
contratto
1. Il modello
contrattualista
2.LacesuradiThomas
Hobbes
3. Il patto democratico
diSpinoza
4.Ilcontrattoliberaledi
JohnLocke
5. I due patti di JeanJacquesRousseau
6. Kant e il contratto
comeideadellaragione
V.Societàcivileestato
1. Lo spartiacque della
Rivoluzione
2.BenjaminConstante
lalibertàdeimoderni
3.AlexisdeTocqueville
elademocraziainAmerica
4.Illiberalismoradicale
diJohnStuartMill
5. Il superamento
hegelianodelliberalismo
6. Marx: eguaglianza
politica e ineguaglianza
sociale
Parte terza. Concetti e
teoriedellafilosofiapolitica
VI.Concettidellateoria
politica
1.Alcunepremesse
2. Il concetto moderno
dilibertà
3.Liberalismo
4.Socialismo
5.Democrazia
VII. Teorie politiche a
confronto
1. La teoria della
giustiziadiRawls
2.Alternativeallateoria
dellagiustizia
3.Habermaselateoria
dellademocrazia
4. La critica del
normativismo: la teoria del
poterediFoucault
5.Femminismoeteoria
politica
VIII. Questioni per la
filosofiapolitica
1. Il «fondamento» dei
dirittiedellademocrazia
2. Sistema dei diritti e
democrazia
3. Tra fatti e norme: il
problema
delle
teorie
normative
4. La politica della
democrazia e le sfide del
mondoglobalizzato
5.Bioeticaebiopolitica
Lettureconsigliate
Indicedeinomi
Premessa
Lo scopo che questo
volumesiprefiggeèquellodi
offrire
una
sintetica
introduzione alle questioni
principali della filosofia
politica, ai suoi autori e ai
suoi temi più importanti. Per
tentare di soddisfare questa
esigenza il libro si avvale di
diversiapprocci.Perunverso
si sofferma, soprattutto nel
primo e nell’ultimo capitolo,
su alcuni problemi che o
costituiscono temi sempre
ricorrenti, che la filosofia
politica
torna
incessantemente a discutere
(comeperesempioilrapporto
tra etica e politica e la
questione
intorno
al
«fondamento» dei diritti e
della democrazia), oppure
nasconodallenuovesfideche
la filosofia politica si trova a
dover affrontare nel mondo
contemporaneo.
In secondo luogo il testo,
particolarmentenellaseconda
parte, si sofferma su un
insieme di teorie o di
paradigmi
che,
della
tradizione filosofico-politica
occidentale, costituiscono il
lascitopiùcospicuo:inquesta
parte, com’è ovvio - dati i
limiti di spazio che ci
eravamo prefissi - si sono
dovuteoperaredelledrastiche
scelte e selezioni, che
naturalmente risentono dei
gusti dell’autore e del suo
modo di accostarsi alle
questionifilosofico-politiche.
Un terzo approccio,
infine, è quello che procede
per concetti, del quale si è
ritenuto opportuno avvalersi,
nelcapitolosesto,pertentare
un chiarimento di alcune
parole-chiave del lessico
politico
del
mondo
contemporaneo (libertà e
liberalismo, democrazia e
socialismo).
Le scelte che presiedono
all’organizzazione del testo
rinviano, naturalmente, a un
certo modo di intendere la
filosofia politica. Sebbene
essa
sia
ovviamente
intrecciata con i processi
storicieconiconflittipolitici
e sociali, non crediamo che
sia riducibile a una mera
traduzione di essi sul piano
della riflessione e della
elaborazione concettuale. La
specificità della filosofia
politica, invece, consiste a
nostro avviso nel tentativo di
proporre argomentazioni, nel
costruire un ordito di
ragionamenti intorno alle
questioni che la convivenza
sociale
e
politica
inevitabilmente
solleva.
Scopodellafilosofiapolitica,
insomma, ci sembra essere
quello di proporre buoni
argomenti per rispondere alle
sfide, ai problemi e ai
conflitti che nascono nella
cooperazione sociale, che ci
toccano tutti in quanto
cittadini,echecichiamanoal
confronto, alla discussione e
allapresadiposizione.
Questo volume vuol
essere,
pertanto,
una
presentazione di alcune
questioni fondamentali della
filosofia politica utile non
solo a chi, nell’università o
altrove, voglia accostarsi a
questadisciplina,maanchea
chiunque, come cittadino,
desideriprenderecontattocon
un ricco arsenale di
argomentiediriflessioni,che
condizionano in vario modo,
piùomenoesplicito,lanostra
discussione pubblica, e che
potrebbero renderla più
consapevoleepiùricca.
La convinzione che
sottende le pagine di questo
libro,infine,èchelafilosofia
politica, proprio in quanto è
argomentazione pubblica e
discussione razionale, non
può non avere una valenza
critica: sua funzione è anche
quella di aiutarci a prendere
le distanze dalla realtà
politica
e
sociale
semplicemente
data,
commisurandola a criteri o a
principi che siano sostenuti
da buoni argomenti e che
reggano il vaglio della
discussionecritica.
Ringraziamenti.
Un ringraziamento del
tutto particolare va a Mario
Reale che, con la consueta
generosità, ha letto il
manoscritto e mi ha dato
modo di migliorarlo con le
sue
acute
e
precise
osservazioni. Grazie anche ai
tanti amici con i quali, in
questianni,hoavutomododi
discutere dei temi trattati nel
volume: voglio ricordare in
modo particolare Sebastiano
Maffettone e i partecipanti al
Colloquium
on
Ethics,
Politics and Society presso
l’UniversitàLuissdiRoma;e
gli amici del Seminario di
teoria critica e filosofia
sociale di Gallarate, i co-
organizzatori(MarinaCalloni
eAlessandroFerrara)etuttii
partecipanti.
MODELLIDI
FILOSOFIA
POLITICA
Allamemoriadimio
padreMario
Parteprima.
Prologo
I.Territoriedomande
dellafilosofiapolitica
I.Filosofiapolitica:
unosguardo
preliminare.
Per provare a offrire una
prima
e
provvisoria
definizione, si potrebbe
innanzitutto osservare che la
filosofia politica è una forma
di sapere che assume a
proprio oggetto quello che
sembra essere un aspetto
fondamentale dell’esperienza
umana: essa si occupa infatti
delle interazioni tra gli
uomini in società in quanto
esse sono influenzate o
regolate da relazioni di
potere,
che
assicurano
l’integrazione tra i diversi
attorisocialienegovernanoi
comportamenti
anche
attraverso un certo uso della
coercizione, ovvero della
possibilità di comminare
sanzioni.Lafilosofiapolitica,
inaltreparole,sioccupadelle
interazioni sociali tra gli
uomini in quanto queste si
configuranocomerelazionidi
potere, e danno luogo a
discussioneoaconflittocirca
ilmodoincuiilpoteredebba
essere
distribuito
o
organizzato.
La filosofia politica,
quindi, è una forma di
pensiero che assume come
suooggettocentrale,anchese
non
esclusivo,
le
problematichedelpotere.Ma
come possiamo definire il
«potere»? Per «potere»
possiamo intendere, in prima
approssimazione, la capacità
che
qualcuno
ha
di
controllare, attraverso la
propria influenza o con la
minaccia di sanzioni, il
comportamento di altre
persone, ovvero di vedere
obbedite
le
proprie
disposizioni.
Le interazioni sociali ci
offrono un campionario
ricchissimo delle forme di
potere perché quasi nessuna
relazionesocialenevaesente.
Forse vi sono rapporti di
potere anche nell’amicizia e
nell’amore,
ma
indubbiamente relazioni di
potere,
informali
o
formalizzate, strutturano i
rapporti nella famiglia, nel
mondo del lavoro, nelle
associazioni, insomma ;n
quasi tutti i tipi di relazione
sociale. Dovremo pensare
allora che tutte queste
relazioni di potere sono
pertinenti per la filosofia
politica? Se interrogati su
questo punto, i filosofi
politici
comincerebbero
subito a dividersi: la
tradizione piü canonica della
filosofia politica, infatti, si è
occupata delle forme di
potere
istituzionalizzate,
quellechesidepositanonelle
leggi e si incorporano nelle
istituzionistatali;mentresono
stati soprattutto i pensatori
eterodossiainsisteresulfatto
che le relazioni di potere più
fondamentali sono dislocate
fuori dai luoghi canonici
dello stato e del diritto, nei
rapportidiproprietà(Marx)o
nella«microfisicadelpotere»
(Foucault).
Non si farà torto a questi
pensatori eterodossi, però, se
sidiràchelafilosofiapolitica
haachefareprevalentemente
con le forme di potere
istituzionalizzate, che, a
partiredaunacertafasedella
storia degli uomini, possono
essere definite come potere
statale. Ecco quindi che,
prima di procedere oltre, è
necessario delineare anche
una definizione, seppur
minima o provvisoria, di
stato1. Come filo conduttore
si può assumere quella che
restaatutt’oggiladefinizione
di stato piü citata e
autorevole,chesideveaMax
Weber (1864-1920). Nella
famosa conferenza del 1919
su La politica come
professione, - della quale
parleremo ancora perché
costituisce uno dei testi più
illuminanti
per
la
comprensione dell’essenza
della politica - Max Weber
così si esprime: «Lo stato è,
comeleassociazionipolitiche
che
storicamente
lo
precedono, un rapporto di
dominiodi uomini su uomini
basato sul mezzo della forza
legittima (cioè considerata
legittima)»2.
In questa stringatissima e
asciutta definizione di Max
Weber, ormai divenuta
classica, vengono indicati
forse gli elementi essenziali
sui quali si esercita la
riflessione della filosofia
politica: per un verso le
comunità
umane
si
organizzano, delimitandosi
territorialmente, attorno a
forme di potere organizzato
che, da un certo momento
storico in poi, può essere
definito potere statale. Per
MaxWeber,caratteristicadel
potere dello stato, oltre a
quella di esercitarsi su un
determinato territorio, è che
esso detiene il monopolio
della fona legittima.Lo stato
sottrae a tutti i singoli
individui il diritto di
esercitare coercizione o
violenzasuglialtrieloavoca
asé.
Ma si faccia attenzione:
Max Weber afferma che lo
stato è l’organizzazione che
detiene il monopolio della
forza legittima, ovvero
ritenuta tale. Perciò il
prossimopassononpotràche
essere quello di chiedersi: in
che cosa consiste la
legittimità?Questaèappunto
una delle questioni centrali
che la filosofia politica
affronta. Per un verso essa
ragiona intorno al fenomeno
del potere, dello stato e delle
forme che lo governano
(legalità), ma per altro verso
nonpuòfareamenodiporsi
la
questione
che
immediatamente a questo
propositoinsorgeecioè:qual
è il giusto ordinamento
politico?OltreWeber,qualè
l’ordinamento politico che è
legittimo non solo perché
viene riconosciuto tale da
coloro
che
a
esso
obbediscono, ma perché
soddisfa dei requisiti di
giustizia ? Potremmo dire
quindichelafilosofiapolitica
hainuncertosensoduevolti:
daunaparte,equestoèillato
di cui è stato maestro
Machiavelli, la filosofia
politica si occupa del potere,
del conflitto per il potere,
della sua conquista e del suo
mantenimento,quindideivari
aspetti dell’agire politico:
dall’altra,
a
partire
quantomenodallaRepubblica
diPlatone,lafilosofiapolitica
si pone la questione di quale
sia l’ottimo o il giusto
ordinamento politico. In altre
parole, la filosofia politica si
occupa di quale sia il modo
giustodiorganizzarelanostra
convivenza,diqualiformedi
potere siano legittime, di
quali diritti debbano essere
riconosciuti ai cittadini: ed è
proprio su questi problemi
che si confrontano ancora
oggilediversetendenzedella
filosofia
contemporanea.
politica
2.Filosofiae
filosofiapolitica.
Non dobbiamo mai
dimenticarci però, quando
parliamo di filosofia politica,
che essa, prima che essere
politica, è filosofia. In una
delle prime pagine del suo
saggio Che cos’è la filosofia
politica, del 1955, Leo
Strauss,ilgrandestudiosodel
pensiero politico classico e
moderno,ponevasubitoecon
forza la questione del
rapporto tra la filosofia
politica e la filosofia ‘senza
aggettivi’.
«Poiché
la
filosofia politica è un ramo
della filosofia, neppure la
spiegazionepiùprovvisoriadi
che cos’è la filosofia politica
può dispensarci dal chiarire,
per quanto in modo
altrettanto provvisorio, che
cos’è la filosofia»3. Prima di
tornare a riflettere, perciò, su
quale sia la natura peculiare
della filosofia politica, nel
suointrecciospessofittissimo
con le altre discipline
filosofiche e non, conviene
mettere innanzitutto le carte
in tavola, ed esplicitare da
quale modo di intendere la
filosofia ci faremo guidare
neltracciarelanostramappa.
La filosofia non è, come
lafisica,lachimica,lastoria,
una forma di sapere
codificato, che goda di una
legittimità
assicurata
e
incontestata, e che abbia uno
statutochenonsiaessostesso
oggetto di discussione. Al
contrario, la filosofia è, nel
migliore dei casi, una forma
di «sapere» che deve sempre
di nuovo dimostrare la sua,
eventuale, legittimità. Per
questo non può darsi, della
filosofia, una definizione
consolidata o generalmente
accolta. Ogni filosofia che si
rispetti è anche, o forse è
innanzitutto, una definizione
di che cosa debba intendersi
per filosofia. Perciò, al
tentativo di chiarire cosa
debba intendersi per filosofia
noncisipuò,ancheinsededi
filosofiapolitica,sottrarre.
Per quanto mi riguarda,
credochealladomandacirca
la natura o lo statuto della
filosofia si possa tentare di
dare una risposta molto
semplice e non troppo
controversa, che potrebbe
formularsi così: per filosofia
deve intendersi un tipo di
«pratica discorsiva» del tutto
particolare,chesicaratterizza
per
l’unione
di
un
determinato metodo con un
determinatooggetto.
Filosofia è, per dirla nel
modopiùbrevepossibile,una
forma
sofisticata
e
istituzionalizzata di discorso
che, quanto al metodo, si
avvale fondamentalmente di
un’unica risorsa, quella
dell’argomentazione
pubblica, critica e aperta,
mentre, quanto all’oggetto,
affronta la questione tanto
ineludibile quanto (forse)
inesauribile
del
nostro
orientamento nel mondo, una
questione cioè alla quale non
possono dare risposta le
scienze di fatti poiché esse
stesse sono bisognose di
legittimazione
e
di
orientamento. La filosofia,
dunque, non è un sapere di
fatti, ma, come mostra la
storia del pensiero a chi
sappia leggerne e capirne i
percorsi, è una sorta di
ininterrotto
dialogo
argomentativo, un continuo
scambio di ragioni e di
critiche4: la specificità della
filosofia rispetto ad altre
forme di comunicazione o di
significazione sta dunque
proprio nel tentativo di
costruire
argomentazioni,
cioè di non affidarsi né alla
autorità, né alla convenzione,
né all’immaginazione o alla
suggestione, ma di cercare di
costruire
ragionamenti
persuasivi. Naturalmente di
procedureargomentativecisi
avvale anche in molti altri
campi del sapere; così come
ci sono molte forme di
espressione umana o di
comunicazionechecercanodi
illuminare
il
problema
dell’orientamento dell’uomo
nelmondo:èuncompitoche
è sempre stato svolto
egregiamente dalle religioni,
ma anche dalle narrazioni,
dalle forme d’arte, dalle
massime di saggezza. Dov’è
allora la peculiarità della
filosofia? A mio modo di
vedere, non è difficile
rintracciarla. Da un lato essa
si distingue dalle altre forme
di sapere perché ha nel
discorsoargomentativoilsuo
strumento privilegiato se non
unico (non si avvale di
ricerche
materiali
«sul
campo»,diesperimentiecc.);
per altro verso, la sua
peculiarità sta nel fatto che
essa cerca di affrontare con
gli strumenti del dialogo
razionale quei problemi ai
qualilescienzepositivesono
costitutivamente
impossibilitate
a
dare
risposte: perché esse, come
ormaibensappiamo,possono
insegnarci come stanno le
cose,manoncomedobbiamo
scegliere, quali sono i modi
migliori, e più validi, per
orientare il nostro stare al
mondo e la nostra vita in
comune.
La peculiare caratteristica
della filosofia insomma,
quellacheleconferisceilsuo
fascino ma che al tempo
stesso la condanna a uno
statuto sempre instabile e
problematico, è che essa si
pone problemi che non
possono
essere
risolti
restando sul terreno di un
accertamento
di
fatti:
questioni normative, come
dicevamo sopra, ma anche
questioni strutturali, che
riguardano cioè la struttura
dellarealtàedellesuediverse
regioni, quella intelaiatura
permanente, di cui non
possiamo neppure pensare il
venirmeno,qualichesianole
esperienze
nuove
che
andremo a fare, i fatti nuovi
cheandremoascoprire.
In quanto è filosofia, e
non scienza della politica, la
filosofia politica si confronta
proprio con problemi di
questo genere: affronta
questioni normative, quando
cerca di costruire buoni
argomenti per rispondere ai
dilemmi che la nostra
convivenzacipone,aidissidi
e ai conflitti che in essa
quotidianamente
si
incontrano. Ma affronta
anche, o forse ancor prima,
questionistrutturaliquandosi
chiede qual è la natura della
società, qual è l’essenza del
potere, quali sono i moventi,
le caratteristiche, la natura
dell’agire politico. Per dirla
ancora una volta con Leo
Strauss, «la filosofia politica
è dunque il tentativo di
conoscere veramente ad un
tempo la natura delle cose
politiche e il giusto o buon
ordinepolitico»5.
Proprio perché ha a che
fare con problemi di questo
genere,lafilosofiapoliticaha
piùlanaturadiuna«filosofia
ultima» che di una «filosofia
prima»: il terreno sul quale
essa deve muovere i propri
passi è un terreno sul quale
già molte altre discipline,
filosofiche e non, hanno
tracciatostradeepercorsi.
Occupandosi
di
un
fenomeno complesso, come
la vita umana associata, la
filosofia politica non può
essere in nessun modo
autosufficiente: anzi, essa
entra necessariamente in
contatto con molti altri
approcci disciplinari, e
costituiscetradiessiunpunto
di intersezione e di incontro.
In primo luogo, infatti, la
filosofia politica si connette
con la filosofia morale,
perché le questioni intorno a
ciòcheègiusto,oaproposito
dellavitabuona,hannoilloro
luogo genetico proprio
nell’ambito della filosofia
morale. L’altro momento di
forte connessione, che non
sempre viene sottolineato
come si dovrebbe, è quello
che a mio avviso si deve
stabilire tra la filosofia
politica e la filosofia sociale.
Ladomandacircalagiustizia
politica presuppone infatti,
com’è ovvio, determinate
assunzioni circa il modo in
cui è fatta e funziona la
società. Non avrebbe senso
interrogarsi sul buon ordine
politico senza avere un’idea
di ciò che l’ordine politico
deveperl’appuntogovernare,
e cioè le nostre interazioni
sociali.Cosìcomenonsipuò
tralasciare un altro nesso che
oggi forse si tende a relegare
in secondo piano, e che
invece era essenziale, per
esempio, per una filosofia
politica come quella di
Hobbes, e cioè quello con
l’antropologia filosofica. E
non meno importanti sono le
intersezioni con la filosofia e
la teoria del diritto, con la
scienza politica, con la teoria
sociale.
Proprioperchédevetener
conto di una complessa rete
di ricerche e di riflessioni,
che da ogni parte con essa
interferisce, la filosofia
politica occupa, nell’ambito
della filosofia, una posizione
abbastanzapeculiare:èpiùun
punto d’arrivo che un punto
di partenza, è il luogo dove
molti fili convergono, dove
riflessioni e ricerche diverse
devono trovare un punto
d’incontro e disporsi in una
figuracoerente.
3.Ledomande
dellafilosofiapolitica.
Delineando, in una
celebreconferenzadel1970,i
diversi significati che a suo
avviso si potevano dare
all’espressione
filosofia
politica,
Bobbio
ne
distingueva quattro, che
identificavano in sostanza
quattrodomandeallequalila
filosofia politica, nel corso
del suo sviluppo, aveva
cercatodidaredellerisposte:
la questione di quale sia
l’ottima costituzione politica,
la domanda sul fondamento
del-l’obbligo politico (perché
e,soprattutto,achidobbiamo
obbedire),
il
problema
concernente
la
natura
dell’agire politico e la sua
definizione, e infine la
questione,
di
tipo
epistemologico, concernente
il metodo e le condizioni di
validità
della
scienza
politica6.
Se si mette ora tra
parentesi la quarta questione,
che
risulta
piuttosto
eterogenearispettoallealtree
di
natura
puramente
metodologica, sembra che
quelle sulle quali valga la
pena di soffermarsi siano
invece le prime tre: l’ottima
costituzione politica, il
fondamento
dell’obbligo
politico, la natura dell’agire
politico. Assumendo questa
triade di problemi come
primo
filo
conduttore
dell’analisi,
ma
anche
apportando rispetto a essa
qualche
variazione,
cercheremo ora di tracciare
un quadro di quelle che
possono essere individuate, a
nostro avviso, tanto come le
domande fondamentali cui la
filosofia politica ha cercato
nella sua storia di dare
risposta,quantocomeitipidi
approccio alla problematica
filosofico-politica che si
possono riscontrare nella
vicenda
del
pensiero
filosofico-politico
occidentale.
3.1.L’approccio
normativo.Qualèil
giustoordinepolitico.
Se assumiamo come filo
conduttore la tripartizione
enunciata
da
Bobbio,
possiamo
osservare
innanzituttocheleprimedue
questioni messe in risalto
(l’ottimacostituzionepolitica,
il fondamento dell’obbligo
politico) costituiscono due
problematiche
tra
loro
profondamente interconnesse
delle quali si occupa quello
che definiamo l’approccio
normativo alla filosofia
politica. All’interno infatti di
un orizzonte normativo
rientranotantolaquestionedi
quale sia la miglior
costituzione politica, quanto
quella relativa al fondamento
dell’obbligo politico: nella
prospettiva
di
questa
domanda ci si chiede, infatti,
quali caratteristiche deve
avere l’ordine politico per
meritare l’obbedienza da
parte di coloro che a esso
sono sottoposti, ovvero per
essere considerato un ordine
politicolegittimo.
Ciò che caratterizza una
filosofia
politica
normativamente orientata è il
fattocheinessailtemadella
politica viene messo a fuoco
fondamentalmente
nella
prospettiva del dover essere;
l’obiettivo primario non è
quello di indagare i fatti
politicicosìcomesono,nella
loro natura o nella loro
struttura (sebbene questo
costituisca
sempre
un
passaggio essenziale nella
ricerca), ma quello di
giungere a delineare l’ordine
politico come dovrebbe
essere, per poter essere
riconosciuto come buono,
giusto, legittimo. Dalla
Repubblica di Platone alla
Teoria della giustizia di
Rawls,
la
tradizione
filosofico-politicaoccidentale
non ha cessato di elaborare
dei
grandi
paradigmi
normativi per rispondere alla
domandacircailmodoincui
dev’esserestrutturatounbuon
ordine politico. La tradizione
normativa è quindi, a nostro
avviso, quella che meglio
caratterizza l’approccio dei
pensatori occidentali alle
questioni della politica; ed è
per questo che di alcuni
grandi paradigmi normativi
(classici,
moderni
e
contemporanei)
ci
occuperemo nei capitoli
successividiquestolibro.
Il fatto che la domanda
circailbuonordinepoliticosi
riproponga come una delle
grandi questioni sempre vive
della tradizione filosofica
occidentale non vuol dire
naturalmente che questa
tradizione non sia segnata da
profondissime cesure. Così
come mutano gli orizzonti
filosofici, cambia, nelle
diverse prospettive, il modo
di intendere il rapporto tra
realtà e norma, o realtà e
valore.
Nell’orizzonte
aristotelico, per esempio, la
normanonvieneintesacome
qualcosa di separato dalla
realtà, ma al contrario come
ciò che corrisponde alla sua
più vera natura e al suo fine
intrinseco. Ed è solo con la
«grande divisione» humeana
che essere e dover essere,
momento
descrittivo
e
momentonormativo,vengono
pensati come radicalmente
eterogenei, in modo tale che
dal primo non si possa
ricavare il secondo. Le
differenze nel modo di
intendere la natura della
normatività non implicano
però un abbandono di quella
che resta la domanda di
fondo, cioè la ricerca intorno
al buon ordine politico. Essa
permanepurnelmutaredegli
orizzonti filosofici, degli
strumenti argomentativi, e
anche dei valori supremi ai
quali si ritiene che l’ordine
politico
debba
essere
riconducibile per poter venir
giudicato, appunto, un buon
ordinepolitico.Pergliantichi
questivalorisupremi,inbase
ai quali un ordine politico
deveesseregiudicato,sonola
giustizia o il bene comune;
mentre per la tradizione più
influentedelpensieropolitico
moderno il supremo valore
cui l’ordine politico dovrà
essere commisurato sarà
quello della libertà. Ma
questa
differenza
non
sopprime l’unità di un
comuneapproccionormativo,
così come non la sopprime il
fatto che gli approcci
normativi possono essere
molto differenti per quanto
riguarda il grado di
«distanza» che prendono
rispettoallarealtàpoliticadel
loro tempo: accanto a
costruzioni politiche che
collocanolarealizzazionedel
sommo valore in un mondo
totalmentedifferente(comela
Repubblica di Platone,
l’Utopia di Tommaso Moro
o, per altro verso, il
comunismo di Marx) ve ne
sonoaltrechepensanoinvece
il buon ordine politico come
una
«rettificazione»
dell’ordine politico già dato,
che ne conserva aspetti
fondamentali: si potrebbero
intendere, per esempio, il
liberismo di Hayek e il
liberalismo egualitario di
Rawlscomedueproposteper
«correggere», in opposte
direzioni, gli assetti delle
odierne società democratiche
e capitalistiche: nel primo
caso per porre argine alla
«democrazia illimitata» a
favore
del
liberismo
economico, nel secondo per
porre
limite
alle
diseguaglianze
attraverso
principi di giustizia. Più raro
è il caso di teorie normative
della politica che giungano
fino al punto di identificare
l’ordinepoliticomigliorecon
quello già attuato nel loro
tempo storico (questa per
esempio è una lettura che è
statadata,soprattuttodaparte
dei critici «di sinistra», del
pensiero politico di Hegel;
una lettura, però, di cui le
interpretazioni più accurate
hanno via via mostrato
l’inadeguatezza - e peraltro
Hegel appartiene alla teoria
politica normativa intesa in
senso«largo»);tuttaviaanche
questeteoriecheiloronemici
definirebbero «apologetiche»
(in contrapposizione con le
teorie di altro tipo, che si
potrebbero
definire
«critiche»)
restano
nell’orizzonte delle teorie
normative.
Per concludere su questo
punto si potrebbe dire quindi
cheleteorienormative,dicui
latradizioneoccidentaleciha
fornito
un
ricchissimo
campionario,
possono
certamente differenziarsi tra
loro secondo varie linee; qui
ne abbiamo individuate
almeno tre: la modalità
ontologica del rapporto
essere/dover essere (che può
essere
pensato
come
continuità
o
come
separazione più o meno
netta), la determinazione del
dover essere attraverso un
certovaloresupremo(ilbene,
la giustizia, la libertà,
l’uguaglianza o altro), il
gradodidistanzadelmodello
normativodallarealtàfattuale
(partendo da un grado di
distanza zero, e andando ad
accrescerla,
potremmo
distinguere
tra
teorie
apologetiche, critiche e
utopiche).
Le filosofie politiche
normative,
dunque,
si
pongono la domanda circa
l’ordine politico giusto;
ovvero, quando affrontano
questioni più specifiche, si
chiedono se una certa legge,
una certa istituzione (per
esempio, in Aristotele, la
schiavitù) siano giuste o
meno.
E
sviluppano
argomentazioni volte a
dirimere
questioni
di
giustizia. Perciò possiamo
dire che, nella tradizione del
pensiero occidentale, la
filosofia politica normativa è
anche, in un certo senso, la
prosecuzione
della
discussione politica tra i
cittadinicontempipiùlunghi
e strumenti argomentativi e
conoscitivi più sofisticati.
Come ha illustrato JeanPierre Vernant nei suoi
magistrali studi sull’origine
del
pensiero
filosofico
occidentale nella Grecia
classica, la discussione
politicapubblicatraicittadini
e la filosofia (non solo, si
badi, la filosofia politica, ma
la filosofia nel senso più
generale) nascono insieme,
con un solo e medesimo
parto.Ifilosofichediscutono
questioni di giustizia, quindi,
sono i prosecutori di quel
confronto pubblico degli
argomenti che si inaugura
nellapolis,quandolapolitica,
- come scrive Vernant «prende forma di agon: un
certameoratorio,unduellodi
argomenti che ha per teatro
l'agora, piazza pubblica,
luogo di riunione, prima di
essere un mercato». «Tra la
politicaeillogosc’ècosìun
rapporto stretto, un legame
reciproco. L’arte politica
consiste essenzialmente nel
maneggiareillinguaggio;eil
logos, all’origine, prende
coscienza di se stesso, delle
sueregole,dellasuaefficacia,
attraverso la sua funzione
politica»7.
Azione politica, filosofia,
e teoria politica normativa,
quindi, costituiscono tre
momenti geneticamente e
concettualmente
connessi;
circostanza
che
va
sottolineata non solo per
ricordare il grande contributo
diunostudiosocomeVernant
ma anche per un’altra, più
intrinseca
ragione.
L’insofferenza per la teoria
politica normativa in nome
della realtà effettuale o della
realistica presa d’atto dei
rapporti di forza, infatti, è
antica quanto la teoria
normativa stessa. Ma proprio
considerazionicomequelledi
Vernant sopra ricordate
dovrebbero aiutarci a capire
che, sebbene non possa mai
isolarsi
nella
sua
autosufficienza, l’approccio
normativo caratterizza però
un momento strutturale e
inestirpabile nel rapportarsi
delfilosofoall’orizzontedella
politica: perché, non solo
come cittadino, ma più
originariamente ancora come
uomo
razionale
e
responsabile,néilfilosofoné
nessun altro può sottrarsi
all’imperativo di prendere
posizione, e argomentarla,
sulle questioni che la
convivenzacivilepone.
3.2.L’approccio
realistico,da
MachiavelliaWeber.
Che il pensiero politico
debba occuparsi dello stato
come deve essere, è proprio
la tesi alla quale si
contrappone il testo più
classico ed emblematico del
realismo politico, il Principe
di Niccolò Machiavelli.
Volendocomporreuntrattato
utile a chi è impegnato
nell’agone politico, scrive
Machiavelli, «mi è parso più
convenienteandaredrietoalla
verità effettuale della cosa
che alla immaginazione di
essa. E molti si sono
immaginati repubbliche e
principatichenonsisonomai
visti né conosciuti essere in
vero; perché egli è tanto
discosto da come si vive a
come si doverrebbe vivere,
che colui che lascia quello
che si fa per quello che si
doverrebbe fare impara
piuttosto la ruina che la
perservazionesua:perchéuno
uomo,chevogliafareintutte
leparteprofessionedibuono,
convieneroviniinfratantiche
non sono buoni. Onde è
necessario a uno principe,
volendosi
mantenere,
imparare a potere essere non
buono,eusarlo e non l’usare
secondolanecessità»8.
Piuttosto che interrogarsi
sullo stato come dovrebbe
essere, quindi, il realismo
politico nella sua figura
machiavelliana si pone come
una riflessione sull'agire
politico così come esso è,
nella sua aspra «realtà
effettuale». Ma, a chi la
osservi da questo punto di
vista, la sfera dell’agire
politico
si
dischiude
innanzitutto come un regno
segnatodalcontrastoperenne
di centri di forza in conflitto,
che combattono per il potere
servendosi di tutta la gamma
di mezzi cui possono avere
accesso.
È tutt’altro che semplice,
però, nonostante quello che
può sembrare a prima vista,
tracciare
quelle
che
potrebbero
essere
le
«coordinate
concettuali»
dell’approccio realistico alla
questione dell’agire politico9.
Ilprimopuntochedev’essere
fissato, e che ritroviamo in
tuttiigrandipensatorirealisti,
daTucidide,aMachiavelli,a
Weber, è quello per cui
l’agire
politico
viene
concettualizzato innanzitutto
comelottaperilpotere:«Chi
fa politica - scrive per
esempio Max Weber nella
sua famosa conferenza del
1919-aspiraalpotere:potere
come mezzo al servizio di
altri obiettivi, ideali o
egoistici, o potere ‘in se
stesso’, cioè per godere del
senso di prestigio che esso
conferisce»10. Nell’ottica del
realismo, quindi, la sfera
dell’agire
politico
è
rappresentata come il campo
in cui agiscono attori in
conflitto per il potere. Ciò
non vuol dire, come Weber
sottolinea efficacemente, che
scopo dell’agire politico
debbaesserenecessariamente
il potere fine a se stesso; al
contrario,quellatesisignifica
semplicementeche,qualiche
siano i fini, anche i più alti,
nobili o altruistici, che il
politico spera di conseguire
con la sua azione, essi hanno
bisognodelmedium«potere»
per venir attuati, e dunque
non vi è politica che a
qualche forma di potere non
miri. Il punto di vista del
realismopolitico,però,nonsi
limita a fissare questa prima
tesi, che potrebbe persino
apparire ovvia; ci sembra
piuttosto che quello che lo
caratterizza sia la messa a
fuoco della dimensione
politica come dimensione o
ambito conflittuale, dove
agiscono attori in lotta tra
loro che si confrontano
essenzialmente in ragione
della forza (ovvero del
potenziale di costrizione,
influenza o minaccia) di cui
possono disporre. In questo
senso,
nell’ottica
del
realismo, la politica viene
decifrata
come
una
dimensionediquellocheoggi
chiameremmo
l’agire
strategico,
viene
letta
innanzitutto come conflitto e
rapporto di forze: per dirla
ancoraconMachiavelli,«tutti
e’profetiarmativinsono,eli
disarmatiriunorono»11.Ilche
vuol
dire,
molto
semplicemente, che per
conseguire un risultato in
politica non bananzitutto
prendereconoscenzadiquale
sialageometriadelleforzein
campo, e quindi disporsi ad
agireinmodotaledasuperare
la forza che ci si oppone con
una forza più grande. Nella
prospettiva del realismo
politico, insomma, come
sostiene ancora Max Weber
nella conferenza più volte
citata, la forza è il «mezzo
decisivo»12 di cui l’agire
politico non può in nessun
caso fare a meno. Ma questo
assuntodifondodelrealismo
politico,chedaMachiavellia
Marx a Weber viene sempre
di nuovo ribadito, non può
essere certo preso per buono
in modo acritico, come fosse
un articolo di fede; è
necessario piuttosto, seppure
inmodomoltorapido,cercare
dicomprenderemeglioilsuo
esatto significato e le sue
ragioni.
Spessoilrealismopolitico
si sposa con una visione
cruda o, più ancora,
pessimistica della natura
umana, di cui per esempio in
Machiavelli si trovano molti
documenti: se gli uomini
sono - per il Segretario
fiorentino come, dopo di lui,
perHobbes-pernaturaavidi
di potere e di ricchezza,
sempredispostiaingannaree
atradire,prontiadimenticare
«piùprestolamortedelpadre
che
la
perdita
del
patrimonio», allora è ovvio
che non intendono altra
ragione che la forza, e che
solo grazie a essa si possono
governare e tenere a freno.
Tuttavia, non è per nulla
scontato che il realismo
politico debba in ultima
istanza basarsi su una fosca
visionedellanaturaumana,o
su una visione (agostiniana o
calviniana) dell’uomo come
creatura irrimediabilmente
corrottadalpeccatooriginale;
in realtà, non ci sembra
sussista questa connessione
fondativa tra pessimismo
antropologico e realismo
politico, e si può ben
sostenereilsecondosenzafar
ricorso alle problematiche
assunzionidelprimo13.
Per comprendere come il
realismo politico possa
rivendicareilsuobuondiritto
anche prescindendo da una
visione pessimistica della
naturaumanapuòessereutile
riavviare il discorso dalla
perspicua definizione della
politica che Sheldon Wolin
pose all’inizio del suo ampio
volume intitolato Politica e
visione; la politica, sostiene
Wolin,èunaformadiattività
che mostra le seguenti
caratteristiche:
1)
è
«incentratasullaricercadiun
vantaggio competitivo tra
gruppi, individui o società»,
2)è«condizionatadalfattodi
aver luogo in un ambiente
mutevole caratterizzato da
relativa scarsità», 3) è «tale
chelaricercadiunvantaggio
determina conseguenze di
portata così vasta da
riguardare l’intera società o
una parte sostanziale di
essa»14.
Anche assumendo un
punto di vista piuttosto soft
come quello che sorregge
questa definizione, possono
essere facilmente rivendicate
lebuoneragionidelrealismo
politico: la politica ha a che
fare con la distribuzione di
vantaggi competitivi di vasta
portata tra attori e gruppi
sociali; l’agire politico incide
necessariamente
sulle
dotazionidipotere,ricchezza,
prestigio e più in generale
sulla distribuzione di costi e
benefici della cooperazione
sociale, che in ogni società
data sono distribuiti in modo
altamentecomplessoeavolte
scandalosamente ineguale; e
perciò
anche
senza
presupporre una visione
radicalmente negativa della
naturaumanasipuòassumere
che in ogni società i diversi
attori o gruppi conflig-gano
per ridurre i propri costi e
massimizzare
i
propri
benefici avvalendosi dei
mezzi di pressione e di
coercizione
di
cui
dispongono; e se ne può
dunque concludere che la
dimensione del conflitto di
forze è, ed è destinata a
restare, una delle dimensioni
che
connotano
l’agire
politico, che appartengono a
esso in modo strutturale.
Un’azionechemiraaincidere
sulladistribuzionedivantaggi
e svantaggi che hanno
conseguenze di vasta portata
per la vita sociale non può
non entrare a costituire un
elementodiunoscacchieredi
forze in conflitto; e il
realismosembraaveretuttele
ragioni finché ci ricorda che
la dimensione del polemos è
inseparabile
da
quella
dell’agire politico, mentre
rischia di sconfinare in una
visioneunilateraleearbitraria
se assume il polemos come
l’unica dimensione che
caratterizza l' agire politico,
trascurando le dimensioni
normative,
discorsive,
espressivedicuisitratteràdi
vedere che ruolo giochino
accanto a quella del puro
agire strategico. Una volta
che se ne sia riconosciuto il
buon diritto, non si può far a
meno di sollevare, contro il
realismo
politico
assolutizzato
e
monodimensionale, lo stesso
rilievo che gli muoveva
GehrardRitter,inunlibropur
segnatodaqualcheeccessodi
moralismo: l’ottica del puro
realismo non ha organi per
vedere ciò che proprio
l’analisi «realistica» del
carattere multidimensionale
della politica richiederebbe
che si mettesse a fuoco: «il
sentimentomoraledell’uomo,
la sua naturale reazione alla
bestialità, all’uso tirannico
del potere, alle menzogne
grossolane e alla corruzione
pubblica», nonché il suo
«naturale amor di libertà» e
«bisogno
di
pulizia
morale»15. Il rilievo critico
nonimpedivaperòaRitterdi
porreinrisaltoquellochegli
sembravailrisultatodivalore
«metastorico»
conseguito
dalla
riflessione
machiavelliana: l’aver cioè
compreso la politica come
lotta di potenze che in forza
dellasuastessalogicasiattua
servendosi «senza tanti
riguardi di tutti i mezzi
disponibili e senza far tante
questioni di bene e di
male»16.
Etica e politica. La
questione
del
realismo
politico si connette perciò
strettamente con quella del
nesso, o del conflitto, tra la
politica e la morale. Come
osservava Benedetto Croce
nelle sue rapide annotazioni
sul Machiavelli, è forse nella
messa a fuoco di questa
divaricazionecheèdavedersi
«laveraepropriafondazione
di una filosofia della
politica».
Machiavelli,
scriveva
Croce, «scopre la necessità e
l’autonomia della politica,
della politica che è di là, o
piuttosto di qua, dal bene e
dalmalemorale,chehalesue
leggi a cui è vano ribellarsi,
che non si può esorcizzare e
cacciare dal mondo con
l’acqua
benedetta»17.Questione
costitutiva per la filosofia
politica, quindi, è quella che
concerne l’aporia o il
dilemma del rapporto tra la
politica e la morale. Non si
può quindi far a meno di
soffermarsi brevemente su di
essa.
Un primo modo di
ragionare su questo tema è
quello che lo fa scaturire
dal rapporto per così dire
specularechesiinstauratrai
competitori
nell’arena
politica. Se chi fa politica è
unattoreinlottaconaltriper
il potere, allora costui deve
aspettarsi che i suoi
competitori usino, contro di
lui, tutti i mezzi che
consentanolorodicombattere
vittoriosamente la lotta per il
potere;quindichiunquesiain
lottaper il potere non può
esimersidalfarealtrettanto,e
perciò anche dal ricorrere a
quei mezzi, come la violenza
e l’inganno, che ogni visione
morale (o religiosa) della
realtà umana da sempre
condanna. Nella tradizione
occidentale, chi esprime in
modo paradigmatico questa
problematica è ancora una
volta Machiavelli, di cui
conviene
rileggere
innanzituttounpassofamoso.
Nel più «incriminato» tra i
capitolidel Prìncipe, il xviii,
così si legge: «Non può,
pertanto,
uno
signore
prudente,nédebbe,osservare
la fede, quando tale
osservanzia li torni contro e
che sono spente le cagioni
che la feciono promettere. E
se gli uomini fussino tutti
buoni, questo precetto non
sarebbe buono; ma perché
sono tristi e non la
osservarebbonoate,tuetiam
non l’hai ad osservare a
loro»18. Il politico che si
sentisse obbligato al rispetto
della parola data, insegna
questo passo, non farebbe
altro che lavorare alla sua
propria rovina, perché chi fa
politicadevesaperecheisuoi
nemici,sesitrovasseroalsuo
posto, si guarderebbero bene
dal mantenere la parola data;
e perciò comportarsi, in
queste circostanze, in modo
«morale»,
sarebbe
semplicementesuicida.
Daunaltropuntodivista
il tema è prospettato in un
celebre passo dei Discorsi,
paradigmatico per l’idea
moderna della ragion di
stato: «La quale cosa merita
di essere notata ed osservata
da qualunque cittadino si
truova a consigliare la patria
sua:perchédovesidiliberaal
tutto della salute della patria,
non vi debbe cadere alcuna
considerazione né di giusto
néd’ingiusto,nédipiatosoné
di crudele, né di laudabile né
d’ignominioso;anzi,posposto
ogni altro rispetto, seguire al
tutto quel partito che le salvi
la vita e mantenghile la
libertà»19. Qui l’aporia del
rapportotramoraleepolitica
si presenta sotto un altro
profilo:ilpoliticodeveavere
la capacità e l’ardire di
infrangere il comandamento
morale non perché i suoi
nemiciloinfrangerebberonei
suoi confronti, ma perché, e
in quanto, il fine dell’azione
politica (in questo caso, la
salvezza della res publica) è
fine supremo, che deve
prevalere su ogni altro, e
rispetto
al
quale
le
considerazioni di giusto e
d’ingiusto devono passare in
secondopiano.
Partendo
da
considerazioni come queste,
si potrebbe essere tentati di
sciogliereilconflittotraetica
epolitica,inMachiavelli,nel
segnodel«repubblicanismo».
Si potrebbe sostenere, con
Isaiah Berlin20, che non ci
troviamo di fronte a una
insanabilescissionetraeticae
politica, ma piuttosto al
conflittotradueetiche:daun
lato
un’etica
centrata
sull’individuo e sulla sua
coscienza del bene e del
male,dall’altroun’eticadella
polis
o
della
virtù
repubblicana, dove il valore
fondamentale diventa la
partecipazione alla vita della
comunità,
nella
quale
l’individuo realizza la sua
virtù e afferma la sua libertà.
Notevole è stata, soprattutto
in
tempi
recenti,
la
rivalorizzazione del tema
dellalibertàrepubblicanacosì
come
viene
sviluppato
soprattutto dal Machiavelli
deiDiscorsi: in esso Quentin
Skinner21 e altri studiosi
hanno visto un modo di
pensarelalibertàilcuivalore
teorico sarebbe, ancor oggi,
tutt’altro
che
esaurito.
Tuttavia(lasciandodaparteil
fatto che l’elemento davvero
rivoluzionario dei Discorsi
non sta tanto nel concetto di
libertà, quanto nell’idea,
questa sì davvero inedita,
della positività del conflitto
politico, che non è più visto
come semplice negatività e
discordia), non pare che, per
questa via, il dissidio tra
morale e politica possa dirsi
sanato: l’uomo che si batte
per il bene della sua patria,
questa è la convinzione di
Machiavelli,
dev’essere
pronto a sacrificarle anche il
bene della sua anima; e ciò
sembra chiudere la porta a
ogni pretesa di troppo facile
conciliazione.
Il conflitto che così
sembradelinearsitral’ambito
del-l’agire politico e la sfera
della legge morale è uno dei
grandi temi su cui la
riflessione filosofico-politica
non ha mai cessato di
interrogarsi, dando luogo a
esiti antitetici e problematici.
A un estremo, vi sono i
pensatorichequestoconflitto
hanno irrigidito fino a
renderlo elemento strutturale
e insuperabile; una posizione
che, a sua volta, sembra
destinata a biforcarsi al suo
interno,asecondacheall’uno
oall’altroelementosifinisca
per dare il privilegio. Sulla
tesi dell’insanabile dissidio
tra politica e morale, tra
politica e bene, convergono
paradossalmente, per poi
subito divaricarsi, tanto le
posizioni
dei
realisti
inflessibili, da Machiavelli a
Schmitt, quanto quelle di
coloro che sono stati
efficacemente
definiti
pensatori dell’«impolitico»
(da Simone Weil a Hermann
Broch), e che, partendo da
premesse
spirituali
di
tutt’altro genere, guardano
alla dimensione della politica
come a una pura lotta di
potere senza redenzione,
strutturalmente condannata,
proprio per la sua natura, a
non attingere mai la
dimensione del bene o della
giustizia. Un passo di
Hermann Broch dà voce in
modo eloquente a questa
paradossale
coincidentia
oppositorum:«Tutteleanalisi
dellapolitica-scrivel’autore
della Morte di Virgilio - che
ne riconoscono la mancanza
di fini considerandola come
una lotta per il potere fine a
se stessa (ad esempio le
analisi di Machiavelli e di
Clausewitz)
hanno
l’inestimabile vantaggio di
esseregiuste»22.
Già
nella
celebre
conferenza di Max Weber
sulla
Politica
come
professione, però, il dissidio
tra etica e politica si pone in
termini
non
meno
drammatici, ma certamente
più«mobili».Seildissidiolo
si vuole scrutare fino in
fondo,
è
necessario
innanzituttochiarirelanatura
dei termini che all’antitesi
dannocorpo;maciòsignifica
che non si può prendere per
acquisita
una
qualsiasi
visione di ciò che è la
moralità, ma che se ne deve
anzi precisare e indagare il
concetto (perché il dissidio
potrebbe risultare, forse,
proprio da un modo
insufficiente
o
troppo
semplicistico di intendere la
moralità). Ora Max Weber,
che certamente non è,
tecnicamente parlando, un
«filosofomorale»,metteperò
a fuoco quello che, in questo
contesto, risulta essere uno
dei
problemi
decisivi:
«dobbiamo renderci conto scrive - che ogni azione
eticamente orientata può
trovarsi tra due massime
inconciliabilmente opposte,
fondamentalmente diverse:
può essere orientata secondo
l’etica della convinzione o
secondo
l’etica
della
responsabilità»23. L’azione
morale insomma, ci avverte
Max Weber, si pensa in
almeno due modi, dai quali
derivano
conclusioni
totalmente diverse: se la si
intende
secondo
la
prospettiva dell’etica della
convinzione,alloraessanonè
altro
che
l’agire
conformemente a quello che
si
ritiene
essere
il
comandamento della morale,
disinteressandosi
delle
conseguenze che, quanto agli
effetti nel mondo, potranno
derivarne; se la morale mi
vietadimentire,allora,aveva
già sostenuto Kant nella sua
polemica contro Benjamin
Constant24, non mentirò
neppure all’assassino che va
in cerca della sua vittima:
l’aver seguito il puro
comandamento della morale
mi
esime
da
ogni
responsabilitàpergliesitiche
il corso degli eventi potrà
produrre. Chi agisce secondo
l’etica della responsabilità,
invece,ècoluichesisentein
dovere di rispondere anche
delleprevedibiliconseguenze
della propria azione: l’azione
moralmente giusta non è
quella che si limita a
corrispondere a un precetto,
ma quella che attua
concretamente un bene nel
mondo, o concretamente
impedisce
un’ingiustizia.
Perciò, dal punto di vista
dell’eticadellaresponsabilità,
vale il principio: «Devi
resistereconviolenzaalmale,
altrimentiseiresponsabiledel
suo prevalere»25. Il vero
politico, dice Max Weber,
non può non essere sensibile
alle ragioni dell’etica della
responsabilità;anzi,ilgrande
politico è solo colui che
riesce
(paradossalmente,
forse) a riunire in sé ciò che
finquieraapparsoantitetico:
etica della responsabilità per
le conseguenze ed etica della
convinzione, nel senso di
fedeltà ai suoi principi. Ma
l’agire nel senso dell’etica
dellaresponsabilitàèappunto
ciò che complica, o forse fa
crollare, quel secco dissidio
tramoraleepoliticadalquale
avevamo preso le mosse: il
politico responsabile infatti,
sostiene
«realisticamente»
MaxWeber,devesapereche,
entrando in una dimensione
dove vigono il potere e la
forza,nonpuòfareamenodi
entrare in contatto con le
«potenze demoniache», col
male, con ciò che mette in
pericolo
la
«salvezza
dell’anima»26; ma al tempo
stesso sa che questo non è
semplicemente un cedere al
male, ma al contrario è
proprioquellochelasuaetica
della
responsabilità
gli
impone. La riflessione di
Webersuquestopunto,dopo
essere passata attraverso le
antitesi e i paradossi, si
conclude infine con una
sintesi che forse potrà
apparire troppo pacificata:
«Pertanto,
l’etica
della
convinzione e l’etica della
responsabilità non sono
assolutamente atteggiamenti
antitetici, ma complementari,
che soltanto quando sono
congiunti formano l’uomo
vero,quellochepuòavere la
‘vocazioneallapolitica’».Ma
come si possono considerare
complementaridueeticheche
rispondono a principi che lo
stessoWebercihapresentato
come contrapposti ? I
paradossi del rapporto eticapolitica sono in realtà più
difficili da districare, proprio
perchéledimensionidisenso
e di razionalità che sono
implicate dall’agire politico
sono molteplici e complesse,
e poco si prestano alle
riduzioni ad unum e alle
troppofacilisistemazioni.
3.3.Ladimensione
esistenzialedella
politica.Hannah
Arendt.
Già dalle considerazioni
chefinquiabbiamosvoltosi
può forse trarre un primo
risultato: l’ambito dell’agire
politico sembra sfuggire a
ogni
approccio
monodimensionale
e
richiedere invece, per essere
pensato,
un
quadro
concettuale
riccamente
articolato. Dalla politica,
crediamodiavermostratofin
qui, non si può espungere né
la dimensione morale dalla
giustizia, né la dimensione
strategicadelconflittoedella
forza (quali che siano poi i
rapporti, certo complicati e
non pacificati, tra questi due
ambiti).
Ciò non vuol dire però
che queste due dimensioni
esauriscano il significato
dell’agire politico nel più
ampiocontestodellasocialità
umana; anzi, chi prospettasse
la questione in questo modo
finirebbe forse per perdere,
della dimensione politica,
aspetti essenziali. Se è vero
che la politica è certamente
competizione per ottenere
vantaggi in termini di potere,
di onori, di ricchezza, se è
vero che da essa non si può
espungere il tema della
legittimità, cioè della ricerca
di
una
legittimazione
razionale in termini di
giustizia o di libertà, è anche
veroche,limitandosiaquesti
aspetti, si rischia forse di
trascurare dimensioni meno
evidenti ma più profonde: si
rischia cioè di non vedere il
fatto che l’agire politico non
risponde solo a logiche
autointeressate o a orizzonti
universalistici, ma trova
invecemotivazioninonmeno
profonde in quella che
potremmo
chiamare
la
dimensione della ricerca di
senso che, non meno delle
altre qui sopra richiamate,
sembra costituire una delle
strutture
inaggirabili
dell’umanoessereinsocietà.
Il rilievo dell’opera di
HannahArendtstaproprio,si
potrebbe sostenere, nella
capacità che hanno le sue
pagine di lanciare dei
sensibili scandagli in questa
dimensione. Per Arendt la
comprensione del senso della
politica resta povera se non
prende le mosse da una
riflessionedipiùlargoraggio
sulla condizione umana.
L’indaginecheArendtsvolge
sulla Vita activa ha proprio
come obiettivo quello di
mettere in luce come le
diverse
dimensioni
dell’attività
umana
corrispondano a diversi
aspetti di quella che l’autrice
individuacomelacondizione
dell’uomo. Mentre l’attività
lavorativa è resa necessaria
dal fatto che l’uomo deve
riprodurre le condizioni
materiali della sua vita, la
secondadimensionedellavita
activa, quella che Arendt
chiamal'operare,rispondeal
dato per cui l’esistenza
umana, a differenza di quella
animale, ha come sua
condizionelacreazionediun
mondo artificiale di cose,
permanente e nettamente
distinto
dall’ambiente
naturale. Da queste due
dimensionisidistingueinfine
quellanellaqualesiradicala
politicaecheHannahArendt
chiamal'azione.L’azionenon
ha a che fare con i rapporti
uomo/cosa,maconirapporti
diretti tra gli uomini; essa va
compresa a partire da due
aspettichesecondolaArendt
sono
fondamentali
per
intendere la condizione
umana,ecioèlapluralitàela
natalità.
Che la condizione umana
sia
caratterizzata
dalla
pluralità sta a indicare,
nell’orizzontearendtiano,una
circostanza molto precisa: e
cioè non solo che vivere
significaesseretragliuomini
(con-essere, avrebbe detto il
maestro
della
Arendt,
Heidegger),macheesseretra
uomini vuol dire al tempo
stesso essere tra uguali e
diversi: «la pluralità è il
presupposto
dell’azione
umana perché noi siamo tutti
uguali, cioè umani, ma in
modo tale che nessuno è mai
identico ad alcun altro che
visse, vive o vivrà»27. Ma se
èverochelapluralitàumana
è la «paradossale pluralità di
esseri unici»28, allora è
proprio in questa unicità che
l’azione politica, secondo
Arendt, trova la sua radice.
L’agiretragliuomini,infatti,
è quella dimensione nella
quale, con i loro atti e con i
loro discorsi, gli uomini
manifestano agli altri la loro
identità, affermano «chi»
sono, e quindi, diremmo con
un linguaggio un po’ diverso
da quello della Arendt,
costituiscono il senso sempre
precario della loro identità
stabilizzandolo
proprio
nell’atto in cui lo rendono
manifestoadaltri.
All’idea di una pluralità
che è al tempo stesso
uguaglianza e unicità si
intrecciano strettamente gli
altri due fili del discorso
arendtiano, quello della
natalità
e
quello
dell’immortalità.
Proprio
perché ogni individuo è
irriducibilmente unico, il suo
venire al mondo significa al
tempo stesso la capacità di
dar luogo a qualcosa di
nuovo; in quanto unico
l’individuo possiede la
capacità di iscrivere nella
realtàqualcosadiinedito,che
prima non c’era. E sebbene,
come nota Arendt, un
elemento di natalità sia
intrinseco a tutte le attività
umane, è nell’azione politica
chelacategoriadellanatalità
trova la sua corrispondenza
più diretta. Nell’azione che
fonda un organismo politico
nuovo, o che ne rinnova uno
esistente, si esprime, dunque,
tanto la natalità che
caratterizza l’umano, quanto
quello che è in qualche
modo il suo necessario
contro-polo, il ricordare,
perché l’irruzione del nuovo
crea al tempo stesso le
condizioniperilricordoeper
la storia (solo del nuovo,
vorremmo dire, può esserci
storia, del sempre uguale c’è
solostorianaturale).
Per i Greci, nella cui
civiltà della polis si fonda,
per la Arendt, il nostro
concetto della politica,
l’azionecheèdegnadiessere
ricordata, quindi, è capace di
trascendere la mortalità del
singolo uomo per attingere
una sorta di immortalità: va
oltre la caducità dell’essere
umanorivelandounanatura«
divina »29. Si stringe così il
nesso
tra
natalità
e
immortalità: l’uomo, in
quanto soggetto d’azione,
possiede la capacità di
generare
l’inatteso,
l’infinitamente improbabile,
che proprio in quanto tale si
sottrae al mero circolo della
vita naturale e si afferma
nella
permanenza
dell’immortalità.
L’importanza della lettura
arendtianadella polis, con lo
spazio pubblico che questa
apriva di fronte a chi volesse
compiere grandi imprese o
pronunciarediscorsiprofondi,
non
sta
certo
nella
ricostruzione più o meno
attendibile di un contesto
storico, quanto nel fatto che
ci aiuta a chiarire il senso
esistenziale della politica. La
poliscostituisce, nella lettura
arendtiana, innanzitutto uno
spazio pubblico dove il
singolo può mostrarsi agli
altri nella sua irripetibile
singolarità, che solo nel
mettersi in scena di fronte a
un pubblico si consolida e si
fissa come tale: «senza uno
spaziodell’apparenzaesenza
fiducia nell’azione e nel
discorsocomemodidiessere
insieme, né la realtà del
proprio sé, cioè la propria
identità, né la realtà del
mondo che ci circonda
possonoesserepreservatedal
dubbio...Ilsolocaratteredel
mondo che permette di
misurare la realtà è il suo
essere comune a tutti...»30.
L’apparire davanti agli altri
nell’azione politica (atti e
discorsi) che si compie nello
spazio pubblico è quindi il
modo in cui l’individuo può
mettereinscenadifronteagli
altri, e quindi anche rendere
stabiledifronteasestesso,la
sua identità unica; ed è
altempostessolacondizione
perché ciò che si è compiuto
di inedito e di grande possa
essere ricordato e tramandato
dalle generazioni che si
succederanno, conservandone
la memoria. L’agire nella
sfera pubblica al cospetto
degli altri e con gli altri,
quindi, è salvezza contro
l’evanescenza del senso e la
futilità delle pratiche umane
puramente
riproduttive.
L’organizzazione della polis
«assicural’attoremortaleche
la sua esistenza transeunte e
la sua fuggevole grandezza
non perderanno mai la realtà
che proviene dall’esser visti,
uditi
e
in
generale
dall’apparire davanti a un
pubblico di uomini simili a
lui...»31.
«Alla
base
dell’anticastimariservataalla
politica - scrive ancora la
Arendt-èlaconvinzioneche
l’uomoinquantouomo,ogni
individuonellasuairripetibile
unicità, appare e conquista la
sua identità nel discorso e
nell’azione, e che queste
attività, malgrado la loro
futilità da un punto di vista
materiale, posseggono una
qualità durevole perché
provocanoilricordodisé.La
sfera pubblica, lo spazio nel
mondo di cui gli uomini
hannobisognoperapparire,è
quindi ‘opera dell’uomo’ più
specificamente di quanto non
losial’operadellesuemanio
illavorodelsuocorpo»32.
Non ci interessa qui
seguire tutte le implicazioni
che Arendt ricava dalla sua
originale lettura dell’agire
politico, né discutere altri
aspettidelsuopensiero.Quel
checistaacuore,piuttosto,è
trarre, dalle sue riflessioni,
qualche indicazione ai fini di
una prima illuminazione e
delineazione del campo della
politica. Già dalle prime
suggestioni e dai sommari
riferimenti che abbiamo fin
qui raccolto esso ci appare
come
un
campo
straordinariamente
multidimensionale.Inesso,si
potrebbe
dire
facendo
riferimento a un filosofo
politicocontemporaneo,sono
all’opera in modo al tempo
stesso sinergico e dissonante
tutte quelle che Habermas ha
individuato come le distinte
ed eterogenee dimensioni
della razionalità dell’azione
umana. All’agire politico
appartiene certamente (ed è
quello su cui hanno insistito
tutti i grandi classici del
realismo) il momento della
razionalitàchemodernamente
potremmo definire strategica:
non c’è politica senza lotta
competitiva tra attori che
intendono conseguire fini
conflittuali. Ma alla politica
appartengono
altrettanto
inesorabilmente il momento
della razionalità morale,
ovvero della giustizia, e
quello, che abbiamo voluto
sottolineare con il richiamo
allaArendt,dellacostituzione
simbolicadisensodellarealtà
umana e della espressione
autentica di sé33. Il motivo
per cui la politica risulta
essere
un
oggetto
categorialmente
così
complicato a nostro avviso è
proprio questo: mentre le
varie
dimensioni
di
razionalità dell’azione si
possono isolare come tipi
ideali(edèl’impresache,tra
gli altri, ha tentato Habermas
nella Teoria
dell’agire
comunicativo, distinguendo i
tipi dell’agire strategico,
dell’agireregolatodanormee
dell’agire ‘drammaturgico’),
nell’agire politico queste
dimensionileritroviamotutte
all’opera, con la loro
necessità e ineludibilità ma
anche con la difficoltà di
integrarsi in un orizzonte
armonico. In questo si
potrebbe vedere, forse, un
indice della natura tutto
sommato paradossale della
politica. Ma non è su questa
strada che ora vorremmo
avventurarci. La grande
prestazione del pensiero
politico occidentale, nato
come si diceva dal grembo
della polis, è stata quella di
avere elaborato una serie
imponente di paradigmi
normativi della politica, o,
come anche si potrebbe dire,
di modelli di giustizia. È ad
essiperciòchevorremmoora
volgere la nostra attenzione,
con l’intento di richiamare
alla mente alcuni paradigmi
teoricidistraordinariovigore,
con i quali, per quanto siano
lontanineltempo,lafilosofia
politica continua anche nel
presenteafareerifareiconti.
1 Per una sintetica
introduzione al concetto di
statosivedailvolumedip.p.
Portinaro, Stato, il Mulino,
Bologna 1999 (incluso nella
serie
«Lessico
della
politica»). Utili anche il
volume di n. bobbio, Stato,
governo, società, Einaudi,
Torino 1993 e quello di N.
MATTEUCCI,Lostatomoderno,
ilMulino,Bologna1997.
2 M. weber, La politica
come professione (1919),
trad. it. Armando, Roma
1997.P-333 L. strauss,Che cos’è la
filosofia politica, trad. it. a
curadiP.F.Taboni,Argalia,
Urbino1977,pp.34-35.
4Traimoltipensatoriche
hannointerpretatolafilosofia
in questo modo, uno è stato
sicuramente Theodor W.
Adorno; cfr., per esempio, il
saggio Kritik, nel volume
omonimo Kritik. Kleine
Schriften zur Gesellschaft,
Suhrkamp, Frankfurt am
Main1971,pp.10-19.
5 Strauss, Che cos’è la
filosofiapoliticacit.,p.36.
6 Queste riflessioni di
Bobbio si possono ora
rileggere in Teoria generale
delta politica, a cura di M.
Bovero, Einaudi, Torino
1999,pp.5-16.
7 j.-p. vernant, Le origini
del pensiero greco (1962),
trad.it.EditoriRiuniti,Roma
1976,p.39ep.42,
8 N. machia velu, Il
Principe, introduzione e
commento di G. Sasso, La
Nuova Italia, Firenze 1963,
cap.xv,pp.136-37.
9 Cfr. comunque, sul
tema, il recente volume dip.
p. Portinaro, Il realismo
politico, Laterza, Roma-Bari
1999.
10 WEBER, La politica
comeprofessionecit.,p.33.
11 MACHIAVELLI, Il
Principecit.,cap.VI,p.60.
12 WEBER, La politica
comeprofessionecit.,p.104.
13 Ciò è vero anche nel
casodiMachiavelli:comeha
mostrato Gennaro Sasso con
ricchezza di argomentazioni,
sarebbe una interpretazione
inadeguataquellacheponesse
la «tristizia» della natura
umanaalleradicidellalettura
machiavelliana della politica.
Cfr. G. SASSO, Niccolò
Machiavelli. Storia del suo
pensiero politico, il Mulino,
Bologna1980,p.415.
14 s. wolin, Politica e
visione.
Continuità
e
innovazione nel pensiero
politico occidentale (i960),
trad. it. il Mulino, Bologna
1996,pp.22-23.
15 G. RITTER,Ilvolto
demoniaco delpotere (1948),
trad. it. il Mulino, Bologna
1958,p.36.
16Ibid.
17 B. CROCE, Etica e
politica, Laterza, Bari 1981,
p.205.
18MACHIAVELLI,IlPrincipe
cit.,cap.xviii,pp.152-53.
19 MACHIAVELLI, Discorsi,
III,41,inOpere,acuradiE.
Raimondi, Mursia, Milano
19838,p.388.
20 Questa tesi di Berlin,
sostenuta nel saggio The
OriginalityofMachiavelli,in
AA.VV.,
Studies
on
Machiavelli, a cura di M. P.
Gilmore, Sansoni, Firenze
1972,pp.147-206,èdiscussa
e criticata in SASSO, Niccolò
Machiavellicit.,pp.433sgg.
21 Gli studi fondamentali
suMachiavellielatradizione
repubblicanasonoquellidiQ.
SKINNER (Le origini del
pensiero politico moderno
(1978), trad, it. il Mulino,
Bologna 1989; Machiavelli
(1981), il Mulino, Bologna
1999)edij.G. A.POCOCK,
Il momento machiavelliano
(1975), 2 voli., trad. it. il
Mulino, Bologna 1980. Cfr.
anche M. VIROLI, Dalla
politica alla Ragion di stato,
Donzelli,Roma1992.
22IIpassodiBroch,tratto
dallaraccoltadisaggiAzione
e conoscenza, è citato nella
introduzione di Roberto
Esposito al volume Oltre la
politica.
Antologia
del
pensiero«impolitico», a cura
di R. Esposito, Bruno
Mondadori, Milano 1996, p.
11. Si deve a Roberto
Esposito la riproposta, ma in
un senso completamente
diverso da quello di Thomas
Mann (Considerazioni di un
impolitico), del concetto
dell’«impolitico». Si vedano
aquestopropositosoprattutto
i suoi lavori: Categorie
dell’impolitico, il Mulino,
Bologna 1988 e Nove
pensieri sulla politica, il
Mulino,Bologna1993.
23 WEBER, La politica
comeprofessionecit.p.102.
24
Per
un’ampia
illustrazione della polemica e
delle sue implicazioni è utile
il volume I. KANT e B.
CONSTANT, La verità e la
menzogna, a cura e con
introduzione
di
A.
Tagliapietra,
Bruno
Mondadori,Milano1996.
25Ibid.,p.101.
26Ibid.,p.113.
27 H. arendt, Vita activa
(1958), trad. it. Bompiani,
Milano1994,p.8.
28Ibid.,p.128.
29Ibid.,p.15.
30Ibid.,p.153.
31Ibid.,p.145.
32Ibid.,p.153.
33
Il rapporto tra
autenticità e politica è
centraleneilavoridiA. FERRA
RA: Autenticità riflessiva,
Feltrinelli, Milano 1999, e
Giustiziaegiudizio,Laterza,
Roma-Bari2000.
Parteseconda.
Paradigmidella
filosofiapolitica
II.L’ordinedellapolis
I.«Polis»e
democrazia.
La politica come ancora
la pensiamo noi, uomini del
xxi secolo, è, a differenza di
molte altre pratiche sociali,
una pratica per la quale
possiamo
individuare
un’originebenprecisa1:siala
parola che la cosa nascono
nella Grecia classica, da
quella peculiare istituzione il
cui mito è ancora ben vivo
nel Novecento (lo abbiamo
vistorileggendopocosoprale
pagine di Hannah Arendt) e
chevasottoilnomedipolis.
La città-stato greca (il
modello della quale nella
culturaoccidentaleèAtenee,
più precisamente, l’Atene
democratica),nascetrailviie
ilvisecoloavantiCristodalla
crisi delle forme tradizionali,
regali e sacrali della
sovranità. Il potere non è più
appannaggio delle stirpi
aristocratiche
che
dominavano dai loro palazzi
fortificati,
ma
trapassa
idealmente in quello che è il
centrosimbolicodellacittà:la
piazza, l'agora, lo spazio
pubblico comune a tutti i
cittadini, che attraverso di
esso si riconoscono come
comunità, e che intorno a
esso stabiliscono le loro
dimore e le delimitano
attraversolacintadimura.La
città stato greca è il luogo in
cui compare per la prima
volta quella novità radicale
che è la discussione politica
nello spazio pubblico. Con
essaeinsiemeaessanascono
quellepratichechesonostate
caratteristiche per tutta la
storiadellaciviltàoccidentale
come
il
discorso
argomentativo, la filosofia, il
dibattito politico, il pensiero
politico. Nella polis la
sovranità
sempre
più
laicizzata è posta al centro
della istituzione comunse e
diventa oggetto di un
dibattere che si svolge nella
sfera pubblica dell 'agora', il
comando, quindi, non è più
proprietà
esclusiva
di
qualcuno, di un eletto per
ragioni di stirpe, sacrali o
religiose, ma è il risultato di
un confronto dialettico, di un
agone in cui si sfidano i
miglioridiscorsielemigliori
qualità, e nel quale, per così
dire, si «urbanizza» la
mentalità al tempo stesso
agonisticaedegualitaria(trai
«signori») che caratterizzava
learistocrazieguerrieredicui
i poemi omerici ci hanno
tramandatoilritratto.
Alla città si accompagna
la nascita della legge scritta,
«regola comune a tutti ma
superiore a tutti, norma
razionale
sottoposta
a
discussione e modificabile
per decreto»2. L’uguaglianza
dei cittadini che così si
cominciaadeterminarenonè
certo, da principio, una
perfettasimmetriadidiritti;e
la polis perpetua, allargando
al tempo stesso il consenso
verso di essa, la primazia
sociale degli aristocratici e
dei
proprietari
terrieri.
L’uguaglianza consiste però,
come scriveva Jean-Pierre
Vernant,nelfattocheidiritti
sono distribuiti con un
criterio di proporzionalità,
che «la legge è la stessa per
tutti i cittadini e che tutti
possonofarpartedeitribunali
comedell’assemblea»3.
Il modello classico della
polisdemocratica,destinatoa
rimanere un punto di
riferimento per tutta la
tradizione del pensiero
politico occidentale, è quello
delle istituzioni politiche di
Atene, così come vengono
definite, nel 508-507 a.C.,
dalla riforma democratica di
distene e successivamente,
alla metà del v secolo, dalle
riforme
di
Pericle.
L’istituzione nella quale si
incarnalasovranitàpoliticaè
l’Assemblea dei cittadini di
pienodiritto,l'ekklesia:essaè
aperta a tutti i cittadini
maschi e liberi che abbiano
più di 18 anni; in essa tutti
hanno diritto di parola e le
decisioni vengono prese a
maggioranza. L’assemblea
rappresentalapiùaltaautorità
decisionale sulle questioni
legislative e sulle più
importanti questioni di
governo.
L’attività
di
carattere più propriamente
amministrativo
veniva
esercitatainvecedaunaparte
piùlimitatadellacittadinanza,
il consiglio dei 500 (boule).
Moltedelleprincipalicariche
politiche venivano attribuite
per sorteggio, ed era previsto
un compenso per chi era
designato a ricoprirle. La
politica ateniese consisteva
dunque di meccanismi di
deliberazione
che
funzionavano attraverso un
sistema di democrazia diretta
e partecipativa; si trattava
quindidiunademocraziache,
a differenza di quelle
moderne,eraprivadiunvero
e proprio apparato statale, e
nellaqualeavevanoinveceun
ruolo di primo piano il
confronto degli argomenti e
ladiscussionepubblica.
È proprio nel contesto
della città, e dei dibattiti che
in essa si svolgono, che si
manifestano le prime forme
di pensiero politico: i sofisti
mettono in risalto la
convenzionalitàdelnomos,le
leggidellacittà,rispettoauna
presunta giustizia naturale; o
si spingono persino, come il
Trasimaco rappresentato nel
libro I della Repubblica di
Platone, a demistificare ogni
idea di giustizia sostenendo
che questa non consiste in
altro che nell’utile del più
forte. Tucidide, narrando
dello sterminio dei Melii da
parte degli ateniesi nella
guerra del Peloponneso,
mostra per la prima volta
sulla scena il più duro
realismo politico, assertore
del dominio senza alternative
della legge della forza4. Il
pensiero
di
matrice
aristocraticaeoligarchica(cui
dà voce il famoso pamphlet
La
costituzione
degli
ateniesi),
sviluppa
una
precoce
critica
della
democrazia come regime che
portala«canaglia»allaguida
dello stato e che, con
l’imperialismo
ateniese,
consente alla plebaglia di
soddisfare i suoi appetiti
dominando, nella città, sui
possidenti e, verso l’esterno,
sullealtrecomunità.Ilsofista
Protagora,
per
contro,
legittima la democrazia,
sostenendo la tesi che la
capacitàdifarepoliticanonè
un talento speciale, di cui
solo alcuni siano dotati, ma
un’attitudine che tutti i
cittadini possono avere o
acquisire. Conformemente
alla
visione
convenzionalistica che è
propria
della
sofistica
Protagora afferma, secondo
quanto possiamo leggere nel
Teeteto di Platone, che il
giusto e l'ingiusto dipendono
daciòchelacittàstabiliscein
materia. Giusta la tesi
protagorea che l’uomo è
misuradituttelecose,nonsi
può dire che un individuo
sia più saggio di un altro o
che una città superi un’altra
per la bontà delle sue
istituzioni.
2.Lavisione
platonicadelBene
politico.
La giovinezza di Platone
e la condanna a morte di
Socrate si collocano in una
fase in cui la democrazia
ateniese, dopo i fasti dell’età
di Pericle, conosce un’epoca
di profonda crisi. È proprio
questa democrazia ormai
debole e malsicura che, nel
399 a.C., si assume la
responsabilità della condanna
amortediSocrate;esperienza
che sarà determinante per la
formazione del pensiero del
suo giovane allievo Platone
(427-347a.C.).
Lo racconta Platone
stesso nella Lettera VII:
«Quandoerogiovane,ioebbi
un’esperienza simile a quella
di molti altri: pensavo di
dedicarmi alla vita politica,
non appena fossi divenuto
padrone di me stesso». Ma
l’osservazione della vita
politica reale doveva presto
farlo recedere da questa
intenzione. In un primo
momento egli aveva riposto
qualchesperanzanelgoverno
dei Trenta Tiranni tra i quali
egli, come appartenente
all’aristocrazia
ateniese,
contava numerosi parenti e
conoscenticheloinvitaronoa
collaborare. Ma questo
governo
fece
presto
rimpiangerequelliprecedenti;
«tral’altro-raccontaPlatone
- un giorno mandarono,
insieme con alcuni altri,
Socrate, un mio amico più
vecchiodime,unuomoch’io
non esito a dire il più giusto
delsuotempo,adarrestareun
cittadino per farlo morire,
cercando in questo modo di
farlolorocomplice,volesseo
no; ma egli non obbedì,
preferendo correre qualunque
rischio che farsi complice di
empi misfatti. Io allora,
vedendo tutto questo ... fui
preso da sdegno e mi ritrassi
dai mali di quel tempo».
Venne poi la restaurazione
dellademocrazia,chesembrò
portare al potere uomini
«pienidimoderazione».«Se
non che accadde poi che
alcuni potenti intentarono un
processo a quel mio amico,
Socrate, accusandolo di un
delitto nefandissimo, il più
alieno dall’animo suo: lo
accusarono di empietà, e fu
condannato,elouccisero,lui
che non aveva voluto
partecipare all’empio arresto
di un amico degli esuli di
allora, quando essi pativano
fuori della patria. Vedendo
questo, e osservando gli
uomini che allora si
dedicavano alla vita politica
... tanto più mi sembrava che
fosse difficile partecipare
all’amministrazione
dello
stato, restando onesto»; «alla
fine m’accorsi che tutte le
città erano mal governate,
perché le loro leggi non
potevano essere sanate senza
una
meravigliosa
preparazione congiunta con
una buona fortuna, e fui
costretto a dire che solo la
retta filosofia rende possibile
di vedere la giustizia negli
affari pubblici e in quelli
privati». Platone conclude
questo passaggio affermando
latesichecostituisceancheil
pernodellaRepubblica:«vidi
dunque che mai sarebbero
cessate le sciagure delle
generazioni umane, se prima
alpoterepoliticononfossero
pervenutiuominiveramentee
schiettamentefilosofi,oicapi
politicidellecittànonfossero
divenuti, per qualche sorte
divina,verifilosofi»5.
Lungi dal costituire una
tesi bizzarra, l’affermazione
platonica che solo i filosofi
potrebbero essere dei buoni
reggitori risponde alla logica
stringente
della
sua
argomentazione. Il compito
dell’arte politica, di quella
che nel dialogo Il politico
Platone definisce come l’arte
regia e suprema, che deve
orientaretuttelealtreelavita
della comunità nel suo
complesso6, è quello di
attuare il bene di ognuno nel
bene della comunità. E il
bene per gli uomini non
coincidenecessariamentecon
quello
che
essi
si
rappresentano come tale;
anzi,ilverobeneconsistenel
coltivare la perfezione della
propriaanimaenelseguirela
giustizia. La vera arte
politica, che realizza il bene
dellacomunità,devealtempo
stesso, e proprio in quanto
tale, rendere anche migliori i
cittadini: le buone leggi e il
buon governo hanno come
compitononultimoquellodi
creare buoni cittadini7. Se
però la politica si riduce,
come accade troppo stesso
nella città reale, a una
competizione feroce per gli
onorieperilpotere,essanon
potràcherisultareinadeguata
al conseguimento di quelli
che sono i suoi autentici fini.
Una buona politica, perciò,
potranno farla solo i veri
filosofi, per ché questi,
avendocompresoinchecosa
consista il vero bene, non si
azzufferanno, come ciechi
abitantidiunregnodiombre,
perlaricchezza,perglionori
eperilpotere,maalcontrario
non desidereranno di meglio
che allontanarsene, per
ricercarequellichesonobeni
piùcompleti,laconquistadei
quali non costringe a recare
ingiustizia ad altri e quindi
non rovina e corrompe il sé
(poiché,
come
insegna
Socrate nel Gorgia, fare
ingiustiziaèunmalepeggiore
chesubirla)8.«L’amantedella
sapienza - ha scritto Sheldon
Wolin nelle belle pagine che
ha dedicato al pensiero
politico di Platone - a
differenza di coloro che
desideravanoardentementela
ricchezza e il potere, non era
in competizione con i suoi
concittadini,néraggiungevai
suoi scopi a spese del
prossimo. La sua era la sola
attività dalla quale traeva
vantaggio
l’intera
comunità»9.
Nelmodopiùnettoqueste
conclusioni,forseparadossali
ma certo rigorosamente
dedotte, sono espresse nel
settimo
libro
della
Repubblica: la maggioranza
deglistatisonooggiesempre
governati da «persone che si
battono fra loro per ombre e
si disputano il potere, come
sefosseungrandebene».Ma
la verità è altra: «lo stato in
cuichidevegovernarenonne
ha il minimo desiderio, è per
forza
amministrato
benissimo, senza la più
piccola discordia, ma quello
in cui i governanti sono di
tipo opposto, è amministrato
inmodoopposto...Seperchi
deve governare troverai un
modo di vita migliore del
governare [cioè il filosofare]
ottima
potrà
essere
l’amministrazione del tuo
stato, perché sarà il solo in
cui governeranno le persone
realmente ricche, non di oro,
ma di quella ricchezza che
rende l’uomo felice, la vita
onesta
e
fondata
sull’intelligenza. Se invece
vanno al potere dei pezzenti,
avidi di beni personali e
convinti di dover ricavare il
lorobenedilì...ilgovernoè
oggetto di contesa e una
simileguerracivileeintestina
rovina con loro tutto il resto
dello stato ... Al governo
devono andare persone che
non
amino
governare,
altrimenti la loro rivalità
sfocerà in contesa»10. Alla
rissosità
della
polis
democratica, ai discorsi
abilmente persuasivi dei
sofisti,cheprosperanosulsuo
terreno, si può rispondere
solo, per Platone, con la
riaffermazione della vera
filosofia e del principio della
competenza, che rovescia il
principiodemocraticopercui
tutti sarebbero in grado di
giudicaregliaffaripubblici.
Come la città ha bisogno
del filosofo, anch’egli da
parte sua ha bisogno della
città: non ci può essere, per
Platone,
una
felicità
contemplativa e appartata di
cui il filosofo potrebbe
godere anche nella città più
vile e corrotta, perché anche
la sua ricerca della saggezza,
della perfezione e della
felicità richiede lo scambio e
la relazione con altri
uomini11. Come ha mostrato
propriolavicendadiSocrate,
nella città ingiusta il filosofo
non può coltivare la filosofia
e restare fedele alla giustizia
senonalprezzodelmassimo
sacrificio:quindi,lacittàben
amministrata ha bisogno dei
filosofi così come i filosofi
hanno bisogno di una
comunitàrettadallagiustizia,
solo in essa la filosofia può
essereliberamenteesercitata.
È a partire da questo
sfondo che va compreso il
progettoplatonicodiunacittà
ideale così come viene
delineato nella Repubblica.
La delineazione di una
comunità politica orientata
dall’idea della giustizia
presuppone innanzitutto il
confronto con coloro che,
come il sofista Trasimaco,
protagonista del primo libro
della Repubblica, negano la
validità stessa dell’idea di
giustizia, con argomenti non
dissimilidaquelliche,nelxix
secolo, saranno riproposti
dall'immoralismodiFriedrich
Nietzsche. Ciò che in ogni
stato viene definito giusto,
afferma
Trasimaco,
è
semplicementeciòcheèutile
al potere costituito; e poiché
il potere è tale in quanto
detiene la forza, ne discende,
«perchisappiabenragionare,
che in ogni caso il giusto è
semprel’identicacosa,l’utile
delpiùforte»12.
Così come il pastore non
si preoccupa del bene delle
pecore, ma del proprio, e del
primo solo in funzione del
secondo, allo stesso modo il
governante; e il destino dei
cosiddettigiusti,cheinrealtà
non sono altro che deboli o
ingenui, è quello di subire il
fisiologico dominio del più
forte,cioèdicoluichesoloil
pregiudizio chiama ingiusto.
La vita del cosiddetto
ingiusto,continuaTrasimaco,
è in ogni caso migliore di
quella del giusto: «quando ci
siano tributi da pagare, il
giusto a parità di condizioni
pagadipiù,l’altrodimeno;e
quandoc’èdaricevere,l’uno
non guadagna nulla, e l’altro
molto». Se poi si tratta di
occupareunacaricapubblica,
l’ingiusto ne trae ricchezza e
onori, mentre il giusto si fa
tanti nemici e ci rimette di
tascapropria13.Siprendaatto
di questa eterna realtà,
conclude quindi il Trasimaco
platonico (di cui qualche
volta Nietzsche ci appare
come nient’altro che una
pallida imitazione), e si
smetta di predicare la
giustizia. Le leggi, gli fa eco
Glaucone, anticipando ora
invece gli argomenti di un
contrattualismo
di
tipo
strategico, nascono perché
colorochenonsonocapacidi
evitaredisubireingiustizia,e
non riescono a infliggerla ad
altri,hannopensatochefosse
vantaggioso
venire
all’accordo di non farsi
ingiustiziareciproca,ehanno
appunto stabilito una legge a
questo scopo, mediante una
sorta di patto; un patto che
nessuno sottoscriverebbe mai
(a meno che non fosse folle)
se avesse la possibilità di
soverchiare impunemente gli
altri14.Sonoideboli,sostiene
Callide nel Gorgia, che
tessonolelodidellagiustizia,
che non è altro che un velo
dietro cui essi nascondono la
loroimpotenza.
Nella Repubblica Platone
non ci presenta una
confutazione diretta e lineare
delle tesi di Trasimaco. La
confutazione si articola
piuttostoinunaserieampiae
intrecciata di ragionamenti e
di argomentazioni, che solo
nel loro insieme giungono a
delineare il quadro di una
giusta comunità politica.
L’osservazione preliminare è
che, tanto per cominciare,
l’ingiustizia
sembra
presupporrelagiùstiziaenon
poterla negare del tutto:
anche una banda di predoni,
per
poter
funzionare
efficacemente, ed evitare la
divisione e la distruzione,
presuppone che viga, almeno
al suo interno, una qualche
formadigiustizia.Maciòche
vale per l’aggregato di
individui sembra valere, in
qualche modo, anche per il
singoloindividuo:l’individuo
assolutamenteingiustoètanto
diviso al suo interno che alla
fine risulta del tutto incapace
di agire, come una banda di
ingiusti dilaniata e distrutta
daconflittiintestini15.
Il paragone potrebbe
apparireimproprio,manonlo
è, in realtà, perché anche
l’individuo considerato come
agente reca in sé una
pluralità:
come
mostra
l’esempio banalissimo di
colui che si costringe, con la
sua volontà, a non guardare
unacosaversolaqualeilsuo
desiderio lo attirerebbe; se
non si assumesse una
pluralitàinternaall’individuo,
si andrebbe incontro a una
impensabilecontraddizione16.
Se dunque noi assumiamo
che c’è giustizia quando una
pluralità è ordinata in modo
tale da mantenere una sua
unità armonica, e in modo
che ogni parte svolga al
meglio la funzione che le è
propria, possiamo dire che la
giustizia è la condizione
stessaperchéunorganismosi
mantenga e realizzi il suo
bene; e possiamo aggiungere
che ciò implica, in modo
altrettanto
stringente
e
necessario, che nell’ordine
dellepartidomininoquellela
cui signoria assicura nel
modo migliore il bene del
tutto.
Il ragionamento circa la
giustizia nello stato, perciò,
viene sviluppato da Platone
tenendo come fermo filo
conduttore l’analogia tra la
comunità politica e quella
piccola comunità in interiore
homine che è l’anima
individuale.Nellapluralitàdi
questa,
che
dobbiamo
necessariamente postulare, si
devono distinguere per
Platone tre momenti: c’è
un’animaappetitiva,chemira
alla soddisfazione dei piaceri
del corpo (il mangiare, il
bere, il copulare e così via);
c’è un’anima razionale, che
hadimiralaconoscenzaela
verità; e infine vi è il
momento volitivo, l’energia
del volere, grazie alla quale
l’animasidirigeversol’unoo
l’altro dei suoi obiettivi, con
maggiore
o
minore
determinazione e coraggio:
insomma,
l’anima
concupiscibile,
quella
razionale e quella animosa.
Giusto è l’individuo17 in cui
le tre parti dell’anima non
sono in lotta tra loro, ma
danno luogo a un ordine
intimoeaun’armonia,maciò
è a sua volta possibile, nella
visionediPlatone,solosetra
gli elementi vige la giusta
gerarchia, se non vengono
invertiti i rapporti di signoria
conformi a natura. L’uomo
giustoèquelloincuilaparte
razionale,sostenutadaquella
animosa, domina sulla parte
concupiscibile; poiché solo
questo ordine consente
all’individuo di attingere il
suo vero bene, la sua felicità
più autentica. Si potrebbe
obiettare, riprendendo per
esempio
la
linea
di
ragionamento sofistica, che
l’uomopiùfeliceèquelloche
soddisfa senza freni tutti i
suoi appetiti, come per
esempio il tiranno; ma in
realtà,percomprenderequale
parte
dell’anima
deve
comandare,bastarifletteresui
diversi tipi di piacere verso i
quali ogni parte dell’anima è
indirizzata, e ragionare su
quali sono quelli che
assicuranolafelicitàpiùvera.
La parte razionale cerca il
piacere di apprendere e di
conoscere la verità; quella
animosavaincercadifamae
di
onori,
quella
concupiscibile è dedita ai
diversi piaceri del corpo e al
denaro, che consente di
acquistare tutti i mezzi di
piacere. Ma quali sono i
piaceri che danno la felicità
maggiore ? Se lo si chiede a
chicoltivaunodeitremodidi
vita, la risposta sarà che il
migliore è appunto quello al
quale egli si dedica; il
filosofo loda i piaceri
dell’intelletto, l’amante della
vittoria ritiene che niente
valga quanto gli onori e la
fama, l’amante del guadagno
si prende gioco di entrambi
giudicando futile ciò che a
essiappareimportante.Mase
ci troviamo di fronte a tre
giudizi diversi, a quale
dovremo prestare fede ?
Dovremo credere - risponde
Platone - al filosofo, e non
perpartitopreso,mainforza
di solide ragioni; egli infatti,
in quanto uomo che vive in
società, ha una chiara
conoscenza anche dei tipi di
piacere che ritiene meno
validi, mentre gli uomini
dediti all’inseguimento degli
onoriodeldenarononhanno
una pari esperienza dei
piaceri
della
mente:
pretendono di giudicare
intorno a ciò che conoscono
pocoemale.Illorogiudizio,
quindi, è meno attendibile
non solo per questa ragione,
maancheperchéilfilosofoè
quello che ha, per così dire,
coltivato«professionalmente»
l’arte del giudicare in modo
retto, e quindi anche da
questo punto di vista la sua
opinione dev’essere accolta
come la più ponderata.
Accanto a questa, Platone
adduce anche molte altre
argomentazioni;maforsenon
esplicita fino in fondo quella
che
a
noi
sembra
l’argomentazione da lui
stesso più profondamente
sentita: l’apprendere e il
conoscere sono, in rapporto
agli altri, gli unici beni che
noi possiamo conseguire in
modo illimitato senza per
questo doverli sottrarre ad
altri: denaro e onori sono
risorse scarse per cui si
compete,mentreilsapereche
si acquista non lo si toglie a
nessuno, e anzi lo si regala
volentieriadaltri18.
Non v’è dubbio perciò
che la parte dell’anima che
devegovernaresullaaltresia
quella razionale, perché solo
affidandosialgovernodiessa
l’uomo potrà conseguire la
sua più compiuta felicità e
autorealizzazione.Maciòche
èveroperilsingoloindividuo
è vero anche per quella
comunità più ampia che è lo
stato. Le tre parti dell’anima,
come
abbiamo
visto,
corrispondono a tre tipologie
fondamentali di individui:
quelli che ricercano la
saggezza,
quelli
che
ambisconoaglionoriequelli
che bramano il guadagno. La
societàgiustaobeneordinata
sarà quella che assicurerà
l’appropriato equilibrio tra
questesuecomponenti.
Innanzitutto non è privo
di significato che anche l’«
idealista»Platonenonmanchi
di prendere le mosse da
quellache,collinguaggiodel
nostro tempo, potremmo
definire come l’esigenza
fondamentale di assicurare la
riproduzione materiale della
società:lasocietàumana,per
Platone,
nasce
sostanzialmente dal bisogno,
dalfattochel’uomononèin
gradodibastareasestessoe
per vivere instaura quindi
rapportidicollaborazioneedi
scambio con altri. Lo
sviluppo sempre più ricco e
articolato di questi rapporti
genera una sempre più
marcata divisione del lavoro,
che risponde a una ben
precisa logica di efficienza:
«le singole cose riescono più
e meglio e con maggiore
facilitàquandounofacciauna
cosa sola, secondo la propria
naturale disposizione e a
tempoopportuno,senzadarsi
pensierodellealtre»19.
A soddisfare le necessità
materiali,chesonolaragione
stessa
del
costituirsi
dell’uomo
in
società,
provvederà quindi la classe
dei produttori e dei
commercianti, formata dagli
uomini nei quali prevale il
desiderio di guadagno. Con
l’accrescersi della città e dei
suoi bisogni, questa entrerà
fatalmente in conflitto con le
altre comunità, e potrà
prospettarsi la necessità della
guerra; ed ecco quindi la
necessità di una classe di
guardiani che proteggano la
città, e che dovrà essere
formatadaquellinelcuipetto
prevale l’elemento animoso:
coraggio,aggressività,ricerca
di gloria. Superiore alla
funzione
di
protezione
militare, però, è quella
propriamentedigovernodella
città; a essa dovranno
presiedere quei guardiani in
senso più alto e perfetto che
sono i governanti-filosofi,
cioè coloro nella cui anima
prevale il momento razionale
e che sono legittimati a
governare dal fatto di
possedere la conoscenza del
vero bene. La platonica città
bene ordinata, quindi, è
quella che assicura ai diversi
tipidiuominilapossibilitàdi
vivere nel modo cui il loro
temperamentoliindirizza,ma
tenendolientroqueilimitiche
fanno
sì
che
essi
contribuiscano, ciascuno a
suomodo,albenedellacittà,
e non ne preparino invece la
rovina.
Così, gli amanti del
denaro,gliuominiacquisitivi,
potranno dedicarsi all’attività
economica, che però dovrà
essere regolata in modo da
non produrre differenze
troppo rilevanti tra ricchezza
e povertà: perché se questo
accadesse,nonsiavrebbepiù
una città, ma due poleis,
quella dei ricchi e quella dei
poveri, nel cui conflitto si
distruggerebbe quel bene
primario che è l’unità dello
stato. Gli uomini acquisitivi,
inoltre, non devono avere
accesso al potere politico,
perchéquestononpuòessere
esercitato in modo giusto da
chi ha come interesse
primario quello di accrescere
isuoipossessi.
Proprioperquestomotivo
laclassedeireggitori,cioèdi
quellichegovernanolostato,
deve
essere
tenuta
rigorosamente lontana da
tutto ciò che implichi un
privato interesse acquisitivo:
in quanto custodi del bene
pubblico i governanti devono
vivere in modo tale da non
avereneppurelatentazionedi
dedicarsi ad accrescere i loro
beni privati. Essi perciò non
devono avere proprietà
privata ma, come buoni
amici, devono avere tutto in
comune, abitare e mangiare
insieme.Nonviènessuntipo
didiscriminazionetrauomini
e donne, nel senso che tutti i
ruoli che sono aperti agli uni
sono aperti anche alle altre.
Leunionivengonocombinate
attraverso un complicato
sistema di sorteggi, che in
realtà, dice Platone, dovrà
essere
manipolato
dai
supremi guardiani in modo
che
gli
accoppiamenti
riescano al meglio. I figli
sarannoconsideratitutticome
figli della città e allevati in
comune. Questo tipo di vita
comunitaria varrà per i
guardiani in generale, sia per
ifilosofi-governanticheperi
guerrieri; ma una attenzione
assolutamenteparticolaresarà
consacrata all’educazione dei
filosofi, alla quale Platone
dedica, entrando assai nel
vivo
delle
questioni
filosofiche, molte pagine
dellaRepubblica.
Per quanto riguarda
l’appartenenza alle tre classi,
l’ottimo stato platonico non
disdegnerà di ricorrere a una
«nobile menzogna»20: si farà
credere agli uomini che
appartengono a esse a
secondachenellaloronatura
sia mescolato oro (filosofi),
argento (guerrieri), oppure
ferro e bronzo (artigiani e
commercianti); i giovani
apparterranno di regola alla
classedichilihagenerati,ma
non senza eccezioni. Con
l’idea della nobile menzogna
Platonecisvelaanche,molto
precocemente,ilmeccanismo
con cui funziona l’ideologia:
essa legittima gli assetti
sociali, fatti dagli uomini,
facendoli apparire come dei
dati naturali indipendenti
dallalorovolontà.
Dopo aver tracciato nella
Repubblica il quadro della
societàbeneordinata,Platone
si sofferma sulle costituzioni
che invece si discostano
dall’ideale,
che
quindi
possono essere considerate
come
altrettante
forme
degenerate di esso, e che
corrispondono al prevalere di
parti dell’anima che invece
dovrebbero essere sottoposte
al
governo
dell’anima
razionale.Lequattroformedi
costituzione
degenerata
(timocrazia,
oligarchia,
democrazia,
tirannide)
possono essere lette come un
processo di decadimento
progressivo a partire dalla
corruzione della costituzione
ottima. Dapprima, col venire
meno
nei
governanti
dell’egemonia della ragione,
prevarràlaparteanimosa,eil
governo passerà nelle mani
degli individui caratterizzati
dalla
«ambizione
di
affermarsi e di ricevere
onori» (timocrazia)21; quindi
al desiderio degli onori si
sostituirà quello più volgare
dellericchezze,esiaffermerà
la costituzione oligarchica,
dovelapolisèscissa:dauna
parte i ricchi, dall’altra una
massadipoverisenzarisorse,
carichi di debiti, «bramosi di
una rivoluzione» 22. E così,
scrive
Platone,
«la
democrazia nasce quando i
poveri, dopo aver riportata la
vittoria, ammazzano alcuni
avversari,altrinecaccianoin
esilio e dividono con i
rimanenti, a condizioni di
parità,ilgovernoelecariche
pubbliche, e queste vi sono
determinate per lo più col
sorteggio»23. Per Platone
quindi la democrazia per un
versoècaratterizzatadalfatto
cheprendeilpotereunacerta
classe,quelladeinullatenenti,
peraltroversodalfattochevi
regna una libertà che
apparentementeèmoltobella,
ma che in realtà si traduce
presto nel dominio dei
demagoghi, che si mostrano
bendispostiversoilpopoloe
i suoi desideri, e infine nel
rifiuto
di
qualsiasi
obbedienza,chelasciaspazio
alla«tracotanza,l’anarchia,la
sregolatezza
e
l’impudenza»24.
Dall’insofferenza
per
l’anarchia si genera quindi
infine la tirannide, perché
«l’eccessiva libertà, sembra,
non può trasformarsi che in
eccessivaschiavitù»25. E con
essa si chiude il ciclo delle
forme
degenerate
di
costituzione.
Ma, se il quadro della
degenerazione è chiaro, e
dipinto da Platone con tratti
efficacissimi, meno chiaro è,
invece, come e se si possa
perveniredaunasituazionedi
corruzione politica all’ottima
repubblica. Nel libro V della
Repubblica Platone ribadisce
la sua convinzione che
l’instaurazione dello stato
giusto è pensabile, «con una
sola trasformazione, certo
non piccola né facile, eppure
possibile»26 e cioè che i
filosofi diventino governanti
o che i governanti diventino
filosofi. Ma sa bene quanto
ciò sia improbabile, perché,
se filosofi sono quelli che
aspirano a un modo di vita
diversoesuperiorerispettoal
governare, sarà difficile che
essi conquistino il potere, e
ancor più difficile che vi
siano chiamati da coloro che
invece proprio al potere
ambiscono. Perciò, sembrano
avere buone ragioni quelli
che pensano che Platone non
poteva intendere il progetto
della Repubblica come un
progetto
realisticamente
attuabile; del resto, lo stesso
Platone
si
distacca
dall’orizzonte delineato nella
Repubblica
nella
più
«realistica» opera della
vecchiaia,leLeggi.
Perciò, come è stato
scritto, «la Repubblica deve
intendersi come un modello
ideale e come un paradigma
etico prima che politico, e
noncertocomelabaseperun
programma
politico»27.
L’ottimo stato, si legge nella
chiusa del libro IX della
Repubblica, è «uno stato che
esiste solo a parole, perché
non credo che esista in alcun
luogo della terra. Ma forse
nelcielo,replicai,neesisteun
modello, per chi voglia
vederlo e con questa visione
fondarelapropriapersonalità.
Del resto non ha alcuna
importanza che questo stato
esistaoggioinfuturo...».Ciò
che forse più importa è che
esso mette in luce uno dei
paradossichesonocostitutivi
del politico: uno stato
ordinato al Bene sarebbe
quello dove fossero al potere
colorochenonlodesiderano,
così come non desiderano la
ricchezza che dal potere
consegue.
3.Aristoteleeil
pluralismodelBene.
Sebbeneilsuopensierosi
collochi già nell’epoca del
tramonto della polis, anche
per Aristotele la città rimane
il punto di riferimento
privilegiato, il contesto al
quale la filosofia politica si
riferisce come al proprio
oggettoenelqualesoltantoè
possibile l’agire dell’uomo
attraverso il quale rifulge la
sua virtù. Come per Platone,
quindi, anche per Aristotele
l’oggetto
primario
di
riflessione della politica è il
Bene, sia il bene del singolo
uomo che il bene della città,
perchéilbenedell’individuo,
che
fondamentalmente
consiste
nell’attività
dell’anima conforme a virtù,
si attua nel contesto della
relazione con gli altri, e
quindi il bene «è amabile
anche nella dimensione
dell’individuo singolo, ma è
piùbelloepiùdivinoquando
concerne un popolo o delle
città»28.Lapolitica,quindi,è
la scienza più direttiva
e architettonica, perché si
occupa
del
«bene
propriamenteumano»nelsuo
contesto più ampio, cioè
ordinando tutte le condizioni
all’interno delle quali gli
individuipossonoviverebene
eattingerelalorofelicità.
Se resta quindi fermo il
quadro paradigmatico di una
comunità politica pensata in
funzione del conseguimento
del bene degli individui e
della comunità, mutano però
profondamente, rispetto a
Platone,
le
coordinate
teoretiche dalle quali la
ricerca sul bene per l’uomo
vieneguidata.
Cambia in primo luogo il
modo di intendere lo statuto
teorico del sapere pratico,
etico e politico: «le cose
moralmente belle e le cose
giuste,intornoallequaliverte
la politica, hanno molta
diversità e instabilità, a tal
punto che si crede che
esistano
soltanto
per
convenzione e non per
natura»29. Proprio in forza di
questa varietà e instabilità, il
bene pratico non può essere
oggetto di un sapere
assolutamente rigoroso, di
una visione epistemica come
quella nella quale invece
confidava
Platone;
al
contrario,
bisognerà
accontentarsi di una verità
conosciuta «in maniera
approssimativa e a grandi
linee»,
poiché
l’uomo
veramentecoltochiedeaogni
tipo di ricerca tanta esattezza
quanta l’oggetto ne consente;
il sapere pratico non potrà
mai conseguire il rigore
dimostrativo
di
quello
matematico e di quello
teoretico30.
Mutainsecondoluogola
visione del bene; perché se è
veroche,comeèstatoscritto,
«Aristotelenonabbandonòla
credenza
essenzialmente
platonica secondo la quale la
comunità politica avrebbe
dovuto mirare al sommo
bene»31, è altrettanto certo
che egli sottopone a una
criticamoltobenargomentata
e complessa la teoria
platonica in forza della quale
vièun’unicaideadelbenein
sé, di cui tutti i beni
particolari partecipano. Gli
argomenti che Aristotele
adduce contro la tesi
platonica dell’unità del bene
sono molteplici, ma basterà
qui ricordarne uno dei più
perspicui, e cioè che se vi
fosse un bene unico, vi
sarebbe anche una sola
scienzadiesso,mentreinvece
sono molte e diverse le
scienzechetrattanodiquello
che, in un determinato
contesto, è bene. La critica
della
eccessiva
concentrazione
platonica
sull’unità, dell’idea come
anche del corpo politico, sta
alla base del modo assai più
articolato in cui Aristotele
prospetta una polis bene
ordinata.
Nella complicata e molto
discussa struttura della
politica aristotelica, che è
stata anche considerata come
un aggregato abbastanza
estrinseco
di
trattati
indipendenti, il primo libro
illumina però con grande
chiarezzaquellocheèunodei
punti nodali del pensiero
delloStagirita,controilquale
si dirigerà, più che su ogni
altro,lapolemicadiHobbese
dei
pensatori
politici
dell’individualismo e del
contrattualismo
moderno.
Polemicoinvece,asuavolta,
contro
il
protocontrattualismo antico (nel
libro III della Politica il
riferimento è al sofista
Licofrone, che intende la
legge
come
una
convenzione)32
Aristotele
sviluppa
in
modo
paradigmatico la tesi del
carattere naturale (e quindi
nonartificialeepattizio)dello
stato e, di più, del carattere
altrettanto
naturale
dei
rapporti
di
comando/obbedienza
che
fondano la stessa comunità
umana. In principio non c’è
l’individuodasolo,masubito
la comunità (originaria,
potremmodire)cheunisceda
unlatomaschioefemminain
vista della riproduzione,
dall’altro
colui
che,
preveggenteeintelligente,ha
natura di capo, con chi
invece,
dotato
prevalentemente di forza
fisica e idoneo alla fatica, è
per natura subordinato o
schiavo. La natura dell’uomo
èdiessereunozoonpolitikon
che, partendo dalla più
piccola cellula familiare, dà
vita a comunità via via più
ampie, prima di discendenza,
poi di villaggio, e infine alla
città dove può attingere
finalmente i beni della vita
civile. Il concetto aristotelico
di natura, peraltro, a
differenzadiquellomoderno,
èunconcettointrinsecamente
teleologico: la natura di una
cosaèilfinecuitendeilsuo
sviluppo,einquestosensola
comunitàcivileèiscrittanella
natura dell’uomo. La natura
non fa niente per caso e se
l’uomopossiedelaparolaeil
sensodelbeneedelmale,del
giusto e dell’ingiusto, è
perché questi possano essere
sviluppati e attuati nella
comunità con i suoi simili.
Come, sul piano metafisico,
l’attoèanterioreallapotenza,
così lo stato è anteriore (non
nel tempo, ma quanto al suo
concetto) all’individuo e alla
famiglia, perché «il tutto
dev’essere necessariamente
anteriore alla parte: infatti,
soppresso il tutto non ci sarà
più né piede né mano se non
per analogia verbale ... È
evidente dunque che lo stato
esiste per natura e che è
anterioreaciascunindividuo:
difatti,
se
non
è
autosufficiente,
ogni
individuo separato sarà nella
stessa condizione delle altre
partirispettoaltutto,equindi
chi non è in grado di entrare
nella comunità o per la sua
autosufficienza non ne sente
il bisogno, non è parte dello
stato, e di conseguenza è o
bestiaodio»33,macertonon
èunuomo.
Non meno naturale è per
Aristotele il rapporto di
subordinazione, e quindi
anche quello tra padrone e
schiavo: come, nel singolo
uomo, l’anima domina sul
corpo
e
l’intelligenza
sull’appetito,comegliuomini
nel loro insieme dominano
sugli animali, come il
maschio
domina
sulla
femmina, così gli uomini più
dotati di intelligenza e di
capacità
di
comando
dominanosuquellipiùdotati
di forza fisica e quindi atti a
servire come schiavi, come
veri e propri strumenti
animati.
Anche le famiglie, di cui
la comunità politica si
compone (essendo però al
tempo stesso, come abbiamo
visto, il loro autentico
fondamento), sono strutturate
secondo questi rapporti di
gerarchia naturale; l’uomo
libero, il signore e padrone,
comanda ma in modi diversi
allo schiavo, alla femmina e
al ragazzo: comanda allo
schiavo perché questi non
possiede in tutta la sua
pienezza la parte deliberativa
dell’anima,alladonnaperché
essa la possiede senza
autorità, al ragazzo perché la
possiede ma non sviluppata.
Il comando sulla donna è del
tipo di quello del governante
sul governato, e potrebbe
essere avvicinato a un
governo costituzionale. Il
comando sul figlio, invece, è
similealcomandoregale,esi
basa sull’autorità fondata
sull’affetto e sull’età più
matura. La base economica
della famiglia è data dalla
proprietà, e una parte
importante della trattazione
aristotelicaèdedicataproprio
all’amministrazione
domestica, cioè al modo in
cui la ricchezza può essere
acquistata, accresciuta e
scambiata. Aristotele accetta
lo scambio di beni per
soddisfare le necessità della
vita, ma condanna come
innaturale lo scambio di beni
contro denaro finalizzato
all’accrescimento illimitato
dellaricchezza.
Non ultimo dei difetti
dellaRepubblicadiPlatoneè,
secondo Aristotele, quello di
aver sacrificato, in nome
dell’unità dello stato, il ruolo
della famiglia e della
proprietà.Aquestoproposito,
Aristotele esamina diversi
possibili ordinamenti della
proprietà, che si distinguono
da quello in cui possesso
della terra e consumo dei
prodotti sono entrambi
privati; le possibilità prese in
esamesono:proprietàprivata
della terra, ma con uso
comune
dei
prodotti,
proprietà comune con uso
privato,proprietàcomunecon
uso
comune.
Quindi,
Aristotele muove diverse
obiezioni al sistema della
proprietà comune, che nella
repubblica platonica valeva
per i custodi. Innanzitutto il
sistema della comunanza
sembra destinato a generare
contrasti tra chi, lavorando
molto,
ottiene,
in
proporzione, poco e chi,
lavorando poco, ottiene, in
proporzione, molto: c’è da
attendersi risentimento e
rimostranze dei primi nei
confronti dei secondi. Un
eccesso di comunità, inoltre,
continuaAristotele,generaun
sovrappiù di conflitto e di
contrasto, come si può
osservare spesso tra i
compagnidiviaggio,cioètra
coloro che sono costretti a
unacomunitàforzata.
A favore della proprietà
privata
parlano,
per
Aristotele,
molte
considerazioni: chi deve
occuparsi personalmente di
ciòcheèsuo,sicuramentene
avrà maggior cura di quanta
nonavrebbeperbenicomuni;
inoltre, l’essere proprietario
di qualcosa è una grande
sorgente di felicità, che si
collega con il naturale amore
persestessi.Questoamoredi
sé non è un male e non deve
essere condannato, a meno
chenontrapassiinegoismo,e
cioè in un amore eccessivo.
Altrettanto può dirsi per il
denaro: non c’è niente di
malenelnormaledesideriodi
ricchezza, purché non sia
eccessivo e smodato. Solo la
proprietà, inoltre, consente il
godimento che viene dal
lasciare agli amici l’uso dei
propri beni, cioè in altre
parole consente di coltivare
quellapregevolevirtùcheèla
liberalità. Per tutte queste
considerazioni,
Aristotele
conclude dunque che la
proprietà privata è preferibile
allaproprietàcomune,mache
il sistema migliore è quello
dove alla proprietà privata si
accompagna anche un uso
largamente comune dei beni
privatamente posseduti: «è
meglio, come si vede, che la
proprietà sia privata, ma si
faccia comune nell’uso:
abituare i cittadini a tale
modo di pensare è compito
particolare del legislatore»34.
È questa la soluzione più
equilibrata,checompenetrail
naturale amore di sé con la
felicità che viene dalla
generosità, la cura (non
egoistica ed esagerata) di ciò
che è proprio con la liberale
disponibilità nei confronti
degli altri, il momento
ineliminabile
della
particolarità con quello
altrettanto
importante
dell’universalità. Il difetto
fondamentale
della
Repubblica platonica, infatti,
è quello di avere esagerato
troppo l’unità dello stato35, e
di avere pensato che la
negazione della proprietà
privata producesse la fine
delledivisionitragliuominie
una «meravigliosa amicizia»
e armonia. Le cause di
divisione
però,
obietta
Aristotele, non nascono solo
dalla proprietà, e dalle liti e
contese a essa legate, ma
dalla malvagità degli uomini
che, se avessero tutto in
comune, disputerebbero tra
loro in modo ancor più
violento. Infine, osserva
Aristotele,sePlatoneeracosì
convinto della superiorità
della proprietà comune,
perché l’ha applicata solo ai
guardiani e non anche alle
altreclassidellasocietà?
Riprendendoiltemadella
proprietà nel capitolo VII del
libro II della Politica,
Aristotele osserva inoltre che
mentre l’uguaglianza delle
proprietà ha carattere statico,
la società umana è invece in
movimento: per esempio, c’è
chihapiùfigliechinehadi
meno, e già questa semplice
dinamicasconvolgegliassetti
che si vorrebbero eguali
della
proprietà.
L’ineguaglianza
delle
proprietà, inoltre, non è
l’unicanélaprincipalecausa
di conflitto e di sedizione: «i
più
grandi
mali
si
commettono
in
vista
dell’eccesso,
non
del
necessario»36, mentre grandi
contese
vengono
dall’ineguaglianza
delle
cariche e degli onori, così
come dal carattere illimitato
dei desideri «per il cui
soddisfacimento
i
più
vivono»37. «Senza dubbio,
l’eguaglianzadiproprietàtrai
cittadini è uno dei fattori che
contribuiscono a eliminare
discordie tra loro»38, ma non
basta di per sé ad assicurare
laconcordiaelavitabuona.
Il problema fondamentale
della comunità politica,
insomma, è per Aristotele
quellodelrapportotraunitàe
differenze: certamente lo
stato, come la famiglia, deve
realizzare l’unità, ma non in
modo assoluto”, dev’essere
simile a un coro, non a una
voce solista. «Al contrario, è
indispensabile che lo stato,
essendo, come s’è detto
prima, pluralità, realizzi
mediante
l’educazione
comunità e unità»40; l’unità
non deve essere imposta
attraverso la negazione delle
differenze, ma risultare da
unagiustaeducazioneedaun
giustosensodellavirtù;deve
essere un’unità la cui forza
sta proprio nel saper ospitare
dentro di sé i diritti legittimi
della particolarità. Lo stato,
peraltro,spiegaAristotelenel
capitoloIX del libro III, non
ha per fine né quello di
garantire la sicurezza, né
quello di facilitare l’attività
economica. Tutto questo è
certamente necessario, ma il
fine dello stato dev’essere
collocatopiùinalto:«lostato
ècomunanzadifamiglieedi
stirpi nel viver bene: il suo
oggetto
è
un’esistenza
pienamente realizzata e
indipendente»41; è, come
Aristotele dice poco più
avanti, «il vivere in modo
feliceebello»42.
Il
governo
politico
peraltro,soprattuttoquandosi
eserciti nell’ambito della
comunità di liberi ed eguali,
dev’essere ben distinto da
altreformedicomando,come
quello del padrone sullo
schiavo o del padre sulla
famiglia: tra i liberi e gli
eguali,tuttiricopronoaturno
il ruolo di governante e di
governato: quando sono al
potere
lo
esercitano nell’interesse dei
governati, mentre possono
occuparsi dei propri interessi
quando
rientrano
nella
semplice condizione di
governati43.
Ma qual è la costituzione
migliore, quella che meglio
può realizzare il fine cui la
vitadellostatodevetendere?
Ricollegandosi
alla
riflessione
platonica,
Aristotele
elabora
una
tipologia che prevede sei
formedicostituzione:tretipi
di
costituzioni
giuste
(monarchia, aristocrazia e
politeia) e tre tipi di
costituzioni
degenerate
(tirannia,
oligarchia
e
democrazia). Le costituzioni
giuste o rette sono quelle
dove il potere di governo
vieneesercitatoperilbenedi
tutti, in vista di un interesse
comune a governanti e
governati; mentre sono
degeneri quelle costituzioni
dove i governanti governano
soloperassicurarel’interesse
proprio, e non quello dei
governati.
All’interno di queste due
grandi categorie, le forme di
governo si distinguono poi a
seconda che, a esercitare il
potere, siano uno, pochi o
molti. La distinzione tra le
forme di governo, però, non
ha una valenza puramente
quantitativa ma, al contrario,
ha un significato largamente
sociale: ciò vale soprattutto
per l’oligarchia, che è il
governo della minoranza
ricca, e per la democrazia,
che si ha quando il potere è
nelle mani della moltitudine
povera.
Ma quale sarà il governo
migliore, quello di uno, di
pochi o di molti ? Nel
capitolo xi del libro III,
Aristotele presenta diverse
argomentazioniafavoredella
superiorità del governo dei
molti: in primo luogo, anche
se nessuno dei molti eccelle
per virtù e saggezza, essi nel
loro insieme e attraverso il
confronto
raggiungeranno
una saggezza che è superiore
a quella di ogni singolo
isolatamente preso, anche il
migliore; in secondo luogo,
proprio perché i molti sono
tantidinumero,escluderlidal
governo dello stato potrebbe
essere pericoloso per la
stabilità della costituzione; in
terzo luogo, anche se i molti
non possiedono l’arte del
governo, ciò non vuol dire
che essi non abbiano titolo
per giudicare chi governa.
Qui Aristotele propone uno
dei più forti argomenti a
favore della democrazia: è
vero che coloro che
partecipano a un banchetto
non
possiedono
l’arte
culinaria come la possiede il
cuoco; ma, rispetto al cuoco
stesso, essi sono migliori
giudici del risultato che egli
ha prodotto e che, dopotutto,
a loro deve piacere. La casa,
continua Aristotele, deve
andar bene a coloro che ci
abitano,nonall’architettoche
l’ha costruita. Infine, è vero
che gli esponenti della
moltitudine
singolarmente
presi
non
sono
particolarmente saggi, e
quindi sembrerebbe sbagliato
affidarloroilgoverno,machi
governainquestocasononè
mai un singolo, ma
un’assemblea, un gruppo, un
comitato (che quindi mette
insieme la saggezza di più
persone); e poi, il governo
non è propriamente delle
persone ma, sopra di esse,
delleleggi.
Certo,
continua
Aristotele, se in una città vi
fosse
un
uomo
indiscutibilmente superiore
agli altri per saggezza e per
virtù, allora sarebbe più
saggio affidare a lui il
governo e la costituzione
migliore
sarebbe
la
monarchia.Mapoichéquesto
nonècheuncasolimite,sarà
più opportuno affidarsi al
governodialcuniodimolti.
Se si esclude la
monarchia restano dunque,
tra le costituzioni rette,
l’aristocraziaelapoliteia.Ed
è quest’ultima, il cui nome
significa
appunto
«costituzione», a essere
quella
cui
Aristotele
attribuisce il maggior valore.
La politela è la forma retta
della democrazia; e cioè
quella costituzione che,
essendosempreunaformadi
governo dei molti, non ha
però quelli che secondo
Aristotele sono i difetti della
democrazia come governo
della moltitudine povera: e
cioè il fatto che in essa il
numero prevale sul merito e
che
si
afferma
una
concezione della libertà per
cui ognuno è padrone di fare
ciò che più gli aggrada. La
politeia,inrealtà,sebbenesia
la forma retta della
democrazia, è vista piuttosto
da Aristotele come una
commistionetrailgovernodi
pochi e il governo di molti,
che però inclina di più verso
il momento democratico che
non verso quello oligarchico.
Per esempio, mentre la
democrazia non pone alcun
requisito di censo per la
partecipazione
alle
assemblee, e l’oligarchia lo
esigeelevato,lapoliteiaporrà
si dei requisiti di censo, ma
tali che consentano una larga
partecipazione del ceto
medio. Per quanto riguarda
poi le cariche pubbliche, la
democrazialeassegnaasorte
e indipendentemente dal
censo, l’aristocrazia solo ai
ricchi e per elezione; la
politeia
accoglie
dalla
democrazia il principio
dell’indipendenza dal censo,
e dall’aristocrazia quello
dell’elezione: le cariche sono
aperteancheainonricchi,ma
attraverso un meccanismo
elettivo, che garantisca
quell’elementodelmeritoche
invece la forma degenerata e
plebea della democrazia
sacrifica. Il pregio della
politela comunque sta per
Aristotele,checomeabbiamo
visto è sempre attento alla
sostanza sociale delle forme
politiche,nelfattocheinessa
nongovernanonéiricchinéi
nullatenenti, ma il ceto
medio: lo stato migliore è
quello ove tutti i cittadini
possiedono
sostanze
sufficienti44edèancheilpiù
stabile,
perché
grandi
ricchezze e grandi povertà
suscitano i rivolgimenti che
portano in ultima istanza alla
tirannide.
La ricerca sui requisiti
che deve possedere la polis
per costituire l’orizzonte
idealenelqualepossaattuarsi
lavitabuonapergliindividui
è sviluppata in modo
particolaredaAristotelenegli
ultimi libri della Politica, il
VII e l’VIII. Ma questa
ricerca suppone che prima si
torni ad affrontare il
problema, già messo a tema
in particolare nell 'Etica
Nicomachea, di quale sia la
vita buona per l’uomo.
Certamente è condizione
della felicità che l’uomo
possa disporre dei tre tipi
fondamentali di beni: i beni
esteriori, quelli del corpo e
quelli dell’anima. Tuttavia
mentreiprimiduetipidibeni
debbono essere ricercati
senza eccesso, e solo nella
misuraincuisononecessari,i
beni dell’anima non soffrono
di questi limiti, e sono quelli
che meglio assicurano il
conseguimento della felicità.
La felicità per l’uomo
consiste essenzialmente, per
Aristotele,nell’eserciziodelle
virtù, sia delle virtù
dianoetiche, che si esplicano
nella vita teoretica, sia delle
virtùetiche(comeadesempio
la giustizia, il coraggio, la
temperanza, l’amicizia), che
siattuanonellavitapratica.
Discutendo la questione
se sia preferibile la vita
politica e pratica o quella
puramente teoretica (come
sarebbe quella di chi,
stranieroinunapolis-edera
ilcasodellostessoAristotele
ad Atene -, si dedica alla
ricerca senza partecipare agli
affari della città) Aristotele
giungeallaconclusionechela
vita felice è quella in cui
l’esercizio della virtù si
esplica in entrambe le
direzioni, e che la città
migliore è quella che
consente appunto ai cittadini
di estrinsecare in tutte le
possibiliformelaloroattività
secondovirtù.
Il fine della polis, lo
abbiamo visto, non è
semplicementeilvivere,mail
vivere bene, attraverso le
varie attività che a questo
scopoconcorrono;eperciòla
polis deve possedere certi
requisiti,comeperesempiole
giuste dimensioni: affinché i
cittadini possano partecipare
allavitapolitica,eleggerecon
consapevolezza
e
amministrare imparzialmente
lagiustizia,lapolisnondeve
essere così grande che essi
non possano conoscersi tra
loro. Il corpo dei cittadini,
d’altraparte,lasciafuoridisé
tutti quelli che non sono, per
varie ragioni, idonei a
esercitare
virtuosamente
l’attivitàpolitica:accantoalle
donne e agli schiavi, non ne
fanno parte neppure i
lavoratori
manuali,
i
contadini e i mercanti, cioè
coloro che svolgono funzioni
che li vincolano alla
dimensione delle necessità
vitali e che non dispongono
deltempoliberopercoltivare
sestessiaifinidiunavirtuosa
partecipazione alla vita
pubblica. Quindi la felicità,
comeeserciziodelievirtùnel
contestodellapolis,nonèun
ideale che possa essere
universalizzato; la libertà di
alcuni presuppone che altri
portino il carico della
necessità.
Affinché
la
polis
costituisca un orizzonte nel
qualedivienepossibilelavita
buona per gli uomini, le
attività che sono comandate
dalla necessità devono essere
subordinate a quelle attività
chesonounfineinsestesse,
come l’attività politica e
quella teoretica. Compito
dellapoliticaèappuntocreare
lecondizioniperchéciòpossa
accadere, e quindi mettere i
cittadini nelle condizioni di
poter
realizzare,
nella
comunità,lalorofelicità.
4.Dalla«polis»
alla«cosmopolis».
Quando Aristotele ancora
tesseva l’elogio della polis,
questa forma politica era già
entrata nella fase della sua
decadenza. Con l’impero di
Alessandro Magno e con le
grandi monarchie che a esso
faranno seguito, si affermano
nuove forme politiche che,
alla limitata comunità della
polis,
sostituiscono
un
orizzonte politico molto più
universalistico, e all’interno
delqualediventaimpensabile
quella partecipazione diretta
del cittadino, quel governare
edesseregovernatiaturno,in
cui Aristotele aveva visto la
pienezzadellavitapolitica.
Nell’età delle grandi
monarchie e degli imperi, al
senso di comunità dellapolis
subentra
un
nuovo
atteggiamento intellettuale,
che per un verso è più
universalistico, per altro
verso più individualistico.
Caduta la vecchia distinzione
tra Greci e barbari, comincia
ad affermarsi l’idea della
eguaglianza fra tutti gli
uomini, di una natura umana
che è la stessa in ciascuno.
Per altro verso, gli individui
che non trovano più
l’autorealizzazione
nella
politica si ripiegano verso
l’interno, nella ricerca di
forme di saggezza che li
aiutino a bastare a se stessi,
quali che siano le condizioni
politicheincuiessisitrovino
a vivere. Mentre il saggio
epicureo coltiva l’ideale di
vivere nascosto e non prende
parte alla vita politica, lo
stoicismo si nutre della
prospettiva della cosmopolis,
di una grande repubblica in
cui popoli diversi possano
vivere in pace rispettandosi
paritariamente, perché si
sottopongono tutti all’unica e
universale
legge
della
ragione. Il saggio stoico,
quindi, a differenza di quello
epicureo, non si ritrae dalla
politica, ma anzi partecipa
allavitapubblicaamenoche
ciò non gli venga reso
impossibile;
l’orizzonte
ideale della cosmopolis non
gliimpediscedioffrireilsuo
servizioallapatriaparticolare
incuisitroviavivere.
Il saggio stoico è dunque
un uomo superiore alle
passioni,fedeleaunrigoroso
concetto della virtù e del
dovere, capace di accettare
serenamente il destino e
persinolamorte.DallaGrecia
questa morale si diffonde in
ampi
strati
dell’élite
intellettuale romana, da
Seneca a Marco Aurelio, in
cui si uniscono la figura
dell’imperatore e quella del
filosofo. Ma prima ancora
l’influenza dello stoicismo, e
più precisamente di quello
che si definisce stoicismo
«medio»,siritrovanell’opera
diCicerone(106-43a.C.).
L’apporto di maggior
rilievo che Cicerone e la
cultura romana danno allo
sviluppodelpensieropolitico
occidentale, e che qui
vogliamo solo limitarci a
ricordare, sta nella centralità
che conferiscono al concetto
di diritto. A fondamento
dell’ordine giuridico, per
Cicerone, vi è una legge di
natura o legge della ragione,
che è eterna e immutabile e
vale per tutti gli uomini e
tutte le latitudini. Essa
incarna la Giustizia ed è
superiore a tutte le leggi
umane positive. La res
publica, ovvero la comunità
politica, è un’unione tra
uominichesiassocianoperla
loro
utilità
comune
vincolandosi sotto una certa
legge cui danno il loro
consenso. Conformemente
all’orientamento
giuridico
che è così decisivo per la
cultura romana, la comunità
politica è vista come una
societàdiuominicheètenuta
insieme dal vincolo del
diritto;èsolograziealdiritto,
infatti,chesirealizzal’uscita
dalla barbarie primordiale e
l’accessoallacomunitàcivile.
Il compito del magistrato,
ossia di chi detiene il potere
di governo, è quello di
mettereinoperaildiritto:egli
èlaleggecheparla,edènella
leggechevivelarespublica.
Si afferma in tal modo una
nuova concezione che pensa
lo stato e la politica a partire
dallacentralitàdellecategorie
giuridiche, e che sarà
determinante per tutto lo
sviluppodelpensieropolitico
fino
alla
modernità
contrattualista.
1Perlastoriadelconcetto
cfr. la voce «Politilk» di v.
SELLIN,
IN
Geschichtliche
Grundbegriffe; trad. it.
Politica, Marsilio, Venezia
1993.
2 VERNANT, Le origini
delpensierogrecocit.,p.44.
3Ibid.)p.81,
4 Tucidide, La guerra del
Peloponneso,5.84sgg.Suldialogo
dei Melii e degli Ateniesi cfr. L.
canfora, Tucidide e l’impero,
Laterza,Roma-Bari1992.
5LetteraVII,324c-325b
[trad. it. di A. Maddalena in
PLATONE,Opere,Laterza,Bari
1966,vol.II].
6Politico305e[trad.it.
diA.Zadro,ibid.,vol.I],
7Gorgia517[trad.it.di
F.Adorno,ibid.,vol.I],
8Gorgia469.
9 WOLIN, Politica e
visionecit.,p.86.
10 Repubblica 520-521
[trad. it. di F. Sartori, in
PLATONE, Opere cit., vol. II];
cfr.ancheLeggi4.715.
11 F. M. CORNFORD,
Plato’s Commonwealth, in
The Unwritten Philosophy
andotherEssays,Cambridge
University Press 1967, pp.
47-67,inparticolarep.55.
12Repubblica,339a.
13Ibid.,343d-e.
14Ibid.,359a-b.
15Ibid.,351-352.
16Ibid.,436-437.
17Ibid.,443-44418
Questo punto è ben
sottolineato da CORNFORD,
Plato ’s Commonwealth cit.,
p.62.
19Ibid.,370c.
20Ibid.,414b.
21Ibid.,548c.
22Ibid.,555d.
23Ibid.,557a.
24Ibid.,560e.
25Ibid.,564a.
26Ibid.,473c.
27
m. ISNARDI parente,
II pensiero politico dì
Platone, Laterza, Roma-Bari
1996,pp.32-35.
28 Etica Nicomachea,
1094I31-12 [trad. it. di M.
Zanatta, Rizzoli, Milano
1986].
29Ibid.,I094b14-16.
30 Per questo aspetto di
metodo, importantissimo per
tutta la cosiddetta rinascita
della filosofia pratica, si può
vedere il volume di G. bien,
La filosofia politica di
Aristotele, trad. it. il Mulino,
Bologna2000,pp.108sgg.
31 WOLIN, Politica e
visionecit.,p.97.
32 Polìtica, i28obio [trad.
it. di R. Laurenti in
ARISTOTELE, Opere, vol. IX,
Laterza,Bari1973].
33Politica1253aI8-30.
34Ibid.,1263a40.
35Ibid.,1263b9;
36Ibid.,1267a14.
37Ibid.,1267b4.
38Ibid.,1267a38-39.
39Ibid.,1263b32.
40Ibid,1263b38.
41Ibid.,1280b32-33.
42Ibid1281a2.
43
Ibid.,
I278b301279a13.
44Ibid.,1296a1.
III.Lacittàdell’uomoe
lacittàdiDio
I.Larivoluzione
cristiana.Paoloe
Agostino.
Sebbene il messaggio
cristiano sia un messaggio di
redenzione il cui nucleo di
significato si colloca in uno
spaziodiversodaquellodella
politica,
l’intreccio
tra
cristianesimoepoliticaècosì
determinante per la storia
dell’Occidentechenonsipuò
fare a meno di dedicare a
questo
tema
qualche
considerazione, per quanto
assolutamente rapida e
sommaria.
Il carattere rivoluzionario
del messaggio cristiano è da
vedersi innanzitutto nel fatto
che in esso il tema
dell’eguaglianza di tutti gli
uomini, che già era stato
posto dallo stoicismo, si
trasvalutainquellodelvalore
infinito di ogni singolo
individuo,inquantocreatoda
Dio. Il cristianesimo quindi
travolge il quadro di una
società divisa in signori e
servi, padroni e schiavi,
perchétuttequestedistinzioni
nonhannopiùalcunvaloredi
fronte a ciò che accomuna
tuttigliuomini,ecioèalloro
essere figli di Dio. Come è
scrittonellaLetteraaiGalati
di Paolo «non c’è più né
Giudeo né greco, né schiavo
nélibero,néuomonédonna,
perché tutti siete una sola
persona in Gesù Cristo».
Come è evidente a chi legga
ilDiscorsodellamontagna,il
cristianesimo
attua
un
completo rovesciamento dei
valori che erano stati
dominanti nella classicità: al
posto della forza e della
potenza predica la carità e la
fratellanza, al posto della
ricchezzalapovertà:sivolge
con misericordia verso i più
poveri, i più umili, persino i
peccatori; riconosce il valore
assoluto dell’uomo anche
nell’umile, nel servo, nel
lavoratore manuale, cioè
anche là dove il pensiero
classico
aveva
visto
l’impossibilitàdirealizzarela
virtùelariuscitaumana.
La rivoluzione cristiana,
però, sebbene destinata a
dispiegare nel tempo enormi
ricadute politiche, non si
pensa come una rivoluzione
politica e non vuole essere
tale. Paolo, dopo aver tolto
ognivaloredavantiaDioalla
distinzionetraschiavieliberi,
servi e padroni, non afferma
che debba essere soppressa:
esorta i primi a continuare a
obbedire e i secondi a
comandare in modo giusto e
umano, nella consapevolezza
che quei ruoli non sono più
decisivi e appartengono a un
mondo
destinato
a
tramontare. Conformemente
al detto evangelico che
comanda di dare a Cesare
quel che è di Cesare, i
cristiani non aspirano a
fondare un nuovo e diverso
regno su questa terra: Cristo
insegna che il suo regno non
è di questo mondo. D’altra
parte, una predicazione
radicalecomequellacristiana
non può non minare, in
qualche misura, le basi di
legittimità degli ordinamenti
politici esistenti. Dare a
Cesare quel che è di Cesare
significa anche, infatti, non
dargli di più di quel che
propriamente gli appartiene.
Il cristiano è tenuto a una
doppia lealtà, a Cesare e a
Dio, e non c’è dubbio che,
ove insorga un conflitto di
doveri, sia l’obbligo nei
confronti del Signore quello
chedeveprevalere.
Anchedaquestopuntodi
vista, la rottura rispetto al
mondo classico della polis è
completa: mentre quella
esigeva dall’individuo una
lealtàpiena,colcristianesimo
è posta la distinzione tra ciò
che è dovuto allo stato e ciò
che invece (come per
esempio la dimensione
spirituale dell’individuo) non
appartiene allo stato e può
essere anche in tensione con
esso. Con ciò, e sebbene
attraverso mille vicende e
conflitti, è aperta la
possibilità
per
una
articolazione di libertà più
complessa e ricca di quella
che non fosse possibile nella
polis.Perunverso,quindi,il
cristianesimononè,nonvuol
essere
una
rivoluzione
politica,eanziassicuralasua
lealtà al potere politico
esistente; per altro verso ne
minainvariomodolebasidi
legittimità.
Perseguitato nell’impero
Romano fino a che non si
converti a esso l’imperatore
Costantino, il cristianesimo
da parte sua cominciò subito
ainterrogarsisullalegittimità
del potere politico, sul suo
fondamento,
sulla
sua
autonomiaeisuoilimiti;eil
pensiero cristiano su questi
temi dette luogo a soluzioni
molto differenziate e anche
divaricate.
Per il Paolo della Lettera
aiRomani,i cristiani devono
obbedienza
all’autorità
politicaperchéquestaautorità
proviene da Dio, e quindi
opporsi a essa equivale a
mettersicontrounordineche
riceve da Dio la sua
legittimità. Chi si comporta
bene, continua Paolo, non
deve
temere
nulla
dall’autorità pubblica; chi
invece fa il male, dev’essere
giustamente punito dalla sua
«spada» che, in questa
funzione di amministratrice
dellagiustizia,èesecutricedi
un comando divino. Perciò
l’obbedienza che i cristiani
devono al potere pubblico
nondeveesseresolomotivata
dal timore della punizione,
ma è anche un obbligo di
coscienza, dato appunto il
fondamento in ultima istanza
divinodelpoterelegittimo.
Quando però, dopo la
conversione di Costantino, il
cristianesimo acquista piena
cittadinanza nell’impero, i
problemi politici e dottrinali
che la nuova religione deve
affrontare divengono assai
più articolati e complessi.
Diventa necessario, infatti,
stabilire i limiti e le
competenze dei due poteri,
quello spirituale e quello
temporale, che devono
coesistere;esiapreperciòun
terreno di conflitti che
segneràinmododeterminante
tuttalastoriadellacristianità.
Ilrapportotraleduecittà
è al centro dell’opera di
Agostino De civitate Dei.
L’occasione da cui l’opera
prende le mosse è la volontà
di difendere il cristianesimo
dall’accusa che i pagani gli
avevanomossodopoilsacco
di Roma operato da Alarico
nel 410, l’accusa cioè di
avere determinato la crisi
dell’impero. A coloro che
rimproveranoilCristianesimo
di essere all’origine dei mali
che hanno colpito Roma,
Agostino ricorda che Roma
aveva già subito rovesci e
sventure anche prima che si
diffondesse
la
nuova
religione; ma soprattutto si
interrogasuqualèilvalorein
base al quale dobbiamo
giudicare uno stato, e quindi
su quale è il giudizio che si
debbadaresuRoma.
Seilcriteriopergiudicare
uno stato dev’essere quello
dellaveragiustizia,cioèdella
giustizia cristiana, allora si
deve
sostenere,
dice
Agostino, che la Roma
pagana, anche quella del
tempo di Cicerone, non è
stata una vera res publica,
perchélemancavaappuntola
vera giustizia, che consiste
neldareaciascunociòchegli
è dovuto e quindi anche nel
dare a Dio ciò che gli spetta:
fuori dalla giustizia cristiana,
insomma,nonc’èunpopolo,
un ordine politico, uno stato
che sia realmente legittimo1:
«dove non vi è una tale
giustizia, non vi è neppure
una unione di uomini
associati dal consenso del
diritto e dal bene comune»2.
In quanto vi manchi la
giustizia, sostiene Agostino
nel libro IV della Città di
Dio,iregnidegliuomininon
si distinguono in realtà dalle
associazioni dei briganti, che
siunisconoperdepredareesi
danno una norma per
dividersi il bottino: «Bandita
la giustizia, che altro sono i
regni se non grandi
associazioni di delinquenti ?
Elebandedidelinquentiche
altro sono se non piccoli
regni?
Si
ha
infatti
un’associazione di uomini
quando un capo comanda, è
stato accettato un patto
sociale e la divisione del
bottino è regolata da certe
convenzioni»3.
Si deve anche ricordare,
peraltro,chelanecessitàdello
stato, nella visione di
Agostino,nonèqualcosache
risponda
alla
natura
dell’uomo, ma rimanda
piuttosto alla natura umana
corrottaedisordinatachesiè
determinata in seguito al
peccato
originale.
Nel
disegno divino, non c’era il
dominio dell’uomo su altri
uomini, ma solo quello
dell’uomo sugli animali. Il
dominio degli uomini sugli
uomini,ilgovernocoercitivo,
è reso necessario dalla
corruzione
del
peccato
originale e ne è anche il
castigo4.
Tuttavia, il giudizio di
Agostino sullo stato non si
arrestaallaaffermazioneche,
dovenonvièveragiustizia,lì
non vi è neppure né popolo
né stato. Anche un ordine
politico che non attinga alla
giustizia ha infatti una sua
funzione che, se non deve
essere esaltata, deve essere
però riconosciuta come
significativa e positiva. Se si
adotta un criterio meno
intransigente per ragionare
sulla legittimità di una
associazione politica, si deve
riconoscere
che
questa
soddisfa il suo scopo quando
riunisce una moltitudine di
esseri ragionevoli uniti nel
perseguire i beni che
prediligono, e assicura loro
un ordinamento di pace e di
concordia.
Ma,sesiassumonoquesti
punti di partenza, allora si
può affermare che i Romani
furono effettivamente un
popolo e una res publica, la
cui funzione fondamentale,
peraltro,fuquelladiunificare
il mondo preparando il
terreno per l’avvento della
predicazione cristiana. Per
Agostino dunque, come è
stato scritto, «nell’ordine
della vera storia della
salvezza
l’effettiva
importanza della Roma
imperiale
consiste
nel
mantenimento della pace
sulla terra come condizione
perladiffusionedelVangelo.
Imperiestatinonsonoopera
del demonio e neppure sono
inséunbenecheabbialasua
giustificazione nella legge di
natura.Laloroorigineènella
iniquità dell’uomo, e il loro
relativo significato poggia
sulla conservazione della
paceedellagiustizia»5.
Quello che veramente
importa
nella
storia
dell’uomononèlagrandezza
degli imperi, le cui vicende
sonocomunquegovernatedal
disegnodivino,malalottatra
la civitas Dei e la civitas
terrena. Le due città non si
identificano rispettivamente
con la Chiesa e con lo stato,
ma designano piuttosto due
opposti modi di vivere: nella
Chiesa
concretamente
esistente (che pure della città
celeste è la prefigurazione),
noncisonosoltantoigiustie
gli eletti, ma anche individui
destinatiaesseredannati;elo
stesso accade nella società
politica. Le due città sono
pertanto da intendersi come
due società governate da
principi contrapposti: la città
terrenaèun’unionechenasce
per soddisfare il desiderio di
gloria,
l’ambizione,
la
cupidigia;
è
governata
dall’amore di sé spinto fino
all’indifferenza nei confronti
di Dio. La città di Dio,
ovvero la città celeste, è
invece governata dalla legge
dell’amore, dell'umiltà, del
sacrificio di sé. Essa è la
società dei giusti che vivono
questo mondo da stranieri,
come un transito verso la
redenzione.
Il dualismo tra le due
città, intrecciate e destinate a
conviveredaltempodiCaino
eAbele(chenesonoleprime
incarnazioni) per tutta la
duratadellastoriadell’uomo,
terminerà soltanto nella fine
escatologica, quando si
instaureràlacittàdiDioecon
essalaperfettaconcordia.
E a partire da questo
orizzontechesiprofilaanche
il modo in cui, secondo
Agostino, devono essere
pensatiirapportitralaChiesa
e lo stato cristiano, cioè
quello stato che professa la
vera fede. Ognuno dei due
poteri ha la sua autonoma
sfera d’azione: lo stato si
occupa dell’uomo nella sua
dimensione materiale e
brandisce la spada che
punisce; la Chiesa invece
cura gli interessi spirituali.
Sebbene le due sfere siano
distinteeindipendenti,quella
spirituale è superiore, anche
perché la sua giurisdizione
non è limitata nello spazio e
nel tempo: mentre gli stati
sono soggetti al tempo la
Chiesa è al di sopra del
tempo, perché si situa nella
prospettiva escatologica della
città celeste. Essa peraltro
nonesitaaservirsidellostato
come suo «braccio secolare»
per reprimere l’eresia: la
spada dell’impero deve
accorrere in soccorso della
fede col timore che ispira ai
miscredenti.
2.Ilpoteredel
ponteficeeilpotere
politico.
Il problema del reciproco
rapporto tra i due poteri,
quello sacro del pontefice e
quello politico dei re o degli
imperatori, attraversa tutta la
storiadelMedioevocristiano,
generando una lunga serie di
interpretazioni e di conflitti.
Per un verso i due poteri
devono essere distinti in
quanto sono diverse le
funzioni che spettano a
ciascuno di essi; ma il
problema è se si debbano
considerare entrambi i poteri
come derivanti direttamente
da Dio, e quindi posti su un
piano di coordinazione e di
cooperazione
reciproca,
fermo restando che ognuno è
sovrano nella sua sfera di
competenza; oppure se,
partendo dal fatto che il
poteredellaChiesasicolloca
spiritualmente su un piano
più alto, si debba porre una
supremazia del pontefice, e
fardiscenderedaluianchela
legittimazione del potere
politico.
Il
principio
dell’indipendenza reciproca
dei due poteri, ciascuno
sovranonelsuoambito,passa
perciò in secondo piano
quanto più si sottolinea il
rango superiore del potere
pontificale, fino al punto di
subordinare o assorbire il
diritto dello stato nel diritto
ecclesiastico.
La dottrina del primato
del potere papale su quello
secolare verrà sostenuta dalla
Chiesa con sempre maggiore
energia nei secoli che
seguono alla morte di
Agostino. Essa in questo
modosiavvianelladirezione
di quello che è stato definito
l’«agostinismo politico», e
che però si allontana dalle
originarie tesi agostiniane,
giungendo a subordinare
sempre più decisamente la
politica ai fini sovrannaturali
di cui l’autorità religiosa è
custode. È questa la linea di
pensiero che verrà difesa già
dapapaGregorioMagnoalla
fine del vi secolo, e
successivamentedaIsidorodi
Siviglia. Nell’800, con
l’incoronazione di Carlo
Magno in Roma da parte di
papa
Leone
III,
la
restaurazione
dell’idea
imperiale nel Sacro Romano
Impero avviene sotto l’egida
della Chiesa di Roma, che le
conferisce il crisma della
legittimità; l’alleanza tra la
Chiesa e gli imperatori,
tuttavia, implica anche il
rischio per la Chiesa di venir
riassorbita dal potere politico
e di cadere sotto la sua
egemonia.
Sfaldatosi nel periodo
successivoallamortediCarlo
Magno, l’impero verrà poi
ricostruito da Ottone I re di
Germania che nel 962
riceverà la corona imperiale
da papa Giovanni XII; ma il
nuovo
imperatore,
pur
proclamandosi devoto figlio
dellaChiesaedifensoredella
cristianità,cercheràdimettere
laChiesasottolasuatutelae
rafforzerà il suo potere con i
vescovi-conti da lui stesso
nominati. L’accrescersi del
potere imperiale, che con
Ottone II pretenderà di
esercitare il proprio controllo
anche sul papato, porterà
successivamenteallalottaper
leinvestitureealconflittopiù
asprotrapapatoeimpero.La
battaglia per riconquistare
l’autonomia della Chiesa e il
suo esclusivo diritto di
conferire le cariche religiose
saràsostenutaconlamassima
energia, nel conflitto che lo
oppone all’imperatore Enrico
IV di Germania, da
IldebrandodiSoana,salitoal
soglio pontificio come Papa
Gregorio VII nel 1073.
Poiché
l’imperatore
continuava ad arrogarsi la
nomina dei vescovi, ed era
arrivato al punto di far
convocare un sinodo che
dichiarasse la deposizione di
Gregorio VII, il papa, dopo
averloscomunicato,proclama
lasuadeposizione,edichiara
sciolti i sudditi dall’obbligo
dell’obbedienza: l’imperatore
Enrico IV sarà costretto
all’umiliazionediimplorareil
perdono del papa a Canossa.
In quanto successore di
Pietro, che ha ricevuto
direttamente da Cristo il
poteredisciogliereelegare,il
papa, sostiene Gregorio VII,
possiede l’unica vera autorità
universale, alla quale chi
detiene un’autorità di origine
meramente umana come
l’imperatore non può che
essere sottoposto: come ogni
cristiano,
anch’egli
è
sottomesso al giudizio e alle
sanzioni
del
pontefice
romano, che deve insegnare
ai sovrani della terra l’umiltà
eabbatternel’orgoglio.
In modo ancora più netto
la superiorità del potere
papale sarà riaffermata da
InnocenzoIVcontroFederico
II,conlacuisconfittacrollerà
il sogno degli imperatori
tedeschi di restaurare la
monarchia
universale.
L’universalismo della Chiesa
di Roma non dovrà più
misurarsi con un altro
universalismo,
quello
imperiale, ma con la nuova
realtà di organismi politici
più limitati e più compatti
comelecittàeiregni.
3.Tommaso
d’Aquino,
Alla metà del xiii secolo,
con la diffusione delle
traduzioni latine delle opere
di Aristotele, il pensiero
cristiano dà luogo a un
grandioso
rinnovamento,
segnato
dalla
figura
imponente di Tommaso
d’Aquino. La riscoperta di
Aristotele apre la via a un
nuovo modo di pensare lo
spazio della politica, nella
positività e nella autonomia
delle sue ragioni umane.
Mentre in Agostino la
riflessione sulla politica
partiva da una concezione
pessimistica della natura
umana,dall’ideacheilpotere
politico fosse reso necessario
dalla corruzione di questa
natura attraverso il peccato
originale, e quindi da una
netta
antitesi
tra
la
dimensione della natura e
quella della grazia, in
Tommaso al posto di questa
antitesi subentra, anche in
seguito alla ricezione del
pensiero
politico
di
Aristotele,
una
visione
improntata non alla frattura
ma alla prosecuzione e alla
continuità: la natura e la
realizzazionedelbeneterreno
si superano e si compiono
nella dimensione della grazia
edellarealizzazionedelbene
spirituale. E in questo
orizzonte
la
politica
costituisce appunto una sfera
che, sebbene sia collocata su
un piano puramente umano,
halasuaprecisaautonomiae
il suo positivo spazio in
quanto attraverso di essa si
attuailbenedell’uomo.
La legge che sta al di
sopra di tutte e che governa
l’intero universo è per
Tommasolaleggeeternache
coincide con la sovranità di
Dio su tutte le creature.
Questa legge, che è appunto
la volontà del monarca
supremo, coincide con la
ragione divina e ordina tutto
invistadelmeglio.Poichéla
legge eterna governa tutte le
cose, anche le creature
ragionevoli (cioè capaci di
provvedere per sé e per gli
altri) vi sono sottoposte, ma
in una maniera particolare: il
modoincuigliuominidotati
di ragione partecipano della
legge eterna è la legge
naturale. La legge è una
regola delle azioni che
obbligaacompierecertecose
evietadifarnealtre;lalegge
naturale è nei suoi precetti
essenziali nota a tutti gli
uomini,validainognitempo,
e le sue prescrizioni sono
finalizzate al bene comune.
La legge naturale prescrive
quindi tutto ciò che giova a
conservare la vita dell’uomo,
mentre proibisce ciò che va
contro questo fine. Essa
comandaquindidiagireperil
bene,
e
perciò
è
fondamentalmenteinaccordo
con l’ordine naturale delle
inclinazioni umane, che
guidanol’uomoversociòche
è bene per lui. Essa quindi
prescrive di fare il bene e di
evitareilmale;dinonfaredel
male a coloro con i quali
viviamo;ditendereaunavita
in cui si realizzi la natura
razionaledell’uomo.
Poiché però la natura
umana può anche deviare da
quelli che sono i suoi fini
positivi, e la ragione può
essere alterata dalle passioni,
dalle cattive abitudini o dalla
malvagità
naturale,
è
necessario che gli uomini
siano educati alla disciplina
della virtù, e siano puniti
qualora se ne allontanino:
questa è la funzione delle
leggi umane, che assicurano
che tra gli uomini regnino la
pace e siano bandite le
ingiurie reciproche, grazie al
timore del castigo che queste
stesse leggi comminano ai
trasgressori.
Le leggi umane, quindi,
hanno il loro fondamento
razionale nella legge di
natura, che non devono mai
contraddire:unaleggeumana
ingiusta,cioèchevacontrola
legge di natura, non può
essere neppure chiamata
legge. Derivando dalle leggi
di natura, però, le leggi
umane le articolano e le
specificano: dai principi
generali della legge di natura
discendono le proibizioni
fondamentali (come per
esempio non ammazzare);
mentre in modo diverso
derivanodallaleggedinatura
tutte
le
specificazioni
riguardantiimodi,itempi,la
naturadellepunizioniecc.La
giustizia si definisce come la
volontà costante di dare a
ciascuno il suo, mentre il
dirittovienedistintoindiritto
naturale e diritto positivo:
naturale è quello che deriva
dallanaturastessadellacosa,
mentre positivo è quello che
deriva o da un accordo
privato, o da un patto
pubblico,odaciòcheèstato
stabilitodalprincipe.
Seguendol’impiantodella
Politica
di
Aristotele,
Tommaso considera il vivere
insocietàcomeconformealla
natura dell’uomo: l’uomo fa
parte della famiglia e questa
della città, e il bene del
singolo perciò non è un fine
ultimo,
ma
dev’essere
ordinato al bene comune. Il
potere politico, cioè quello
che si esercita non sugli
schiavi o sui servi ma sui
liberi, è una necessità della
convivenza umana, che non
dipendedalfattochelanatura
si sia corrotta attraverso il
peccato originale. Anche
nello stato di innocenza ci
sarebbe bisogno del potere
politico, perché gli uomini
tendono per loro natura a
vivere in società e la vita in
società non sarebbe possibile
senonvifosseunpotereche
regolal’azionedeisingoliela
orientaversoilbenecomune.
Come il corpo dell’uomo ha
bisogno di un’unità direttiva
che comanda all’agire e lo
orienta verso il bene, così la
moltitudine degli uomini ha
bisogno di una direzione per
non disgregarsi caoticamente
epervenireorientataversoil
bene comune. Il bene
comune, peraltro, non è in
conflitto con il bene del
singolo perché, essendo
questi per sua natura un
membrodellafamigliaedella
società, realizza il suo bene
solo nel contesto di un bene
piùvasto.Laleggedev’essere
dunque finalizzata non al
bene di un singolo, ma
all’utilità
generale
dei
cittadiniedev’essereconsona
alle circostanze e alle
consuetudini nelle quali si
deve applicare. Inoltre la
leggepoliticanondeveenon
puòpuniretuttiiviziàiquali
si abbandonano gli uomini
non virtuosi, e che sono
condannati
dalla
legge
morale:essadevepuniresolo
i vizi più gravi e quelli
attraversoiqualigliindividui
nuoccionoaglialtri,comeper
esempio l’omicidio, il furto
ecc.
Se è vero che, come
abbiamo detto sopra, una
legge ingiusta non è una
legge, fino a che punto gli
uominisonotenutiaobbedire
a essa, e fino che punto le
possono opporre una giusta
resistenza ? Per rispondere a
questa domanda, secondo
Tommaso,
bisogna
distinguere tra diversi tipi di
ingiustizia. Se un legge
ingiusta comanda qualcosa
contro Dio, per esempio
imponendo
un
culto
idolatrico, allora gli uomini
non devono in nessun caso
obbedire a essa, perché il
comandodiDioèsuperiorea
quello del principe e vincola
l’uomo anche contro di esso.
Diverso è il caso delle leggi
inique che sono tali perché
attentanoaquelbenecomune
chelaleggeavrebbeinveceil
compito di promuovere.
Questeleggicontrariealbene
umano
possono
essere
ingiuste in diversi sensi: o
perché mirano solo a
soddisfareilbenedelprincipe
e non quello della comunità,
o perché escono dai limiti di
competenza di chi le emana,
o ancora perché impongono
oneri ai sudditi in modo
iniquo. Queste leggi (che si
potrebbero definire come
delle vere e proprie
«violenze»),
in
quanto
ingiuste, non obbligano nel
foro interno ovvero in
coscienza; però, aggiunge
Tommaso,inquantoessenon
ci impongono di violare i
comandi divini, può essere
consigliabile rispettarle per
evitarescandaliodisordine.
Il governo tirannico dà
luogo a un caso tipico di
legge ingiusta, perché (e
anche qui Tommaso segue
Aristotele) è quello dove la
legge non è indirizzata al
bene comune ma al solo
vantaggio
del
despota.
Sebbene Tommaso condanni
ingeneralelaribellionecome
un peccato, non considera
come atto sedizioso la
resistenza opposta al tiranno.
Rovesciare un governo
tirannico, perciò, è lecito e
non configura atto di
ribellione, a meno che i
disordini causati da questo
rivolgimento
non
determinino,
per
la
moltitudine, mali peggiori di
quellicheessasubivasottoil
potere tirannico. Secondo
Tommasononèinvecelecito,
per un privato cittadino,
uccidereiltiranno.
Per quanto riguarda la
questione di quale sia la
migliore forma di governo,
ancheinessaTommasosegue
l’orientamento della Politica
di Aristotele: nella Summa
Theologica
l’Aquinate
sostiene che la forma
migliore di regime politico
non è né la monarchia, né
l’aristocrazia
né
la
democrazia, ma una forma
mista, che riassuma in sé i
vantaggi di tutte e tre le
forme «pure»: il potere di
comando dev’essere detenuto
da
un’autorità
unica
(monarchia); questa deve
essereaffiancatadaunampio
corpo di cittadini qualificati
(come vuole l’orientamento
aristocratico);conformemente
invece
al
principio
democratico,
questi
governanti dotati di idonee
qualità devono essere scelti
nell’ambito del popolo ed
eletti dal popolo stesso. Il
pensierodiTommasosembra
però assumere una curvatura
diversa nel De regno (noto
anche come De regimine
principium,),
un’opera
indirizzata al monarca di
Cipro.
Qui,
Tommaso
sostienecheilgovernodiuno
solo è preferibile al governo
di
molti,
adducendo
numerose
ragioni
in
proposito. Verso la fine del
xiiisecolo,quandoTommaso
scriveva il suo trattato, si
stavaappuntoconsumandola
forma politica imperiale e si
stavano cominciando ad
affermareiregniparticolari.
Nelle sue tanto ampie
riflessioni, infine, Tommaso
non manca di discutere il
punto che, come abbiamo
accennato, era stato al centro
per secoli di molte lotte e
conflitti: e cioè quello del
rapporto tra potere politico e
potere religioso. Tommaso
ribadisce che il potere
spirituale, cioè quello del
pontefice, è superiore al
poteresecolare;quest’ultimo,
però, è soggetto alle
intromissioni del primo non
nellemateriecheriguardanoi
suoi scopi precipui, e cioè la
felicità terrestre, ma solo in
ciò che tocca il fine della
beatitudine eterna. Questo
pensiero viene ribadito e
chiaritonelDeregno:comeil
fine terreno è subordinato al
fine soprannaturale, così il
potereterrenoèsubordinatoa
quello sacerdotale (valeva
l’inversonellasocietàpagana
dove, essendo fine supremo
l’acquisto dei beni temporali,
ilpoteredelsacerdotedoveva
essere subordinato a quello
del re). Il re dunque deve
presiedere a tutte le funzioni
umane
e
assicurare
l’attuazione della vita buona
suquestaterra:assicurandola
pace,chetuttioperinobene,e
che ci sia sufficiente
abbondanza delle cose che
sono necessarie per vivere
bene. Ma la vita buona su
questa terra è poi nel suo
insiemeordinataaunfinepiù
alto, e cioè quello della
beatitudineceleste,lacuicura
è nelle mani non del re ma
dell’autoritàreligiosa.
Bisognerà aspettare la
Monarchia di Dante, agli
inizi del xiv secolo, perché
questa subordinazione venga
messa
radicalmente
in
discussione. Riproponendo il
tema dell’impero come unica
garanziadellagiustiziaedella
pace universale Dante (il cui
pensiero sembra a questo
proposito
colorarsi
di
venature averroiste) sosterrà
al tempo stesso la netta
indipendenza dei due fini ai
quali la vita umana è
ordinata:
quello
della
beatitudineterrena,alqualesi
perviene
attraverso
gli
insegnamentifilosofici,eche
è
di
competenza
dell’imperatore;equellodella
beatitudineceleste,alqualesi
perviene attraverso le verità
rivelate e gli insegna-menti
spirituali, e che è di
competenzadelpontefice.Per
Dante non vi è dunque
subordinazione del potere
secolare rispetto a quello
Spirituale; e il primo, non
meno del secondo, riceve la
sua investitura direttamente
daDio,senzaintermediari.È
chiaro che il potere politico
dovrà, a quello religioso,
rispettoedevozione(comesi
legge nella conclusione della
Monarchia) senza però che
ciòconfigurialcunaformadi
vera
e
propria
subordinazione.
4.Larotturadella
«respublicachristiana»
elaRiforma
protestante.
La crisi dei due
universalismi concorrenti e
complementari, quello della
Chiesaequellodell’impero,è
già
ampiamente
aperta
quando Dante ne traccia,
nella Monarchia, i reciproci
confini.Fallisce,agliinizidel
Trecento,
il
tentativo
teocratico di papa Bonifacio
VIII
di
ricondurre
all’obbedienzàilrediFrancia
Filippo il Bello, impegnato a
rafforzare il potere centrale
dellamonarchiaaidannidella
nobiltà e del clero; e
l’impresa imperiale di Enrico
VII, che scende con le sue
truppeinItalianel1310,eal
quale Dante guarda come a
una speranza, naufraga tre
anni dopo con la morte di
Enricostesso.
Nel 1324 Marsilio da
Padova, schierato a favore
dell’imperatore Ludovico il
Bavaro e contro la Chiesa
romana che lo aveva
scomunicato,
pubblica
un’opera, il Defensor Pacis,
nella quale le pretese
ecclesiastichediun’egemonia
sul potere politico vengono
respinte con violenta forza
polemica: la legge che deve
governarelacittàdeveessere
il frutto della volontà dei
cittadini o della loro parte
prevalente, in senso sia
quantitativo che qualitativo.
L’autorità politica non può
ammettereunsuperioresopra
di sé, e perciò la tesi della
plenitudo potestatis (cioè
della pienezza di potere)
sostenuta da Bonifacio VIII
deve essere respinta: questa
moltiplicazione dei poteri e
delle possibili occasioni di
conflitto,
anzi,
è
incompatibile con quello che
è lo scopo dell’unione
politica, e cioè assicurare la
paceelaconcordia.Ancheil
francescano Guglielmo di
Ockamsibatte,intesticome
il Dialogus de potestate
papae et imperatoris, del
1342, contro la tesi della
pienezza del potere papale
anche nelle cose temporali; e
difendelalibertàdeicristiani
dalle pretese del pontefice di
dettare legge anche nel
campo
politico,
che
determinerebbero la peggiore
delletirannie.
Nei primi decenni del
Trecento la crisi dei due
grandi
universalismi
medievali è sempre più
evidente: a essa concorrono
unamolteplicitàdifattoriche
imprimono
alla
storia
dell’Occidente una svolta di
enorme rilievo, la svolta
verso la modernità. Per
quanto riguarda la Chiesa,
questaèattraversata,apartire
dal trasferimento della sede
papale ad Avignone sotto il
diretto controllo di Filippo il
Bello, da una sequenza di
gravissime
crisi:
dalla
cattivitàavignonesealgrande
scisma d’Occidente (13781417), con due papi, e infine
addiritturatre,acontendersiil
soglio pontificio. Il processo
che porterà alla nascita dei
grandi stati nazionali (a
cominciare dalla Francia e
dall’Inghilterra) spinge le
monarchie a voler esercitare
un potere diretto sulle chiese
nazionali, che devono essere
rese indipendenti da Roma.
Mentre la corruzione della
chiesa romana, sempre più
assorbita nei suoi interessi
temporali, innesca i primi
movimenti di critica radicale
e di riforma, che combinano
istanze di rinnovamento
spiritualeconspintenazionali
(è il caso per esempio di
WyclifinInghilterraediHus
in Boemia). Intanto, ai primi
decenni del Quattrocento, il
movimento conciliare (con i
concili di Costanza e di
Basilea) afferma una visione
collegiale della Chiesa dove
hanno
più
peso
i
rappresentanti delle nascenti
nazioni e si mette in
discussione l’autorità del
papa.
ConlaProtestadiLutero,
che nel 1517 affigge sulla
porta del castello di
Wittenberg 95 tesi contro il
commercio delle indulgenze
(uno dei molti mali che
affliggevano la Chiesa di
Roma,echedapiùpartieda
tempovenivanodenunciati)si
rompe
l’unità
del
cristianesimo europeo. Nel
1520 Martin Lutero, un
monacoagostiniano,bruciala
bolla di scomunica che era
stataemessacontrodiluidal
papaLeoneX,edàl’avvioa
quel processo di riforma
religiosa che in breve tempo
farà proseliti in molti Paesi
d’Europa.
La
riforma
distrugge
la
struttura
gerarchica della Chiesa che
era stata una delle grandi
istituzioniportantidelmondo
medioevale: per Lutero,
infatti, non c’è più un ruolo
specificodelsacerdoziocome
intermediario tra Dio e i
fedeli; egli sostiene la
dottrina del sacerdozio
universaledeicredenti;riduce
il numero dei sacramenti
riconoscendone soltanto tre
(l’eucaristia, il battesimo e la
penitenza, che hanno il loro
fondamento nella sacra
Scrittura,mentreglialtrisono
stati istituiti dall’autorità
ecclesiastica); afferma il
principio del «libero esame»,
per cui ogni credente può
rapportarsi direttamente al
testo sacro, e interpretarlo,
senza
la
mediazione
dell’autorità ecclesiastica; a
questo fine, traduce in
tedesco la Bibbia e ne
sollecita la diffusione tra i
credenti in modo che la
possanoleggeredirettamente.
Alla
negazione
dell’autorità
ecclesiastica
gerarchicamente strutturata
corrisponde però, in Lutero,
unaaltrettantoforteinsistenza
sul dovere dell’obbedienza
alleautoritàpolitichevigenti,
che lo porterà ad appoggiare
interminidrasticieviolentila
repressione da parte dei
principi tedeschi della rivolta
dei contadini, che si
ispiravanoalletesiradicalidi
ThomasMuntzer.Ricercando
l’appoggio dei principi nella
sualottacontroRoma,Lutero
tesse la più dura apologia
dell’autorità politica, la cui
repressione del male e della
disobbedienza
dev’essere
spietataesenzalimiti.
A partire dal suo
peculiareorizzonteteologico,
caratterizzato da una netta
scissione e da una mancanza
di mediazione tra l’ordine
della natura e quello della
grazia, Lutero giunge a una
visione del mondo politico
dove
la
separazione
agostiniana tra le due città,
quellaterrenaequellaceleste,
è ulteriormente radicalizzata
andando molto al di là di
quanto aveva sostenuto
l’autoredellaCittàdiDio.Le
antitesi
proprie
dell’insegnamento paolino e
agostiniano (legge e grazia,
carne e spirito, fede e opere,
libertà e servitù) vengono da
Lutero
ulteriormente
drammatizzatenellascissione
tra il regno terrestre e quello
spirituale.IlregnodiDioèun
regno di grazia e di
misericordia, di una grazia
che l’uomo non può
guadagnarsi con le opere,
perché è un puro e gratuito
donodivino.Ilregnoterreno,
invece, è irrimediabilmente
segnato dalla perversità e dal
disordine della natura umana
cheèconseguenteallacaduta
nel
peccato
originale.
Contrariamente a quanto
accadeva in Tommaso, dove
la felicità terrena, con la sua
positività, era inserita in un
orizzonte
finalistico
indirizzatoversolavettadella
beatitudineceleste,perLutero
nonvièmediazionetraidue
regni, e quello terreno,
spogliato di ogni intrinseco
valore e positività, si oppone
polarmente a quello della
grazia e della misericordia:
esso «è un regno d’ira e
severità, perché non sa che
punire, vietare, giudicare e
condannare, per tenere a
frenoimalvagieproteggerei
buoni»6.
Come è stato scritto,
perciò, il potere, in Lutero
«non si esercita più nei
confronti di un popolo
organicamenteenaturalmente
riunitonellacomunitàpolitica
-secondounclassicodisegno
ancora presente in Marsilio
ma già abbandonato da
Machiavelli -, né è più
legittimato dal suo ruolo di
garante e interprete di un
comuneordinedifiniaiquali
ciascuno e tutti sono legati.
Esso, al contrario, nasce per
raffrenare una moltitudine
d’individualità singolarmente
senzienti e desideranti e,
proprio perché tali, tra loro
ferocemente
divise
e
contrastanti. Un potere
politico nato da questi
presupposti si deve perciò
manifestare nel modo più
decisoeinattaccabile»7.Maè
proprio la radicale scissione
luterana tra i due regni, che
consegna quello dell’uomo a
una pura malvagità e
immanenza, priva di una
regola finalistica e di una
intrinsecapositività,chepone
alcuni
dei
presupposti
culturali per la modernità
politica come sarà pensata a
partire da Hobbes, nel suo
orizzonte di pessimismo
antropologico e di radicale
individualismo. Così come
sarà a partire dall’esperienza
delle guerre di religione, che
insanguineranno l’Europa in
seguito alla Riforma, che
verrà
faticosamente
affermandosi la tesi della
tolleranzaedellaconvivenza,
in uno stesso stato laico, di
dottrinediverse.
1 agostino,De Civitate
Dei, 19.21, trad. it. Edizioni
Paoline, Roma 1963, pp.
1068sgg.
2Ibid.,19.23,p.1078.
3Ibid.,4.4,p.178.
4Ibid.,19.15,pp.1060-
62.
5K.Lowith,Significato
e fine della storia (1949),
trad.it.EdizionidiComunità,
Milano1972,p.194.
6 M. lutero, Scritti
politici,Utet,Torino1986,p.
510.
7 G. cotta, La nascita
dell’individualismo politico.
Lutero e la polìtica della
modernità,
il
Mulino,
Bologna2002,p.134.
IV.Ilparadigmadel
contratto
I.Ilmodello
contrattualista.
Al modello classico che
pensa l’ordine politico come
finalizzato al vivere bene
nella comunità, la filosofia
politica della modernità
contrappone il modello
contrattualistico, che, nelle
sue
differenti
versioni,
domina le vicende del
pensieropoliticotraHobbese
Kant salvo poi riproporsi, in
unanuovadeclinazione,nella
filosofia politica del tardo xx
secolo. La forza del modello
contrattualisticononstacerto
nella pretesa di ricostruire il
processo
storico-genetico
dellasocietàpoliticaapartire
da individui originariamente
pensati come isolati. Se lo si
intendesse così, il modello
contrattualista
andrebbe
effettivamenteincontroatutte
le obiezioni, molto facili e
banali,cheneltempoglisono
state mosse, a cominciare da
quella,inognisensodecisiva,
inforzadellaqualelapretesa
di separare l’umanità dalla
socialità, e di porre un uomo
isolato che sia già uomo
prima ancora di instaurare il
legame sociale con i propri
simili, non è altro che una
ridicola «robinsonata», come
avrebbe detto ironicamente
Marx alludendo al Robinson
CrusoediDefoe.
L’interesse del modello
contrattualista non è certo da
vedersi,dunque,nelfattoche
esso fornisce uno schema
lungo il quale ricostruire la
genesi dello stato politico;
esso risiede invece in una
problematica completamente
diversa, che lo strumento
contrattualista
sembra
particolarmente adatto ad
affrontare: e cioè la
problematica della legittimità
dell’ordine statale ovvero del
carattere
vincolante
dell’obbligo politico che a
esso ci lega. Il modello
contrattualista, perciò, è
essenzialmenteunmetodoper
dare una risposta razionale
alla domanda che in un certo
senso fa tutt’uno con il
pensieropoliticoecioè:come
deve essere organizzato uno
stato legittimo, cui tutti i
cittadinisianotenutiadareil
loro assenso. Se si ragiona
utilizzando lo schema del
contratto, la via per
rispondere a questa domanda
viene aperta e tracciata in
modo
straordinariamente
limpido
e
interessante:
l’ordine politico legittimo, si
dirà,
è
quello
che
deciderebbero
di
darsi
individui che, come in un
esperimento mentale, non
vivessero già in uno stato
costituito, ma si trovassero
invece a vivere in una
condizione prepolitica e
prestatale,prividirapportidi
subordinazione reciproca e
quindi in una situazione di
sostanziale eguaglianza e
libertà. Sta in questo, e non
certoaltrove,ilgrandevalore
rivoluzionario
dell’idea
contrattualistaeilsuonucleo
profondo di senso: l’ordine
politicolegittimoèquelloche
meriterebbe il consenso
razionaledapartediindividui
liberi ed eguali, che si
trovassero a scegliere come
organizzare
la
loro
convivenza partendo da una
condizione
prepolitica
ovvero, come diranno i
contrattualisti, da uno «stato
dinatura».
L’idea contrattualistica,
insomma, non esprime una
verità storica ma una
questione controfattuale; non
risponde alla domanda come
sono andate le cose, ma a
quella su come dovrebbe
essere organizzato un ordine
politico
legittimo.
Gli
argomenti
contrattualisti
quindi, nelle loro differenti
versioni,
mostreranno
innanzitutto che, se gli
individui si trovassero a
vivere in una condizione
prepolitica,
essi
sceglierebberodidarvitaallo
stato,chequindièlegittimato
in quanto è una istituzione
che, qualora non si fosse già
data, gli individui avrebbero
scelto di darsi; in secondo
luogo, obiettivo del pensiero
contrattualista sarà quello di
mostrare, partendo dalla
ipoteticasituazioneinizialedi
scelta, quali istituzioni gli
individui si sarebbero dati;
perché appunto legittime,
nella
prospettiva
contrattualista, sono solo
quelle istituzioni cui gli
individui
in
situazione
inizialeavrebberodatoilloro
assenso. Nella tradizione
contrattualistica,
però,
incontriamo molti modi,
profondamentediversigliuni
dagli altri, di rappresentarsi
quelle che dovrebbero essere
le caratteristiche strutturali di
unordinepoliticolegittimo:e
le risposte sono diverse, tra
l’altro,perchécambiailmodo
in cui viene prospettata la
situazione iniziale, mutano le
caratteristiche che vengono
attribuite agli attori che ne
sonoprotagonisti,cosìcomei
criteridirazionalitàsecondoi
quali essi operano le loro
scelte. Val la pena di
soffermarsi su quello che,
senza troppe forzature,
possiamo
chiamare
il
paradigma
contrattualista
perché esso può essere
considerato il paradigma
concettuale più forte e
consistente cui abbia dato
luogo la filosofia politica
normativa,cheinfattiaessoè
in qualche modo tornata
anche dopo un periodo di
lunga eclisse. Accingiamoci
perciò ora a ripercorrerne le
figure e le mutazioni più
rilevanti.
2.Lacesuradi
ThomasHobbes.
Ciò che consente di
individuare
in
Thomas
Hobbes (1588-1673) il vero
padre della filosofia politica
moderna è innanzitutto la
chiarezza con la quale egli
prende le distanze dal modo
classicodipensarelasocialità
elapoliticitàdell’uomo,così
come era stato tramandato
nella Politica di Aristotele.
Mentre
nella
visione
aristotelica l’assestarsi degli
uomini in rapporti di
convivenza gerarchicamente
ordinata può essere visto
come un processo naturale e
spontaneo, che non ha nulla
di
particolarmente
«improbabile» e non richiede
dunquesofisticatespiegazioni
che ne rendano conto, nella
visione hobbesiana vale
esattamentel’opposto.Perun
verso non ci sono ragioni
«naturali»inforzadellequali
alcuni uomini siano, per così
dire, destinati a comandare e
altri a obbedire. Hobbes sa
bene, e lo ricorda nel
Leviatano1cheAristotele,nel
primolibrodellasuaPolitica,
ha sostenuto che vi sono
uominipiùsaggi,predestinati
dalla natura a comandare, e
altri meno dotati, e fatti per
ubbidire.
Ma
questa
presunzione di una originaria
e naturale ineguaglianza di
capacità che, se si desse,
consentirebbe agli uomini di
assestarsi in rapporti naturali
e ordinati di comando e
obbedienza,
è
secondo
Hobbes, come ora vedremo,
smentita dalla ragione e dai
fatti. A smentire il carattere
artificiale e «improbabile»
dell’ordine politico non vale
neppure
il
richiamo,
anch’esso aristotelico, a
quegli animali politici che,
come le api e le formiche,
vivono naturalmente in
società senza aver in alcun
modo istituito l’ordine al
qualesottostanno.Gliuomini,
infatti,nonsonoassimilabilia
questi ordinati animali, per
molte ragioni tra cui quelle
che gli uomini sono
costantemente
in
competizione tra loro, che la
soddisfazione che più li
gratifica è quella di essere
superiori agli altri, che sono
dotati di ragione e quindi la
usanopercriticareilmodoin
cui vengono condotti gli
affaricomuni,chepossiedono
l’arte della parola grazie alla
quale possono far apparire
buono ciò che è cattivo e
cattivociòcheèbuono2.
La destrutturazione della
socialità
naturale
(e
naturalmente gerarchica) di
Aristotele non è quindi
nient’altro
che
la
implicazionecriticadelledue
tesi principali che Hobbes in
positivo sostiene, e che sono
tra
loro
strettamente
connesse, e cioè la tesi della
naturale eguaglianza tra gli
uomini(cheimpediscelorodi
assestarsi spontaneamente in
rapporti gerarchici) e quella
della loro conflittualità (che
impedisce loro di convivere
pacificamente a meno che
non si siano dati delle
«artificiali»
istituzioni
coercitive,
che
questa
conflittualità tengano a
freno).
Hobbes (che avrebbe
potuto anche addossare ai
sostenitori dell’ineguaglianza
il difficile onere della prova)
dimostra con argomenti
semplici ma efficaci che gli
uomini sono eguali «per
natura», e che quindi è
implausibile e illegittimo
spacciare come naturale
qualsiasi rapporto gerarchico
tra di essi: quanto alla forza
fisica, gli uomini possono
anchedifferire,masitrattadi
differenze non dirimenti
perché, infine, anche il più
debole ha abbastanza forza
per uccidere, magari con
l’astuziaoatradimento,ilpiù
forte. Quanto alle facoltà
mentali, la «prudenza» si
acquistaconl’esperienza,che
ovviamente è alla portata di
tutti; e inoltre i sostenitori
dell’ineguaglianza
dovrebbero spiega re perché,
se gli uomini sono ineguali
quanto alle facoltà dello
spirito, accade che ognuno
pensi dentro di sé di essere
più saggio degli altri: «non
c’èsegnopiùgrandediegual
distribuzione di qualcosa, del
fatto che ogni uomo è
contento
della
propria
parte»3. Gli uomini, dunque,
sono e si pensano eguali; nel
senso
che
anche
le
diseguaglianze che pur
sussistono non alterano
questa fondamentale parità, e
quindi non potrebbero mai
giustificare
la
naturale
sottomissione degli uni agli
altri.
Ma sono anche, per
Hobbes,
altamente
conflittuali;
anche
se
individuare con chiarezza i
motivi profondi del conflitto,
al di là della letteralità dei
testi in cui Hobbes li espone,
non è proprio cosa semplice:
quasi che il nostro, per
mostrarel'implausibilitàdiun
ordine
socio-politico
naturalisticamente
e
aristotelicamente
pensato,
avesse accumulato ragioni di
conflittualitàanchealdilàdi
quello che una tessitura di
pensiero coerente consenta.
Le linee di ragionamento,
comunque,
sono
fondamentalmente due. In
primo luogo, individui che si
trovassero in uno stato di
natura
entrerebbero
in
conflitto per diffidenza: non
potendo nessuno essere certo
di non venir aggredito e
ucciso dagli altri, ciascuno
dovrebbe a sua volta
aggredire e uccidere in
anticipo onde evitare di fare
la stessa fine. In secondo
luogo, gli uomini entrano in
conflitto perché animati da
quella passione che Hobbes
chiama la gloria: la maggior
soddisfazione, il piacere più
ambito,gliuominiloprovano
nel compararsi con gli altri e
nel vedere affermata e
riconosciuta
la
propria
superiorità; ma se ognuno
vuol esser superiore, il
confronto non potrà che
trasformarsiinconflitto.
Ma c’è di più. Alle
riflessioni fin qui ricordate
Hobbes aggiunge anche una
teoria della necessità del
conflitto nello stato di natura
di taglio più propriamente
giuridico: se si ammette che
ogni uomo ha per natura
dirittoadautoconservarsi,ea
usare tutti i mezzi atti a tale
scopo, allora ne consegue
che,nonessendocinellostato
di natura una legge comune
condivisa, ognuno è il solo
giudice di ciò che è
necessario
alla
propria
autoconservazione. Si può
direperciòche,finchénonvi
è una legge comune, ognuno
ha diritto a tutto; ma, poiché
tutti hanno diritto a tutto,
questi
diritti
entrano
necessariamente in conflitto,
e la conseguenza è che gli
uomini si ritrovano dunque a
vivere in uno stato di guerra
dove neanche il più piccolo
dirittoègarantito.
In ultima istanza, però, si
può forse affermare che la
radice più profonda del
conflitto, al di là di tutte le
deduzioni presentate da
Hobbes, sta proprio nella
fondamentale eguaglianza tra
gli uomini che della teoria
hobbesiana costituisce il
saldo e moderno assunto di
partenza: poiché gli uomini
sono
eguali,
nessuno
accetterà «naturalmente» di
sottomettersi a un altro. E
quindi il conflitto potrà
nascere in ogni momento,
finché gli individui non
avranno trovato il modo di
istituireunpoterecomune.
Lo stato prepolitico, o
stato di natura, caratterizzato
dalla mancanza di un potere
comune, non può essere
pertanto che uno stato di
guerra di tutti contro tutti. In
quantoconflittuale,lostatodi
naturaèunostatodipericolo,
insicurezzaemortedacuigli
individui non possono non
desiderare di uscire: come
diceHobbes,inunadellesue
note e più eloquenti
espressioni, nello stato di
natura, «la vita dell’uomo è
solitaria, misera, sgradevole,
brutaleebreve»4.
Lo stato prepolitico
significa dunque guerra,
insicurezzaemorte.Epoiché
ogni uomo desidera prima di
ognialtracosaconservarsiin
vita, la ragione gli prescrive
di cercare la pace e di
conseguirla. Le regole di
condotta che, se venissero
seguite da tutti gli uomini,
assicurerebbero loro la
pacifica convivenza sono
chiamatedaHobbes«leggidi
natura». Una legge di natura,
infatti, è «una regola
generale, scoperta dalla
ragione,chevietaadunuomo
di fare ciò che è lesivo della
suavita»5: le leggi di natura,
perciò, comandano agli
uomini di astenersi da tutti
quei comportamenti che,
costituendo un torto nei
confronti
degli
altri,
produrrebbero la guerra e
dunque metterebbero a
repentaglio
l’autoconservazione.Dabuon
teorico
della
ragione
calcolante,Hobbesritieneche
i comportamenti giusti siano
anche quelli che per gli
uomini sono convenienti,
poiché costituiscono appunto
la condizione di una pacifica
convivenza. Le leggi di
natura, dunque, sono i
precetti di una morale
razionale della reciprocità
che, se fosse seguita da tutti
gliuomini,consentirebbeloro
diviverebeneeinpace.Esse
ci impongono di trattare gli
altri come vorremmo essere
trattatinoi,dirispettareipatti
e di astenerci da ogni specie
di torto che potremmo voler
commettere ai danni degli
altri. In quanto ci ordina di
cercare la pace, la legge di
natura ci impone innanzitutto
di rinunciare al nostro diritto
sopra tutte le cose, e di
conservare solo tanta libertà
nei confronti degli altri
quanta ne concediamo agli
altri nei confronti di noi
stessi.
Ma il problema è che,
nello stato di natura, e cioè
finché manca un potere
comune, le leggi di natura,
cioè i comandi di questa
morale razionale, non sono
per gli uomini veramente
vincolanti.
In
quella
situazione, infatti, nessuno
può avere garanzie del fatto
che gli altri non gli faranno
torto, non lo aggrediranno,
non gli sottrarranno le sue
cose,nonlouccideranno,non
gli mancheranno di parola. E
proprioperquesto,ancheseè
assolutamente morale e ben
disposto verso gli altri,
nessun
uomo
può
razionalmente attenersi a ciò
che la legge di natura gli
prescriverebbe. Essa, per
dirloconlaclassicalocuzione
latina, mi obbliga soltanto in
foro interno, non in foro
externo. Anzi, per pure
ragionidirazionaleprudenza,
iodevoesseresemprepronto
adattaccareperprimo,anon
mantenere la parola data, a
fare agli altri quei torti che
devotemeredaloro.Questoè
l’unico
comportamento
razionale in una situazione
dove non c’è alcun ordine
pubblico, e dove quindi
ognuno deve pensare in
primo luogo a salvaguardare
sestesso.
Perliberarsidallestrettoie
di questa situazione, gli
individui hanno davanti a sé
una sola via d’uscita:
stringere tra di loro un patto
in forza del quale ognuno di
loro rinuncia (a condizione
che anche gli altri facciano
altrettanto)atuttiidirittiche
avevanellostatodinaturaeli
trasferisceaunsovrano,sotto
l’imperio del quale tutti
potrannoviveresicurieitorti
saranno puniti. La formula e
le conseguenze di questo
contrattosonodaHobbescosì
esposte: «Io autorizzo e cedo
ilmiodirittodigovernareme
stesso a quest’uomo o a
questaassembleadiuomini,a
questa condizione, che tu gli
ceda il tuo diritto, e autorizzi
tutte le sue azioni in maniera
simile. Fatto ciò, la
moltitudine così unita in una
persona viene chiamata uno
stato,inlatinocivitas.Questa
è la generazione di quel
grandeLeviatanoopiuttostoperparlareconpiùreverenza
-diquelDiomortale,alquale
noi dobbiamo, sotto il Dio
immortale,lanostrapaceela
nostradifesa...»6.
Attraversoilpatto,quindi,
gli individui istituiscono un
potere sovrano, in modo da
poter
vivere
in
un
ordinamento di pace e di
giustizia; la legge naturale
viene sostituita dalla legge
civile o positiva, cioè dalla
legge che il sovrano riterrà
opportuno emanare. Il potere
che
gli
individui,
spogliandosi tutti insieme del
loro diritto a governare se
stessi, hanno conferito a uno
solo (o a un gruppo di
uomini), è ora un potere
assoluto in quanto, per
inoppugnabili ragioni di
ordinelogico,nonpuòessere
soggetto a limiti. In primo
luogo, questo potere non è
limitatodalcontrattograzieal
qualeènato:ilpatto,infatti,è
stipulato tra gli individui, e
non tra gli individui e il
sovrano; questi ne è solo il
beneficiario.
In secondo luogo, il
potere sovrano non può
essere limitato nel suo
eserciziodalleleggidinatura:
queste sono ora sostituite
dalleleggipositive,ecioèda
quelle che il sovrano detta;
riappellarsi ora alle leggi di
natura significherebbe far
ricadereilcorpopoliticonella
incertezza e nella anarchia.
Néilsovranoèlimitatodalla
leggepositiva,anzi,inquanto
nedisponepienamente,egliè
al di sopra della legge,
legibussolutus.
Infine, il potere sovrano
nonpuòesserelimitatodaun
altro potere perché, se così
fosse,siverrebbeacreareun
potere «limitante» superiore
al potere sovrano stesso.
Questopoterelimitante,asua
volta, non potrebbe essere
limitato da altro, pena un
regresso all’infinito (a un
certo punto è necessario
fermarsi,anankestenai,come
aveva insegnato Aristotele
introducendo, al vertice del
suo universo fisico, il
«Motore Immobile»); ne
consegueperciòcheilpotere
sovrano, se è tale, non può
essere limitato, e dunque è
potereassoluto.
Questo però non implica
cheisudditinongodanodella
loro giusta libertà. Per
Hobbes, come per i teorici
della liberta «negativa» della
quale ci occuperemo più
avanti, libertà significa
essenzialmente assenza di
impedimenti, e quindi vi è
sempre
libertà
finché
l’individuo può disporre di
spazi d’azione nei quali
muoversi a piacimento senza
esserne impedito: la libertà
deisudditi,dunque,siesplica
in tutte quelle azioni che il
sovrano omette di regolare,
come per esempio «la libertà
di comprare, di vendere e di
fare altri contratti l’uno con
l’altro, di scegliere la propria
dimora, il proprio cibo, il
proprio modo di vita, di
istruire i figli nel modo che
pensano sia idoneo e di fare
altrecosesimili»7.
Nella
straordinaria
tessituralogicadellateoriadi
Hobbes, che proprio per
questo rimarrà sempre per il
pensieromodernounpuntodi
partenza inaggirabile, il
modello
contrattualista
sembra dunque trovare una
delineazione,
in
prima
battuta, assai chiara e
rigorosa. La legittimità
dell’ordinepoliticosibasasul
fatto che gli individui che ne
fossero privi sceglierebbero,
per fortissime ragioni di
utilità, di dare vita a esso,
onde evitare i mali che
altrimenti lo stato di natura
riserverebbe loro, e cioè
insicurezza e morte. Ogni
individuo, peraltro, deve
spogliarsi totalmente dei
propri diritti a favore del
sovrano; se così non fosse,
infatti, e se l’individuo ne
trattenesseunapartepersé,il
problema di determinare il
punto dove finiscono i diritti
del sovrano e cominciano
quelli del suddito (mancando
ovviamente una istanza terza
e superiore in grado di
dirimerlo, perché al di sopra
del sovrano non c’è nulla),
nonfarebbealtrochericreare
le basi per una condizione di
guerra,ecioèdiinsicurezzae
morte; anche il diritto di
proprietàc’èsoloinquantoil
sovrano lo concede. È chiaro
che ciò significa che il
sovrano può commettere
abusi, perché non c’è istanza
che lo tenga a freno, salvo il
suopersonalerapportoconle
leggi naturali e divine; ma
anche la più dura sovranità
assoluta è preferibile alla
condizione misera e incerta
dello stato di natura: se la
condizione prepolitica è così
invivibilecomeHobbescela
rappresenta, qualsiasi ordine
statale è a essa preferibile, al
di là dei rischi di dominio
arbitrario
che
necessariamente,
per
inoppugnabiliragionilogiche,
porta con sé. Sebbene non
limitato, d’altra parte, il
potere sovrano esiste per
garantirepaceesicurezza;nel
momento in cui non ne fosse
piùcapaceequestevenissero
meno, il corpo politico
perderebbe la sua ragion
d’essere e i sudditi non
sarebbero più in alcun modo
tenutiall’obbedienza.
Nel
ragionamento
hobbesiano,
così
apparentemente limpido e
inoppugnabile,restanoperòa
ben guardare non pochi
problemiaperti,chesonostati
messi in risalto tanto dagli
sviluppi successivi della
filosofia politica di impianto
contrattualista, quanto dalla
ricca discussione che si è
sviluppata, soprattutto nella
seconda metà del Novecento,
intorno alla interpretazione
delpensierodiHobbes.
Una
prima
grande
questione è quella che
riguarda
l’interpretazione
hobbesiana dello stato di
natura: prima Rousseau (ce
ne occuperemo tra breve), e
molto più tardi gli interpreti
marxisti, rimprovereranno a
Hobbes
di
avere
illegittimamente proiettato,
nello stato di natura
prepolitico, quelle istanze
conflittuali e quella brama di
autoaffermazione
e
di
superiorità
che
sono
sostanzialmente
estranee
all’uomo naturale e che
invece
caratterizzano
quell’autentico
bellum
omnium contra omnes che è
lasocietàcivileborghese,con
la sua spietata lotta
concorrenziale e la sua
inesaustacompetizioneperla
ricchezza e per gli onori;
come potrebbero tutte queste
pulsioni,
proprie
dell’individualismo
competitivo della società
mercantile
moderna,
appartenere a uomini che
ancora devono affacciarsi
sullaprimasogliadellaciviltà
?
La
seconda
grande
questione è quella che
riguarda
le
modalità
dell’uscita dallo stato di
natura e le motivazioni, di
tipoegoistico-utilitario,sucui
essa si fonda. Se gli uomini
hobbesiani sono soltanto dei
calcolatori razionali tesi ad
assicurarsi
l’autoconservazione, perché
mai non dovrebbero essere
sufficienti, a questo fine,
strumenti diversi dal patto
politico che vincola tutti
egualmente,
come
per
esempio l’alleanza di una
parte degli individui che
assicurerebbe
ordine
e
dominiosuun’altraparte8?
Inoltre,pensareilrispetto
dell’obbligo politico come
basato fondamentalmente su
motivazioni utilitarie, e cioè
sultimorechelastraordinaria
forzadelLeviatanogenerain
chi sarebbe tentato di
trasgredire,
appare,
se
scrutata attentamente, come
una soluzione del tutto
insufficiente.Comehanotato
uno dei grandi interpreti
novecenteschi di Hobbes,
Howard
Warrender9,
riprendendo un passaggio dal
Behemoth
dello
stesso
Hobbes, se il rispetto
dell’obbligo politico fosse
basato semplicemente sul
timore,siandrebbeincontroa
delle difficoltà insolubili:
ammettiamo pure che i
cittadini obbediscano per
timore della forza pubblica;
masucosasibaseràallorala
fedeltà di questa al potere
costituito ? La conseguenza
che si deve trarre da queste
considerazioni è che, sia per
quantoriguardalanascitadel
corpopolitico,siaperquanto
concerne
il
suo
mantenimento,
la
pura
razionalità strategica sembra
insufficiente ad assicurarli.
Così come insufficiente è la
risposta che Hobbes dà allo
«stolto», cioè a colui che
ritiene che i patti debbano
essere rispettati solo finché
conviene,rispostacheancora
una volta si basa su una
presunta
convenienza
utilitaria del mantenere la
paroladata.
Ma se il fondamento
utilitaristico-strategico
si
rivela troppo debole per
sostenere
l’architettura
politica hobbe-siana, ecco
allora che acquistano valore
interpretazioni, non prive di
agganci nei testi stessi di
Hobbes, in forza delle quali
genesi e mantenimento del
corpo politico non possono
fareamenodiunfondamento
dimoralità,equindidiunpiù
forte riferimento a quelle
leggi naturali che altrimenti
restano,
nel
pensiero
hobbesiano, un tema che si
presenta solo per essere
abbandonato. In questa
prospettiva, allora, l’uscita
dallo stato di natura
conflittuale
può
essere
pensata non più come dettata
da mere ragioni utilitarie, ma
da una più complessa
tessitura morale: gli uomini
che in prima istanza, come
moderni,sipensanoeguali,e
perciò si scontrano per la
superiorità, arrivano, proprio
attraverso l’esperienza dura e
catastrofica del conflitto, a
riconoscersicomeeguali10;e
solo a partire da questo
passaggiosipuòcomprendere
il fondamento egualitario
dellostatoattraversounpatto
diognunocontutti,enonsul
merodominiodiunapartesu
un’altra.Siaprequilospazio
per un’altra lettura del
paradigma contrattuale, dove
i contraenti del patto non
appaionopiùcomeguidatida
mere ragioni utilitarie, ma da
una altrettanto fondamentale
consapevolezza
morale
dell’eguaglianza tra gli
uomini.
Un ultimo grande gruppo
di problemi è quello che
riguarda il carattere assoluto
del potere sovrano che col
patto si verrebbe a istituire.
La tesi hobbesiana è che sia
razionale,dapartedeisudditi,
rinunciare a tutti i propri
diritti per ottenere in cambio
la sicurezza; ma, si chiederà
Rousseau, consegnarsi a un
sovranorinunciandoaipropri
diritti significa davvero
garantirsi la sicurezza, o non
vuoldirepiuttostopassareda
un’insicurezza a un’altra ? A
questo problema si connette
in modo diretto quello della
natura del potere sovrano, se
debba trattarsi, cioè, di un
potere sovrano monarchico,
aristocratico o democratico.
LepreferenzediHobbessono
tutteperilpoteremonarchico
(sebbene, formalmente, le tre
forme di governo siano
egualmente possibili), ma
questa scelta non sembra
inserirsi in modo molto
coerente nella prospettiva
contrattualista:
se
gli
individui devono spogliarsi
del proprio potere su di sé,
perché dovrebbero cederlo a
un individuo particolare, e
non (come sosterranno
Spinoza e Rousseu) alla
collettività democratica di
tutti i cittadini ? Questa
difficoltà, del resto, era
avvertita dallo stesso Hobbes
il quale, negli Elementi di
legge naturale e politica,
aveva sostenuto, a differenza
di quanto dirà poi nel
Leviatano,
che
«la
democrazia precede tutte le
altre istituzioni di governo»
perché, anche per dar vita a
una forma di governo
aristocratica o monarchica, è
necessario che si sia prima
costituita una collettività
democratica dei cittadini che
potrà,seloriterràopportuno,
scegliere di affidare la
sovranità a uno o a pochi11.
Ma a motivare il mancato
incontro di Hobbes con la
democrazia (e l’abbandono
della tesi sostenuta negli
Elementi)
sono
fondamentalmente, come è
stato detto, da un lato la
terribile
attualità
del
problema della guerra civile,
edall’altrolaconsapevolezza
della «forza dirompente delle
passioni»12.
3.Ilpatto
democraticodiSpinoza.
Una
declinazione
democratica del patto sociale
la troviamo invece nella
prospettivadiSpinoza(163277), che pure a quella di
Hobbes è per certi versi
affine. Anzi, ancor più
hobbesiano di Hobbes è il
modo in cui Spinoza
prospetta lo stato di natura:
nellostatodinatura,sostiene,
il diritto e la potenza
coincidono, e il diritto di
ognunosiestendepropriofin
dove arriva la sua potenza13.
Non
essendoci
leggi
vincolantipertutti,nellostato
dinaturaciascunindividuoha
pienodirittoatuttociòcheè
in suo potere: ognuno ha
diritto a conservare se stesso
eaperseguireilproprioutile
in tutta la misura che la sua
potenzagliconsente.Perciòed ecco un punto dove si
evidenzia più nettamente
l’assoluta
radicalità
di
Spinoza-nellostatodinatura
nonsolononvièpeccato,ma
noncisononeppureilbenee
il male, il giusto e l’ingiusto:
ilfattocheognunoaffermise
stesso per quanto glielo
consente la sua potenza non
dà luogo, su questo piano
puramente naturalistico, ad
alcungiudiziomorale.Benee
male esistono solo quando
vengono stabiliti da leggi
civili che esprimono una
volontà comune. Nello stato
di natura, privo di leggi,
parlaredibeneodimalenon
hasenso.
Tuttavia
anche
per
Spinoza,comeperHobbes,lo
stato di natura non è una
condizione nella quale sia
piacevole rimanere. Certo, se
gliuominifosserotuttisaggi,
evivesserotuttisottolaguida
della ragione, le cose nello
stato di natura andrebbero
ottimamente,
ognuno
eserciterebbe il suo diritto
senzarecarealcundannoagli
altri.Lasaggezza,però,nonè
affatto la condizione normale
degli uomini: per lo più essi
sonosoggettiagliaffettiealle
passioni, che li spingono a
nutrireinimiciziaperglialtri,
a odiarli, danneggiarli e
ingannarli. Se gli uomini
permanessero nello stato di
natura, perciò, essi sarebbero
condannatiavivereinmezzo
alle inimicizie e agli odi, a
danneggiarsi gli uni con gli
altri, a non poter godere di
una vita tranquilla e sicura.
Ne deriva che, se gli uomini
vogliono ricercare davvero il
loro utile e la loro sicurezza,
devono uscire dallo stato
naturale:devonorinunciareal
diritto su tutto, di cui
godevano in quello stato (e
cheliportavaaconfiggeretra
loro), e cederlo alla
collettività stringendo con
tutti gli altri un patto sociale.
Col patto gli individui
rinunciano al loro diritto di
natura (compreso il diritto di
vendicarsidelleoffesesubite)
e lo cedono alla collettività
dando vita allo stato: da
questo momento in poi solo
l’autorità statale ha il diritto
di imporre le leggi e di
punire; e la minaccia della
punizione è il modo più
sicuro per convincere i
cittadini ad astenersi dal
danneggiareingiustamentegli
altri.
Ma come dev’essere
organizzatolostato?Mentre
Hobbes prediligeva la forma
monarchica,Spinozasostiene
invece con grande forza che
lamigliorformadigovernoè
quella democratica. Nella
democrazia, infatti, il diritto
di cui ognuno godeva nello
stato di natura non viene
trasferito a un individuo
particolare (il monarca o il
sovrano) ma alla collettività
di tutti coloro che hanno
sottoscritto il patto sociale.
L’ordinamentodemocraticoè
quello che maggiormente
rispettalalibertàchelanatura
haconcessoaognuno:inesso
infatti«nessunotrasferiscead
altriilproprionaturalediritto
in modo così definitivo da
nonesserepoipiùconsultato;
ma lo deferisce alla maggior
parte dell’intera società, di
cui è membro, e per questo
motivo tutti continuano ad
essere uguali come erano nel
precedente stato di natura»14.
Nonsarebbeperciòunascelta
razionale quella di colui che,
una volta constatata la
necessità di spogliarsi dei
propri diritti, scegliesse di
cederli a un individuo o a un
gruppo
di
individui
particolari, anziché alla
totalitàdeicittadinidicuiegli
stessoèparte.
Ma vi è anche un altro
aspetto per il quale la
concezione di Spinoza si
distinguemoltonettamente,e
criticamente, da quella di
Hobbes. Il patto sociale, una
voltasottoscritto,nonè,nella
prospettiva spinoziana, per
nullairrevocabile.Gliuomini
che lo hanno sottoscritto, lo
hanno fatto per meglio
garantire il proprio utile; ma
se la società non attua quella
utilità comune che è la vera
ragionedelpatto,essononha
piùalcunmotivodiesistere,e
dunque può venire annullato
edistrutto.
Proprio perché la ragion
d’esseredelpattoèlacomune
utilità, inoltre, l’autorità
sovrana che col patto viene
istituita non ha un potere
assoluto sui sudditi: nessuno
si spoglia dei suoi diritti al
puntodarinunciareaciòche
caratterizza la sua natura di
uomo.«Percuièragionevole
ammettere che ciascun uomo
riservi sempre a sé molti
dirittiiquali,diconseguenza,
dipendonodallasuavolontàe
non da quella di altri». La
rinuncia ai diritti naturali,
insomma, non è totale e
illimitata perché una simile
rinuncia
non
sarebbe
razionale, e perché vi sono
diritti cui l’uomo non può
rinunciare senza cessare di
essereuomo.
Il primo di questi diritti
inalienabili è per Spinoza la
libertà di pensiero, un diritto
che non potrebbe essere
ceduto se non rinunciando
all’umanità stessa. Lo stato
può vietare determinati modi
di agire; ma non deve far
nulla contro la libertà di
pensiero, di parola e di
insegnamento (salvo nel caso
estremo in cui costituisca un
pericolo immediato per
l’esistenzadellostatostesso).
Ogni cittadino ha diritto al
libero esercizio della sua
ragione, anche se se ne serve
per criticare i decreti dello
stato; ciò che allo stato deve
interessare
è
il
comportamento del cittadino,
non le sue idee. Quella di
Spinoza è dunque una
versione
del
modello
contrattualista molto legata a
quelladiHobbes,cheperòse
ne allontana per quanto
riguarda la valorizzazione
della forma di governo
democraticael’insistenzasui
diritti cui gli individui non
potrebbero
rinunciare
neanche se lo volessero,
perché questo entrerebbe in
contrasto con la loro stessa
naturaumana.
4.Ilcontratto
liberalediJohnLocke.
Mentre in Spinoza il
modello
contrattualista
subisce una torsione in senso
democratico, John Locke
(1632-1704),purmantenendo
ilriferimentoalpattosociale,
costruisce un orizzonte
politico che per certi versi è
quasi l’opposto di quello
hobbesiano.Lockepuòessere
considerato infatti il vero
fondatore del contrattualismo
liberale, per il ruolo centrale
chesvolgononelsuopensiero
il tema dei diritti naturali, la
questione dei limiti che da
questidirittivengonopostial
potere dello stato, e,
soprattutto, il concetto della
proprietà, il cui carattere di
diritto sacro e inviolabile è
uno degli assi portanti
dell’intera
costruzione
lockiana.
«Definisco il potere
politico - scrive Locke in
apertura della sua opera
politica più importante, il
Secondo trattato sul governo
- come diritto di formulare
leggichecontemplinolapena
di morte e, di conseguenza,
tutte le pene minori, in vista
d’una regolamentazione e
conservazionedellaproprietà;
di usare la forza della
comunità
per
rendere
esecutive tali leggi e per
difendere lo stato da attacchi
esterni: tutto questo soltanto
ai fini del pubblico bene»15.
«Il grande e fondamentale
intento per cui dunque gli
uomini si uniscono in Stati e
si assoggettano a un governo
è la salvaguardia della loro
proprietà»16.
Per quanto riguarda
l’originaria
eguaglianza,
almeno dal lato politico, e
quindiinmeritoairapportidi
naturalistica subordinazione
gerarchica, il punto di
partenza di Locke è quello
stesso di Hobbes: gli uomini
sono per natura eguali, e
nessuno può pretendere di
avere sugli altri più potere e
autorità di quanto gli altri ne
abbiano
su
di
lui:
l’eguaglianza implica questa
condizione
di
perfetta
reciprocità
per
quanto
riguarda la soggezione e il
dominio reciproco17. Questo
è il punto che Locke
sottolinea contro i teorici
della derivazione del potere
politico dal potere paterno,
come Robert Filmer col suo
Patriarca; anche per Locke,
come per Hobbes, non vi
sono
rapporti
di
subordinazione
o
di
soggezione per natura, e il
poteremonarchicononderiva
né da quello divino né da
quellopaterno.
Se
quindi
Locke
condivide col suo illustre
predecessore il punto di
partenza
propriamente
moderno dell’eguaglianza,
ben diversa è però la
concezione che egli sviluppa
perquantoriguardalostatodi
natura. Poiché gli uomini
sono eguali e indipendenti la
ragione comanda loro (ed
ecco la legge di natura) il
precetto secondo il quale
«nessunodeveledereglialtri
nella vita, nella salute, nella
libertà o negli averi». La
legge di natura è, come in
Hobbes, quella regola il cui
rispettoassicura«lapaceela
sopravvivenza di tutto il
genere umano»; dove però
Lockesiallontanadall’autore
delLeviatano,ènellatesiper
cui «la legge di natura è per
tutti vincolante»18: essa
obbligainmodopieno,enon
solo in foro interno, come
invece aveva sostenuto
Hobbes. Ma su quali
argomentisifondaquestatesi
lockiana? La legge di natura
obbliga perché, anche nello
stato di natura, i modi di
punire chi la trasgredisce ci
sono: non c’è un potere
istituito che applichi sanzioni
ai
trasgressori
(perché
altrimentinonsaremmonello
stato di natura), ma ognuno
ha il diritto di punire coloro
cheattentanoallalegge,eciò
dovrebbe, secondo Locke,
scoraggiarne la violazione. È
vero che essa sarebbe vana
(come aveva sostenuto
Hobbes) se non vi fosse
nessuno dotato del potere di
renderla esecutiva, ma per
fortuna le cose non stanno
così: anzi, nello stato di
natura ognuno ha il diritto di
punire chi trasgredisca le
norme della ragione e della
giustizia.
Checisiaildiritto,senon
addirittura il dovere, di
intervenire
contro
gli
aggressorieidelinquentiedi
punirli,
non
sembra
contestabile. Il problema che
invece si pone è il seguente:
comefunzionaconcretamente
questa punizione, in una
situazione in cui non vi sono
organi speciali deputati a
questoscopo,chedispongano
dellaforzanecessariaechesi
possano richiamare a una
legittimità
universalmente
riconosciuta?
Come vedremo tra breve,
il
problema
dell’amministrazione della
giustizia è proprio quello in
forza del quale si genera il
passaggio dallo stato di
natura allo stato civile. Ma
accanto alla legge di natura,
l’altropuntofondamentalesul
quale John Locke prende le
distanzedaThomasHobbesè
proprio la concezione dello
stato di natura. Si può
discutereseequantolateoria
lockiana dello stato di natura
siacoerenteoinvecesiainse
stessa incerta e oscillante19.
Manellesuelineegeneralila
teoria sembra abbastanza
chiara.
È
necessario
innanzitutto, contro Hobbes,
distinguere nettamente tra
stato di natura e stato di
guerra, e non confonderli
come fossero una cosa sola.
Lo stato di guerra è stato di
«inimicizia,
malvagità,
violenza
e
reciproco
sterminio»20,epuòesseresia
un
risultato
della
degenerazione dello stato
pacifico di natura, sia una
sorta di interruzione che si
verificadentrolostatocivile,
quando un uomo vuole
sottometterne un altro con la
forza. Lo stato di natura,
invece, è definito addirittura
da Locke come uno «stato di
pace, benevolenza, assistenza
e difesa reciproca»: «Quando
gli uomini vivono insieme
secondo ragione, senza un
sovrano comune sulla terra,
col potere di giudicarsi tra
loro, si ha lo stato
dinatura»21.Quindi,sebbene,
a differenza che in Hobbes,
stato di natura e stato di
guerra siano ben distinti tra
loro, lo stato di natura corre
sempre il rischio di
degenerare in stato di guerra.
Perchélostatodiguerrasiha
quando qualcuno voglia
ridurre in suo potere qualcun
altro, ma questa situazione,
che può presentarsi tanto
nello stato di natura quanto
nellostatocivile,sisviluppa,
nei due casi, diversamente:
nello
stato
civile
intervengono la polizia e la
legge e lo stato di guerra
cessa, nello stato di natura,
dove non c’è un giudice
comune, lo stato di guerra,
una volta che sia iniziato,
tende a non finire più. Può
avertermine,selecircostanze
sono favorevoli, ma può
anche
durare
ininterrottamente.
LaconclusionecheLocke
ne ricava, pertanto, è la
seguente: per allontanare il
rischio
di
ricadere
continuamente nello stato di
guerra, gli uomini devono
associarsi
tra
loro
abbandonando lo stato di
natura e istituire un potere
sovranoeungiudicecomune
che
possa
risolvere
imparzialmente
le
controversie. Lo stato civile
quindi conferma in buona
sostanza la validità della
legge di natura, ma
assicurando
inoltre
la
possibilità di risolvere le
controversie
in
modo
imparziale attraverso un
giudicecomune.
Lo stesso approccio vale
perlaproprietà,cheèunodei
temi centrali del liberalismo
lockiano. Anzi, l’importanza
storica del liberalismo di
Locke sta proprio nell’aver
stabilito uno stretto legame
tra proprietà privata e libertà
individuale. Questo punto è
così importante che talvolta
Lockeraccogliesottoilnome
generale di proprietà tutti
quei beni che lo stato deve
assicurare all’uomo: vita,
libertà e averi sono tutti, per
Locke,
«proprietà»
dell’individuo22.
Lostatocivile,perciò,ha
come suo compito primario
quello di assicurare e
difenderequellaproprietàche
già si può acquistare nello
stato di natura. Su questo
punto la teoria lockiana della
proprietàsidistinguetantoda
quella di Hobbes quanto da
quelladiGrozioePufendorf.
PerHobbeslaproprietàviene
solo dopo l’istituzione dello
stato (nello stato di natura
tutti hanno diritto a tutto); è
lo stato che decide cosa
l’individuo possa considerare
come sua proprietà privata, e
nessuno se ne deve
lamentare23. Per Grozio e
Pufendorf la proprietà è
possibile anche prima dello
stato,maacondizionechevi
sia il tacito consenso degli
altri uomini. Per Locke
invece la proprietà privata
precedelostato,el’individuo
la acquisisce legittimamente
«facendo tutto da solo», cioè
senza bisogno di passare per
ilconsensodeisuoisimili.
Ma vediamo allora come,
in Locke, si legittima
l’appropriazione privata di
quello che è il primo bene
appropriabile,ecioèlaterra.
L’appropriazione privata
non è una condizione
originaria,
perché
la
condizioneoriginariaèquella
in cui le cose naturali non
sononéprivatenédinessuno
(res nullius) bensì sono di
tutti
collettivamente
considerati. Il punto di
partenzaèquindilaproprietà
comune.
Ma su cosa si basa allora
la legittimità della proprietà
privata ? Ecco il quesito al
quale Locke cerca di dare
risposta. L’argomentazione
lockiana è originale e acuta;
essa parte da un assunto di
fondo: «Benché la terra e le
creature inferiori siano
comuni a tutti gli uomini,
ciascuno ha tuttavia la
proprietà della sua persona:
su questa nessuno ha diritto
alcuno all’infuori di lui». A
partire da questa base
apparentemente solidissima,
si
sviluppa
tutta
l’argomentazione lockiana,
con i seguenti passaggi. Se
l’uomo è proprietario della
sua persona, è anche
proprietario del suo lavoro e
di ciò che con il suo lavoro
produce. Se l’uomo quindi
prende qualcosa dalla natura
e vi mischia il suo lavoro, il
prodotto che ne risulta, dal
quale il lavoro non è più
separabile, è anch’esso
proprietàdell’uomocheloha
generatoconlasuafatica.Ma
se è vero che il lavoro
legittima l’individuo ad
appropriarsi del frutto del
lavoro,
perché
sarebbe
ingiusto che il suo lavoro
diventasse proprietà comune,
sarebbe però anche ingiusto
che gli altri uomini non
avessero terra da coltivare,
ovvero materia prima sulla
qualeesercitareillorolavoro.
Perciò la conclusione che
Locke trae è che l’uomo ha
diritto di appropriarsi di ciò
cuihamischiatoilsuolavoro,
acondizionecherestimateria
lavorabile per gli altri,
altrettanta
e
altrettanto
buona24.
Poste così le basi della
sua teoria della proprietà,
Locke passa a criticare la
teoria del consenso altrui
come condizione necessaria
per l’appropriazione privata
di risorse originariamente
comuni. Chi si appropria
privatamentedellamateriada
luilavoratanelquadrofinqui
enunciato non toglie nulla a
nessuno; perché mai quindi
dovrebbe esserci bisogno di
consenso ? Inoltre la teoria
del consenso è, si perdoni il
gioco
di
parole,
un
controsenso, perché se per
appropriarsipersonalmentedi
qualcosa fosse necessario un
consenso, che a rigore
dovrebbe essere dato da tutta
l’umanità, l’uomo sarebbe
mortodifameprimadipoter
arareuncampo,catturareuna
preda, anche solo raccogliere
unpo’dibacche.
La
teoria
lockiana
dell’appropriazione è quindi,
secondo il suo autore, tanto
conformeallaleggedinatura
che anche nel mondo
civilizzato, dove i rapporti di
proprietà sono ormai fissati
dalle leggi positive che li
governano, il pesce che uno
pescanelmare(solopossesso
comune rimasto) è proprietà
di chi ha fatto la fatica di
andarlo a pescare, che non è
certo tenuto a dividerlo con
altri (cioè con i proprietari
comuni del mare da cui il
pesceproviene).
L’acquisizione
della
proprietà privata con il
proprio lavoro, però, ha
secondo Locke dei ben
precisi limiti: ognuno può
prendere, dei frutti della
natura, tanto quanto può
consumare; sarebbe contrario
alla legge di natura, invece,
raccogliere frutta o pescare
pesce, sottraendolo alla
potenzialeraccoltadapartedi
altri,perlasciarlomarcire.Lo
stesso discorso vale per
quella che è al tempo di
Lockelaproprietàprivataper
eccellenza, e cioè la terra:
«Quanto terreno un uomo
zappa, semina, migliora e
coltiva,ediquantopuòusare
il prodotto, tanto è di
proprietà sua. Col suo lavoro
egli lo ha, per così dire,
recintodallaterracomune»25.
Poichéalleoriginiditerrave
n’erainabbondanza,nessuno
veniva danneggiato dalla
recinzione,
così
come
«nessuno viene danneggiato
dalfattochequalcunobevaa
grandi sorsi l’acqua di un
fiume»26.
Nel rispetto di questa
leggedinatura,c’èpostoper
tutti:perquantograndesiala
popolazione,
terra
da
coltivare ce ne sarebbe per
ognuno.Quindi,perunverso
nessunohafondatimotiviper
lamentarsi, per altro verso
tutti dovrebbero ringraziare
coluichelavorandolaterrala
fafruttare.Chilavoralaterra,
infatti,
ne
incrementa
enormemente la produttività,
e
quindi
contribuisce
all’accrescimento del monte
dibenichel’umanitàhaasua
disposizione. Perciò, chi si
appropria della terra e ne fa
unusoproduttivoèancheun
benemeritodell’umanità.
Si può però porre ancora
un’altra questione: perché il
diritto
all’appropriazione
privata che viene dal lavoro
prevale sull’originario diritto
di proprietà in comune ? La
risposta di Locke è molto
interessante:ilvaloredeibeni
è dato molto più dal lavoro
che non dalla materia prima,
e quindi chi ci ha messo il
lavorohamoltopiùdirittosu
unbenedelproprietariodella
materia prima, il valore della
quale,senonlavorata,tendea
zero. Quindi Locke per un
verso fonda la teoria del
valore-lavoro, che sarà fatta
propria
dall’economia
politica classica fino a Marx,
per altro verso ribadisce che
nessuno ha motivo di
lamentarsi, perché ciò che è
statoappropriatohaunvalore
pressoché nullo. La prova di
questo primato del lavoro la
forniscono
i
popoli
d’America che, nonostante le
enormi risorse naturali, sono
poverissimi: «il sovrano d’un
ampio e fertile territorio
mangia, alloggia e veste
peggio d’un bracciante
inglese»27. Questo dimostra
due cose: 1) che la ricchezza
ècreataperil99percentodal
lavoro;
2)
Che
gli
appropriatori/lavoratori,
incrementando i beni a
disposizione della società,
migliorano la situazione
anche dei non appropriatori,
cioèdeibracciantidicuiparla
qui Locke. E quindi questa è
un’altraragionepersostenere
che nessuno ha motivo di
lamentarsi
per
l’appropriazioneprivata.
Lo stato presente dei
rapportidiproprietàcimostra
però che questa originaria
modalità
di
legittima
appropriazione, dove tutti
sono lavoratori e piccoli
proprietari, è stata superata
dandoluogoadiseguaglianze
molto più grandi nella
ripartizionedelleproprietà.Si
pone quindi la domanda se
esse siano o meno legittime.
La risposta di Locke è molto
chiara: finché non c’era il
denaro, non si poteva
accumulare più di tanto,
perché si sarebbe deteriorato.
Conildenaro,invece,diventa
possibile un’accumulazione
illimitata: per esempio,
possederegrandiestensionidi
terraevenderneiprodotti.La
legittimità di questa più
estesa diseguaglianza non
riposa su un patto, ma sul
fatto che gli uomini hanno
conclusountacitoaccordotra
loro circa l’uso del denaro,
accordo che è dimostrato dal
fatto che tutti accettano il
denaro, lo scambiano e lo
prendono in pagamento dei
loro beni. Ma l’accettazione
del denaro equivale alla
accettazione, da parte di tutti
gli uomini, della possibilità
dell’accumulazioneillimitata.
Da vero padre del
pensiero liberale, quindi,
Locke
sviluppa
una
giustificazione estremamente
accurata e ben argomentata
della appropriazione privata
delle risorse naturali e del
capitalismo inteso come
accumulazione illimitata e
fine a se stessa (economia
cioè che, grazie al denaro, si
svincola dal limite dei
bisogni).
Ma quali sono i punti
deboli a partire dai quali si
potrebbe
discutere
criticamentelateorialockiana
della proprietà ? Possiamo
limitarci
a
elencarli
sinteticamente:
a) il concetto della
proprietàdisénonsembradel
tutto convincente, perché
nessun
uomo
può
legittimamente
vendersi,
come invece può vendere le
sueproprietà;
b) più in generale, le
abilità di qualcuno non gli
appartengono
in
modo
esclusivo perché egli le ha
apprese da altri che gliele
hannoinsegnate(lafamigliae
lasocietà)equindianchenel
suo lavoro il contributo
propriamente individuale è
unapiccolaparte(letecniche
e i saperi che generano la
gran parte della ricchezza
sonoilprodottodellavorodi
tuttelegenerazioniumane);
c) vi è infine il
problema delle generazioni:
perché chi arriva dopo,
quando tutto è diventato
proprietàprivatadiqualcuno,
dovrebbeaccettareilfattoche
con il denaro si sia resa
possibile la proprietà senza
limiti, fatto da cui deriva
l’impossibilità di avere
accesso
alle
risorse
produttive, perché sono tutte
giàappropriate?
La risposta implicita di
Locke a questo terzo
argomento è quella che farà
scuolaeverràripresaintutto
il pensiero liberale, da Adam
Smith fino a John Rawls:
ancheilpiùpoverobracciante
ingleseècomunquepiùricco
delpiùriccodeireselvaggi,e
quindi in ogni caso non ha
nulla di cui lamentarsi. Ma
l’argomento potrebbe forse
essere messo in crisi da una
semplice domanda: cosa
preferireste
essere,
un
braccianteounre?
Lostatonascedunqueper
salvaguardare quei diritti che
gli individui hanno già in
forza della legge di natura
(vita, libertà, proprietà). Ciò
su cui Locke insiste
maggiormente
è
che,
associandosi nello stato, gli
individui istituiscono un
giudice che è legittimato a
risolvere le controversie, in
quanto è al di sopra dei due
contendenti. Ma se questa è
l’essenza del passaggio alla
società politica, allora ne
conseguechelasovranitànon
può essere, come invece
aveva sostenuto Hobbes,
assoluta. La società politica,
infatti,siidentificaperilfatto
che in essa nessuno
dev’essere più giudice in
causa propria. Ma il sovrano
assoluto, che riassume in sé
tanto il potere legislativo
quantoquelloesecutivo,nelle
eventuali controversie con i
sudditi è giudice in causa
propria, e quindi si trova,
rispetto a coloro che sono
soggetti al suo dominio,
esattamente nello stato di
natura. Il potere assoluto,
quindi, anziché superare lo
stato di natura, lo reinstaura
nelpuntodecisivo,ecioènel
rapporto tra i sudditi e il
sovrano. Ponendo l’accento
su questo punto, Locke
formula un’altra delle tesi
fondamentali del liberalismo
moderno: non si esce
veramente dallo stato di
natura se non c’è una
salvaguardia anche nei
confrontidelpoteresovrano.
Ma vediamo finalmente
quali sono le caratteristiche
principalichecontrassegnano
secondo Locke il patto
politico. Esso è sottoscritto
dagli individui liberamente;
chi vuole - ed ecco ancora il
forte
presupposto
individualistico - può non
aderire a esso; formando un
solo corpo politico tutti
s’impegnano, onde l’unità ne
sia garantita, a seguire il
volere della maggioranza; lo
scopo del patto non è solo
quello di sopravvivere ma di
«vivere
bene,
nella
tranquillità e nella pace
reciproca, assicurandosi il
godimento
delle
loro
proprietà e una maggiore
protezione contro coloro che
a quella società non
appartengono»28.
Unendosi nello stato,
dunque,
gli
individui
istituiscono un supremo
potere, che è innanzitutto
potere di fare leggi e di
risolvere le controversie:
questo è per Locke il potere
legislativo, che può avere la
forma di una democrazia, di
una oligarchia o di una
monarchia. Quale che ne sia
la forma, però, il potere
legislativo deve sottostare,
per adempiere i suoi scopi, a
delleregoleoadeilimitiben
precisi29:
1) Diritti inalienabili:
deve muoversi nell’ambito
fissatodallaleggedinatura,e
nel rispetto dei diritti
inalienabili che da questa
discendono. La legge di
naturacostituisceuna«norma
eternapertuttigliuomini»,e
dunqueancheperilegislatori,
che devono limitarsi a
tradurlainleggepositivaead
assicurarneilrispetto.
2)Principiodilegalità:
il potere deve governare
attraversoleggigeneralicerte
e non attraverso decreti
estemporaneioadpersonam.
3) Intangibilità della
proprietà:«ilpoteresupremo
non può togliere a un uomo
una parte della sua proprietà
senza il suo consenso». Le
tasse per mantenere lo stato
devono avere il consenso
dellamaggioranzadeisudditi.
4) «Il legislativo non
devenépuòtrasferireadaltri
il potere di legiferare, né
affidarlo a mani diverse da
quelle cui l’ha affidato il
popolo»: per esempio non lo
puòdareaundittatore.
Macomesipuògarantire
che il potere legislativo
rimanganell’ambitodiquesti
limiti?LarispostadiLockea
questo problema è da
ricercarsi nella sua teoria
dellaarti-colazionedeipoteri.
Argine contro il pericolo
della degenerazione tirannica
è la chiara distinzione tra il
potere legislativo e il potere
esecutivo: il primo deve
riunirsi, solo periodicamente
e non in permanenza, per
legiferare, mentre il secondo
deveassicurarecoattivamente
l’obbedienzadeicittadinialle
leggi. Chi dispone della
coazione non dispone della
legge, e a essa è anzi
vincolato,mentrechilegifera
nonhaalcunpoteredirettodi
coazione. Il legislativo è il
potere supremo, ma la
coazione spetta a quello
esecutivo che è al primo
subordinato. Il modello
ispiratore di fondo delle tesi
lockiane è quello inglese del
King in Parliament, e con la
riflessione su questo punto
Locke si pone proprio alle
origini del costituzionalismo
moderno.
Con questo però il
problema non può dirsi
risolto.Poniamoilcasocheil
legislativo voglia render
schiavo il popolo, e quindi
non si attenga ai limiti da
Locke
scrupolosamente
fissati; cosa accade allora? A
questa domanda Locke
risponde
con
la
(problematica) teorizzazione
del diritto di resistenza:
mancando di un giudice
superiore cui appellarsi nei
confrontidiunlegislativoche
lo voglia rendere schiavo, il
popolohadirittodiappellarsi
al cielo, ovvero a una legge
superiore alla legge positiva
che lo autorizza a rovesciare
ilgovernochevengamenoal
suo mandato. Il diritto di
resistenza non può essere
legge positiva, ma in ultima
istanza si fonda sulla legge
naturale, che è superiore alla
stessaleggepositiva.
La teoria del diritto di
resistenza, però, incorre nelle
grandi difficoltà concettuali
che più tardi Kant metterà
con molta precisione in
risalto: non essendoci un
giudice superiore in grado di
dirimerelecontroversietrail
popolo e il sovrano, col
diritto di resistenza si ricade
nellostatodinaturanépiùné
meno di quanto accadeva nel
casodelpoteredispotico.
5.Iduepattidi
Jean-Jacques
Rousseau.
Con Rousseau (1712-78)
tutta la problematica del
contrattualismo hobbesiano e
lockiano viene sottoposta a
un rovesciamento critico
radicale: il contrattualismo
cessadiporsicomeorizzonte
entro il quale in ultima
istanza si legittimano gli
assetti di potere vigenti per
trasformarsi in leva di un
pensiero
critico,
tendenzialmente
rivoluzionario. La più netta
espressione
di
questo
rovesciamento radicale la
troviamo nelle stesse parole
di Rousseau: «Apro i libri di
diritto e di morale, ascolto
filosofiegiureconsultietutto
pieno dei loro insinuanti
discorsi deploro le miserie
dellanatura,ammirolapacee
la giustizia prodotte dallo
stato civile, benedico la
saggezza delle istituzioni
pubbliche e, vedendomi
cittadino, mi consolo di
essereuomo.Beneistruitosui
miei doveri e sulla mia
felicità, chiudo il libro, esco
discuolaemiguardointorno:
vedo popoli disgraziati che
gemono sotto un giogo di
ferro, il genere umano
schiacciato da un pugno di
oppressori,
una
folla
affamata, stremata dalla pena
e dalla fame, di cui il ricco
beve in pace il sangue e le
lacrime, e dovunque il forte
armato contro il debole del
temibile potere delle leggi».
Seilcontrattualismohaposto
alla radice del patto sociale
uomini liberi e eguali, il
problema dal quale Rousseau
prendelemosseapparesubito
chiaro:comehapotutoquesta
eguaglianza
originaria
capovolgersi
in
quelle
strutture di dominio e di
oppressioneche,allosguardo
del ginevrino, segnano e
inquinano ogni società civile
moderna. «L’uomo è nato
libero e dappertutto è in
catene»; ma come si è
compiuto
questo
capovolgimento ? Di fronte
allaconstatazionedellarealtà
universale del dominio, il
patto sociale si disloca su un
terreno
controfattuale,
normativo, rivoluzionario. La
teoria politica normativa si
distingue
dall’analisi
scientifica della società
esistente, delle sue strutture
oppressive. «Per la prima
volta in Rousseau la
diseguaglianza sociale non è
solo oggetto di denuncia e di
condanna
morale.
Al
contrario essa è compresa
geneticamente nella sua
razionale necessità»30. E il
primo compito della teoria
diventa quindi quello di
svelare come le strutture
inegualitarie del dominio
abbiano potuto sorgere,
stabilirsi, godere persino del
consenso degli oppressi.
L’eguaglianza di partenza
non si conserva, seppur
trasvalutata, nella società
civile, ma si capovolge nel
suo opposto, l’ineguaglianza:
ed è pertanto di questa che
Rousseausiaccingearendere
ragione.Individuatogiànella
replica alle obiezioni che
Stanislao Leszczynski aveva
mosso nei confronti del
Discorso sulle scienze e le
arti («La fonte prima del
male è la disuguaglianza»)31,
il tema è l’oggetto precipuo
del Discorso sull’origine e i
fondamenti
della
disuguaglianza
fra
gli
uomini,cheRousseaudedica,
nel 1754, alla repubblica di
Ginevra.
L’attacco alla funzione
legittimante
del
giusnaturalismoprecedentesi
concentra in primo luogo
sulla questione dello stato di
natura: se per Hobbes la
condizione miseranda dello
stato di natura legittimava
qualsivoglia stato civile,
anche quello più oppressivo,
Rousseau non può che
rovesciarne i presupposti: il
limite di fondo dello stato di
natura hobbesiano, popolato
da uomini avidi, orgogliosi,
desiderosi di opprimersi l’un
l’altro,ècheinessovengono
attribuite all’uomo naturale
quelle che non sono altro, in
realtà,
che
passioni
caratterizzanti
l’uomo
civilizzato, anzi, corrotto e
rovinato da una civiltà
malsana. Diversa è la critica
nei confronti dello stato di
natura lockiano: mentre
Hobbes pone (giustamente)
tra stato di natura e stato
civile una netta cesura, ma
poi la nega proiettando nel
primo caratteristiche che
appartengono
solo
al
secondo, Locke incorre in un
altrettanto grave peccato di
apologia, perché, con la sua
visione continuistica del
rapporto tra stato di natura e
stato
civile,
retrodata
abusivamente al primo
(legittimandoli) istituti che,
come quello della proprietà,
possono appartenere solo
all’umanità
civilizzata.
Lucidissimo nella critica del
modoincuilostatodinatura
venne pensato dai suoi
predecessori,
Rousseau
pretende
di
costruirne
finalmente una visione
sciéntifica. Per lui lo stato di
natura non è uno stato di
guerraperilsemplicemotivo
cheèunostatodiisolamento:
l’uomo naturale di Rousseau
èunuomosolocheabitauna
naturanonostile,nelrapporto
conlaqualenonhadifficoltà
a soddisfare i suoi limitati
bisogni. Lo stato di natura
non è affatto, come
continuano a ripetere coloro
contro
cui
Rousseau
polemizza, una condizione
«miserabile», anzi si può
paradossalmente affermare,
contro Hobbes, che esso sia
«ilpiùadattoallapace,ilpiù
conveniente
al
genere
umano»32. Non vi è quindi
alcunanecessitàchecostringa
a uscirne (semmai il
problema è come se ne sia
usciti, dato il suo carattere
pacifico e stabile) e il
passaggio allo stato civile è
determinato
solo
dal
«concorso
fortuito
di
parecchie cause esterne che
potevano
anche
non
verificarsi mai e senza le
quali l’uomo sarebbe rimasto
eternamente
nella
sua
condizione primitiva»33: una
condizione
nella
quale
l’ineguaglianza
era
sconosciuta perché delle due
specie di disuguaglianza tra
uomini, quella naturale e
quella morale o politica, la
primaèdigranlungalameno
importante e, nello stato di
natura, non esercita «quasi
nessunainfluenza»34.
Ma come si costituisce
dunque
l’insopportabile
ineguaglianzachecaratterizza
la società civile o borghese ?
Il processo di costituzione
della società ineguale e
oppressiva si addensa attorno
a uno snodo fondamentale,
cheèquellodellaproprietà:«
Il primo che, cintato un
terreno, pensò di affermare,
questoèmio,etrovòpersone
abbastanza
ingenue
da
credergli,fuilverofondatore
della società civile. Quanti
delitti, quante guerre, quante
uccisioni, quante miserie e
quanti
orrori
avrebbe
risparmiato al genere umano
coluiche,strappandoipaletti
ocolmandoilfossato,avesse
gridato ai suoi simili:
‘Guardatevi
dall’ascoltare
questo
impostore.
Se
dimenticate che i frutti sono
dituttiechelaterranonèdi
nessuno,voisieteperduti’»35.
Quiildiscorsolockianoè
rovesciato: lungi dall’essere
acquisizione
legittima,
l’appropriazioneèunasagace
impostura, che si stabilizza
soloperl’ingenuitàdeigonzi
che ne sono le vittime.
L’ineguaglianza
delle
proprietà è il vero stigma
della società corrotta, è la
cesura maggiore nel fatale
percorso storico verso la
società borghese, acquisitiva,
rapace,ineguale.
Questo percorso però, a
partiredalprimomomentoin
cuilaperfettasolitudinedello
stato di natura s’incrina,
sembra procedere in modo
sostanzialmente continuo e
inesorabile, e tale quindi da
ridimensionare la cesura che
Rousseau stesso, peraltro, ha
voluto segnare, iniziando la
seconda parte del suo
Discorso sull’ineguaglianza
proprio col passo appena
citatosullaproprietà.
Appare manifesto, infatti,
che il processo degenerativo
di cui Rousseau ripercorre
minuziosamente le tappe
(ponendosi, così, anche tra i
fondatori della moderna
scienza antropologica e
sociale), fa tutt’uno, nel
Secondo discorso, con la
dimensionedellasocialitàche
soppianta
quella
della
originaria solitudine: quando
gliuominismettonodierrare
nei boschi e si riuniscono
formando raggruppamenti di
famiglie, di villaggio, e poi
via via sempre più vasti, si
sviluppa
subito
quel
sentimentodelconfronto,dell
’amour propre, quella stima
dellapropriasuperioritàcheè
laradiceprimadellosviluppo
dell’ineguaglianza,pensatain
terminicherichiamanomolto
l’antropologia
hobbesiana
della competizione. La
passionedell’orgoglio,chelo
spinge a competere con gli
altri per superarli, non
appartiene e non può
appartenere
all’uomo
naturale,
che
è
fondamentalmente solitario,
ma domina gli individui non
appena
cominciano
a
stringerelegamireciproci:«il
più bello, il più forte, il più
abile o il più eloquente
divenne anche il più
considerato, e fu il primo
passoversoladisuguaglianza
e al tempo stesso verso il
vizio »36.
Le
prime
emergenze della corrazione e
della
diseguaglianza
si
trovano
quindi,
dice
Rousseau, già nel primitivo
statodisocietà,cheèsimilea
quello in cui si trovano
ancora «i popoli selvaggi a
noi noti», e che però non va
confuso col vero stato di
natura e anzi ne è molto
lontano, perché ha già
sviluppato,conlasocialità,il
morbo che spinge l’uomo al
confronto e a dipendere
dall’opinione degli altri:
«l’uomo socievole, sempre
proiettato fuori di sé, non sa
viverechedell’opinionedegli
altri»37.Gliuominiavrebbero
potuto rimanere a lungo in
questo stato di ineguaglianza
soloembrionale,senonfosse
intervenuto lo sviluppo delle
abilità
tecniche,
dell’agricolturaedellavoroa
determinare,conladifferenza
dei talenti, quella delle
proprietà, e quindi a spianare
lastradaall’ineguaglianzanel
suosvilupposenzapiùlimiti:
perché la proprietà nasce dal
lavoro, come in Locke, ma,
poiché gli uomini hanno
diversa forza, capacità e
talento, il lavoro di alcuni
procura
loro
maggior
proprietà di quanto non
accada ad altri. È così
completamentespianatalavia
versolacorruzione,versouna
società divisa in padroni e
servi, dove l’apparire grandi,
ricchi e superiori agli altri
diventa più importante di ciò
che davvero si è, dove non
regna altro che «questo
universale
desiderio
di
reputazione, di onori e di
distinzione che ci divora
tutti», che rende gli uomini
tutti «concorrenti, rivali, o
piuttosto nemici», al punto
che i ricchi e potenti, pur
rimanendo
tali,
«smetterebbero di essere
feliciseilpopolosmettessedi
esseremiserabile»38.
Il
proliferare
dell’ineguaglianza,
il
polarizzarsi di ricchezza e
povertà,l’impossibilità,daun
certo punto in avanti, di
legittimare la proprietà con
unaremotaoriginenellavoro,
gettano la società non ancora
politicamente organizzata in
una condizione di conflitto e
di disordine: qui si ha
dunque, non nello stato di
natura,ilveroepropriostato
di guerra. E da esso gli
uomini sono usciti, dice
Rousseau, con un patto
politico che è stato proposto
dai ricchi ai poveri, e che ha
costituito «il progetto più
avveduto che mai sia venuto
in
mente
all’uomo»39:
uniamoci, hanno proposto i
ricchi ai poveri, sotto un
potere politico comune che
assicuri a ognuno le garanzie
della legge e quindi protegga
i deboli dai soprusi e dalla
violenza, mentre al tempo
stesso garantisce ai ricchi il
sicuro godimento delle loro
proprietà. Ma si tratta di un
patto iniquo e che i poveri
accettarono
solo
per
ingenuità, perché, mentre
distruggeva
la
libertà
naturale, legittimava per
sempre «la legge della
proprietà
e
della
diseguaglianza».
Sanciva
quindi una proprietà che, se
in prima battuta nasceva dal
lavoro, in seguito era
divenuta vieppiù frutto di
inganno, appropriazione e
rapina,eallaqualesisarebbe
dovuto dunque obiettare che,
per appropriarsi di ciò che
eccedeva le necessità di
sopravvivenza proprie di
ciascuno, sarebbe stato
necessario «il consenso
espresso ed unanime di tutto
il genere umano». Iniquo è
dunque, vuol dire Rousseau,
anche il patto sociale così
comelohaprospettatoLocke,
perché, se i nullatenenti
accettano di lasciare la loro
libertà
naturale
sottomettendosi alla legge
civile, non è razionale (ma è
invece frutto di cecità, di
dabbenaggine o di incapacità
di comprendere l’inganno
altrui) che lo facciano senza
pretenderechevengarimessa
in discussione anche la
distribuzione delle proprietà
che, in modi diversi e spesso
usurpatori, si è venuta fino a
quel momento determinando.
Sitrattainsommadiunpatto
che non sarebbe razionale
sottoscrivere, perché i ricchi
ci guadagnano troppo e i
poveri troppo poco rispetto a
ciòchecedono.
Mentre nel Discorso
sull’ineguaglianzalasocialità
si configura di per sé come
unadimensionedi«caduta»e
di alienazione, poiché induce
l’uomo a perdere la vera
consapevolezzadisestessoe
a guardarsi solo attraverso il
riflesso che vede negli occhi
degli altri, è attraverso una
visionepiùcomplessaemeno
negativa del rapporto sociale
(elaborata in quel testo di
passaggio
che
è
il
Manoscritto di Ginevra) che
Rousseau giunge a porre le
condizioni per delineare il
quadro di quel patto equo e
razionalechevienedisegnato
nelContrattosociale:dovele
caratteristiche
dell’uomo
sociale devono essere prese
conrealismo,perciòcheesse
effettualmente sono, ma al
tempostessodevonolasciarsi
ricondurre
nella
trama
razionale e condivisa della
politica. Bisognerà dunque
considerare, dice Rousseau,
gliuominicomedifattosono
(nella
loro
conflittuale
particolarità) e le leggi come
possono essere, in modo che
si possano associare la
giustizia e l’utilità, ciò che il
diritto permette e ciò che
l’interesseprescrive.
I punti di partenza
fondamentali
della
concezione rousseauiana del
contrattononsonolontanida
quelli che già erano stati
fissati modernamente da
Hobbes e Locke. L’ordine
sociale non è dato per natura
maèunordineartificialeche
deve essere istituito tra
uomini-originariamente liberi
ed eguali: sono destituite di
ognifondamentoleteorieche
vedono il potere sovrano
come una derivazione del
potere patriarcale, o come
scaturente da una superiorità
naturale di alcuni rispetto ad
altri, o come derivante da un
presunto
(ma
secondo
Rousseau
in
realtà
contraddittorio)dirittodelpiù
forte. «Poiché nessun uomo
ha un’autorità naturale sul
suo simile, e poiché la forza
non produce nessun diritto,
alla base di ogni autorità
legittima restano dunque le
convenzioni»40. Ma come
dev’essere pensata allora la
convenzione tra gli uomini
dalla quale ha origine il
governo legittimo ? Per
comprenderlo
conviene
vedere, innanzitutto, in che
modo, secondo Rousseau,
essa non può essere
razionalmenteprospettata.
II potere legittimo non
può essere pensato, dice
Rousseau
polemizzando
soprattutto con Grozio, come
il risultato di un patto di
sottomissione in cui un
popolo aliena la sua libertà
nei confronti di un sovrano
divenendone suddito. La tesi
di Rousseau è innanzitutto
che sarebbe irrazionale, da
parte di un popolo,
sottoscrivere un patto di
questo genere, e che, anche
qualoraunpopololofacesse,
questo
patto
sarebbe
comunque nullo, e non
potrebbe dunque servire per
legittimare un qualsiasi
ordine politico dato. A
sostegno di questa tesi
Rousseau adduce diverse
ragioni:
a)sarebbeirrazionale,per
i sudditi, spogliarsi della
libertàperottenereincambio
la sicurezza che un sovrano
assoluto dovrebbe garantire,
perché sotto un governo
dispotico, che tra l’altro può
dichiarare guerre a suo
piacimento, la sicurezza dei
sudditinonèaffattogarantita.
Essi perciò cedono qualcosa
senza ottenere nulla in
cambio.
b) Ma un contratto in
cui una parte sola cede
qualcosa, e non riceve niente
in cambio, è nullo o
insensato.
c)Nessunagenerazione
di uomini, comunque, può
alienare la libertà delle
generazioni
successive,
perchéessanonleappartiene.
d) La libertà non è
qualcosachesipossaalienare
(ovvero cedere) come una
proprietà:seunuomosidesse
a un altro e questi gli
ordinasse di commettere un
crimine, l’uomo non sarebbe
per questo dispensato dalla
sua responsabilità morale: il
crimineresterebbeuncrimine
suo. Perciò, sostenere che la
libertà dell’uomo può essere
alienata, equivale a negare
all’uomo la responsabilità
delle
sue
azioni,
a
disconoscere la sua natura di
essere
morale
e
responsabile41.
e) Ammesso per
assurdo che un popolo possa
alienare la sua libertà e
sottomettersi a un sovrano
assoluto, resta sempre valido
il fatto che, come avevano
sostenuto molti teorici del
giusnaturalismo, tra cui
Pufendorf, perché un popolo
possa darsi a un re è
necessario che esso si sia
primacostituitocomepopolo:
un pactum subjectionis non
può darsi se non si
presuppone un anteriore
pactum unionis; per potere
decidere qualcosa, tutti
devono prima aver deciso,
all’unanimità, di unirsi e di
sottomettersi a ciò che la
maggioranza
deciderà.
Caduta la pretesa di porre la
radice legittimante della
sovranità in un pactum
subjectionis,
tutta
la
questione della convenzione
originaria su cui si edifica
lordine politico va ripresa
dallefondamenta.
Ammesso quindi che gli
uominisitrovino(perragioni
riducibili
alla
precaria
autoconservazione) a dover
usciredallostatodinaturaper
dar vita all’ordine politico, e
assodato
che
sarebbe
insensato che essi si
spogliasserodellalorolibertà,
ilproblemacheessidebbono
risolvere si pone nella forma
seguente: «trovare una forma
di associazione che protegga
e difenda con tutta la forza
comunelapersonaeibenidi
ciascunassociato,mediantela
qualeognunounendosiatutti
non obbedisca tuttavia che a
se stesso e resti libero come
prima»42. E il problema può
essere
risolto,
secondo
Rousseau, soltanto da un
patto di tipo tutt’affatto
particolare: tutti gli individui
alienano totalmente i loro
diritti in favore del corpo
politico comune che tutti
insieme costituiscono; per
dirlo con le parole di
Rousseau, «ciascuno di noi
mette in comune la sua
persona e tutto il suo potere
sotto la direzione della
volontà generale; e noi come
corpo riceviamo ciascun
membro
come
parte
indivisibile del tutto». È
questo, dice Rousseau,
l’unico
patto
politico
razionalmente
possibile:
rinunciando infatti al diritto
di autogovernarsi da sé,
l’individuo accetta che gli
altri abbiano un diritto su di
lui, ma al tempo stesso
acquisisce un diritto sugli
altri,equindinonperdenulla
dellasualibertà.Mentreperò
nello stato di natura la sua
libertà di autogovernarsi
poteva essere in ogni
momento negata dalla forza
altrui, ora la libertà messa in
comune ha dalla sua la forza
dituttoilcorpopolitico,edè
quindi
assicurata.
L’individuo, nel patto così
formulato, non perde libertà
(in quanto riottiene ciò che
cede) e in più acquista la
certezzadipotergoderedella
libertàcheha.
Sebbene nella critica del
potere assoluto di un re o di
un despota Rousseau si fosse
mosso su una linea
antihobbesiana,
quando
descrive la clausola del patto
eglitornadinuovoaHobbes
allontanandosi radicalmente
da Locke: il patto esige
infatti,
da
ciascuno,
l’alienazione totale di tutti i
suoi diritti in favore della
comunità; per la semplice e
ovvia ragione che, se gli
individui conservassero dei
diritti contro la comunità,
cioè contro il corpo politico
sovrano, non essendoci un
giudice superiore ad ambo le
parti per dirimere eventuali
controversie, dato che non
può esserci nulla sopra il
sovrano, le controversie si
trasformerebbero in contese,
e si regredirebbe a quello
statodinaturadacuiinveceil
patto doveva assicurare
l’uscita.
D’altra
parte,
secondo Rousseau, di questi
diritti contro il sovrano non
c’è neppure bisogno: perché
il sovrano, «essendo formato
solo dei privati che lo
compongono, non ha né può
avere interessi contrari ai
loro»43.
Questa impostazione si
applica innanzitutto al diritto
di proprietà, che invece
Locke aveva considerato
intangibile: per Rousseau
«ciascun membro della
comunità,nelmomentoincui
essa si forma, le si offre così
comeallorasitrova,contutte
le sue forze, di cui fanno
parte i beni che possiede»44;
in rapporto ai membri della
comunità, lo stato è, in forza
delcontrattosociale,padrone
di tutti i loro beni; ciò non
significa, precisa Rousseau,
cheibenidebbanopassaredi
mano, ma vuol dire piuttosto
che il diritto di ciascun
privato sul suo terreno è
sempre subordinato al diritto
della comunità sul tutto;
altrimenti non vi sarebbe né
stabilità nel vincolo sociale,
né forza reale nell’esercizio
dellasovranità.Ilcompitodel
patto sociale non è quello di
sancire
l’abbandono
dell’eguaglianzanaturaleelo
stabilirsi dell’ineguaglianza,
al contrario, è quello di
rinforzare
l’uguaglianza
naturale nella forma di
«un’eguaglianza morale e
legittima».Ladifferenzatrai
buoni e i cattivi governi, da
questo punto di vista, è che
neiprimil’eguaglianzaèsolo
apparente, e serve a
«mantenere il povero nella
suamiseriaeilricconellasua
usurpazione»; mentre in
verità «lo stato sociale giova
agli uomini solo in quanto
posseggano tutti qualcosa e
nessuno di essi abbia
qualcosaditroppo»45.
Dopo aver fissato nel
primo libro del Contratto le
clausole
che
devono
caratterizzare il patto sociale,
e che non possono essere
mutate né alterate, Rousseau
apre il secondo libro
dell’opera ricordando che
l’istituzione dello stato è
legittima e razionale non
semplicemente per uscire
dallo stato di natura, ma per
perseguire un preciso fine,
che è il bene o l’interesse
comune. Come è stato
osservato, è proprio qui che
Rousseau sottolinea quello
che, distinguendolo dalle
teorie giusnaturalistiche dei
suoi predecessori, viene ad
essere «il tratto forse più
caratteristico della sua teoria:
quello che fa consistere la
politicanongiànellagaranzia
diinteressicontrastanti,bensì
inciòcheinquestiinteressiè
immediatamente comune, nel
punto di unione dove si
accordano e si fanno
solidali»46. Ma proprio per
questo lo stato rousseauiano
non può essere altro che una
costituzione dell’eguaglianza,
che è il primo presupposto
perché un interesse comune
possa venir evidenziato e
possa affermarsi (mentre
l’ineguaglianza
è,
al
contrario,
ciò
che,
divaricando gli interessi,
rendeimpossibileallostatodi
rimanere conforme alla sua
ragione
istitutiva).
Uguaglianza non vuol dire,
precisa Rousseau, che i gradi
di potenza e di ricchezza
debbano
essere
«assolutamente
identici»:
vuol dire però che nessun
cittadino dev’essere in grado
diimporrelasuavolontàaun
altro se non in forza delle
leggi, e che nessuno
dev’essere abbastanza ricco
da poter comprare un altro e
nessuno tanto povero da
essere costretto a vendersi.
L’eguaglianza è dunque
condizione di uno stato che
abbiadimirailbenecomune
ma, più in profondità, è
condizionedellalibertàstessa
(«lalibertànonpuòsussistere
senza di essa»): perché le
grandi
diseguaglianze
consentono ai più ricchi di
comprare la libertà pubblica,
e spingono i più poveri a
venderla.
Tuttavia, è la stessa
«forza delle cose», dice
Rousseau,
che
tende
incessantementeadistruggere
l’eguaglianza; così come è la
spinta
inestirpabile
dell’interesse
particolare,
saldamente radicata in ogni
individuo,
a
rendere
estremamente arduo quello
che pure dell’istituzione
politica è il fine e prima
ancora la ragion d’essere, e
cioè appunto la realizzazione
di un bene comune. Perché
«l’accordodituttigliinteressi
sicostituisceinopposizionea
quello di ciascuno. Se non ci
fossero interessi diversi...
tutto andrebbe da sé, e la
politica cesserebbe di essere
un’arte»47.
La comunità politica
rousseauiana diventa così, in
ultima istanza, il terreno di
una lacerazione drammatica:
là dove vi è società vi sono
individui
con
interessi
particolari e confliggenti; ma
vi è certamente anche
interesse comune, perché, se
non vi fosse, la società
cesserebbe semplicemente di
esistere48.Ilcompitodifficile
dell’arte politica è appunto
quellodigovernarelasocietà
a partire da questo interesse
comune, di cui la volontà
generale è voce, senza
lasciarsi travolgere dalla
spinta
centrifuga
degli
interessiantagonisti.Compito
difficile perché non è affatto
scontato che la volontà
generale, che dà voce
all’eguaglianzaeall’interesse
comune, coincida con la
volontàcheilpopolosovrano
di fatto esprime: la volontà
generale può divergere dalla
volontà di tutti, che è una
semplice somma di interessi
particolari; e il popolo può
essereingannatoepuò
Nella
tessitura
del
pensiero
rousseauiano,
dunque, l’arte della politica
diventa un’arte così difficile
da lasciare forse addirittura
disperare nella sua stessa
possibilità: «la volontà
particolare agisce senza posa
controlavolontàgenerale»49,
e il terreno della politica
rimane segnato da un
conflitto strutturale, dove
«l’opposizione tra le finalità
delle due volontà, tra
préferencesedegalité appare
assolutamente
inconciliabile»50:
il
trascendimento dell’interesse
particolare nella volontà
generale
appare
concettualmentearduosenon
impossibile; e la difficoltà di
fondo del pensiero del
ginevrino,cherestaperaltroil
vero
fondatore
della
democrazia moderna, si
condensa nella ricerca di una
improbabilecoincidenzadella
singolarità individuale con il
tutto sociale, nell’aporia che
nasce dal tentativo di tenere
insieme il citoyen dedito alla
virtù repubblicana e al bene
comune e l'homme della
società civile, impossibilitato
a trascendere la sua
particolaristica
natura51.
Un’aporia che nel pensiero
democratico ed egualitario di
Rousseau
non
trova
soluzione,echeilMarxdella
Questioneebraicacercheràdi
superare, come vedremo,
togliendo alla radice la
particolaritàstessa.
6.Kanteil
contrattocomeidea
dellaragione.
ComeinHobbes,anchein
Kant la riflessione sulla
politica sembra prendere le
mosse da un corposo
presuppostoantropologico,al
quale è bene dare subito il
dovutorisalto:allaradicedel
rapporto interumano vi è
quella che Kant chiama nella quarta tesi del saggio
sull’idea di storia universale
dal
punto
di
vista
cosmopolitico
-
la
«insocievole socievolezza»
dell’uomo.Kantnonsostiene,
come Hobbes, che l’uomo è
lupo per l’altro uomo, ma
pone la questione in modo
assai più articolato: l’uomo,
afferma, ha una naturale
inclinazione ad associarsi,
perché solo nella società con
gli altri può sviluppare al
meglio le sue disposizioni
naturali. Ma ha altrettanto
fortemente una tendenza a
dissociarsi,
poiché
è
caratterizzatodalla«proprietà
insocievole di voler condurre
tutto secondo il proprio
interesse».L’uomo,inoltre,si
aspetta che anche gli altri
faccianolostesso,equindiin
questo senso è sempre in
guerra con loro. Ma ciò
«risveglia tutte le forze
dell’uomo», lo induce a
vincere la sua tendenza alla
pigrizia,edeglièspinto«dal
desiderio di onore, potere o
ricchezza, a procurarsi un
rango tra i suoi consoci, i
qualinonpuòsopportare ma
di cui anche non può fare a
meno»52.L’uomokantianoè
quindi sociale, ma anche
egoista e antisociale, e i due
momenti non si possono
separare(contuttalatensione
reciproca che generano),
perché per prevalere sugli
altri bisogna porsi in
relazioneaessi.
L’egoismo e la dedizione
al proprio privato interesse
non sono per Kant, come
erano invece per Rousseau,
fenomeni appartenenti a una
sorta di storica corruzione da
cui la natura umana potrebbe
essere emancipata. Una
simile emancipazione per un
verso non sarebbe possibile,
dato il carattere strutturale
che queste caratteristiche
rivestono
nella
visione
kantiana («da un legno così
storto - scrive Kant - come è
quello di cui è fatto l’uomo
non si può fare nulla di
completamente diritto») 53,
ma per altro verso non
sarebbeneppuredesiderabile,
poiché
solo
attraverso
l’egoismo e la competizione
che ne deriva si sviluppano i
talenti dell’uomo, le sue
capacità, la sua razionalità.
Ciò che prima facie si
potrebbe
giudicare
negativamente svolge in
realtà un ruolo altamente
positivo. « Senza quelle
proprietà, in sé certo non
propriodegned’essereamate,
dell’insocievolezza,
dalla
quale nasce la resistenza che
ognunodevenecessariamente
incontrare nelle sue pretese
egoistiche, tutti i talenti
rimarrebbero
eternamente
racchiusi nei loro germi, in
un’arcadica vita pastorale di
perfetta
concordia,
appagamento
e
amorevolezza: gli uomini,
mansueti come le pecore che
conducono al pascolo, non
darebbero alla loro esistenza
un valore superiore di quello
che essa ha per questo loro
animaledomestico»54.
Ciònonvuoldirecheper
Kant la competizione sia un
valoreinsé:essaèpiuttostoil
mezzo attraverso il quale si
produce ciò che ha valore, e
cioè lo sviluppo della
razionalità, della cultura,
dellascienza,dellaricchezza.
Proprio in quanto tesse
l’elogio della competizione
comenecessariaalprogresso,
d’altra parte, Kant non può
non introdurre il tema di
quellacheoggichiameremmo
eguaglianza delle opportunità
(cheèpoilaformapiùtipica
dell’eguaglianza liberale): è
tollerabileunadiseguaglianza
anche considerevole nelle
condizioni
economiche,
scrive Kant, purché però a
nessuno sia impedito, se il
suotalento,lasuaattivitàela
suafortunaglieloconsentono,
di «riuscire con il proprio
merito ai più alti gradi della
gerarchiasociale»55.
La concezione kantiana
dello stato di natura presenta
fondamentalmente
due
aspetti, uno dei quali lo
avvicina a Hobbes, mentre
l’altro
sembra
invece
collocarlo in una posizione
più simile a quella di Locke.
Il primo aspetto è quello per
cuiancheperKant,comeper
Hobbes,lostatodinaturanon
può che essere uno stato di
guerra: «lo stato di pace, fra
uomini che vivano l’uno
accanto all’altro, non è uno
stato di natura (status
naturalis); questo è invece
uno stato di guerra, anche se
non sempre comporta lo
scoppio delle ostilità ma
piuttosto la minaccia di esse.
Lostatodipacedevedunque
essere
istituito,
infatti
l’astenersidalleostilitànonè
ancora sicurezza, e se tale
sicurezza non viene garantita
aunvicinodall’altro(ciòche
puòaccaderesoloinunostato
in cui vi siano leggi), quello
può trattare questo, al quale
ha richiesta tale garanzia,
comeunnemico»56.
Tuttavia,
sebbene
costituisca uno stato di
guerra,
quantomeno
potenziale, lo stato di natura
puòesseredefinitosoloinun
certo senso uno stato nongiuridico. Esso è tale perché
non si è ancora costituita
quella unione civile che dà
luogo al passaggio allo stato
giuridico 57. Ma, in un altro
senso, esso non è del tutto
non giuridico, poiché in esso
sono già vigenti dei rapporti
di diritto privato tra gli
individui, sebbene in un
modo peculiare, che Kant
definisce provvisorio e non
perentorio:
«se
prima
dell’entrata nello stato civile
nessun acquisto si volesse
riconoscere anche solo
provvisoriamente
come
legittimo, allora quello stato
stesso sarebbe impossibile.
Perché, secondo la forma, le
leggi nello stato di natura
contengonointornoal‘mio’e
al ‘tuo’ le stesse condizioni
prescritte dalle leggi nello
statocivile,inquantoessosia
pensato unicamente secondo
concetti puramente razionali;
tuttaladifferenzaèchenello
stato civile sono indicate le
condizioni che assicurano
l’esecuzione (conformemente
alla giustizia distributiva)
delle leggi dello stato di
natura. Se dunque non ci
fosse
nemmeno
provvisoriamente un ‘mio’ e
un ‘tuo’ esterni nello stato di
natura, non ci sarebbero
neppure doveri giuridici
riguardoadesso,néquindici
sarebbe alcun comando che
imponessediusciredaquello
stato»58.Proprioinquantovi
ègiàunaleggerazionaleche
regola i rapporti di diritto
privato tra gli uomini dello
stato di natura, diventa
doveroso il passaggio allo
stato civile, dove non è più
possibile a ognuno «fare di
testa propria»59 (con la
bellicosità che a ciò si
connette); finché sono nello
stato di natura, privi di un
giudice comune, gli uomini
non commettono ingiustizia
sesicombattono,scriveKant;
si rendono però colpevoli di
una somma ingiustizia se
vogliono rimanere in quello
stato, dove «nessuno è certo
del suo contro la prepotenza
degli altri»60. Perciò Kant
può scrivere che è proprio
«daldirittoprivatonellostato
naturale» che «scaturisce ora
il postulato del diritto
pubblico: tu devi, in base al
rapportodicoesistenzachesi
stabilisce tra te e gli altri
uomini, uscire dallo stato di
naturaperentrareinunostato
giuridico, vale a dire in uno
stato
di
giustizia
distributiva»61.
Ecco quindi che la
transizione dallo stato di
natura allo stato giuridico si
configura, in Kant, in un
modo profondamente diverso
da quello che aveva
caratterizzato gli altri grandi
autoridelcontrattualismo:per
Kantlacreazionediunordine
giuridicoè,primaancorache
una necessità, un atto
doveroso,lacuidoverositàsi
radica proprio nel fatto che,
nello stato di natura, vi sono
si dei diritti che devono
essere riconosciuti agli
individuiinforzadiunalegge
dellaragione,maquestidiritti
restano
ineffettuali
e
richiedono quindi che si dia
vita alla coazione statale per
garantirli.
L’uscita dallo stato di
natura, d’altra parte, non è
solo doverosa, ma risponde
anche, come aveva insegnato
ilcontrattualismoprecedente,
all’interesse degli uomini
stessi:«Acostringerel’uomo,
altrimenti
così
ben
predisposto ad una libertà
incontrollata, ad entrare in
questo stato di coazione, è la
pena; e precisamente la
massima fra tutte le pene,
quella che reciprocamente si
procurano gli uomini, le cui
inclinazioni fanno si che essi
non possano stare a lungo
l’uno accanto all’altro in
selvaggia libertà» 62. Proprio
perché la costituzione dello
stato civile, oltre a essere
doverosa, è qualcosa cui gli
uomini sono spinti dalla
necessità e dallo stesso
interesse egoistico, Kant può
scrivere nella Pace perpetua
che
«il
problema
dell’instaurazione dello stato,
per quanto ciò possa suonare
aspro, è risolvibile anche da
un popolo di diavoli (purché
abbianointelletto)»63.
Dalfattochecostituirelo
statosiaundovere,invece,si
ricava una conseguenza di
rilievo, a proposito della
quale la dottrina kantiana
prendenettamenteledistanze
da quella lockiana. Mentre
per Locke la decisione di
spogliarsi
della
libertà
naturale coinvolge solo
coloro che la fanno propria,
mentre chi non aderisce a
essa resta come prima nello
stato di natura, fermo
restando che « nessuno può
essere tolto da questa
condizione e assoggettato
all’altruipoterepoliticosenza
ilsuoconsenso»64,inKantla
questione si pone del tutto
diversamente. Proprio in
quanto l’uscita dallo stato di
natura è un dovere, a questo
dovere corrisponde il diritto,
da parte di chi sia entrato in
una costituzione civile, di
costringere a farne parte
anchechivorrebberimanerne
fuori,semprechécostuisiain
condizione di entrare in
relazione con coloro che
fanno parte dello stato civile,
e non sia irrevocabilmente e
assolutamente separato da
essi: «Ma l’uomo (o il
popolo) nel semplice stato di
natura mi priva di questa
sicurezza e mi lede già
soltantoconl’essereinquesto
stesso, in quanto si trova
accantoame;sebbenenondi
fatto(facto), ma appunto con
la mancanza di leggi del suo
stato(statoiniusto),percuiio
sono
costantemente
minacciato da lui e lo posso
costringereadentrareconme
in uno stato comune-legale o
a ritirarsi dalla mia
vicinanza»65. Il punto è di
estrema rilevanza, perché
mentreper
Locke,eperilliberalismo
più in generale, la legittimità
dell’ordine politico dipende
dal consenso di fatto che gli
individui hanno dato a esso,
perKantessadipendeinvece
dalconsensochegliindividui
sono tenuti a dare, perché
rifiutarsiaessovorrebbedire
sceglieredipermanereinuno
stato di ingiustizia, mentre
l’adesione non è altro che
l’adesione doverosa a una
legge della ragione, e non ha
niente a che vedere con una
preferenza che, fattualmente,
gli individui possono nutrire
o meno. Proprio per questo
suo collocarsi radicalmente
nell’ambito del normativo il
contrattualismo kantiano va
oltre il problema di motivare
l’adesione al patto con la
convenienza degli individui
(anche se Kant ritiene che
l’adesione
sia
anche
conveniente) così come
risultanonespostoallacritica
hegeliana secondo la quale
l’idea del contratto porrebbe
riduttivamenteallabasedello
stato i singoli con «il loro
arbitrio, la loro opinione e il
loroespressoconsenso,datoa
piacimento
Costituire l’unione statale
è quindi un dovere; ma - si
potrebbechiedere-sitrattadi
un dovere morale o di un
dovere giuridico ? Come
notava puntualmente Bobbio
nelle sue lezioni kantiane67,
alla questione deve darsi una
rispostaarticolata:certamente
costituirelostato,ondeuscire
dall’ingiustizia, è qualcosa
che somiglia molto a un
dovere morale (e Kant ne
parla infatti, nel saggio sul
Detto comune, come di un
dovere
«primo»
e
«incondizionato»perquelche
riguarda il rapporto esterno
degli uomini in generale);
tuttavia, non si può
dimenticare che, quando si
parla di rapporti esterni, si è
giànellasferadelgiuridico,e
cheinoltreildoverediuscire
dallo stato di natura è
giuridicoinunsensopreciso,
nelsensocioèpercuivièda
parte degli altri un diritto di
costringereiriottosiaentrare
nello stato giuridico. E un
dovere la cui osservanza
vienegarantitadallacoazione
non può essere altro che un
dovere giuridico; ma un
doveregiuridico,ovviamente,
non nel senso del diritto
positivo, che è appunto ciò
che dev’essere costituito, ma
nelsensodeldirittonaturaleo
diragione.
Si può dunque affermare
cheinKantèproprioildiritto
naturale, o di ragione, a
costituireiltramitetralostato
di natura e lo stato civile: si
deve passare allo stato
politico,
insomma,
per
assicurare e consolidare la
giuridicità solo provvisoria e
pericolante dello stato di
natura. Questo passaggio,
quindi, è doveroso proprio
perchévièunaleggenaturale
che è anteriore alla legge
positiva, il cui carattere
obbligante si può riconoscere
a priori per mezzo della
ragione, e che quindi obbliga
anche se non è posta da un
legislatore. Tra le leggi
esterne,
che
non
appartengonocioèallamorale
ma al diritto, quelle il cui
carattere vincolante può
essere riconosciuto a priori
permezzodellaragionesono
legginaturali;«mentrequelle
che senza una reale
legislazione esterna non
obbligano per nulla, e che in
conseguenza senza questa
legislazione non sarebbero
leggi, si chiamano leggi
positive»68. La filosofia o la
dottrina razionale del diritto
non si accontenta di
conoscere quali sono, in un
determinato stato, le leggi
positive, ma mira a stabilire
un «criterio universale per
mezzo del quale si può
riconoscere in generale ciò
che è giusto e ciò che è
ingiusto»69.
Ora,
dal
momento che, diversamente
dalla moralità, il diritto
riguarda soltanto le relazioni
esterne tra gli uomini, il
criterio del giusto, ovvero il
«Principio universale del
diritto» può essere secondo
Kant formulato come segue:
«Qualsiasiazioneèconforme
aldirittoquandopermezzodi
essa, o secondo la sua
massima,
la
libertà
dell’arbitrio di ognuno può
coesistere con la libertà di
ogni altro secondo una legge
universale»70.
L’unico
«dirittooriginario»chespetta
all’uomo in forza della sua
umanità è «la libertà
(indipendenza dall’arbitrio
costrittivo altrui) in quanto
essa può coesistere con la
libertà di ogni altro secondo
unaleggeuniversale»71.
Una volta posto così il
primo principio, vediamo ora
quali sono secondo Kant le
caratteristiche
che
definiscono
l’ordine
giuridico:
il
diritto,
innanzitutto, appartiene al
mondodellerelazioniesterne,
riguardacioèilrapportotrale
libertà che i diversi individui
hanno di agire nel mondo
esterno: la sua funzione è
quelladiregolarelarelazione
traunapluralitàdiarbitrinon
già prescrivendo ad essi dei
fini cui debbano adeguarsi,
ma soltanto ordinando il
modo della loro coesistenza,
affinché
ognuno
possa
esplicare il proprio arbitrio
tanto quanto è possibile
coesistendo con una eguale
esplicazione
dell’arbitrio
altrui. In quanto attiene alla
libertà esterna, inoltre, il
diritto è inseparabile dalla
coazione,ovverodallafacoltà
di costringere: se qualcosa è
mio diritto, ciò vuol dire al
tempostessocheiohodiritto
a costringere gli altri a
rispettarlo.
Ma qual è allora il giusto
ordinamento
giuridico,
ovvero
l’ordinamento
giuridico che soddisfa i
requisiti di validità razionale
?
Lo stato giuridico, in
quanto
associazione
di
individuiliberiedegualisotto
leggi, si deve fondare su
principichevengonoprimadi
ogni legge che lo stato possa
emanare, poiché sono la
struttura della costituzione
dello stato secondo i principi
razionali.Questitreprincipia
priori dello stato giuridico
sono
(secondo
la
formulazione,
che
qui
assumiamo, del saggio Sul
dettocomune):
a.lalibertà,
b.l’uguaglianza,
c.l’indipendenza.
Illustriamonerapidamente
ilcontenuto.Lelibertàchelo
stato deve garantire sono da
Kant messe a fuoco
soprattutto sotto due profili:
da un lato i diritti che
concernono l’uso pubblico
della
propria
ragione,
dall’altro il diritto di ognuno
diricercarelapropriafelicità
come meglio crede, purché
naturalmente non pregiudichi
l’altrui diritto di fare
altrettanto.
Soffermiamoci
innanzitutto
sul
primo
aspetto:
tra
i
diritti
inalienabili dell’uomo Kant
annovera, già nel famoso
scritto del 1783 Che cos’è
l’illuminismo,ildirittodifare
uso pubblico della propria
ragione in tutti i campi, e
quindi anche di criticare
pubblicamente con gli scritti
le dottrine religiose e le
autorità politiche. Una critica
che non può mai tradursi in
disobbedienzaalleleggidello
stato, anche se ritenute
inique, ma che, come
insegnano
i
principi
dell’illuminismo,èstrumento
essenziale per rischiarare le
menti e per trasformare e
riformare, nel tempo, quelle
costituzionipolitichechenon
siano conformi ai principi di
libertà.Aidirittifondamentali
e inalienabili appartengono
quindi la libertà di religione,
la libertà di pensiero, la
libertà di critica pubblica:
qualsiasi atto del potere
sovrano teso a limitarli
sarebbeillegittimo,eanchese
un intero popolo deliberasse
di spogliarsi volontariamente
di questi diritti la sua
decisionesarebbenulla,priva
di alcun valore; anzi,
configurerebbe in realtà un
crimine contro la stessa
natura umana la cui
destinazione consiste proprio
nel
progredire
e
nellosviluppare
le
sue
disposizionirazionali.
L’altro
aspetto
fondamentaledellariflessione
kantianasuidirittiinalienabili
riguarda quella che si
potrebbedefinirel’autonomia
privatadell’individuointesosecondo le stesse parole di
Kant-come«uomo»,ovvero
membro della società civile.
Compito dello stato non è
quello
di
promuovere
paternalisticamente il bene
dei sudditi (questo sarebbe
per Kant il peggiore dei
dispotismi),masoloquellodi
garantirelecondizioniperché
ognunopossaricercareilsuo
benessere e la sua felicità
comemegliocrede:«Nessuno
mi può costringere ad essere
felice a suo modo (nel modo
in cui questi pensa il benessere di altri uomini),
maognunodevepotercercare
la sua felicità per la via che
gli appare buona, purché non
ledal’altruilibertàditendere
adanalogofine»72.
Daunlatoquindilostato
deve lasciare gli individui
liberi di perseguire i fini che
essi preferiscono, dall’altro
deveessererettononinmodo
arbitrario ma secondo leggi
(dev’essere, cioè, stato di
diritto). Da qui la peculiarità
della riflessióne kantiana
sulle forme di governo, che
tradizionalmente venivano
distinte
in
monarchia,
aristocraziaedemocrazia.Per
Kant la distinzione più
importantenonriguardailchi
deve governare (uno, pochi,
tutti), ma il come si deve
governare:osecondoleggi(e
questo è lo stato che Kant
chiama repubblicano), o
secondo arbitrio, come
accade nel dispotismo. Al
concetto di repubblicanismo
si collega quello di divisione
deipoteri:perchéungoverno
nonsiadispoticoènecessario
che la funzione legislativa,
che è la funzione suprema
nella quale si esprime la
volontàcollettiva,siadistinta
da quella esecutiva e da
quellagiudiziaria.
Accantoalprincipiodella
libertà Kant pone, come
abbiamo visto, quelli della
eguaglianza
e
della
indipendenza. L’eguaglianza
non
è
eguaglianza
nell’accesso ai beni, ma
eguaglianza di fronte alla
legge: essa richiede perciò la
negazione dei privilegi
ecclesiastici,
feudali
e
nobiliari, in modo che tutti i
cittadini siano egualmente
soggetti alla legge e che a
nessuno sia impedito di
accedere alle posizioni
migliori.
Il
principio
dell’indipendenza
afferma
invece che i cittadini, che
devono obbedire alle leggi,
hannoildirittodiesserneessi
stessi gli autori. Il potere
legislativo,però,noncompete
secondo Kant a tutti coloro
che vivono sotto la
giurisdizione di uno stato; lo
possonoesercitaresolocoloro
che sono indipendenti anche
nella loro vita materiale ed
economica, ovvero che
possiedono un capitale o una
abilità che consente loro di
mantenersi, senza dover
vender le proprie braccia.
Indipendenti,
e
quindi
cittadini, sono perciò il
proprietario
e
anche
l’artigiano, ma non il
lavoratoreagiornata,ilservo
domestico e la donna; non
sono pienamente cittadini
coloro che, se dovessero
esprimersi
politicamente,
finirebbero fatalmente per
esprimerelavolontàdicoloro
dacuidipendono.
Le leggi giuste, d’altra
parte, non sono frutto di una
volontàarbitraria,madevono
essere conformi alla ragione.
La fonte della legittimità di
una legge non è né il
contratto
come
fatto
realmente accaduto, né
semplicemente il consenso
effettivo dei cittadini, ma
piuttosto
il
contratto
originario come idea della
ragione, alla quale tanto il
legislatore quanto i cittadini
devono sentirsi vincolati: il
primo deve emanare solo
quelleleggicuituttoilpopolo
potrebbedareilsuoconsenso,
e i secondi devono obbedire
alleleggicomesederivassero
dalla loro volontà riunita. E
per converso una legge è
ingiusta quando sarebbe
impossibile che tutto un
popolo desse a essa il suo
consenso.
Laleggeallaqualetuttoil
popolo potrebbe dare il suo
consenso, d’altra parte, può
essere solo una legge
razionale
e
universale,
ispirata all’unico principio di
garantire il rispetto della
libertà di ciascuno. In questo
senso si può dire che Kant,
col suo repubblicanismo, dà
luogo a un tentativo di
pensare un rapporto di
reciprocitàocomplementarità
tra il momento liberale dei
diritti individuali e quello
rousseauiano della volontà
generale: la legge giusta è
quellacuilavolontàgenerale
del popolo potrebbe dare il
suo assenso (e perciò il
fondamentodellalegittimitàè
la volontà generale), ma la
legge cui ognuno potrebbe
dare il suo assenso non può
accoglierenelsuosenoalcun
principio particolare che
differiscadall’unicoprincipio
universale e razionale, e cioè
quello di garantire la eguale
libertà di tutti. Kant dunque
costituirà un punto di
riferimentoessenziale,finoai
giorni nostri, per un pensiero
politico che voglia tenere
insieme e articolare in modo
coerente il principio liberale
dell’autonomiadell’individuo
e quello democratico della
sovranità del corpo collettivo
deicittadini.
1 T. hobbes, Leviatano,
trad. it. a cura di G. Micheli,
La Nuova Italia, Firenze
1976,p.148.
2 Ibid., pp. 165-66.
Questo tema è uno di quelli
messi maggiormente a fuoco
nella
interpretazione
hobbesiana di Mario Reale,
che in queste pagine teniamo
presente; si veda il suo La
difficile eguaglianza. Hobbes
eglianimalipolitici:passioni
morale socialità, Editori
Riuniti,Roma1991.
3hobbes,Leviatanocit.,
p.118,
4Ibid.,p.120.
5lbid.,p.124.
6Ibid.,p.167.
7lbid.,p.208.
8 Cfr a questo proposito
Reale,
La
difficile
eguaglianza,pag.236
9 Cfr. h. warrender, Il
pensiero politico di Hobbes
(1957), trad. it. Laterza,
Roma-Bari1995.
10
È questa, nel suo
schema più sintetico, la linea
di lettura proposta da reale
neltestosopracitato.
11 B. spinoza, Trattato
teologico-politico, tradotto e
commentato da A. Droetto e
E. Giancotti Boscherini,
Einaudi,Torino1980,p.377.
12 reale, La difficile
eguaglianzacit.,pp.266-67.
13 B. spinoza, Trattato
teologico-politico, tradotto e
commentato da A. Droetto e
E. Giancotti Boscherini,
Einaudi,Torino1980,p.377.
14Ibid.,pp.384-85.
15 j. locke, Secondo
trattato sul governo, trad. it.
EditoriRiuniti,Roma1970.§
3p.52
16Ibid.,§124,p.141.
17Ibid.,§54,p.91.
18Ibid.,§6,p.54.
19 Su questo, come su
altri aspetti del pensiero
lockiano, si legge ancora
utilmenteilcorsodilezionidi
n. bobbio, Locke e il diritto
naturale,Giappichelli,Torino
1963.
20 locke, Secondo
trattatosulgovernocit.,§19,
p.64.
21Ibid.
22Cfr.adesempioi§§
87e123.
23T.HOBBES,Decive,
12.7.
24 Condizione enunciata, per
esempio, nei §§ 27 e 36 del
SecondoTrattato.
25 locke, Secondo trattato sul
governocit.,§32,p.74.
26lbid.,S33,p.75.
27Ibid.,§41,p.82.
28Ibid.,§95,p.121.
29 Su questo punto cfr.
bobbio, Locke e il diritto naturale
cit.,pp.259sgg.
30 M. reale,Le ragioni
della politica. Rousseau dal
«Discorso
sull’ineguaglianza»
al
«Contratto»,
Edizioni
dell’Ateneo, Roma 1983, p.
277.
31J.-J.Rousseau,Scritti
politici, trad. it. Laterza,
Roma-Bari 1994, vol. I, P4432Ibid.,p.162.
32Ibid.,p.162.
33Ibid.,p.171.
34Ibid.,p.171.
35Ibid.,p.173.
36Ibid.,p.179,corsivo
nostro.
37Ibid.,p.204.
38Ibid.,p.200.
39Ibid.,p.187.
40 rousseau, Contratto
sociale, in Scritti politici cit.,
vol.II,p.87
41
Discorso
sull'
ineguaglianza,ibid.,vol.I,p.
194.
42 Contratto sociale cit.,
p.93.
43Ibid.,p.96.
44Ibid.,p.98.
45Ibid.,p.210.
46 Reale, Le ragioni della
politicacit.,p.435.
47Ibid.,p.211.
48Ibid.,p.101.
49Ibid.,p.155.
50
reale, Le ragioni
dellapoliticacit.,p.486.
51Ibid.,p.591.
52 I. kant, Scritti di
storia, politica e diritto, a
cura di F. Gonnelli, Laterza,
Roma-Bari1995,p.33.
53Ibid.,pp.35-36.
54Ibid.,p.33.
55Ibid.,p.140.
56Ibid.,p.169.
57 I. KANT, Metafisica
dei costumi, trad. it. Laterza,
Bari1970,p.133.
58Ibid.,p,141;cfr.anche
p.69.
59Ibid.,p.140.
60Ibid.,pp.134-35·
61Ibid.,p.134.
62kant,Scrittidistoria
politica e diritto cit., pp. 3435.
63Ibid.,p.184.
64 locke, Secondo
trattatosulgovernocit.,§95,
p.131.
65kant,Scrittidistoria
politicaedirittocit.,p.169.
66 G. w. F. hegel,
Lineamenti di filosofia del
diritto, trad. it. Laterza,
Roma-Bari 2000, § 258
aggiunta,p.197.
67 N. bobbio,Diritto e
stato nel pensiero di Kant,
Giappichelli, Torino 1969,
pp.210-14.
68 kant,Metafisicadei
costumi,cit.,p.27.
69Ibid.,p.34.
V.Societàcivileestato
I.Lospartiacque
dellaRivoluzione.
Mentre le vicende del
paradigma contrattualista si
snodano lungo quella che,
riprendendo
una
periodizzazione marxista ma
largamente condivisibile, si
può caratterizzare come
l’epoca dell’ascesa sociale
dellaborghesia,apartiredalla
Rivoluzione francese il
quadro
cambia
completamente.
Acquisita
l’affermazione, sul piano
teorico,deiprincipidilibertà
e di eguaglianza che
caratterizzano il pensiero
modernoapartiredaHobbes,
echelaRivoluzionefrancese
pone come sue bandiere, il
problema diventa quello di
consolidare questi principi in
un nuovo assetto, capace di
stabilizzarsi lasciandosi alle
spallelefiguredellasovranità
popolare, «terroristica», della
fase
giacobina
della
Rivoluzione francese. Per i
liberali,quindi,elovediamo,
oltrecheinMadamedeStaël,
in modo paradigmatico nella
figura e nell’opera di
Benjamin
Constant,
la
questione decisiva diventa
quella di accogliere sì, con
l’eguaglianzagiuridicaditutti
gli individui, anche il
principio della sovranità
popolare, ma al tempo stesso
di porre a esso dei limiti
ferrei.Ilsignificatoeilvalore
storico
del
liberalismo
postrivoluzionario sta in
sostanzanelmodoincuiesso
si pone il problema, per dirla
con una locuzione che ha
goduto di molta fortuna, di
términer la Révolution·, il
problema
dei
liberali
postrivoluzionarièquelloper
unversodimantenereforteil
legame con alcuni principi
dell’89, liberamente rivissuti;
e per altro verso di segnare
unacesura,edifarediquesti
principiilpuntodipartenzaa
partire dal quale costruire
nuovastoriaenuovopensiero
politico.Comeèstatoscritto,
ilproblemachesipresentaai
liberali della Restaurazione,
decisi comunque a non
tagliare il filo ideale che li
lega alla grande Rivoluzione,
può essere espresso nei
seguenti termini: «come si
esce idealmente dalla più
grande rivoluzione del tempo
moderno, come se ne
appresta, con la parola di
Tocqueville, l’epilogo, e
come si dipanano perciò
nuove forme culturali e
politiche,nuovastoria?Come
sa bene, ancora alla metà del
secolo, Tocqueville, si tratta
di un passaggio difficile;
l’assestamento secondo i
propri principi... ha in primo
luogobisognodiunadistanza
liberatrice,comesostratoalla
liberazione delle scelte. Il
tema è allora quello della
conchiusione ideale della
Rivoluzione»1.
Il
liberalismo
postrivoluzionario, dunque,
mantiene la connessione con
Γ89, ma al tempo stesso
riflette sui rischi e i pericoli
della sovranità popolare, di
cui gli anni della rivoluzione
hanno consentito di fare
esperienza. Il rischio, in
primo luogo, è quello che la
sovranità
popolare
si
trasformi, come era accaduto
nella fase giacobina della
rivoluzione, nella dittatura
popolare, o meglio esercitata
da coloro che pretendono di
rappresentare il popolo. Ma,
forse ancora di più, il rischio
è che l’uguaglianza politica
dei cittadini, che si è
affermata come principio
inderogabile attraverso il
contrattualismo
e
le
rivoluzioni, voglia trovare la
sua coerente prosecuzione
nell’eguaglianza
sociale,
come già rivendicano le
correnti più radicali della
Rivoluzione
francese,
all’interno
della
quale
appaiono le prime forme di
comunismo
non
più
utopistico ma politico, come
la Congiura degli eguali di
Babeuf e Buonarroti (1796).
La questione che la
Rivoluzione ha aperto,
dunque, è se l’eguaglianza
politica
non
debba
necessariamente dar luogo
all’eguaglianza sociale; esito
che per certi versi può
apparire persino fatale e
inevitabile perché, se la
maggioranza che vive in
condizioni economiche di
deprivazione e di disagio ha
accesso ai diritti politici, è
evidente che li utilizzerà per
far leggi che portino alla
redistribuzionedellaproprietà
e alla garanzia pubblica del
diritto al lavoro, ovvero alla
soppressione delle condizioni
diprivilegioeconomicoealla
instaurazione
progressiva
dell’eguaglianza sociale. Su
questo sfondo di problemi
assolutamente
comune
ragionano tanto i liberali
quanto i loro nemici: i primi
nella ricerca di un equilibrio
che consenta di mantenere il
principio
moderno
e
rivoluzionario
dell’eguaglianza politica (che
soloireazionarieinostalgici
si ostinano a negare) ma al
tempo stesso di confinarlo
entro ben precisi limiti, e
impedirgli di straripare nel
senso di una trasformazione
rivoluzionaria di tutta la
società. Proprio quello che,
invece, rivendicano, nella
logica di una coerenza
egualitaria, i secondi. Per i
liberali, non porre dei limiti
alla sovranità popolare
significa spianare la strada a
unpoteredittatoriale,equindi
rinnegare i principi di libertà
della Rivoluzione e quasi
tornare
indietro
all’assolutismo; per gli altri,
invece, le libertà della
Rivoluzione devono essere
attuate
concretamente,
facendo sì che ognuno
disponga delle risorse per
esercitarle
effettivamente.
Nell’epoca
postrivoluzionaria,
perciò,
non si tratta più di
rivendicare,comeavevafatto
il
contrattualismo,
il
fondamento egualitario e
individualisticodelpotere,da
un lato, l’eguaglianza delle
opportunità
nella
competizione sociale e di
mercato, contro i privilegi
nobiliari,
dall’altro:
il
problemaèpiuttostoquellodi
pensareseecomequestidue
momentipossanocomporsiin
un struttura solida ed
espansiva, capace di tenere
produttivamente dentro di sé
tanto il principio moderno
dell’uguaglianza
politica
quanto quello, parimenti
moderno,
dei
diritti
dell’individuo comprensivi
delle sue libertà private e
della libertà di comprare e
vendere sul mercato le merci
non meno che il lavoro. Dal
punto di vista dei critici del
liberalismo,
invece,
il
problema è quello di partire
da questa tensione costitutiva
del moderno per volgerla
nella direzione di una libertà
ed eguaglianza sostanziale o,
quantomeno, di un crescente
riempimento delle libertà
giuridiche e formali con
contenuti sociali. Per dirla
con le parole di un acuto
pensatore
politico
contemporaneo,
Jacques
Bidet2, la questione del
pensiero
politico
postrivoluzionario è quella di
capire se, e come, possano
stare insieme la contrattualità
centrale
dei
cittadini,
fondamento
del
potere
politico e dello stato, e la
contrattualità interindividuale
degli
uomini
che
interagiscononellospaziodel
mercato, in quello che
soprattutto Hegel e Marx
individueranno
come
l’ambito della società civile,
distintadallostato.Sitratterà
allora di limitare lo stato per
lasciar spazio al libero
dispiegamento della società
civile, come vogliono i
liberali,oinvecediforzarela
contraddizione che, tra i due
termini, già Hegel aveva
posto?
Sono queste le grandi
tensioni che attraversano il
pensiero
dell’epoca
postrivoluzionaria, e che
dividono le menti che su di
essesimisurano.
2.Benjamin
Constantelalibertàdei
moderni.
Il percorso di pensiero di
Benjamin Constant (17671830) muove i suoi primi
passi proprio nel fuoco dei
conflitti della Rivoluzione
francese, ai quali egli prende
partedaquando,il24maggio
1795, arriva a Parigi, in
compagnia di Madame de
Staël.IlTermidoro(27luglio
1794) ha posto fine alla
dittatura giacobina, cercando
di «porre termine» alla
Rivoluzione ma in realtà
inaugurando una fase di lotte
e di incertezza che si
concluderà con il colpo di
stato di Napoleone del 18
brumaio
1799.
La
collocazione che Constant
intende darsi appare già in
questi anni molto chiara:
difesa dei principi di libertà
ed
eguaglianza
della
Rivoluzione, che si sviluppa
attraverso una polemica su
duefronti:daunlatocontroi
giacobini,chehannostravolto
i principi dell’89 instaurando
una dittatura arbitraria e
violenta, dall’altro contro i
nostalgici della monarchia,
che proprio dagli eccessi del
giacobinismo
traggono
argomenti per perorare il
ritornoalvecchioordine.Ma
ènelperiodonapoleonicoche
Constant (il quale, critico
dell'impero, sceglie l’esilio a
partiredal1803,anchesepoi,
con il Napoleone dei «cento
giorni»,
terrà
un
comportamento
diverso)
elabora i fondamenti teorici
del suo pensiero politico, al
cui centro è la inderogabile
necessità di limitare il potere
politico, affinché esso non
possa
trasformarsi
in
dispotismo.
I Prìncipi di politica del
1806 prendono le mosse
propriodall’analisicriticadel
pensierodiRousseau,neicui
errori sono da rintracciarsi,
secondo Constant, le radici
profonde dei «crimini con i
quali i nostri demagoghi
hannospaventatoilmondo»3.
Rousseau ha perfettamente
ragione, secondo Constant,
quando individua, attraverso
la pur insostenibile volonté
générale, nella volontà dei
cittadini l’unica fonte dalla
qualepuònascereun’autorità
politicalegittima:sesirifiuta
il fondamento divino del
potere politico, infatti, non
resta che una soluzione, e
cioèfondarelasualegittimità
sul consenso di coloro che a
esso devono sottoporsi. Ma
questo
principio
incontestabile, che Constant
intende in modo assai
generico come una sorta di
principio del consenso,
compatibile con ogni tipo di
costituzione, dalla teocrazia,
alla
monarchia,
alla
repubblica, non basta ancora
per definire quale sia un
governo legittimo. Una volta
determinata
la
fonte
dell’autorità, restano da
stabilire i suoi compiti,
ovvero i limiti del suo
esercizio. L’errore fatale di
Rousseau, allora, concerne
proprio questo punto: egli
afferma infatti che la
costituzione
del
corpo
politico
presuppone
l'alienazione totale, da parte
degli individui, di tutti i loro
diritti, e dà luogo pertanto a
un potere che, anche se
esercitato dalla collettività,
risulta,
come
quello
hobbesiano, assoluto ovvero
privodilimiti;tesisullaquale
concordano gli illuministi
radicaliHolbacheMably,per
il quale il potere legislativo,
chedichiaraerendeesecutiva
la volontà generale, non può
essere sottoposto ad alcuna
limitazione.DunqueConstant
finisce in sostanza per
attaccarelostessoconcettodi
volonté
générale
rousseauiana.
Per negare che questa
alienazione
completa
dell’individuo alla comunità
sia rischiosa, Rousseau
sostienecheinrealtàsitratta
di un’alienazione in cui
l’individuononperdenulla,e
anzi guadagna, perché,
unendosi con gli altri in un
corpo comune, acquisisce su
tutti loro gli stessi diritti che
cedeaglialtrisudilui,conin
più la forza comune
per garantire questi diritti. Il
fattodiesserepartedelcorpo
sovrano,
obietta
però
Constant, non è per
l’individuounaveragaranzia:
infatti, quando si passa
all’organizzazione
pratica
dell’autorità
sociale,
il
sovrano è costretto a
delegarla,el’azionecompiuta
a nome di tutti è, di fatto,
gestitadapochi,alcuipotere
l’individuo si trova infine
consegnato. Non è vero,
conclude Constant, che
l’individuo cedendo i suoi
diritti al corpo comune in
realtà li conserva; perché chi
esercitadifattol’autoritànon
èmaiilcorpocomunenelsuo
insieme,maunapartediesso,
che può anche farne un uso
arbitrario. Il potere illimitato
è quindi sempre dispotico,
anche quando esso sia nelle
mani non di individui
particolari, ma della totalità
deicittadini.
Ma allora come e dove
devono essere fissati i limiti
del potere legittimo ? La
riflessione sui limiti del
potere si articola, per
Constant, in due direzioni: in
primoluogosipuòragionare,
come ha fatto Montesquieu
quando ha proposto nel suo
Spinto delle leggi il modello
della Costituzione inglese,
sulla limitazione del potere
tramite divisione e articolazione, partendo dal
principio che un potere non
puòesserelimitatochedaun
altro potere; è questa la via
del costituzionalismo, che
tenta di elaborare un assetto
dei poteri dove essi si
controllino a vicenda, in
modo che nessuno possa
trasformarsi in arbitrio. Il
costituzionalismo è un tema
sulqualeConstantcontinuerà
sempre a interrogarsi e al
quale darà un contributo
importante.
La limitazione reciproca
dei poteri però, secondo
Constant,
è
ancora
insufficiente a impedire il
dispotismo: «la reciproca
sorveglianza delle diverse
frazioni dell’autorità è utile
soltanto per impedire ad una
di esse di ingrandirsi a spese
delle altre. Ma se la somma
totale dei loro poteri è
illimitata, se è permesso a
queste autorità riunite di
invadere tutto, chi impedirà
loro di coalizzarsi per
opprimere
a
loro
piacimento?»4.
Perché un assetto politico
non scivoli nel dispotismo e
garantisca
la
libertà
individuale, dunque, non
bastaneppureladivisionedei
poteri. Ciò che è essenziale,
invece, è stabilire con
nettezzagliambitineiqualiil
potere politico può esercitare
la propria competenza, e
quelli invece che esso deve
lasciarefuori,perchélelibere
scelte degli individui vi
regninoincontrastate.
Macome,inbaseaquale
principio, fissare questo
limite
?
Poiché
la
sottomissione a un potere
estraneo è una cosa che
preferiremmo
comunque
evitare, esso deve limitarsi
strettamenteaquellefunzioni
che sono indispensabili per
l’esistenzastessadellasocietà
civile: sul piano interno la
sicurezza dei cittadini e dei
loro averi, sul piano esterno
l’organizzazione di una forza
armata per garantire la
sicurezza dello stato; queste
due funzioni richiedono
inoltre una certa tassazione
sulleproprietà,senzalaquale
esse non potrebbero venir
finanziate. Ogni estensione
dell’autorità della stato oltre
questi limiti minimi è
illegittima. E dove l’autorità
statale finisce comincia lo
spazio dei diritti individuali
cheessanonpuòlimitare,ma
solo
proteggere
dalle
eventualiinterferenzedialtri:
«I diritti individuali si
compongono di tutto ciò che
resta
indipendente
dall’autorità sociale». Essi
perciò dovrebbero consistere
«nellafacoltàdifaretuttociò
che non nuoce ad altri,
ovvero nella libertà d’azione;
nel diritto di non essere
costretti a professare alcuna
fede,fosseanchequelladella
maggioranza,dicuinonsisia
convinti, ovvero nella libertà
religiosa; nel diritto di
manifestare
il
proprio
pensiero, con tutti i mezzi di
espressione, a patto che
questa espressione non
nuoccia ad alcun individuo e
non provochi alcuna azione
colpevole;
infine
nella
certezza di non essere trattati
arbitrariamente, come se si
fossero superati i limiti dei
diritti individuali, vale a dire
nella garanzia di non essere
arrestati, detenuti o giudicati
che secondo le leggi e le
forme»5. Una attenzione
particolare Constant dedica
alla difesa dell’opinione
pubblica e del suo strumento
principe,lalibertàdistampa:
essa
costituisce
un
indispensabile presidio dei
diritti degli individui perché,
se non vi fosse, le violazioni
dei diritti, potrebbero essere
perpetrate
molto
più
facilmente, non potendo
venir
denunciate
pubblicamente: i tribunali
potrebberogiudicareinmodo
ingiusto,
gli
innocenti
potrebbero essere messi in
prigione,
i
detentori
dell’autorità
potrebbero
fingere di ignorare le
violazioni che i loro apparati
commettono.
Nella
visione
constantiana, comunque, il
potere dello stato dev’essere
strettamente funzionale a
garantire l’esistenza della
società civile. Il fine è
l’ordinato sviluppo di questa,
nellaqualel’individuoesplica
la sua libertà; lo stato ne è
soltanto il mezzo, e diviene
illegittimo se vuole essere
qualcosa di più. Ma qual è
allorailruolocheresta,inun
quadro così concepito, per la
sovranitàpopolare?
Per un verso, come è
chiaro, il potere legislativo
detenuto dai rappresentanti
del popolo dovrà essere
esercitato
dentro
limiti
rigorosamente fissati e molto
ristretti, affinché non invada
quella sfere della vita
individuale e sociale che non
sono di competenza della
politica. Proprio per evitare
questo rischio, però, i diritti
politici, e cioè innanzitutto il
dirittodivotarepersceglierei
propri rappresentanti, non
potrannoessereestesiatuttii
cittadini: «per esser membro
di un’associazione politica
bisogna avere un certo grado
di cultura e un interesse
comune con gli altri membri
dell’associazionestessa»6;ei
nullatenenti, «coloro che
l’indigenza mantiene in
un’eterna dipendenza e
condanna, fin dall’infanzia, a
lavorigiornalieri,nonsononé
più illuminati dei fanciulli
riguardo agli affari pubblici,
né più interessati degli
stranieri a una prosperità
nazionale di cui non
conoscono gli elementi e di
cui godono i vantaggi
soltantoindirettamente»7.Per
essere cittadini si devono
conoscereipropriinteressi:si
deve quindi disporre di una
cultura, del tempo libero per
coltivarla, delle proprietà che
sonolacondizionepergodere
di questi agi. E perciò,
conclude
seccamente
Constant: «solo la proprietà
rende gli uomini capaci
dell’esercizio dei diritti
politici; solo i proprietari
possono essere cittadini». E
un proprietario, precisa
Constant,
non
è
semplicemente chi possiede
qualcosa, ma chi detiene «un
redditofondiariosufficientea
mantenersi durante l’anno
senza essere obbligato a
lavorare per altri»8. I diritti
politicidevonoesserelimitati
acolorochegodonodiquesta
sovrana
condizione
di
indipendenza, che non sono
obbligati a lavorare per
vivere.
Nella
sua
durezza
«classista», il ragionamento
di Constant non manca però
diunasuapeculiarecoerenza.
Si badi bene, egli non
considera, come aveva fatto
Locke, la proprietà come un
diritto che preesiste alla
società,esucuiquestanonha
alcunpotere,cioènonlapone
sullo stesso piano dei
fondamentali e intangibili
dirittidilibertà:laproprietàè
una «convenzione sociale», e
quindi non è in linea di
principio
sottratta
alla
giurisdizione della società.
Tuttavia, è ugualmente
«sacra» e «inviolabile»,
anche se lo è mediatamente,
poiché essa si connette in
modo inscindibile «ad altre
parti dell’esistenza umana, di
cui alcune non sono
assolutamentesottomessealla
giurisdizione collettiva ed
altre non vi sono sottomesse
che in maniera limitata»9. In
quanto strettamente connessa
alla libertà dell’individuo, la
proprietàvieneagoderedella
protezionecheaquestaspetta
didiritto,echetrovaulteriore
giustificazionenelfattochela
proprietà privata è, per
Constant, condizione di ogni
progressoebenesseresociale;
mentre la sua soppressione,
costringendo tutti a lavorare,
distruggerebbe
ogni
possibilità di avanzamento
spirituale e intellettuale, di
cui tutta la società raccoglie
poiibenefici.
La proprietà privata è
dunque elemento essenziale
di una società civile libera e
capacedimiglioraresestessa.
Edèproprioperquestochei
diritti politici dei non
proprietari devono essere
negati: se infatti essi ne
disponessero, li userebbero
per redistribuire la proprietà,
perimporledeilimitisocialie
infine per distruggerla.
Questo
principio
non
comporta però una divisione
dellasocietàinclassieordini
rigidamente distinti, come
accadevanell'ancienrégime:
perché la proprietà è per sua
natura mobile, e può essere
tantofacilmentepersaquanto
acquisita da chi ne abbia i
meriti e le capacità: le leggi
non devono far nulla per
limitare questa «salutare»
circolazione.
Il rapporto tra politica e
società civile è al centro
anche di quello che è
indubbiamente il più famoso
tra i testi di Constant, il
Discorso sulla libertà degli
antichi paragonata a quella
deimoderni(1819).Latesidi
Constant, presente in tutto lo
sviluppodelpensieropolitico
fino ai giorni nostri, è che la
libertà può intendersi in due
sensi
fondamentalmente
diversi. Nel senso degli
antichi, la libertà, così come
viene praticata nella polis,
consiste essenzialmente nella
partecipazione diretta al
potere politico: è la libertà
come autogoverno, una
libertà collettiva che peraltro
è perfettamente compatibile,
osserva
Constant,
con
«l’assoggettamento completo
dell’individuo
all’autorità
dell’insieme» e con la
privazionediquellicheanoi
moderni sembrano diritti
fondamentali, come per
esempiolalibertàdireligione
che, sostiene Constant,
«sarebbe sembrata agli
antichi un crimine e un
sacrilegio»10. Si ricordi, per
esempio, che Socrate fu
condannato a morte in Atene
perchéaccusatodiempietà.
La libertà nel senso dei
moderni, al contrario, è
fondamentalmente
libertà
dell’individuo privato: «il
diritto di non essere
sottoposto che alle leggi, di
non poter essere né arrestato,
né detenuto, né messo a
morte,némaltrattatoinalcun
modo a causa dell’arbitrio di
unoopiùindividui.
Il diritto di ciascuno di
dire la sua opinione, di
sceglierelasuaindustriaedi
esercitarla, di disporre della
sua proprietà e anche di
abusarne»;diandareevenire
senza
dover
chiedere
permesso;ildirittodiriunirsi
conaltrisiaperragionaresui
propri interessi che per
professare un culto o per
qualsiasi altro motivo; e
infine il diritto non già di
esercitare direttamente e in
prima persona il potere
politicoeamministrativo,ma
di influire in vari modi su di
esso, per esempio con
l’elezionedeirappresentantio
conlapressionedell’opinione
pubblica.
Che i moderni debbano
preferire questo secondo tipo
dilibertà,d’altraparte,risulta
damolteragioni:neglistatidi
grandidimensioni,l’influenza
del singolo sulle decisioni
politiche è minima; la
partecipazione diretta alla
politica,
inoltre,
non
essendoci più gli schiavi,
costringerebbe l’individuo a
trascurare gli affari e il
commercio, che lo assorbono
completamente e gli danno
soddisfazioni più visibili; dal
commercio inoltre gli uomini
apprendono l’amore per
l’indipendenza individuale e
al
tempo
stesso
la
convinzione che «tutte le
volte
che
i
governi
pretendono di fare i nostri
affari li fanno peggio e con
maggior dispendio di noi»11.
La conclusione è netta: «Il
fine degli antichi era la
divisione del potere sociale
fra tutti i cittadini di una
stessa patria: era questo che
essi chiamavano libertà. Il
fine dei moderni è la
sicurezza dei godimenti
privati; ed essi chiamano
libertà le garanzie accordate
dalle istituzioni a questi
godimenti»12.
La vera libertà dei
moderni, dunque, è la libertà
privata, quella che Hegel e
Marx chiameranno la libertà
del membro della società
civile. La libertà politica è
anch’essa fondamentale, ma
principalmente in quanto
strumento per garantire la
libertàchepiùcistaacuore,
quella
propriamente
individuale.Seicittadininon
controllassero il potere
politico, questo potrebbe
finire per privarli anche di
quei godimenti privati cui
essi tanto tengono. Perciò,
anche la libertà politica è
preziosa. Un rinchiudersi
eccessivo nella sfera privata,
inoltre, non comporterebbe
solo il rischio di perderne le
garanzie, ma implicherebbe
una sorta di angustia morale
dalla quale l’esercizio della
libertà politica ci libera,
mettendoci in contatto con
orizzonti più ampi. Senza
libertà politica non c’è
perfezionamento e progresso
morale, ma questo non toglie
che la sua funzione
fondamentale
resti
pur
sempre quella di garanzia
della libertà privata13. Sul
rapporto tra le due libertà,
dunque, la riflessione di
Constant resta in qualche
modoaporetica:perunverso
eglisirendecontoche,senza
la partecipazione politica,
l’intero assetto delle libertà
rischia di crollare; ma, per
altro verso, come tener viva
la partecipazione politica, se
l’individuo moderno, che
Constantcoglieintuttalasua
radicalità, è prevalentemente
concentrato
nella
sua
dimensione privata ? È vero
chelareligione,cuiConstant
affida un ruolo importante,
costituisce a sua volta un
legametragliuomini;manon
si tratta di un legame di
naturapolitica.
Una operante garanzia
dellalibertà,peraltro,richiede
secondoConstantcheipoteri
pubblicisianoarticolatieben
delimitati
nelle
loro
competenze: ed è su questi
temi che si esercita la
complessa
riflessione
costituzionale di Constant.
L’elemento più originale
dellasuacostruzioneconsiste
nell’affiancare, al potere
legislativo e a quello
esecutivo, una terza istanza
cheConstantdefiniscepotere
neutro o preservatore, che,
elettodalpopoloetotalmente
indipendente dagli altri due,
si pone come una sorta di
arbitroingradodidirimernei
conflitti. A questi si
affiancanoaltriduepoteriche
Constant concepisce come
elettivi, e cioè da un lato
quello amministrativo locale
edall’altroquellodeigiudici,
cui deve essere garantita la
massimaindipendenza.
3.Alexisde
Tocquevilleela
democraziainAmerica.
Discendente da genitori
aristocratici e fedeli alla
dinastia borbonica, Alexis de
Tocqueville (1805-59) è un
discepolo di Constant che
però finisce quasi per
rovesciarne
gli
esiti,
recuperando il valore di
quella libertà politica che in
Constant
era
rimasta
comunque subordinata alla
libertà privata. I suoi studi
sulla democrazia americana
nacquero in seguito a un
viaggio che, nel 1831, egli
compì nel nuovo continente,
dopo che, nel 1830, la
dinastia borbonica era stata
soppiantata,
sul
trono
francese, da Luigi Filippo
d’Orléans,
al
quale
Tocqueville aveva giurato
fedeltà, non senza però
provare disagio per questa
rottura dei legami che
univano la sua famiglia ai
Borboni. Il viaggio non gli
consenti solo di prendere le
distanze
dalla
nuova
situazione politica che si era
creata nel suo paese, ma gli
offri l’opportunità di quello
studioravvicinatodellanuova
democrazia americana da cui
sarebbero nati i suoi libri più
influenti: la Democrazia in
America, pubblicato in due
partieinduetempinel1835
e nel 1840, e L’Antico
Regime e la Rivoluzione, del
1856.
Mentre il liberalismo di
Constant credeva ancora di
poter arginare l’impatto della
democrazia attraverso la
limitazionedeldirittodivoto
ai soli proprietari, la
posizionediTocqueville,che
di Constant è ammiratore e
discepolo, si caratterizza
innanzituttoperchéegli,forte
dell’esperienza americana,
prende atto del carattere
inarrestabile dell’affermarsi
della democrazia, alla quale
perciò ritiene che sarebbe
vano opporsi. Egli cerca
perciò
innanzitutto
di
individuare le caratteristiche
del nuovo universo politico
democratico
che
va
affermandosi, mettendone in
risalto tutti i pericoli ma
senzacoltivarel’illusioneche
il processo possa in alcun
modovenirbloccato.
ConConstanteconmolti
pensatori politici della prima
metà
dell’Ottocento,
Tocqueville condivide però
unpresuppostodifondo:sela
democraziasiidentificaconil
suffragio universale, e se la
maggioranza della società è
composta da poveri, o
comunque da gente priva di
proprietà, allora con la
democrazia il potere politico,
o più precisamente il potere
legislativo, è consegnato alla
classe non proprietaria.
Constantvolevainognimodo
scongiurare
quest’esito;
Tocqueville ne prende atto:
«Il suffragio universale
assegna dunque realmente il
governo della società ai
poveri»14. È questa una delle
tesidifondocheTocqueville
sviluppa nella prima parte
della Democrazia: con il
governo democratico il
popolo, la massa dei non
proprietari, diventa davvero
sovrana:«Ilpopoloregnanel
mondo politico americano
come
Iddio
regna
nell’Universo.Essoèlacausa
e il fine di ogni cosa: tutto
esce da lui e tutto finisce in
lui»15.
Seaquestopropositosiè
potuto parlare, e non a torto,
di una sorta di esagerata
sopravvalutazione
della
sovranità popolare, dettata
più dal timore e dalla
diffidenza che da una
effettivaanalisidellarealtà16,
l’altro tema fondamentale su
cui Tocqueville costruisce la
suaanalisidellademocraziaè
quello della «eguaglianza
delle
condizioni»:
per
l’aristocratico Tocqueville è
proprio questa eguaglianza
che dà il tono generale alla
società democratica, che
sopprime qualsiasi privilegio
giuridico, di status, di ceto.
L’eguaglianza
delle
condizioni, perciò, è un
concetto dai contorni non
strettamentedefiniti,chestaa
indicare in sostanza quella
che per Tocqueville è una
caratteristica di fondo della
«mentalità» democratica: il
non riconoscere alcuna
superioritàdirangoodialtro
genere, e il collocare tutti gli
individui su un medesimo
terreno. Non è vero perciò,
neanche per un pensatore
liberale come Tocqueville,
che la democrazia sia un
mero strumento attuativo del
liberalismo; piuttosto, essa si
definisceperdellequalitàche
la caratterizzano anche al di
là delle forme giuridicopolitiche, come per esempio
questa
«mentalità».
L’eguaglianza
delle
condizioni, peraltro, è ben
compatibile anche con le più
grandi
diseguaglianze
economiche: la democrazia
americana è caratterizzata da
un grande divario tra
ricchezza e povertà, ma
questo non implica una
divisione «antropologica»,
perché la proprietà e le
ricchezze sono altamente
mobili e l’individuo può
trovarsi a occupare, in breve
spazio di tempo, posizioni
molto diverse nella scala
sociale.
Proprio perché considera
ineluttabile l’affermarsi del
«dogma» della sovranità
popolare e della eguaglianza
delle condizioni, Tocqueville
vuole mettere in guardia dai
costi che lo sviluppo della
democrazia comporta in
terminidiautonomiaelibertà
dell’individuo, che si trova
sempre più sottomesso a
quella che egli definisce
l’onnipotenza o, peggio
ancora, la «tirannide della
maggioranza».
La fenomenologia di
questa degenerazione è così
ricca e suggestiva che a essa
attingeranno, ancora nel
Novecento,tuttiicriticidella
società
di
massa.
L’onnipotenza
della
maggioranza si esprime negli
spazi sempre più grandi
che vengono occupati dal
potere legislativo, esercitato
da
deputati
fortemente
condizionati
dall’opinione
popolare.Leleggisonomolto
numerose e soggette a
cambiamenti frequenti; il
potere
legislativo
è
praticamenteprivodilimiti,e
in questa assenza si annida
perTocquevilleilgermedella
tirannide. La maggioranza
peraltro controlla, negli Stati
Uniti, anche tutti gli altri
poteri: dall’esecutivo, al
giudiziario eletto dal popolo,
fino
al
potere
non
istituzionalizzatodellastampa
e dell’opinione pubblica. Ma
questo
significa,
per
Tocqueville, che l’individuo
non dispone di vere garanzie
qualora i suoi diritti vengano
violati col beneplacito della
maggioranza del popolo.
L’arringa contro la tirannide
dellamaggioranzaculminain
pagine durissime sulla sorte
che attende la libertà di
discussioneedipensiero:«In
America, la maggioranza
tracciauncerchioformidabile
intorno
al
pensiero.
Nell’interno di quei limiti lo
scrittore è libero, ma guai a
lui se osa oltrepassarli».
«Nessuno
scrittore,
qualunquenesialanotorietà,
può sfuggire all’obbligo di
incensare i suoi concittadini.
La maggioranza vive dunque
in una perenne adorazione di
sé medesima...» Severissima
è la conclusione che
Tocqueville trae: «Non
conoscounpaeseincuiregni,
in generale, una minore
indipendenza di spirito e una
minore vera libertà di
discussione
come
in
America»17.
Nello
sviluppo
del
pensiero di Tocqueville,
perciò,
la
critica
classicamente
liberale
(segnata, come in Constant,
dal trauma del giacobinismo)
dellademocraziacomepotere
illimitato delle classi non
abbientisitrasforma,comesi
vedebenenellasecondaparte
della Democrazia, in una
riflessione sui nuovi rischi
della società egualitaria (nel
sensodettosopra)edimassa,
caratterizzata
da
una
decadenza e «dipendenza»
dell’individuo che viene
diagnosticata in modo tanto
più netto quanto più resta
vivoinTocquevilleilricordo
di ciò che ormai non si può
piùrestaurare,ecioèillibero
e
potente
individuo
aristocratico. «Nei secoli di
aristocrazia, che hanno
preceduto il nostro, vi
erano dei privati potentissimi
e un’autorità sociale assai
debole»18;
nel
tempo
democratico il rapporto si
inverte, e alla crescente
impotenza degli individui fa
da contraltare un potere
socialesemprepiùsmisurato.
Non si tratta più, però, del
potere incontrollato della
massa democratica e plebea,
fantasma
che
si
è
materializzato al tempo dei
giacobini;sitrattapiuttostodi
un potere pubblico tanto più
onnipervasivo quanto più
anonimo, a cui fa da
contraltare un individuo
privato che si spoliticizza, e
che si dedica al culto del
denaro e delle sue piccole
soddisfazioni materiali. La
minaccia che Tocqueville
vedeall’orizzonte,perciò,èsì
quella di un dispotismo, ma
di nuovo genere, un
dispotismo«mite»:«Secerco
di immaginarmi il nuovo
aspetto che il dispotismo
potrà avere nel mondo, vedo
una folla innumerevole di
uomini eguali, intenti solo a
procurarsi piaceri piccoli e
volgari,coniqualisoddisfare
i loro desideri. Ognuno di
essi, tenendosi da parte, è
quasi estraneo al destino di
tuttiglialtri...Aldisopradi
essi si eleva un potere
immenso e tutelare, che solo
siincaricadiassicurareiloro
beni e di vegliare sulla loro
sorte.
È
assoluto,
particolareggiato, regolare,
previdente e mite ... Lavora
volentieri al loro benessere,
ma vuole esserne l’unico
agenteeregolatore;provvede
alla loro sicurezza e ad
assicurare i loro bisogni,
facilita i loro piaceri, tratta i
loroprincipaliaffari,dirigele
loro industrie, regola le loro
successioni, divide le loro
eredità; non potrebbe esso
togliere interamente loro la
fatica di pensare e la pena di
vivere ?»19. Questa società
soffocata da «una rete di
piccole regole complicate,
minuziose e uniformi» che
comprimonoogniveralibertà
e indipendenza individuale,
soddisfacendoaltempostesso
il profondo bisogno degli
individui di essere guidati ed
esonerati
dal
rischio,
configura una specie di
«servitù
regolata
e
tranquilla»,
assolutamente
compatibile con tutte le
«forme
esteriori
della
libertà».
Non manca però, in
Tocqueville, la riflessione
sulle tendenze che si
oppongono, o potrebbero
opporsi, a questa involuzione
della
democrazia
in
dispotismo mite, adatto a
uomini ricchi di piccole
passioni e di piccole
ambizioni, ma privi di quelle
grandi. Se l’uguaglianza
democratica tende a produrre
uomini chiusi nella loro
dimensione individualistica,
privi di legame sociale20,
incapaci di uscire dalla
«solitudine del proprio
cuore»21 (e in ciò ben accetti
al dispotismo che vuole
governarli), questa tendenza
puòesserecontrastata,enella
società americana in buona
misura lo è, da una grande
rivitalizzazione della libertà
politicaedellapartecipazione
civica: «Molti in Francia scrive
Tocqueville
considerano
l’eguaglianza
delle condizioni come un
primo male e la libertà
politica come un secondo.
Quando sono obbligati a
subire l'una, si sforzano
perlomeno
di
sfuggire
all’altra. E io dico che, per
combattere i mali che
l’eguaglianza può produrre,
non vi è che un rimedio
efficace:lalibertàpolitica»22.
Tocqueville si sofferma
infatti ampiamente su tutte
quelle
istituzioni
che,
nell’America democratica,
danno modo ai cittadini di
porsi come soggetti attivi di
partecipazione
politica,
recuperando quasi, in alcuni
aspetti, quella «libertà degli
antichi» che era parsa a
Constant ormai inaccessibile
alla modernità; l’autore della
Democrazia in America
insisteinmodoparticolaresul
grande
valore
della
democrazia municipale e
dell’associazionismo: poter
gestire direttamente gli affari
cheliriguardanosuscitanegli
individuiunacuraperilbene
pubblico e rivitalizza quei
legami sociali che l'
individualismo del benessere
minaccia di recidere: «Le
libertàlocali,chefannosiche
ungrandenumerodicittadini
riçerchino l’affetto dei loro
vicini e dei loro parenti,
conducono
dunque
continuamente gli uomini gli
uni verso gli altri, malgrado
gli istinti che cercano di
separarli, e li costringono ad
aiutarsi fra loro»23. La sfida
fondamentale
della
democrazia sta dunque per
Tocqueville, che in ciò si
rivela come un pensatore
straordinariamente acuto e
attuale, nella capacità di
non
lasciarsi
assorbire
dall’orizzonte
della
spolitìcizzazione e di un
benessere
tutto
individualistico, nello sforzo
di tener viva la diretta
partecipazione politica dei
cittadini.
La sua critica delle
tendenze dispotiche della
società di massa, peraltro,
investeinmododecisoanche
ilsocialismo,chediquellagli
sembra riassumere in sé gli
aspettipeggiori.Deputatonel
periodo che va dal 1839 al
colpo di stato di Luigi
Napoleone, Tocqueville non
mancadischierarsi,nel1848,
contro coloro che vorrebbero
proseguire la rivoluzione
democratica in rivoluzione
sociale. Nel suo memorabile
discorso su, o megliocontro,
il diritto al lavoro, il
socialismo
diventa
il
concentrato di tutti quei mali
che Tocqueville aveva visto
minacciare il futuro della
società democratica: «La
Rivoluzione francese non ha
avuto la pretesa ridicola di
creare un potere sociale che
assicurassedipersestessola
fortuna,
il
benessere,
l’agiatezza
di
ogni
cittadino...»24. Proprio ciò
che invece vuol fare il
socialismo
quando,
reclamando il diritto al
lavoro, chiede che lo stato si
sostituisca alla previdenza
individuale, si intrometta
nelle industrie, imponga a
essedeiregolamenti,sifaccia
insomma paternallsticamente
carico del benessere di tutti.
Tocqueville propone così,
ora, una contrapposizione
secca tra socialismo e
democrazia, che non sembra
molto coerente con quello
che, sulla democrazia, egli
stesso aveva scritto qualche
anno prima. Ma la ricchezza
del suo pensiero sta forse
proprio
nelle
sue
contraddizioni, ambiguità o
ambivalenze:chenefannoun
pensatore aperto a molte
interpretazioni anche assai
contrastanti, ma comunque
straordinariamenteprofetico.
4.Illiberalismo
radicalediJohnStuart
Mill.
La
lettura
della
Democrazia in America di
Tocqueville esercitò una
notevole
influenza
sul
pensiero di John Stuart Mill
(1806-73) che, formatosi
nell’orizzonte intellettuale di
suo padre James Mill e
dell’utilitarismo di Jeremy
Bentham,
ne
modificò
notevolmente l’impostazione,
fino
a
giungere
all’elaborazione
di
un
pensierosocialeepoliticonel
quale confluiscono molti
motivi diversi, e la cui
originalità sta soprattutto nel
dar luogo a quello che si
potrebbe
chiamare
un
liberalismo
radicale,
caratterizzato per un verso
dalla apertura nei confronti
delsocialismoeperl’altroda
una difesa della libertà e
dell’anticonformismo
individualemoltopiùnettadi
quella che era stata propria
deipensatoriliberaliclassici.
Mentre l’utilitarismo di
Bentham aveva posto come
fine della morale e della
legislazione
quello
di
realizzare la massima felicità
per il maggior numero, John
Stuart Mill, senza rinnegarne
il principio, si rende conto
però che la felicità degli
individui non può essere in
alcun modo ridotta alla
ricerca
del
benessere
individuale
strettamente
inteso, ma anzi può essere
talvolta
conseguita
più
facilmente se ci si dedica a
fini apparentemente non
utilitaristici
come
il
contribuire alla felicità degli
altri o più in generale allo
sviluppo delle facoltà e delle
capacità umane. Non tutti i
piaceriumani,perlui,stanno
sullo stesso piano, e l’errore
dell’utilitarismo classico sta
proprio nel non aver dato
spazioadistinzioni.
La
sua
visione
progressivaeumanistica,ela
sua indignazione per le
condizioni di ingiustizia
sociale e di deprivazione,
portaronoMillaguardarecon
molta simpatia al movimento
socialista e cartista, e a
concedere ampio spazio alla
critica
socialista
della
proprietà privata nel suo
capolavoro
di
teoria
economica, che si iscrive
nellalineadiDavidRicardoe
di James Mill, i Principi di
economiapoliticadel1848.
Una delle tesi più
caratteristiche
del
Mill
economista è che, mentre le
leggi che governano la
produzione della ricchezza
sono assimilabili a delle
verità fisiche, del tutto
indipendenti dalla volontà
umana, la distribuzione della
ricchezza, invece, dipende
dalle
leggi
e
dalle
consuetudinidellasocietà,ed
è
quindi
modificabile
attraverso
l’intervento
cosciente degli uomini. Mill
critica, perciò il modo in cui
laricchezzaèdistribuitanella
società del suo tempo; e
sostiene
che,
se
la
conseguenza
di
un
ordinamento sociale fondato
sullaproprietàprivataèchela
ricchezza venga distribuita in
proporzione quasi inversa al
diretto contributo lavorativo,
allora questo ordinamento
dev’essere modificato, forse
anche sostituendo a esso un
sistema comunistico. Un
sistemadiquestotipo,d’altra
parte, potrebbe comportare
deirischiperquantoriguarda
lo sviluppo libero e
multiforme della personalità
umana, che per Mill resta il
fine fondamentale; in questo
caso sarebbe preferibile
combattere i mali derivanti
dall’istituto della proprietà
privataattraversounapolitica
di riforme sociali, a
cominciare dalla diffusione
dell’istruzione
e
dalla
limitazione della crescita
dellapopolazione:misureche
risulterebbero sicuramente
efficaci per combattere il
male della povertà, e che
vannoaffiancateadaltretese
nella medesima direzione,
come la limitazione delle
successioni, la sostituzione
dellagrandeproprietàterriera
con la piccola proprietà
contadina, lo sviluppo della
produzione
cooperativa.
«Non bisogna attendersi scriveMillneiPrincipi-che
ladivisionedelgenereumano
indueclassiereditarie,datori
di lavoro e lavoratori, possa
essere
eternamente
conservata».C’èdaaspettarsi
piuttostochequestadivisione
venga sostituita da nuove
forme
associative
e
cooperative, tra lavoratori e
datoridilavorootraglistessi
lavoratori. Mill critica quindi
del capitalismo il fatto che
esso si basi su una
distribuzione ineguale delle
proprietà che è il sedimento
di passate sopraffazioni,
mentre difende il principio
della libera concorrenza con
la sola eccezione della
concorrenza tra i lavoratori.
Egli però non crede che lo
sviluppo, l’accumulazione e
quindi la stessa lotta
concorrenziale
debbano
continuare all’infinito, anzi
ritiene che sia inevitabile
giungere a uno «stato
stazionario», con il quale
l’umanità
si
lascerà
finalmente alle spalle la
continua
corsa
all’accrescimento
del
guadagno.
Per quanto riguarda il
contributo di Mill alla
filosofia politica, questo si
trova innanzitutto in quella
cheèlasuaoperapiùfamosa
e più letta, il volumetto On
libertydel 1859. Ispirato alla
stessa preoccupazione che
avevaanimatoTocqueville,e
cioè che l’invadenza dello
stato e la tirannide della
maggioranza
possano
soffocare ogni spazio per la
libertà degli individui, On
liberty si propone di
determinare i limiti che il
potere pubblico e la
legislazione non possono
varcare, ovvero quelle sfere
di libera azione individuale
che alla normazione statale
debbono restare comunque
sottratte.Ilprincipiodiquesta
limitazione, nel modo in cui
Millloformula,èsemplicee
univoco: lo stato non può
vietare
alcuna
azione
dell’individuo che non rechi
dannoadaltri:«Ilsoloscopo
per il quale si può
legittimamente esercitare un
potere su un qualunque
membro di una comunità
civilizzata, contro la sua
volontà, è quello di
impedirgli di nuocere agli
altri.Ilbene,fisicoomorale,
di questo individuo, non è
una
giustificazione
sufficiente»25. Se definiamo
paternalista
un’autorità
politica che pone ai sudditi
delle limitazioni motivate da
una miglior conoscenza, vera
o presunta, di quello che è
bene per loro, allora
dobbiamodirecheMill,dopo
Kant, è uno dei critici più
fermi del governo ispirato a
principipaternalistici.
Adifferenzadialcunidei
suoi predecessori, Mill non
fondalasuatesicircailimiti
del potere dello stato né su
una teoria dei diritti naturali,
nésuunabasecontrattualista:
la riconduce piuttosto, come
dice egli stesso, al criterio di
utilità (che resta per lui il
criterio supremo) inteso però
nel senso più ampio del
termine,
e
facendo
riferimento agli «interessi
permanenti dell’uomo come
essere perfettibile»26. Il
principio
di
minima
limitazione della libertà, in
altreparole,nonvienebasato
su un diritto dell’individuo
alla non-interferenza, ma
sulleconseguenzepositive,in
terminidiutilitàrettamentee
largamente intesa, che ne
discendono. Proprio per
questo la sua tesi viene
dimostrata da Mill, in primo
luogo, per quanto riguarda il
casodellalibertàdiopinione.
Il potere politico che
pretendesse di vietare la
pubblica espressione di
opinioni che l’autorità o la
maggioranza
ritengono
perniciose,
deleterie,
o
semplicemente
sbagliate,
commetterebbe,
sostiene
StuartMill,untortonontanto
contro i sostenitori di quelle
opinioni, che verrebbero
limitati nella loro libertà,
quanto contro l’umanità in
generale, contro gli uomini
viventi e ancor più contro
quelli
che
verranno.
L’argomento di Mill è molto
chiaro; ammettiamo il caso
cheunacertaopinionevenga
proibita: « Se l’opinione è
giusta, essi vengono privati
dell’opportunità
di
abbandonare l’errore per la
verità;seèsbagliata,perdono
un beneficio quasi altrettanto
grande: la percezione più
chiaraepiùvivadellaverità,
prodotta dal contrasto con
l’errore»27.Perescludereche
una certa opinione sgradita
possaungiornorivelarsivera,
prosegue Mill, ci si deve
arrogare la pretesa di una
certezzaassolutadelleproprie
idee che dovrebbe essere
estraneaaogniuomodibuon
senso;
l’esigenza
di
mantenere
sempre
una
apertura
fallibilista
è
rafforzata dal fatto che molte
idee ritenute certissime in
epoche passate si sono
rivelate, in seguito, non solo
false, ma persino assurde. Se
l’opinione che oggi viene
ritenutafalsaevieneproibita
dovesse essere vera, la
proibizione sarebbe un
ostacolo
sul
cammino
dell’umanità in cerca del
vero. Ma anche se l’opinione
proibita fosse falsa, il
proibirla
renderebbe
impossibile all’opinione vera
di chiarire e motivare se
stessa nel confronto con la
suanegazione,elaridurrebbe
infine a un dogma non
chiarito e non articolato. La
cosa più probabile, d’altra
parte,concludeStuartMill,è
che l’opinione dissidente non
sia né del tutto vera né del
tutto falsa, ma contenga una
parte della verità (così come
l’opinionemaggioritariachea
essasicontrappone);proibirla
vorrebbedireperciòimpedire
all’opinione prevalente di
correggersiemigliorarsi.
Non c’è progresso verso
la verità, insomma, senza
libertà di discussione, così
come non vi è progresso
sociale se i fautori delle
diverse opzioni (aristocratici
e democratici, socialisti e
difensori del mercato) non
hanno modo di esprimerle e
di sostenerle con uguale
libertà28.
Il ragionamento che vale
per le opinioni si applica
anche (con la sola esclusione
diciòcherecadannoadaltri)
agli stili di vita e ai
comportamenti: se non vi
fosse la possibilità per gli
individui di sperimentare
modi di vita eterodossi,
sgraditi al conformismo dei
più e al potere dello stato,
sarebbe impedito agli uomini
di conoscere ciò che forse
potrebbe portarli a una vita
piùrealizzataepiùfelice.La
possibilità per l’individuo di
svilupparsi autonomamente,
seguendoipropriimpulsipiù
personali e spontanei e
sottraendosi alla tirannia
conformistica
della
maggioranza, non è solo uno
dei principali fattori della
felicità umana, ma «quello
sicuramente più essenziale al
progresso individuale e
sociale»29:«illiberosviluppo
dell’individualità è uno degli
elementi essenziali del bene
comune», ma un elemento
che rischia di scomparire,
come aveva denunciato
Tocqueville, quanto più la
tirannidedellamaggioranzasi
afferma
a
scapito
dell’originalitàdeisingoli.
Derivadaciòlacriticadel
paternalismo, ovvero della
pretesa di proibire agli
individui
comportamenti
(come per esempio il bere o
l’assunzione di sostanze
nocive) che, senza recar
dannoadaltri,sembranoperò
contrari al loro stesso bene:
«nessunapersonaogruppodi
persone è autorizzata sostiene Mill - a dire a
un’altra persona matura che
per il suo bene non può fare
dellasuavitaquelchesceglie
difarne»30.
Qui arriviamo alla punta
più radicale, e anche
controversa, del liberalismo
milliano.Inprimoluogo,non
è facile distinguere un
comportamento che reca
dannoadaltridaunochenon
lo fa: si potrebbe sostenere
che il danno dipende dai
criteri di liceità che ogni
società si dà, e che mutano
storicamente. In secondo
luogo,seammettiamochesia
lecito, o magari anche
doveroso, impedire a un
individuo,ancheconlaforza,
di gettarsi in un fiume per
annegarsi, che obiezione ci
può essere, per esempio, alla
proibizione di far uso di
sostanze che danneggiano, in
modo accertato, la salute, la
vita e la lucidità mentale
dell’individuostesso?Perché
non sarebbe lecito, in questo
caso,costringeregliindividui
in vista del loro stesso bene?
Oppure: se il principio di
libertà è difeso per ragioni
conseguenzialiste, cioè in
quanto
genera
buone
conseguenze
consentendo
agli individui di perseguire il
loro bene, non perde la sua
ragion d’essere quando il
comportamento
dell’individuo
va
manifestamente contro il suo
stessobene?
Alla plausibilità di queste
obiezioni Mill oppone una
seriediargomentichesono,a
nostro
giudizio,
non
conclusivi ma comunque
rilevanti: 1) il singolo è la
persona più interessata al
proprio benessere, più di
quanto non lo sia la società;
2)lasocietàhaavutoinogni
caso
il
modo,
con
l’educazione,diprevenirenel
singolo i comportamenti
sgraditi; 3) se non si
ponessero
dei
limiti
all’ingerenzadelpubblicosui
comportamentiprivati,questo
finirebbe per punire, come è
successo infinite volte nella
storia, non ciò che è
provatamente dannoso per i
singolistessi,matuttociòche
va contro le sue preferenze e
soprattutto
le
sue
superstizioni: basti pensare
alla
persecuzione
nei
confronti delle persone
irreligiose
o
giudicate
immorali. Insomma, non si
può conferire alla società un
potere che essa ha sempre
dimostrato, nei secoli, di non
sapereusarebene.
Vi sono però delle
eccezioni: è lecito proibire
agli individui di vendersi
come schiavi, anche se lo
volessero, perché il principio
di libertà non può essere
usato per legittimare la
rinuncia, seppure volontaria,
alla libertà stessa: «la facoltà
di alienare la propria libertà
non è libertà»31. Così come
non è una violazione della
libertà, né dei genitori né dei
figli,l’istruzioneobbligatoria,
che però secondo Mill non
deve essere affidata a un
unico sistema educativo
statale. E infine, Mill precisa
che il principio della libertà
individuale non ha niente a
che fare con la dottrina del
libero scambio 32: limitare la
concorrenza, per esempio, è
quasi sempre sbagliato, ma
nonèunattentatoallalibertà,
poiché il commercio non è
una libertà privata ma
un’attività sociale, soggetta
perciòalleleggichelasocietà
leprescrive.
La sua visione dell’uomo
come essere che si realizza
sviluppando
in
modo
autonomo e originale le sue
piùpropriecapacitàinfluenza
anche la visione che Mill ha
della democrazia. Per un
verso,inquantofautorediun
avanzamento culturale e
intellettuale di tutti gli
uomini,Millpensachequesto
sarebbe senz’altro favorito
dalla partecipazione alla
politicaattraversoilsuffragio
universale
democratico.
D’altra parte, egli, come i
suoi predecessori liberali, è
ben consapevole di vivere in
una
società
fondamentalmente divisa in
classi,edovelamaggioranza
della popolazione appartiene
allaclassepiùpovera.Perciò,
nel suo saggio Sul governo
rappresentativo
(1861),
sostiene che il suffragio
universale applicato secondo
la regola un uomo/un voto
porrebbe il potere legislativo
nellemanidellamaggioranza
più povera e meno colta,
comportandoquindiilrischio
di una legislazione classista,
ingiusta, attenta solo agli
interessi immediati della
maggioranzaenonaquellidi
lungo termine, delle altre
classi, delle generazioni a
venire.
A questi inconvenienti
Mill pensò che si potesse
porre rimedio non già
eliminando il suffragio
universale (anche se ne
escludeva gli analfabeti e gli
indigenti che non pagavano
tasse)
ma
piuttosto
introducendo il correttivo del
voto plurimo, in modo tale
che tutti avessero a
disposizione un voto, ma che
lepersonepiùistruite,esperte
e qualificate ne avessero più
d’uno (un uomo di cultura,
per esempio, poteva averne
cinqueosei,unimprenditore
tre, un capo operaio due). In
questo modo si sarebbe
potuta
ottenere
una
legislazione non classista e
sensibile
agli
interessi
generaliedilungoterminedi
tutta la società. Sempre
pensando a una democrazia
dell'intelligenza, e quindi
antilivellatrice, Mill ritiene
che le leggi non dovrebbero
essere
elaborate
dal
Parlamento, ma da una
commissione ristretta e
qualificata,
mentre
il
Parlamento
dovrebbe
limitarsi
a
discuterle,
approvarle o respingerle. Il
votoplurimo,peraltro,erada
Mill considerato più che un
espediente per evitare la
legislazione di classe: si
trattava di una misura in se
stessa giusta perché, scriveva
Mill, «non è utile, ma
dannoso, che la costituzione
del paese debba dichiarare
che l’ignoranza abbia diritto
al potere politico quanto
l’istruzione».
Proprio perché il suo
pensiero costituisce, come
abbiamo visto, il tentativo di
tenere insieme molte e
diverse esigenze intellettuali,
Millèall’originenonsolodel
liberalismo radicale, che
rifiuta ogni paternalistico
intervento nella sfera privata,
ma
anche
del
liberalsocialismo e di un
modello di democrazia
centrato sullo sviluppo
culturale degli individui, che
è stato opportunamente
definito «democrazia di
sviluppo»(Macpherson).
5.Ilsuperamento
hegelianodel
liberalismo.
Anchelafilosofiapolitica
diHegelsicostruisceintorno
alla centralità del tema
moderno della libertà; essa è
caratterizzata dalla libera
volontà
universale
fondamento dello stato -,
pensata in una prospettiva
che, senza negare alcune
acquisizioni di fondo del
liberalismo, le inserisce però
inunacornicepiùampia,che
nericonosceilrelativovalore
e ne evidenzia anche i limiti.
La filosofia del diritto
hegeliana si articola in tre
grandi
parti
dedicate
rispettivamente al diritto
astratto, alla moralità e
all’eticità. L’oggetto delle
prime due parti è proprio
quellodimostrarecometanto
la dimensione della mera
libertà giuridica, quanto
quella della libertà morale
delineata secondo il modello
kantiano, non costituiscano
un modo soddisfacente di
pensare la libertà: nella
visione di Hegel, infatti, la
libertà dell’individuo non
consiste compiutamente né
nella sua facoltà di operare
come persona giuridica,
capace di disporre di sé e
delle sue proprietà e di
concludere contratti con altre
personegiuridiche,eneppure
nella sua capacità di
autodeterminarsi
come
persona morale capace di
scegliere in base alla ragione
senzalasciarsidominaredalle
inclinazioni. Entrambi questi
modi di intendere la libertà,
sebbene abbiano il merito di
insistere
sul
momento
irrinunciabilmente moderno
della soggettività, colgono il
significato della libertà solo
inmodoastrattoeparziale:la
libertàinfatti,secondoHegel,
non va intesa tanto come
possibilità per l’individuo di
determinarsi in una direzione
o in un’altra, ma più
compiutamente dev’essere
compresa come il fruire di
quelle condizioni e di quei
rapporti
oggettivi
che
consentano all’individuo la
sua autorealizzazione33, che
gli assicurino le condizioni
per esplicare la sua libera
personalità. Da questo punto
di vista tanto la libertà del
diritto astratto quanto quella
della moralità kantiana
risultano insufficienti: la
libertà del diritto astratto
conferisce
all'individuo
soltanto delle facoltà, mentre
la libertà morale kantiana gli
prescrive di agire secondo
massime universalizzabili.
Ma quali sono le massime
universalizzabili? La tesi
hegeliana è che si può
rispondere a questa domanda
solo se già si presuppone il
valore di determinati istituti
sociali, che però la moralità
kantiana è incapace di
generare da sé mostrandone
la razionalità: se si assume
l’istituto della proprietà,
allora la massima che
consente il furto non è
certamente universalizzabile;
ma come sappiamo che deve
esserviproprietà?
La libertà concreta,
perciò, non può essere
pensata come mera capacità
di
autodeterminazione
individuale; essa viene
ricostruita piuttosto, da
Hegel, come l’insieme di
quegliistitutinelcontestodei
quali gli individui possono
godere,adiversilivelli,delle
condizioni per la loro
autorealizzazione, E questa è
appunto la terza sfera della
filosofia del diritto, la sfera
dellaeticità,cioèdellalibertà
attuatainconcreteistituzioni,
che a sua volta si articola
nelle tre dimensioni della
famiglia,dellasocietàcivilee
dellostato.
Rispetto al liberalismo,
che pensava la libertà
dell’individuoessenzialmente
come esplicantesi nella
dimensione della società
civile, e che vedeva lo stato
fondamentalmente come il
garante di questa libertà
(civile, privata o economica)
la posizione di Hegel
costituisce per molti aspetti
un superamento. In primo
luogo egli mostra, contro il
contrattualismo, che non si
può pensare lo stato come il
risultato di un patto tra
individui privati, quasi che si
dessero prima i soggetti di
contratto nell’ambito della
società
civile
e
poi
l’organismo politico che li
stabilizza e li garantisce. Al
contrario, per Hegel, come
già per Aristotele, lo stato,
cioèl’organismopolitico,èil
momento che precede gli
altri: non ci sono individui
capaci di autodeterminarsi
liberamente,famiglia,società,
senza l’unità politica che di
tutto ciò costituisce la
condizione.
Ma proprio per questo
non ha senso affermare che
l’unità
politica
sia
semplicemente un mezzo per
garantire quello che i liberali
allaConstantponevanocome
il fine prevalente, e cioè il
godimento delle libertà
private da parte del membro
dellasocietàcivile.PerHegel
èveroilcontrario,ecioèche
lostatoèscopofinale,finein
se stesso, mentre il supremo
dovere dei singoli è
innanzitutto quello di essere
componentidellostato34.
Peraltro, l’individuo che
persegue il proprio interesse
egoisticoinstaurandorapporti
discambioconaltriindividui
egoisti, e che costituisce
appunto il soggetto operante
nelladimensionedellasocietà
civile e di mercato, lungi dal
costituire la figura unica o
dominante della soggettività,
comeaccadeinmoltevisioni
liberali, ne è semplicemente
un aspetto parziale. Il primo
istituto all’interno del quale
gli individui trovano le
condizioni
della
loro
autorealizzazione,infatti,non
è la società civile, ma la
famiglia, che ha la sua
determinazione nell’amore e
nell’unità tra i componenti.
La separazione tra gli
individui interviene solo
successivamente,
e
presuppone alla sua radice
questa dimensione di più
originaria e insostituibile
unità, di spontanea dedizione
aunbenecomune.
L’ambito della società
civileèinvecequelloincuisi
afferma la separazione degli
individui, come persone
private
dedite
al
soddisfacimento dei loro
bisogni e interessi egoistici.
Si tratta, per Hegel, di una
dimensione fondamentale: lo
sviluppo
dell’individuo,
infatti, presuppone la sua
separazione
dall’unità
immediata, la conquista
dell’autonomia; l’errore sta
solo nel considerare questa
sfera come la dimensione
unica o fondamentale per la
vita dell’individuo; sta nel
non capire, in altre parole,
che gli individui possono
confrontarsi nella società
civile come portatori di
interessi egoistici solo in
quanto
sono
iscritti
nell’orizzonte
di
altre
istituzioni, non di mercato,
cheassicuranolalorounitàe
la salvaguardia dell’interesse
comune, come la famiglia a
un primo gradino e le
istituzioni dello stato a un
livellopìualto.
Esulterrenodellasocietà
civile,però,chesigeneranoil
progresso e la civiltà: il
lavoro, la sua divisione
sempre più articolata, la
moltiplicazione dei bisogni,
losviluppodellemacchine,la
sempre
crescente
intensificazione dei rapporti
di scambio; in questa sfera,
come avevano insegnato
Mandeville e Adam Smith, i
vizi privati si trasformano in
pubbliche virtù, «l’egoismo
soggettivo si rovescia nel
contributo all’appagamento
deibisognidituttiglialtri»35.
Nella visione hegeliana,
però (e anche in questo egli
prende le distanze da
presupposti
largamente
condivisi tra i pensatori di
orientamento liberale), le
conquiste della società civile
generano a loro volta
problemi che' essa non è in
grado di risolvere con i suoi
stessi
strumenti,
cioè
confidando semplicemente
nelle virtù della mano
invisibileedellaconcorrenza:
la sua legge è quella di uno
sviluppocheèsiimpetuosoe
privo di limiti (perché non
sono più i bisogni a
comandarelaproduzione,ma
è quest’ultima a generare
sempre nuovi bisogni), ma al
tempostessoinegualeepieno
di
contraddizioni.
La
dinamica spontanea della
società civile, infatti, tende
per Hegel a generare da un
lato la più straordinaria
accumulazione di ricchezza,
dall’altrolaconcentrazionedi
povertà e deprivazione, la
formazione della «plebe»:
«malgrado l'eccesso della
ricchezza, la società civile
non è ricca abbastanza, cioè
nellerisorseadessapeculiari
non possiede abbastanza per
ovviare all’eccesso della
povertà e alla produzione
dellaplebe»36.
È questo paradosso,
inseparabile dalla natura
stessa della società civile
moderna,
a
rendere
necessarie, all’interno stesso
dellasocietàcivile,istituzioni
non di mercato, e anzi aventi
il precipuo scopo di operare
nel senso del bene comune e
della solidarietà. Si tratta
degli istituti che in Hegel
vanno sotto il nome di
«polizia»
e
di
«corporazione»;laprimahail
compito di regolare diversi
aspetti della vita sociale ed
economica sottraendoli alla
loro
accidentalità:
armonizzare gli interessi di
produttori e consumatori,
fissare i prezzi dei beni di
prima necessità, esercitare
sorveglianza sull’educazione,
svolgere per i poveri quelle
funzioni che la famiglia non
puòadempiere.Ancorpiùche
la polizia, la corporazione,
cheriuniscegliappartenentia
un determinato ceto o
professione,èperHegelquasi
una seconda famiglia: nel
senso che, oltre a porre dei
limiti al libero mercato,
ripropone, al livello più
complesso della società
civile, quelle funzioni di
solidarietà che in un
primo tempo erano state
proprie della famiglia (i più
ricchi, ad esempio, hanno
obblighi
verso
la
corporazione,cheintalmodo
puòsoccorrerecolorocheper
accidente sono caduti in
povertà).
Perciò già nella società
civile si pongono, attraverso
il rilievo che viene conferito
ai momenti del bene comune
e della solidarietà, quelle
radici etiche che poi si
dispiegheranno
compiutamente nello stato,
che,
nelle
classiche
definizionidatedaHegel,èla
realtàdell’ideaetica,ilregno
della libertà sostanziale, il
momento in cui l’interesse
universale
si
attua
consapevolmente,
non
sopprimendo gli interessi
particolari,
ma
anzi
accogliendoli in sé e
mediandosiattraversodiessi.
«Lostato-scriveHegelinun
passaggio davvero centrale
della sua riflessione - è la
realtà della libertà concreta:
ma la libertà concreta
consiste nel fatto che
l’individualità personale, e i
di lei particolari interessi
tanto hanno il loro completo
sviluppo e il riconoscimento
del loro diritto per sé (nel
sistemadellafamigliaedella
società civile), quanto che
essi, o trapassano per se
stessi
nell’interesse
dell’universale, o con sapere
e volontà riconoscono il
medesimo e anzi come loro
proprio spirito sostanziale e
sono attivi per il medesimo
come per loro scopo finale,
cosìchenél’universalevalga
e
venga
portato
a
compimento
senza
il
particolareinteresse,saperee
volere,négliindividuivivano
come
persone
private
meramente per l’ultimo, e
non in pari tempo vogliano
nell’universale
e
per
l’universale
e
abbiano
un’attivitàcoscientediquesto
fine. Il principio degli stati
moderni ha questa enorme
forzaeprofondità,dilasciare
il principio della soggettività
compiersi fino all 'estremo
autonomo della particolarità
personale, e in pari tempo di
ricondurre esso nell' unità
sostanzialeecosìdimantener
questainessomedesimo» 37.
La grande forza dello stato
moderno, se lo paragoniamo
all’unitàsostanzialemameno
differenziata dello stato
anticoodellapolis,stainciò:
che in esso per un verso si
afferma il principio cristiano
eborghesedell’infinitovalore
della soggettività, spinto fino
all’estremo
del
perseguimento
autonomo
dell’interesse più particolare,
mentre per altro verso gli
individui riconoscono il loro
necessario
legame
con
l’intero e quindi assumono
consapevolmente l’interesse
generalecomeilloroproprio
interesseescopofinale.Nella
prospettiva hegeliana perciò,
come è stato scritto, «v’era
unalibertàformale,reale,che
eralalibertàdeisingolicome
privati, soggettiva; e sopra di
essa v’era una libertà
sostanziale, pur essa reale,
che era la libertà dei singoli
autocoscienti del proprio
legame col tutto, insieme
oggettivaesoggettiva»38.
L’individuo che, nella
compagine statale, realizza i
suoi interessi particolari,
comprende che il bene del
tuttoèlacondizioneprimaria
della
sua
soggettiva
autorealizzazione, e assume
quindi l’interesse della
generalità come suo proprio
interesse cosciente; e in tal
modo l’interesse dello stato
nons’imponecomeoggettivo
sopra le teste degli individui,
masimediaattraversoilloro
operareconsapevole.
Ma come è possibile che
si attui questa mediazione di
universalitàeparticolarità,se
lasocietàcivileèquelmondo
lacerato e contraddittorio che
lo stesso Hegel ci ha
descritto, in paragrafi la cui
tensione dialettica e critica
non è inferiore a quella che
troveremo in Marx, che
propriosuquestebasicrederà
di dover smentire la
conciliazionehegeliana?
Inrealtàlamediazionedi
universale e particolare è
possibile, in Hegel, perché
già nella stessa società civile
se ne dà la preparazione:
questa è sì il mondo degli
interessi conflittuali e della
polarizzazione di ricchezza e
povertà, ma al tempo stesso
contiene la possibilità di
superare le sue lacerazioni:
sia attraverso gli istituti della
polizia e della corporazione,
sia perché non è un mondo
puramente atomistico, ma è
invece
organicamente
strutturato nell’articolazione
delletreclassioceti(Stände)
che la compongono: il ceto
sostanziale, formato dai
proprietari terrieri, il ceto
industriale, nelle sue varie
articolazioni
artigianale,
manifatturiera, commerciale,
e nella sua organizzazione in
corporazioni; e infine il ceto
generale, cioè quello dei
funzionari dello stato, che ha
comepropriocompitolacura,
appunto, degli interessi
generali.
Lasocietàcivilequindi,al
di là del suo atomismo,
contiene già un’articolazione
organica e armonica dei
diversi interessi. E su questa
basesielevaquell’organismo
compiuto, cerchia di cerchie,
che è lo stato. La struttura
costituzionale dello stato, a
sua volta, si dispiega
nell’articolazione dei tre
poteri che non devono essere
pensati nella logica della
«separazione», ma piuttosto
come
momenti
e
determinazionidiunintero:il
potere
sovrano,
che
costituisce il culmine e il
principio della totalità, che
detiene la decisione ultima e
che compete al monarca
costituzionale; il potere
governativo,
che
deve
eseguire e applicare le
decisioni; e il potere
legislativo,
al
quale
concorrono tanto i due poteri
precedentemente menzionati
quanto l’elemento dei ceti,
nelle sue tre componenti dei
proprietari fondiari, dei
funzionari e della classe
industriale
che
è
la
protagonista della società
civile moderna. Che il potere
legislativo venga da Hegel
strutturato attraverso una
rappresentanzadeicetiedelle
corporazioni è un passaggio
fondamentale per tutta la sua
costruzione, e sul quale non
per caso si incentrerà la
critica
di
Marx.
Nell’elementodeiceti,infatti,
le differenze, organicamente
strutturate,dellasocietàcivile
giungono ad avere un
significato e un’attività
politica. La rappresentanza
cetuale,inaltreparole,nonfa
astrazionedaidiversiinteressi
della società civile come
accade invece nel caso della
rappresentanza universale e
indifferenziata; non separa il
sociale dal politico, e non
distacca quest’ultimo dalla
vita e dagli interessi della
società. Hegel critica la
concezione che, sciogliendo
lediversecerchieecomunità
in una moltitudine di
individui, «tiene appunto
perciò la vita civile e la vita
politica
separate
l’una
dall’altra, e colloca questa,
per così dire, in aria, poiché
la sua base sarebbe soltanto
l’astratta
singolarità
dell’arbitrio e dell’opinione,
quindi l’accidentale, non una
base in sé e per sé stabile e
legittima»39. Che invece i
diversiinteressisiconservino
e si trasvalutino sul terreno
della politica è, nella
prospettiva hegeliana, un
passaggio essenziale per
attuare quella mediazione di
universalità e particolarità
nella quale sta propriamente
la forza dello stato moderno:
la rappresentanza per ceti
costituisce
non
solo
l’elemento che media tra
popolo e governo, ma
soprattutto
la
concreta
possibilità di saldatura tra gli
interessi,
organicamente
articolati in cerehie, che si
fanno valere nella società
civile,euninteressegenerale
al quale essi concorrono
come tali, al di fuori della
finzione della rappresentanza
astratta e proiettata nel cielo
disincarnato della politica.
Nella critica di questa, Hegel
anticipa chiaramente Marx;
mamentreperquest’ultimola
contraddizione tra l’uomo
egoistadellasocietàcivileeil
cittadino astratto e «celeste»
della
politica
è
la
contraddizione stessa della
società borghese moderna,
che può essere superata solo
con
la
trasformazione
rivoluzionaria di questa e
delle sue strutture, per Hegel
le cose non stanno così: la
separazionedisocietàcivilee
stato politico (momenti che
devono permanere nella loro
differenza)
si
concilia
nell'elevarsi della società
civile a società politica
attraverso la rappresentanza
per ceti, e quindi nella
costruzione
di
una
mediazioneorganicatraidue
momenti, necessaria così
come lo è la mediazione
organicatragliinteressidelle
varie
cerchie
che
compongono la società.
Hegel,
dunque,
coglie
l’aporia
della
politica
moderna che anche Marx
collocheràalcentrodellasua
riflessione, ma al tempo
stesso
non
riesce
a
prospettarne una soluzione
che si collochi anch’essa
all’altezzadellamodernità:le
sue
premesse
antiindividualistiche (che lo
portano sempre a privilegiare
il
momento
dell’unità
sostanziale), e perciò non
democratiche, lo portano a
ricercare un superamento
dellarappresentanzamoderna
attraverso istituti «organici»
comeicetielecorporazioni,
che però egli stesso sa
tramontati e che, soprattutto,
vorrebbero
incardinare
l’individuo moderno in
rapporti ai quali esso non si
lasciapiùridurre.
6.Marx:
eguaglianzapoliticae
ineguaglianzasociale.
Dopo una prima fase di
orientamento
piuttosto
liberale,
Marx
viene
elaborando il suo pensiero
politico proprio attraverso
una critica serrata della
Filosofia
del
diritto
hegeliana, e soprattutto del
modoincuiinessasiponeil
rapporto tra società civile e
stato.
NellaprospettivadiMarx,
il punto di maggior
profondità
dell’analisi
hegeliana sta nel fatto che
Hegelhacoltolaseparazione
moderna tra la società civile
(ilterrenosucuiagisconogli
individui con i loro interessi
particolari)elostato(illuogo
dell’interesse universale) in
tutta la sua nettezza; ma il
limite
della
filosofia
hegeliana,
nella
prospettazione che Marx ne
offre, è quello di aver
ricercato una soluzione
illusoria
di
questa
contraddizione,
reintroducendo
all’interno
dellaseparazionemodernatra
società civile e stato politico
elementi di mediazione che
provengono
dall’ordine
antico, premoderno, come ad
esempiolarappresentanzaper
ceti(Stände).
Per Marx invece l’analisi
critica della società moderna
devepartiredallaseparazione
che
strutturalmente
la
caratterizza. La società civile
è il regno degli individui
privati che perseguono, nel
quadro di una economia di
mercato, i loro interessi
particolari: essa è quindi
caratterizzatadall’esistenzadi
ampie diseguaglianze di
denaro, di proprietà, di
cultura, di posizione sociale.
Ma ciò che caratterizza il
moderno è che queste
diseguaglianzedicondizione,
a differenza che nella società
feudale, perdono il loro
significato politico: mentre
nella società feudale la
condizione di servo o di
signore è anche una
condizione politica, nella
società moderna, nata dalla
rivoluzione francese, tutti i
cittadini sono politicamente
eguali, a prescindere dalla
posizione che occupano nella
società,aprescinderesesiano
possidenti o nullatenenti. Le
resistenze contingenti che le
classi proprietarie possono
opporre a questa eguaglianza
politica non tolgono che essa
sia il principio strutturale del
politicomoderno,chesivede
già dispiegato nelle società
borghesipiùsviluppate,come
per esempio quella del
Nordamerica. Ma se è vero
che la Rivoluzione borghese
rende
tutti
eguali
politicamente,comecittadini,
e quindi sopprime il
significato
politico
dell’ineguaglianza sociale,
non meno rilevante è l’altro
latodiquestatrasformazione,
sul quale Marx insiste: la
Rivoluzione borghese non
sopprime
l’ineguaglianza
sociale, ma solo il suo
significatopolitico;essaanzi,
dando luogo a una società
civile e di mercato separata
dallo stato, lascia che
l’ineguaglianza
possa
svilupparsi su questo terreno,
e si limita ad assicurare che
essa venga politicamente
neutralizzata
nella
eguaglianzatraicittadini.Da
quinascequellocheèunodei
problemi fondamentali di
Marx come filosofo politico:
come si deve pensare il
rapporto tra queste due
dimensioni,
cioè
tra
l’ineguaglianzasociale,chesi
dispiega
nella
società
modernaattraversoilmercato
e
il
capitalismo,
e
l’eguaglianzapolitica?
Nel
saggio
Sulla
questione ebraica Marx
affronta questo problema
attraverso un’analisi delle
Dichiarazioni dei diritti
elaborate nel corso della
Rivoluzione francese. In esse
si trova la distinzione tra i
dirittidell’uomo(lasicurezza,
la libertà, la proprietà) che
tutelano appunto i diritti
dell’individuo
privato,
membrodellasocietàcivile,e
i diritti del cittadino, che
concernono
invece
la
partecipazione al potere
pubblico, la libertà politica. I
primi garantiscono l’uomo in
quanto«membrodellasocietà
civile,
cioè
individuo
ripiegatosusestesso,sulsuo
interesse privato e sul suo
arbitrioprivato,eisolatodalla
comunità»40. I secondi
istituiscono una comunità
politica ma solo come una
sfera particolare della società
separatadallealtre,cheastrae
dalla vita concreta degli
individui, dal modo in cui
essi riproducono la loro
esistenza, dal loro lavoro. Lo
statopolitico,quindi,secondo
Marx,
domina
«senza
dominare realmente, cioè
senza
penetrare
materialmente il contenuto
delle restanti sfere non
politiche»41.
Ma torniamo allora a
quella che ci sembra la
domanda di fondo: come si
deve pensare, secondo Marx,
il rapporto tra queste due
sfere ? Se lo si pensa alla
manieraliberale(peresempio
almodo,diConstant)idiritti
politici costituiscono nulla
più che la garanzia degli
intangibili e inviolabili diritti
dell’uomo: ma ciò significa,
nellaprospettivadiMarx,che
l’eguaglianza politica diventa
nient’altro
che
un’uguaglianza illusoria, la
cui funzione è quella di
difendere, e al tempo stesso
mascherare,l’ineguaglianzae
i rapporti di dominio che
regnano nella società civile.
Inessainfattiiproprietaridei
mezzi di produzione, dei
capitali e della terra,
esercitano un vero e proprio
dominio su coloro che,
essendone privi, si trovano
nellaletteraleimpossibilitàdi
riprodurre la propria vita e
quindi sono costretti a
vendere,
riducendosi
a
«merce», la propria forzalavoro, che i capitalisti
acquistano solo in quanto
produca per loro un
plusvalore, cioè se i proletari
lavorano di più di quanto è
necessario per riprodurre gli
strumenti di produzione e i
loro mezzi di sussistenza. Se
si intendono i diritti politici,
in modo classicamente
liberale, solo come una
garanzia dei diritti privati e
dellelibertàdimercato,allora
essi diventano una copertura
illusoria dell’ineguaglianza
reale.
Nelle
prospettive
democratico-radicali però (e
Marx cita a questo proposito
Robespierre) ai diritti politici
si attribuisce un significato
molto
più
ampio:
l’eguaglianza politica diventa
(equestoeraappuntociòche
temeva un liberale come
Constant) una leva per
mettere
in
questione
l’ineguaglianza sociale, per
esempio
attraverso
il
livellamentodelleproprietà,il
riconoscimento del diritto al
lavoro, o misure simili. La
contraddizione
tra
eguaglianza
politica
e
ineguaglianza sociale si
dispiega in questo caso nel
tentativo di adeguare le
condizionisocialialprincipio
della eguale sovranità dei
cittadini, che è incompatibile
con l’esistenza della povertà
e, come aveva insegnato
Rousseau, di una marcata
ineguaglianza dei possessi.
La soluzione democraticogiacobina, però, non è agli
occhidiMarxmenodifettosa
di quella liberale: mentre
quest’ultima
accetta
e
riconosce francamente la
società
ineguale,
il
giacobinismo ne pretende un
superamento illusorio. Lo
stato politico non può
sopprimere le ineguaglianze
della società civile e i
connessi rapporti di dominio
perché esso non è che l’altra
faccia complementare della
societàcivileineguale,sulcui
fondamento riposa: lo stato
politico non può sopprimere
le ineguaglianze della società
civilesenzatoglierealtempo
stesso anche sé medesimo
come stato politico separato.
La
contraddizione
tra
eguaglianza
politica
e
ineguaglianza sociale, perciò,
si può superare solo con
l’eliminazione di entrambi i
termini
contrapposti
e
complementari: e cioè, come
Marx scrive nella sua
giovanile
critica
della
filosofiadeldirittohegeliana,
attraverso una democrazia
integrale che non sia più
soltanto politica, cioè che
instauri la comunità umana a
partiredallivellodellavoroe
della effettiva ri-produzione
della vita, e non solo in un
ambito politico, astratto e
posto
accanto
alle
ineguaglianze reali, contro le
qualinonhanessunpotere.
La rivoluzione come la
pensa
Marx,
dunque,
sopprimel’antitesitrasocietà
civile e stato politico, per
rifondare la comunità umana
a partire dalla libera
associazione dei produttori; e
ciò implica l’estinzione del
potere
politico
come
dimensioneseparatadaquella
in cui si attua l’effettiva riproduzione della vita degli
individui. Le linee di questa
trasformazione
vengono
tracciate da Marx ed Engels
nel Manifesto del partito
comunista
del
1848:
attraverso la conquista della
democrazia, il proletariato si
impadronisce del potere
politico e lo usa come leva
per sopprimere la proprietà
capitalistica dei mezzi di
produzione e quindi le
differenze di classe. Una
volta che queste, dopo una
fase di conflitti e di
«interventi
dispotici»,
saranno superate, e la
produzione sarà tornata nelle
manidegliindividuiassociati,
«il potere pubblico perderà il
carattere politico». Infatti, «il
potere politico, nel senso
proprio della parola, è il
potere organizzato di una
classe per l’oppressione di
un’altra»42; superata la
contrapposizionetraleclassi,
diunpoterepoliticoseparato
dalla società non ci sarà più
bisogno.
Ma se questo è, nelle sue
linee generali, lo schema
teorico,lecosesifannoassai
più complicate quando ci si
inoltrasulterrenodellastoria
effettuale: che rapporto vi è
tralelotteperlademocrazia,
che
si
combattono
nell’Europa del 1848, e in
Francianellaformapiùaspra,
e
il
cammino
della
rivoluzione sociale ? Per
Marx deve trattarsi di un
rapportodistrettasuccessione
e continuità: il proletariato
partecipa alla rivoluzione
democraticaelasostienecon
la sua forza, ma il suo
programma è quello di non
consentire che la rivoluzione
si arresti, bensì di renderla
permanente, proseguendo la
rivoluzionedemocraticanella
rivoluzione sociale. Ben
sapendo che in questo
percorso gli interessi del
proletariato
giungeranno
necessariamente a scontrarsi
con quelli della borghesia,
come ha mostrato la vicenda
del 1848 in Francia, il cui
punto nodale, per Marx, è la
repressionedellainsurrezione
operaia parigina di giugno a
operadelleforzeborghesi.
Mentre la rivoluzione del
1848inFranciasichiude,nel
dicembre del 1851, con il
colpo di stato di Luigi
Bonaparte, alla sua sconfitta
nel 1870, a Sedan, nella
guerra
franco-prussiana,
seguirà un nuovo episodio
insurrezionale, la Comune di
Parigi (1871). Al di là delle
sue scarse possibilità di
successo, la Comune dà a
Marx l’occasione per tornare
a riflettere sulla questione
dello stato politico: in essa
egli vede infatti il modello
abbozzato
di
una
organizzazione politica di
tipo nuovo, che si distingue
dalla
democrazia
rappresentativa
borghese
perchéinessailpotereviene
esercitato o direttamente dal
popolo, a livello locale,
oppure attraverso delegati
che, percependo salari da
operai,
possono
essere
revocatiinqualsiasimomento
esonovincolatiaunmandato
imperativo da parte dei loro
elettori43.
La
Comune
insomma sembra dar corpo
per la prima volta all’idea
marxianapercuilostatodeve
cessare di essere un organo
chegravasullasocietà,conla
suaburocrazia,isuoicostiei
suoiprivilegi,madeveessere
invece
strettamente
subordinato alla società, che
deve organizzarsi quanto più
possibile
nella
forma
dell’autogoverno.
Nel
1875
infine,
discutendo criticamente il
programma elaborato per il
congresso di unificazione
della
socialdemocrazia
(Gotha,
22-27
maggio
I
875)44, Marx precisa un
aspetto ulteriore del suo
modo di intendere la
trasformazione rivoluzionaria
dellasocietà:nellaprimafase
della società collettivista,
fondata
sulla
proprietà
comune dei mezzi di
produzione, la distribuzione
dei beni avverrà secondo il
principio « a ciascuno
secondo il suo lavoro»; nella
fase più matura della società
comunista, invece, dopo che
le forze produttive e la
ricchezzacollettivasisaranno
sviluppate
oltre
ogni
possibilità
oggi
immaginabile, la società
potrà finalmente lasciar
spazio a un principio più
libero e più elevato: «da
ciascuno secondo le sue
capacità,aciascunosecondoi
suoi bisogni». Si giunge con
ciò, non v'è dubbio, a quello
che è il momento più
arditamente utopico del
pensiero di Marx; tuttavia, le
difficoltà maggiori della sua
teoria non derivano forse da
questo eccesso di slancio
utopico, ma da un problema
più strutturale: la sua visione
di una società come libera
associazione dei produttori
implicainfattiunasortadide-
differenziazione rispetto alle
complesse articolazioni di
sferedellasocietàmoderna.E
quindi appare, nonostante il
suo straordinario potenziale
di criticità, incapace di
includere nel suo orizzonte
teorico la dinamica di
crescente
evoluzione,
complessificazione
e
differenziazione che sembra
caratterizzare i processi di
sviluppodellesocietàumane.
L’importanza della teoria di
Marxèdavedersiquindinon
tantonegliesiticuiessamette
capo, quanto nella domanda
difondocheessaconforzae
radicalità pone, e che
concerne appunto il rapporto
tralademocraziapoliticaela
suabaseeconomicaesociale.
1 M. reale, Storia, cultura
e politica. Una rilettura della
‘Cultura francese nell’età
della Restaurazione’ di
Adolfo Omodeo, in «Annali
dell’istituto italiano per gli
studi storici», XI (1989-90),
pp. 535-97, in particolare p.
551.
2 Di cui si veda, per
questo tema, Teoria della
modernità (1990), trad.
it. Editori Riuniti, Roma
1992.
3 L’edizione critica e
completa dei Prìncipi di
Constant è quella di E.
Hofmann, Les «Principes de
politique» de Benjamin
Constant, 2 voli., Droz,
Genève 1980; il primo
volume contiene la tesi di
Hofmann. Le nostre citazioni
sono tratte dall’antologia
curata da s. de luca, Il
pensieropoliticodiConstant,
Laterza, Roma-Bari 1993, p.
117.
4Ibid.,p.124.
5Ibid.,p.127.
6Ibid.,p.139.
7Ibid.,p.140.
8Ibid.,p.144.
9Ibid.,p.145.
10 Discorso sulla libertà
degli antichi paragonata a
quelladeimoderni,trad.it.in
deluca(acuradi),Ilpensiero
politico di Constant cit., p.
188.
11Ibid.,p.192.
12Ibid.,p.194.
13Sulrapportotraledue
libertàinConstantsipossono
ricordare il breve intervento
dicroce(ConstanteJellinek:
intorno alla differenza tra la
libertà degli antichi e quella
dei moderni, in Etica e
politica, cit., pp. 244-250) e
la replica diG. Calogero, La
«libertà degli antichi» e la
«libertà dei moderni». Note
suConstant,inSaggidietica
editeoriadeldiritto,Laterza,
Bari 1947, pp. 56-73, che
vede in Constant la «sintesi
armonica»traiduemomenti.
Perunaietturaequilibratacfr.
il volume di a. zanfarino, La
libertà dei moderni nel
costituzionalismo
di
Benjamin Constant, Giuffrè,
Milano
1961.
Una
interpretazione
del
liberalismo di Constant in
chiave
fortemente
«democratica»èquelladiM.
barberis (Benjamin Constant.
Rivoluzione,
costituzione,
progresso,
Il
Mulino,
Bologna 1988), discussa
criticamente in reale, Storia,
culturaepoliticacit.,pp.564
sgg. e nella utile rassegna di
s. de luca, La riscoperta di
Benjamin Constant (19801993): tra liberalismo e
democrazia,in «La Cultura»,
XXXV(1997),nn.1e2,pp.
145-74e295-324.
14 A. de Tocqueville, La
democrazia in America, trad.
it. Rizzoli, Milano 1999, p.
200.
15Ibid.,p.66.
16
a. M. battista,
Tocqueville. Un tentativo di
sintesi, «Trimestre», XVIII
(1985) n. 3-4, pp. 171-244;
poi ripubblicato in id.. Studi
su Tocqueville, Cet, Firenze
1989.
17 Tocqueville, La
democrazia in America cit.,
pp.260-61.
18Ibid.,p.742.
19Ibid.,p.733.
20Perquestoaspettosi
vedano le pagine dedicate a
Tocqueville nel volume diE.
pulcini, L’individuo senza
passioni.
Individualismo
modernoeperditadellegame
sociale, Bollati Boringhieri,
Torino2001.
21 Tocqueville, La
democraziacit.,p.516.
22Ibid.,p.522.
23Ibid.,p.521.
24
Tocqueville, Discorso
sul diritto al lavoro,
manifestolibri,Roma1996,p.
52.
25j.s.mill, Sulla libertà,
trad. it. Sugarco, Milano
1990,p.32.
26Ibid.,p.34.
27Ibid.,p.41.
28Ibid.,p.85.
29Ibid.,p.99.
30Ibid.,p.128.
31Ibid.,p.168.
32Ibid.,p.156.
33Suquestopuntoinsiste
molto, nella sua lettura
hegeliana, A. honneth, II
dolore
dell’indeterminato.
Una attualizzazione della
filosofia politica di Hegel
(2001),
trad.
it.
manifestolibri,Roma2003.
34 Hegel, Lineamenti di
filosofiadeldirittocit.,§258.
35Ibid.,§199.
36Ibid.,s245.
37Ibid.,§260.
38 G. marini, Libertà
soggettiva e libertà oggettiva
nella 'Filosofia del diritto’
hegeliana,
Bibliopolis,
Napoli1978,p.85.
39Ibid.,§303.
40 K. MARX, Sulla
questione ebraica, in K.
MARXeF.ENGELS,Opere
complete, vol. III, Editori
Riuniti,Roma1976,p.178.
41 K. MARX, Dalla
critica
della
filosofia
hegelianadeldiritto,ibid.,p.
35.
42 κ. Marx e f. ENGELS,
Manifesto del Partito Comunista,
in Opere complete, cit., vol. VI,
EditoriRiuniti,Roma1973,p.506.
43
K. Marx, La guerra
civile in Francia,in K. marx
e f. engels, Opere scelte,
Editori Riuniti, Roma 1966,
pp.908sgg.
44
K. marx, Critica al
programmadiGotha,inmarx
eengels,Operesceltecit.,pp.
951-75.
Parteterza.
Concettieteorie
dellafilosofia
politica
VI.Concettidellateoria
politica
I.Alcune
premesse.
Sesigettaunosguardoad
ampio raggio sul pensiero
politico così come si è
dipanato
nel
mondo
contemporaneo, vediamo che
in esso emergono tre grandi
assi concettuali, ovvero tre
grandi concetti politici:
liberalismo,
democrazia,
socialismo.Èattornoaquesti
tregrandipolichesisviluppa
la vicenda della politica e
della teoria politica ottonovecentesca, ed è questo il
motivo per cui ora vogliamo
fermarciarifletteresudiessi.
Come ha scritto Giovanni
Sartori,
«liberalismo
e
democrazia,
assieme
a
socialismo e comunismo,
sono le etichette che
compendiano la lotta politica
delxixexxsecolo.Diqueste
etichette nessuna è chiara,
ancheselapeggiocapitaèla
prima (liberalismo) e la più
facile da chiarire è l’ultima
(comunismo)»1.
Sarebbe ovvio, a questo
punto, far notare che la lotta
politica nel Novecento ha
avutoanchealtri,piùtemibili
protagonisti: si pensi soltanto
al fascismo e al nazismo. Al
di là di ogni altra
considerazione
possibile,
però, ci limiteremo a
osservare che, per non
occuparcene qui, c’è almeno
una ragione ben chiara:
liberalismo, socialismo e
democraziasonoconcetticon
un forte contenuto normativo
che ancora oggi, con
maggiore o minor successo,
sono
presenti
nella
discussione pubblica delle
società
democratiche.
Altrettanto non può dirsi, per
fortuna, delle ideologie
politiche
della
destra
reazionaria del Novecento,
cheperaltrosoloincasiassai
rari assumono lo statuto di
qualcosa che possa definirsi
filosofia.
Ma perché diciamo che
liberalismo, socialismo e
democraziasonoitreconcetti
politici
fondanti
della
modernità?Perduemotivi:in
primo luogo perché essi si
sviluppanofondamentalmente
a partire dall’epoca delle
rivoluzioni borghesi, e in
secondo
luogo
perché
possonovenircompresicome
letture diverse, e certamente
anche antagonistiche, di
un’unica radice comune, e
cioè del principio moderno
dellaegualelibertà.
Il principio dell’eguale
libertà è quello che sta alla
base
delle
moderne
Dichiarazioni dei diritti. Nel
Bill of Rights della Virginia
(1776), ad esempio, si legge:
«all men are by nature
equally
free
and
independent»; la più famosa
di tutte le enunciazioni dei
diritti, la Dichiarazione dei
diritti dell’uomo e del
cittadino del 1789, recita,
all’articolo primo: «Gli
uomini nascono e rimangono
liberiedegualineidiritti»2.
Alla base della modernità
politica c’è dunque il
principio di eguale libertà,
quella che Etienne Balibar,
nelvolumeLefrontieredella
democrazia, ha chiamato la
proposizione di egaliberté3.
La modernità politica, come
abbiamo visto quando ci
siamooccupatidelparadigma
contrattualista, si fonda
sull’assunto che non vi sono
rapporti di subordinazione
naturale tra gli uomini,
ovvero rapporti di signoria e
servitù.Inquestaprospettiva,
eguaglianza e libertà si
interpretano reciprocamente,
si legano in un nesso che è
costituitoinmodotalepercui
ognunodeiduetermini,sene
vogliamo
esplicitare
il
significato moderno, ha
bisogno di richiamare in
qualche modo l’altro. E
tuttavia, come scrive Balibar,
la proposizione di egaliberté
ècomeunasortadinucleoda
cui si dipartono molte
interpretazioni
possibili,
anche confliggenti tra loro.
Perciò, prima di tracciare un
quadrosinteticodiquelleche
abbiamo individuato come le
grandi teorie politiche della
modernità, è opportuno
soffermarsi
sul
nucleo
generatore dal quale tutte
scaturiscono, e cioè sul
concettodilibertàesullesue
diverseinterpretazioni.
2.Ilconcetto
modernodilibertà.
La tesi di fondo dalla
quale prendiamo le mosse,
comeabbiamogiàaccennato,
ècheliberalismo,democrazia
e socialismo costituiscano i
tre
modi,
tipicamente
moderni, di interpretare
quegli assunti di libertà ed
eguaglianza
che
costituiscono,percosìdire,il
codice
genetico
della
modernità politica. L’analisi
delconcettodilibertà,perciò,
potrebbe anche essere fatta
coincidere
con
la
delineazione delle vicende
che questo concetto ha
conosciuto nel conflitto delle
grandi ideologie politiche
moderne. Prima di procedere
a essa, però, ci sembra
opportuno
fare
alcune
premesse di fondo, quasi
definitorie, onde rendere più
chiara la mappa delle
interpretazioni che, del
concettodilibertà,sonostate
offertenegliultimiduesecoli.
Da un punto di vista
analitico e definitorio, si
possonotracciareinnanzitutto
alcune coordinate di base. In
primo luogo, il concetto di
libertà politica non coincide
certamente con quello di
libertà inteso in senso
metafisico: forse si potrebbe
sostenere che il concetto di
libertà politica presuppone il
concetto,moltocomplesso,di
libertà in senso metafisico
(come
possibilità
di
determinarsi autonomamente
a
compiere
un’azione
libera)4; ma pure i due
concetti
devono
essere
distinti. Il concetto di libertà
politica riguarda infatti il
modo in cui l’uomo è libero
nell’ordine politico e sociale.
Il problema del concetto
politico di libertà è quindi
quello di cosa significhi
essere liberi nel momento in
cui si agisce nel contesto di
rapporti di interazione con
altriuomini,normatidaleggi
giuridiche, morali e da
costumi, e tali comunque da
imporre all’azione di ognuno
diversitipidivincoli.
Nella discussione sul
concetto di libertà, una
fortuna particolare ha goduto
la tesi secondo la quale del
concettopotrebberodarsi,per
così dire, due definizioni
fondamentali,chealorovolta
possono essere pensate o
come definizioni alternative
del concetto di libertà (tali
cioèchesel’unaèveral’altra
è falsa e viceversa) oppure
comechiarificazionidiaspetti
diversidelconcettodilibertà,
nel
senso
che
esso
conterrebbe due momenti,
distinti
ma
entrambi
essenziali per la sua accurata
delineazione. Si allude, come
i lettori avranno già
compreso, alla dicotomia
divenuta ormai classica tra
libertà negativa e libertà
positiva, della quale le più
lucideillustrazionisipossono
ritrovare negli scritti di
Norberto Bobbio e di Isaiah
Berlin5.
La definizione della
libertà che privilegia il senso
negativo del termine viene
formulata,
all’alba
del
pensiero politico moderno,
proprio da Hobbes6: per
Hobbes la libertà consiste
propriamente nell’assenza di
impedimenti esterni che
ostacolino un uomo nel fare
ciò che vuole. Libertà è
dunque, in questo primo e
fondamentale teorico, libertà
negativa:
assenza
di
impedimenti esterni, nonimpedimento.Inquestosenso
dilibertà,l’uomochepagaun
debito per non finire in
prigione, dice Hobbes,
compie un’azione libera,
perché nessun impedimento
fisicoglivietavaditrattenere
perséciòchedovevaadaltri.
Questoprimosensodilibertà
negativa, però, ci riporta in
realtà al concetto di libertà
che abbiamo indicato come
«metafisico»; dal punto di
vista dell’interazione in una
società politica, infatti, non
avrebbe senso dire che io
sono libero di non pagare i
debiti, cioè di fare qualcosa
chelaleggemivieta:ciòche
è proibito dalle leggi è
appunto ciò che (nel senso
politico del termine libertà)
nonsiamoliberidifare.Qual
è allora il senso del concetto
di libertà nell’ambito della
società politica ? Anche a
questopropositolarispostadi
Hobbes è molto chiara:
poiché le leggi regolano
necessariamente una parte
delle azioni dei sudditi e non
latotalità(perchéatalfineci
vorrebbe un numero di leggi
infinito), la libertà sta
nell’agire
a
proprio
piacimento in tutte le cose
che la legge ha volutamente
omessodiregolare,esiattua
per esempio, dice Hobbes,
nella «libertà di comprare, di
vendere, e di fare altri
contrattil’unoconl’altro,edi
sceglierelapropriadimora,il
propriocibo,ilpropriomodo
divita»oilmododieducarei
figli7. Quanto più ampio è
l’ambito delle azioni che la
legge ha omesso di regolare,
tanto maggiore è la libertà
(nonmetafisica,mapoliticae
sociale)degliindividui8.
Nel senso «negativo» del
termine, libertà significa
dunque poter disporre di se
stessi col minimo di
interferenze da parte dei
poteri pubblici o degli altri
individui. I difensori della
libertà negativa, come ha
scritto Berlin, che ne è uno
dei più convinti sostenitori,
non sono interessati al
problema di «chi deve
comandare?», ma a una
questione tutt’affatto diversa:
«in quali ambiti io sono
padrone, e posso agire senza
interferenze da parte di altri
?» Vi è tanto più libertà
negativa,quindi,quantopiùè
estesa l’area in cui gli
individui si governano da
soli, senza dover rispondere
adalcunodelleloroscelte.
I teorici della libertà
positiva, invece, concentrano
la loro riflessione proprio su
quegli aspetti che la
concettualizzazione negativa
della libertà lascia in ombra.
In primo luogo, infatti, essi
pongono l’accento su quella
domanda
che,
nella
prospettiva della libertà
negativa,apparivainsostanza
secondaria:
chi
deve
comandare? Chi deve essere
autore delle norme che sono
comunque indispensabili per
assicurare
l’ordinata
interazione sociale? La più
netta e originaria concezione
della libertà positiva, com’è
noto, è quella di Rousseau:
essereliberisignificanongià
godere degli spazi d’azione
che le norme comunque ci
lasciano, ma, propriamente,
vuol dire essere autori di
quelle stesse norme: non
obbedireadaltreleggisenon
a quelle che noi stessi ci
siamo dati9. È da questo
primo concetto di libertà
positiva che si sviluppa
quindi, palesemente, la teoria
democratica.
Vi sono però anche altri
aspetti che il concetto
negativo di libertà lascia in
ombra. Uno dei più rilevanti
haachefare,perdirlamolto
semplicemente,conlerisorse
e le effettive opportunità. In
questa
prospettiva,
la
domanda che viene posta al
centro dell’attenzione è la
seguente: ha senso affermare
cheiosonoliberodidecidere
i miei pasti, o di comprare e
vendere ciò che voglio, se,
per esempio, non dispongo
deldenarochemiconsentadi
acquistare del cibo, o di
comprare qualsiasi altro bene
? In che senso è libero di
comprarechimanca,difatto,
dellerisorseaciònecessarie?
Si presenta così la possibilità
di formulare un secondo
concetto di libertà positiva,
distinto da quello che
abbiamo indicato per primo:
in questo secondo senso
essere positivamente liberi
significadisporredeimezzie
delle
risorse
che
ci
consentano
di
godere
effettivamente delle libertà
che la legge ci attribuisce, di
non lasciarle sulla carta. È
questo il concetto che
ritroveremo nelle teorie
socialiste.
Il secondo concetto di
libertàpositiva,comesembra
evidente,èpiùproblematicoe
complesso del primo; ma se
ne può distinguere anche un
terzo, che forse è il più
problematico di tutti e che
assomigliamoltoaquelloche
Berlin assume come suo
bersaglio polemico nel
famoso saggio sui Due
concetti di libertà. In questo
terzo senso, essere liberi
significa non solo obbedire a
normechenoistessicisiamo
dati, ma a norme che siano
espressione della nostra
volontà razionale, non di una
mera volontà arbitraria, che
forsepotrebbeanchelasciarsi
guidare da motivazioni
sbagliateoirrazionali.Essere
liberi, in questo senso,
significa obbedire alle norme
della ragione e quindi,
paradossalmente, potrebbe
voler dire anche obbedire a
norme che contraddicono la
nostra empirica, arbitraria e
forse irrazionale volontà. Dal
puntodivistadiquestoterzo
concettodellalibertàpositiva
(che
peraltro
viene
curiosamente
apprezzato,
entro certi limiti, anche da
uno studioso tipicamente
liberale come John Gray)10
non
è
contraddittorio
affermare,conRousseau,che
qualcuno
può
essere
«costretto»aesserelibero.
Una volta che si siano
così delineati, per quanto in
modosommario,alcunimodi
possibili di intendere la
libertà,siapreallariflessione
unasceltatradiverseopzioni
possibili: per un verso si può
andare, più o meno
decisamente, nella direzione
dì affermare che il «vero»
concettodilibertàèunosolo,
e
quindi
mostrare
l’inconsistenzaol’incoerenza
di quelli che al concetto
preferito si oppongono
(questa era, a mio giudizio,
l’intenzione originaria di
Berlin, poi in qualche modo
corretta in seguito). In
alternativa, si può assumere
questapolisemiadelconcetto
di libertà come punto di
partenza per una riflessione
cheleggalalibertàcomeuna
realtà multidimensionale, a
piùfacce,tutterilevantianche
se
non
egualmente
importanti, perché alcune di
questefaccecostituisconoper
così dire dei territori di
confine, dove la riflessione
sulla libertà diventa più
problematica, rischiosa e
incerta. Senza entrare qui nel
vivo di simili analisi, che
peraltro torneranno in modo
più
concreto
quando
esamineremoilliberalismo,il
socialismo e la democrazia,
mi pare che si debba però
formulare
almeno
una
considerazione.
La distinzione più solida
concettualmente (cioè quella
tralibertànegativacomenonimpedimento
e
libertà
positivacomeobbedienzaalle
leggi che noi stessi ci siamo
dati) si può rendere ancora
più chiara se, andando oltre
l’ideanondeltuttoperspicua
del non-impedimento, la si
formula così: la libertà
negativa richiede che sia
ampio lo spazio che le leggi
lasciano agli individui per
decidere da soli; la libertà
positiva richiede che, delle
leggi, gli individui siano
autori, cioè richiede che
almenounaseriediquestioni
fondamentali siano decise
dalla collettività dei cittadini.
La libertà negativa vuole
massimizzare l'ambito delle
decisioni private, la libertà
positiva rivendica decisioni
collettive. Se le cose stanno
così, però, la partita tra i
sostenitorideidueconcettidi
libertà antagonisti sembra
prospettarsi
nel
modo
seguente.
In primo luogo, pare
difficile
negare
che
l’autolegislazione
democratica accresca la
libertà degli individui; essa
infatti non toglie la libertà di
cui essi godono nell’ambito
incuileleggitacciono,mane
attribuisce loro un’altra
aggiuntiva, quella appunto di
concorrere
alla
determinazionedelleleggi.
In secondo luogo, però, i
sostenitori della libertà
negativa potrebbero ribattere
che
nessuno
vorrebbe
appartenere a una collettività
democraticadilegislatori,che
legiferasse però anche sugli
aspetti più minuti o privati
della vita dell’individuo:
sarebbe difficile parlare di
libertà ove le decisioni
collettivepotesseroesercitarsi
inogniambitoesenzalimiti.
Senzanegarelavaliditàdi
questo punto, i sostenitori
della
libertà
positiva
potrebbero ancora ribattere:
ammesso che si debba porre
un limite agli ambiti che le
decisioni collettive possono
regolare, chi avrebbe la
competenza a fissarlo ? Non
dovrebbero essere i cittadini
stessi, e non sarebbe quindi
esso, ancora una volta, il
fruttodidecisionicollettive?
E ciò non implica, allora,
riconoscere di nuovo il
primato alla libertà positiva,
intesa come autolegislazione,
rispettoallalibertànegativa?
La disputa potrebbe
continuare; ma per ora ci
basta mettere in evidenza il
punto che fin qui si è
acquisito:
difficilmente
sostenibile ci sembra la
pretesadiprendereunaspetto
del concetto di libertà e
identificarlo con la «vera»
interpretazione del concetto
stesso. Più plausibile appare
allora l’idea che il compito
dellateoriapoliticasiaquello
di costruire una visione che
del concetto di libertà catturi
il più possibile gli aspetti
diversi;nellaconsapevolezza,
però, che non si tratta per
nientediuncompitoscontato,
perché le diverse dimensioni
della libertà possono anche
essere tra loro conflittuali, e
quindi non è detto che
possano essere tenute tutte
insieme in un orizzonte
coerente. Il confronto e lo
scontro tra le ideologie
politiche negli ultimi due
secoli, peraltro, può essere
proprio letto come un
confronto tra interpretazioni
in conflitto della libertà, ed è
a partire da questa chiave di
lettura
che
ora
ne
descriveremoalcunitrattiche
cipaionoessenziali.
3.Liberalismo.
Sebbene se ne faccia
continuamente
uso
(soprattutto in tempi recenti,
neiqualiilconcettoètornato
ampiamente in auge) il
concetto di liberalismo è uno
dei
più
difficili
da
determinare o definire con
una qualche pretesa di
univocità. Anche all’epoca
delsuotrionfoilliberalismo-
ha scritto Harold Laski - non
fu mai «un complesso
organico di dottrine e di
esperienze»; al suo sviluppo
hanno contribuito «correnti
dottrinali così diverse nelle
loro origini da rendere la
chiarezza difficile e la
precisione
forse
irraggiungibile»11.
Di
liberalismi ve ne sono
un’infinitàditipi(quindicine
indicava
Sebastiano
Maffettone in una pagina
introduttiva a un suo studio
sull’argomento)12, ricondurli
a un minimo denominatore
concettuale pare impresa
difficilissima, e sembra già
molto affermare, riprendendo
una
fortunata
idea
wittgensteiniana,chetraivari
liberalismi sono riscontrabili
tutt’al più alcune vaghe
«somiglianzedifamiglia».
Se però del concetto
vogliamo
continuare
a
servirci (e pare che non sia
così facile farne a meno), il
tentativo di determinarne il
significato non sembra si
possa eludere13. Anche se è
certamente impervio, perché,
già sul piano puramente
lessicale, la situazione è più
ingarbugliata di quanto non
accada per altri concetti
politici.
Una prima questione che
sipone,anchesolodalpunto
divistalessicale,èquellache
concerne la distinzione o
la identità di significato tra
liberalismo e liberismo. Si
tratta, com’è noto, di una
distinzione che appartiene
soloallalinguaitalianaeche
nonhadegliesattiequivalenti
nelle altre lingue, e la cui
importanza fu rivendicata
soprattutto da Benedetto
Croce in una famosa
discussione con l’economista
liberale e liberista Luigi
Einaudi14. La tesi di Croce a
questo proposito era molto
chiara: mentre il liberismo è
una dottrina che si situa sul
terreno economico, per
affermare le virtù del libero
scambio e criticare i limiti
che a esso si vogliano
imporre, il liberalismo si
collocasuunterrenodiverso,
etico e politico, e perciò,
diceva Croce, è teoricamente
compatibile anche con una
visione non liberista, ma
persino
socialista,
dell’economia15.
La
questione della legittimità o
meno della distinzione,
quindi, non è certo soltanto
una questione lessicale: anzi,
mette in risalto quello che
resta comunque (anche a
prescindere dalla peculiare
concezione del liberalismo
che di Croce era propria)16
unodeiproblemidifondoper
chi voglia tentare una
chiarificazione
del
liberalismo: in che misura
una scelta liberale implica
una presa di posizione a
favoredellaproprietàprivata,
della sua libera disponibilità,
e della libertà di scambiare
sul mercato i propri beni e il
propriolavoro?
Delicatiproblemilessicali
nasconoanchesecivolgiamo
aun’areaculturalediversada
quella italiana, e cioè agli
Stati Uniti. Qui l’aggettivo
liberalindicaunavisionedel
liberalismo molto diversa da
quellachepotremmoindicare
come liberalismo classico,
tradizionale o liberista. Vi
sono
perciò
studiosi
contemporanei
che
si
spingono fino al punto di
affermare che i liberals
americani sono altra cosa
rispetto
alla
tradizione
liberale: Sartori scrive che
sono i socialisti di un paese
senza socialismo17; per
Cubeddu,tradurreliberalcon
liberale significa dar luogo a
un colossale equivoco18,
perché il pensiero liberal,
sebbeneaccolgaalcunivalori
del liberalismo19, appartiene
in sostanza a un filone
diverso,
di
matrice
democratica e sociale, che in
Europa
si
definirebbe
socialdemocratico. I liberals
perciò, secondo Cubeddu,
non possono ascriversi al
liberalismo come lui lo
intende;inunpensieroliberal
come quello di Rawls, per
esempio, viene teorizzato un
diritto alla giusta ripartizione
deibenisocialiprincipali,che
implica necessariamente uno
stato interventista e quindi
sembra contraddire alcuni
principi del liberalismo
classico.
All’estremo
opposto
rispetto ai liberals si colloca
invece quello che negli Stati
Uniti
viene
chiamato
libertarianism (che somiglia
moltoaquellocheinitaliano
definiamo liberismo, mentre
libertario in italiano ci fa
pensare più ad anarchico), e
che in sostanza è una teoria
dello stato minimo (come
quella avanzata da Robert
Nozick)otendenteazero.La
radicalizzazione estrema di
questa posizione è il
cosiddetto
anarcocapitalismo, che difende le
libertà di mercato ma è
convinto che si possano
anche mercatizzare tutte le
principali funzioni svolte
dallostato20.
Anche dal punto di vista
lessicale, quindi, la questione
diidentificareilnucleodiciò
che chiamiano liberalismo
appare non poco complicata.
Certamente, i sostenitori di
alcune visioni specifiche del
liberalismo possono essere
inclini a espungere, dal
liberalismo,
quelli
che
difendono
interpretazioni
polarmente opposte. Ma allo
studioso che, in queste
dispute, si pone nella
posizione dello spettatore,
sembra più produttiva l’idea
di assumere, grosso modo,
come liberali tutte le
posizioni
che
si
autodefiniscono tali, per
indagare quali siano le
caratteristiche a esse comuni,
e quindi per strutturare
concettualmente
quelle
somiglianzedifamigliachea
primavistaappaionovaghee
confuse.
Una buona proposta di
chiarificazione
della
questione, a mio avviso, si
può formulare seguendo
alcune linee guida piuttosto
semplici. In primo luogo il
concetto di liberalismo può
esserechiaritoperdifferenza:
ciò
che
mi
sembra
accomunare
le
molte
posizioni liberali, al di là
delle profonde differenze che
tra di esse intercorrono, è il
conferire
maggiore
importanzaaidirittidicuigli
individui devono godere,
dando invece minor rilievo
alla loro partecipazione ai
processi
di
decisione
collettiva e di autogoverno.
Un
primo
punto
di
chiarificazione,
dunque,
consiste a mio avviso nel
distinguere le posizioni
liberali
da
quelle
democratiche: mentre per
queste ultime hanno rilievo
primario
i
diritti
all’autogoverno, per le
posizioni liberali il rapporto
si inverte, e i diritti
all’autogoverno o sono
decisamente svalutati (come
in
Hayek)
oppure
costituiscono semplicemente
un aspetto, in nessun caso
primario, del più ampio
pacchetto di diritti che la
comunità politica deve
garantireagliindividui.
Comune a tutte le
posizioni liberali, dunque, è
l’idea che la funzione
fondamentale dello stato sia
quella di garantire i diritti
degli individui che, anche
quandononsonodecisamente
ancoratiinunaleggenaturale
o razionale, anche quando
non preesistono allo stato,
hanno però un primato
rispetto alle scelte della
politica e alle decisioni della
democrazia:
costituiscono
quindi,fondamentalmente,un
limite della politica e un
vincolo che le decisioni
democratiche
devono
comunque rispettare. Gli
aspetti invece in forza dei
quali le posizioni liberali si
diversificano sono a mio
avviso
fondamentalmente
due,moltointrecciatitraloro:
la
valutazione
della
democrazia e quella della
giustizia economico-sociale.
Perciò, fermo restando il
primato e la centralità dei
diritti, vi sono posizioni
liberali(èilcasoperesempio
di Hayek e di Gray) che
ritengono che una società
liberapossaformarsianchein
assenza di democrazia, e che
vedono quindi quest’ultima
più come una minaccia che
come una garanzia di tutela
delle libertà; mentre ve ne
sono altre (si pensi a Rawls)
che
invece
accolgono
pienamente la democrazia
lasciando da parte le riserve
«liberali»controdiessa.
Una analoga polarità si
registra per quanto attiene al
giù-dizio
sugli
assetti
economico-sociali: a un
estremo si collocano coloro
che, come Hayek o Nozick,
ritengonocheladistribuzione
più giusta della ricchezza sia
quella che risulta dalla
competizione regolata dei
soggetti
sul
mercato;
all’estremooppostosisituano
invece coloro che pensano
che, tra i diritti che debbono
essereassicuratiatutti,visia
anchequellodigodere,inuna
misura
più
o
meno
egualitaria,dell’accessoaipiù
importantibenisociali.
Se guardiamo allo spettro
di posizioni che così si viene
delineando, possiamo anche
osservarecheidueprincipali
criteri di distinzione spesso
tendono a coincidere: coloro
chehannomenofiducianella
democrazia, sono anche
coloro che credono più
decisamenteinunasocietàdi
mercato; quelli che hanno
meno riserve nei confronti
dellademocrazia,spessosono
anche gli stessi che
considerano irrinunciabili i
diritti di giusta ripartizione
sociale. Tuttavia, non è
necessariochesiacosì:come
fa notare un liberale
radicalmenteegualitariocome
Philippe
Van
Parijs,
affermare ampi diritti di
giustizia sociale potrebbe
anche richiedere di porre
stretti limiti alla democrazia,
perché le decisioni della
maggioranza
democratica
potrebbero non risultare
favorevoliaquestidiritti21.
Sullabasediquesteprime
considerazioni,cisembrache
si possa addivenire, in
materia di definizione del
liberalismo, al seguente
risultato.
Appartengono
sostanzialmente
al
liberalismo tutte quelle
posizioni che condividono la
tesi del primato e della
centralità dei diritti, visti
comelimitiaciòchelostato
o la democrazia possono
imporre ai cittadini; la
differenziazione dei molti
liberalismi
è
generata
soprattuto da due fattori, e
cioè dall’attitudine più o
meno aperta nei confronti
della democrazia e dal modo
in cui si interpretano i diritti
economici e sociali. Per
quest’ultimo
aspetto,
troviamoaunestremocoloro
che difendono la inviolabilità
dei diritti di proprietà e la
legittimità
delle
sole
transazioni di mercato,
all’altro coloro che invece
ritengono che, tra i diritti
irrinunciabili, vi sia quello a
una certa quota di beni
sociali, da garantirsi a tutti
anche a scapito dei più
possidenti.Tragliestremidel
liberalismo proprietario e del
liberalismo socialista vi sono
naturalmente
moltissime
posizioni intermedie. Ma è
importante sottolineare che
ancheilliberalismosocialista
ed egualitario (si pensi per
esempio a Van Parijs) resta secondo la schematizzazione
che noi proponiamo liberalismo, perché, appunto,
considera il diritto a
determinati beni o dotazioni
comeundirittofondamentale
di libertà, che dovrebbe
prevalereinlineadiprincipio
sulledecisionidemocratiche.
Come
abbiamo
cominciato a mostrare, ciò
che caratterizza, dal nostro
punto di vista, un approccio
definibile come liberale, è il
porre a fondamento della
convivenza sociale individui
dotati di diritti: diritti che
vengono considerati innati,
inalienabili o inviolabili nel
senso che gli individui non
potrebbero rinunciare a essi
neancheselovolessero,eche
le leggi pubbliche devono
assumere come un limite
invalicabile. Il principale
tratto
caratteristico
del
liberalismo è appunto la
convinzione che il fine delle
leggi pubbliche sia quello di
tutelare i diritti indisponibili
degli individui, cioè di
assicurare a essi una sfera
protettadalleintrusionisiada
parte di altri individui sia da
partedeipoteripubblici.
Comescriveunpensatore
che esprime il punto di vista
liberale in modo davvero
classico, Benjamin Constant,
vi è «una parte dell’esistenza
umana
che
resta
necessariamenteindividualee
indipendente, e che è, di
diritto, fuori da ogni
competenza sociale. La
sovranità non esiste che in
maniera limitata e relativa.
Dove inizia l’indipendenza
dell’esistenza individuale, là
si arresta la giurisdizione di
questasovranità»22.
Gli individui, pertanto,
sono
considerati,
nella
prospettivaliberale,comedei
portatori di diritti dei quali il
corpo politico non può
disporre, e che deve limitarsi
atutelare.
ComesileggegiànelBill
of Rights della Virginia
(1776), gli individui hanno
«diritti innati» di cui non
potrebbero privarsi neanche
selovolessero;equestidiritti
comportano, «il godimento
della vita, della libertà,
mediante l’acquisto e il
possesso della proprietà, e il
perseguireeottenerefelicitàe
sicurezza»23.
Nel liberalismo quindi la
società
politica
nasce
(lockianamente)
per
confermare e assicurare i
diritti
imprescrittibili
dell’individuo: libertà della
persona,libertàdireligionee
dipensiero,libertàdidisporre
delpropriolavoroedeipropri
averi. Come si legge ancora
nella
Costituzione
rivoluzionaria francese del
1793, «il governo è istituito
per garantire all’uomo il
godimento dei suoi diritti
naturali e imprescrittibili.
Questi
diritti
sono
l’uguaglianza, la libertà, la
sicurezza,laproprietà»24.
Ma la salvaguardia dei
diritti degli individui esige
che vengano posti dei ben
precisi limiti all’esercizio del
potere politico sovrano: il
sovrano non può essere più
pensatocomecoluichestaal
di sopra delle leggi, che è
legibus solutus·, al contrario,
nello stato di diritto,
l’esercizio del potere deve
essere
rigorosamente
sottoposto alla legge così
come
lo
sono
i
comportamenti di ogni
cittadino. L’illimitata e
assolutasovranitàhobbesiana
dev’essere
domata
e
ricondottaentroprecisilimiti,
altrimenti la società politica
mancherebbe il suo scopo,
perché l’individuo non
potrebbe dirsi in alcun modo
sicuro dei suoi diritti. Nella
tradizione del liberalismo,
pertanto, la teoria dei diritti
inalienabili si sposa con
quella dello stato a poteri
limitati: «Garanzia dei diritti
e controllo dei poteri sono i
due tratti caratteristici dello
stato liberale» 25. E la
garanzia del fatto che il
potere sovrano non si
trasformiinpoteredispoticoè
data fondamentalmente dalla
divisione dei poteri, la cui
teorizzazione si trova già in
Locke, ma poi soprattutto in
Montesquieu
e
nel
costituzionalismo successivo,
che deriva in buona misura
dalle
riflessioni
sulla
divisione dei poteri nella
costituzione
inglese
sviluppate nell’XI libro dello
Esprit des Lois. Nella
costituzione
federale
americana del 1787 si trova
appunto realizzato un assetto
costituzionale in cui tutti i
diversi poteri, « tutti
intrinsecamente
limitati»,
sono «disposti in modo che
possano
e
debbano
reciprocamente
frenarsi,
utilizzando le tecniche del
bilanciamento
che
la
tradizione inglese ancora
mettevaadisposizione»24.
Accanto alla tesi del
primato dei diritti individuali
e a quella che il potere
pubblicodev’esserelimitatoe
diviso, affinché nessuno ne
possa disporre in modo
arbitrario e incontrollato
(mettendo così a repentaglio
quei diritti che sono il primo
bene da salvaguardare), vi
sonopoiunaseriedialtretesi
che si dispongono attorno a
questo nocciolo duro del
pensiero liberale, e che
vengono
variamente
argomentate, come abbiamo
visto, dai pensatori che nella
linealiberalesiiscrivono.
Fondamentale è il rifiuto
di misurare la bontà di un
ordine politico a partire da
unaconcezionesostantivadel
bene comune: da questo
punto di vista i grandi
capiscuola del liberalismo
sonocoloroche,comeKante
Mill, argomentano contro
ogni forma di paternalismo
politico(anchesenontuttele
concezioni sostantive sono
necessariamentepaternaliste),
difendendo l’idea che ogni
individuo ha il diritto di
cercare il suo bene o la sua
felicità dove meglio crede, e
che in ciò non deve essere
impedito da un’autorità
politica che pretenda di
insegnargliqualèilsuovero
bene.
Nel
liberalismo
contemporaneo, come per
esempio quello di Rawls,
questo
principio
viene
riformulatoneiterminidiuna
«prioritàdelgiustosulbene».
Da ciò consegue più o
meno direttamente l’idea,
nata
sul
terreno
dell’economia di mercato,
che la competizione tra
individui non sia un aspetto
criticabile della società
individualistica, di cui una
società migliore potrebbe
liberarsi, ma invece un modo
straordinariamente efficace
persvilupparealmeglioiloro
talenti e le loro capacità,
generando benefici non solo
per coloro che nella
competizione
risultano
più capaci ma, di riflesso,
ancheperl’interasocietà,che
in modo più o meno mediato
viene a goderne i frutti.
All’idea di competizione si
accompagna spesso, nel
pensieroliberale,quellacheè
il
suo
necessario
complemento,
e
cioè
l’eguaglianza
delle
opportunità, che a sua volta
può essere intesa in molti
modi diversi, più o meno
esigenti.
A questi temi si affianca
inoltre, in molte visioni
liberali, la concezione dello
stato come una sorta di male
necessario: esso implica
infatti, in ogni caso, che
l’individuo debba obbedire a
un potere estraneo; ma, se
questo è vero, l’autorità e le
competenze dello stato
devonoesserelimitatequanto
piùpossibile,ridotteaciòche
risulta
davvero
indispensabile, in modo che
sia minimizzata l’area in cui
l’individuo non è padrone di
se stesso. A questo tema si
aggiunge talvolta, in alcune
versioni del liberalismo,
l’idea che la partecipazione
politica non è un bene in sé,
ma ha il suo valore
nell’essere strumento per
garantire e conservare le
fondamentalilibertàprivate.
Dal nostro sguardo sulla
galassia dei liberalismi ci
sembra,perciò,dipotertrarre
la seguente conclusione: vi è
un nucleo formato da alcune
tesidifondo,comeilprimato
dei diritti individuali, la
limitazione
del
potere
pubblico, il rifiuto dell’idea
sostantiva di bene comune e
delpaternalismopolitico,che
funziona come una cartina di
tornasole e ci dà un criterio
per collocare una teoria
dentroofuoridall’ambitodel
liberalismo. Vi sono poi una
seriedialtretesichesonoun
po’ periferiche rispetto a
questo nucleo e che possono
essereononesserepresentiin
posizioni che si definiscono
liberali. E vi sono infine altri
temi, come quello del ruolo
da attribuirsi alla libertà di
mercato o (dalla parte
opposta) all’eguaglianza di
risorseodibeniprimari,dove
iliberalismi,senzacessaredi
essere tali, si divaricano
radicalmente, cosicché a un
estremo possiamo trovare il
«liberalismo proprietario» di
un Hayek o di un Nozick, e
all’altro
estremo
il
liberalsocialismo
di
Hobhouse, di Rosselli, di
Calogero”,einuncertosenso
anche del Rawls di Teoria
dellagiustizia.
4.Socialismo.
Non meno ambiguo e
sfuggente del concetto di
liberalismo è quello di
socialismo28:enondaultimo
perché,selosivuolecogliere
nei suoi lineamenti più
essenziali,bisognainqualche
modo allargare la visuale
oltrelastraordinariainfluenza
storica che in questo campo
ha avuto il marxismo: il
socialismo, infatti, ha una
lunga storia prima del
marxismoedopodiessoe,se
lo vogliamo mettere a fuoco
come concetto politico, è il
suo nucleo essenziale, o
addirittura comune, che
dobbiamotentaredicogliere.
Non si va fuori strada, io
credo, se si afferma che il
nucleo
generatore
del
socialismo
è
fondamentalmente di tipo
negativo o critico: il
socialismo
«allo
stato
nascente», le cui prime
manifestazioni incontriamo
giànell’etàdeiLumi,oanche
più indietro, è una critica di
ispirazionefondamentalmente
moraledellaproprietàprivata
e della ineguaglianza sociale
che a essa si accompagna. Il
socialismo è quindi una
negazione dell’ineguaglianza
sociale,unaprotestacontrodi
essa e la sua illegittimità, e
contro le sue manifestazioni
antropologiche
(egoismo,
rapacità, accumulazione) in
vistadellacostituzionediuna
società più giusta e più
eguale, che molti socialisti
cercano di progettare o
descrivere meritandosi così,
da parte di Marx, il
rimproverodiutopismo.
Se si considerano le
ideologie socialiste allo stato
nascente, non vi è una
fondamentale differenza tra
socialismo e comunismo; vi
sono piuttosto alcuni principi
di fondo, che cominciano a
esseredefinitieprecisatinelle
correnti più radicali ed
egualitarie della Rivoluzione
francese, come quella che fa
capoaGraccoBabeuf.Questi
principi di fondo si riducono
in sostanza a poche tesi
basilari. Per dirla con le
parole di Filippo Buonarroti,
nella sua Congiura per
l'eguaglianza, «la natura ha
dato a ogni uomo un diritto
ugualealgodimentodituttii
beni».
«Lo
scopo
della società è di difendere
questa eguaglianza» 29. Il
punto di partenza del
socialismo, quindi, è che,
radicalizzando le tesi della
Rivoluzione
francese,
l’affermazione che tutti gli
uominisonoegualineidiritti
vaintesanelsensopiùampio,
coerenteecomprensivo:eciò
vuol dire non solo nei diritti
di libertà e nei diritti politici,
ma anche nel diritto di
accedereaibenieallerisorse.
Segliuominisonoegualinei
diritti,aessiappartieneapari
titolo il diritto di godere dei
beni naturali e dei benefici
della cooperazione sociale,
alla sola condizione che non
facciano mancare ad essa il
loro apporto. Questi principi
vengono esposti, nei primi
decenni dell’Ottocento, da
scrittoripoliticidiispirazione
babuvista e buonarrotiana.
Nella Dichiarazione dei
diritti dell’uomo e del
cittadino redatta nel 1832 da
Albert Laponneraye, per
esempio, si legge: «I diritti
principali dell’uomo sono
quelli di provvedere alla
conservazione dell’esistenza
edellalibertà».«Questidiritti
appartengono egualmente a
tuttigliuomini,qualunquesia
la diversità delle loro forze
fisicheemorali».«Lasocietà
ha l’obbligo di provvedere
alla sussistenza di tutti i suoi
membri»30.Glistessiconcetti
si ritrovano nell’opera sulla
questione sociale scritta nel
1840 dal babuvista JeanJacques Pillot: «Essendo
l’umanità formata da esseri
assolutamente identici, non
può ammettere nel suo
ambitonépriminéultimi,né
grandi né piccoli, né potenti
né deboli, né orgogliosi né
umili...Lasocietàhaquindiil
compito di dare ad ogni
membrolamaggiorequantità
possibile
di
benessere,
assicurandoglil’appagamento
delle sue vere necessità; e in
cambio di questo beneficio
ognuno deve usare, per la
società,tuttelesuefacoltàper
ilbenessereditutti»31.
Dal punto di vista
socialista, perciò, talenti e
capacitànoncostituisconoun
titolo per appropriarsi di una
quota maggiore di beni o di
risorse;comescriveCabetnel
Viaggio in Icaria (1840), «il
talento e il genio sono i
risultati
dell’educazione
impartita dalla società, e ...
l’uomoditalentononsarebbe
nulla senza la società»32.
SullastessalineaProudhonin
Che cos’è la proprietà: «il
talento è una creazione della
societàassaipiùcheundono
della natura; è un capitale
accumulato e colui che lo
riceve non è che il
depositario» 33. Ciò che
caratterizza il socialismo,
quindi, è una visione
cooperativaesolidaristicadel
rapporto sociale: poiché
l’individuo, con i suoi talenti
e con le sue capacità, è in
buona misura un risultato
della cooperazione sociale,
alla quale è per molti versi
debitore, allora egli non può
accampare un diritto assoluto
su ciò che produce col suo
lavorooilsuotalento,maha
dei doveri nei confronti della
società, così come ha dei
diritti verso di essa: la ripartizione dei frutti della
cooperazione sociale, perciò,
deve ispirarsi a principi
solidaristici, e primariamente
al principio di distribuire
secondo i bisogni, come se
tutti avessero reciprocamente
sottoscritto, per dirla con le
parole del protocomunista
Cabet, «una assicurazione
generaleemutuacontroogni
accidenteeogniavversità»34.
Alla base del socialismo
vi sono dunque un’idea forte
della cooperazione sociale e
unavisionesolidaristicadella
giustizia e della libertà degli
uomini.Essoriposaperciòsu
assunti di tipo etico o
normativo che, a ben
guardare,
si
possono
rintracciare anche in una
teoria, come quella di Marx
35,che,secisiattienealsuo
dettato esplicito, non sembra
voler intrattenere nessun
rapporto con l’etica o con le
concezionidellagiustizia.
Ma come è possibile
tradurre questa ispirazione di
fondoinunastrutturasociale
nuova,chesuperil’ingiustizia
e l’ineguaglianza che sempre
hannoregnatotragliuomini?
Nei socialisti dell’epoca
premarxiana troviamo, a
questo proposito, alcune
indicazioni
di
fondo
largamente comuni: essi
propongonol’abolizionedella
proprietà privata e la
generalizzazionedeldirittoal
lavoro, la pianificazione
coordinata della vita sociale
ed
economica
e
il
superamentodell’anarchiadel
mercato, che dovrebbe
accompagnarsi, sul piano
antropologico,
a
un
progressivo
superamento
dell’egoismo e della pulsione
rapaceversoilguadagno,che
dovrebbero lasciare sempre
più spazio a un solidale
sentimento di comunità e di
fraternità.
Pretendendodidistaccarsi
completamente dalle scuole
socialiste che li hanno
precedutiMarxedEngels,nel
Manifesto
del
Partito
Comunista, rivolgono a esse
il rimprovero di utopismo.
Tuttavia,
per
quante
resistenze mostrasse su
questo punto, anche Marx
non può fare a meno di
delineareinmodonontroppo
lontano dai suoi predecessori
quelle che dovrebbero essere
le istituzioni portanti di una
società giusta al di là del
capitalismo: essa richiede la
socializzazione
o
statalizzazione dei grandi
mezzi di produzione e di
scambio, e la sostituzione
dell’anarchiadelmercatocon
la produzione pianificata,
cioè
in
sostanza
la
collettivizzazione
dell’economia. Non sta qui,
dunque,ilpuntodifondoche
segna il distacco di Marx
dall’utopismo: sta piuttosto
nel fatto che Marx prova a
mostrare come si possa
giungere a una società giusta
oltre il capitalismo; e quindi,
non dando importanza a
quelle che considerava futili
ricette per la cucina
dell’avvenire, si concentra
sullo studio scientifico del
capitalismo,
delle
sue
dinamiche e delle sue
contraddizioni; perché una
prospettiva di superamento
può aprirsi solo attraverso di
esse, e non restando
nell’ambito di mere istanze
morali.
Marx approfondisce la
riflessione sul tema del
socialismo nelle note critiche
che scrive, nel 1875, a
commento del progetto di
programma che era stato
preparato per il congresso di
unificazione
della
socialdemocrazia
tedesca.
Qui Marx intende con
socialismo(ovveroconprima
fase della società comunista)
una società collettivistica
basatasullaproprietàcomune
deimezzidiproduzioneesul
principio«aciascunosecondo
ilsuolavoro»;eloconsidera
come
una
forma
di
cooperazione sociale ancora
difettiva che verrà superata,
nella fase più elevata e ricca
delcomunismo,daunaforma
di cooperazione basata sul
superiore principio: «Ognuno
secondo le sue capacità; a
ognuno secondo i suoi
bisogni»36.
Con il «revisionismo»,
chesisviluppagrossomodoa
partire da quando, nel 1899,
EduardBernsteinraccogliein
volumealcunisuoiscritticon
il titolo I presupposti del
socialismo e i compiti della
37,
socialdemocrazia
l’opzione socialista viene
nuovamente presentata nella
chiavediunatensioneeticadi
ispirazione kantiana, e nella
prospettiva di uno sviluppo
gradualista: il socialismo
«revisionista» si caratterizza
per una serie di opzioni:
rifiuto
dell’idea
della
rivoluzione
come
atto
violento e «puntuale» (sulla
scorta di quanto aveva già
sostenuto l’ultimo Engels
nellaPrefazionedel1895alle
Lotte di classe in Francia di
Marx); identificazione del
socialismo con il progresso
deilavoratorinelquadrodella
democrazia; rifiuto di una
letturaestremista,manicheao
catastrofista della società e
dell’economiaafavorediuna
lettura più duttile, che
riconosce le potenzialità di
sviluppo del capitalismo, il
ruolodelleclassimedieedei
contadini, la crescita dei
consumi, l’espansione del
capitalismo con l’azionariato
diffuso
ecc.;
grande
importanzaattribuitanonsolo
al movimento cooperativo,
ma anche allo sviluppo della
democrazia amministrativa,
municipale e locale, e alla
crescita dei servizi sociali
(istruzione, sanità ecc.);
trasposizione
del
fine
socialista in un orizzonte
sempre più lontano e
indefinito
da
attendere
pazientemente (attendismo)
per concentrarsi sui progressi
sociali di volta in volta
possibili (con il famoso
slogan: «il fine è nulla, il
movimentoètutto»).
La
vicenda
della
socialdemocrazia tedesca del
primoNovecentotrovalasua
conclusione, ingloriosa, nel
voto che la socialdemocrazia
esprimeafavoredeicreditidi
guerraalloscoppiodelprimo
conflittomondiale.
L’esperienza
socialdemocratica riprenderà,
su basi diverse, nel secondo
dopoguerra. I cardini della
politica
socialdemocratica
così
come
l’abbiamo
conosciuta negli ultimi
decenni del Novecento sono
fondamentalmente: difesa del
diritto al lavoro e politiche
per
l’occupazione;
affermazione dei diritti dei
lavoratorisulluogodilavoro
(a
cominciare
dalla
limitazione
dell’orario);
fornitura di servizi sociali
essenziali
ai
cittadini
attraverso lo sviluppo del
Welfare State (istruzione,
sanità, edilizia, trasporti);
espansione della democrazia
anche nelle sue forme
autonomistiche, locali e
partecipative; emancipazione
delledonne.
L’opzione alternativa è
quella cui darà adito
l’iniziativa politica di Lenin
che, contrapponendosi al
binomio social-democratico
tra un’ortodossia di sfondo e
una politica riformista nei
fatti,apriràconlarivoluzione
d’Ottobre una nuova fase
della
storia
mondiale,
dell’Europa e ancor più del
Terzo Mondo. Ponendosi
come gli unici interpreti
capaciditradurreininiziativa
politica l’insegnamento di
Marx i partiti comunisti nati
dal processo innescatosi con
la Rivoluzione sovietica, a
suavoltafruttodell’ecatombe
della grande guerra, si
accingono a costruire un
socialismo che da un certo
punto in poi diventa
socialismodistato,basatoda
un
lato
sulla
collettivizzazione economica,
dall’altro sul potere del
partito unico e perciò sulla
negazione di un vero
pluralismopolitico.
Nelmomentoincui,però,
il tempo ha fatto calare il
sipario sullo spettacolo
terribile delle lotte politiche
che hanno segnato il
Novecento, la difficoltà o
l’aporia fondamentale del
socialismo, non solo come
esperienza storica, ma anche
come concetto politico,
appareintuttalasuanettezza:
ilsocialismodistatocostruito
dai comunisti, certo a fronte
dienormidifficoltàinterneed
esterne, non è riuscito a
mantenerelesuepromessedi
liberazionedegliuomini,edè
crollato grazie al combinato
disposto di una forte
pressione esterna, di una
sempre
più
evidente
inefficienza economica e di
un bisogno di libertà che
aveva lasciato inappagato. Il
socialismo democratico ha
dovutorinunciareatuttiisuoi
obiettivi più ambiziosi di
trasformazione sociale per
porsi «realisticamente» come
l’ala
sinistra
della
democrazia, impegnata a
porre un argine al dominio
del
mercato
e
alle
conseguenti ineguaglianze,
richiamando al rispetto di
certi doveri minimi di
solidarietàsociale,cheormai,
almenonelmondocristianoe
occidentale, ben pochi hanno
l’ardire
di
respingere
apertamente.
Perciò la vicenda storica
del socialismo, che così
fortemente ha segnato lo
sviluppo sociale degli ultimi
centocinquant’anni,
ha
qualcosa di paradossale: per
unversononsièrealizzatala
prospettata trasformazione
sociale, né in forma
gradualista e progressista, né
in
forma
di
rottura
rivoluzionaria. L’ambizione
che l’uomo potesse prendere
in mano le sorti della sua
storia, che potesse governare
l’economia attraverso gli
strumenti
della
pianificazione,sièinfrantadi
fronte alla sue difficoltà
intrinseche e alle avverse
circostanze esterne; il sogno
dell'«uomo nuovo» è uscito
sconfitto dal confronto con
un’antropologia «possessiva»
che ha rivelato una sua
tenacissima
forza
di
resistenza.Maperaltroverso
i movimenti socialisti e
comunisti hanno inciso assai
profondamentenonsolonelle
strutture sociali (attraversate
da conflitti che hanno
generato più giustizia, più
eguaglianza, più democrazia)
ma anche nelle idee e nelle
ideologie più diffuse. Se non
ci fossero stati in campo
l’Urss e la sua sfida non
avremmo
avuto
uno
straordinario
personaggio
come
Roosevelt,
né
Beveridge e lo sviluppo del
Welfare State. E sul piano
della teoria politica si può
tranquillamente affermare,
per esempio, che il valore
dell’eguaglianza non solo nei
diritti di libertà, ma anche
nell’accessoaibeniprimarie
alle risorse fondamentali,
proprio grazie all’impatto del
socialismo,
è
oggi
riconosciuto anche nelle più
avanzateteorieliberali,come
per esempio quelle di John
RawlsoRonaldDworkin.Se
oggi il liberalismo gode di
tanto successo è anche
perché, in molti suoi
esponenti,
ha
saputo
accoglieredentrodiséistanze
socialistiche ed egualitarie
che invece il liberalismo
classico, anche nei suoi
migliori rappresentanti come
Tocqueville,
decisamente
respingeva. Perciò crediamo
sipossaaffermarechelacrisi
delsocialismocomeazionee
teoria politica, non trascini
con sé quei principi di
eguaglianza, giustizia e
solidarietà sociale che del
socialismo hanno costituito
l’ispirazione più antica e
autentica,econiqualianche
la
riflessione
politica
contemporaneaèimpegnataa
confrontarsi, se non altro
perché sono una componente
e una naturale estensione
dellademocrazia.
Unarecenteeutilemessa
a punto su questo tema è
quella tracciata da John
Roemer nel suo interessante
libro Un futuro per il
socialismo: il principio
socialista, secondo Roe-mer,
è quello che afferma che in
una società giusta, ogni
individuo deve avere pari
opportunità
di
autorealizzazioneebenessere,
di influenza politica e di
status sociale. Alcuni dei
termini usati in questa
proposta possono apparire
problematici, come per
esempio
quello
di
autorealizzazione. Roemer
precisa, pertanto, che con
autorealizzazioneegliintende
un concetto che affonda le
sue radici, tra l’altro, nel
pensierodiMarx,echestaa
significare «lo sviluppo e
l’applicazione del talento di
un individuo in modo da
conferire significato alla
vita»38.L’altroconcettopoco
definito, nella succinta
definizione di Roemer, è
quellodipariopportunità,che
introduce all’interno del
discorso socialista un tema il
cui codice genetico è
originariamente liberale. Ma
su questo punto bastino qui
due
rapidissime
considerazioni: dicendo che
ciò che deve essere
eguagliato
non
sono
l’autorealizzazione e il
benessere, ma le opportunità
di
autorealizzazione
e
benessere, si sottolinea che
comunque all’individuo resta
una responsabilità per se
stesso,dallaqualeneppurela
società più solidaristica può
esimerlo.Insecondoluogo,il
concetto di eguaglianza di
opportunitàpuòancherestare
vago (anche se dovrebbe
necessariamenteincluderedei
contenuti
imprescindibili,
comeperesempiol’istruzione
per tutti); in questa sede è
sufficiente precisare che le
interpretazioni socialiste di
questo concetto saranno
comunque assai più esigenti
delle interpretazioni liberali
classichediesso.
Ma se si intende il
socialismo come criterio o
principio, allora la prima
conseguenza che ne deriva è
cheessononsiidentificacon
un certo modello di società
oppure con certe istituzioni
specifiche,comeperesempio
la proprietà pubblica dei
mezzi di produzione; esso si
colloca a un livello di
astrazione più alto rispetto a
ognisingolasceltaconcreta,e
lascia quindi aperto il
problemadiindividuarequali
siano gli strumenti migliori e
piùidoneiperraggiungeregli
obiettivisocialisti,sesianola
proprietà
pubblica,
il
socialismo di mercato sul
quale ragiona Roemer,
l’economia mista con una
fortetassazioneredistributiva,
o altro. Tutti gli assetti
possono essere in linea di
principio ugualmente validi
(un po’ come accadrà anche
nellaTeoriadellagiustiziadi
Rawls), purché funzionino
perraggiungerequeifinichei
socialisti si propongono di
conseguire.
Vi è però anche un
secondo punto che merita di
essere messo a fuoco: i
socialisti, se accettiamo il
punto di vista di Roemer,
vogliono che gli individui
abbiano pari opportunità di
autorealizzazione e benessere
e
pari
opportunità
(democratiche) di influire
sulle scelte pubbliche. Ma si
possono volere le due cose
insieme ? Come ha scritto
Philippe Van Parijs in un
interessante saggio, che
s’intitolaproprioLajusticeet
la démocratie sont-elles
incompatibles?, «la relazione
tra democrazia e giustizia,
lungi
dall’esprimere
un’armonia prestabilita, è al
contrario
altamente
problematica»39.
Per un verso, infatti, non
si può essere socialisti senza
essere democratici: le scelte
che
riguardano
l’autorealizzazione e il
benessere degli individui
devono essere opera degli
individui stessi, e non
possono certo venire affidate
a un governo di «custodi»
benevolieautocratici.Maper
altro verso, se si assume il
principio democratico che i
cittadini devono avere pari
opportunità di influire sulle
scelte pubbliche, come si
potrà negare loro il diritto di
compieresceltechevadanoin
unadirezionediversarispetto
a quella che pare auspicabile
ai socialisti ? Perciò, se si
definisce
il
socialismo
seguendo la interessante
proposta di Roemer, esso si
configuracomeiltentativodi
pensareunpuntod’equilibrio,
che non può non essere
sempredifficileeprecario,tra
duevaloridifondocheperun
verso
si
richiamano
reciprocamente, ma che per
altroversorestanoeterogenei.
Aconsiderazioninondiverse,
peraltro,sigiungeanchesesi
assume come punto di
partenza un orizzonte di
teoria democratica: per un
verso non si può essere
democraticisenzanutrireuna
qualche tensione verso
istanzesocialistiche,perchéle
pari opportunità di influire
sulle
scelte
pubbliche
presuppongono una certa
uguaglianza
sociale
(altrimenti prevarrà sempre
l’influenza dei più ricchi e
potenti); ma questo significa
per l’appunto imporre dei
precisi limiti a quelle scelte
democratiche che per altro
versosonostateassuntecome
ilvalorefondante.Iltemadel
socialismo,
perciò,
si
intreccia strettamente con
quello della democrazia, se
almeno la si intende, come
oravedremo,inunadiquelle
chepossonoesseredefinitele
sueversioni«esigenti».
5.Democrazia.
Sebbene abbia il suo
lontano
progenitore,
nell’epoca moderna, in
Rousseau,
la
teoria
democratica si è sviluppata
lentamenteneiduesecoliche
abbiamo alle spalle, così
come lentamente e in epoca
relativamente recente si sono
affermate in Europa, tra la
fine del xix secolo e la metà
di quello seguente, le
istituzioni fondamentali della
democrazia, prima fra tutte il
suffragiouniversale.
Sebbene
costituisca
anch’esso un terreno che ha
ospitato
interpretazioni
fortemente divaricate, il
concetto di democrazia si
presta,inprimabattuta,auna
definizione piuttosto chiara:
mentreilliberalismorichiede
l’uguaglianza dei diritti
individuali, e il socialismo
l’uguaglianza
di
autorealizzazioneebenessere,
il principio della democrazia
è l’eguaglianza politica entro
una comunità (un demos),
ovvero
l’eguale
partecipazione di tutti i
cittadini adulti alle decisioni
politichevincolantipertutti.
La democrazia quindi
rovescia l’idea (carica di un
illustre passato, a partire da
Platone) che solo alcuni
uomini, i più qualificati o i
più saggi, abbiano diritto di
prendere
le
decisioni
politiche. Ma come si
giustifica, allora, il principio
dell’uguaglianza
democratica?Nellatradizione
di pensiero che risale a
Rousseau,echevieneripresa
da uno dei maggiori teorici
della
democrazia
del
Novecento, Hans Kelsen, la
democrazia si fonda sul
concetto di libertà intesa in
senso positivo: se gli uomini
devono vivere sottoposti alle
leggi coercitive di uno stato,
l’unica soluzione perché
essi non perdano la loro
libertà è che, di queste leggi,
sianoessistessigliautori.Se
dobbiamo essere comandati,
«Io vogliamo essere da noi
stessi»40. Alla democrazia
vista in questa prospettiva si
associa immediatamente il
principio di maggioranza:
poiché vogliamo essere in
grado di decidere, non
possiamoaspettareognivolta
diaverraggiuntol’unanimità:
sceglieremo
quindi
il
principio di maggioranza
perché esso minimizza il
numerodicolorochedevono
obbedire a leggi cui non
hanno dato il loro consenso.
Neigrandistati,d’altraparte,
al principio di maggioranza
deve aggiungersi quello
parlamentareche,basatosulla
finzionedellarappresentanza,
costituisce in realtà un
compromesso praticamente
necessariotral’esigenzadella
libertà come autogoverno e
una indispensabile divisione
dellavoro.
Nella prospettiva di
Robert A. Dahl, uno dei più
importantiteoricidemocratici
contemporanei,
la
giustificazione
della
democrazia
procede
in
maniera un po’ diversa: non
prende le mosse dalla libertà
ma dall’idea di eguaglianza.
Allabasedellademocraziavi
è l’idea della eguaglianza tra
gli uomini intesa come
«uguale considerazione che
deveesseredataalbeneeagli
interessi
di
ciascuna
persona»41;
l’idea
di
eguaglianzasitraducequindi,
per Dahl, in un principio di
pari considerazione degli
interessi: gli interessi di ogni
cittadino non valgono più di
quellidiognialtro,equestoè
un principio che si può
assumere senza particolari
oneri dimostrativi, poiché
sarebbe
assai
difficile
argomentare
in
modo
convincentelatesiopposta,e
cioèchegliinteressidialcuni
debbano venire privilegiati a
scapitodiquellidialtri.Seal
principio
della
pari
considerazione degli interessi
aggiungiamo quella che Dahl
chiama la presunzione di
autonomia personale («in
assenza di una palese
dimostrazione del contrario,
ognuno dovrebbe essere
ritenutoilmigliorgiudicedel
proprio bene o dei propri
interessi»)42, disponiamo di
tutto quel che ci serve per
sostenere la tesi che non c’è
miglior governo di quello
democratico:«Seilbeneogli
interessi di ciascuno devono
avere uguale peso. e se
ciascunadultoèingeneraleil
miglior giudice del proprio
bene o dei propri interessi,
alloratuttiimembriadultidi
un’associazione sono nel
complesso sufficientemente
ben qualificati a partecipare
alle decisioni collettive
vincolanti che influenzano il
loro bene o i loro interessi,
cioèaesserecittadiniapieno
titolodeldemo»43.
Se si parte da un assunto
dieguaglianzatragliuomini,
dunque,lademocraziarisulta
giustificata in quanto è il
miglior modo di tutelare
paritariamente gli interessi di
tutti, attraverso la loro
partecipazione alle decisioni
collettive. Le soluzioni
alternative, come quella di
affidare la tutela degli
interessi di tutti a un despota
benevolo o a un governo
platonico di saggi «custodi»,
danno certamente minori
garanzie di quante la
soluzione
democratica,
sempre
imperfetta
e
migliorabile
nelle
sue
attuazioni, possa comunque
offrire.
Il modo in cui la
democrazia viene giustificata
influisce naturalmente anche
sulla forma che le diverse
teorie della democrazia
vengono ad assumere44: qui
per semplicità vorremmo
limitarci a distinguere tre
opzioni
teoriche:
la
democrazia come «metodo»,
la teoria realistica della
democrazia, e infine quella
che si potrebbe definire la
teoria «dinamica», ovvero,
per riprendere un’idea di
Macpherson, la «democrazia
disviluppo».
5.1.Democrazia
comemetodo.
L’idea di democrazia
comemetodoèquellachesta
alla base della definizione
minima o essenziale di
democrazia proposta da
NorbertoBobbioinunsaggio
del fortunato volume che si
intitolava appunto Il futuro
dellademocrazia.PerBobbio
si ha democrazia quando
vengono
soddisfatte
le
seguenti condizioni: 1) alle
decisioni
collettive
partecipanoinmododirettoo
indiretto un numero molto
alto di cittadini; 2) sono
vigenti regole per decidere, a
cominciare dalla regola di
maggioranza; 3) i cittadini
hanno la possibilità di
sceglieretraalternativerealie
dispongono di quelle libertà
(di espressione, di riunione,
di associazione) che sono
necessarie affinché queste
alternative possano essere
scelte con una certa dose di
consapevolezza, e cioè dopo
che sono state proposte,
illustrate e confrontate nel
dibattitopubblico45.
Nel
pensiero
del
Novecento,ilmaggiorteorico
della democrazia come
metodoperdecidereèstatoil
giurista e filosofo del diritto
Hans Kelsen (1881-1973).
Per Kelsen la democrazia
implica innanzitutto, come
suo presupposto teorico di
fondo, la fine della credenza
inunaveritàassolutaoinun
bene assoluto (come quello
che orienta, a per esempio il
pensiero di Platone); essa
presuppone in sostanza il
relativismo46.Comeformadi
stato, la democrazia si basa
sull’idea rousseauiana della
libertà come autogoverno:
nella lettura kelseniana è
l’ideadilibertà(trasformatasi
in sovranità popolare) a
costituire il nucleo dell’idea
didemocrazia,enonl’ideadi
eguaglianza47, a meno che
non la si intenda come la
semplice eguaglianza dei
diritti
politici.
Alla
democrazia, quindi, non
appartengono
necessariamente
specifici
contenuti di eguaglianza
sociale, anzi, la democrazia,
per Kelsen, è un «metodo di
creazione
dell’ordine
sociale»48 che non dice nulla
sul
modo
in
cui,
concretamente, questo ordine
deveesserestrutturato.
Molto
attento
a
distinguere tra ideologie e
realtà, Kelsen sottolinea
ripetutamente
come
la
democrazia attuabile negli
stati moderni costituisca
(innanzitutto a causa della
mediazioneparlamentare)una
realizzazione molto limitata
rispetto
all’idea
di
democrazia
come
autogoverno. Tuttavia l’idea
di fondo resta quella che le
decisioni politiche debbano
essere in qualche modo
riconducibili,
sia
pure
attraverso la mediazione dei
partiti e del parlamento, alla
volontà dei cittadini. Proprio
per questo Kelsen delinea
un modello di democrazia
con caratteristiche molto
precise:
primato
del
parlamento
rispetto
all’esecutivo; preferibilità del
sistema proporzionale, più
rappresentativo, rispetto a
quello
maggioritario;
necessità di non intendere le
decisioni
come
mera
espressione della volontà
della
maggioranza
ma
piuttosto
come
un
compromesso
tra
maggioranza e minoranza,
che le regole e le procedure
parlamentari rendono spesso
necessario,echecomunqueè
per
Kelsen
sempre
auspicabile,
perché
le
decisioni politiche debbono
essere quanto più possibile il
frutto delle volontà dei
cittadini e dei loro interessi,
attraverso
l’indispensabile
mediazione
della
aggregazione in partiti. «È
chiaro che l’individuo isolato
non ha, politicamente, alcuna
esistenza reale, non potendo
esercitare un reale influsso
sulla
formazione
della
volontà dello stato. La
democrazia può quindi
esistere soltanto se gli
individui si raggruppano
secondo le loro affinità
politiche ... cosicché, fra
l’individuo e lo stato, si
inserisconoquelleformazioni
collettive che, come partiti
politici, riassumono le eguali
volontà
dei
singoli
individui»49. L’ostilità nei
confronti dei partiti, sostiene
Kelsen,èallafineostilitànei
confrontidellademocrazia50.
Il valore del metodo
democratico per giungere a
decisioni collettive, d’altra
parte,losicomprendemeglio
- per Kelsen - se si ha
presente la composizione
della
società
moderna,
attraversata da aspri conflitti
di interessi e, soprattutto, di
classi:inunmondosolcatoda
duri conflitti di classe come
quello dei primi decenni del
Novecento, la democrazia
(nel modo in cui la intende
Kelsen, e cioè ampiamente
rappresentativa e orientata al
compromesso) è l’unico
metodopergestireilconflitto
pacificamente,ondeimpedire
che esso degeneri (come di
fatto accadeva, nel mondo
che Kelsen aveva intorno) in
guerracivile.
5.2.Lateoria
realisticadella
democrazia.
Se
Kelsen
mantiene
ancora, sia pure come mera
base di partenza, il punto di
riferimento
rousseauiano
della teoria democratica, le
teorie propriamemte realiste,
a partire da quella di
Schumpeter, recidono del
tutto
questo
legame,
inclinandopiuttostoapensare
lademocraziasulmodellodel
mercato. Non possono più
essere presi per buoni, per
Schumpeter, gli assunti sui
qualisibasavaquellacheegli
definisce come la «dottrina
classica della democrazia» di
impianto rousseauiano: non
esiste un bene comune al
quale le diverse volontà
individuali possano orientarsi
per dar luogo a una volontà
generale; e alla volontà degli
individui come soggetti
politici nello stato moderno
non possono essere attribuite
quelle caratteristiche di
autonomiaerazionalità51che
sono necessarie per farne dei
soggetti
autonomi
di
decisioni: la volontà del
cittadinosiriduceapocopiù
che «un fascio confuso di
impulsi vaghi, operanti su
slogans
e
impressioni
equivoche»52.
Riprendendo dunque per
certi aspetti l’impostazione
élitistica di Mosca e di
Pareto, Schumpeter rompe
con la visione tradizionale
dellademocrazia,cheprevede
una direzione ascendente
della volontà politica dal
basso verso l’alto, e rovescia
decisamente il senso del
vettore politico: non è la
volontà dei cittadini a dar
luogo, sia pure attraverso
molte
mediazioni
e
rappresentazioni,
alla
decisione politica (come
accadeva ancora in Kelsen).
Al contrario, il primo attore
sulla scena sono le élites
politiche, e il consenso di
cittadini è la posta in gioco
della lotta concorrenziale che
queste élites ingaggiano per
conquistarselo.
La
democraziapuòessereperciò,
a questo punto, definita nel
modo seguente: «il metodo
democratico è lo strumento
istituzionale per giungere a
decisioni politiche, in base al
quale
singoli
individui
ottengono il potere di
decidere attraverso una
competizione che ha per
oggettoilvotopopolare»53.
Le scelte politiche, come
aveva insegnato la teoria
delleélites,sonosemprenelle
mani di piccoli gruppi che
hannoilpoterediprenderele
decisioni; ma, diversamente
dalle forme di potere
autocratico, la democrazia si
caratterizzaperilfattochetra
queste élites si instaura una
competizionesimileallalotta
concorrenziale
degli
imprenditori per conquistare
consumatori,
una
competizione che ha come
oggetto la conquista del voto
dei cittadini. Come la
concorrenza sul mercato,
anche la concorrenza sul
mercato politico non è mai
perfetta, e anzi può essere
talvolta più o meno alterata,
distorta, persino fraudolenta.
Vi è democrazia, comunque,
finché vi è un minimo di
concorrenza, e finché resta
agli elettori la possibilità di
non votare per un governo
che abbia tradito le loro
aspettative, determinandone
lacaduta.
Proprio
perché
la
funzione del voto popolare
non è quella di tradurre in
decisioni politiche la volontà
degli elettori, ma più
semplicemente
(e
passivamente) quella di
accettareunacertaleadership,
non vi è più nessuna ragione
per preferire, come aveva
fatto Kelsen, un sistema
elettorale
proporzionale.
Anzi, se il problema è solo
quello di dare l’investitura a
una leadership (riservandosi
soltanto di togliergliela
qualora essa si riveli
insoddisfacente) il sistema
maggioritario sembra assai
piùfunzionale54.Lafunzione
del cittadino democratico, in
sostanza, si risolve in quella,
assai ridotta, di decidere chi
debba essere il leader. Ma,
nel momento in cui si
chiamano i cittadini a
esprimere il loro parere, i
giochi sono già stati fatti
nell’ambito dei partiti, che
perSchumpetersonoappunto
gruppi «i cui membri si
propongono di agire di
concerto nella lotta per il
potere politico». Se questa è
«realisticamente» la loro
natura, allora ben si
comprende il fatto, che
altrimenti
resterebbe
inspiegabile, che partiti
diversi o persino opposti
adottino
programmi
straordinariamentesimili55:la
lorofunzioneinfatti,inquesta
visionedellademocrazia,non
è altro che quella di
conquistare il consenso di un
elettore medio che, per
quanto sia intellettualmente
evoluto nell’ambito dei suoi
affariodellasuaprofessione,
quandosiesprimesulterreno
politico, dove non ha
conoscenze di prima mano e
preparazione scientifica, dà
fatalmente
luogo
a
comportamenti infantili e
primitivi.
Alla
visione
schumpeteriana
della
democrazia (di cui offre una
critica efficace e sintetica
Danilo Zolo ne II principato
democratico)56
si
può
avvicinare per certi aspetti
quella di Giovanni Sartori,
chesottolineaanch’eglicome
il vero potere dell’elettorato
sia soprattutto quello di
«scegliere
chi
lo
governerà»57;
mentre
l’analogia tra mercato e
democrazia è stata sviluppata
soprattutto nella Teoria
economica della democrazia
di Anthony Downs58. In
questa prospettiva, non
sembri un paradosso, le
preferenzedeivotantiequelle
dei rappresentanti sono
completamente distinte: i
votanti sono interessati ai
programmipoliticiealmodo
in cui essi entrano nella loro
funzione di utilità; ai
rappresentanti
invece
i
programminoninteressanoin
quanto tali, ma solo come
strumentiperraccoglierevoti
(che è lo scopo in vista del
quale i programmi vengono
confezionati). Da qui si
genera il cosiddetto risultato
dell’elettore «mediano»: i
rappresentanti che si fanno
concorrenza
tendono
a
presentare
piattaforme
politiche convergenti e
sovrapponibili, appunto, a
quella preferita dall’elettore
«mediano». Ma l’ipotesi
«ultrarealistica»
che
ai
candidati sia del tutto
indifferente il prodotto che
offrono è andata incontro a
critiche, che hanno messo
variamente in risalto le
difficoltà
di
una
comprensione
della
democrazia che la riduca a
mercato59.
Approfondendo l’analisi
dellademocraziarealeRobert
Dahlnesottolineailcarattere
pluralistico: si deve infatti a
lui l’introduzione del termine
«poliarchia», con il quale
Dahl si riferisce alle
democrazie esistenti in
numerosi
paesi
dell'Occidente,
e
caratterizzate dalla diffusione
dei diritti politici (dal
suffragio universale alla
libertàdiespressione),dauna
pluralità
di
fonti
di
informazione alternative e
dalla libertà di associazione,
cioè dal fatto che i cittadini
hanno «il diritto di costruire
associazioni e organizzazioni
relativamente indipendenti,
come pure partiti politici e
gruppi
di
interesse
indipendenti» 60. Nella
riflessione di Robert Dahl,
però,
all’analisi
della
democrazia reale (descritta
come
«poliarchia»)
si
affianca
progressivamente
una riflessione che assume
caratteristiche
criticonormative, e che si pone il
problema se la «poliarchia»
siaabbastanzademocratica,e
dicomesipossacostruireuna
democraziapiùsoddisfacente,
che vada oltre i limiti della
«poliarchia».
L’analisi
realistica della democrazia
così com’è non blocca, ma
anzi apre la possibilità di
interrogarci sui modi per
superare i limiti che nella
democrazia esistente si
riscontrano.
5.3.Lademocrazia
disviluppo.
È proprio in questa
direzione che si muovono i
teorici di quella che, con C.
B. Macpherson, potremmo
chiamare la democrazia di
sviluppo61.
In
questa
prospettiva (che è stata
diversamente espressa nelle
opere di John Dewey, dello
stesso
Macpherson,
di
Cunningham) una visione
come quella di Schumpeter
non rappresenta la fisiologia
della vita democratica, ma
piuttosto
la,
sempre
incombente, patologia: la
democrazia infatti tradisce se
stessa nel momento in cui il
vettore della volontà politica
non va più dal basso verso
l’alto ma dall’alto verso il
basso, e i cittadini diventano
l’oggetto delle strategie
messe in atto da parte delle
élites
politiche
per
conquistarneilconsenso.
Due sembrano essere gli
aspetti che caratterizzano più
nettamente le visioni della
democraziacomeunprocesso
dinamico, alla radice del
quale c’è una idealità di
fondo che tende sempre ad
andare oltre le acquisizioni
della democrazia reale. In
primoluogo,vièl’ideachela
democraziapoliticaèpartedi
un più vasto processo di
democratizzazione
della
società, e che solo in questo
contesto assume veramente il
suo significato. John Dewey
per esempio, nel suo The
Public and its Problems, del
1927, sostiene che bisogna
tener sempre presenti due
aspetti: la democrazia come
idea sociale e la democrazia
politica come sistema di
governo:
«l’idea
di
democraziaèpiùestesaepiù
ampia dell’esempio che di
essa può dare anche lo stato
piùperfetto.Perattuarsi,essa
deveinfluiresututtiimodidi
associazione umana, sulla
famiglia,
la
scuola,
l’industria, la religione; e gli
stessi modi politici di
attuazione, le istituzioni
governative,nonsonocheun
meccanismo per offrire a
un’ideaimezzidifunzionare
in modo effettivo» 62. La
democrazia dunque non è
soltanto un metodo politico
ma, più originariamente, un
ideale di società: «La
democrazia - scrive Dewey è qualcosa di più di una
formadigoverno.Èprimadi
tuttountipodivitaassociata,
di esperienza continuamente
comunicata»63.Èunatesiche
viene ripresa e sviluppata
anche in Macpherson e in
Cunningham64,
che
ne
riprende e ne svolge
l’insegnamento: come scrive
il primo in Democratic
Theory, la democrazia è «un
tipodisocietà-uncomplesso
globale di relazioni tra
individui -»65 e non
semplicemente una forma di
governo.
Ne
discende
l’esigenza di affiancare alle
istituzioni della democrazia
politica
processi
di
democratizzazione della vita
associata,inunavisionedella
democrazia come processo
dinamico ed espansivo66 che
nonsiacquietanelleformedi
volta in volta raggiunte.
All’espansione
della
democrazia in sfere della
società diverse da quella
propriamente politica ha dato
un contributo importante
anche Robert Dahl, con la
sua ricerca sulla democrazia
nelle aziende67 e, più in
generale, sul rapporto tra
democraziaedeconomia.
L’altro aspetto che mi
sembra centrale nelle visioni
dinamichedellademocraziaè
quellocheconcerne,perdirla
ancora con Dewey, il ruolo
del
pubblico,
e
più
precisamente del dibattito e
delladiscussionepubblica.Se
non si accetta il fatto che i
cittadini restino al margine
dei processi effettivi di
formazione della volontà
politica,
limitandosi
sostanzialmente a esprimere
una delega, diventa centrale
la riflessione sui modi in cui
essi possono far sentire la
loro voce, concorrendo allo
sviluppo di un’opinione
pubblica attiva, informata e
influente. Uno dei più gravi
pericoli che minacciano la
democrazia, osserva sempre
John Dewey, è l’eclisse del
pubblico,ovveroilfattochei
cittadini si riducano a quei
consumatoripassividiofferte
politiche
che
vengono
rappresentati nella teoria
schumpeteriana. Il conteggio
dei voti, che è essenziale in
democrazia,
«deve
necessariamente
essere
preceduto da discussione,
colloquio e persuasione»68; e
il principio di maggioranza
sarebbe insensato come
pretendono i suoi detrattori,
senoncisisoffermasseanche
sul modo in cui le
maggioranze si devono
formare: e cioè attraverso il
dibattito pubblico e il
confronto
critico
degli
argomenti.
Le teorie dinamiche della
democrazia, ponendo le
istanze
di
una
democratizzazione
della
società e di una centralità
della discussione pubblica,
costituiscono quindi il polo
opposto rispetto alle teorie
realistiche;omeglio,possono
anche far propri aspetti
analitici che sono evidenziati
dalle teorie realistiche, ma se
ne distinguono soprattutto
perché colgono il «fatto»
della democrazia in modo
molto più ricco e più
complesso,
in
quelle
potenzialità espansive che gli
ineriscono, e che esso può
sempredinuovorigenerare.
1G.sartori,Democrazia:
cosaè,Rizzoli,Milano2000,
p.195.
2Cfr.LeCartedeidiritti,
a cura di F. Battaglia,
Sansoni, Firenze 1947, p.
119.
3 E. balibar, Le frontiere
della democrazia, trad. it.
manifestolibri, Roma 1993,
pp.83sgg.
4
Per
una
utile
presentazione
della
discussioneanaliticasuquesti
temisivedailvolumeacura
diM.decaro,Lalogicadella
libertà,Meltemi,Roma2002.
5DiN. bobbio si vedano
soprattutto, tra i numerosi
interventi su questo tema, il
volume Politica e cultura,
Einaudi,Torino1955,pp.160
sgg. e il libretto Eguaglianza
e libertà, Einaudi, Torino
1995; si legga inoltre il
saggio di M. BOVERO,
Libertà,in Alla ricerca della
politica. Voci per un
dizionario, a cura di A.
D’Orsi, Bollati Boringhieri,
Torino 1995, pp. 33-52; di I.
berlin si legga il classico
Quattro saggi sulla libertà
(1969), trad. it. Feltrinelli,
Milano 1989. Per la
discussione intorno alle tesi
diBerlincfr.ilvolumeacura
diI.cartereM.RICCIARDI,
L’idea di libertà, Feltrinelli,
Milano 1996 e il recente
scrittodiG.CADONI,Suun
celebre saggio d'Isaiah
Berlin, in «Il pensiero
politico», XXXV (2002), n.
2, pp. 302-19. Per una
panoramica generale sul
concetto di libertà si veda il
volumetto di M. barberis,
Libertà, il Mulino, Bologna
1999.
6 hobbes, Leviatano cit.,
p.205.
7Ibid.,p.208.
8 È questo un concetto
che, come ricorda bobbio in
Eguaglianzaelibertà,cit.,p.
47, si trova anche in Locke
(Secondo trattato, § 22) e in
Montesquieu(Lospiritodelle
leggi,XII,2).
9 rousseau, Contratto
sociale,cit.,p.98.
10 Cfr. gray, Liberalismo
(1986}, trad. it. Garzanti,
Milano1989,
11H.LASKi,Leorigini
delliberalismoeuropeo,trad.
it.Firenze1971,pp.2-3.
12 s. Maffettone,
Fondamenti filosofici del
liberalismo, in R. dworkin e
s. Maffettone, I fondamenti
del liberalismo, Laterza,
Roma-Bari1996,pp.129-30.
13 Come sottolinea, per
esempio, G. bedeschi nella
Avvertenza alla seconda
edizione della sua Storia del
pensiero liberale, Laterza,
Roma-Bari 1992. Tra i
tentativi di dare una visione
complessivadelliberalismosi
possono leggere utilmente
gray, Liberalismo cit.; R.
cubeddu,
Atlante
del
liberalismo,Ideazione, Roma
1997 (si tratta in entrambi i
casi di volumi molto vicini
alla prospettiva di Hayek);p.
p. portinaro, Profilo del
liberalismo, pubblicato di
seguito al saggio di B.
constant, Sulla libertà degli
antichi paragonata a quella
dei moderni, Einaudi, Torino
2001, pp. 37-158. Ma non si
dimentichi il classico G. de
RUGGIERO, Storia del
liberalismo europeo (1925),
Laterza,Roma-Bari1995.
14Itestidellapolemica,
con altri che la illustrano, si
leggono in B. croce e L.
Einaudi,
Liberismo
e
liberalismo, a cura di P.
Solari, Ricciardi, Milano-
Napoli 1957. Per una recente
riflessione
sul
tema
«liberalismo e liberismo»,
che tende ad archiviare la
disputa come appartenente
ormai al passato, cfr.
cubeddu,
Atlante
del
liberalismocit.,pp.113sgg.
15 Cfr. croce, Etica e
politicacit.,pp.266-67.
16 Su questo tema vedi la
critica di bobbio, Benedetto
Croce e il liberalismo, in
Politica e cultura cit., pp.
211-68.
17
sartori,
Democrazia:cosa è cit., p.
206.
18cubeddu,Atlantedel
liberalismocit.,p.91.
19Ibid.,p.95.
20 Uno degli esponenti
più noti di questa corrente è
M. rothbard; tra i molti testi
tradotti anche in italiano si
può vedere L'etica della
libertà, Liberilibri, Macerata
1996.
21 Cfr. P. van parijs, La
justice et la démocratie sontelles incompatibles?, in
Sauver la solidarité, Éditions
du Cerf, Paris 1995, pp. 2760.
22 constant, Prìncipi di
polìticacit.,p.123.
23Cfr.Lecartedeidiritti
cit.,p.45.
24Ibid.,p.131.
25
bobbio, Politica e
culturacit.,p.168.
26
M.
Fioravanti,
Costituzione, il Mulino,
Bologna 1999, p. 105. Su
Montesqieu
e
il
costituzionalismo si leggono
ancora utilmente le pagine
dello studioso legato alla
Scuola di Francoforte f.
neumann,
LO
STATO
democratico e lo stato
autoritario (1957), trad. it. il
Mulino, Bologna 1973, pp.
181-241.
27 Sul liberalsocialismo
cfr. il volume collettaneo, a
curadiM. bovero, v. murae
F. sbarberi, I dilemmi del
liberalsocialismo, La Nuova
ItaliaScientifica,Roma1994,
nonché il volume di F.
sbarberi, L'utopia della
libertà
eguale,
Bollati
Boringhieri,Torino1999.
28 Sulla difficoltà di
definire «socialismo» insiste
anchej.-p.thomasnellavoce
«Socialisme»
del
Dictionnaire de philosophie
politique, a cura di P.
RaynaudeS.Rials,Puf,Paris
1997.
29
F.
Buonarroti,
Congiuraperl'eguaglianzao
di Babeuf, a cura di G.
Manacorda, Einaudi, Torino
1946,pp.277e279.
30
a.
laponneraye,
Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino
(1832), trad. it. in II
socialismo prima di Marx, a
cura di G. M. Bravo, Editori
Riuniti,Roma1966,pp.15260.
31 j. j. PILLOT, Né
castelli né capanne (1840),
trad.itinIIsocialismoprima
diMarxcit.,p.407.
32 Riportato da G. M,
Bravoin II socialismo prima
diMarxcit.,p.490.
33 p. j. PROUDHON,
Checos'èlaproprietà(1840),
trad. it. Laterza, Roma-Bari
1974,p.203.
34 Riportato da G. M.
Bravoin II socialismo prima
diMarxcit.,p.480.
35 Per una analisi della
concezione della libertà e
dellagiustiziainMarxsiveda
il volume a cura di s.
Petrucciani e f. s. trincia,
Marx in America. Individui,
etica,scelterazionali,Editori
Riuniti,Roma1993.
36 Marx, Critica al
programma di Gotha cit., p.
962.
37
E. Bernstein, I
presuppostidelsocialismoei
compiti
della
socialdemocrazia, trad. it.
Laterza,Roma-Bari1974.
38J.E.roemer,Unfuturo
perilsocialismo(1994),trad.
it.Feltrinelli,Milano1996,p.
17.
39Cfr.ilvolumettodivan
parijs, Sauver la solidarité
cit.
41 R. A. Dahl, La
democrazia e i suoi critici
(1989), trad. it. Editori
Riuniti,Roma1990,p.127.
42Ibid.,p.150.
43Ibid.,p.158.
44 Un’ottima panoramica
recente sulla teorie della
democraziaè(dopoillibrodi
D.
HELD, Modelli di
democrazia, il Mulino,
Bologna 1997) il volume di
F.CUNNINGHAM,Theories
of Democracy. A Critical
Introduction,
Routled-ge,
London-NewYork2002.In
italiano, una sintetica guida
storica
al
pensiero
democratico è E. GREBLO,
Democrazia, il Mulino,
Bologna 2000; utile anche la
lettura
della
voce
«Demokratie»
dell’opera
Geschichtliche
Grundbegriffe, tradotta in
italiano come volume a sé
presso Marsilio nel 1993
(Democrazia: ne sono autori
W. Conze, R. Koselleck, H.
Maier, C. Meier, H. L.
Reimann).
45 Cfr. N. BOBBIO, Il
futuro della democrazia,
Einaudi, Torino 1984, pp. 47.
46
Kelsen, Essenza e
valore della democrazia cit.,
p.141.
47Ibid.,p.133.
48Ibid.,p.134.
49Ibid.p.56.
50Ibid.,p.62.
51 J. A. Schumpeter,
Capitalismo
socialismo
democrazia (1954), trad. it.
Etas Libri, Milano 1984, p.
242.
52Ibid.,p.342.
53Ibid.,p.257.
54Ibid.,p.260.
55Ibid.,p.269.
56
D. zolo, Il principato
democratico. Per una teoria
realistica della democrazia,
Feltrinelli, Milano 1992, pp.
111sgg.
57 SARTORI, Democrazia :
cosaècit.,p.75.
58 A. downs, Teoria
economica della democrazia
(1957), trad. it. il Mulino,
Bologna1988.
59 Interessanti riflessioni
sul rapporto tra economia e
politica in questa prospettiva
si trovano nell’intervento di
M.GrilloenelCommentodi
M. Reale inclusi nel volume
Relazioni
pericolose.
L’avventura dell’economia
nellaculturacontemporanea,
a cura di A. Boitani e G.
Rodano, Laterza, Roma-Bari
1995,rispettivamentepp. 75-
97e98-108.
60DAHL,Lademocraziae
isuoicriticicit.,p.334.
61 Cfr. c. B. MACPHERSON,
La vita e i tempi della
democrazia liberale (1977),
trad. it. Il Saggiatore, Milano
1980;
62 j. Dewey, The Public
anditsProblem(1927), trad.
it. Comunità e potere, La
NuovaItalia,Firenze1971,p.
113.
63
j.
DEWEY,
Democrazia e educazione
(1916), trad. it. La Nuova
Italia,Firenze1992,p.133.Il
passo è citato nell’utile
volume di M. alcaro, John
Dewey.
Scienza
prassi
democrazia, Laterza, RomaBari1997,p.112.
64DiF. CUNNINGHAM
si vedano il volume Teoria
della
democrazia
e
socialismo (1987), trad. it.
EditoriRiuniti,Roma1991,e
The
Real
World
of
Democracy
Revisited,
Humanities Press, Atlantic
Highlands,NewJersey1994.
65 c. B. macpherson,
DemocraticTheory.Essaysin
Retrieval, Oxford University
Press1973,p.51.
66 Una visione dinamica
dellademocraziaèquellache
viene proposta da M. REALE,
La fragilità della democrazia
vincente, in AA.VV., Per un
nuovo vocabolario delta
politica, a cura di L.
Capuccelli, Editori Riuniti,
Roma1992,pp.15-175.
67
R.
DAHL,
La
democrazia
economica
(1984), il Mulino, Bologna
1989
68 J.DEWEY, Comunità e
poterecit.,p.162.
VII.Teoriepolitichea
confronto
I.Lateoriadella
giustiziadiRawls.
Con A Theory of Justice,
pubblicata negli Stati Uniti
nel 1971, John Rawls ha
impresso una vera e propria
svolta al pensiero filosoficopolitico
della
contemporaneità. La Teoria
della giustizia di Rawls,
infatti, ha riportato al centro
della discussione filosoficopolitica
l’approccio
normativo,cheilprevaleredi
altriorientamentidipensiero,
realistici o marxistici, aveva
relegato piuttosto sullo
sfondo nei decenni del
secondo dopoguerra. A
partire
dalla
sua
pubblicazione, la teoria
rawlsiana non ha suscitato
solo un’enorme quantità di
discussioni critiche e di
interpretazioni, ma ha anche
stimolato, per contrasto, la
costruzione
di
teorie
alternative che assumono
quelladiRawlscometermine
diparagonecritico,comeper
esempio il liberismo di
Robert Nozick o le teorie
comunitarie.
ComeRawlschiariscegià
nelle primissime pagine del
suo libro, il tema specifico
della sua indagine è quello
della giustizia sociale1. Per
affrontarlo è necessario
perciò prendere le mosse da
unaconcezione,seppurmolto
essenziale, di cosa sia una
società. Egli la definisce,
quindi,
come
«un’associazione più o meno
autosufficiente di persone
che, nelle loro relazioni
reciproche,riconosconocome
vincolanti certe norme di
comportamento e che, per la
maggior parte, agiscono in
accordoconesse»2.
Lasocietà,precisaRawls,
puòesserequindiconsiderata
come un «sistema di
cooperazione
teso
ad
avvantaggiare coloro che vi
partecipano», e che si basa
quindi su una certa
ripartizione degli oneri e dei
benefici della cooperazione
sociale tra i partecipanti a
essa. La società, precisa
ancoraRawls,ècaratterizzata
siadaconflittochedaidentità
di interessi: vi è identità di
interessi
perché
la
cooperazione sociale rende
possibilepergliindividuiuna
vita migliore di quella che
avrebbero senza di essa; ma
vi è anche conflitto di
interessi
perché
Rawls
presume
che
ognuno
preferisca avere per sé una
quota maggiore di benefici e
una quota minore di oneri.
Date queste semplici e poco
controverse premesse, la
ricercaverteràdunqueintorno
al problema di quali siano i
giustiprincipiinbaseaiquali
deve essere organizzata la
struttura fondamentale della
società e, quindi, la
ripartizione dei costi e dei
benefici della cooperazione
sociale.
Ma come procedere nella
ricerca di questi principi
normativi ? Per rispondere a
questo problema Rawls
riprendel’ideadifondodella
teoria del contratto sociale,
che egli ritrova in Locke,
RousseaueKant:iprincipidi
giustizia per la struttura
fondamentale della società,
sostiene, sono quelli che
sarebbero oggetto di un
accordo originario, ovvero
quelli
sui
quali
si
metterebbero
d’accordo
individui liberi, eguali e
razionali, tesi a perseguire i
propri interessi, che si
trovassero a dover istituire le
norme fondamentali della
lorocooperazionesociale.
È molto importante, nella
prospettivadiRawls,stabilire
le
caratteristiche
della
situazione originaria a partire
dalla quale si deve trovare
l’accordo sui principi di
giustizia; su questo punto lo
schema contrattualistico va
precisato, e se ne devono
sciogliere le ambiguità. Non
possono essere considerati
giusti principi, infatti, quelli
che scaturirebbero da un
contratto concluso, in un
ipotetico stato di natura, tra
individui reali, portatori di
dotazioni differenziate di
forza fisica, intelligenza,
abilità, e così via. Se si
partisse da una situazione di
questogenere,ilcontrattoche
le parti sottoscriverebbero
non potrebbe non risentire
delle
ineguaglianze
di
partenza, e quindi non
potrebbe essere definito
giusto 3. È per questo che i
contrattualisti, a partire da
Hobbes, si preoccupavano di
mostrare che nello stato di
natura gli individui erano
sostanzialmente
uguali.
Poiché però è difficile
sostenere la tesi che il punto
di
partenza
sia
un’eguaglianza di fatto,
Rawls si muove nella
direzione di precisare le
condizioni nelle quali si
devono trovare i contraenti
per poter dar luogo a un
contrattogiusto.
Vi sono innanzitutto
alcune condizioni di sfondo:
lepartidelcontrattosonotese
apromuovereilpropriobene,
non sono né altruiste né
invidiose, si trovano nella
condizione di «scarsità
moderata», cioè in una
situazione in cui le risorse
non sono così abbondanti da
rendere superflui gli schemi
di cooperazione né così
esigue da condannarli al
fallimento. Ma, se si vuol
giungere a un contratto
giusto,
il
vincolo
fondamentalechedeveessere
impostoallepartièquelloche
Rawls definisce il «velo di
ignoranza»: le parti devono
scegliere i principi di
giustizia
disponendo
certamente di informazioni
generali sulla società umana;
ciascuno però deve ignorare
quali sono le sue specifiche
doti (intelligenza, forza,
talenti),qualèilsuopianodi
vita e la sua concezione del
bene, quale posto andrà a
occupare nella società. Solo
sesisupponecheicontraenti
siano sottoposti a questa
limitazione, si può assumere
che essi daranno luogo a un
contratto giusto, poiché, dal
momento
che
nessuno
conosce i propri interessi
specifici, si potrebbe dire
giocando un po’ con le
parole,tuttiavrannointeresse
atutelaregliinteressiditutti.
Lacondizionedelvelodi
ignoranza,peraltro,nonèche
un modo ingegnoso e un po’
tecnico per dire una cosa
moltosemplice4:uncontratto
giusto è quello che verrebbe
sottoscritto da contraenti
imparziali; e le parti sotto
velo di ignoranza sono
imparziali
perché,
non
conoscendolepropriedotiei
propri
interessi,
sottoscriveranno solo accordi
chetutelinoinparimisuragli
interessidiciascuno.
Ma quali sono dunque i
principi per le istituzioni
fondamentalisuiqualileparti
idealizzate del contratto
rawlsianosiaccorderebbero?
Nella formulazione che
Rawls ne dà nella Teoria
della giustìzia essi sono i
seguenti:
Primo principio - Ogni
personahaunegualedirittoal
più ampio sistema totale di
eguali libertà fondamentali
compatibilmente con un
simile sistema di libertà per
tutti.
Secondo principio - Le
ineguaglianze economiche e
socialidevonoessere:
a) per il più grande
beneficio
dei
meno
avvantaggiati,
compatibilmente con il
principio
del
giusto
risparmio,e
b)collegateacarichee
posizioni aperte a tutti in
condizioni
di
equa
eguaglianzadiopportunita5.
Lasciandodaparteimolti
problemi di dettaglio che
questeformulazionirawlsiane
possono porre, conviene
concentrarsi sulle linee
essenzialidelragionamento.I
principidiunasocietàgiusta,
per Rawls, vertono su due
questioni basilari: il primo
riguarda il pacchetto delle
fondamentalilibertàliberalie
democratiche, che dev’essere
a tutti garantito; il secondo,
più discusso e controverso,
concerneinveceiltemadelle
ineguaglianze
economicosociali:se,efinoachepunto,
in
un
orizzonte
contrattualista, esse sono
legittime ? La risposta di
Rawls,
e
cioè
l’argomentazioneafavoredel
secondo principio, si articola
come segue. Le parti
contraenti in posizione
originaria
sono
tutte
interessate a massimizzare la
propria dotazione di «beni
principali», cioè di quei beni
cheservonoarealizzareogni
pianodivitaecheincludono,
accanto alle libertà, i redditi,
le ricchezze è le basi per il
rispetto di sé. Essi quindi, in
prima istanza, stabiliscono
che ricchezze e redditi siano
ripartiti in modo eguale tra
tutti i partecipanti alla
cooperazione
sociale6.
Tuttavia, come sostiene
Rawls,nonc’èmotivoperché
questasceltasiadefinitiva.Le
parti,abbiamosupposto,sono
reciprocamentedisinteressate,
e ciò vuol dire che ognuno è
interessatosoloadaumentare
la propria dotazione di beni
principali; non gli importa
quale sarà la dotazione degli
altrienonnutresentimentiné
di generosità né di invidia.
Perciò, nel caso in cui una
distribuzione ineguale (per
esempio una retribuzione
maggiorepergliindividuipiù
produttivi)
consenta
(accrescendo la produttività
complessiva
della
cooperazione sociale) di
aumentare la dotazione di
beni principali di cui gode
ognuno, anche chi riceve di
meno,nonvisonomotiviper
non accettarla; anzi, una
situazione dove, grazie a una
distribuzioneineguale,tutti,e
in particolare coloro che
prendono di meno, stanno
meglio, verrebbe preferita a
una situazione dove vige
l’eguaglianza, ma ognuno
guadagna meno di quel che
guadagnerebbe
nella
situazione
ineguale.
Intuitivamente,
l’argomentazione di Rawls
appare
piuttosto
forte.
Proviamo a ripercorrerla in
termini semplificati: se si dà
il caso che, a retribuzione
uguale, tutti si impegnino
poco nel lavoro e a ognuno
spetti quindi una modesta
quantità di beni, appare
ragionevole
introdurre
incentivi per chi è più
produttivoinmodotaleche,a
prezzo di una certa
ineguaglianza, a ognuno
tocchi però un pacchetto di
beni
maggiore.
L’ineguaglianza rawlsiana,
un’ineguaglianzacheproduce
vantaggi per tutti, unita a
eguali opportunità (dove cioè
ognuno può accedere col suo
impegno alle posizioni più
retribuite) appare preferibile,
nella situazione originaria di
scelta,
all’eguaglianza
perfetta.
Il
«principio
di
differenza» di Rawls sembra
dunque superiore rispetto a
quello
di
intransigente
eguaglianza. Ma si possono
ipotizzare anche altri principi
di distribuzione, con i quali
quello rawlsiano si deve
confrontare.
Tra
le
alternative, spiccano da un
lato quella di un principio
puramente «meritocratico», e
dall’altra quella di un
principio utilitarista, che
afferma che si deve
massimizzare l’utilità media
prevista, preferendo cioè una
situazione dove mediamente
tutti hanno di più, anche se
coloro che capitano peggio
possono avere persino meno
di quanto spetterebbe loro
con una distribuzione eguale.
Rispetto al principio di
massimizzazione dell’utilità
media, quello rawlsiano è il
fruttodiunasceltapiùcauta:
inessoinfatti,anchechiavrà
meno avrà comunque di più
di quello che gli sarebbe
toccato in una situazione di
eguaglianza.
Le
parti
rawlsiane
scelgono
il
principio
di
differenza
facendosi
guidare
dal
principio del maxi-min·. «Al
buiosullanostrasortesociale
e naturale, scegliamo quella
distribuzioneincuièmigliore
la condizione di chi sta
peggio»7. L’uso di questo
principiodisceltarazionaleè
stato ampiamente criticato,
ma ciò non toglie che l’idea
diRawlsabbiacomunqueuna
sua forza. Si deve ricordare,
infatti,chelaprimasceltache
farebbero dei soggetti in
posizione originaria sarebbe
quella per l’eguaglianza;
sembra
ragionevole
abbandonare l’eguaglianza se
vi è la certezza di stare
meglio, mentre sarebbe assai
più azzardato abbandonarla
per una situazione dove
l’utilità media è più alta, ma
dove un singolo sfortunato o
pocoabilehaunaprospettiva
di vita anche peggiore di
quella, già modesta, che
avrebbenellostatodiperfetta
eguaglianza. Perché mai le
parti contraenti dovrebbero
assumersiquestorischio?
Lo stesso tipo di
obiezionesipuòmuoverenei
confronti dei sostenitori di
principi «meritocratici», cioè
di principi in forza dei quali
l’ineguaglianza è legittima
anche se non migliora la
prospettiva
dei
più
svantaggiati. Nella posizione
originaria i soggetti non
conoscono le loro doti, non
sanno se sono abili o
incapaci,
intelligenti
o
stupidi, dotati di un forte
carattere oppure deboli e
inetti;ragionanoquindicome
se gli potesse capitare di
trovarsi dall’una o dall’altra
parte,scegliendounprincipio
di distribuzione meritocratico
(molto ai più capaci, poco
agli altri) farebbero cosa
molto
incauta,
e
rischierebbero di darsi la
zappasuipiedi.
Peraltro,
anche
prescindendo dal velo di
ignoranza,Rawlssostieneche
il suo principio di differenza
dovrebbe comunque essere
accettato dai meglio dotati:
essi devono in ogni caso
cooperare nella società con i
meno dotati, e hanno quindi
bisogno che questi ultimi
accettino una distribuzione
sociale ineguale; ma questi
ultimi non la accetteranno se
dal contributo dei più dotati
non verrà anche un
miglioramento per la loro
posizione. Il principio di
differenza, quindi, è la
condizione
per
una
cooperazione sociale che non
è solo giusta, ma anche
stabile e accettabile da tutti.
Come è stato scritto, «la
struttura
sottostante
l’argomento per il principio
di differenza risiede ... più
che
in
un
generale
pregiudizio umanitario a
favore degli svantaggiati,
nell’idea che le istituzioni
collettive sono costituite in
vista
di
un’intrapresa
cooperativa»8; il principio di
differenza, infatti, sostiene
Rawls, è anche un principio
di
reciproco
beneficio:
«sembraessereunabaseequa
rispetto a cui i più dotati, o i
più fortunati nei fatti
contingenti della società,
possono
attendersi
la
collaborazione degli altri... »
9.
Rawls infine aggiunge
anche un’ulteriore riflessione
a sostegno del suo principio
didifferenza,cheriprendeun
punto sul quale aveva
insistito,comeabbiamovisto,
la tradizione socialista: dato
che gli individui non
«meritano» né i loro talenti
naturali (forza, intelligenza,
saluterobustaecosìvia)néle
qualità che acquisiscono
graziealnascereealcrescere
in circostanze familiari e
sociali favorevoli (fiducia in
se stessi, fermezza di
carattere ecc.)10 - si tratta
infatti di qualità che essi
hanno grazie a una sorte
fortunata - allora non si può
dire neanche che essi
«meritino»
i
maggiori
guadagni che, grazie alle
qualità che possiedono,
riesconoaottenere.Perciòun
principio
moderatamente
egualitario e redistributivo
come il principio di
differenza è da preferirsi
rispetto a un principio
meritocratico.
Riassumiamo quindi il
percorso fin qui compiuto: le
partiinposizioneoriginaria,e
sottoposte al velo di
ignoranza, scelgono come
principi per la cooperazione
socialedaunlatounprincipio
di eguale libertà, dall’altro il
principio di differenza, in
forza
del
quale
le
ineguaglianzesonoconsentite
se vanno a beneficio di tutti
in condizioni di eguali
opportunità: non sapendo se
saranno molto abili o poco
abili, i contraenti optano,
prudentemente, per quella
distribuzione dove anche i
menofortunatiavrannodipiù
cheinognialtroassettodella
società.
Aldilàdelsuosofisticato
impiantoconcettuale,lateoria
rawlsiana della giustizia
sociale costituisce anche una
prospettiva all’interno della
quale
si
possono
giustificare normativamente
gli interventi redistributivi
dello stato sociale del
benessere:l’ineguaglianzanei
redditi,infatti,ègiustificabile
soloinquantocontribuisceal
miglioramento
della
situazione di tutti. E questo
puòavvenireancheattraverso
l’intervento dello stato che,
tassando i redditi più alti, ne
utilizza i proventi per fornire
servizi o sussidi che
migliorino la situazione di
ciascuno, e in particolare dei
piùsvantaggiati.
Lo sviluppo successivo
della riflessione di Rawls,
però, fa emergere un
problema al quale il filosofo
dedica in modo sempre più
mirato la sua attenzione: i
principi esposti in Teoria
della giustizia si inseriscono
inunabenprecisaconcezione
morale, in un moralità di
ascendenza
kantiana
incentrata sull’equità o
sull’imparzialità, che si
traduce nell’artificio teorico
della posizione originaria e
del velo di ignoranza. Il
problema che però a questo
punto si pone è abbastanza
evidente: se si prende sul
serio il pluralismo, e cioè il
fatto che noi viviamo in
società caratterizzate da una
grande varietà di visioni
morali, di religioni, di
ideologie, come si può
pensare che i principi di
giustizia che devono regolare
la cooperazione sociale siano
l’espressione di una visione
morale particolare, nella
quale molti cittadini delle
nostre società non si
riconoscerebbero ? In un
orizzonte liberale come
quello di Rawls, in altre
parole, i principi di giustizia
che devono vincolare tutti
non possono essere ispirati a
una specifica «dottrina
comprensiva» (la moralità
kantiano-liberaleincuiRawls
stesso si riconosce) ma
devono essere accettabili
anche dai sostenitori di
visioni diverse. Perciò la
giustificazione morale dei
principi di giustizia (che
Rawls ha elaborato nella
Teoria del 1971) non è più
sufficiente: si tratta ora di
darne una giustificazione
puramente politica11, cioè
una giustificazione che non
dipenda dall’assunzione di
unateoriamoraledeterminata
nédall’accettazionedialcuna
«dottrinacomprensiva»,esia
quindi ricevibile da ogni
persona ragionevole, quali
che siano i suoi orientamenti
ideali e morali. Con
Liberalismo politico (1993)
Rawls si propone appunto di
mostrarecheisuoiprincipidi
giustizia possiedono questi
requisiti: essi sono tali da
poter essere accettati da tutte
le persone ragionevoli, quali
che siano le loro credenze
filosofiche,moralioreligiose,
come principi che fissano
equi
termini
della
cooperazione sociale. Le
persone ragionevoli sono
infatti quelle che, prendendo
atto come di un fatto
ineliminabile e positivo del
pluralismo che caratterizza le
società moderne, intendono
ricercare
principi
di
cooperazione sociale che
siano accettabili per tutti,
mentre irragionevoli sono
coloro che pretendono di
imporre ad altri di vivere
secondo la loro visione
religiosa, morale o filosofica.
Se si vuol dar luogo a una
cooperazione sociale equa,
cioèrettadaprincipichetutte
le
persone
ragionevoli
possano accettare, allora
questi principi devono essere
scelti dal punto di vista della
posizione originaria, cioè da
un punto di vista che non
privilegia
nessuno.
A
proposito dei principi di
giustizia, dunque, potrà
realizzarsi quello che Rawls
definisce un «consenso per
intersezione» (overlapping
consensus), cioè un’adesione
non solo da parte di coloro
che hanno una visione
liberale della vita e della
politica, ma anche di quanti,
partendo da dottrine diverse
(per esempio cattolici o
socialisti)
giungono
attraverso loro ragioni a
condividere i medesimi
principi.
Dopoavermostratocome
i suoi principi possano
costituire la base per la
convivenza, all’interno dello
stato, tra i cittadini liberali e
quelli che si riconoscono in
altre
visioni,
purché
ragionevoli, Rawls riflette
infine (Il diritto dei popoli,
1999) sui principi che
dovrebbero
regolare
la
convivenza tra popoli, e in
particolaretraipopoliliberali
e quelli che non lo sono, che
hanno idee di giustizia
differenti, e che si possono
definire, nella prospettiva di
Rawls,
come
«popoli
gerarchici decenti» (Rawls
propone
l’esempio
immaginario del Kazanistan,
un paese islamico che non
accettaseparazionetrastatoe
Chiesa, che però rispetta i
fondamentali diritti umani, e
che, anche se non è
democratico,
prevede
istituzioni di consultazione
dei vari gruppi che lo
compongono). Tra i principi
che verrebbero scelti, in una
posizione originaria, dai
rappresentanti dei popoli per
regolarelaloroconvivenzavi
sono, accanto a quelli
tradizionali che implicano il
rispetto dell’indipendenza,
dellasovranitàedeitrattati,il
principio che «i popoli sono
tenuti a onorare i diritti
umani» e quello secondo il
quale: «i popoli hanno il
doverediassisterealtripopoli
che versano in condizioni
sfavorevoli tali da impedire
loro di avere un regime
sociale e politico giusto o
decente»12.
2.Alternativealla
teorìadellagiustizia.
LateoriadiRawlsnonha
solo
suscitato
una
straordinaria
mole
di
discussioni, ma è stata anche
all’origine di teorizzazioni
alternative,chehannoassunto
quellarawlsiana,inmodopiù
omenodiretto,cometermine
di paragone o di riferimento
polemico.
2.1.Illiberismodi
RobertNozick.
Col suo testo del 1974
Anarchia, stato, utopia13,
Robert Nozick ha proposto
una visione della giustizia
radicalmente alternativa a
quella di Rawls, che rientra
nel filone di un liberalismo
liberista e antiegualitario, e
checertamenteaffondalesue
radicinelpensierodelgrande
economista e pensatore
liberistaFriedrichvonHayek.
Il punto di partenza della
riflessionediNozicksonogli
individui con i loro diritti,
concepiti
lockianamente
comediritticheappartengono
a essi prima e a prescindere
dall’istituzione dello stato.
Gli individui sono liberi e
padronidisé,enessunohail
dirittodiusarli,controlaloro
volontà, per i propri scopi.
Immaginiamo,
dunque,
suppone Nozick, che questi
individui si trovino a vivere
nello stato di natura, ovvero
nella condizione pre-statuale;
per ovviare ai mali di questa
condizione, messi in rilievo
nella
tradizione
giusnaturalistica, non è però
necessario imboccare la
strada del contratto, visto
come unico modo per
generare uno stato legittimo.
In modo più semplice e
lineare, dice Nozick, la
nascitadellostatolegittimosi
può spiegare secondo una
logicanondicontratto,madi
mercato: per garantirsi la
sicurezza, gli individui
cominceranno dapprima a
costituire associazioni di
mutua protezione, e poi, con
la divisione del lavoro, ad
acquistare protezione da
compagnie costituite da altri
individui-imprenditori
per
vendere questo servizio. I
problemi
derivanti
dall’esistenza di una pluralità
di compagnie di protezione
avranno come conseguenza
che, su uno stesso territorio,
resterà prima o poi una sola
compagnia di protezione
dominante. Poiché l’adesione
alla compagnia di protezione
è volontaria, alcuni potranno
sceglieredirestarnefuoriedi
continuareafarsigiustiziada
soli; ma ciò comporterà
problemi
di
difficile
soluzione in caso di
controversie tra gli affiliati
alla compagnia (che hanno
delegato a essa la protezione
e la soluzione delle
controversie)
e
gli
indipendenti. Per garantire ai
propri clienti sicurezza e
corrette
procedure
di
risoluzione dei conflitti, la
compagnia di protezione
dominante dovrà dunque
proibire agli indipendenti di
farsi giustizia da soli; ma
questo, secondo Nozick, non
violerà i loro diritti se, come
risarcimento
della
proibizione, la compagnia
estenderà loro la sua
protezione e il suo soccorso
nellarisoluzionedeiconflitti.
Si giunge così, attraverso un
meccanismo governato da
una
smithiana
«mano
invisibile», alla genesi dello
statominimo,cheèlegittimo
perché nasce senza violare i
dirittidinessuno:colorocuiè
stato impedito, per la
sicurezza di tutti, di farsi
giustizia da soli, sono stati
infatti
risarciti
con
l’elargizione gratuita dei
servizi di protezione e non
hanno quindi subito alcun
torto.Conquestoprimopasso
Nozickvuoldimostrarecheè
possibile dar luogo alla
costituzione di uno stato
(minimo) legittimo anche
senza passare per un
contratto;
tuttavia,
l’inclusione forzosa degli
indipendenti nello stato, per
quantolirisarciscadiciòche
perdono, sembra piuttosto in
contrasto con l’impostazione
libertaria che Nozick stesso
afferma di voler difendere, e
rischia
perciò
di
compromettere la tenuta di
tuttalasuacostruzione.
Ilpassoulterioreèquello
che concerne la teoria
della proprietà: dopo aver
negato la base contrattualista
della teoria di Rawls, Nozick
ne contesta anche gli esiti
egualitari e redistributivi.
L’assuntodipartenzaèmolto
vicinoaquellolockiano:seio
sonoliberoovveropadronedi
me stesso, sono padrone
anche dei miei talenti e delle
mie capacità e di ciò che
grazieaessiriescoaprodurre
o a guadagnare: quindi, se
uno stato «più che minimo»
miimponedipagaretasseper
finanziare servizi sanitari o
educativi, o sussidi per i
disoccupati e gli indigenti,
esso dà luogo a una
violazione dei miei diritti di
autoappartenenza.
Perciò,
tanto legittimo è lo stato
minimo, quanto illegittimo è,
per contro, uno stato che
voglia assumersi compiti più
ampi rispetto a quelli di
garantire la sicurezza e
l’amministrazione
della
giustizia, e che pretenda di
imporretasseaisuoicittadini
aquestoscopo.L’unicateoria
della giustizia accettabile si
traduceperciò,perNozick,in
una«teoriadeltitolovalido»:
ognuno
possiede
legittimamente ciò che ha
acquisito o attraverso una
giustaacquisizioneiniziale,o
attraverso
un
libero
trasferimento del bene da
qualcunoaqualcunaltro.
La critica di Nozick alle
politiche
egualitarie
o
redistributive,
dunque,
funziona
soltanto
a
condizioneche:
a)sipossapensareuna
genesi legittima dello stato
senzapassareperilcontratto;
b) le proprietà e le
ricchezze
attualmente
possedutesianoilrisultatodi
acquisizioni iniziali giuste e
di conseguenti legittimi
trasferimenti. (Altrimenti si
dovrebbe dar corso, secondo
lo stesso Nozick, alla
redistribuzionediproprietàla
cui storia pregressa non
soddisfi i requisiti di
legittimità).
Entrambe
queste
assunzioni, però, sembrano
difficilidasostenere:laprima
per i motivi che abbiamo già
accennato, la seconda perché
presuppone che si possa
ricostruire dall’origine la
storia
delle
proprietà
attualmente possedute e che
in essa non si riscontrino atti
di usurpazione, conquista,
violenza
ecc.
Essendo,
dunque,
altamente
problematici i presupposti,
sembra difficile trarre dallo
schemateoricodiNozickuna
argomentazione stringente
per contestare le politiche
statali egualitarie di impianto
rawlsiano.
2.2.Lacritica
comunitariadel
liberalismo.
Un’altra
linea
di
riflessionechesièsviluppata
in polemica diretta nei
confronti di Rawls è quella
spessoindicataconl’etichetta
genericaeforseancheunpo’
fuorviante
di
«comunitarismo». A questo
orizzonte di pensiero sono
stati ricondotti autori che in
realtà perseguono progetti
teorici tra loro molto diversi
come
Michael
Sandel,
Alasdair
Mac-Intyre14,
Charles Taylor”. Se vi è un
punto che accomuna questi
pensatori,aldilàdellegrandi
differenze che pure li
caratterizzano,èlacriticanei
confronti di alcuni assunti di
fondodellateoriarawlsiana,e
del liberalismo più in
generale.
L’obiettivo polemico di
questi
pensatori,
come
scriveva Sandel in uno dei
libri che hanno aperto il
dibattitosulcomunitarismo,è
quell’impostazione
dominante nel liberalismo
contemporaneo in forza della
quale «la società, essendo
composta da una pluralità di
persone,ciascunaconipropri
fini,interessieconcezionidel
bene, è meglio ordinata
quando è governata da
principi che di per sé non
presuppongono
alcuna
particolare concezione del
bene; ciò che giustifica
soprattutto questi principi
normativi non è il fatto che
essi
massimizzino
il
benessere
sociale
o
promuovano altrimenti il
bene, quanto piuttosto che
sianoconformialconcettodi
diritto, una categoria morale
datacheprecedeilbeneedè
indipendente da esso. Questo
è il liberalismo di Kant e di
gran parte della filosofia
morale
e
politica
contemporanea, ed è questo
liberalismo che mi propongo
dimettereallaprova»16.
Obiettivo polemico delle
impostazioni comunitarie è
dunqueinprimoluogolatesi
liberale della priorità del
giusto sul bene, che si regge
su alcune assunzioni di base
che costituiscono il filo che
lega la critica kantiana del
paternalismo politico al
liberalismo contemporaneo:
1) vi sono molte concezioni
del bene o visioni della vita
buona in disaccordo tra loro;
2) non ci sono ragioni
dirimentipersceglierneunaa
scapitodellealtre;3)compito
della società è solo garantire
che
ciascuna
ricerca
individuale della vita buona
possa svilupparsi al meglio e
senzadetrimentoperglialtri.
La
politica
liberale
pretende, per dirla con
Maclntyre, di essere ispirata
solo da regole che devono
essere «neutrali rispetto a
insiemi di credenze rivali e
concorrenti intorno alla
migliore maniera di condurre
una vita umana»4. Ma la
domanda che i critici del
liberalismo si pongono è
duplice: questa neutralità
delle istituzioni politiche
rispetto alle diverse visioni
del bene o della vita buona è
realizzabile?E,ammessoche
lo
fosse,
sarebbe
desiderabile?
Pensatori come Sandel e
Maclntyre
rispondono
negativamente a entrambe le
questioni. A proposito della
prima, basta addentrarsi in
materie dove le controversie
sono scottanti per vedere che
si danno importanti conflitti
normativi circa i quali è
praticamente
impossibile
individuare norme capaci di
posizionarsi rispetto a essi in
modo
neutrale:
ogni
normazione implica scelte
che
inevitabilmente
privilegiano l’una o l’altra
delle visioni del bene
alternative. Come è stato
scritto, per esempio, «il caso
dell’aborto - ma si potrebbe
citare anche la discussione
intorno alla pena di morte o
all’eutanasia - mostra quanto
sia
illusoria
quella
separazione tra giustizia e
visioni del bene su cui fa
perno l’idea liberale di
neutralità delle istituzioni.
Nel caso di questi moral
issues il terreno su cui una
posizione
neutrale
può
attestarsi è virtualmente
ridotto a zero. Non si vede
come si possa svincolare il
giudizio
legale
sull’ammissibilità dell’aborto
... da una presa di posizione
morale sul diverso status
dellavitadelfetorispettoalla
vita del neonato, né come si
possa
decidere
sulla
ammissibilità della pena di
morte o dell’eutanasia senza
prender posizione fra diverse
concezioni della persona
umana»18.
Se ci si incammina
decisamentesuquestastrada,
come fa per esempio Sandel,
la tesi rawlsiana circa la
priorità del giusto sul bene
viene
completamente
rovesciata:lasceltadinorme
giuste non può pretendere di
restare neutrale fra visioni
controverse del bene, anzi
nonpuòevitaredischierarsia
favore dell’una o dell’altra
delle visioni del bene
alternative. Ma c’è di più:
nellaprospettivadiSandel(e
qui emerge l’orientamento
propriamente comunitario, e
fortemente discutibile, della
sua riflessione), gli individui
non sono neppure in
condizione di scegliere in
senso proprio, quasi fossero
soggetti astratti e disincarnati
da legami e impegni
normativi (punto sul quale
insiste, da buon hegeliano,
Charles Taylor), tra visioni
alternative di quella che è la
vitabuonaperloro.L’identità
dell’io è consustanziale, per
Sandel, alla sua visione del
proprio bene, che certo
l’individuo può modificare
attraverso le esperienze e i
processi di formazione, ma
dalla quale non si può
distanziare assumendo un
puntodivistaesterno,perché
con essa ne va della sua
identità. Rispetto alle diverse
visioni del bene, quindi, non
si dà un punto di vista
superiore
e
imparziale
muovendo dal quale esse
possano essere giudicate e
distanziate, poiché esse non
sono l’oggetto su cui si
giudica, ma piuttosto lo
strumentoel’orizzontegrazie
al quale formiamo i nostri
giudizi.
Esse
sono
inestricabilmente intrecciate
col
nostro
modo
di
identificarci come persone e
con le forme di vita e di
comunità
alle
quali
apparteniamo,enellequalila
nostra identità si forma.
Perciò il comunitarismo
contrapponeaunavisionedel
giusto astratta e neutrale una
visionedelbenesostanzialee
situata: essa si radica in
quella imprescindibilità del
legame di comunità sociale
grazie al quale esistiamo
come
soggetti;
all’individualismo liberale,
giudicato
astratto
e
atomistico, si contrappone la
consapevolezza, fortemente
nutrita, soprattutto in Taylor,
di riferimenti hegeliani, del
carattere costitutivo che il
nesso sociale, e il tessuto
normativo che lo rende
possibile,
ha
per
le
personalitàindividuali.
Per gli autori che si
muovono lungo questa linea
di pensiero, dunque, l’ideale
liberaledellaneutralitànonè
attingibile: se anche fosse
attingibile, però, non sarebbe
comunquedesiderabile,anche
perché i singoli individui
possono non essere in grado
di giudicare in modo
razionale e ponderato quale
siaillorobene,edunquenon
viènulladimaleselasocietà
e la politica esercitano una
funzione di guida e di
indirizzo, anche attraverso
norme (Sandel difende, per
esempio, quelle che limitano
la libertà della pornografia)
ispirate non da una
impossibileneutralitàliberale
ma da una visione sostantiva
delbenecomune.
Le difficoltà o le aporie
interne alle posizioni di tipo
comunitario non sono poche,
e sono state prontamente
messeinrisalto;perunverso
esse non fanno i conti con
l’ampiopluralismoculturalee
religioso che caratterizza
ormai le società occidentali
moderne: in esse appare
semprepiùdifficiletracciarei
confini di un «noi» e dei
corrispondenti
valori
condivisi.Insecondoluogola
tesi, che troviamo per
esempio
in
Maclntyre,
secondo la quale ogni
giudizio
normativo
è
formulato dall’interno di una
tradizione, e ne dipende, dà
adito a risultati paradossali:
se
la
tesi
della
intrascendibilità
delle
tradizioni appartiene essa
stessaaunatradizione,allora
nonhacogenzaperchinonsi
riconoscainquellatradizione
(non è un enunciato teorico
che tutti debbano accettare);
se invece trascende le
tradizioni - ponendosi come
tesi universalmente valida allora smentisce il suo stesso
assunto«contestualista».
E tuttavia, come spesso
accade, se assai debole è,
nelle posizioni comunitarie,
lapartecostruttiva,altrettanto
non può dirsi per la parte
critica: anche quando si
definisce l’estensione o la
portata
delle
libertà
fondamentali, come abbiamo
visto, è difficile evitare di
prendereposizionetravisioni
controversedelbeneodicosa
sia la vita buona per l’uomo.
E ciò vale a maggior ragione
quando si affrontano i
problemi della giustizia
distributiva, e cioè di quali
benidebbanoessereassegnati
eachi.
2.3.AmartyaSen
elateoriadelle
capacità.
Nella
prospettiva
rawlsiana questo difficile
problema si risolve con il
ricorso alla teoria dei beni
principali, sulla quale Rawls
ritorna più volte nel suo
itinerario
teorico
apportandole anche alcuni
significativi cambiamenti19.I
beni primari costituiscono
strumenti necessari per il
perseguimento di tutti gli
scopi umani, e quindi per il
perseguimento delle diverse
concezionidelbenedicuigli
individui, in una società
pluralistica, sono portatori:
essenzialmente,
essi
includonolelibertàdibase,la
libertà di movimento e la
libera scelta del tipo di
occupazione, il potere e le
prerogative delle cariche e
delle
posizioni
di
responsabilità, il reddito e la
ricchezza, e infine quelle che
Rawls chiama le basi sociali
del rispetto di sé20. I beni
primari, precisa Rawls nel
saggio del 1988 su La
priorità del giusto, non sono
lecosechequalcunopotrebbe
desiderare di più in base alla
sua dottrina comprensiva
ovvero alla sua visione del
bene:
«essi
non
corrispondono ai valori
fondamentali della vita
umana praticamente per
nessuno. Qualcuno potrebbe
sostenere,
perciò,
che
concentrarsi sui beni primari
significa intervenire in buona
parte nello spazio sbagliato...
»21. Ma in realtà non è così,
perRawls,poichél’indicedei
beni primari fa parte di una
concezione politica della
giustizia,equindideveavere
semplicemente la funzione,
datoilfattodelpluralismo,di
criterioaccettabiledatuttiper
giustificare le richieste in
conflittotralorodeicittadini.
Restano
però
delle
difficoltà: per un verso
sembra difficile sganciare la
formulazione della lista dei
beni primari da una qualche
visione sostantiva (e perciò
controversa) di cosa sia bene
pergliuomini.Peraltroverso
sorge un problema sul quale
si è concentrata soprattutto
l’attenzionedell’economistae
premio Nobel Amartya Sen.
Vi sono due modi in cui
qualcuno
può
essere
svantaggiato
da
una
distribuzione anche eguale di
beni primari: può esserlo in
quanto la sua personale
ricerca della vita buona può
giovarsi meno, rispetto ad
altri, del paniere di beni
messoasuadisposizione,per
motivi attinenti alla dottrina
comprensiva nella quale egli
si riconosce. Ma qualcuno
puòesseresvantaggiatoanche
perché, indipendentemente
dalla dottrina comprensiva
cui aderisce, a parità di
dotazione dei beni primari,
ottiene acquisizioni inferiori,
adesempioperchéèportatore
di una qualche forma di
disagioodihandicap:aparità
di beni primari, per esempio,
chi è costretto ad affrontare
spese ingenti per cure
mediche
avrà
minori
possibilità di condurre una
vitasoddisfacente.
Il punto sul quale Sen
insiste,dunque,èchevisono
molte condizioni personali e
sociali che influenzano la
conversione di redditi e
risorseinqualitàdellavita 22.
Se quest’ultima è ciò che ci
deve interessare, allora per
Sen è più opportuno porre in
primo piano non i beni
primari in quanto strumenti
per perseguire i propri fini,
madirettamentela«vitareale
che la gente riesce a vivere
(o,facendounpassoinpiù,la
libertàdi realizzare vite reali
cui si possa a ragion veduta
darevalore)»23.
Proprio per mettere a
tema questo aspetto, che si
può definire anche «libertà
sostanziale», Sen introduce
due concetti che sono
caratteristici per la sua
riflessione,
quelli
di
«funzionamento»
e
«capacitazione»: «Il concetto
di ‘funzionamento’, le cui
radici sono chiaramente
aristoteliche,riguardaciòche
una persona può desiderare in quanto gli dà valore - di
fare o di essere. Questi
funzionamenti cui viene
riconosciuto un valore vanno
dai più elementari, come
l’esserenutritoasufficienzae
il non soffrire di malattie
evitabili, ad attività o
condizioni personali molto
complesse, come l’essere in
grado di partecipare alla vita
della comunità e l’avere
rispetto
di
sé.
La
‘capacitazione’
di
una
persona non è che l’insieme
dellecombinazionialternative
difunzionamenticheessaèin
gradodirealizzare.Èdunque
unaspeciedilibertà:lalibertà
sostanziale di realizzare più
combinazioni alternative di
funzionamenti (o, detto in
modo meno formale, di
mettereinattopiùstilidivita
alternativi)»24.
Nella prospettiva di Sen,
insomma,
la
società
desiderabile non è quella che
massimizza la dotazione di
beniprimaripergliindividui,
ma quella che massimizza la
lorolibertàsostanziale,intesa
come possibilità di scelta tra
diversi
insiemi
di
‘funzionamenti’.Manontutti
i funzionamenti hanno la
stessaimportanza;l’eticaela
teoria politica, per Sen,
devonooccuparsianchedella
questione di quali siano «i
funzionamenti da includere
nell’elenco
delle
cose
importanti da realizzare»25.
La qualità della vita delle
persone,spesso,secondoSen,
può non essere colta bene
attraverso
una
misura
standardizzata come quella
del reddito; altre variabili
possono essere decisamente
più importanti (come per
esempio la mortalità, la
morbilità, l’istruzione, la
libertà e i diritti). Ma, per
poter dire questo, bisogna
entrarenelcampodeigiudizi
di valore, ovvero della
discussione pubblica su quali
siano i funzionamenti che
consideriamo più essenziali
per una buona qualità della
vita degli individui. In tal
modo, il problema del bene
(che il primato rawlsiano del
giusto voleva relegare sullo
sfondo) rientra decisamente
in primo piano nella
riflessionediteoriapolitica;e
questo accade in modo ancor
piùdecisonellariflessionedi
una pensatrice come Martha
Nussbaum26, che riabilita
senzaincertezzeunapproccio
di tipo aristotelico e una
teoriadelbene.Delresto,non
è detto che l’approccio del
giusto e quello del bene
debbano essere alternativi:
essi
possono
anche
compenetrarsi
reciprocamente,nelsensoche
una teoria della giustizia
stabilisce come e perché tutti
devono avere accesso ai beni
fondamentali, mentre una
teoria dei beni si occupa
appuntodellanaturadiquesti.
3.Habermasela
teoriadellademocrazia.
La riflessione politica di
Habermas
si
radica
fortemente
all’interno
dell’orizzonte di teoria
morale elaborato dallo stesso
Habermas e da Karl-Otto
Apel nella chiave di un’etica
del discorso. Alla base della
teoria della democrazia che
Habermas costruisce in Fatti
e norme vi è infatti un
principio che definisce, in
chiavediscorsiva,cosadebba
intendersipernormavalida,e
che
Habermas
chiama
«principio del discorso»:
«sono valide soltanto le
norme d’azione che tutti i
potenziali
interessati
potrebbero
approvare
partecipando a discorsi
razionali»5.
Nell'ambitodellafilosofia
pratica,
però,
bisogna
distinguere fra due tipi di
norme d’azione: le norme
morali e le norme giuridiche.
Il principio del discorso,
perciò, dev’essere specificato
e differenziato per divenire
idoneo a generare norme dei
due diversi tipi. Da esso
discendono, quindi, tanto un
principio
morale
di
universalizzazione (le norme
valide sono quelle che tutti i
coinvolti
potrebbero
discorsivamente
accettare
perchéleconseguenzechene
derivano per gli interessi di
ciascun
singolo
sono
preferibili a quelle che
deriverebbero da norme
alternative)
quanto
un
principio concernente le
norme giuridiche legittime,
che Habermas chiama il
principio
democratico:
«Possono pretendere validità
legittima solo le leggi
approvabili da tutti i
consociati in un processo
discorsivodistatuizioneasua
volta
giuridicamente
costituito»28.
Il
principio
della
democrazia, che sta a
fondamento della teoria
politicadiHabermas,èquindi
il punto d’incontro tra lo
strumento del diritto, che è
indispensabile per regolare le
interazioni sociali nelle
società moderne, e il
principio
dell’accordo
discorsivo di tutti gli
interessati,sulqualesolopuò
fondarsi la validità di norme
pratiche;
il
principio habermasiano della
democrazia ci dice quindi
che, per essere legittime, le
norme
giuridiche
che
governano
la
nostra
convivenza sociale devono
essere il risultato di processi
discorsivi precisamente e
rigorosamente
istituzionalizzati,
capaci
quindi di generare un diritto
legittimo
in
quanto
discorsivamentefondato.
Questo è appunto il
compitodelleistituzionidella
democrazia. Superando la
dicotomia
che
ha
caratterizzato tanta parte del
pensieropoliticomodernotra
le
libertà
liberali
dell’individuo privato e la
sovranità popolare teorizzata
dai democratici (a partire da
Rousseau), Habermas ritiene
che la democrazia debba
essere pensata a partire non
da una contrapposizione ma,
alcontrario,daunrapportodi
cooriginarietà
e
di
complementarità
tra
l’autonomia
liberale
dell’individuo privato e
l’autonomia pubblica dei
cittadini: diritti individuali e
sovranità
popolare,
se
rettamente intesi, non stanno
inconflitto,masiintegranoe
si
presuppongono
reciprocamente.
Se
la
sovranità popolare viene
compresa come un grande
processo
discorsivo
(istituzionalizzato
in
procedure e norme) essa
presuppone che gli individui
che vi partecipano siano
tutelatinellelorolibertàenei
loro diritti: i diritti degli
individui, quindi, per un
verso sono condizioni del
processo
democratico,
presuppostiindispensabilidel
suo svolgimento, mentre per
altro verso ne sono anche il
risultato, poiché i diritti sono
anche quelli che i cittadini
democratici
si
autoattribuiscono.
I diritti fondamentali che
definiscono l’assetto di uno
stato democratico devono
essere pensati, perciò, come
quei diritti che i cittadini
devono
riconoscersi
reciprocamente,
quando
decidono
di
regolare
legittimamente
la
loro
convivenza con strumenti
giuridici:idiritti,quindi,non
preesistono alla comunità
politica, ma la comunità
politica, a sua volta, non può
prescinderedaidiritti.
I diritti fondamentali che
costituiscono l’architrave di
una democrazia formano,
secondo Habermas, un
sistema articolato in diverse
categorie;
compito
del
filosofo politico è appunto
quello di indicare le grandi
categoriedidirittichedevono
esserepresentiinunlegittimo
statodemocratico:staràpoiai
cittadini
riempire
di
contenutoquestoschema.
Itipididirittivengonoda
Habermascosìindicati:
1) diritti che tutelano le
parilibertàindividuali(cioèi
classicidirittiliberali);
2) diritti che
definiscono lo status di
membro associato, cioè a
qualetitolosiappartieneaun
certodemos;
3) diritti ad agire in
giudizio per la tutela dei
propridiritti;
4)dirittiapartecipareai
processi
discorsivi
di
creazione del diritto, cioè
dirittiaesercitarel’autonomia
politica
(ovvero
diritti
democratici);
5) diritti di ripartizione
sociale, cioè diritti a godere
di condizioni di vita che
consentano di utilizzare con
pari opportunità i diritti
elencatineipuntida1a429.
Per Habermas i diritti,
come si diceva, formano un
sistema nel senso che tutti i
tipi di diritti sopraelencati
sono necessari perché si
possa avere una democrazia
ben funzionante. Inoltre,
proprio perché il centro
focale della sua riflessione è
la democrazia, Habermas
include (nel punto 5 del suo
sistema dei diritti) i diritti
sociali, non in quanto fine a
se stessi, ma piuttosto in
quanto precondizioni per il
pienoeserciziodituttiglialtri
diritti. Per Habermas, si
potrebbe dire quindi: il fine
dellasocietànonèlagiustizia
sociale,maessaè,inqualche
misura, imprescindibile in
quanto condizione della
democrazia.
Nella democrazia il
discorso si istituzionalizza
grazie a un sistema di diritti;
ma con ciò si genera anche
quella che è la sua più
caratteristica
ambiguità.
Fondandolasualegittimitàsu
procedure discorsive (a due
livelli, quello informale
dell’opinione pubblica e
quello istituzionalizzato dei
parlamenti) la comunità
democratica dei cittadini per
unversopresupponechetutti
partecipino alla ricerca
cooperativa delle soluzioni
migliori;peraltroverso,però,
consente anche che ognuno
prenda parte al processo
democratico facendo un uso
puramente
strategico
e
autointeressato dei propri
diritti.Lademocraziacomela
pensa Habermas è dunque
strutturalmente aperta a due
esiti ben diversi: i titolari di
diritti possono accogliere
l’invito a misurarsi con gli
altrisulterrenodeldiscorsoe
a confrontarsi ricercando gli
argomenti migliori (e in tal
modo la sostanza discorsiva
della democrazia prende
corpo e si sviluppa) oppure
possono usare i loro diritti di
comunicazione
e
di
partecipazione solo come
strumento per perseguire
strategicamente i propri
interessiegoistici.
Proprio
perché
si
mantenga viva la fragile
sostanza comunicativa della
democrazia,èimportanteche
il Parlamento, ovvero il
discorsoistituzionalizzato,sia
sempre
stimolato
e
controllatodaldiscorsolibero
e informale che si svolge
nella sfera dell’opinione
pubblica,
attraverso
la
stampa, i movimenti, le
iniziative dei cittadini. La
sovranità
popolare
discorsivamente pensata ha
bisogno,pernonimpoverirsi,
di entrambi questi aspetti: la
deliberazione formale in sedi
istituzionalizzate, da un lato,
e il dibattito informale
dell’opinione
pubblica
dall’altro. Essa richiede
inoltre che venga arginata
l’invadenza di quei poteri
sociali che, colonizzando in
vario modo, grazie al
possesso
di
risorse
economiche, i mezzi di
comunicazione e il dibattito
pubblico, costituiscono una
minaccia per l’autentica
sostanza discorsiva della
democrazia.
Ilcarattere«esigente»del
modello habermasiano di
democrazia si mostra anche
nellacriticacheeglirivolgea
un modello di democrazia da
lui considerato minimale,
come per esempio quello
proposto anni addietro da
Norberto
Bobbio.
La
traduzione bobbiana della
democrazia in una serie
definita di requisiti minimali
non
coglie,
secondo
Habermas,«lasostanzad’una
concezione
genuinamente
proceduralista
della
democrazia». Con Dewey, e
andando anche oltre le sue
riflessioni, Habermas ricorda
che fonda-mentale per la
democrazia non è tanto la
decisione a maggioranza,
quanto il processo discorsivo
che a essa ha condotto e che
«può svolgere funzioni
d’integrazione sociale solo
grazie all’aspettativa d’una
qualità ragionevole dei suoi
risultati»30. Ma questo è
possibile solo se la sovranità
popolare viene strutturata ed
esercitata in modo da
mantenersi conforme alla sua
natura
di
potere
comunicativo,
sostiene
Habermas riprendendo un
tema di Hannah Arendt. «A
stretto rigore - scrive
Habermas - questo potere
comunicativo
nasce
dall’interazionechesicreatra
una formazione della volontà
istituzionalizzata come stato
di diritto, da un lato, e sfere
pubbliche
culturalmente
mobilitate, dall’altro; queste
ultime,alorovolta,poggiano
sulle associazioni di una
società civile egualmente
separata sia dallo stato che
dall’economia».
Una delle principali
difficoltà che caratterizzano
la teoria habermasiana della
democrazia, però, è quella di
comprendere il rapporto che
in essa si stabilisce tra gli
aspetti normativi e quelli
descrittivi. Il modello della
democraziadeliberativanonè
inteso da Habermas come un
puro modello normativo, che
non abbia nulla a che vedere
con la realtà. Al contrario, i
processi di intesa discorsiva
sono ben radicati nelle
strutture dei mondi vitali
moderni, che si riproducono
anche grazie a essi; la
razionalità del discorso è per
molti versi già attiva e
operante nelle articolazioni
della società moderna, più di
quanto non vedano le teorie
«realistiche» che considerano
la democrazia solo come
conflitto strategico o mercato
politico:
«irrealistica
è
l’ipotesi
che
ogni
comportamento sociale possa
essere pensato come agire
strategico e dunque spiegato
in termini di calcolo
egocentrico e utilitaristico.
Questo modello ha una forza
di spiegazione sociologica
manifestamentelimitata»31.
Ma il rifiuto di una
visione puramente strategica
dell’agire
politico
democratico sembra talvolta
indurre Habermas a incorrere
nell’errore opposto, e cioè in
quella che è parsa ad alcuni
«una visione ampiamente
idealizzata
della
comunicazione,
e
in
particolare del dibattito
pubblico democratico»32. Le
ragionisullequalisibasauna
simile critica sono evidenti:
nelle democrazie reali, il
potenziale di razionalità
discorsiva può essere ridotto
o neutralizzato se l’opinione
pubblica viene manipolata e
colonizzata
dai
grandi
strumenti di comunicazione
di massa; l’influenza del
pubblico ragionante rischia
sempre di essere schiacciata
da quella delle lobbies e dei
grandi poteri sociali, di cui
anche
Habermas
appare
preoccupato, ma ai quali
dedica però solo poche e
rapide
considerazioni;
insomma, anche la politica
democratica del discorso
pubblico sembra dover fare
i conti, in modo più radicale
di quanto in Habermas non
accada, con la questione dei
poteri che si sottraggono alla
mediazione comunicativa, e
anzi le impongono il loro
pesantecondizionamento.
4.Lacrìticadel
normativismo:la
teoriadelpoteredi
Foucault.
Uno dei rimproveri che
più frequentemente si muove
alle teorie normative (tornate
prepotentementeinaugenegli
ultimi decenni) è proprio
quellodinonavereocchiper
la ineludibile dimensione del
potere e della forza che
caratterizzerebbe, quasi come
unasuacostantestrutturale,la
dimensione della politica, e
ne sarebbe inseparabile. Da
questo punto di vista, la
società giusta di Rawls o la
democrazia discorsiva di
Habermas finiscono per
apparire come una sorta di
astratte elucubrazioni, cieche
di fronte al dato che la
politica,
anche
nella
modernità
liberale
e
democratica,
non
può
svincolarsi dal suo fondo
duro e inquietante, da quel
polemos che ne ha sempre
costituitol’essenza.
Il pensatore che nel
Novecento ha radicalizzato
con maggiore energia la tesi
chelapolitica,nelsuoessere
più profondo, sia definita dal
conflittoirriducibiletraamico
enemicoèstatoCarlSchmitt;
ma, a partire da Schmitt, la
questione della politica come
ambito del potere, del
dominio,dellaforza,èstataal
centro di un ricchissimo
spettro di riflessioni che, pur
svolgendosi nelle direzioni
più differenti, sono però
accomunate
dalla
convinzione della vanità del
progetto normativistico, che
si propone di tracciare alla
luce della ragione (o della
ragionevolezza),lecoordinate
della società libera e giusta,
del
potere
«buono»,
addomesticato e ricondotto
alle
sue
sorgenti
comunicative.
Mentre Schmitt finisce in
sostanza per fare l’apologia
della politica come conflitto
senza quartiere, del suo
irriducibile nocciolo di
dominio, non mancano nei
tortuosi itinerari del pensiero
del Novecento percorsi di
riflessione che di quello
schmittiano
costituiscono
quasi
il
rovesciamento
speculare: in pensatori come
Simone Weil o Hermann
Broch la tesi che la politica
sia il puro regno della forza
vieneassuntacomeveritàma
al tempo stesso rovesciata di
significato: non più apologia
della
politica,
ma
consapevolezza tragica della
sua
irredimibilità33.
Il
realismo politico schmittiano
sta però alla radice anche di
un altro tipo di esito, quello
messianico-escatologico cui
dà luogo Walter Benjamin,
soprattutto negli scritti degli
anni Venti: se il diritto è,
quanto alla sua stessa
costituzione, violenza, allora
non ha senso ragionare
intorno al buon ordine
giuridico;sitrattapiuttostodi
collocarsi nell’orizzonte del
suo
trascendimento
messianico34.
Latesidellapoliticaodel
diritto come puro potere o
pura forza, non riconducibile
a una misura di giustizia, si
presenta quindi nel pensiero
del
Novecento
come
suscettibile di curvature tra
loro anche radicalmente
antitetiche:
dall’apologia
della forza che riduce la
giustizia a mero flatus vocis,
alla tesi che, piegando il
realismoinun’altradirezione,
mantiene si la giustizia ma
come qualcosa che non è di
questomondo,echehailsuo
luogo
solo
in
una
trascendenza extramondana o
escatologica. In entrambi i
casi, si vorrebbe dire, il
mondo degli uomini è
destinalmente assegnato a un
orizzonte di violenza e di
peccaminosità, che è tanto
poco razionalmente dicibile
(dirlo razionalmente, infatti,
significa già trascenderlo)
quantofortementesegnatoda
più o meno espliciti
presuppostiteologici.
Su una linea più
nietzscheana, a mio avviso,
che schmittiana, si colloca
invecequelloche,traiteorici
del potere, si conquista
comunque un rango di primo
pianograzieallasuaassoluta
originalità:conlesuericerche
genealogiche e micrologiche,
MichelFoucaultimprimealla
riflessione sul potere una
svolta che costituisce una
vera e propria rottura. Per
Foucault il potere è tanto
coestensivo con la realtà
umana e sociale quanto
irriducibile
ai
modi
tradizionali attraverso i quali
èstatorappresentato.
In primo luogo, il potere
non è qualcosa che si
concentri nella istituzione
statale o nei luoghi deputati
della sovranità, ma vive
piuttosto in un insieme di
pratiche che attraversano la
societàinognisuoaspetto:si
tratta perciò, per Foucault, di
costruireuna«microfisicadel
potere», di tracciarne le
mappe inseguendolo in tutte
le pratiche e istituzioni nelle
quali esso si incarna: dai
luoghidellareclusione,come
prigioni e manicomi, ai
luoghi di lavoro, dagli
ospedali
alle
pratiche
mediche, fino alle forme di
controllo sul corpo degli
individui e sulla sessualità.
Perciò - ed ecco un altro
aspetto
saliente
della
riflessione foucaultiana - tra
potere e sapere (per esempio
ilsaperemedico,psichiatrico,
sessuologico), tra potere e
forme del discorso, vi è una
interconnessione molto più
intrinseca e profonda di
quanto a prima vista non
appaia: non è che il potere
condizioniilsapere,lopieghi
ai propri scopi; non è così
perché sapere e potere sono
costitutivamente,
strutturalmente intrecciati:
«non
si
può
infatti
configurare un elemento di
sapere se, da un lato, non è
conforme a un insieme di
regoleecostrizionipropriodi
un certo tipo di discorso
scientificoinunadataepoca;
e se, d’altro canto, non è
dotato degli effetti di
costrizione tipici di ciò che è
convalidato come scientifico,
o semplicemente razionale o
comunque
recepito.
Viceversa
nulla
può
funzionarecomemeccanismo
di potere se non si afferma
con procedure, strumenti,
mezzi, obiettivi che possano
essere convalidati in sistemi
più o meno coerenti di
sapere»35.
Maproprioperlapotenza
costitutivacheappartienealla
diade potere/sapere, il potere
non
può
essere
più
rappresentato,
secondo
Foucault, come qualcosa che
semplicemente opprima e
reprima gli individui, i loro
bisognioleloropulsioni;più
radicalmente, il potere li
produce, li costituisce, ha
natura quindi non repressiva
maproduttiva·, esso struttura
e codifica le soggettività e i
comportamenti.
Per esempio, scrive
Foucault, non era ovvio che
«il
desiderio,
la
concupiscenza,
il
comportamentosessualedegli
individui
dovessero
effettivamente articolarsi gli
unisuglialtriinunsistemadi
sapere e di normalità
chiamato sessualità». Ma,
prosegue,
«comprendere
l’accettabilitàdiunsistemaè
inseparabile
dalla
comprensione di cosa lo
rendadifficiledaaccettare:la
suaarbitrarietàsottoilprofilo
della conoscenza, la sua
violenza in termini di
potere»36. Ma ciò significa
cheognistrategiaopraticadi
potere si scontra con attriti e
resistenze, ingaggia sempre
un conflitto con strategie di
potere concorrenti: in un
giocoagonisticodivolontàdi
potenzacheameparericordi
molto da vicino quello
nietzscheano.
Mailfattosingolareèche
Foucault, come è noto, non
intenderinunciareallospazio
della critica, anzi lo
rivendica: solo che, nella sua
prospettiva, la critica non è
qualcosachefacciaappelloa
un principio o criterio
razionale che trascenda il
potere, ma è (e non può
essere diversamente) tutta
interna
all’intreccio
conflittuale di strategie di
poterecuinellarealtàsociale
nulla è sottratto. Il paradosso
cui a mio avviso questa
posizione dà luogo è il
seguente: per un verso si
legge nietzscheanamente la
realtà con le categorie della
volontà di potenza, per altro
verso, a differenza di
Nietzsche, non si prende
partitoperlapotenza,maper
il contropotere, per le forme
di resistenza. Ma, se tutto è
forza, cosa motiva questa
presa
di
partito
?
Abbandonati gli ormeggi
trascendentali non resta che,
pura e infondata, la
«decisione di non essere
governati»37,
o,
più
precisamente, quello che
Foucault
chiama
un
«atteggiamento morale e
politico», che si potrebbe
definire semplicemente come
«l’arte di non essere
governati o, se si preferisce,
l’arte di non essere governati
in questo modo e a questo
prezzo»; pertanto, continua
Foucault, «proporrei come
prima definizione generale
dellacriticalaseguente:l’arte
di non essere eccessivamente
governati»38.
La
rinuncia
alla
riflessione
sul
potere
legittimo,motivatatantodalla
consumazione postmoderna
della razionalità e del
trascendentale, quanto dal
sospetto che questi criteri
mettano capo in fondo alla
legittimazione dei poteri
esistenti, lascia spazio solo
per una politica critica intesa
come
resistenza,
destabilizzazione,
decostruzione; una linea di
fuga che, se affascina molti
esponenti del pensiero soprattutto
francese
contemporaneo, resta però
consegnata, al di là dei suoi
discutibilipresuppostiteorici,
a una sorta di «cattiva
infinità», di circolo senza
uscita tra «governamentalità»
edecostruzione.
5.Femminismoe
teoriapolitica.
Ilproblemadifondodelle
teorie femministe è quello di
mettereatema,esottoporrea
critica, una forma di potere
tanto pervasivamente diffusa
nella società, quanto ignorata
dalle più influenti tradizioni
di teoria politica: il potere, o
la supremazia sociale, del
sesso maschile su quello
femminile. Sviluppata già,
alla fine del Settecento, negli
scrittidiMaryWollstonecraft
o di Olympe de Gouges, la
criticadelpatriarcatocomedi
uno degli assi portanti della
civiltà occidentale (e non
solo), diventa il centro di
sofisticate
elaborazioni
teoriche, le più importanti
delle
quali
vengono
sviluppateapartiredaglianni
SettantadelNovecento.
Una delle autrici più
influenti, a partire dalle quali
si sviluppa quello che verrà
definito come il pensiero
della differenza sessuale, è
Luce
Irigaray,
che
intraprende,apartiredallibro
del 1974 Spéculum. L’altra
donna39,unacriticadelmodo
in cui, all’interno dell’ordine
simbolico maschile (messo a
fuoco in un primo tempo
soprattutto attraverso la
lettura critica di Freud e di
Lacan), viene compresa e
rappresentata la donna, e in
modoparticolarelasessualità
femminile. Nella visione che
è propria di Freud e della
psicanalisi, sostiene Irigaray,
la
donna
è
vista
fondamentalmentecomenonmaschio, è letta attraverso le
categorie della «assenza» e
della«mancanza»,comecolei
che non possiede e «invidia»
l’organosessualemaschile:la
differenza sessuale, dunque,
non viene pensata nella sua
specificità e autonomia, ma
ridottaameraprivazione.
Questa
peculiare
svalorizzazionedelfemminile
è ciò che caratterizza da
sempre l’ordine simbolico
patriarcale. Il potere degli
uomini sulle donne nella
società,perciò,siradicae.fa
tutt’uno con un ordine
simbolico e con un sistema
deisaperi(equisiamovicini
all’intreccio foucaultiano di
potereesapere)cheassumeil
sesso
maschile
come
«paradigmadell’interogenere
umano»,inmodocherispetto
a esso «il sesso femminile
risulta non pienamente
umano, ossia umano ma di
gradoinferiore,incompiuto...
Visto che sugli uomini si
modella il genere umano per
eccellenza, il differire delle
donne dagli uomini diventa
una
differenza
che
corrisponde a una mancanza
o inferiorità»40. L’ordine
simbolico
patriarcale
(l’ordinechedaalcuneautrici
è
definito
come
«fallologocentrico»), dunque,
secondo
una
proposta
interpretativa che, come nota
Cavarero, è ampiamente
condivisa
dal
pensiero
femminista, si struttura come
un sistema a economia
binaria, duale e gerarchica,
dove
il maschile rappresenta il
polopositivoedominanteeil
femminile il polo negativo e
dominato; esempi di questo
modo di pensare bipolare
sono
le
dicotomie
cultura/natura,
ragione/passione,
mente/corpo,
pubblico/privato41.
Nell’ordine
simbolico
patriarcale, che è momento
inscindibile del dominio
maschile sulla donna, il
maschile si identifica con
l’universale, mentre la donna
è
privazione,
umanità
incompleta, e si definisce
attraverso quei caratteri che
l’uomoleattribuisceechela
donna stessa fa propri nella
suaautocomprensione.
A partire da questa linea
di riflessione si sviluppa
anche
una
critica
dell’eguaglianza
politica
moderna. In un primo tempo
essa
si
pone
come
eguaglianzadituttiicittadini,
dove resta inteso però che i
cittadini sono solo i maschi,
mentre le donne ne sono
escluse. Nel corso del
Novecento,
invece,
l’eguaglianza politica si
spinge a includere tutti gli
individui«senzadifferenzadi
sesso»;
ma
questa
inclusione nell’eguaglianza
nasconde però, sostiene
Adriana
Cavarero,
un
singolare paradosso: «Prima
coerentemente escluse, le
donne vengono poi incluse
attraverso una logica di
omologazione che prescinde
dal fatto che sono donne e
non uomini»42. In altre
parole,siconsentealledonne
di diventare uguali agli
uomini, mentre però esse
restano donne, e si vuole che
tali restino, «a tutti gli effetti
pratici e simbolici»: mentre
gliuominisicollocanosenza
attriti in una eguaglianza
pensata a loro misura, le
donne per entrarvi devono
rinunciare
alla
loro
differenza.
Mentre la linea di ricerca
che parte dalla Irigaray e si
sviluppa nel pensiero italiano
della differenza sessuale
intrattiene un dialogo critico
con i grandi autori del
pensiero europeo (Freud e
Lacan,
Heidegger
e
l’ermeneutica, Foucault e
Derrida),leteoriefemministe
nell’àmbito della cultura
anglosassone da una parte
recepiscono e radicalizzano i
temi del decostruzionismo
(come è per esempio il caso
diJudithButler)43, mentre in
altri settori sviluppano un
confronto ravvicinato con le
teorie morali e politiche
universalistiche che hanno in
Rawls il loro esponente di
maggiorprestigio44.
In questo contesto, una
tappafondamentaleèsegnata
dal lavoro di Carol Gilligan
(In a Different Voice, 1982)
chesviluppaunacriticadella
psicologia morale evolutiva
di Lawrence Kohlberg, alla
quale anche Habermas aveva
fatto
riferimento
per
corroborareearticolarelasua
teoria morale universalista.
Nei suoi studi di psicologia
evolutiva,Kohlbergdistingue
diversi livelli di sviluppo
della coscienza morale: da
uno stadio preconvenzionale,
in cui il fanciullo comprende
le nozioni di giusto e
sbagliato solo in termini di
punizioni e ricompense che
ne derivano, si passa a uno
stadio convenzionale, dove il
buoncomportamentoèquello
conforme alle regole date
dallafamigliaedallasocietà,
e infine a uno stadio
postconvenzionale, dove i
dilemmi morali non vengono
risolti col riferimento alle
regole di fatto vigenti, ma
richiamandosi a principi o
valori morali di tipo
universale. La riflessione
dellaGilligan45partedalfatto
che, poste di fronte ai test
usati da Kohlberg per
misurare il livello di
consapevolezza
morale
raggiunto da un soggetto, le
ragazze
tendevano
a
collocarsi ai livelli più bassi,
senza raggiungere quello
considerato da Kohlberg
come lo stadio più elevato di
consapevolezzamorale.
Gilligan
propone
un’interpretazionealternativa,
rispettoaquelladiKohlberg,
di questa situazione: il fatto
che le donne tendano in
generale a non risolvere i
dilemmi morali in base a
principi astratti e universali
nonsignificachenonabbiano
raggiunto un completo
sviluppo della competenza
morale (come si dedurrebbe
dalla teoria di Kohlberg), ma
èpiuttostoindicedelfattoche
l’etica femminile si lascia
guidare da orientamenti
diversi che, se misurati sulla
scala presunta universale di
Kohlberg, appaiono come
inferiori. Per esempio, a un
testchechiedeseunsignore,
la cui moglie è gravemente
malata, e che non ha i soldi
per le medicine, fa bene a
rubarle, i soggetti maschi
tendonoarisponderedisì,in
base a principi generali e
astratti come per esempio
quello che la vita di una
persona è più importante del
diritto di proprietà. Le
risposte dei soggetti di sesso
femminile sono invece più
sfumate e articolate, più
attente a tutti i problemi del
contesto (per esempio: se il
maritoperrubarelemedicine
finisce in galera, chi si
occuperà della moglie malata
?)
Le conseguenze teoriche
che la Gilligan trae dalle sue
osservazioni sono molto
chiare;nelledonnesiosserva
unapproccioallamoralenon
inferiore, ma diverso da
quello più congeniale ai
maschi:lesceltegiustenonsi
ricavano
da
principi
universali ma, in modo
sensibile al contesto, dai
rapporti e dai legami
preesistenti, dalle aspettative
dichiattendechecisiprenda
cura di lui: «le donne hanno
più spesso a che fare con
istanze particolarissime e che
ci si aspetta che vengano
soddisfatte. Immerse come
sono in una rete di relazioni,
le donne sono indotte a
prendere sul serio sempre e
solo altri particolari, altri
concreti, come dice la
Benhabib, cioè caratterizzati
da bisogni che chiedono
risposte. Ed è questo
l'orientamento morale che le
donnehannoneiconfrontidel
mondo»46. Propria delle
donne, insomma, è un’etica
della cura, che si distingue
dall’etica universalistica dei
principi perché non ha il suo
termine di riferimento in un
«altro generalizzato», ma si
indirizza
alla
persona
concreta che esprime un
bisogno, una richiesta di
attenzioneediaiuto.Nonviè
dunque, secondo la Gilligan,
un unico parametro di
pensiero morale, un’unica
concezione del giusto: a
un’eticamaschiledeiprincipi
fa da contraltare un’etica
femminiledellacura.
Questaaffermazionedella
differenza femminile, però,
pone un problema che la
stessa teoria femminista ha
messo subito a fuoco:
sostenere
la
specificità
femminile nel senso di
un’etica della cura significa
iscriversi ancora una volta
nell’orizzonte
binario
dell’ordine
simbolico
patriarcale,
modificandolo
solo con una diversa
indicazione di valore: «la
donna come natura e come
essere
oblativo
è
precisamente ciò che l’uomo
posiziona, da millenni, come
altro da sé e per sé. Il gesto
femminista di cambiare il
segno
della
dicotomia,
esaltando il valore positivo
delle equazioni donna/natura
e donna/al truismo, contro il
valore
negativo
delle
equazioni uomo/tecnologia e
uomo/egoismo, più che
dissolvere
l’ordine
patriarcale,
dunque,
lo
legittima»47. In altre parole,
«quella della Gilligan è in
fondo la consacrazione del
ruolo tradizionale delle
donne»48, nel senso che non
fa altro che conferire valore
alla posizione che l’ordine
patriarcale ha da sempre
assegnatoalledonne.
Accantoaposizionicome
quelle fin qui ricordate, che
assumono come proprio
oggetto
polemico
l’universalismo della teoria
morale e politica, ve ne sono
altre che invece accettano in
qualche misura i presupposti
di questo universalismo, ma
non le conseguenze che in
genere se ne derivano: è il
caso per esempio della
riflessione di Susan Mol1er
Okin49.LaOkinsviluppa,dal
punto di vista delle donne,
una critica stringente di
alcune prospettive influenti
della
teoria
politica
contemporanea, come per
esempio il liberismo di
Nozick, il comunitarismo di
MacIntyre e la teoria della
giustiziadiRawls.
Alla teoria di Nozick,
Okinobiettache,sesiaccetta
l’assioma liberista secondo il
quale ciascuno è proprietario
diséediciòcheproducecol
suo lavoro e la sua fatica,
allorasenedovrebbetrarrela
conseguenza assurda che i
figli sono proprietà delle
donne, che faticosamente li
mettono al mondo. Al
comunitarismo, Okin fa
notare che le tradizioni di
pensieroeticoediriflessione
sulla vita buona che questo
vorrebbe valorizzare (in
particolare, nel caso di
Maclntyre, quella aristotelica
etomistica)prevedonoperle
donne
un
ruolo
irrimediabilmente subalterno,
e quindi non sono certo
tradizioni alle quali il
pensiero etico femminile si
possarichiamare.
Diversoèilgiudiziodella
Okin su Rawls: per l’autrice,
meritodiRawlsècertamente
quello di avere messo nel
giusto risalto il ruolo che la
famigliasvolge,nellasocietà,
comefattorechecondizionae
determina le opportunità di
cui gli individui possono
giovarsi. Il limite dell’autore
di Teoria della giustizia,
invece, è quello di non avere
tratto, dai principi che egli
pone alla base della sua
costruzione,
tutte
le
conseguenze che se ne
sarebbero potute ricavare, al
finedimettereindiscussione
la struttura sessista della
famiglia e della società
esistente: la critica della
Okin, quindi, non si rivolge
contro i principi della teoria
diRawls,mapiuttostocontro
ilmodoincuiegliliapplicae
lisvolge.Sesiapprofondisce
l’idea del velo di ignoranza,
assumendo che le parti in
posizione originaria non
conoscono il proprio sesso, e
se al tempo stesso si assume
latesi(enunciatadallostesso
Rawls) secondo la quale la
famiglia è una delle
istituzioni
sociali
fondamentali, allora se ne
deve trarre, andando oltre
Rawls,laconseguenzachele
parti in posizione originaria
dovrebbero preoccuparsi di
estendere anche alla sfera
familiare e ai rapporti di
genere i principi di giustizia,
cosa che implicherebbe una
sostanziale revisione del
modo in cui ha funzionato
fino ad oggi l’istituzione
familiare, ma anche una
riconsiderazione del modo in
cui i rapporti di genere sono
strutturatinellenostresocietà.
A differenza di altre
pensatrici
femministe,
dunque, la Okin non
sottopone a critica i
presupposti
di
fondo
dell’universalismo; pensa, al
contrario, che li si debba
prendere sul serio più di
quanto la teoria politica non
abbia fatto, per criticare alla
lucediessiilsessismoancora
vigente nelle nostre società.
AllateoriadellaOkin,perciò,
sono state mosse delle
osservazioni
critiche
esattamenteopposterispettoa
quelle
indirizzate
alla
prospettiva della Gilligan:
concentrando
tutta
l’attenzione sulla giustizia
all’internodellafamigliaenei
rapporti di genere, la Okin
trascurerebbe la rilevanza
della differenza femminile, e
l’esigenza di politiche sociali
non meramente egualitarie
ma differenti. La sua
riflessione rappresenta quindi
unodeipoliall’internodiuna
discussione complessa e
intrecciata, che per un verso
rivendicaladifferenzacontro
un sedicente universalismo
che
è
in
realtà
discriminatorio, per altro
verso vede anche che la
differenza femminile è stata
in parte costruita dall’ordine
dominante del patriarcato, e
non è quindi un’essenza da
riattingere o da valorizzare.
Una questione difficile, che
porta la Okin a concludere,
dialogandoconlafemminista
radicale
Catharine
MacKinnon,
che
«non
possiamo in alcun modo
saperequantoecomedonnee
uomini siano diversi, fino a
quando non potremo vederli
in una situazione di
eguaglianza»50.
1 j. RAWLS, Una teoria
dellagiustizia(1971),trad.it.
Feltrinelli, Milano I99 75. P·
24·
2Ibid.,p.22.
3Perulteriorichiarimenti
su questo punto cfr. w.
kymlicka, Introduzione alla
filosofia
politica
contemporanea (1990), trad.
it.Feltrinelli,Milano1996,p75·
4
Come
sottolinea
giustamente
kymlicka,
Introduzione alla filosofia
politica contemporanea citp.
83.
5Rawls,Unateoriadella
giustiziacit„p.255,
6Ibid.,p.136.
7 s. Veca, Il paradigma
delle teorìe della giustìzia, in
aa.vv., Manuale di filosofia
politica, a cura di S.
Maffettone e S. Veca,
Donzelli,Roma1996,p.172.
8
s.
Maffettone,
Utilitarismo e teoria della
giustizia, Bibliopolis, Napoli
1982, p. 18. Sulla centralità
del tema della cooperazione
sociale nella Teoria della
giustizia di Rawls si veda
l’interessante articolo di L.
salvatore,
Rawls,
la
cooperazione e l'Aristotele
che è in noi (surfisti esclusi),
in «Filosofia e questioni
pubbliche», VI (2000) n. 2,
pp. 141-61. Sul principio di
differenza e la cooperazione
in Rawls è da leggere B,
barry, Teorie della giustizia
(1989),trad.it.IlSaggiatore,
Milano 1996, pp. 239 sgg.
Invece, una lettura di Rawls
nella prospettiva di un
dialogocriticotramarxismoe
contrattualismo è quella di j.
bidet: cfr. John Rawls et la
théorie de la justice, Puf,
Paris 1995 e Théorie
generale,Puf,Paris1999,pp.
323-43.
9rawls, Una teoria della
giustiziacit.,p.99.
10Ibid.,p.100.
11 Sulla distinzione tra
giustificazione morale e
giustificazione politica si
veda l’articolo di s.
Maffettone,SostieneRawls...,
in «Filosofia e questioni
pubbliche»,I(1995)n.1,pp.
79-92.
12 J. RAWLS, Il diritto dei
popoli(1999), trad. it. a cura
di S. Maffettone, Edizioni di
Comunità, Torino 2001, pp.
47-48.
13 R. nozick, Anarchia,
stato, utopia (1974), trad. it.
Le Monnier, Firenze 1981;
ora in nuova edizione presso
IISaggiatore.
14Dicuicfr.soprattutto
Dopo la virtù. Saggio di
teoriamorale(1984),trad.it.
Feltrinelli,Milano1988.
15 Tra le principali
opere di TAYLOR sono da
ricordare Radici dell'io. La
costruzione
dell'identità
moderna (1989), trad. it.
Feltrinelli, Milano 1993 e II
disagio della modernità
(1991), trad. it. Laterza, Bari
1994. Su Taylor si legga p.
costa, Verso un’ontologia
dell’umano.
Antropologia
filosofica e filosofia politica
in Charles Taylor, Unicopli,
Milano2001.
16 M. SANDEL, Il
liberalismo e i limiti della
giustizia (1982), trad. it.
Feltrinelli, Milano 1994, p.
11.
17 a. MACiNTYRE, Il
patriottismo è una virtù? (1984),
trad. it. in a. Ferrara (a cura di),
Comunitarismo e liberalismo,
EditoriRiuniti,Roma1992,p.71.
18 Ferrara (a cura di),
Comunitarismo e liberalismo cit.,
pp.LII-LIII.
19
Precisazioni rispetto
all’impianto di Teoria della
giustizia si trovano per
esempio nei saggi: Il
costruttivismo kantiano nella
teoriamorale(1980),trad.it.
in Saggi, Edizioni di
Comunità, Torino 2oor, pp.
77-79; Utilità sociale e beni
primari(1982),ibid.,pp.139
sgg.;La priorità del giusto e
idee del bene (1988), ibid.,
pp.212-14.20
20
RAWLS,
Il
costruttivismo kantiano cit.,
p.77.
21 RAWLS, La priorità del
giustocit.,p.212.
22Suquestotemasiveda
ilfascicolomonograficodella
«Rivista di filosofia», XCII
(2001) n. i, dedicato appunto
a «La qualità della vita», e
curato da E. Lecaldano e S.
Veca. Accanto al saggio di
Veca si legga, nel fascicolo,
quello di I. CARTER,
Funzionamenti e capacità :
unacriticaliberalealleteorie
di Sen e Nussbaum (pp. 4970).
23 A. SEN, Lo sviluppo è
libertà (1999), trad. it.
Mondadori, Milano 2001, P·
77·
24Ibid.,p.79.
25Ibid.
26Dicuicfr.peresempio
il recente M. nussbaum,
Giustizia sociale e dignità
umana, il Mulino, Bologna
2002.
27 j. Habermas, Fatti e
norme.Contributiaunateoria
discorsiva del diritto e della
democrazia (1992), trad. it.
Guerini e Associati, Milano
1996,p.131.
28Ibid.,p.134,
29Ibid.,pp.148-49.
30ibid.,p.360.
31Ibid.,p.400.
32
Cfr. per esempio Y.
SYNTOMER, La démocratie
impossible. Politique et
modernité chez Weber et
Habermas, La Découverte,
Paris1999,p.368.
33 Su questa linea di
pensiero,chenellasualettura
svolge e al tempo stesso
rovescia il realismo nella
direzione dell'impolitico, ha
insistito molto Roberto
Esposito; una sintesi efficace
della sua prospettiva è la
introduzionealvolumedalui
curatoOltrelapoliticacit.
34 w. benjamin, Per la
critica della violenza (1921),
trad. it. in Angelus No-vus,
Einaudi,Torino1962.
35
M.
FOUCAULT,
Illuminismoecritica,trad.it.
Donzelli,Roma1997,p.55.
36Ibid.,pp.56-57.
37Ibid.,p.61.
38Ibid.,pp.37-38.
39 Trad. it. Feltrinelli,
Milano1975.
40 A. Cavarero, Il
pensiero femminista. Un
approccio teoretico, in F.
restaino e a. cavarero, Le
filosofìe femministe, Paravia,
Torino1999,pp.116-17.
41Ibid.,p.119.
42 Di cui cfr. Corpi che
contano.Ilimitidiscorsividel
corpo, Feltrinelli, Milano
1996.
43Ibid.,p.126.
44
Per uno sguardo
d’insiemesivedailsaggiodi
A. E. GALEOTTI, Teorie
politiche femministe, in
Manuale di filosofia politica
cit.,pp.47-67.
45L’operaprincipaledic.
GILLIGANèConvocedidonna.
Etica e formazione della
personalità (1982), trad. it.
Feltrinelli, Milano 1987. Il
pensiero della Gilligan è
presentatoediscussoinmodo
chiaro ed efficace nel saggio
di i. salvatore, Teoria
femminista e critica, in
Ragionevolidubbi,Seminario
diUrbino,acuradiP.Costa,
M.RosatieI.Testa,Carocci,
Roma2001,pp.124-43.
46Ibid.,p.131.
47 Cavarero, Il pensiero
femministacit.,pp.120-21.
48 salvatore, Teoria
femminista e critica cit., p.
132.
49 Cfr. soprattutto, di s.
M. OKIN, Le donne e la
giustizia. La famiglia come
problema politico (1989),
trad.it.Dedalo,Bari1999.A
propositodellaOkinsivedail
volume III (1997) n. 2 della
rivista «Filosofia e questioni
pubbliche», con saggi della
stessaOkinediE.Galeotti,I.
Salvatore,A.Pauncz.
50 Cfr. l'intervento di
okin,ivi,p.77.
VIII.Questioniperla
filosofiapolitica
I.Il«fondamento»
deidirittiedella
democrazia.
Nelle due proposte più
influenti all’interno della
discussione odierna sulla
teoria politica normativa,
quelladiJohnRawlsequella
di Jürgen Habermas, la
questione del rapporto tra
teoriamoraleeteoriapolitica
nontrovaunarisoluzioneche
possa dirsi del tutto
soddisfacente. Mentre il
Rawls di Teoria della
giustizia costruiva la sua
riflessione a partire da un
orizzontemorale,cheperaltro
non veniva giustificato nelle
sue ragioni ultime, quello di
Liberalismopoliticodistingue
nettamente tra giustificazione
morale e giustificazione
politica,esostienelatesiche
la
seconda
dev’essere
indipendente dalla prima,
poiché l’ordine politico deve
essere
accettabile
dai
sostenitori
di
«dottrine
comprensive» diverse e
antagoniste tra loro, purché
ragionevoli. La visione
rawlsiana lascia però in
buona misura aperto il
problemadicomesidebbano
determinare, appunto, i
confini del ragionevole: se i
confini del ragionevole
vengono stabiliti sullo stesso
terrenodelragionevole,allora
lo scotto che si paga per
rispettare il pluralismo delle
dottrine comprensive è la
rinuncia a una costruzione
teorica che possa dirsi basata
su
solidi
fondamenti
razionali; se invece i confini
del ragionevole fossero
determinati da una precisa
teoria filosofica, allora la
politica verrebbe di nuovo a
dipendere da una dottrina
comprensiva, e si ricadrebbe
nella posizione che il Rawls
diLiberalismopoliticovoleva
superare. Come è stato
scritto: «il vantaggio in
termini di realismo pluralista
sembra
essere
pagato
dall’ultimo Rawls in termini
difiacchezzamotivazionalee
debolezza
normativa.
Addirittura, si potrebbe dire
che più si procede in una
direzione, più si arretra
dall’altra»1.Inaltreparole,la
pretesa di sganciare la teoria
politica dalla sua dipendenza
daunagiustificazionemorale
sembra per un verso
facilitare, ma per un altro
verso rendere più difficile la
giustificazionerazionaledella
teoriapoliticastessa.
Per quanto riguarda
questo problema, però, anche
la prospettiva di Habermas
non sembra del tutto priva di
incoerenzeinterne:Habermas
rifiuta,
non
molto
diversamentedaRawls,difar
dipendereiprincipidelgiusto
ordine politico da una
prospettivamorale,allaquale
lapoliticafinirebbeperessere
gerarchicamente subordinata.
Al tempo stesso, però, egli come abbiamo visto - fa
derivare il principio della
democrazia da un più
originario principio del
discorso, in forza del quale
sonovalidequellenormeche
potrebbero
meritare
il
consenso da parte di tutti i
partecipanti a un discorso
pratico.Aquestopunto,però,
appare assai convincente
l’obiezione secondo la quale,
nel principio del discorso, è
già contenuto il nucleo di
quello che verrà poi più
precisamente articolato come
moralità2: ma se questo è
vero, ne consegue, contro le
intenzioni di Habermas, che
la teoria della democrazia,
derivando dal principio del
discorso,
dipende
sostanzialmente da assunti di
teoria morale, anche se nega
questa dipendenza rifiutando
la subordinazione gerarchica
del diritto democraticamente
statuitoallamorale.
L’esigenza che sta alla
basedelleriflessionidiRawls
e di Habermas su questo
punto è a mio giudizio tanto
chiara e comprensibile,
quanto insidiata da una certa
tensione o contraddizione
interna:perunversosivuole
mantenere un qualche nesso
tra teoria politica e teoria
morale
(tagliarlo
completamente
significherebbe uscire dalla
dimensione della teoria
politica normativa); per altro
verso si ritiene che il
riconoscimento
del
pluralismo e della autonomia
delmomentopoliticoesigano
che questo non dipenda da
teorie morali specifiche, che
inunasocietàpluralisticanon
possono essere condivise da
tutti. Ma né Rawls né
Habermas
riescono
a
soddisfare insieme le due
esigenze delle quali si fanno
portatori.
Perciò,
per
quanto
riguarda la questione del
nesso tra giustificazione
morale e giustificazione
politica, appare più coerente
una linea che si ispiri ad
alcune delle osservazioni che
sono state proposte da KarlOtto Apel nella sua
discussione critica delle tesi
habermasiane. In primo
luogo, sembra chiaro che la
ricerca intorno al giusto
ordine politico non può
tagliareilcordonechelalega
a una concezione della
giustizia, che viene elaborata
innanzitutto in sede di teoria
morale;questaeradelrestola
posizione tanto del primo
Rawls quanto del primo
Habermas. Chiarito questo
punto, si tratta però di
indagare quale teoria morale
sia in grado non solo di
offrire
una
sufficiente
giustificazionerazionaledise
medesima, ma anche di
costituire lo sfondo per una
costruzione politica che non
sacrifichi la fonda-mentale
istanza
del
pluralismo.
L’ipotesi che mi pare più
percorribileèpertantoquella,
avanzata da Apel e in una
certa fase anche da
Habermas, di assumere come
punto di partenza una teoria
morale che (come l’etica del
discorso
apelianohabermasianao,prima,l’etica
del dialogo del filosofo
italiano Guido Calogero) per
unversoèingradodiaddurre
solidi argomenti a proprio
sostegno, per l’altro non
sembra meno pluralistica
della visione di Rawls: si
tratta,infatti,diun’eticailcui
nucleo è la disponibilità ad
ascoltare tutte le voci e tutte
leistanzeumane,echequindi
lascia fuori solo coloro che
nonsonodispostiasentirele
ragioni degli altri, e che
pretendono di imporre con la
forzailpropriopuntodivista.
Un’etica del discorso o
del dialogo, però, non è solo
profondamente pluralistica
ma, al tempo stesso, è anche
in grado di mostrare perché
ogni individuo razionale la
dovrebbe accettare o, detto
diversamente, perché non
potrebbe trovare argomenti
validi per rifiutarla. In
sostanza, l’argomento che si
può addurre a sostengo della
validità di un’etica del
discorso o del dialogo può
essereformulatocomesegue.
Supponiamo di intraprendere
una discussione teorica
intorno al problema, se si
diano
principi
etici
suscettibili di giustificazione.
Prima ancora di rispondere,
eventualmente, che di tali
principinonsenedanno(così
risponderebbero,infatti,molti
tra i filosofi contemporanei),
chiunquesipongaseriamente
ilproblemadovrebbedisporsi
nell’atteggiamento di chi,
come partecipante a un
dibattito argomentativo, è
pronto a dare ascolto a tutti
gli argomenti che gli
verranno proposti, e a
prestare a ciascuno di essi
pari attenzione. Non appena
si cominci a esaminare un
problema,osiintraprendaun
dibattito, insomma, si accetta
già quella che potremmo
chiamare la fondamentale
norma della discussione
critica, che impone di
sottoporre ogni tesi al
confronto discorsivo e di
prestare
ascolto
agli
argomenti di tutti i partner
della
discussione.
Ma
l’ascolto e il rispetto che si
devono a tutti gli argomenti
non possono non estendersi
anche alle persone, che sono
tutte possibili dialoganti e
argomentanti. E perciò dalla
norma della discussione
critica,chechiunquepartecipi
a un dibattito non può non
fare propria, discende anche
una più impegnativa norma
morale,cheappuntoprescrive
di prestare ascolto alle
ragioni, alle istanze e alle
esigenze di tutte le persone.
Come
scrive
Apel:
«Nell’apriori
dell’argomentazione è insita
la pretesa di giustificare non
solo tutte le affermazioni
della scienza ma, al di là di
qùeste,tuttelepreteseumane
(anche le pretese implicite,
che sono contenute nelle
azionienelleistituzioni,degli
uomini nei riguardi di altri
uomini). Chi argomenta
riconosceimplicitamentetutte
le possibili pretese di tutti i
membri della comunità della
comunicazione
che
si
possono giustificare tramite
argomenti razionali ... e si
impegna al tempo stesso a
giustificaretramiteargomenti
le proprie pretese nei
confronti degli altri»3. Il
principio di un’etica del
discorso, quindi, prescrive
fondamentalmente il rispetto
el’ascoltodelleragionidegli
altri; e afferma che la giusta
risoluzione dei conflitti che
dovessero insorgere tra
esigenzeincontrastoèquella
che risulterebbe dal dialogo
argomentativo e paritario tra
tutti gli interessati e i
coinvolti, impegnati in coresponsabilità solidale nella
ricercadiquellesoluzioniche
meglio rispondano agli
interessiditutti.
A mio parere, è solo a
partire
da
questo
orientamento etico di fondo
che si può (tentare di)
proporre una risposta alla
domanda, che sempre si
ripresentainfilosofiapolitica,
su quale sia il «fondamento»
deidirittiedellademocrazia.
Dal principio etico che
prescriveilrispettodituttele
persone, con i loro bisogni,
pretese e interessi, consegue
anchelagiustificazionediun
ordine giuridico-politico che
garantisca l’eguaglianza di
diritti,ovverol’egualelibertà
e dignità di tutte le persone,
nonsolocomemeroprincipio
morale, ma come norma di
cui si impone, anche
coattivamente, il rispetto.
L’esigenza di superare la
mera moralità in un ordine
giuridico ha la sua radice
nella moralità stessa: essa
infatti mi prescrive di
rispettarelealtrepersone,ma
nonpuòrealmenteobbligarmi
a ciò finché io non abbia la
garanziacheancheglialtrisi
comporteranno così nei miei
confronti. Se non la si
intendesseinquestomodo,la
morale
diverrebbe
paradossalmente la via per
trasformare chi ne segue la
regola in preda disarmata di
chiinvecelacalpesta.Perciò,
«ilprincipiodeldialogononè
soltanto il principio della
persuasione disarmata, ma
anche il principio della
coercizionegiuridico-politica,
cioè della difesa efficace di
coloro che rispettano la sua
regola da coloro che invece
nonintendonorispettarla»4.
Il principio etico in forza
del quale le esigenze di tutte
lepersonehannodirittoapari
considerazione e rispetto (un
principio simile lo abbiamo
incontrato
anche
nella
riflessione di Robert Dahl
intorno ai fondamenti della
democrazìa) deve quindi
costituire il filo conduttore
per individuare le linee di
fondo di un ordine giuridico
legittimo. Fermo restando
naturalmentechelacomunità
giuridicamente organizzata
dei cittadini di uno stato non
può essere in alcun modo
assimilata a una comunità
etica:questasarebbeilregno,
semplicemente pensabile, di
individui che si regolano nei
loro
rapporti
reciproci
secondo quanto prescrive il
punto di vista morale. La
comunità politica, invece,
conferisce agli individui dei
diritti il cui fine è quello di
assicurareaessiegualelibertà
e dignità; ma resta in ogni
caso una comunità reale di
individui che possono avere
un senso di giustizia ma
possono
anche
essere
decisamente autointeressati
ed egoisti, che sono portatori
di dotazioni naturali e sociali
per tanti aspetti ineguali, e
che possono servirsi dei loro
diritti fondamentalmente per
scopi di autoaffermazione;
perciò la comunità politica
non
attuerà
mai
compiutamente quell’ideale
di eguale rispetto per tutte le
persone che pure ne deve
ispirare
gli
istituti
fondamentali, e al quale essa
si deve sempre commisurare,
come alla sua promessa in
qualche
modo
sempre
inevasa.
2.Sistemadei
dirittiedemocrazia.
Volendo esprimere gli
stessi concetti con il
linguaggio
del
contrattualismo, si potrebbe
dire che gli istituti di un
ordine giuridico legittimo
sono quelli che si darebbero,
nell’atto di costituire una
comunità politica, individui
che
volessero
regolare
giuridicamente
la
loro
convivenza in modo tale da
assicurare l’eguale rispetto
per gli interessi di ciascuno.
La finzione contrattualista è
un buon metodo per
enucleare gli istituti di un
ordine politico legittimo,
purché sia chiaro che il
contratto o meglio l’accordo
che può generare un ordine
politicosiffattononèunpatto
sottoscritto da soggetti reali,
presi così come sono (con i
lorointeressiegoisticieiloro
diversi
potenziali
di
minaccia), ma un patto i cui
autorisonoindividuiegualie
imparziali (per dirla con
Rawls, individui che si
autoimpongono un velo di
ignoranza).
Se mettiamo a confronto,
come aspetti fondamentali di
unasocietàgiusta,daunlatoi
principidigiustiziadiRawls,
dall’altroilsistemadeidiritti
in cui per Habermas si
concreta
una
buona
democrazia, possiamo a mio
pareregiungereadalcunenon
troppo
problematiche
considerazioni.
Come abbiamo visto,
mentre in Rawls la struttura
di una società giusta si basa
su una dualità di principi (il
primo assicura la libertà, il
secondo determina i margini
entro i quali deve essere
contenuta la diseguaglianza),
in Habermas viene proposta
unaarticolazionepiùampia,i
cui punti nodali sono a mio
avviso i diritti «classici» di
libertà,idirittidemocraticiei
diritti sociali. In Habermas
però, anche questo va
sottolineato, il tema della
giustizia sociale ha una
rilevanza sostanzialmente inferiore a quella che ha nel
primo Rawls: per Habermas,
infatti, i diritti che egli
chiama «di ripartizione
sociale»noncostituisconoun
fine in sé, ma sono per così
direstrumentalialgodimento
degli altri diritti (agli
individui devono essere
assicurate certe condizioni
sociali, perché altrimenti essi
non
potranno
godere
veramentedeidirittidilibertà
odeidirittidemocratici).
Se si riparte dal
fondamentale assunto etico
circa la pari dignità degli
interessidituttelepersone,la
via più promettente da
seguire sembra quella che,
per così dire, si colloca a
mezza strada tra Rawls e
Habermas: i diritti e gli
istituti nei quali si traduce
l’istanza dell’eguaglianza o
della giustizia sociale non
possono essere visti, come
accade in Habermas, come
sostanzialmente «funzionali»
agli altri diritti; al contrario,
devono essere assunti come
diritti fondamentali a pari
titolo dei diritti di libertà
individuale e dei diritti
democratici. Con Habermas,
d’altra parte, è opportuno
distinguere chiaramente tra i
dirittidilibertàindividualeei
dirittidemocratici,perchéessi
fanno riferimento a due
dimensioni
diverse
di
esplicazione della libertà, il
rapporto tra le quali non è
affatto semplice e scontato, e
anzimeritaattentariflessione.
Solo attraverso una
siffatta articolazione, il
«sistema dei diritti», per
riprendere
l’espressione
habermasiana,
può
effettivamente costituire un
quadro all’interno del quale
sia assicurato il pieno e
concreto rispetto per tutte le
persone.Sitrattaoradicapire
meglio, però, come le tre
dimensioni fondamentali dei
diritti di libertà, dei diritti
democratici e dei diritti
sociali
debbano
essere
pensate ciascuna per sé e, al
tempostesso,nelnessochele
unisce. In primo luogo, i
diritti di libertà individuale
costituiscono la garanzia di
base perché ognuno sia non
solotutelatonellasicurezzae
nella persona, ma possa
sviluppare, attraverso la
libera scelta dei suoi modi di
vita,lasuaricercadelproprio
bene, e possa far valere
liberamenteleproprieistanze
e i propri punti di vista: essi
tutelano
l’insopprimibile
esigenza dell’individuo, più
che mai sentita nella tarda
modernità, di disporre di uno
spaziodisceltesquisitamente
personali, di cui egli solo si
assume la responsabilità. I
diritti democratici assicurano
che gli interessi, i valori, le
esigenze
di
ognuno
concorrano, attraverso il
dibattito pubblico e le
appropriate procedure di
rappresentanza
e
di
deliberazione,
alla
formazione delle leggi. I
diritti sociali (che potrebbero
essere articolati attraverso un
apparato concettuale come
quello proposto da Sen, che
prima abbiamo ricordato)
hannolafinalitàdiassicurare
aciascunolecondizioniperil
più ampio sviluppo possibile
della sua personalità umana,
ovvero, per usare il
linguaggio di Sen, dei suoi
«funzionamenti» e delle sue
«capacitazioni». Il rapporto
tra questi differenti ambiti di
diritti, però, non è né
semplicenélineare.Permolti
versiidirittifannosistemain
quanto si presuppongono
reciprocamente: i diritti
democratici, per esempio,
presuppongono come loro
precondizioni i diritti di
libertà e i diritti sociali5;
questi altri tipi di diritti, per
parte loro, presuppongono i
dirittidemocraticiinquantoè
solo
nell’esercizio
dell’autolegislazione,
costituzionaleoordinaria,che
icontenutipiùdeterminatidei
diritti di libertà e dei diritti
sociali
possono
essere
legittimamente fissati: essi
quindi hanno bisogno della
sovranitàpopolareperlaloro
determinazione
ed
esplicitazione, così come
questa ha bisogno dei diritti
di libertà e dei diritti sociali
come sue precondizioni.
Questa idea del reciproco
presupporsi6sipuòfarvalere
pertuttiitipididiritti:idiritti
di libertà richiedono quelli
democratici per la loro
garanzia (lo diceva già
Constant) e quelli sociali per
le risorse che, della libertà,
consentono
il
concreto
esercizio. I diritti sociali,
senza i diritti di libertà e i
diritti democratici, non
potrebbero conferire agli
individui quelle condizioni
che essi stessi devono in
ultimaistanzagiudicarecome
funzionali allo sviluppo della
loroindividualità.
Tuttavia, anche se si
assume la tesi, ben fondata a
mio avviso, che un sistema
dei diritti così concepito
costituisca una delle strutture
portanti di una democrazia
«nonapparente»,ènecessario
mettere a fuoco anche un
altroaspetto:traidiversitipi
di diritti non regna nessuna
armonia prestabilita, nel
senso che il gioco degli
equilibri tra di essi include
necessariamente tensioni o
frizioni,chesolonelconcreto
esercizio
della
pratica
democratica si possono
sciogliere. Per esempio: fin
dove si estende il legittimo
esercizio della libertà privata
individuale, il campo dei
comportamenti leciti? Il
tentativo liberale di tracciare
in quest’ambito dei confini
invalicabili (per esempio
attraverso il «principio del
danno» di John Stuart Mill)
non può dirsi pienamente
riuscito. E forse è più
coerente sostenere, con
Habermas, che, una volta
stabilito il principio della
presupposizione reciproca di
autonomia
privata
e
autonomia pubblica, i precisi
confini tra le due sfere
devono essere determinati
mediante l’agire politico e
mutano con le circostanze
storiche: «Come non si può
circoscrivere una volta per
tutte la sfera dell’autonomo
perseguimento degli interessi
privati di contro alla sfera in
cui si realizza il ‘bene
comune’, nemmeno si può
ritagliare entro la sfera
comunemente definita del
diritto privato una vera e
propria sfera dell’intimità. Il
dibattito sulla pornografia
dimostracomestabilirequesti
confini sia una questione
difficile, che deve sempre
poter essere demandata al
confrontopolitico»7.
A me pare che qui
Habermas
colga
perfettamente il punto, la cui
problematicità va messa a
fuoco con precisione: per un
verso
la
democrazia
presuppone i diritti di libertà
e i diritti sociali che ne sono
precondizioni;peraltroverso
questidirittivengonoappunto
stabiliti
nel
processo
democratico, che sempre di
nuovo li reinterpreta e li
ricodifica. E non è detto che
questo
circolo
debba
necessariamente prendere la
forma di un circolo virtuoso.
Quello che si può sostenere
dalpuntodivistadellateoria
è che, se quanto fin qui si è
detto è vero, la democrazia
intesa nel senso ampio del
termine, e cioè come
l’insieme sinergico dei diritti
di libertà, dei diritti sociali e
dei diritti politici è, come è
stato talvolta sostenuto, una
questione di gradi: tanto più
si attua e si espande quanto
più rende giustizia a tutte le
sue dimensioni, da quella
della libertà squisitamente
individuale a quella della
partecipazione politica attiva,
fino a quella della più ampia
garanzia di diritti sociali
espansivi. Il che significa
naturalmente anche saper
gestire, attraverso il dialogo
democratico, le tensioni che
sempreinsorgonotraidiversi
aspetti della libertà, che in
fondo rimandano, come
abbiamo visto, alle grandi
tradizioni
liberale,
democraticaesocialista.
Se si ragiona su questa
linea,cioènellaprospettivadi
una
filosofia
politica
«democratica» nel senso che
abbiamo appena specificato,
la tesi, sulla quale ormai
convergono sia Rawls che
Habermas, della «priorità del
giustosulbene»dev’esserein
una certa misura ricalibrata.
Non per andare nella
direzione comunitarista di
una priorità del bene sul
giusto, ma piuttosto in quella
diunpiùbilanciatoequilibrio
tra queste due dimensioni. Il
punto risalta in tutta la sua
evidenza se ci si sofferma
sulla questione dei diritti
sociali
ovvero
dell’eguaglianza di risorse:
mentre il primato del giusto
impone a Rawls di fermarsi
all’idea che la distribuzione
dei beni primari dev’essere
quanto più possibile eguale
(fatto salvo il principio di
differenza), le critiche mosse
a questa scelta rawlsiana, per
esempio da Sen, portano alla
conclusione che una società
ben ordinata non può fare a
meno di operare delle scelte
circa
quelli
che
si
considerano
i
«funzionamenti»olecapacità
più importanti per gli
individui, da promuovere e
garantire. Nel far questo,
però, la politica non può non
lasciarsi
guidare
da
concezioni di ciò che è bene
pergliindividui,che,comele
concezionidelgiusto,devono
essere elaborate e verificate
nel dibattito pubblico, e
quindi sono in ultima analisi
legittimate dal consenso
discorsivo degli individui
stessi.TantoinRawlsquanto
in Habermas, invece, prevale
l’idea che le questioni
concernenti il bene (il
filosofo tedesco le definisce
questioni
«etiche»),
a
differenza
di
quelle
concernentiilgiusto(cheegli
chiama questioni «morali»),
poiché fanno riferimento a
visionicontroversediciòche
ognuno intende come la vita
buona per sé, non siano
suscettibili
di
un’argomentazione
tanto
rigorosa quanto quella che si
può applicare alle questioni
morali (dove il problema è
trovare soluzioni che siano
accettabili
nell’eguale
interessediciascuno).
Sebbene questa tesi non
sia priva di una sua
plausibilità, essa però non
può essere assunta in senso
troppo rigido, come se le
questionicircailbenefossero
materia di pura idiosincrasia
soggettiva. Al contrario, la
riflessione teorica su quali
sianoibenipiùimportantiper
l’uomo (sulla quale si è
cimentata
una
grande
tradizione filosofica, da
Platone e Aristotele a
Spinoza) è terreno di
argomentazionerazionalenon
meno di quanto lo sia la
riflessionesullagiustizia.Dal
punto di vista della filosofia
sociale e politica, si aprono
quindi ampi spazi non solo
per la ricerca di quelli che
potremmo considerare come
gli «elementi necessari a un
funzionamento
autenticamente
umano»8,
attorno ai quali è possibile
raccogliere
un
ampio
consenso transculturale, ma
anche
per
una
riconsiderazione
dell’importantissimotemadei
beni comuni, cioè di quei
benicomel’ambientesano,le
possibilità di comunicazione,
la cultura, il cui valore non
sta solo negli effetti positivi
che generano, ma anche nel
fattochesitrattadibeniche,
a differenza di quelli di tipo
acquisitivo,sonogodutisenza
che
questo
implichi
privazione per qualcun altro;
anzi, sono beni di cui noi
godiamosoloinquantoanche
gli altri ne godono. Essi
perciò dovrebbero essere
oggetto
di
particolare
attenzione in una società
democraticaorientataversolo
sviluppoditutti.
3.Trafattie
norme:ilproblema
delleteorienormative.
Le considerazioni che
abbiamo fin qui svolto si
collocano
sostanzialmente
nello spazio della teoria
normativadellapolitica;mail
problema che alle teorie
normative sempre si pone è
quello di come si rapportino
alle realtà effettuali della
politica. La teoria normativa
ciparladiunasocietàgiusta,
di una democrazia come
potrebbe e dovrebbe essere;
ma che rapporto intrattiene
con i dati di fatto, spesso
assaisconfortanti,dellarealtà
politica effettiva ? Alcuni
modi di rispondere a questa
domanda sono chiaramente
insoddisfacenti:loèquellodi
quantiritengono(pensandoin
talmododifarprofessionedi
realismo) che la teoria
normativa non sia altro che
un esercizio sterile, un
trastullo per «anime belle»
che niente ha a che vedere
con la dura realtà di forza e
conflitto che caratterizza la
politica nella sua verità di
fatto.Questoatteggiamentoè
poveroeriduttivoperchénon
si avvede che, per quanto
severa e aspra sia la realtà
della politica, questioni di
giustizia in essa sempre si
pongono,
argomenti
si
discutono, e pertanto il
momento
normativo
è
anch’esso radicato e presente
nella verità dei fatti: negarlo
significherebbe accreditare
una visione della politica
troppounilaterale,equindi,a
ben guardare, molto poco
«realistica».
Altrettanto
insoddisfacente è il modo di
vedere verso il quale talvolta
teorie come quelle di
Habermas o di Rawls
sembrano «scivolare»: quel
modo di vedere per cui
sembra che la teoria
normativa
possa
quasi
descrivere, con qualche
sopportabile scostamento, la
politica così come realmente
è. Che non sia così, che tra
normaefattosussistanongià
un abisso ontologico, ma
certamenteunafortetensione,
è un punto di cui lo stesso
Habermas (formatosi - non
dimentichiamolo
-
alla
scuola,delmarxismocritico),
anche se talvolta non lo
sottolinea come dovrebbe, è
ben consapevole: l’assunto
propriodellateorianormativa
è che «non esistono
impedimentidiprincipioaun
ordinamento egualitario dei
rapporti interpersonali». Ma,
continua
Habermas,
«naturalmente le nostre
società sono profondamente
segnate sia dalla violenza
manifestasiadaunaviolenza
strutturale.
Esse
sono
attraversate dal micropotere
di repressioni occulte e
deformate da dispotismo,
emarginazione
e
sfruttamento. Ma di ciò non
potremmo indignarci, se non
sapessimochequestirapporti
inverecondipotrebberoanche
configurarsi altrimenti»; la
critica dei rapporti di fatto,
quindi, è possibile proprio a
partire dall’assunto che esige
«che a tutte le persone spetti
unegualestatusnormativo,e
che tutte debbano darsi
simmetrico e reciproco
riconoscimento»9.
Anche Rawls, del resto,
considera il consenso intorno
ai principi di giustizia non
come un dato, ma come
qualcosa che rientra nel
novero delle possibilità. Il
vero problema delle teorie
normative,quindi,èquellodi
comprendere
come
la
scissione tra fatto e norma
possa essere elaborata,
mitigata, anche se non
completamente superata. Ma
è il problema più complicato
di tutti, che può essere
affrontato seriamente solo
utilizzando molti e diversi
punti di vista, e che richiede
anche considerazioni che
esulano dall’ambito della
filosofia politica intesa in
sensopiùstretto.
Innanzitutto, la tensione
tra fatto e norma è il tema
proprio con cui un agire
politico che si lasci guidare
da principi di libertà e di
giustizia si deve misurare. Il
terreno dell’agire politico,
nell’orizzonte di una teoria
normativa, e perciò critica, è
quellodisfidareleistituzioni
e le situazioni che negano il
simmetrico e reciproco
riconoscimento,
che
impongono condizioni di
dominio, di deprivazione, di
sfruttamento, di non-libertà.
Suo obiettivo polemico sono
tutte le forme di privilegio
socialmente e politicamente
consolidato, dal privilegio di
classe al dominio di genere,
dalladiscriminazionerazziale
a quella etnica. E proprio in
quanto si trova di fronte
situazioni di consolidato
vantaggiooprivilegio,l’agire
politico non può fare a meno
di situarsi sul terreno del
conflitto: è una pratica che
opera a molti livelli, nel
linguaggio
habermasiano
dovremmodire:comunicativa
e strategica al tempo stesso.
Siavvaledeibuoniargomenti
e del dibattito pubblico, ma
anche della messa in
movimento di forze e
interessi la cui pressione è
necessaria per scuotere
privilegi di vecchia data,
rapportidipoterestabilizzati,
forme
di
non-libertà
depositate nel costume e
sostenute da ideologie.
L’agire politico è quindi
praticaaltamentecomplessae
innovativa: che incrocia il
terreno comunicativo (sul
quale
hanno
insistito
particolarmente Arendt e
Habermas) non solo con
quello strategico, ma anche
con
quello
simbolico,
identitario, talvolta persino
mitico; e che deve essere
capace di tenere insieme
interessi
e
valori,
e
soprattutto,
se
vuole
conseguire i propri obiettivi,
di essere al tempo stesso
parzialitàeuniversalità(cheè
forse l’insegnamento ancora
attuale che si può trarre dal
concetto gramsciano di
egemonia)10.
Ma proprio in questo suo
necessario
polimorfismo
hanno radice anche le
inaggirabili aporie dell’agire
politico. Perché a esso
inerisce sempre, al di là di
ogni attitudine comunicativa
e di ogni riferimento all’idea
di
un
riconoscimento
simmetrico e paritario, il
momento del conflitto, del
polemos, dell’organizzazione
di forze e interessi contro
altre forze e interessi. Certo
che la politica non è
riducibile, come voleva Carl
Schmitt,
alla
contrapposizione
amiconemico; ma nel mondo reale
avrà sempre a che fare, o
almeno per molto tempo
ancora, con la costante
ridefinizione di linee di
conflitto, anche quando si
tratti di un conflitto
«addomesticato» e giocato
dentro le regole del diritto e
della democrazia. In ciò si
radica l’inevitabile aporia di
ogni politica che voglia
incidere sui rapporti di fatto
vigenti (ad esempio per
combattere o per contrastare
dei privilegi): per vincere
nella situazione data, anche
una politica critica deve in
qualche misura rendersi
conforme a essa, ma ciò
significa che rischia di
trovarsi a sua volta in
tensione con i principi ai
quali si richiama. È l’aporia
che, a titolo di esempio, si
può illustrare perfettamente
con un aforisma della
Dialetticadell’illuminismo di
Horkheimer
e
Adorno
intitolato
«Propaganda»:
anche la propaganda per le
idee migliori (indispensabile,
potremmodire,perchéessesi
diffondano e si affermino) le
tradisce nel momento stesso
in cui le diffonde: perché fa
del linguaggio, invece di un
medium dell’intesa, uno
strumento di manipolazione
degli uomini, della verità un
mezzoperacquistareseguaci:
«dà per scontato che il
principio secondo cui la
politica deve nascere da una
comprensione comune non
sia che un modo di dire»; la
propaganda «altera la verità
giànell’attodiformularla»11.
Horkheimer e Adorno ne
traevano la conclusione,
davvero «impolitica», che
fosse quindi ormai inutile
rivolgersi alle masse o anche
ai singoli, e che convenisse
piuttosto limitarsi a lasciare
un messaggio nella bottiglia.
Ma se la conclusione non è
d’aiuto, la diagnosi merita di
esseremeditata,soprattuttoin
un tempo che ha dato alla
vecchia propaganda i mezzi
tecnologicamente
più
straordinari per penetrare
ovunque, e ne ha ampliato
notevolmentelapotenza:ela
diagnosi ci dice che anche la
miglior politica si fa nel
mondo com’è, e quindi ne
porta su di sé i segni (nel
modoincuiparlaalpubblico,
nelle sue organizzazioni, in
millealtriaspetti).Lapolitica
ha sempre a che fare con
queste aporie: non può
scrollarsele di dosso, deve
convivercicriticamente.Nella
consapevolezza però che, in
ultima istanza, l’idea che per
cambiare il mondo si debba
adeguarsi ad esso non può
che essere contraddittoria; e
che quindi è senz’altro più
attendibile l’idea opposta, e
cioè che chi vuol cambiare il
mondo deve cominciare dal
saper cambiare se stesso. Il
Novecento ha visto troppa
politicaanimatadallemigliori
intenzioni riprodurre dentro
di sé tutti i vizi di ciò contro
cuivolevalottare.
4.Lapoliticadella
democraziaelesfide
delmondoglobalizzato.
Nel mondo globalizzato
che si viene delineando dopo
ilcrollodelMurodiBerlinoe
l’ingresso nel terzo millennio
dell’era
cristiana,
le
prospettive realistiche di una
democrazia comunicativa ed
espansiva sembrano trovarsi
difronteasfideeadifficoltà
moltodiversedaquelleconle
quali dovevano confrontarsi
nelmondobipolare.
Da qualche tempo, in
molte analisi sociologiche,
economiche, politiche, si
tendearaccoglieregliaspetti
salienti dei mutamenti che
hanno trasformato gli assetti
planetari sotto il concetto
alquanto polisenso, ma per
altriversiancheproduttivo,di
globalizzazione11(infrancese
si preferisce, ancora nella
discussione
odierna,
il
terminemondialisation)15.
Gli aspetti principali del
processo che va sotto questo
nome potrebbero essere
schematicamente indicati nei
puntiseguenti:
-Sulterrenoeconomico
assistiamoallosviluppodiun
mercato mondiale che ormai
copre tutto il pianeta, a una
crescitadellainterdipendenza
tra paesi e aree diverse e a
una più aspra competizione
globale. Tuttavia il processo
di globalizzazione non deve
esserevistosoltanto,inmodo
economicistico,
come
processo di realizzazione di
un mercato unico globale.
Esso deve essere analizzato
ancheneisuoiaspettipolitici,
culturalieantropologici.
- Sul terreno politico
molti sostengono la tesi che
saremmo
ormai
entrati
nell’età
postwestfaliana,
perché la fase attuale non
vedepiùcomeattoredecisivo
lo stato nazionale dotato di
chiare prerogative sovrane su
un territorio definito. Ci
troveremmo quindi nello
spazio di un ordine
posthobbesiano14, dove al
sistema di stati come
autonome potestà sovrane si
sostituisceunamolteplicitàdi
livelli normativi sovra e
transnazionali, di regimi
regionali come l’Unione
europea e di regolazioni da
parte di enti sovranazionali,
che configurano una sorta di
multilevelgovemance.
- L’ulteriore grande
processo che caratterizza la
fase
attuale
della
globalizzazione, e che forse
più di ogni altro ne segna la
novità, è lo straordinario
sviluppo delle tecnologie
dell'informazione e delle reti
globali fino alla dimensione
diunacomunicazione-mondo,
che trasforma non solo le
forme del lavoro e i modi di
vita e di consumo, ma anche
le modalità della politica (si
pensi per esempio a come
diventa più difficile, per i
regimi autoritari, schermarsi
difronte ai flussi informativi
e quindi anche rispetto alle
critiche
dell’opinione
pubblica).
- Molta attenzione è stata
dedicata inoltre, negli studi
recenti, alle trasformazioni
chelaglobalizzazioneinduce
negli
stili
di
vita:
l’antropologo indiano Arjun
Appadurai, nel recente
Modernitàinpolvere15,mette
al centro della sua analisi
della fase attuale della
modernità globale i due
fenomeni
della
comunicazione attraverso i
media elettronici e delle
migrazioni
di
massa,
volontarie o forzose, come
elementi che, determinando
nuove
dimensioni
dell’immaginazione
collettiva, ne potenziano
anchel’impattosullestrutture
e sui poteri del sistemamondo.
Nel loro insieme queste
trasformazioni corrodono per
molti aspetti anche le basi di
quellademocraziasostanziata
diimportanticontenutisociali
(anche se non esente da
corposi limiti) che si era
venuta sviluppando, con
alterne vicende, soprattutto
nell’Europa occidentale dopo
lasecondaguerramondiale.
La
pressione
della
competizione globale e lo
sviluppo di forme produttive
più differenziate e articolate
rispetto a quelle dell’epoca
«fordista», ad alto contenuto
disapereedicomunicazione,
destrutturano quello che era
stato (accanto a movimenti
sociali come quelli dei
giovani,
delle
donne,
dell’ambientalismo) uno dei
fattori fondamentali di spinta
dei
processi
di
democratizzazione e delle
politiche
sociali
del
dopoguerra: il movimento
operaio organizzato, con i
suoi partiti e i suoi sindacati.
La «fine della società del
lavoro» (Jeremy Rifkin), i
mutamenti delle forme
produttive e una più marcata
individualizzazione degli stili
di vita sembrano minare le
basi stesse della politica
democratica come si era
sviluppata
nei
decenni
passati: le forme organizzate
tradizionali
della
partecipazionepoliticaedella
rappresentanza appaiono per
molti versi consumate,
mentre i diritti sociali del
Welfare sembrano troppo
onerosi
rispetto
agli
imperatividellacompetizione
globale e poco aderenti alle
nuove figure del lavoro
«flessibile» e di una
soggettività sempre più
individualizzata.
Lecosenonvannomeglio
sul
terreno
della
partecipazione democratica:
mentre
le
potenzialità
democratichedellenuovereti
di comunicazione elettronica
restano in buona parte
inesplorate, la tendenza che
largamente prevale è quella
verso una riduzione della
democrazia in senso verticistico e mediatico: le facce
dei leader soppiantano il
dibattito pubblico e il
cittadino attivo è rimpiazzato
dallospettatoredeitalk-show.
Malesfidepiùimportanti
per una politica democratica
non sono quelle che si
pongono sul piano interno,
ma quelle indotte dai
mutamenti nei rapporti tra le
nazioni: le difficoltà cui
vanno incontro le politiche
tradizionali di democrazia e
di giustizia sociale, si
intrecciano con i nuovi
problemicheoggisipongono
sul terreno di una giustìzia
globale.
Tra le conseguenze più
evidentidellaglobalizzazione
vi è quella per cui le arene
democratiche «domestiche»
subiscono una progressiva
perdita di incidenza, perché
cresce il numero delle
decisioni che vengono prese
al di fuori di esse, e il
restringersi dello spaziomondofasicheisingolistati
subiscano, per esempio come
inquinamento ambientale, le
conseguenze di processi che
si svolgono altrove, e che
sono sottratti al loro
controllo. La veloce mobilità
deicapitalifinanziarialivello
planetario condiziona le
politiche economiche degli
stati, mentre cresce il potere
decisionale di molteplici
istituzioni di governarne
sovranazionale, largamente
sottratte
al
controllo
democratico.
Gli ampi flussi migratori
e la crescente mobilità della
popolazione, inoltre, rendono
sempre più incerta e difficile
la determinazione dei confini
deldemos;con il rischio che
lacittadinanzademocraticasi
riduca, negando le sue
premesse universalistiche, a
statuto privilegiato di una
partedellapopolazione,dalla
quale restano esclusi molti
chepurvivonoelavoranonel
territoriodellostato;allimite,
potrebbe configurarsi il
rischio di una sorta di nuovo
apartheid16.
Infine, dopo il crollo del
mondo bipolare, e il
permanere in campo di
un’unica
superpotenza,
sembradelinearsinelsistemamondo una struttura di tipo
imperiale,doveisingolistatinazione potrebbero ridursi
tuttiallacondizionedistatia
sovranità limitata, e i più
deboli alla condizione di
quasi-stati, a fronte della
supremazia indiscussa di un
unico Paese, forte della sua
superiorità
militare,
tecnologica, economica e
«comunicativa».
Gli
scenari
della
globalizzazione,
perciò,
pongono con forza il
problema di cosa possano
significare, forse non oggi,
ma domani o dopodomani,
diritti, giustizia e democrazia
a scala mondiale; questione
noneludibile,perchéèfuordi
dubbio che ormai il pensiero
politico deve fare i conti con
una situazione inedita e dai
contornipoconetti,chenonè
né quella degli stati
pienamente sovrani che
stannotraloroinunrapporto
simile allo stato di natura, né
quelladiununicoSuperstato
mondiale di cui non si vede
né la fattibilità né la
desiderabilità. Come è stato
scritto, «le potenze capaci di
agiresulpianoglobalenonsi
muovonopiùentrolostatodi
natura teorizzato dal diritto
internazionale classico, bensì
piuttosto sul livello mediano
diunapoliticamondialecheè
in via di formazione. Oggi
questa politica mondiale è
solo
confusamente
percepibile. Essa non si
presenta staticamente come
politica gerarchizzata nel
quadrodiunaorganizzazione
mondiale,
bensì
dinamicamente come un
insieme di interferenze e
interazioni tra processi
politici che seguono logiche
specifiche
sul
piano
nazionale, internazionale e
globale ... In tal modo
vediamo aprirsi quantomeno
una prospettiva per una
‘politica interna mondiale’
anche senza governo del
mondo»17.
Le vie che potrebbe
percorrere questa costruzione
di una «politica interna
mondiale» sono però quanto
mai difficili. E non è
semplice rispondere alle
domande che Habermas, a
questo
proposito,
ha
chiaramente
enunciato:
«Come è pensabile una
legittimazione democratica
delledecisionichevadaaldi
làdelloschemaorganizzativo
dello stato? A quali
condizioni
l’autocomprensione
degli
attoriglobalipuòtrasformarsi
nel senso di indurre stati e
regimi sopranazionali a
intendersi progressivamente
quali membri comunitari per
cuinonesistaaltraalternativa
se
non
di
prendere
reciprocamente
in
considerazione i propri
interessi e rispettare gli
interessigenerali?»18
La decisione da parte di
stati,
o
di
regimi
sopranazionalicomel'Unione
Europea, di intendersi come
membri di una comunità
dispostiatrattaresuunabase
di reciprocità i propri
interessi presuppone, anche
se in forma più debole di
quanto non lo presupponga
una comunità statale, la
condivisione di un certo
insieme di principi comuni,
relativi tanto alle procedure
democratiche di decisione,
quanto ai diritti degli
individui, quanto ai criteri di
giustizia distributiva o di
solidarietà
economica
internazionale. Presuppone
insomma un consenso di
fondo che vada molto oltre
quello, già esigente, che
Rawls pone alla base della
sua società di popoli19, in un
orizzonte teorico che, a
differenza
di
quello
habermasiano,restamoltopiù
ancoratoallasovranitàstatale
nellesueformetradizionali.
Ma l’affermazione di
principi condivisi in tema di
diritti dell’uomo e di
democrazia
appare,
nell’orizzonte che si delinea
all’inizio di questo terzo
millennio,
quanto
mai
difficile e soggetta a
resistenze di vario genere:
nonmancanosulloscacchiere
mondiale stati che sollevano,
nei confronti della nostra
concezione dei diritti, riserve
che non sono totalmente
ingiustificate. Per un verso si
sostiene che, in quanto
prodotto
della
cultura
occidentale,
i
diritti
dell’uomononpossonoessere
assunti sic et simpliciter da
culture diverse da quella
dell’Occidente, che hanno
della libertà e della
democrazia una visione
profondamente diversa dalla
nostra20. In secondo luogo si
afferma che è piuttosto
singolare che l’Occidente
voglia oggi dare lezioni di
diritti dell’uomo e di
democraziaapaesiicuidiritti
(individuali e collettivi)
l’Occidente
stesso
ha
calpestato
(come
in
parte continua a fare) in una
lunga storia di conquiste,
colonialismi e imperialismi.
Si aggiunge ancora, per
esempio da parte dei
sostenitori dei cosiddetti
«valoriasiatici»,cheaquella
occidentale
si
può
legittimamente contrapporre
una«viaasiaticaaidiritti»,la
cui differenza specifica sta
nel sotto-lineare con molta
energia, facendo riferimento
anche al confucianesimo, il
primato degli interessi della
collettività e dello stato
rispetto a quelli dei singoli
individui.
Visonocertamentebuone
ragioni per affermare, come
Habermas ha sostenuto con
molta convinzione, che la
modernizzazione economica
e la integrazione nel mercato
globale
costringono
in
qualche misura anche i Paesi
che vorrebbero rifiutarla ad
aprirsi a una concezione più
secolarizzata
e
individualistica del diritto,
checostituisceunelementodi
contorno più funzionale per
losviluppodiun’economiadi
mercato21. Altri studiosi di
scienzeeconomicheesociali,
però, tendono a smentire la
tesi di una modernità
monodirezionale, dove la
modernizzazione economica
comporterebbe
necessariamente
secolarizzazione
e
individualizzazione:
Eisenstadt, per esempio,
interpreta il fondamentalismo
islamico come un fenomeno
per niente arcaico, ma anzi
portatore di tratti tipicamente
moderni22. Amartya Sen, da
partesua,prendendoinesame
il ben noto caso delle
cosiddette
«Tigri
del
Pacifico», evidenzia come
modernizzazione capitalistica
e valori antindividualistici
possano convivere in modo
straordinariamente efficace23:
insomma, ci sono molte vie
alla modernizzazione e allo
sviluppo, e non tutte portano
alla secolarizzazione, alla
democratizzazione e ai diritti
dell’individuo.
Mailproblemanonnasce
tanto dallo «scontro di
civiltà», come suona il titolo
di un libro molto citato di
Samuel
Huntington.
Scaturisce piuttosto da un
paradosso di fondo che
condiziona
tutta
la
discussione e i suoi
risultati: per un verso
I’Occidente pretende di
presentarsi come il difensore
deivaloriuniversalidilibertà,
diritti e democrazia, mentre
peraltroversononintendené
può rinunciare alla sua
smisurata
superiorità
economica,
militare,
tecnologica e mediatica, e si
riserva sempre di ricorrere a
essa per regolare i conti con
chinonstaallesueregoledel
gioco.Èquestoparadossoche
dà fiato e conferisce una
parvenza di legittimità a
regimi integralisti e nemici
dei diritti e che rende più
difficilelabattagliadicoloro
che, per esempio nel mondo
arabo, si oppongono a essi:
«Di fronte a un Occidente
abbarbicato alla difesa dei
propri privilegi, quanti si
richiamano
ai
principi
universali di libertà ed
eguaglianza che esso, per
primo, aveva enunciato, sono
costretti alla difensiva da
quelli
che
intendono
squalificare ogni pretesa
universalistica,
mostrando
che essa maschera, su scala
mondiale,
il
regno
dell’arbitrio
e
della
diseguaglianza.
L’integralismo si serve
dell’egocentrismo dei ricchi
per riabilitare l’egocentrismo
dei poveri e proclamare il
necessario
ritorno
alla
dimensionecomunitaria»24.
Perciò credo si possa
affermarechelapossibilitàdi
costruire un più vasto
consenso intorno ai principi
dei diritti e della democrazia
dipende anche dal fatto che
l’Occidente sia capace a sua
volta di riconoscere i diritti
dei popoli altri, più deboli,
più poveri, che non li veda
solo come una questione di
ordine
pubblico
internazionale
(«stati
fuorilegge», immigrazione
illegaleecc.)ma,alcontrario,
sia capace di costruire
politiche che vadano nella
direzionedellademocraziatra
i popoli e della giustizia
economica globale25; nella
direzione, insomma, di un
governo
politico
della
globalizzazione economica,
che esige che le potenze
capaci di agire si impegnino,
«-partecipandoattivamentea
procedimenti
istituzionalizzati per la
formazione transnazionale
della volontà26 - nel
mantenimento
di
certi
standard sociali e nella
eliminazionedicertisquilibri
estremi»27 su scala globale.
In mancanza di prospettive
politiche di giustizia tra i
popoli e di lotta alle
diseguaglianze su scala
globalevivremoinunmondo
non solo sempre più ingiusto
ma anche sempre più
insicuro, esposto a minacce
dalle quali nessuno potrà
ritenersi al riparo. Una
politica che sappia resistere
alla tentazione di risolvere i
problemimanumilitari,eche
punti non solo sull’apertura
dei mercati, ma anche sul
governo democratico della
globalizzazione, sembra oggi
molto lontana e difficile
(nonostante vi siano pure
segnali positivi, dai nuovi
movimenti
transnazionali
all’emergere dei primi segni
di una «società civile
globale»). Ma forse lo
sarebbe di meno se si
comprendesse, che, su una
Terra divenuta sempre più
piccola,unapoliticadellacoresponsabilità solidale (per
usare un’espressione-chiave
di Apel) non risponde solo a
ragionimorali,maanchealla
difesa intelligente degli
interessidilungoterminedei
cittadini del Nord ricco del
mondo.
5.Bioeticae
biopolitica.
Se le sfide della
globalizzazione pongono alla
politica problemi inediti e
straordinariamentecomplessi,
essarischiadivenirspiazzata
in modo ancor più radicale
dai nuovi scenari determinati
dagli impressionanti salti in
avanti della scienza e della
tecnologia. Si pensi, per fare
solounesempio,macentrale,
ai progressi compiuti dalla
genetica
e
dalle
biotecnologie,
e
alle
straordinarie possibilità che
ormaisiapronodiintervenire
sul vivente e di manipolarlo.
Presto potrebbero diventare
possibili pratiche che fino a
ieri erano confinate nei libri
di fantascienza: come per
esempio riprodurre esseri
umani
per
clonazione,
prevedere le prospettive di
vita e di salute delle persone
attraverso la mappatura dei
loro geni, produrre embrioni
umani per scopi di ricerca,
terapeuticiocommerciali.
Come devono rapportarsi
le società democratiche e
pluralistiche con le pratiche
di manipolazione del vivente
che presto diventeranno
possibili, e che in buona
misura già lo sono ? È ovvio
chelescelteinquestocampo
sono
profondamente
influenzate dal diverso
orientamento religioso o
morale dei cittadini: per
esempio, mentre i cristiani
insistono sulla sacralità della
vita umana, e quindi sulla
necessitàdivietaregranparte
delle
pratiche
di
manipolazione (anche se non
quelle
tipicamente
terapeutiche,volteallacuradi
malattie genetiche) i laici
assumono di solito posizioni
piùduttili.Ilconflittoperò,e
questo è l’aspetto più
interessante, divide anche gli
orientamenti laici tra di loro,
in un dibattito che è ormai
ampiamente avviato e nel
quale sono già emerse
posizioni
largamente
differenziate.
Naturalmente, i temi di
una politica della vita, o,
come anche si potrebbe dire,
di
una
«bio-politica»,
possono essere affrontati
avvalendosi di ottiche molto
diverse: si possono utilizzare
argomenti religiosi, morali,
prudenziali
(come
per
esempio quello, sollevato da
molte parti, secondo il quale
non siamo in grado di
prevedere quali possano
essere gli effetti a lungo
termine,perlosviluppodegli
individuiedellaspecie,degli
interventi sul patrimonio
genetico). Dal punto di vista
della filosofia politica, però,
le questioni si possono
discutere più specificamente
in termini di diritti o di
divieti: come si legittima il
divieto
di
determinate
pratiche ? Perché limitare la
«libertà procreativa» delle
persone impedendo che essa
si avvalga di tutti gli
strumentichelatecnicamette
a sua disposizione ? Quali
nuovi diritti devono essere
stabiliti per costruire un
quadro di regole legittime
entro il quale si possano
implementare le nuove
possibilità che la tecnologia
offre?
La radicale novità dei
problemi che qui si pongono
stanelfattocherispettoaessi
i fronti tradizionali del
conflittopoliticorisultanoper
moltiversiscompaginati,esi
pone l’esigenza di costruire
quasi da zero un nuovo
quadro di diritti e doveri
condivisi.
I sostenitori di una
politica
ragionevolmente
limitativa o «proibizionista»,
tra i quali si colloca anche
Habermas con la sua
polemica contro i «rischi di
una genetica liberale»28,
adducono argomenti che
possono essere formulati
in termini di difesa dei diritti
degli individui. Discutendo
intorno alle possibilità di
intervenire sugli embrioni
umani modificandone le
caratteristiche
genetiche,
Habermas
propone
di
distinguere tra un’ingegneria
genetica di tipo terapeutico e
una di tipo «migliorativo»;
mentre la prima non sembra
implicare una violazione dei
diritti degli individui che
dagli
embrioni
si
svilupperanno, perché può
presumerecheessidarebbero,
agli interventi terapeutici, il
loroconsenso,perlaseconda
le cose non stanno così. Il
fatto che qualcuno, per
esempio i genitori, possa
intervenire sul patrimonio
genetico di qualcun altro,
magari per favorire lo
sviluppo di qualità che al
genitore sembrano qualità
desiderabili, implica per
Habermas una asimmetria di
dirittitragliindividui(alcuni
possono manipolare altri, ma
non viceversa) che è
incompatibile con l’eguale
rispettochesideveaognuno
di essi: «interventi genetici
migliorativi compromettono
la libertà etica in quanto
fissano
l’interessato
a
intenzioni di terze persone
(intenzioni che restano
irreversibiliancheserifiutate)
e gli impediscono di
concepirsi come l’autore
indivisodellapropriavita»29.
Habermas conclude perciò le
sue riflessioni, nel saggio
Fede e sapere, ponendosi la
seguentedomanda:«Ilprimo
uomo che determinasse a
propria discrezione un altro
uomo nella sua costituzione
naturale, non distruggerebbe
forse anche quelle eguali
libertàchesussistonotrapari
proprio per assicurare la loro
diversità?»30.
A
partire
da
considerazionidiquestotipo,
o simili, si potrebbe
addivenire alla tesi che si
debba garantire a ciascuno il
dirittoa«un’identitàgenetica
non predeterminata da altri
(con l’eccezione di alcuni
casi, espressamente previsti,
di gravi anomalie genetiche),
come condizione dell’unicità
irripetibile del singolo»31;
questo tipo di diritto, da
includersi tra i diritti della
persona che la nuova
situazione
richiede,
costituirebbe un ostacolo
tanto per gli interventi di
ingegneria
genetica
migliorativa, quanto per
la clonazione riproduttiva,
perchéinquest’ultimocasoil
patrimonio
genetico
dell’individuo è totalmente
determinato da colui che
decide di produrlo. A
proposito della clonazione
riproduttiva si è sostenuto
anchecheessaviolerebbe«il
diritto ad avere un’identità
unicaeildirittoall’ignoranza
sul proprio futuro (o diritto a
un futuro aperto)» 32. Ma in
questi termini il divieto
sembra meno difendibile,
perché il diritto a un’identità
unica è qualcosa che già
manca ai gemelli monozigoti
(e quindi non avrebbe senso
sostenere che si tratti di un
diritto fondamentale) mentre
l’argomentodelfuturoaperto
sarebbe valido solo se,.si
presupponesse un totale
determinismo genetico e si
trascurassero tutti gli altri
fattori che influenzano lo
sviluppo di una persona. Il
vero problema, perciò, è
quello che nasce dalla
violazione di rapporti di
reciproco e simmetrico
rispetto tra gli individui: il
clone è un individuo la cui
identità genetica gli è stata
imposta da un altro a sua
immagine e somiglianza e
che quindi subisce le scelte
che un altro ha fatto per lui
senzapoterleinnessunmodo
controllare, e senza potere a
sua volta influire sull’altro
come l’altro ha influito su di
lui; si pone qui un
drammatico problema di
dirittidell’individuo.
È vero che chiunque
nasce è portatore di
caratteristiche che non ha
scelto e che i genitori gli
hanno trasmesso ma, nel
momento in cui queste
diventasserooggettodiscelta,
c’è da chiedersi a chi debba
essere
legittimamente
attribuito il potere di
esercitare queste opzioni; se
l’individuo non può ancora
esprimerle, perché i genitori
dovrebbero avere questo
potere su di lui ? Questo ci
porta ancora una volta alla
tesi per cui gli interventi
legittimi sono solo quelli
(chiaramente terapeutici) ai
quali si può ragionevolmente
supporre che coloro che li
subiscono darebbero il loro
consenso.
Ma allora, si obietta,
dovrebbero essere consentite
anche
tutte
quelle
manipolazioni genetiche che
sono volte chiaramente a
migliorareilcorredogenetico
degli individui (che ne
accrescono per esempio la
forza fisica, la memoria,
l’intelligenza);
nessuno
negherebbe ragionevolmente,
se fosse in grado di
esprimersi,
il
proprio
consenso ad esse. Qui, in
effetti, la questione sembra
farsi più complicata. Ci sono
ad esempio - sostiene
Habermas - piccoli difetti
fisici che alla fine possono,
per le mutevoli circostanze
della
vita
individuale,
rivelarsi dei vantaggi; chi si
arrogasse il diritto di
eliminarli modificherebbe la
biografia di qualcun altro in
un
modo
certamente
irreversibileechenonèdetto
sia positivo. E, più in
generale,
«si
potrebbe
insisteresulfattochel’ideadi
progettarequalitàdesiderabili
percosìdire‘inassoluto’per
l’uomo, pecca non tanto per
tracotanzaquantopereccesso
di superficialità, dato che a
nessuno di noi è dato
conoscere a fondo la natura
umana»33.
Macomunquelesivoglia
affrontare, si tratta senza
dubbio di questioni che
pongono problemi inediti e
complicati:daunapartec’èil
diritto dell’individuo a non
essere strumentalizzato da
altri; dall’altra l’esigenza
insopprimibile per gli uomini
di sondare tutte le possibilità
per vivere meglio, per
allontanare la malattia e la
morte. Molto ragionevole
sembra in ogni caso l’idea
cheogniinterventodebbafar
riferimento al consenso
almeno presumibile di colui
cheneèoggetto;mentrepare
assai debole la tesi che
vorrebbe lasciare ai genitori
tutta la libertà di scelta in
materia. Anche in questo
caso, l’unico orientamento di
fondodalqualesipuòpartire
per
affrontare
terreni
inesplorati è l’idea di una
complementaritàsinergicadei
diritti individuali e della
democrazia: per cui a ogni
individuo
deve
essere
riconosciuto
eguale
e
simmetrico rispetto, mentre i
termini e la concreta
normazionediquestirapporti
tra cittadini liberi ed eguali
nonpossonoesserededottida
alcuna norma trascendente,
ma debbono essere il frutto
del dibattito pubblico libero,
paritario e informato tra i
cittadinistessi.
1 Maffettone, Sostiene
Rawlscit.,p.91.Perlacritica
diquestoaspettodelpensiero
rawlsiano cfr. anche v.
marzocchi, Tre strategie di
composizione del pluralismo
normativo : tradizione,
consenso per intersezione,
discorso, in « Filosofia e
questioni pubbliche», I
(1995), n. 1, pp. 93-111 ;
ripubblicato in Per un'etica
pubblica. Giustificare la
democrazia, Liguori, Napoli
2000.
2Questacriticaèmossa
a Habermas da K.-O.apel in
Discorso,
verità,
responsabilità,trad.it.acura
di V. Marzocchi, Guerini e
Associati, Milano 1997, pp.
291sgg.SulpensierodiApel
cfr. il volume dello stesso
marzocchi, Ragione come
discorso
pubblico.
La
trasformazione della filosofia
diK.-O.Apel,Liguori,Napoli
2001.
3K.-O.apel, Comunità e
comunicazione, trad. it.
Rosenberg & Sellier, Torino
1977,p.260.
4 G. CALOGERO,
Filosofia
del
dialogo,
EdizionidiComunità,Milano
1977,p.358.
5 Nel suo Contro il
governo dei peggiori. Una
grammaticadellademocrazia
(Laterza, Roma-Bari 2000,
pp. 40-41) Michelangelo
Bovero sostiene una tesi
simile: diritti di libertà e
alcuni diritti sociali sono
precondizioni in mancanza
delle quali la democrazia
rischia di trasformarsi in
democraziaapparente.
6 Un’idea che,
limitatamente alla diade
libertà/giustizia, è stata
ampiamente sviluppata nel
liberalsocialismo; si veda per
esempio, di G. Calogero, Le
regole della democrazia e le
ragioni del socialismo,
Edizioni dell’Ateneo, Roma
1968; ora opportunamente
ripubblicato, con una utile
introduzione di Thomas
Casadei, presso Diabasis,
ReggioEmilia2001.
7 Habermas, Fatti e
normecit.,p.373.
8 Cfr. il testo di M.
nussbaum,Giustiziasocialee
dignità umana, trad. it. il
Mulino,Bologna2002,pp.74
sgg. dove l’autrice propone
anche una lista ragionata di
questi
funzionamenti
fondamentali.
9
j. Habermas, Il futuro
della natura umana. I rischi
di una genetica liberale
(2001) ttad. it. a cura di L.
Ceppa,Einaudi,Torino2002,
p. 65. Ho evidenziato alcune
espressioniincorsivo,perché
smentiscono
assai
efficacemente
quanti
attribuisconoaHabermasuna
visione irenica o pacificata
dellasocietàincuiviviamo.
10 Su egemonia, agile
politicoedemocraziasilegga
il saggio di M. reale, La
fragilità della democrazia
vincente, in aa.vv., Per un
nuovo vocabolario della
politica, a cura di L.
Capuccelli, Editori Riuniti,
Roma1992,pp.155-75.
11 M. horkheimer e th. w.
adorno,Dialetticadell’illuminismo
(1947), trad. it. Einaudi, Torino
1997,pp.272-73.
12
Tra gli innumerevoli
libri che affrontano questo
tema ci limitiamo a
segnalarneunoperl’originale
approccio filosofico che lo
contraddistingue: Filosofie
della globalizzazione, a cura
di D. D’Andrea e E. Pulcini,
EdizioniETS,Pisa2001.
13 Per un ricco confronto
tra autori prevalentemente di
lingua francese intorno al
temadellamondialisationcfr.
il n. 20 (secondo semestre
2002) della «Revue du
Mauss», dal titolo Quelle
‘autremondialisation’?.
14Cfr.aquestoproposito
G. marramao, Dopo il
Leviatano,
Giappichelli,
Torino 1995, ora riedito da
BollatiBoringhieri.
15 Trad. it. Meltemi,
Roma2001.
16 Su questo tema attira
l’attenzionedatempoEtienne
Balibar; cfr. per esempio il
suo ultimo libro, Nous,
citoyens d’Europe? Les
frontières, l’Etat, le peuple,
LaDécouverte,Paris2001.
17 J. Habermas, La
costellazione postnazionale
(1998), trad. it. Feltrinelli,
Milano1999,p.98.
18Ibid.
19 Cfr. Rawls, II diritto
deipopolicit.
20
Per un pacato
ragionamento su questi temi
si veda il volume del
presidente della repubblica
islamicadell’Iranmohammad
khatami, Religione, libertà e
democrazia, trad. it. Laterza,
Roma-Bari1999.
21 J. Habermas,
L’inclusione
dell’altro
(1996), trad. it. Feltrinelli,
Milano1998,p.227.
22 s. EISENSTADT,
Fondamentalismo
e
modernità, Laterza, RomaBari 1994; in proposito si
legga l’articolo di c.
pasquinelli,
Fondamentalismi, in «Parole
chiave», 1993, n. 3 (dedicato
monograficamente a questo
tema).
23 Cfr. per esempio A.
sen, La ricchezza della
ragione. Denaro, valori,
identità, trad. it. il Mulino,
Bologna2000,pp.insgg.
24 M. Hussein, Venante
Sud della libertà, trad. it.
manifestolibri, Roma 1994,
P-94·
25 Su questo tema,
partendodaunaimpostazione
rawlsiana ma andando molto
oltre Rawls, ha scritto cose
assai interessanti Thomas
Pogge.
26 Qui si dovrebbe aprire
il discorso intorno al tema
della
«democrazia
cosmopolitica», a proposito
del quale si vedano i molti
scritti di David Held e
DanieleArchibugi.
27
HABERMAS,
La
costellazione postnazionale
cit.,p.100.
28 Habermas, II futuro
dellanaturaumanacit.
29Ibid.,p.64,
30Ibid.,p.112.
31m.ToraldoDIFrancia,
La sfida delle biotecnologie:
ricerca
scientifica,
mutamento culturale, nuovi
scenari per l’etica, nel
numero monografico di
«Parole chiave» dedicato alle
Biotecnologie(n.17,1998,p.
47-70).
32 Su questi diritti, con
riferimentoaglistudidiD.w.
brock, si sofferma per
sottoporli a critica s. pollo
nell’articolo
Libertà
procreativa e clonazione, nel
numero succitato di «Parole
chiave»,pp.157-66.
33 s. Maffettone, Genetica, in Etica pubblica. La
moralità delle istituzioni nel
terzomillennio,IlSaggiatore,
Milano 2001, pp. 131-61, in
particolarep.156.
Lettureconsigliate
Indichiamo qui di seguito
una serie di letture che
possono essere utili per un
approfondimento dei temi
toccatinelvolume.
1.Operegeneralisulla
filosofia politica e la storia
delpensieropolitico.
CHEVALIER,J.-J.
1979 Storia del pensiero
politico, trad. it. il Mulino,
Bologna1989,3voll.
ESPOSITO R. E GALLI C. (A
CURADI)
2000 Enciclopedia del
pensiero politico. Autori,
concetti, dottrine, Laterza,
Roma-Bari.
GALLIc.(acuradi)
2001Manualedistoria
del pensiero politico, il
Mulino,Bologna.
MAFFETTONE, s. e VECA s.
(acuradi)
1996Manualedifilosofia
politica,Donzelli,Roma.
20013 L’idea di giustizia
da Platone a Rawls, Laterza,
Roma-Bari.
SABINE,G.H.
19613
Storia
delle
dottrine politiche, trad. it.
EtasLibri,Milano19782.
VECAs.
1998 La filosofia
politica,Laterza,Roma-Bari.
2. Testi su momenti o
autori della storia della
filosofia politica, in ordine
cronologicoperargomenti.
SINCLAIR,TH.A.
1951 II pensiero politico
classico, trad. it. Laterza,
Roma-Bari1993.
WOLIN,S.S.
1960 Politica e visione.
Continuità e innovazione nel
pensieropoliticooccidentale,
trad. it. il Mulino, Bologna
1996.
GASTALDI,S.
1999 Storia del
pensiero politico antico,
Laterza,Roma-Bari.
ISNARDIPARENTE,M.
1999 II pensiero
politico di Platone, Laterza,
Roma-Bari.
BERTI,E.
1997 II pensiero politico
di Aristotele, Laterza, RomaBari.
BIEN,G.
1973 La filosofia politica
di Aristotele, trad. it. il
Mulino,Bologna1985.
CARLYLE, R. W. e
CARLYLE,A.J.
1922-36 II pensiero
politico medievale, 6 voli.,
trad. it. Laterza, Bari 19561968.
FUMAGALLI BEONIO
BROCCHIERI,M.T.
2000 II pensiero
politico medioevale, Laterza,
Roma-Bari.
MESNARD,P.
1963-64 Il pensiero
politico rinascimentale, 2
voli., a cura di L. Firpo, Laterza,Roma-Bari.
SKINNER,Q.
1978 Le origini del
pensiero politico moderno, 2
voli., trad. it. il Mulino,
Bologna1989.
Duso,G.
1999 II potere. Per la
storia della filosofia politica
moderna,Carocci,Roma.
Duso,G.(acuradi)
19983Il contratto sociale
nella
filosofia
politica
moderna, Franco Angeli,
Milano.
BOBBIO, N. e B0VER0,
M.
1979 Società e Stato
nella
filosofia
politica
moderna, Il Saggiatore,
Milano.
SASSO,G.
1980 Niccolò
Machiavelli. Storia del suo
pensiero politico, il Mulino,
Bologna.
REALE,M.
1991
La
difficile
eguaglianza. Hobbes e gli
animali politici: Passioni,
morale,socialità,
Editori
Riuniti,Roma.
WAHRENDER,H.
1957 II pensiero politico
di Hobbes, trad. it. Laterza,
Roma-Bari1974.
MAGRI,T.
19892 Saggio su Thomas
Hobbes,
Il
Saggiatore,
Milano.
MACPHERSON,C,B.
1962 Libertà e proprietà
alle origini del pensiero
borghese, trad. it. Isedi,
Milano1973.
BALIBAR,É.
1985 Spinoza e la
politica,
trad.
it.
manifestolibri,Roma1996.
DUNN,J.
1969 Il pensiero
politico di John Locke, il
Mulino,Bologna1992.
DERATHÉ,R.
1950
Jean-Jacques
Rousseauelascienzapolitica
del suo tempo, trad. it. il
Mulino,Bologna1993.
REALE,M.
1983 Le ragioni della
politica. J.-J. Rosseau dal
«Discorso
sull’ineguaglianza»
al
«Contratto»,
Edizioni
dell’Ateneo,Roma.
VALENTINI,F.
1995 Il pensiero
politico
contemporaneo,
Laterza, Roma-Bari (nuova
ed.rivedutaeampliata).
BOBBIO,N.
1969 Diritto e Stato nel
pensiero di Emanuele Kant,
Giappichelli,Torino.
GONNELLI,F.
1996 La filosofia
politica di Kant, Laterza,
Roma-Bari.
ZANFARINO,A.
1961 La libertà dei
moderninelcostituzionalismo
di
Benjamin
Constant,
Giuffrè,Milano.
BARBERIS,M.
1988 Benjamin
Constant.
Rivoluzione,
costituzione, progresso, il
Mulino,Bologna.
MARINI,G.
1978Libertà soggettiva e
libertà
oggettiva
nella
«Filosofia
del
diritto»
hegeliana,
Bibliopolis,
Napoli;nuovaed.rivedutae
ampliata di altri studi
hegeliani, Morano, Napoli
1990.
OAFAGNA,E.
1998 La libertà nel
mondo. Etica e scienza dello
Stato nei «Lineamenti di
filosofiadeldiritto»diHegel,
ilMulino,Bologna.
HONNETH,A.
2001
II
dolore
dell’indeterminato.
Una
attualizzazione della filosofia
politica di Hegel, trad. it.
manifestolibri,Roma2003.
DESANCTIS,F.M.
1986 Tempo di
democrazia.
Alexis
de
Tocqueville,Esi,Napoli.
BATTISTA,A.M.
1989 Studi su
Tocqueville,Cet,Firenze.
CRESSATI,C.
1988 La libertà e le sue
garanzie. Il pensiero politico
diJohnStuartMill,ilMulino,
Bologna.
AVINERI,S.
1968 II pensiero politico
e sociale di Marx, trad. it. il
Mulino,Bologna1984.
TEXIER,J.
1998 Révolution et
démocratie chez Marx et
Engels,Puf,Paris.
AA.VV.
1978-82
Storia
del
marxismo, 4 voli., Einaudi,
Torino.
ALCARO,M.
1997
John
Dewey.
Scienza, prassi, democrazia,
Laterza,Roma-Bari.
MOMMSEN,W.J.
1974 Max Weber e la
politica tedesca, trad. it. il
Mulino,Bologna1993.
SARTORI,G.
1997 Scritti su Croce, 2
voli.,ilMulino,Bologna.
PORTINARO,P.P.
1992 La crisi dello jus
publicum europaeum. Saggio
su Carl Schmitt, Comunità,
Milano.
GALLI,C.
1996 Genealogia della
politica. Carl Schmitt e la
crisi del pensiero politico
moderno,ilMulino,Bologna.
CUBEDDU,R.
1983 Leo Strauss e la
filosofia politica moderna,
Esi,Napoli.
FORTI,s.
1996 Vita della mente e
tempo della polis. Hannah
Arendttrafilosofiaepolitica,
Angeli,Milano.
WIGGERSHAUS,R.
1986 La Scuola di
Francoforte, trad. it. Bollati
Boringhieri,Torino1992.
MARZOCCHI,V.
2001 Ragione come
discorso
pubblico.
La
trasformazione della filosofia
di K.-O. Apel, Liguori,
Napoli.
CATUCCI,s.
2000 Introduzione a
Foucault, Laterza, RomaBari.
KYMLICKA,W.
1990 Introduzione alla
filosofia
politica
contemporanea, trad. it.
Feltrinelli,Milano1996.
MAFFETTONE,S.
1982Utilitarismoeteoria
della giustizia, Bibliopolis,
Napoli.
PETRUCCIANI,S.
2000 Introduzione a
Habermas, Laterza, RomaBari.
3. Temi e concetti delta
filosofiapolitica.
BARBERIS,M.
1999 Libertà, il Mulino,
Bologna.
BEDESCHl,G.
19994Storia del pensiero
liberale,Laterza,Roma-Bari.
BOBBIO,N.
1995 Eguaglianza e
libertà,Einaudi,Torino.
1999 Teoria generale
della politica, a cura di M.
Bovero, Einaudi, Torino.
CUBEDDU,R.
1997
Atlante
del
liberalismo,Ideazione,Roma.
CARTER,I.(ACURADI),
2001 L'idea di
eguaglianza,
Feltrinelli,
Milano.
CARTER, I. E RICCIARDI,
M.(ACURADI),
1996 L’idea di libertà,
Feltrinelli,Milano.
CUNNINGHAM,F.
2002 Theories of
Democracy.A
Critical
Introduction,
Routledge,
London.
DERUGGIERO,G.
1995
Storia
del
liberalismo europeo (1925),
Laterza,Roma-Bari.
DWORKIN,
R.
e
MAFFETTONE,S.
1996 I fondamenti del
liberalismo, Laterza, RomaBari.
FF.RRARA,A.
2000 Giustizia e
giudizio,Laterza,Roma-Bari.
FIORAVANTI,M.
1999 Costituzione, il
Mulino,Bologna.
GRAY,J.
1986Liberalismo,trad.it.
Garzanti,Milano1989.
GREBLO,E.
2000 Democrazia, il
Mulino,Bologna.
HELD,D.
19961
Modelli
di
democrazia, trad. it. il
Mulino,Bologna1997.
MACPHERSON,C.B.
1977 La vita e i tempi
della democrazia liberale,
trad. it. Il Saggiatore, Milano
1980.
PORTINARO,P.P.
1977 Stato, il Mulino,
Bologna1999.
SARTORI,G.
20005Democrazia:cosa
è,Rizzoli,Milano.
Indicedeinomi
Adorno,Francesco,37n.
Adorno,
Theodor
Wiesengrund,9n,254,255e
n.
Agostino d’Ippona, 61,
63,64en,65,66,68.
AlaricoI,63.
Alcaro,Mario,202n.
AlessandroMagno,57.
Apel,Karl-Otto,224,242
n,243,244en,263.
Broch, Hermann, 23 e n,
229.
Buonarotti,
Filippo,
126,184,185n.
Butler,Judith,235.
Cabet,Etienne,185,186.
Cadoni,Giorgio,170n.
CallidediAcarne,40.
Calloni,Marina,ix.
Calogero, Guido, 135 n,
183,243,245n,248n.
Appadurai,Arjun,257.
Archibugi, Daniele, 262
n.
Arendt, Hannah, 25, 26,
27en,2830,33,227,254.
Aristotele,15,47,49en,
50-58,6870,71,79,80,151,
251.
Babeuf, François Noël,
126,184.
Balibar,Etienne,168en,
258n.
Barberis, Mauro, 135 n,
170n.
Barry,Brian,211n.
Battaglia,Felice,168n.
Battista,AnnaMaria,138
n.
Bedeschi, Giuseppe, 175
n.
Benhabib,Seyla,237.
Benjamin, Walter, 230 e
n.
Bentham,Jeremy,143.
Canfora,Luciano,35n.
Capuccelli, Luciano, 202
n,254n.
CarloMagno,67.
Carter,Ian,170n,222n.
Casadei,Thomas,248n.
Cavarero, Adriana, 234 e
n,237n.
Ceppa,Leonardo,253n.
Cicerone, Marco Tullio,
58,59,63.
Clausewitz, Carl von, 23.
distene,34.
Constant, Benjamin, 24 e
n, 125, 128, 129 n, 130-34,
135 e n, 136, 137, 139, 141,
151,159,160175n,180en,
248.
Conze,Werner,195n.
Cornford,
Francis
Macdonald,39n,
Berlin,Isaiah,22en,170
en,171-173-.
Bernstein, Eduard, 188 e
n.
Beveridge, sir William,
190.
Bidet, Jacques, 127, 211
n.
Bien,Günther,48n.
Bobbio, Norberto, 6n,
nen,12n,94,100n,118en,
170en,171n,176n,181n,
195,196n,227.
Boitani,Andrea,200n.
BonifacioVIII,73,74.
Bovero,Michelangelo,11
n,170n,183n,248n.
Bravo,GianMario,185n,
186n.
Brock,DanielW.,266n.
Costa, Paolo, 217 n, 236
n.
Costantino,
Flavio
Valerio,62,63
Cotta,Gabriella,76n.
Croce, Benedetto, 20 e n,
135n176en.
Cubeddu, Raimondo, 175
n,176n177en.
Cunningham,
Frank,
195n,201202en.
Dahl, Robert Alan, 194 e
n, 200 201 e n, 202, 203 n,
245.
D’AndreaDimitri,256n.
DanteAlighieri,72,73.
DeCaro,Mario,169n.
Defoe,Daniel,77.
De Luca, Stefano, 129 n,
134n,135n.
Derrida,Jacques,235·
De Ruggiero, Guido, 175
n.
Dewey, John, 201 e n,
202en,203en,227.
D’Orsi,Angelo,170n.
Downs,Anthony,200en.
Droetto,Antonio,89n.
Dworkin, Ronald, 175 n,
190.14,118n,128,135,150,
151,152en,153-58.
Heidegger, Martin, 27,
235.
Held, David, 195 n, 262
n.
Hobbes, Thomas, 11, 18,
49,76,77,79en,80,81en,
82-87,88en,89-94,95n99,
103,104,108,110,113,115,
125,170en,171,207.
Hobhouse,
Leonard
Trelawny,183.
Hofmann,Etienne,129n.
Einaudi,Luigi,176en.
Eisenstadt, Shmuel Noah,
261en.
Engels, Friedrich, 159 n,
161en,162n,187,188.
Enrico IV di Germania,
67.
Enrico
VII
di
Lussemburgo,73.
Esposito, Roberto, 23 n,
230n.
FedericoIIdiSvevia,68.
Ferrara, Alessandro, IX,
30n,218.
Filippo IV di Francia,
dettoilBello,73.74·
Filmer,Robert,92.
Fioravanti, Maurizio, 182
n.
Foucault, Michel, 6, 229,
230,231en,232,235.
Freud, Sigmund, 233,
235.
Galeotti, Anna Elisabetta,
235n,238n.
GesùCristo,61,62,67.
Giancotti
Boscherini,
Emilia,89n.
Gilligan, Carol, 235, 236
en,237,239.
Holbach, Paul Henri
Dietrich (Thiry), baron d’,
129.
Honneth,Axel,150n.
Horkheimer, Max, 254,
255en.
Huntington,Samuel,261.
Hussein, Mahmoud, 262
n.
Ildebrando di Soana vedi
GregorioVII.
InnocenzoIV,68.
Irigaray,Luce,233,235.
Isnardi
Parente,
Margherita,47n.
Kant, Immanuel, 24 e n,
77,101,113,114en,115en,
116,117en,118en,119en,
120, 121 en, 122, 123, 145,
182,206,217.
Kelsen, Hans, 193 e n,
196en,197-199.
Khatami,
Mohammad,
260n.
Kohlberg,Lawrence,235,
236.
Koselleck, Reinhart, 195
n.
Kymlicka, Will, 206 n,
207n.
Gilmore,MyronPiper,22
n.
Glaucone,40.
GiovanniXII,67.
Gonnelli,Filippo,114n.
Gouges,Olympede,233.
Gray, John, 173 e n, 175
n,178.
Greblo,Edoardo,195n.
GregorioMagno,67.
GregorioVII,67.
Grillo,Michele,200n.
Grazio,Ugo,95,108.
GuglielmodiOckam,74.
Habermas,Jürgen,29,30,
224 e n, 225-29, 235, 241,
242en,243,246,247,249e
n,250,252,253n,254,259e
n, 261 e n, 263 n, 264 e n,
265,267.
Hayek,Friedrichvon,14,
175n,178,179,183,214.
Hegel, Georg Wilhelm
Friedrich,
Lacan,Jacques,233,235.
Laponneraye, Albert, 185
en.
Laski,Harold,175en.
Laurenti,Renato,49n.
Lecaldano, Eugenio, 222
n.
Lenin
(Ul'janov),
VladimirIl'ic,189.
LeoneIII,67.
LeoneX,75.
Leszczynski, Stanislao,
103.
LicofronediCalcide,49.
Locke, John, 91, 92 e n,
93,94en,95)96,97en,98-
101, 103, 106-8, 110, 115,
117en,118,133,171n,181,
206.
Lowith,Karl,65n.
Ludovico IV, detto il
Bavaro,73.
Luigi
Bonaparte
(NapoleoneIII),142,162.
Luigi Filippo d’Orléans,
136.
Lutero,Martin,74,75,76
en.
Mably, Gabriel Bonnot
de,129.
Machiavelli, Niccolò, 7,
16en,17en,18en,20,21e
n,22en,23,76.
MacKinnon, Catharine,
239.
MacIntyre, Alasdair, 217,
218en,220,238.
Macpherson, Crawford
Brough, 149, 195, 201 e n,
202en.
Maddalena, Antonio, 37
n.
Maffettone, Sebastiano,
ix,175en,209n,210n,212
n,214n,242n,
Petrucciani, Stefano, 186
n.
Pericle,34,36.
Pillot,Jean-Jacques,185e
n.
Platone,7,12,14,35,36,
37 e n, 38 en, 39-43,4548,51,52,193,196,251.
Pocock, John Greville
Agard,22n.
Pogge,Thomas,262n.
Pollo,Simone,266n.
Portinaro, Pier Paolo, 17
n,175n.
ProtagoradiAbdera,35.
Proudhon, Pierre-Joseph,
186en.
Maier,Hans,195n.
Manacorda, Gastone, 185
n.
Mandeville, Bernard de,
152.
Mann,Thomas,23n.
Marco Aurelio Antonino,
58.
Marini,Giuliano,155n.
Marramao, Giacomo, 256
n.
Marsilio da Padova, 73,
76.
Marx,Karl,6,14,18,77,
98, 113, 128, 135, 155-58,
159en,160,161en,162en,
163,184,186en,187,188e
n,189,191.
Marzocchi, Virginio, 242
n.
Matteucci,Nicola,6n.
Meier,Christian,195n.
Pufendorf, Samuel, 95,
109.
Pulcini, Elena, 141n, 256
n.
Rawls, John, 12, 14, 99,
177,178,182,183,190,192,
205 e n, 206, 207, 208 e n,
209, 210, 211 e n,
212,213,214en, 216, 217,
220, 221 e n, 229, 235, 238,
241-43, 246, 247, 250, 252,
253,260en,262n.
Raynaud,Philippe,184n.
Reale,Mario,ix,80n,86
n, 87 n, 88 n, 103 n, 111 n,
113 n, 126n, 135 n, 202 n,
254n.
Reimann, Hans Leo, 195
n.
Micheli,Gianni,79n.
Mill,James,143.
Mill,JohnStuart,142-44,
145en,146-49,182,249.
MollerOkin,Susan238e
n,239en.
Montesquieu, Charles de
Secondât, baron de La Brède
etde,130,171n,181,182n.
Moro,Tommaso,14.
Mosca,Gaetano,198.
Müntzer,Thomas,75.
Mura,Virgilio,183n.
Napoleone
Bonaparte,
128.
Neumann,Franz,182n.
Nietzsche, Friedrich, 39,
40,232.
Nozick,Robert,177,179,
183, 205, 214 e n, 215, 216,
238.
Nussbaum,Martha,223e
n,251n.
Restaino,Franco,234n.
Riais,Stéphane,184n.
Ricardo,David,143.
Ricciardi,Mario,170n.
Rifkin,Jeremy,257.
Ritter,Gehrard,20en.
Robespierre, Maximilien
MarieIsidorede,160.
Rodano,Giorgio,200n.
Roemer,John,190,191e
n,192.
Roosevelt,
Franklin
Delano,190.
Rosati,Massimo,236n.
Rosselli,Carlo,183.
Rothbard,Murray,177n.
Rousseau, Jean-Jacques,
86, 88, 102, 103 e n, 104-7,
108 e n, 109-14, 128, 129,
160, 171, 172 n, 173, 193,
206,225.
OttoneIdiGermania,67.
Ottone II di Germania,
67.
PaolodiTarso,61,63.
Pareto,Vilfredo,198.
Pasquinelli,Carla,261n.
Pauncz, Alessandra, 238
n.
Salvatore, Ingrid, 210 n,
236n,237n,238n.
Sandel,Michael,217en,
218-20.
Sartori,Franco,38n.
Sartori, Giovanni, 167 e
n,176,177n,200en.
Sasso, Gennaro, 16 n, 18
n,22n.
Sbarberi,Franco,183n.
Schmitt, Carl, 23, 229,
254.
Schumpeter,
Joseph
Alois,198en,199,201.
Sellin,Volker,33n.
Sen, Amartya, 220, 221,
222en,223,248,250,261e
n.
Seneca,LucioAnneo,58.
Skinner,Quentin,22en.
Smith,Adam,99,152.
Socrate,36,38,39,134.
Solari,Paolo,176n.
Spinoza,Baruch,88,89e
n,90,91,251.
Staël, Germaine Necker,
Madamede,125,251.
Strauss, Leo, 7, 8 n, 10 e
n.
Syntomer,Yves,228n.
Taboni,PierFranco,8n.
Tagliapietra, Andrea, 24
n.
Taylor, Charles, 217 e n,
219.
Testa,Italo,236n.
Thomas, Jean-Paul, 184
n.
Tocqueville, Alexis de,
126,136,137en,138,139e
n,140,141en,142en,144,
147,190,
Tommaso d’Aquino, 68,
70,71,76.
Toraldo di Francia,
Monica,265n.
Trasimaco di Calcedone,
35,39,40.
Trincia,
Francesco
Saverio,186n.
Tucidide,17,35en.
Van Parijs, Philippe, 179
en,180,192en.
Veca, Salvatore, 209 n,
222n.
Vernant,Jean-Pierre,15e
n,34en.
Viroli,Maurizio,22n.
Wartender, Howard, 87 e
n.
Weber,Max,6en,7,16,
17en,18en,23,24en,25.
Weil,Simone,23,229.
Wolin, Sheldon, 19 e n,
38en,48n.
Wollstonecraft,
Mary,
233.
Zadro,Attilio,37n.
Zanatta,Marcello,47n.
Zanfarino, Antonio, 135
n.
Zolo,Danilo,200en.