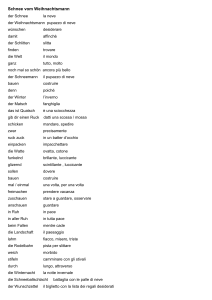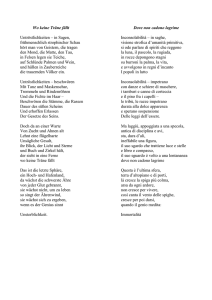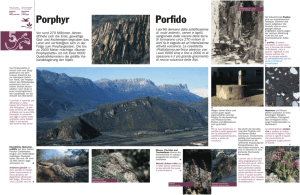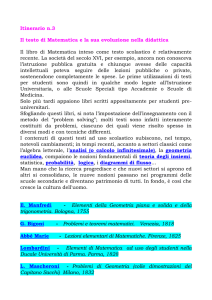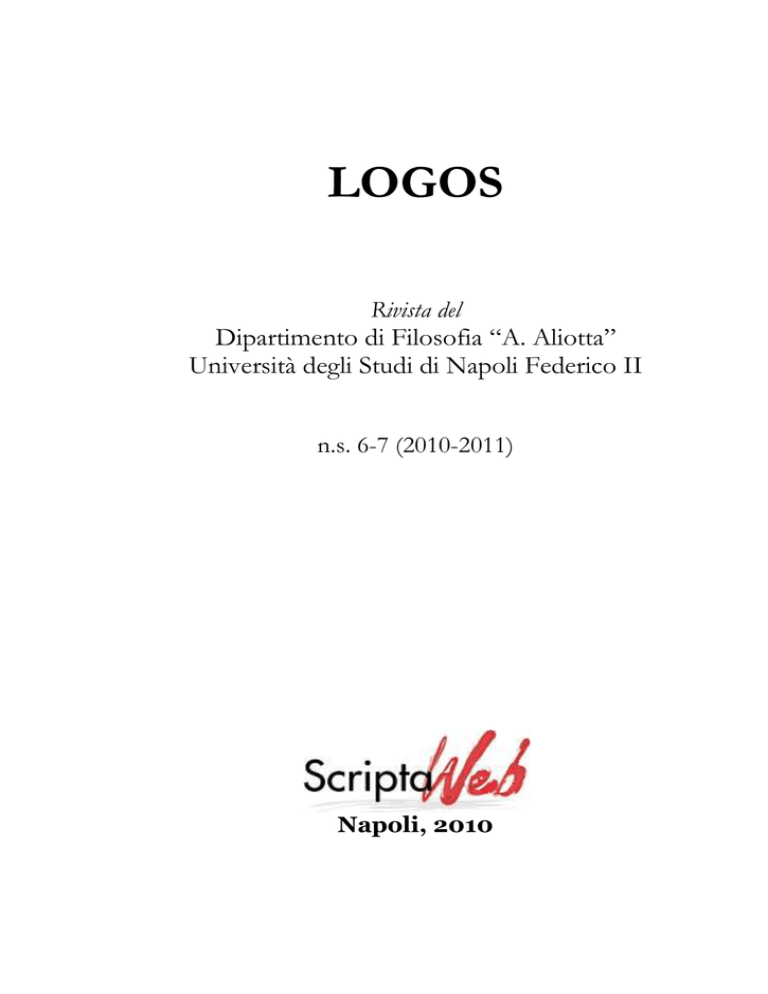
LOGOS
Rivista del
Dipartimento di Filosofia “A. Aliotta”
Università degli Studi di Napoli Federico II
n.s. 6-7 (2010-2011)
Napoli, 2010
- Direzione:
Giuseppe Cacciatore e Fabrizio Lomonaco
- Comitato scientifico:
Giuseppe Acocella, Gianfranco Borrelli, Giuseppe Cacciatore, Giuseppe Cantillo,
Giovanni Casertano, Domenico Conte, Giuseppe A. Di Marco, Francesco Donadio,
Giuseppe Giannetto, Antonello Giugliano, Domenico Jervolino, Marco Ivaldo,
Giuseppe Lissa, Fabrizio Lomonaco, Edoardo Massimilla, Eugenio Mazzarella, Fulvio
Tessitore, Aldo Trione, Renata Viti Cavaliere.
- Redazione:
Paolo Amodio, Maria Teresa Catena, Maria Di Domenico, Giulio Gentile, Salvatore
Giammusso, Nicola Grana, Michele Malatesta, Lidia Palumbo, Felice Ciro Papparo,
Valeria Pinto, Rocco Pititto, Valeria Sorge. Antonio Carrano, Giovanni Ciriello, Anna
Donise, Gianluca Giannini, Nicola Russo, Teodoro Tagliaferri, Pierluigi Venuta.
- Segreteria di Redazione:
Marilena Anzalone, Agostino Cera, Giuseppe D’Anna, Riccardo De Biase, Andrea Di
Miele, Edvige Di Ronza, Armando Mascolo, Maria Lida Mollo, Giovanni Morrone,
Rosalia Peluso, Stefano Santasilia, Fabio Seller.
- Coordinatore della Redazione:
Antonello Giugliano
Materiali, libri, files e corrispondenza vanno inviati all’attenzione del prof. Antonello
Giugliano ad uno dei seguenti indirizzi postali: [email protected]
oppure
Dipt. di Filosofia «A. Aliotta», Università degli Studi di Napoli «Federico II», via Porta
di Massa 1, 80133-Napoli
Ciascun contributo ricevuto dalla rivista per la pubblicazione in rete e/o in cartaceo è
preventivamente sottoposto alla procedura di “peer review”.
Registrazione Tribunale di Napoli n 2028 del 7/1/1969
Editore: Scriptaweb, via F. Caracciolo 10, 80122 Napoli, Tel.081.663318 Telefax 081.
663365, per conto del Dipartimento di Filosofia «A. Aliotta» dell’Università degli Studi
di Napoli «Federico II».
Direttore Responsabile: Aldo Trione
La rivista in formato telematico è posta all’URL: www.scriptaweb.it
Print-on-demand dei singoli contributi della rivista in formato cartaceo:
www.scriptaweb.it
©Logos, Dipartimento di Filosofia «A. Aliotta», Università degli Studi di Napoli
«Federico II».
Tutti i diritti riservati.
Pubblicato con il contributo finanziario del MIUR (progetto cofinanziato) e della
Regione Campania
ISSN:
ISBN:
INDICE
Saggi
Reinhard Brandt
Kant und Europa ............................................................................................................... 9
Giulio Gentile
Polizia, economia, ragion di Stato. Il regno nelle Riflessioni di Nicola Fortunato. ..............37
Antonio Gisondi
«Sana filosofia e sofistica prussiana», «principessa di sangue e vera regina» La filosofia
italiana tra due «patriarchi» ..............................................................................................75
Louis Begioni
Le operazioni memoriali del linguaggio nell’ambito della psicomeccanica del linguaggio di
Gustave Guillaume: esempi di applicazione alla temporalità in francese ed in italiano ..... 109
Piero Marino
Edmund Husserl e l’umanità europea ............................................................................ 123
Christoph Jamme
Pensée des origines et cosmopolitisme. Hölderlin et la destruction de l’humanisme chez
Heidegger ....................................................................................................................... 169
Rocco Pititto
Comprensione linguistica e comprensione musicale. Ludwig Wittgenstein filosofo della musica?
...................................................................................................................................... 183
Antonello Giugliano
Et.Quid.Amabo.Nisi.Quod.Rerum.Metaphysica.Est? de Chirico e Nietzsche ............... 211
Renata Viti Cavaliere
Una scelta di lettere di Carlo Antoni a Raffaello Franchini ........................................... 231
Note
Alessandro Barbone
La teoria pitagorica dell’armonia celeste .......................................................................... 263
Ciro Asproso
Giordano Bruno e il Dio in-esistente .............................................................................. 282
Salvatore Principe
L’uomo di Kant. Note in margine all’antropologia kantiana ......................................... 294
Alfonso Mirto
La fortuna editoriale dei Saggi di naturali esperienze nei secoli XVII-XIX.................... 312
Fernanda Gallo
Il manoscritto De Anima di Bertrando Spaventa ............................................................ 334
Simona Giacometti
La guerra e le decisioni spirituali: un possibile progetto politico ........................................ 348
Stefania Vacca
La teologia dialettica tra fede e esistenza nel pensiero di Karl Barth ................................. 374
Maurizio Filippo Di Silva
Heidegger: Agostino e l’ellenizzazione della coscienza cristiana ........................................ 382
Maria Giungati
Comprensione e perdono in Hannah Arendt ................................................................... 398
Piertoni Russo
L’immaginazione, la memoria e la storia. ....................................................................... 426
Alessio Pignorio
Demarcazione e irrazionalismo ....................................................................................... 434
Agostino Cera
“La filosofia come professione”. Note intorno al fenomeno della Consulenza Filosofica .... 442
Fabrizio Lomonaco
Mistica impura ............................................................................................................... 464
Recensioni
Rita Melillo
A. Lemme, La bibbia nella vita e nel pensiero di Agostino laico, Praha, Nakladatelství
Nové město Praha, 2008 ............................................................................................... 472
Edvige Di Ronza
Ai margini di Hegel a proposito di un recente studio di R. Bonito Oliva* ....................... 476
Giovanni Sgro’
K. Marx – F. Engels, Opere complete. XXII: Luglio 1870 – settembre 1871, trad. it. di
S. Bracaletti, V. Morfino, M. Vanzulli e F. Vidoni, a cura di M. Vanzulli, NapoliRoma, La città del sole-Editori Riuniti, 2008 ............................................................... 486
Indice
Fernanda Gallo
Bertrando Spaventa, Opere, a cura di Francesco Valagussa, postfazione di Vincenzo
Vitiello, Milano, Bompiani, 2009 ................................................................................. 492
Maria Letizia Pelosi
Il Novecento di Hannah Arendt. Un lessico politico, a cura di Olivia Guaraldo, Verona,
Ombre Corte, 2008 ....................................................................................................... 498
Clementina Gily
Franco Cambi, Pensiero e tempo. Ricerche sullo storicismo critico: figure, modelli, attualità,
FirenzeUniversityPress, Firenze 2008 ........................................................................... 502
Stella Sepe
Rita Melillo, L’Io che non c’è, Milano, FrancoAngeli, 2008 ......................................... 508
Stefania Achella
J. N. Tetens, Saggi filosofici sulla natura umana e sul suo sviluppo, cura, intr. e trad. di R.
Ciafardone, Milano, Bompiani, 2008 ............................................................................ 512
Stefania Vacca
Lo scontro dentro le civiltà. A proposito di un recente studio di M. C. Nussbaum* ........ 518
Giovanni Sgro’
La differenza nomologica e il bisogno di giustizia delle masse. A proposito di un recente
studio di Hasso Hofmann .............................................................................................. 524
Saggi
Reinhard Brandt
Kant und Europa
Kant: Das ist eine Zeitspanne von 50 Jahren publizistischer Tätigkeit,
von 1748 bis 1798, von der Schätzung der lebendigen Kräfte bis zum Streit der
Fakultäten. Keine der Kantischen Schriften befasst sich nach Titel und
Thema mit Europa, und das Kant-Lexikon von Rudolf Eisler1 verzeichnet
den Namen “Europa” nicht als Stichwort, auch die Sekundärliteratur
schweigt fast gänzlich zu dem Thema, und doch ist es eines der vielen
Nebenmotive, das zu verfolgen aufschlussreich ist für beide Seiten: Für
die Metamorphose des Europakonzepts in der Aufklärung und für die
Kantische Kultur- und Rechtsphilosophie.
Europa: Das ist ein Mythos, sodann eine geographische, eine
historisch-kulturelle und eine politisch-rechtliche Realität. Für den
Mythos Europa und auch für sonstige antike Mythen oder Sagen hat sich
Kant partout nicht interessiert, es gibt, so weit ich weiß, nur einen
Interpretationsversuch des biblischen Mythos vom Anfang der
Menschheit – im Mutmaßlichen Anfang der Menschengeschichte (1786)2 –, und
dieser Essay bildet ein Stück der Auseinandersetzung mit Rousseau, er ist
nicht aus einem originären Interesse am Gegenstand erwachsen. Dabei
belehrt der aufgeklärte Philosoph den vor sich hin fabulierenden
Bibeltext darüber, was in ihm eigentlich gesagt wird und zaubert so ein
Stück Vernunft in die Vorzeit. Zweitens: Von dem geographischen
Kontinent Europa handelt die Vorlesung über Physische Geographie,
die er von ungefähr von 1757 bis 1796 hielt3; aber nur bis zum Anfang
der siebziger Jahre wird Europa als Kontinent neben Asien, Afrika und
Amerika besprochen, nach 1770 fällt Europa fort, vermutlich, weil es
danach als Teil der Anthropologie-Vorlesung geführt wird, die ab 17721773 parallel zur Physischen Geographie läuft und in der einzelne
R. Eisler, Kant-Lexikon, Berlin, 1930. – Kant wird im folgenden mit Band-,
Seiten- und meist auch Zeilenangabe nach der Ausgabe der Gesammelten Schriften
(Akademie-Ausgabe) zitiert.
2 Kant selbst spricht dabei nicht von einem Mythos, führt jedoch auch keine
Gründe an, die die “Genesis” von einer mythischen Erzählung unterscheiden.
3 Die Vorlesung wurde im Bd. IX der Akademie-Ausgabe in der höchst
problematischen Edition von Friedrich Theodor Rink herausgegeben. Die kritische
Edition der erhaltenen Texte wird durch Werner Stark (Marburg) vorbereitet.
1
10
Logos
europäische Völker charakterisiert werden4. Drittens: das historischkulturelle Europa wird in verschiedenen Kontexten erwähnt und erfährt
in den divergierenden Bereichen eine erstaunlich homogene Behandlung,
ihm kommt von Anfang an bis in Kants Gegenwart der Primat unter
allen Erdteilen zu; dasselbe gilt für die Realisierung des rechtlichen
Friedenspostulats; Europa tritt als Gesetzgeber der künftigen
paritätischen Völkergemeinschaft auf.
Ich möchte im folgenden die drei Europa-Aspekte erörtern:
Geographie, Kultur, Recht. In einem Rückblick soll die EuropaPräferenz der Vernunft erläutert werden – wird Europa am Ende zu
einem (dann nicht nur Kantischen) Vernunftmythos, der den ZeusMythos forterzählt?
Es ist üblich geworden, von Kant ein möglichst sympathisches Bild
zu zeichnen, er sei kein Stubengelehrter, der bürokratisch nach der Uhr
spazieren geht, sondern ein weltoffen-fröhlich-freundlicher Mann, und
er sei kein bornierter Alteuropäer, sondern ein Kosmopolit mit Sitz in
der UNO. Das ist nicht ganz falsch, aber die Anbiederung an den
ikonensüchtigen Publikumsgeschmack ist allzu offenkundig. Im
folgenden wird versucht, die Dinge wieder ein wenig ins Lot zu bringen.
1. Europa – geographisch und biologisch
Kant hat ungefähr von 1757 bis 1795 über “Physische Geographie”
gelesen und dabei eine eigene Vorlesung und feste Textvorgabe kreiert5.
Geographie war kein eigenständiges Universitätsfach, fand jedoch der
zahlreichen Entdeckungs- und Handelsreisen und der Berichte darüber
ein großes Publikumsinteresse. Das Fach selbst ist Kant in seiner
Geschichte nicht vertraut; es gibt keine Anzeichen dafür, dass er wusste,
dass es von den Vorsokratikern bis zu den hellenistischen Geographen,
etwa Eratosthenes und Ptomlemaios, eine hochrangige mathematische
Geographie mit der Erkenntnis der Erde als eines runden Planeten, der
sich jährlich um die Sonne bewegt, schon gab, diese Wissenschaft jedoch
wegen Desinteresse bei den Römern und der Rückkehr zur kindlichen
Anschauung der Bibel im Mittelalter praktisch ausgelöscht war und erst
allmählich wieder entdeckt wurde. Kant hielt die “kopernikanische
Wende” für neu und wusste auch nichts von den antiken Klimatheorien.
4 S. in den Vorlesungsnachschriften XXV 232-234, S. 450-452, S. 654-661, S. 11811187, S. 1398-1414.
5 Vgl. die Bemerkung des Ministers von Zedlitz
Kant und Europa
Die Vorlesung zur Physischen Geographie untersucht die eine der
beiden Naturvorgaben für die Europäer, die geographische Lage und
Gestalt und damit auch das Klima des Kontinents im Vergleich mit den
Naturbedingungen der anderen Erdteile. Die zweite physische
Vorbedingung für das Handeln der Menschen in Europa ist die
Beschaffenheit der weißen Rasse innerhalb der Menschengattung mit
insgesamt vier Rassen. Naturvorgabe bedeutet zweierlei: Einmal haben
wir es mit Fakten einer mechanisch konzipierten Naturkausalität zu tun,
zum anderen jedoch mit einer teleologischen Natur, die die
mechanischen Abläufe auf ein vernünftiges Ziel hin lenkt. Sowohl in der
Gestaltung der Erdteile wie auch in der globalen Disposition der vier
Rassen leuchtet in einer schwer genau zu bestimmenden Weise die
Vorsehung hervor; es scheint dann so, als ob die Vorsehung Europa
bewusst bevorzugt habe.
Wenn man die (noch nicht edierten) Nachschriften der GeographieVorlesung aus der Frühzeit bis in die frühen siebziger Jahre verfolgt,
kommt man zu einer überraschenden Feststellung: Wären die Hefte
nicht in deutscher Sprache überliefert, wäre man auf den ersten Blick
kaum in der Lage, auf den Ort oder auch das Land zu schließen, aus dem
der Autor stammt. Die Theorie der Winde und der Quellen, die
Beschreibung der Einwohner Japans und Amerikas, Mitteleuropas und
Madagaskars, alles wird, so scheint es, ohne jeden Eurozentrismus
eingeordnet und dargestellt. Die Weltgeographie wird von einem
Weltbürger verfasst – das ist eine Neuerung, die Kant hier gegen frühere
Autoren einführt, die die physische Geographie unter einem vorwiegend
an Europas Geopolitik orientierten Interesse behandelten. Natürlich, so
läßt sich sagen, ist der enteuropäisierte Blick auf das Ganze eine
besondere Eigentümlichkeit der europäischen Kultur, das eben ist ihre
Sonderstellung. Auf diese Figur, dass das Partikulare Europas das
Allgemeine aus sich erzeugt, werden wir auch später zurückkommen; es
ist eine Struktur, die die zeitgenössische Auseinandersetzung mit Johann
Georg Hamann und Johann Gottfried Herder bestimmt und die später
als Konflikt zwischen Kommunitariern und Universalisten weiterleben
sollte. Bei Kant jedoch ist der möglichst europa-neutrale Blick in dem
Fachgebiet der Physischen Geographie eine eigene Errungenschaft6.
Die Vorlesung mit dem Titel Physische Geographie ist vor 1772 so
angelegt, dass nach einer kurzen Behandlung der mathematischen
Geographie (Thema: Die Stellung der Erde im Planetensystem) die drei
Elemente Wasser, Land, Atmosphäre und die durch Feuer verursachten
6
Vgl. die Anthropologie in Bd. VII und XXV der Akademie-Ausgabe.
11
12
Logos
vulkanischen Veränderungen der Erde vorgeführt werden; dann folgt ein
Teil über die vier Reiche der Natur, die Menschen, Tiere, Pflanzen und
Mineralien, und drittens die Behandlung der vier Erdteile oder
Kontinente Asien, Afrika, Europa und Amerika in eben dieser
Reihenfolge. Diese letzte Anordnung folgt der Sonnenbewegung; mit
dem Störelement Afrika ist Asien für uns der Orient und Amerika der
Okzident der Sonne, also dringt hier trotz der möglichst neutralen
Behandlung doch eine klare Eurozentrik in die Anlage.
In der Annahme von vier Erdteilen oder Kontinenten folgt Kant der
Standardversion, und er hat kein Interesse, sie in Zweifel zu ziehen.
Australien ist zwar entdeckt7, aber die Viererordnung hat noch eine
solche klassifikatorische Macht, dass man sich nicht entschließen kann,
sie durch einen fünften Kontinent zu erweitern. In Zedlers Großem
vollständigem Universal Lexikon heißt es in Bd. VIII von 1734: «Obwohl
Europa das kleinste unter allen 4. Theilen der Welt ist, so ist es doch um
verschiedener Ursachen willen allen übrigen vorzuziehen. Die Lufft ist
darinnen gemäßigt, die Landschafften sind sehr fruchtbar, [...]. Die
Europäer haben auch durch ihre Geschicklichkeit und Tapfferkeit die
vortrefflichsten Theile der Welt unter sich gebracht. Ihr Witz erhellet aus
ihren Wercken, ihre Klugheit aus ihrer Regierung; ihre Stärke und Macht
aus ihren Armeen; ihre gute Conduite aus ihrem Handel und Wandel
[...]»8. Insgesamt wird Kant dieser Vorstellung zustimmen, wenn auch
mit neuen Präferenzkriterien für Europa; dazu später Näheres.
Die Grenze Europas im Süden, Westen und Norden bietet kein
Verlaufsproblem; der Osten jedoch leidet unter der ambivalenten
Stellung Russlands, die in der späteren Phase überraschend nicht nur
geographisch, sondern auch zeitlich gilt. Geographisch gibt es ein
europäisches Russland, das bis zum Ural reicht, und dann ein asiatisches
Russland. Historisch gibt es eine ähnliche Zweiteilung, indem gesagt
wird, Russland sei «noch nicht» europäisiert.9 In der Vergangenheit
gehörte demnach Russland zu Asien, in Zukunft aber werde es sich
Europa anschließen, die Gegenwart also bildet gewissermaßen den Ural
im Fortschritt vom Osten zum Westen. Selbstverständlich gehört KleinDazu vgl. z. B. Physische Geographie Volckmann, 1785, 8 R:8 (unpubliziert).
J.H. Zedler (hrsg von) Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und
Künste [...], Leipzig und Halle, 1732-1750, 1734 ff., VIII Spalte 2195-2196. Die
Charakteristik wurde fast wörtlich von der Encyclopédie übernommen. Vgl. R. Brandt
Europa in der Reflexion der Aufklärung, in «Politisches Denken. Jahrbuch» 1997, S. 1-23, S.
7.
9 Ebd., S. 2-3. R. Brandt, Kant in Königsberg, in Studien zur Entwicklung preußischer
Universitäten. Unter Mitwirkung von Werner Stark herausgegeben von Reinhard Brandt
und Werner Euler, Wiesbaden, 1999, 273-322, S. 274-279.
7
8
Kant und Europa
Asien, Asia minor, nicht zu Europa; es wird von einer europäischen
Türkei nördlich des Bosporus gesprochen, aber die Grenzlinie zwischen
Europa und Asien ist eindeutig und wird nicht in Frage gestellt.
Unter dem Titel “Charakter des Volks” (oder auch: “der Völker”)
werden in der Anthropologievorlesung ab 1772-1773 (Bd. XXV) und in
der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht von 1798 (Bd. VII) die
europäischen Nationen der Engländer, Franzosen, Deutschen, Spanier,
Italiener, Polen und Russen charakterisiert, d. h. es wird das
Eigentümliche durch interne Merkmale und Kontrastierung mit den
jeweils anderen Völkern möglichst klar und deutlich herausgestellt.
Außerhalb Europas wird nur das christliche Volk der Armenier
hervorgehoben und charakterisiert, sodann zeigt sich eine unverhohlene
Polemik gegen die Türken als Besatzungsmacht Griechenlands. Diese
Beurteilung entspricht der allgemeinen Auffassung in Europa und führt
zur Begeisterung für die Befreiungskriege; sie findet ihren höchsten
Ausdruck in der Dichtung Friedrich Hölderlins und Lord Byrons. Auf
die Bedeutung Griechenlands werden wir noch zurückkommen.
Außerhalb des Kapitels über den “Charakter des Volks” (VII 311-320)
wird die jüdische Nation in einer Fußnote zu dem Abschnitt “Von den
Gemüthsschwächen im Erkenntnißvermögen” und dort zu dem
Stichwort “Betrüger” in einer diffamierenden Weise vorgestellt (VII 205206)10. Auch hierauf werden wir wieder zurückkommen; Kant hat nicht
die Intention, den Juden als einer selbständigen Kulturkomponente
Europas Rechnung zu tragen, sondern sie zu verdrängen. Es ist schwer
zu ermessen, wie stark seine Autorität durch die deutschen
Bildungsanstalten in einer verhängnisvollen Weise auf die deutsche
Geschichte einwirkte.
Eine nicht unwichtige Rolle im Europabild Kants spielt die
Rassentheorie, die sich allmählich in den siebziger Jahren herausbildet
und verfestigt. Von den vier Rassen der Menschen (Weiße, Schwarze,
Rote, Gelbe) handeln sowohl die Vorlesung zur Anthropologie wie auch
zwei Aufsätze, die Kant 1775 (“Von den verschiedenen Racen der
Menschen”) und 1785 (“Bestimmung des Begriffs einer Menschenrace”)
veröffentlicht11. Die Arbeit von 1775 stellt die These auf, dass es außer
Vgl. dazu R. Brandt, Kommentar zu Kants Anthropologie, in «Kant-Forschungen» 10,
hrsg. von Reinhard Brandt und Werner Stark, Hamburg 1999, S. 205-206.
11 Vgl. R. Malter, Der Rassebegriff in Kants Anthropologie, in Die Natur des Menschen.
Probleme der Physischen Anthropologie und Rassenkunde (1750-1850), hrsg. von Gunter Mann
und Franz Dumont (Soemmering-Forschungen VI), Stuttgart und New York, 1990, S.
113-12. Während Buffon Locke folgt und die Rasseneinteilung als eine menschliche
Maßnahme ansieht, werden die Rassen von Kant als substantielle Naturdifferenzen
gefasst; dazu E. Ch. Eze,The Color of Reason: The Idea of Race in Kant’s Anthropology, in E.
10
13
14
Logos
den vier empirisch auffindbaren Rassen eine «Stammgattung. Weiße, von
brünetter Farbe» (II 441,21) gebe; man müsse sie jedoch entweder «für
schon erloschen ausgeben oder aus den vorhandenen diejenige
aussuchen, womit wir die Stammgattung am meisten vergleichen
können»; obwohl wir, so heißt es, nicht hoffen können, «jetzt irgendwo
in der Welt die ursprüngliche menschliche Gestalt unverändert
anzutreffen», nimmt er jetzt lebende «weiße, doch brünette Einwohner»
als die «Gestalt» an, die der Stammgattung die «nächste» sei (II 441,6)12.
Der weißen Rasse kommt also neben den drei anderen eine Sonderrolle
zu; es ist dies neben dem Vorzug, charakterisierbare Völker zu besitzen,
die zweite Favorisierung, die die Vorsehung den zu den Weißen
zählenden Europäern zuspielt. Hierbei überschreitet die weiße Rasse
zwar die Grenzen des europäischen Kontinents, dieser ist jedoch als
einziger ausschließlich von Weißen besiedelt. Die Rassen unterscheiden
sich nicht nur durch ihre Hautfarbe, sondern durch bestimmte Merkmale
des Naturells, der Temperamente und besonders der intellektuellen und
sittlichen Anlagen. In der Wertung dieser inneren Qualitäten sind die
Weißen den drei farbigen Rassen weit überlegen13. «Der Schwarze ist
zum Sclaven gemacht, und verdienet jederzeit einen Herren. Er befindet
sich besser, wenn der Weiße ihn regieret, als wenn er sich selbst regieret.
[...] Die Einwohner in Asien, [...] besonders die Indianer jenseits des
Ganges [...] sind von Anbeginn der Welt Sclaven gewesen. [...] Die
Chineser sind ebenfalls feige. [...] An Talenten fehlt es ihnen beynahe, so
wie denen Negers». So in einer Nachschrift zur Physischen Geographie
(Hesse ca.1770, 93-94). Die Anthropologie-Friedländer (1775-1776) bestätigt:
«Es ist ein großer Theil des menschlichen Geschlechts von denen es
scheint, dass ihnen die Natur das Vermögen zu urtheilen aus Begriffen
versagt hat. Dahin gehören alle orientalische Völcker. Hieraus folgt, dass die
gantze Moral bey ihnen nicht rein seyn kann, weil sie aus Begriffen erkannt
werden muß. Ihrer Moral fehlt der wahre moralische Begriff, dahero kann
bey ihnen nichts aus dem Grundsatz der Moralitaet entspringen. Die
Ehrbegierde der orientalischen Völcker ist ganz unterschieden von der
Ehrbegierde der occidentalischen. Bey diesen ist der Begriff der Ehre ein
wahrer Begriff, allein die orientalischen Volcker suchten Z. E. in der Gewalt
Ch. Eze (hrsg.), Postcolonial African Philosophy. A Critical Reader, Oxford, 1997, S. 103-140,
S. 119-122. Die Rassenschriften indizieren sich selbst als Werke eines weißen Mannes,
da Farbige und Frauen zur Wissenschaft nicht fähig sind.
12 Goethe suchte bekanntlich die Urpflanze in Sizilien, die Urrasse erscheint hier
als deren Pendant.
13 Vgl. R. Brandt, Europa in der Reflexion der Aufklärung, a. a. O., S. 11. A. Sutter,
Kant und die Wilden. Zum impliziten Rassismus in der Kantischen Geschichtsphilosophie, in «Prima
Philosophia» II (1989), S. 241-265.
Kant und Europa
ihre Ehre, also aus der Sinnlichkeit und nicht aus Begriffen» (XXV 552, 616).
Dies ist genau die Meinung, die in der “Nachschrift Kaehler” zu
einer Vorlesung über die Physische Geographie, datiert mit «per
semestre aestivum 1775», zu finden ist: «Die ursprüngliche Farbe
scheinet die Weiße zu seyn, welche aus der Durchsichtigkeit der
schleimichten Materien und Partikkelchens der Haut entstehet (welches
das Durchschimmern des Bluts und Adern beweiset) indem diese ein
Fundament zu allen ist und durch das Zuthun der äussern Luft und
Bodens, Nahrungsmittel p in andere Farbe degeneriren kann. Adam
scheinet also ein weißer und zwar ein blonder gewesen zu seyn [...]»
(Kaehler 1775, 363-364, unpubliziert). Kant folgt hierin Buffon, bei dem
man lesen kann:
«Die weiße Farbe scheint demnach die ursprüngliche Farbe der Natur
zu seyn, welche der Himmelsstrich, die Speisen und die Sitten verändern,
und sie in das gelbe, Braune oder Schwarze verwandeln, und welche in
gewissen Umständen wieder erscheint, allein mit einer so großen
Veränderung, daß sie mit dem ursprünglichen Weißen keine Aehnlichkeit
hat, welches aus den eben angezeigten Ursachen ganz von seiner Natur
abgewichen ist. Ueberhaupt nähern sich die einander entgegen gesetzten
äußersten Grade in beyden fast beständig einander. Die Natur hat in ihrer
größten Vollkommenheit weiße Menschen gebildet, und die auf das höchste
veränderte Natur bildet sie gleichfalls weiß. Allein das natürliche, oder der
ganzen Art wesentliche Weiße, ist von dem zufälligen, oder nur in einzelnen
Gegenständen befindlichen Weißen, sehr unterschieden» 14. Kant: «Die
Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Race [Variante: in
den Racen] der Weißen» (IX 316,5-6).
1785 wird keine Aussage mehr über die Farbe der ursprünglichen
Stammgattung gemacht, sondern es wird nur gegen Pluralisten (wie
Georg Forster) die Notwendigkeit der Annahme eines einzigen
Menschenstammes geltend gemacht, aus dem sich dann die vier Rassen
auf Grund von Keimen in der ursprünglichen Gattung entwickeln (VIII
101-102).
Den frühen Dokumenten zur Anthropologie entnehmen wir noch
einen weiteren Hinweis, der für die Europa-Frage überraschend
aufschlussreich ist. Kant konfrontiert Rousseaus synthetisches Vorgehen
14 G.-L. L Buffon, Allgemeine Historie der Natur nach allen ihren besondern Theilen
abgehandelt; nebst einer Beschreibung der Naturalienkammer Sr. Majestät des Königs von Frankreich.
Mit einer Vorrede Herrn Doctor Albrecht von Haller, [...], Hamburg und Leipzig, 1750-1781,
II.1, S. 300.
15
16
Logos
mit dem eigenen analytischen15. Rousseau wolle den ursprünglichen
Naturmenschen aufsuchen, um an ihm das Modell zu finden, wozu der
Mensch eigentlich bestimmt sei; er, Kant, wolle umgekehrt den
Menschen der Gegenwart nehmen und ihn analysieren im Hinblick auf
die Elemente, aus denen er sich zusammensetzt. Nun ist der Mensch, an
den Kant bei seinem analytischen Vorgehen denkt, wesentlich der
Europäer, wie er sich in der Kant geläufigen Literatur, also der
europäischen, darstellt. Durch diesen methodischen Schachzug gegen
Rousseau liquidiert er dessen zivilisations- und europakritischen Ansatz.
Aber wie soll man sich die Zukunft vorstellen? Läuft die Geschichte
auf eine Kompilation aller Rassen hinaus? Kant notiert: «Alle racen
werden ausgerottet werden [...], nur nicht die der Weißen» (XV 878,1921 – Refl. 1520). Und: «Es ist nicht gut, dass sie sich vermischen» (XV
878,23 – Refl. 1520). Also wird die Vorsehung eine Vermischung
verhindern.
2. Europa – historisch-kulturell
Zuerst, was mit dem Titel nicht gemeint ist: Kant nimmt kein
Interesse an der europäischen Geschichte oder Kulturgeschichte und
verfasst keine Schrift, die einem historischen Thema als solchem
gewidmet ist. Hiermit bildet er zusammen mit Descartes, Locke, auch
Mendelssohn eine Gegenpartei zu vergleichbaren Philosophen – Hobbes
und Leibniz, Pufendorf und Wolff, Hume, Smith, Rousseau und Voltaire
und die übrigen Enzyklopädisten, später Hegel und Marx: Sie alle
widmen einen Teil ihrer Aufmerksamkeit und Arbeit der Geschichte, sei
es die europäische Ereignis- oder die Sozial-, Religions-, Produktionsoder dynastische etc. Geschichte; sie suchen zugleich die Standards der
Geschichtsschreibung zu verbessern. Bei Kant gibt es in der Vorlesung
zur Physischen Geographie und zur Anthropologie zwar ein reiches
geschichtliches Material, aber es wird immer nur in kurzen Fragmenten
geboten, es dient zur Ergänzung und Illustration und kann durch
anderes geeignetes Material ersetzt werden – die Realgeschichte als
solche mit dem ihr eigentümlichen Zusammenhang ist ähnlich wie bei
Descartes und Locke aus dem Oeuvre ausgeblendet16. In der “Idee zu
einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht” wird eine Idee
Vgl. XXV 684,14 ff.
R. Brandt, Kant in Königsberg, in Reinhard Brandt und Werner Euler (hrsg. von),
Studien zur Entwicklung preußischer Universitäten, unter Mitwirkung von Werner Stark,
Harrassowitz, Wiesbaden, 1999, S. 273-322, S. 276-278.
15
16
Kant und Europa
zu einer philosophischen Geschichte in wirklicher Ausführung
entwickelt, aber das Gebiet dieser Geschichte selbst nicht betreten.
Entsprechend fehlt auch eine Thematisierung Europas als einer
historisch-kulturellen Einheit.
Aber was kann denn “historisch-kulturell” noch heißen, wenn ein
Interesse an der Historie und an der europäischen Kulturgeschichte als
solcher fehlt? Tatsächlich hat dieser von Kant nicht benutzte Begriff
einer Stellungnahme zum historisch-kulturellen Europa seine gute
Berechtigung. Kant hat eine, sagen wir: Vision von Europa als einer
historisch-kulturellen Macht; Europa ist ein fast metaphysischer Raum,
in dem sich die menschliche Vernunft in der Wissenschaft, Kunst und
Philosophie und in der Moral zuerst verwirklicht. Von Europa aus wird
sie sich allmählich zu einer Weltkultur entwickeln. Die Genese einer
reflektierten, humanen und moralisch-rechtlichen Kultur vollzieht sich in
schroffer Ablehnung einer pluralen Entstehung ausschließlich im
europäischen Kontinent; aber da die europäische Vernunft die einzig
mögliche, weil die Vernunft ohne möglichen Plural ist, ist sie identisch
mit der Vernunft aller Völker.
Kant ist also Eurozentriker und als Eurozentriker paradoxerweise
zugleich Kosmopolit. Um diese seine dezidierte Position zu begreifen, ist
es günstig, an zwei Philosophen zu erinnern, die keine Eurozentriker im
Kantischen Sinne waren, Leibniz und Wolff. Beide sehen
außereuropäische Kulturen gewissermaßen auf gleicher Augenhöhe, sie
interessieren sich z. B. für die chinesische Kultur als eine originäre
Formation, die unserer europäischen zunächst nicht nachsteht. Leibniz
publizierte 1697 die Novissima Sinica und verknüpfte mit der Verbindung
zwischen China und Europa die Hoffnung eines Zuwachses an Vernunft
und Sittlichkeit auf beiden Seiten. «Durch eine einzigartige Fügung des
Schicksals [...] ist es geschehen, dass die höchsten Kulturgüter des
menschlichen Geschlechts heute gewissermaßen an den beiden
äußersten Enden unseres Kontinents17 zusammengebracht sind, das
heißt in Europa und China, das gleichsam als östliches Europa den
entgegengesetzten Rand der Erde schmückt»18.
Wolffs Engagement für die Moralphilosophie der Chinesen ist
getragen von wissenschaftlicher Neugier und moralischer Hochachtung,
und fast hätte ihn die wahrhaft aufgeklärte Haltung in seiner
Rektoratsrede von 1721, der Oratio de Sinarum philosophia practica, das
Leben gekostet.
Sc. der eine Kontinent Eurasien.
Zit. nach U. Bitterli, Die “Wilden” und die “Zivilisierten”. Grundzüge einer Geistes- und
Kulturgeschichte der europäisch-überseeischen Begegnung, München, 1991, S. 64.
17
18
17
18
Logos
Von dieser neugierig-offenen Haltung ist bei Kant wenig
übriggeblieben. Die kritische Edition der “Physischen Geographie” wird
en detail belegen, wie er aus dem Material, das ihm vorlag, häufig eine
Negativauswahl traf, ob dies nun die Chinesen und ihre betrügerischen
Praktiken im Handel oder die Hottentotten und ihre animalische
Lebensweise betraf. Das Bild, das insgesamt von den außereuropäischen
Kulturen und Lebensformen entsteht, dient durchweg der Belustigung
oder dem Entsetzen der Hörer der Vorlesung, nicht aber der Neugier
und wenigstens entfernten Achtung vor anderen Lebensformen.
Voltaire wirft in seinem Essai sur les moeurs et l’esprit des nations (17401756) Montesquieu vor, mit seinem Despotismus-Etikett den
orientalischen bzw. asiatischen Regimen nicht gerecht zu werden. Er
habe die Fakten verdreht oder nicht zur Kenntnis genommen. Die
Hochkulturen Asiens und Europas würden sich nicht wesentlich
unterscheiden und könnten einander befruchten. Dann kommt jedoch
im letzten Kapitel der Umschwung: Unser Europa ist spezifisch
unterschieden von den anderen Kontinenten; China z. B. wird die
Befähigung zum Fortschritt abgesprochen. Aber eben dies schreibt auch
Montesquieu in De l’esprit des lois! Dort gibt es ein Kapitel mit dem Titel:
«Cause de l’immutabilité de la religion, des moeurs, des manières, des lois
dans les pays de l’Orient» (XIV 4) “Immutabilité” – aus einem positiven
Wert ist in der Aufklärung ein Verdikt geworden. Während die Antike
die “res novae” perhorresziert und Platon in den Nomoi den Bürger, der
eine Verfassungsänderung vorschlägt, zum Tode verurteilen läßt,
während “Innovation” bei Montaigne noch stigmatisiert wird: «Nichts
bedrängt einen Staat so sehr wie die Neuerung: Veränderung führt zu
nichts als Ungerechtigkeit und Tyrannei»19, erhält die Vorstellung der
historischen Entwicklung zum Besseren, der Änderung, der Bewegung
im 18. Jahrhundert eine zunehmend positive Konnotation. Kein Autor
vor der Aufklärung sieht das Wohl der Staatsgesellschaft im Fortschritt,
aber genau das schreibt auch Christian Wolff: «non impeditus progressus
ad finem societatis consequendum, salus societatis dicitur»20. Der
ungehinderte Fortschritt selbst ist das Wohl der Gesellschaft, Europa
sieht sich als den Erdteil der Innovation auf allen Gebieten der Kultur,
während die anderen Kontinente in einer lähmenden Stagnation
verharren. Kant: «Viele Völker schreiten vor sich selbst nicht weiter fort.
Grönlander, asiater. Aus Europa muß es kommen. Amerikaner
19 M. de Montaigne, Essais, zit. Nach R. Girard, Nachricht von Neuerung, die drauf und
drunter geht, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung» vom 13. November 2004, S. 41.
20 C. Wolff, Institutiones juris naturae et gentium, hrsg. von Marcel Thomann
(Gesammelte Werke II 26), Hildesheim und New York 1968, § 837, 524-525.
Kant und Europa
ausgerottet. Fortschritt von Grichen an» (XV 781,20-22 – Refl. 1499)21.
Von den Orientalen, deren wesentlicher Schlag der der Tartaren und
Calmücken ist, gilt: «Beyde perfectioniren sich nicht, reisen nicht, sind
keiner Gesetze fähig» (XV 879,15-16 – Refl. 1520). In der
“Anthropologie-Pillau” vom Wintersemester 1777-1778 heißt es: «Wir
finden Völcker die in der Vollkommenheit der menschlichen Natur nicht
fortzuschreiten scheinen, sondern einen Stillstand gemacht haben, da
andere, als in Europa immer fortschreiten»22.
Eine derartige Charakteristik wird man in der Antike und natürlich
im Mittelalter nicht finden, sondern erst in der Neuzeit, die den
Baconschen und Wolffschen Imperativ der Verbesserung und
Vervollkommnung vergleichend nach außen wendet und findet, dass die
anderen Kontinente sich nicht verändern und an dem Projekt der
Aufklärung nicht teilnehmen. Der Wechsel der Fremdsicht von Leibniz
und Wolff zu der von Kant ist das Ergebnis auch eines Wandels des
Selbstverständnisses: Der Fortschrittsgedanke erfährt eine zunehmende
Tiefenstruktur und wird zum Maßstab der eigenen und fremden
Kulturkompetenz.
Im folgenden sollen einige Kultursektoren genannt werden, in denen
Europa der Kontinent ist, der den Umbruch von der Natur zur
eigentlichen Kultur leistet und die einmal geleistete Initiative bis heute
bewahrt.
Die ernstzunehmende Geschichte wird in Europa generiert: «Nur
ein gelehrtes Publicum, das von seinem Anfange an bis zu uns
ununterbrochen fortgedauert hat, kann die alte Geschichte beglaubigen.
Über dasselbe hinaus ist alles terra incognita; und die Geschichte der
Völker, die außer demselben lebten, kann nur von der Zeit angefangen
werden, da sie darinn eintraten. Dies geschah mit dem jüdischen Volk zur
Zeit der Ptolemäer durch die griechische Bibelübersetzung, ohne welche
man ihren isolirten Nachrichten wenig Glauben beimessen würde. Das
erste Blatt des Thucydides (sagt Hume)23 ist der einzige Anfang aller wahren
21 S. dazu auch H. Zedelmaier, Der Anfang der Geschichte. Studien zur Ursprungsdebatte
im 18. Jahrhundert, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2003, 181.
22 I. Kant, Vorlesung zur Moralphilosophie, hrsg. von Werner Stark, de Gruyter,
Berlin, 2004, Anm. 240, S. 365.
23 Vgl. D. Hume, Essays Moral, Political and Literary, University Press, Oxford, 1963,
419; Id., Vermischte Schriften über die Handlung, die Manufacturen und die andern Quellen des
Reichthums und der Macht eines Staates (1754-1756). Aus dem Englischen übersetzt,
Hamburg und Leipzig, I, S. 275 – “Von der Menge der Menschen bey den alten
Nationen”: «Das erste Blatt des Thucydides ist, meiner Meynung nach, der Anfang der
wahren Geschichte. Aller vorhergehende Erzählungen sind mit der Fabel so
untermischt, daß Philosophen sie größtentheils der Verschönerung der Dichter und der
19
20
Logos
Geschichte» (VIII 29,28-37). Die außereuropäische Geschichte ist also
ein bloßes Naturgetümmel, das den verständigen Menschen nicht zu
interessieren braucht; die Geschichte beginnt mit Europa und durch
Europa. Durch diese eurozentrische Wende wird auch die jüdische
Geschichte auf den Teil reduziert, der von dem Datum datiert, als die
Griechen sich der Bibel annahmen, erst mit der Übersetzung des Alten
Testaments ins Griechische wird die Sammlung von Erzählungen in die
Kultureinheit integriert. Das Judentum, aus dem sich das Christentum
entwickelte, war schon durch die Griechen sittlich aufbereitet worden, es
befand sich schon in einem Zustand, «wo diesem sonst unwissenden
Volke schon viel fremde (griechische) Weisheit zugekommen war», wie
es in der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft heißt (VI 128,3-4;
79,29-80,11).
Eine kurze Nebenbemerkung zu dieser Geschichtsauffassung.
Leibniz hatte noch in der Theodizee geschrieben, die Geschichte sei ein
«Roman de la vie humaine»24; jetzt wird jedoch die «wahre Geschichte»,
wie Kant zitiert, erst durch den menschlichen Geist des
Geschichtsschreibers möglich, fast als sei die Realgeschichte durch ihre
Erfassung im Geschichtswerk des Historikers möglich und nicht
umgekehrt. Die Bedingung der Möglichkeit der schriftlichen Darstellung
ist die Bedingung der Möglichkeit des Dargestellten, wie man den
Sachverhalt paraphrasieren könnte. Aber zurück zur Europäisierung der
Geschichte. In der Vorrede der Kritik der reinen Vernunft von 1787 steht:
«Die Mathematik ist von den frühesten Zeiten her, wohin die Geschichte
der menschlichen Vernunft reicht […]» – der Leser erwartet vielleicht
Hinweise auf eine «mathematica antediluviana», aber es folgt: «in dem
bewundernswürdigen Volke der Griechen den sicheren Weg einer
Wissenschaft gegangen» (KrV B X).
Johann Gottfried Herder stellt in Kenntnis des Humeschen Diktums
dem Anfang der Geschichte und Moral in Griechenland die jüdische
Genesis in seiner Ältesten Urkunde des Menschengeschlechts (1774/1776)
entgegen; auf sie wieder repliziert Kant mit seinem Mutmaßlichen Anfang
der Menschengeschichte (1786): Das Buch “Genesis” in der Bibel ist für ihn
keine Urkunde, die man wissenschaftlich und wörtlich wie den
Thukydides liest, sondern ein Mythos, den man allegorisch nach eigenen
Redner überlassen müssen». Dieselbe Meinung vertritt Antoine Yves Goguet in seiner
Schrift De l’origine des loix, des arts, et des sciences; et de leurs progrès chez les anciens peuples
(zuerst anonym 1758) nach H. Zedelmaier, Der Anfang der Geschichte. Studien zur
Ursprungsdebatte im 18. Jahrhundert, a. a. O., S. 191-196.
24 G. W. Leibniz, Die philosophischen Schriften, hrsg. von C. J. Gerhardt (1885),
Hildesheim, 1965, VI 198 – Théodicée § 149.
Kant und Europa
Kategorien interpretiert. Kant monopolisiert die Geschichte, sie hat ein
europäisches Maß, weltweit gibt es sie nur in der synchronisierten
Fassung25. Herder beharrt auch in der Spätschrift Metakritik zur Kritik der
reinen Vernunft (1799) auf einer Pluralität von Geschichten und Zeiten:
«Eigentlich hat jedes veränderliche Ding das Maß seiner Zeit in sich;
dies besteht, wenn auch kein anderes da wäre; keine zwei Dinge der Welt
haben dasselbe Maß der Zeit. [...] Es gibt also (man kann es eigentlich und
kühn sagen) im Universum zu einer Zeit unzählbar viele Zeiten»26.
Im besonderen wird die Wissenschafts- und Philosophiegeschichte
auf den europäischen Beitrag reduziert; dies wird an verschiedenen
Stellen dokumentiert, u. a. in der Logik-Vorlesung, in der die Geschichte
der Weltweisheit in den Anfangsteilen vorgetragen wird. Es zählt nur die
europäische Philosophie; die frühe Logik Blomberg geht zwar noch auf die
Philosophie der Chaldäer, Perser, Chinesen und Juden ein, aber mit
unverhohlener Verachtung: «Diese Weltweisheit hat also das Ansehen
der vollkommensten Thorheit, [...]», heißt es von den Chaldäern (XXIV
32,8-9); das Urteil gilt jedoch für alle nicht-griechische Philosophie. Die
Dissertation von 1770 zeichnet «die Alten» aus, ohne etwas anderes zu
meinen als die griechischen und römischen Autoren. Die Verbindung zu
außereuropäischen Kulturräumen und vorgriechischen Zeiten ist
abgerissen. Ein Blick in die KrV und das Kapitel über “Die Geschichte
der reinen Vernunft” in der “Methodenlehre” einerseits und die von
Gottlob Benjamin Jäsche herausgegebene Textsammlung lehrt dasselbe.
In der letzteren heißt es in dem “Kurzen Abriß einer Geschichte der
Philosophie”, die Erkenntnis des Allgemeinen in abstracto sei spekulative
Erkenntnis, die Erkenntnis des Allgemeinen in concreto aber sei gemeine
Erkenntnis. «Unter allen Völkern haben also die Griechen erst
angefangen zu philosophiren. Denn sie haben zuerst versucht, nicht an
dem Leitfaden der Bilder die Vernunfterkenntnisse zu cultiviren,
sondern in abstracto; statt daß die andern Völker sich die Begriffe nur
durch Bilder in concreto verständlich zu machen suchten» (IX 27, 1520). Die Dissertation von 1770 führt die entscheidende titelgebende
Zäsur zwischen “sensibilis” und “intelligibilis” auf die “veteres” (II
392,18) und die “antiquitas” (II 395,11), speziell Platon (II 396) zurück:
Hiermit beginnt die zuverlässige Philosophie, und Kant kehrt zu den
griechischen Quellen zurück. In der KrV beginnt die “Geschichte der
25 Vgl. dazu R. Brandt Die Selbstaufhebung der europäischen Kultur; in «Merkur», LVIII
(2004), S. 670-68.
26J. G. Herder, Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft “Von dem Raume und von
der Zeit”, Berlin, 1955, S. 68
21
22
Logos
reinen Vernunft” nach einem kurzen Hinweis auf das Kindesalter der
Philosophie sogleich mit den Exponenten der griechischen Systeme (A
853 ff.) Die Vorlesungsnachschrift Metaphysik Volckmann (nach 1781, vor
1785) sagt zu diesem Thema:
«Bey den Griechen muß man die älteste Philosophie und also auch
Metaphysic suchen. Man redet wohl von der Philosophie der Egypter,
Celten, Juden, Perser Chineser etc. aber das ist alles nicht rechte
Philosophie. So etwas als Logic ist außer den Griechen bey keiner Nation
gewesen, und von den Griechen ist alles, was menschliche Weisheit ist,
erfunden worden, wie auch alles, was genie und Talent betrift [...]» (XXVIII
368,31-37).
Die Griechen entwickeln als erstes Volk sogar vernünftige Begriffe
der Sittlichkeit:
«Aber nachdem dieses scharfsinnige Volk so weit in Nachforschungen
fortgerückt war, selbst sittliche Gegenstände, darüber andere Völker
niemals mehr als geschwatzt haben, philosophisch zu behandeln: da fanden
sie allererst ein neues Bedürfniß, nämlich ein praktisches, welches nicht
ermangelte ihnen den Begriff des Urwesens bestimmt anzugeben, wobei die
speculative Vernunft das Zusehen hatte, höchstens noch das Verdienst,
einen Begriff, der nicht auf ihrem Boden erwachsen war, auszuschmücken
[…]» (V 140,30-37).
Die Griechen waren die ersten Moralphilosophen und erkannten
schon – pace Platon – den Primat des Praktischen in der Theologie. Von
den Griechen und niemand sonst stammen die «den Sklavensinn
erschütternden moralischen Freiheitslehren» (VI 80,1). Und dann noch:
«Ueberhaupt ist die griechische Sprache dazu [sc. zur Philosophie, RB]
am lenksamsten, und unter den lebenden, die Deutsche» (XXVIII
369,34-35).
Die “Vorrede” zur zweiten Auflage der KrV von 1787 kennt eine
Zweiteilung im Erkenntnisprozeß: Zuerst gibt es ein bloßes
Herumtappen auf den späteren Wissenschaftsgebieten, danach wird
entdeckt, dass die menschliche Vernunft oder der menschliche Verstand
die Gesetzgeber sind, weil die Gegenstände sich als Objekte der
menschlichen Erkenntnis nach uns richten, nicht umgekehrt wir nach
ihnen. «Die Mathematik ist von den frühesten Zeiten her, wohin die
Geschichte
der
menschlichen
Vernunft
reicht,
in
dem
bewunderungswürdigen Volke der Griechen den sichern Weg einer
Kant und Europa
Wissenschaft gegangen» (KrV B X).27 Aber zuvor schon die Logik, in der
es der menschliche Verstand nur mit sich selbst zu tun hat:
«Daß die Logik diesen sicheren Gang schon von den ältesten Zeiten her
gegangen sei, läßt sich daraus ersehen, daß sie seit dem Aristoteles keinen
Schritt rückwärts hat thun dürfen, [...]. Merkwürdig ist noch an ihr, daß sie
auch bis jetzt keinen Schritt vorwärts hat thun können [...]» (KrV B VIII).
Die wissenschaftliche Wende ist also 1787 eine innereuropäische
Angelegenheit. Kant verfasste 1763 einen kurzen Traktat mit dem Titel
“Versuch den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit
einzuführen”; darin wird von der Null Gebrauch gemacht: «Wir wollen
dieses Nichts künftighin Zero = 0 nennen» (II 172,3).
Woher kam die Null? Woher kam das von jedermann benutzte
Ziffernsystem? Hier konnte nicht verborgen bleiben, dass
außereuropäische Einflüsse die eigene Mathematik mitgestaltet hatten,
Kant blendet sie jedoch bewusst-unbewußt, jedenfalls systematisch aus
und erhält so den singulären Kontinent, der für das große Projekt der
Menschheit einzig zählt. In der Vorlesung zur Physischen Geographie
wird dagegen noch ca. 1775 nach einer Nachschrift vorgetragen:
«Zwey Länder sind vor einen AlterthumsForscher die wichtigsten 1)
Thibeth, welches die höchste Gegend in Asien ist. Es ist mit Indostan
benachbart, und scheint der Stammort der Völcker, die sich hernach um
Indostan ausgebreitet haben zu seyn. Würde man da noch mehr
untersuchen […], so würde man finden, daß alle Künste und Wißenschaften
ursprünglich von da herkommen. ZE. Die Ziffern der Zahlen, das
Schachspiel. […] Alle Europäische Völcker haben in ihren Zelten in
OstAsien gewohnt»28.
Aber diese eingesprengte Notiz bestimmt nicht den Tenor der
Kantischen Kultur- und Wissenschaftsauffassung.
Für das 17. Jahrhundert und die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts
war dagegen die Einbeziehung außereuropäischer Kulturräume noch
selbstverständlich29.
Zur Problematik einer derartigen Festlegung vgl. die bewundernswerte Studie
H.-J. Waschkie, Anfänge der Arithmetik im Alten Orient und bei den Griechen, Amsterdam,
1989.
28 Physische Geographie Messina S. 64. Den noch nicht edierten Text verdanke ich
einer Mitteilung von Werner Stark.
29 Zu dem Wandel vgl. Zedelmaier, Der Anfang der Geschichte, a. a. O., S. 60. Dort S.
104: «Die Griechen haben zuerst die Flügel ihres Verstandes in die Höhe geschwungen
und zu philosophiren angefangen».
27
23
24
Logos
Die Anfänge der Kultur überhaupt und speziell der Kunst liegen für
Kant ein für allemal in Griechenland. Kant ist Klassizist wie
Winckelmann in seiner Kunst- und Geschmackslehre: «Der gute
Geschmack, welcher sich mehr und mehr durch die Welt ausbreitet, hat
sich angefangen zuerst unter dem Griechischen Himmel zu bilden»,
lautet der erste Satz der Gedancken über die Nachahmung der Griechischen
Wercke in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst von 175530.
Winckelmann wies ausdrücklich den Gedanken zurück, die schöne
Kunst stamme aus Ägypten:
«Ob ich nun gleich mit denjenigen nicht einerlei Meinung sein kann,
welche behaupten, dass die Ägyptier Lehrer der Hetrurier und Griechen in
der Zeichnung gewesen: so gebe ich doch zu, dass nach Beschaffenheit die
in Ägypten übliche Kunst, und alles, wovon die Zeichnung Vorbild und
Anweisung ist, so wie die Verehrung der Götter, den Griechen und
Hetruriern von da aus mitgetheilt worden. Aber was folget hieraus? –
Nichts, als dass es dieser durch die Ägyptier verpflanzten Kunst eben so
erging wie der Mythologie, deren Fabeln unter dem griechischen Himmel
gleichsam von neuem geboren wurden, und ganz andere Gestalten und
Namen erhielten».
Im Streit um die Rangordnung der antiken Kulturen siegten in der
deutschen Klassik die Pro-Hellenen, und Kant war auf ihrer Seite: Erst
mit den Griechen gibt es die schönen Künste31.
Die KdU versucht den Primat und die Unüberbietbarkeit der
griechischen Kunst aus der einmaligen Konstellation der
Vergesellschaftung der Menschen herzuleiten:
«Das Zeitalter sowohl als die Völker, in welchen der rege Trieb zur
gesetzlichen Geselligkeit, wodurch ein Volk ein dauerndes gemeines Wesen
ausmacht, mit den großen Schwierigkeiten rang, welche die schwere
Aufgabe, Freiheit (und also auch Gleichheit) mit einem Zwange (mehr der
Achtung und Unterwerfung auf Pflicht als Furcht) zu vereinigen, umgeben;
ein solches Zeitalter und ein solches Volk [sc. das der Griechen] mußte die
Kunst der wechselseitigen Mittheilung der Ideen des ausgebildetsten Theils
mit dem roheren, die Abstimmung und Erweiterung und Verfeinerung der
ersteren zur natürlichen Einfalt und Originalität des letzteren und auf diese
Art dasjenige Mittel zwischen der höheren Cultur und der genügsamen
Natur zuerst erfinden, welches den richtigen, nach keinen allgemeinen
30 J. J. Winckelmann, Kleine Schriften. Vorreden. Entwürfe, hrsg. von Walter Rehm,
Berlin, 2002, S. 29.
31 S. dazu auch Grimm und Schoske 2005, 125-126.
Kant und Europa
Regeln anzugebenden Maßstab auch für den Geschmack, als allgemeinen
Menschensinn, ausmacht»32 (V 355,32-356,7).
Hier wird fast wörtlich wiedergegeben, was David Hume in einem
Essay von 1742 geschrieben hatte, Of the rise and progress of the arts and
sciences. Nach antiker Rezeptur wird die Geschichte von Hume in drei
Phasen eingeteilt: Den Naturzustand, die Bildung despotischer
Herrschaften und die im Konsens errichtete Staatsgesellschaft. Der
gesamte Orient wird von Hume der zweiten Phase zugerechnet, erst den
Griechen gelingt es, Freiheit und Zwang miteinander zu verbinden und
damit den Raum für die Ausbildung einer Kultur zu schaffen. Wenn
Kant in der KdU festhält, nicht einem verirrten Königsberger, sondern
einem Irokesischen Sachem habe in Paris nichts besser als die
Garküchen gefallen (V 204,32-33), dann weist er dezent zugleich darauf
hin, dass die Uramerikaner, ob nun aus Nord- oder Südamerika, sich
generell aus den Naturnöten nicht so weit hervorarbeiten konnten, dass
sie zu einem freien ästhetischen Wohlgefallen befähigt sind; sie eilen
zwangsläufig nicht ins Theater, sondern in die Garküche. Noch
schlechter als dem Irokesen ergeht es den Wilden, die zu Hause
geblieben sind:
«[...] und man sieht nicht, warum es denn nöthig sei, daß Menschen
existiren (welches, wenn man etwa die Neuholländer oder Feuerländer in
Gedanken hat, so leicht nicht zu beantworten sein möchte) [...]» (V 378,2528).
Im übrigen muß der Leser der KdU wissen, dass der Irokese nicht
aus Neugier in Paris weilt, sondern als exotisches Mitbringsel eines
Europäers; nach Kant gehört es ganz allgemein zu den Charakteristika
der Europäer, sich aus Neugier oder um Handel zu treiben in der Welt
umzutun, während die Nichteuropäer (ein Wort, das Kant nicht benutzt)
das Reisen nicht kennen.
Herder gehört zur Gegenpartei:
Zu der Figur der Vereinigung von Freiheit und Gesetzmäßigkeit vgl. bes. § 35
der Kritik der ästhetischen Urteilskraft: «[...] so muß das Geschmacksurtheil auf einer
bloßen Empfindung der sich wechselseitig belebenden Einbildungskraft in ihrer Freiheit
und des Verstandes in seiner Gesetzmäßigkeit, also auf einem Gefühle beruhen [...]; und
der Geschmack als subjective Urtheilskraft enthält ein Princip der Subsumtion [...] des
Vermögens der Anschauungen oder Darstellungen (d. i. der Einbildungskraft) unter das
Vermögen der Begriffe (d.i. den Verstand), sofern das erstere in seiner Freiheit zum
letzteren in seiner Gesetzmäßigkeit zusammenstimmt» (V 287,17-28).
32
25
26
Logos
«Daß Wissenschaften und Künste zuerst in Asien und seinem
Grenzlande Ägypten gepflegt sind, bedarf keiner weitläufigen Erweise;
Denkmale und die Geschichte der Völker sagen es [...]. Nützliche und
schöne Künste hat dieser Weltteil, hie und da, allenthalben aber nach
seinem ausgezeichneten asiatischen Geschmack frühe getrieben, wie die
Ruinen Persepolis und der Indischen Tempel, die Pyramiden Ägyptens und
so viel andre Werke, von denen wir Reste und Sagen haben, beweisen: fast
alle reichen sie weit über die Europäische Cultur hinaus und haben in Afrika
und Amerika nicht ihres Gleichen».
Das gelte auch für die Dichtung, den Handel, die Astronomie und
die Zeitrechnung33. Herder spricht von den «Maschinen der kalten
europäisch-nordischen Abstraktion»34. Es ist eine vorprogrammierte
Opposition; während Herder im Verhältnis von Leib und Seele, von Tier
und Mensch, von anderen und europäischen Kulturen ein Kontinuum
sieht, eine Stufenleiter des Seienden, setzt Kant scharfe Cäsuren und
unendliche Unterschiede.
Kant umspielt in dem zitierten Text zugleich die Kontrastbeziehung,
die Winckelmann in seiner Schrift von 1755, den schon genannten
Gedancken über die Nachahmung der griechischen Wercke in der Mahlerey und
Bildhauer-Kunst, mit der chiastischen Formulierung der «edlen Einfalt und
stillen Größe» bezeichnete. Es ist die Gründungsschrift des deutschen
Klassizismus, dem auch Kant wenigstens seit 1770 publizistisch
verpflichtet ist. Wie Winckelmann nimmt er damit Partei in einer
Alternative, die in der griechischen Geschmackslehre und Rhetorik u. a.
unter den Leitwörtern des Attizismus und des Asianismus tradiert
wurden. Der barocke Schwulst wird von Winckelmann mit eben den
Begriffen gekennzeichnet, die man in der Antike für den Asianismus
verwendete, der mit seinen auswuchernden Metaphern den Leser oder
Hörer zu überrumpeln und zu unterwerfen sucht. Kants Wahlspruch in
Geschmacksfragen lautet gewissermaßen: «Civis Atheniensis sum, Ich
bin ein Athener!». Die heute noch gut lesbare deutsche Prosa beginnt in
der Mitte des 18. Jahrhunderts mit der Abwendung von dem, sagen wir
es so: barocken Asianismus hin zum nüchtern-klaren Attizismus. Mit
diesem Stilideal übernahmen die deutschen Intellektuellen die ProsaRichtlinien der Gelehrten in England, wie sie Thomas Sprat für die Royal
Society entwickelt35. Hier entsteht das im Stil und im Umfang moderne
J. G. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, hrsg. von Wolfgang
Pross, München., 2002, I, S. 361-362. Vgl. auch die Hinweise von Pross in Ebd., I 849.
34J. G. Herder, Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, hrsg. von
Hans Dietrich Irmscher, Stuttgart, 1990, S. 88.
35Vgl. T. Sprat, History of the Royal Society (1667), hrsg. von Jackson I, Cope und
Harold Whitmore Jones, Washington und London 1966, S. 40-41. Zu den «plain
33
Kant und Europa
Buch, hier schulen sich die Attizisten Joseph Addison und Richard Steele
in ihrem Spectator, die ihrerseits die Prosa der deutschen
Wochenzeitschriften formieren. Stilfragen und Völkerpsychologie
werden von Kant verbunden:
«Einheit der Vernunft und Erfahrung. Vermögen aus Begriffen zu
urtheilen (Unfähigkeit orientalischer Völker; begeisterter und bilderreicher
Stil)» (XV 186,3-5 – Refl. 451).
Der ausgeprägten Opposition von “Kultur-Gräzisten” einerseits und
“Kultur-Pluralisten” andererseits fehlt, so weit ich sehe, die
Parteibenennung in Analogie etwa zu den “antiqui” und “moderni”.
Hume und Kant gehören zur Partei der ersteren, während Leibniz, Wolff
und Herder bekennende Pluralisten sind. Moses Mendelssohn zeichnet
die Ablösung der Schriftsprache von der Bildsprache in seinem Jerusalem
oder über die religiöse Macht und Judentum (1783) und sieht den eigentlichen
Beginn der Geschichte im jüdischen Monotheismus, der die Ebene der
Phantasie und der Bilder verlässt36. Hier werden die Fronten eines bisher
nicht thematisierten Kulturkampfes sichtbar, der wenn auch literarischhöflich, doch mit aller Entschiedenheit und nicht weniger profiliert
ausgetragen wurde als die Auseinandersetzung zwischen den
Parteigängern der “antiqui” und “moderni”; die letzteren verfügten
jedoch seit dem Mittelalter über die passenden Namen ihrer jeweiligen
Gruppierung
und
entsprechend
über
eine
ausgiebige
Geschichtsschreibung ihres Zwistes. Unter dem Namen der
innereuropäischen “querelle des anciens et modernes” am Ende des 17.
Jahrhunderts gelangte diese Auseinandersetzung zu dem Kompromiß,
dass die Geisteswissenschaften, die beaux arts, in der Antike siegen, die
Naturwissenschaften, les sciences, dagegen in der Moderne. Die
griechisch-römische Kultur wird auch hier implizit zur Norm der
Menschheitskultur erhoben – das war dem Barockzeitalter noch fremd.
Der Klassizismus der Aufklärung legt die Norm der Humanität und des
guten Geschmacks in die europäische Antike, und sie monopolisiert die
Stellung Europas für alle fortschrittliche Neugestaltung der Technik und
der Wissenschaft. Kant partizipiert an dieser Weltsicht und vertieft sie.
undeceiving expressions» im Gegensatz zum blumigen Stil, vgl. auch John Lockes
Losung der «plain method» (J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, hrsg.
von Peter Nidditch, Oxford, 1975, S. 44), mit der er den menschlichen Verstand
untersuchen wolle.
36 Dazu jetzt die wichtigen Beobachtungen von J. Assmann, Die Frühzeit des Bildes
– Der altägyptische iconic turn, in Christa Maar und Hubert Burda (hrsg.), Iconic Turn. Die neue
Macht der Bilder, Köln, 2004, S. 304-322
27
28
Logos
Wir kommen hiermit zu einem weiteren Punkt der EuropaZentrierung, die sich in der geschichtlichen Konstruktion der Religion
finden läßt. Kant hat kein weiteres Interesse an den psychologischen
oder politischen Quellpunkten der Religion, die von der griechischen
Sophistik bis hin zu David Humes Natural History of Religion untersucht
wurden. Religion hat für ihn ihren Sach- (nicht akzidentellen Geschichts) Ursprung in der reinen praktischen Vernunft, die als solche einer
zunehmenden Aufklärung fähig ist. Alle anderen Religionsformen, die
auf politische Machtausübung oder Animismus und dgl. hinauslaufen,
sind pathologische Deformationen. Die Moralreligion nun durchläuft
drei Epochen: Die jüdische, die christliche und die rein moralische.
Während es nach Winckelmann und Kant in der Kunst geboten ist, zu
den griechischen Werken in der Malerei und Bildhauerkunst
zurückzukehren (s. oben), ist die jüdische Religion umgekehrt historisch
überholt; eine Rückkehr zum Judentum wäre eine Perversion des Sinns
der Geschichte.
«Der jüdische Glaube ist seiner ursprünglichen Einrichtung nach ein
Inbegriff bloß statutarischer Gesetze, auf welchem eine Staatsverfassung
gegründet war; denn welche moralische Zusätze entweder damals schon
oder auch in der Folge ihm angehängt worden sind, die sind schlechterdings
nicht zum Judenthum als solchem gehörig» (VI 125,20-24).
Das ursprüngliche Judenbekenntnis hat also einen nur irdischpolitischen Charakter ohne jede ethische Komponente; eine gewisse
Öffnung für die Moral tritt erst in einem späteren Zustand ein, in dem
«diesem sonst unwissenden Volke schon viel fremde (griechische)
Weisheit zugekommen war» (VI 128,3-4). Der Lehrer des Evangeliums
ersetzt dann den Fronglauben der Juden durch den moralischen
Glauben, wenn dieser sich auch noch in vielen äußerlichen Ritualen
ergeht. Der reine Vernunftglaube und seine Stärkung durch ein ethisches
weltweites, also nicht mehr politisch-äußerliches Gemeinwesen löst dann
das Christentum ab und führt so zum Dritten Reich, von dem Kant aber
nicht ausdrücklich spricht37. Das Ergebnis ist auch hier: Der Orient hat
für den Attizisten Kant gewissermaßen seine Schuldigkeit getan, er kann
und muß im anbrechenden Dritten Reich der wahrhaften Sittlichkeit, in
der äußerliche Rituale keine Rolle mehr spielen, vergessen werden.
Die unterschiedliche Behandlung von Religion und Kunst ist darin
begründet, dass die Kunst nach ihrem Beginn in Griechenland von der
Fortschrittsgeschichte ausgenommen ist, während die Religion als Teil
Zum Terminus vgl. S. Breuer, Das Dritte Reich, in Reinhard Brandt und Steffen
Schmidt (hrsg. von), Mythos und Mythologie, Berlin, 2004, S. 203-220.
37
Kant und Europa
der Moral in den historischen Entwicklungs- und Verbesserungsprozeß
gehört; man erinnere sich des Vorwurfs von Montesquieu gegenüber den
Nichteuropäern, sie würden ihre Religion nicht verändern38. So steht der
Gipfel der Kunst am Anfang der europäischen Kultur, die Religion ist
dagegen erst jetzt im Begriff, ihr inneres Telos in der europäischen
Aufklärung zu erreichen. Die Kunst ist Sache des Genies, das zwar die
Regeln seiner spezifischen Disziplin kennen muß, um nicht in einen nur
scheingenialen Koller zu verfallen (wie die Dichter des Sturm und
Drang)39, aber im wesentlichen angewiesen ist auf eine Eruption
unberechenbarer, aller Fortschrittsvermessung fremden Naturgewalt –
wann ein Shakespeare auftritt, das entzieht sich aller
Geschichtsbestimmung. In diesem Punkt stimmt also Kant eher mit
Nietzsche als mit Friedrich Schlegel überein, der die Dichtkunst einer
geschichtlichen Dialektik unterwirft und das Studium der griechischen
Poesie für notwendig hält, um die Ankunft einer neuen Epoche der
Kunst in der Verbindung des Schönen (Klassik) mit dem Interessanten
(Moderne) zu ermöglichen40. Diese Kunstauffassung ist so weit von Kant
wie von Winckelmann entfernt. Im Gegensatz zur Kunst ist die Religion
fortschrittsfähig; sie befindet sich tatsächlich in einem dreiphasigen
Prozeß der zunehmenden Moralisierung, des Abbaus also der
Fremdbestimmung und des Gewinns der Selbstbestimmung, die in der
sittlichen globalen Kirche aller Wohlmeinenden ihr Ziel hat. Ihre
Erkenntnis und erste Realisierung findet diese zu sich selbst kommende
Vernunftreligion in Europa.
Die Gründe dieser eurozentrischen Konzentration gegen den
Kultur-Pluralismus lassen sich nur erschließen. Eines der vielen
Symptome für die zunehmende Selbst-Behauptung Europas ist der
allmähliche Wegfall des Hebräischen als Sprache, die an Gymnasien
gelehrt wurde. Das Lockesche Programm auf der “Westminster School”
umfasste Latein, Griechisch, Hebräisch und Arabisch41. Die von Leibniz
konzipierte Berliner Akademie der Wissenschaften suchte Beziehung
zum Osten und Südosten und hatte eine “Literarisch-orientalische
Klasse”; dieses Interesse jedoch an den orientalischen Sprachen und
Kulturen sinkt in der Zeit der Aufklärung rapide, und die entstehende
S. oben Seite.
I. Kant, Gesammelte Schriften, Akademie-Ausgabe, Berlin, 1900, ff. V 310 – Kritik
der Urteilskraft § 47.
40 Schlegel oben Nietzsche.
41 S. R. Brandt, John Locke; in Grundriß der Geschichte der Philosophie / Ueberweg: 17.
Jahrhundert 3/2, Basel, 1988, S. 607-758, S. 619.
38
39
29
30
Logos
Altertumswissenschaft richtet sich ganz auf die griechisch-römische
Antike.
Schon zu Lebzeiten Kants formiert sich die Gegenfront; ihre beiden
mächtigsten Sprecher entstammen dem Königsberger melting-pot, es
sind der geborene Königsberger Johann Georg Hamann und Kants
zeitweiliger Schüler (1762-1764) Johann Gottfried Herder aus
Mohrungen. Beide stehen gegen Kants vermeintlichen Exorzismus des
Anderen der Vernunft auf. Hamann ist stark bibelgläubig, er stellt
besonders das Alte Testament in den Vordergrund, und er beharrt auf
einer barocken, verrätselten und selbsteitlen Prosa, die in Metaphern
schwelgt42. Herder sucht die gegenwärtigen Völker am Rande und
außerhalb der Zivilisation; es gilt, ihre Eigentümlichkeit nicht all-egorisch
in das eigene Vernunftidiom zu übersetzen, wie es Kant im Mutmaßlichen
Anfang der Menschengeschichte tat, sondern sie, wie es später kurzfristig
heißen wird, tautegorisch, aus sich selbst zu verstehen. Beide, Hamann
sowohl wie Herder, rücken ab von der Kantischen Vorstellung,
Philosophie und damit Weltweisheit sei “Vernunfterkenntnis aus
Begriffen” und opponieren im Namen der Bilder, des Gefühls, des
Ursprünglichen und Naiven gegen die Begriffs-Vernunft. Keiner von
beiden hätte die griechischen Statuen mit Seifenlauge weiß gewaschen,
wie es der Klassizist Lord Elgin tun sollte. Weiß oder bunt – hier konnte
keine Freundschaft auf Dauer entstehen. – Hamann hält am Primat des
Glaubens fest und sucht das Irrationale gegen die Vernunft der
Aufklärung zu retten, die biblischen Wurzeln Europas gegen die
griechischen zu stärken, während Herder den Stimmen der Völker als
solchen Geltung verschaffen will.
Die sich hier abzeichnende Opposition setzt einerseits auf Europa
und den Fortschritt, andererseits auf die Vielheit der Kulturen,
besonders auf den kulturellen Reichtum des Orients. Kant ist der
vielleicht entschiedenste Europäer; die Kunst, die Wissenschaft, die
Moral und das Recht, sie sind europäischen Ursprungs. Die Bestimmung
des Menschen in seiner Kultivierung, Zivilisierung und Moralisierung (s.
VII 324-325) wird nur in Europa zum Programm erhoben, nur hier gibt
es die Initiative, sich aus Vernunftgründen zu reformieren.
Die Betonung des Ursprungs eigentlicher Kultur bei den Griechen
ist nicht originell, sondern findet sich seit der nachhomerischen
Dichtung,
Philosophie
und
Geschichtsschreibung
in
der
Oppositionsbildung von Hellenen und Barbaren bei den Griechen
Vgl. U. Gaier, Hamanns und Herders hieroglyphische Stile, in B. Gajek (hrsg. von),
Johann Georg Hamann. Autor und Autorschaft, Frankfurt am Main, 1996, S. 177-195.
42
Kant und Europa
selbst43. Untermischt von gelegentlichen Gleichheitsvorstellungen
dominiert
besonders
bei
Platon
und
Aristoteles
das
Überlegenheitsbewusstsein gegenüber den Barbaren, zu denen alle
Nichtgriechen zählen44. Hier also konnte die Griechenpartei die
Argumente finden, die sie nur neu zu formulieren brauchte. Zugleich ist
die griechische Präferenzordnung das Muster, nach dem der
Eurozentrismus verfuhr – es brauchte nur auf Europa übertragen zu
werden, was die Griechen für sich selbst in Anspruch nahmen.
Es gibt zwei am Körper und der menschlichen Psyche orientierte
Bilder, um die Stufen von einer Vorform zur endgültigen, nicht mehr
überbietbaren Form zu veranschaulichen. Das eine ist das Herumtappen
an Stelle der Orientierung durch den Sehsinn, das andere das Vorstellen
von Bildern an Stelle des begrifflichen Denkens. In diesem zweistufigen
Modell lokalisiert Kant, wie sich zeigte, die nicht-europäischen Kulturen
wesentlich in der ersten Stufe, die europäische Kultur und Geschichte
jedoch in der zweiten.
Bei Kant fehlt jeder Nationalismus. Er sieht Europa als eine
Pluralität von aufgeweckten Völkern mit je eigenem Charakter (VII). Der
Deutschland-Zentrismus und – Wahn ist eine Phänomen, das zur
Jahrhundertwende aufkommt. Kant hätte nie geschrieben, was Karl
Leonhardt Reinhold sich 17. einfallen ließ, als er – Thukydides zitierend
– schrieb: “…”45.
3. Europa – politisch-rechtlich
In rechtlich-politischer Hinsicht steht Europa bei Kant in einem
Konfliktfeld von rechtlicher Globalisierung und politischer Hegemonie.
Die von ihm angestrebte Rechtsordnung sieht ein Friedenssystem
souveräner republikanischer, also gewaltenteiliger Staaten vor, die
weltweit gleichberechtigt sind. Entsprechend dieser Rechtsauffassung
spielt Europa in dem rechtlichen Friedenssystem keine Rolle und wird
auch in der Schrift Zum ewigen Frieden (1795) so wenig wie in den
einschlägigen Passagen der Metaphysik der Sitten (1797) genannt. Hier geht
Vgl. J. Jüthner, Hellenen und Barbaren. Aus der Geschichte des Nationalbewusstseins,
Leipzig, 1923; R. Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten,
Frankfurt am Main, 1984, S. 218-229; mit weniger Genauigkeit A. Dihle, Die Griechen
und die Fremden, München, 1994.
44 Viele Texte könnten hier zitiert werden, ich verweise nur auf NE 1145a30,
1149a10, Isokrates 12, 163; 15, 293.
45
Reinhold, Vgl. auch di Giovanni 2005, S. 42. Thukydides lässt Perikles von
Athen als der Schule der Griechen sprechen.
43
31
32
Logos
es konsequent nur um eine globale Ordnung und die prinzipielle
Struktur, die sie gemäß der Friedensidee annehmen muß. Daß die
Menschheit auf einem kugelförmigen Planeten wohnt und nicht auf einer
unendlichen Fläche, ist ein gewissermaßen apriorisches, für die
Rechtsphilosophie relevantes Faktum, ähnlich dem Faktum, dass die
Fortpflanzung der Menschen durch zwei verschiedene Geschlechter
geschieht und daher die Ehe zum apriorischen Rechtsproblem wird. Das
erstere ist schon für die Idee des Erwerbs von Eigentum am Boden
innerhalb des «Privatrechts» entscheidend; der «ursprüngliche Besitz»,
aus dem das zu erwerbende Eigentum abgeleitet wird, sei
«ein gemeinsamer Besitz wegen der Einheit aller Plätze auf der Erdfläche
als Kugelfläche: weil, wenn sie eine unendliche Ebene wäre, die Menschen
sich darauf so zerstreuen könnten, daß sie in gar keine Gemeinschaft mit
einander kämen, diese also nicht eine nothwendige Folge von ihrem Dasein
auf Erden wäre» (VI 262,21-26).
Daß es also Europa gibt und daneben noch andere Kontinente,
nimmt die reine Rechtslehre so wenig zur Kenntnis wie die Existenz
verschiedener Rassen unter den Menschen. An einer Stelle aber spielt die
Frage unterschiedlicher Kulturen in Europa und nicht-europäischen
Ländern doch eine Rolle. Freiheit und Gleichheit sind die angeborenen
rechtlichen Qualitäten jedes Menschen; aber mit dieser jedem Säugling
oder gar Embryo (VI 422,7-9) zukommenden Ausstattung ist der Bürger
noch nicht befähigt und befugt, selbst an der Gesetzgebung
teilzunehmen und so das Autonomie-Prinzip der rechtlich-praktischen
Vernunft zu erfüllen. Neben Freiheit und aus ihr folgender Gleichheit
tritt als dritte Qualität die bürgerliche und daraus resultierende
öffentlich-rechtliche Selbständigkeit. Kant deduziert diese letztere
Qualität nicht, sondern rettet sich in Beispiele, zu denen auch
außereuropäische gehören:
«Folgende Beispiele können dazu dienen, diese Schwierigkeit [sc. der
Unterscheidung aktiver und passiver Staatsbürger durch das Kriterium
bürgerlicher Selbständigkeit]46 zu heben: [...] Der Holzhacker, den ich auf
meinem Hofe anstelle, der Schmied in Indien, der mit seinem Hammer,
Ambos und Blasbalg in die Häuser geht, um da in Eisen zu arbeiten, in
Vergleichung mit dem europäischen Tischler oder Schmied, der die
Producte aus dieser Arbeit als Waare öffentlich feil stellen kann; der
Hauslehrer in Vergleichung mit dem Schulmann, der Zinsbauer in
Vergleichung mit dem Pächter u. dgl. sind blos Handlanger des gemeinen
46
Vgl. VIII 295, 37: «etwas schwer».
Kant und Europa
Wesens, weil sie von anderen befehligt oder beschützt werden müssen,
mithin keine bürgerliche Selbständigkeit besitzen» (VI 314,25-315,5).
Der Selbständige hat sich durch seine Urteilskraft, Energie und sein
auf das ökonomische Umfeld bezogenen Interessen bewährt; seine
prekäre privatrechtliche Bestimmung scheint, so ist der Tenor des
Arguments, zunächst vielleicht auf Europa beschränkt zu sein,
tatsächlich kann er mit ihr jedoch global operieren. Mit dem Hinweis auf
den Schmied in Indien wird also dokumentiert, dass die öffentlichrechtliche Differenz von aktiven und passiven Staatsbürgern, basierend
in der bürgerlicher Selbständigkeit und Unselbständigkeit, nicht auf eine
bestimmte Kultur beschränkt sein muß, sondern in allen Gesellschaften
mit einer politischen und einer bürgerlichen Sphäre aufzufinden wäre.
Die Selbständigkeit ist ein Phänomen aller bürgerlichen Gesellschaften,
wird man interpretieren dürfen, die damit dem rechtlichen Postulat
gewissermaßen naturwüchsig entgegen kommen. Aber hiermit ist noch
keine den Gesellschaften selbst inhärente Kraft entdeckt, die z. B. in
Indien zur Etablierung einer Republik führen könnte. Der Text besagt
nur: Wenn es in Indien eine Republik gibt, dann kann sie wie eine
europäische Republik auf eine Differenz in ihrer eigenen Gesellschaft
zurückgreifen, um die rechtliche wichtige Unterscheidung von aktiven
und passiven Staatsbürgern durchzuführen.
Freiheit und aus ihr folgende Gleichheit sind Begriffe und
Schlagworte der antiken Philosophie und Politik; der von Kant
hinzugefügte dritte Begriff ist dagegen entschieden neuzeitlich und
dürfte so wenig wie Freiheit und Gleichheit in zeitgenössische
außereuropäische Kulturen passen. Schon die Übersetzung in das
Griechische und Lateinische ist kaum möglich; der Begriff – etwa
“Autarkie” – begegnet in keiner antiken politischen Theorie, die sich mit
der Frage der Differenz von aktiver und passiver Staatsbürgerschaft
befasst. Die Frage der aktiven Partizipation am politischen Geschehen
wird an die Herkunft des Geschlechts, aus dem jemand stammt,
gebunden47; Kant dagegen lässt alle Fragen der Herkunft, des jus soli und
des jus sanguinis, hinter sich und setzt einzig auf die Effizienz in der
bürgerlichen Gesellschaft, um politisch aktiv werden zu können. Zu
diesem status des effizienten bourgeois (eigenes Auftreten mit Produkten
auf dem Markt; Beamtenstand) muß jeder männliche Einwohner sich
“empor arbeiten” können (VI 315,21).
Europa wird in unserem jetzigen Zusammenhang nicht rechtlich
relevant, aber politisch, und zwar in negativer und in positiver Hinsicht.
47
Vgl. die differenzierten Bestimmungen in der Aristotelischen Politik, Buch III.
33
34
Logos
In negativer Hinsicht ist Europa Gegenstand einer herben politischrechtlichen Kritik und wird hier als Einheit genommen. Die
Kolonialpolitik ist eine europäische Schande:
«Zuletzt kann noch gefragt werden: ob, wenn uns weder die Natur
noch der Zufall, sondern bloß unser eigener Wille in Nachbarschaft mit
einem Volk bringt, welches keine Aussicht zu einer bürgerlichen
Verbindung mit ihm verspricht, wir nicht in Absicht diese zu stiften und
diese Menschen (Wilde) in einen rechtlichen Zustand zu versetzen (wie
etwa die amerikanischen Wilden, die Hottentotten, die Neuholländer)
befugt sein sollten, allenfalls mit Gewalt oder (welches nicht viel besser ist)
durch betrügerischen Kauf Colonien zu errichten und so Eigenthümer ihres
Bodens zu werden und ohne Rücksicht auf ihren ersten Besitz Gebrauch
von unserer Überlegenheit zu machen; zumal es die Natur selbst (als die das
Leere verabscheuet) so zu fordern scheint, und große Landstriche in
anderen Welttheilen als gesitteten Einwohnern sonst menschenleer
geblieben wären, die jetzt herrlich bevölkert sind, oder gar auf immer
bleiben müßten, und so der Zweck der Schöpfung vereitelt werden würde.
Allein man sieht durch diesen Schleier der Ungerechtigkeit (Jesuitism), alle
Mittel zu guten Zwecken zu billigen, leicht durch; diese Art der Erwerbung
des Bodens ist also verwerflich» (VI 266,10-27; vgl. VIII 358-359, dazu
auch XXIII 174-175).
Kant nimmt kein Interesse an der Frage, ob die ungeheure
Akkumulation von Reichtümern in Europa durch die Kolonien etwas zu
tun hat mit der Blüte der Aufklärung, ob diese mit ermöglicht wurde
durch das angeprangerte Unrecht. Bei der Offenlegung eines
Zusammenhangs von kulturellem Fortschritt und seiner Finanzierung
durch Unrecht hätte die Vorsehung angerufen werden müssen, die das
eine durch das andere ermöglicht, um am Ende eine Versöhnung als
Werk der entwickelten Menschheit zu erreichen.
Umgekehrt ist die politische Realisierung der Rechtsform, die die reine
praktische Vernunft darbietet, eine europäische Aufgabe, wie es in der
Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784) heißt;
betrachte man die Geschichte aus dem rechtlichen Standpunkt, «so wird
man einen regelmäßigen Gang der Verbesserung der Staatsverfassung in
unserem Welttheile (der wahrscheinlicher Weise allen anderen dereinst
Gesetze geben wird) entdecken» (VIII 29,25-27).
Europa als Gesetzgeber der anderen Weltteile – hiermit ist ein
bedeutungsschweres Stichwort gefallen. Die Gesetzesherrschaft ist seit
der Antike ein Ideal, das gegen die Willkürherrschaft von Menschen
gestellt wird. Bei Kant: «Dies ist die einzige bleibende Staatsverfassung,
wo das Gesetz selbstherrschend ist und an keiner besonderen Person
Kant und Europa
hängt; [...]» (VI 341,1-2)48. Entsprechend ist der Gesetzgeber eine Figur,
die keine eigenen Interessen verwirklichen will, sondern nach dem
Vorbild des deistischen Gottes eine Menge von Menschen in ein
gesetzliches Ganzes bringt und ihnen dann die Weiterbildung nach dem
Prinzip der Autonomie überlässt49. Speziell für Europa hieße dies, dass
das Unrecht der Kolonialgeschichte und ihrer Willkürherrschaft beendet
wird und die in Europa entfaltete Vernunft sich selbstlos in der Weise
der Stiftung von gesetzlichen Verfassungen global verwirklicht. Europa
war Statthalter der Vernunft; eines Tages wird die so erzeugte
Menschenvernunft ihre globale Realität erringen.
4. Der Mythos Europa
Für die Betrachtung der Natur ergeben sich im Kantischen System
zwei Aspekte, der rein mechanische und der finalistische. Der erste reicht
aus für die Naturphänomene, wie sie z. B. in den Metaphysischen
Anfangsgründen der Naturwissenschaft (1786) dargestellt werden. Nun
begegnen uns zweitens jedoch in der Natur Dinge, mit denen wir nur
dadurch umgehen können, dass wir sie als Naturzwecke betrachten, als
Organismen. Das Muster für derartige finalistisch zu interpretierende
Dinge ist ein Baum, der in der KdU als ein Naturzweck dargestellt wird
(V 371,7-372,11). Die weitere Verfolgung dieses Gedankens führt zu
dem Ergebnis, dass die Natur insgesamt für unsere reflektierende
Urteilskraft zweckhaft sein muß, wenn es isolierte Naturzwecke wie
Bäume oder Tiere gibt, und dann weiter, dass die gesamte Natur objektiv
zwecklos wäre, könnte sie nicht auf einen der Natur enthobenen Zweck
an sich bezogen werden, den Menschen als moralisches Wesen. Die
Teleologie der Natur führt also auf einen Endzweck, der die Natur
überschreitet; dieser Endzweck ist die Existenz des Menschen als eines
moralischen Wesens. Und hiermit verlassen wir die KdU und fügen aus
der Kantischen Geschichtsphilosophie hinzu, dass die Vernunft dieses
Menschenwesens in Europa zu sich selbst kommt. So ist dieser
Kontinent kein epikureischer Zufall von Erdanhäufungen, sondern ein
wohlgeformtes Gebilde, das der Zeuslogos der Vorsehung auserkoren
hat, um in die Erscheinung zu treten. Die Kantische Europa-Idee ist, wie
S. dazu den Platonischen Spätdialog Politikos; 294a heißt es dort, es sei das Beste,
wenn nicht die Gesetze, sondern der mit Einsicht begabte königliche Mann Macht
haben.
49 Vgl. den “Législateur” in Rousseaus Contrat social (J. J. Rousseau, Oeuvres complètes,
hrsg. von B. Gagnebin und M. Raymond, Paris, 1959 ff., III, S. 381-384 – II. 7, “Du
législateur”).
48
35
36
Logos
schon oben angedeutet, eine Erneuerung der Selbstwahl der Griechen
gegenüber allen anderen, den Barbaren. Jetzt sind alle Nichteuropäer
Barbaren, denen eine doppelte Rolle zukommt. Sie sind einerseits von
der Natur nicht geschaffen zur Kultur, Zivilisation und rechtlichmoralischen Autonomie, sie sollen andererseits – und das ist neu
gegenüber der griechischen Dichotomie – das Substrat einer
Universalisierung Europas sein. Kant bleibt bei diesem Dilemma der
Differenz, die sich zwischen Europa und Nicht-Europa auftut, stehen.
Mythos Europa? Wenn die Vernunft sich unter den Lebewesen den
menschlichen Leib mit seinem aufrechten Gang auserkor, in ihm zu sich
selbst zu finden (fügen wir hinzu: den weißen, männlichen), so hat sie
unter den Kontinenten Europa gewählt, um ihre irdische Laufbahn zu
beginnen und zu der Vollendung zu gelangen, dass sie in alle anderen
Kontinente hinauswandern kann. Da diese Vernunft auch diejenige ist,
die eben dies feststellt, gelangt man zu einem logischen “non sequitur”.
Wo die Logik jedoch an ihre Grenzen gelangt, beginnt der Mythos.
Giulio Gentile
Polizia, economia, ragion di Stato. Il regno nelle
Riflessioni di Nicola Fortunato.
Il 28 luglio 1760, dopo aver censito le Riflessioni del giureconsulto
Fortunato, Genovesi osserva che nell’opera non vi è nulla di contrario
alla religione e all’etica pubblica e di avervi «anzi scorto gran zelo del
pubblico bene, e del Sovrano insieme, con istudiate ricerche di cose varie
e grandi»1. L’abate salernitano, evidentemente, coglie appieno la portata
innovativa delle Riflessioni, nelle quali Fortunato propone una lettura assai
originale dei mali del regno, cui Genovesi fa indirettamente riferimento.
Questa lettura, frutto di istudiate ricerche di cose varie e grandi, va oltre ogni
possibile tradizionale interpretazione della miseria e del sottosviluppo di
cui soffre il mezzogiorno: Fortunato lascia cadere il punto di vista
largamente diffuso tra i pensatori politici meridionali, l’opinione comune,
per così dire, che tende a ricondurre la drammatica situazione di miseria
e arretratezza in cui versa il regno all’incapacità cronica di esprimere un
sovrano naturale in grado di guidarlo con mano ferma, di sottrarlo al
destino poco lusinghiero di terra di conquista da parte dello straniero,
teatro di lotte e guerre sanguinose, che nel corso dei secoli lo hanno
definitivamente relegato a provincia di un impero lontano soffocandone
le potenzialità di autonomia e di sviluppo. A rendere effettivamente
stabile e felice la società civile, osserva Fortunato, è solo «l’innesto di
pubblica Economia e Polizia» che deve produrre «l’amore della Patria, la
Pietà verso de’ Popoli naviganti, mercè i pubblici Ristori della povera
umanità».2La mancanza di polizia, nel suo legame diretto con l’economia,
Genovesi è chiamato ad esprimere un giudizio anche su un’altra opera di Nicola
Fortunato, Discoverta dell’Antico Regno di Napoli col suo presente Stato a Pro della sovranità e de’
suoi popoli, Napoli, presso Giuseppe Raimondi, 1767, che non deve sembrargli dello
stesso livello delle Riflessioni, giacchè non ne esalta i contenuti limitandosi a suggerirne la
pubblicazione in quanto priva di elementi contrari all’etica pubblica e alla religione. Cfr.
le dichiarazioni di compatibilità poste a conclusione delle due opere.
2 N. Fortunato, Riflessioni intorno al commercio antico, e moderno, del Regno di Napoli sue
finanze marittime, ed antica loro polizia, navigazione mercantile e da guerra, Napoli, nella
Stamperia Simoniana, 1760, p. 11. Scarsissime sono le notizie su questo giurista
napoletano. Minieri Riccio ne dà un brevissimo cenno. «Fortunato (Niccolò) nacque in
Napoli e scrisse Discoverta dell’Antico Regno di Napoli col suo presente Stato (1767)
2° Riflessioni intorno al commercio antico e moderno del regno di Napoli», C. Minieri
Riccio, Memorie storiche degli scrittori nati nel Regno di Napoli, Napoli, s.e., 1844, p. 187. Fece
1
38
Logos
ha reso il meridione un organismo profondamente malato, agonizzante,
simile a un corpo umano assalito e fiaccato da malattia grave che si
diffonde rapidamente senza trovare resistenza alcuna in anticorpi che
non sa produrre. Le Riflessioni, dunque, si possono considerare un
discorso vero e proprio di polizia e sulla polizia: nel definirne l’oggetto,
Fortunato osserva: «I membri maggiori sono le Compagnie, i Negozianti,
i Trafficanti, i minori, tutte le Classi de’ Popoli, utili, attive; ed operosi in
generale. I polsi sono le Dogane; le mani, i Finanzieri, e loro satelliti. I
nervi sono i Consoli, i Banchi, le Contadorie, per l’aspetto della Polizia in
generale»3. La Polizia si estende a una molteplicità di campi di
applicazione, e ha per oggetto gli ospedali, gli alberghi, i Reclusori, quel
complesso di luoghi che va sotto il nome di Ristori, i trattati pubblici, gli
editti generali «pel regolamento delle Finanze, del commercio, della
Pubblica economia, del Sistema politico, colla loro fede e religiosa
osservanza»4. Il regno, dunque, non sfrutta le immense potenzialità di cui
dispone, perché, di fatto, manca di un vero e proprio sistema politico in
grado di regolare le finanze e “loro Polizia”5. L’antica Roma ha costruito
le sue fortune utilizzando un modello di saggia polizia cui poi si sono
richiamate le nazioni moderne, come l’Olanda che “fu ombra all’altre”,
ma che anche Danimarca e Inghilterra hanno poi fatto proprio. In Roma,
infatti, per la prima volta, fu «eretta una Compagnia di Mercanti sotto il
nome di Collegio d’ Mercanti, per così dare la felicità di riparo ai bisogni
parte della reggenza in qualità di membro effettivo del consiglio di commercio, di cui
era intendente sovrano Giulio Cesare D’andrea. Fortunato, data la giovane età di
Ferdinando IV, cerca di richiamare l’attenzione della reggenza e di D’andrea in
particolare sulle strategie economiche da seguire per riportare il regno ai livelli più alti di
sviluppo. Cfr. l’introduzione alle Riflessioni, cit., in particolare p. XVIII e ss.
3 N. Fortunato, Riflessioni, cit., p. 11. Le Riflessioni sono dedicate a Ferdinando IV
cui, però, sono riservati solo brevi cenni, mentre forte ammirazione riscuote la saggia
conduzione amministrativa della Napoli di Carlo III. La Discoverta, invece, è un’opera
elaborata e scritta esclusivamente per il sovrano nella quale Fortunato riprende e
ripropone i motivi essenziali già elaborati nella prima trattazione sul commercio. «Offro
Sire, i ricchi effetti verso la Sovranità, ed il Ben pubblico, di già appalesati in una delle
mie Opere sul Commercio l’una, sulla Finanza e i Tributi l’altra; tendenti alla pubblica
Economia del vostro Regno». Il commercio «..sia l’oggetto più interessante della vostra
Ragion di Stato, dello Stato de’ Popoli, e delle Finanze insieme» (ivi, pp. 6-7). Qui si fa
menzione di una terza opera, sulla finanza e i tributi, della quale non si ha nessuna
notizia.
4 Ivi, p. 12. La Discoverta tratta essenzialmente De’ primi Abitatori, e loro Regioni
antiche, colle diverse mutazioni di loro Polizia in Provincie, giusto lo stato presente del Regno di
Napoli. In sostanza si tratta di un excursus sulle varie forme di “Polizia di governo” che
hanno strutturato la vita pubblica a partire dalla formazione delle popolazioni italiche.
5 Ivi, p. 51.
Polizia, economia, ragion di Stato. Il regno nelle Riflessioni di Nicola Fortunato
de’ Popoli»6. Tra gli statuti più luminosi e impareggiabili della polizia
romana ancora degno di ammirazione è senz’altro quello con cui
Teodosio il Grande e Graziano riconfermarono e rinvigorirono il «Corpo
della Marittima nell’ordine equestre, cotanto illustre e pregevole, che gli
stessi Senatori Romani cercavano di arrolarvisi al favore dei privilegi,
delle immunità, delle prerogative; degne invero del politico Governo del
Romano Impero….»7. Il modello di polizia romana faceva riferimento a
codici che stabilivano regolamenti certi: i vascelli non potevano superare
determinati limiti di estensione e grandezza; inoltre esistevano varie classi
di Armate navali, oltre a una serie di codici che stabilivano regolamenti
certi. «Ecco come dalla Polizia de Romani ricaviamo i privilegi,
l’esenzioni, le immunità a favore de’ Mercanti, e de’ Trafficanti nelle
Fiere: ed a favore del corpo de’ Navicularj. Ricaviamo le sagge
providenze per lo trasporto de’ generi per l’Annona di Roma, ricaviamo
le diverse classi, e le armate Navali, per garantire il commercio, i Popoli,
e l’Impero»8. A fondamento della saggia polizia dei Romani c’è, dunque,
soprattutto la costituzione di corpi qualificati, come i Naviculari, insieme
con la concessione di privilegi, sotto forma di esenzioni e immunità, alla
classe dei commercianti che producono ricchezza da ridistribuire fra le
parti della repubblica. Il regno è «…sempre stato adorno di scelta, fiorita,
e peregrina Nobiltà, fregiata di distintivi, e con Ordini Militari ed
Equestri»9. In proposito Fortunato fa riferimento agli ordini voluti dai re
Ruggiero, Guglielmo II, Federico II, Carlo II d’Angiò, e cita anche
“L’Ordine della Nave” istituito nel 1381 da Carlo III. La prammatica del
28 novembre 1738 dà luogo, poi, all’istituzione dell’Ordine di San
Gennaro, un corpo di reggenza cui viene affidata la direzione
dell’Albergo dei poveri. Gli Statuti prevedono «quale esser dovesse
l’abito da vestirsi, quali imprese nella Collana, quale il loro numero, e
quali le prove da farsi per essere aggregato»; vi si descrivono, inoltre, i
Ministri dell’Ordine, i cavalieri aggregati per tutto l’anno 1764, i viventi, e
il «Rituale da praticarsi nel conferire l’abito di questo ragguardevole
Ordine»10. Al di là del ruolo e della funzione determinante di corpi
Ivi, p. 34.
Ivi, p. 36.
8 Ivi, p. 38.
9 Ivi, p. 40.
10 Id., Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli continuata da Ginesio Grimaldi,
Napoli, Stamperia Orsiniana, 1764, tomo XII, pp. 24-25. Si tratta di un’importantissima
raccolta che dà conto in maniera dettagliata della produzione legislativa del sovrano
borbonico curata da questo giurista poco noto, che in realtà sembra si chiamasse
Gregorio Grimaldi, come si evince dagli schedari della BNN, che ne registrano sotto
questo nome la notevole produzione scientifica. Oggetto specifico del libro XLI è «…la
6
7
40
Logos
altamente qualificati, nucleo centrale dell’economia, il vero e proprio
cuore, sono le industrie urbane, campestri, marittime; il danaro è il
sangue, il moto è la libera circolazione, le forze ordinarie le particolari
ricchezze de’ Popoli. La sanità del corpo politico risiede nell’armonia; le
malattie sono i conflitti o Guerre civili. In questo contesto la «forza
straordinaria è quella del Sovrano». Il progetto politico di Fortunato,
dunque, come si evince già da queste prime battute, contiene importanti
elementi di novità: l’esercizio positivo della sovranità si misura dalla
effettiva capacità di introdurre polizia, di stabilire un legame stretto con il
commercio e l’economia, oggetto della ragion di Stato,
indipendentemente dalla provenienza del sovrano. Non a caso Fortunato
fa riferimento a Carlo di Borbone «che tanto si è maneggiato con gloria
per lo stabilimento del commercio»11. Il commercio è il «nuovo oggetto
della Ragion di Stato»12 e di certo non sono molti i sovrani amanti del
commercio tra quelli che hanno «signoreggiati in questo ubertoso,
florido, ed impareggiabile Reame»13. Tra essi Fortunato cita solo Carlo II
d’Angiò, Alfonso e Ferdinando d’Aragona, «ed alcuni Sovrani Austriaci
del Trono di Spagna». In questo contesto, dopo aver ripercorso la storia
del regno, rivisitata essenzialmente a partire dal ruolo di potenza
commerciale e marittima cui è assurto nel corso dei secoli, Fortunato tira
poi le conclusioni del lungo excursus concernente «…i progressi delle
nostre Armate Navali dal Regno de’ Normanni in qua»14. I nostri sovrani,
osserva, «dai Normanni in poi» seppero costruire un «…ordine
impareggiabile nella Polizia della Marina» con «diversi Grandi Ammiragli,
e tra costoro l’Admiratus Admiratorum»15. Nel corso del tempo, tuttavia,
sono «andati in decadenza e ‘l Commercio, e la Disciplina militare
Nazionale; e soprattutto la Forza, il Potere, e la Polizia della nostra antica
Marina, fino al segno di essersi poi veduta di nulla ridotta»16. Certamente
polizia delle Leggi e Magistrati in rapporto al tempo, che cominciò a governare il
glorioso Carlo di Borbone…» (ivi, p. 1), cioè lungo un arco temporale che attraversa
uno spazio di venticinque anni, dal 1734 al 1759. Il controllo capillare delle
informazioni è una pratica fondamentale per costruire corpi politici qualificati, per
porre il sovrano e i soggetti che strutturano gli ordini a riparo da eventuali azioni di
discredito. «Ragion di Stato poi volle, che a. 10 Gennaio, e a. 21 dello stesso mese 1737
vietato si fosse il Notiziario impresso in Roma, e l’altro impresso in Bologna, in cui
erasi notata la nascita de’ Principi Sovrani, e de’ Cardinali non premettendo ad essi
alcuno spaccio» (ivi, p. 17).
11 Ivi, p. 55.
12 Ivi, p.1
13 Ibid.
14 Ivi, p. 67.
15 Ibid.
16 Ivi, p. 68.
Polizia, economia, ragion di Stato. Il regno nelle Riflessioni di Nicola Fortunato
il regno ha sofferto il “giochetto” di nazioni belligeranti che lo hanno
ridotto a “teatro lagrimevole” in seguito alla guerre di invasione e
conquista che lo hanno ridotto in una condizione di subalternità
effettivamente avvilente; è pur vero che i Romani hanno recato
distruzione e morte soffocando le fiorenti civiltà italiche, come sosterrà
in seguito Galanti. La decadenza, tuttavia, può essere ricondotta solo in
parte a questi fattori, o alla prolungata assenza di un “Principe naturale”;
nasce anche da «…totale povertà de’ Nazionali Scrittori su queste
particolari materie di Economia, e di Polizia»17. Con le Riflessioni, dunque,
Fortunato si impegna, per quanto può, a colmare questo vuoto di
scritture politiche che avrebbe potuto orientare in senso diametralmente
opposto la scienza amministrativa del regno. Su questo particolare
terreno, infatti, polemizza apertamente, senza mai fare riferimenti
specifici ad autori o ad opere, con chi ha ritenuto e continua a ritenere
che il modello di speciosa polizia adottato dai Romani, potenza
prevalentemente marittima e commerciale, non possa estendersi a
nazioni a base economica esclusivamente agricola come il regno.
L’obiezione è del tutto infondata giacché muove dal presupposto che i
privilegi accordati al Corpo de’ Navicularj dipendessero, presso i Romani,
dal «duro bisogno di Ragion di Stato», al solo scopo di rendere sicuro il
trasporto delle vettovaglie per l’annona di Roma, dal momento che a
quei tempi, «erano solo in voga le armi»18. La mancanza di polizia volta a
ricostruire o fondare gli ordini, sia detto di passaggio, ha determinato, tra
l’altro, anche la decadenza dell’«Illustre Classe della Nobiltà Napoletana»
che ha tanto contribuito alle fortune del regno, non solo militari 19. Nel
mezzogiorno, allora, ci sarebbe «duro bisogno, e ‘l più grande della
Ragion di Stato, l’antica polizia de’ nostri Maggiori», con l’unica
differenza che, mentre all’epoca dei Romani c’era effettiva necessità di
immettere vettovaglie di cui Roma aveva continuamente bisogno, nel
Ibid.
Ivi, p. 38. Il “Marzial vigore” ha esaltato spesso nel corso dei secoli la virtù dei
cittadini più qualificati del regno, è sufficiente menzionare l’Ordine dell’Argata che «nel
1388 molti Nobili del Seggio di Portanuova istituirono sopra di una Nave, per la difesa
del Porto, e della Riviera di Napoli contro gl’Insulti della Reina Margherita» (ivi, pp. 4144). Fortunato fa riferimento all’autorità di Giannone che ritiene indispensabile una
«nuova Polizia della Milizia». La milizia, infatti, nel corso del tempo si è “rivolta” agli
stranieri, mentre manca un battaglione di difesa terrestre e uno per la «nuda difesa pe’
Mari», formato da soldati, che oltre a sentir vivo il valore della patria, perché «nostrani»,
porterebbero spese assai meno rilevanti per le casse dell’erario regio (ivi, p. 199).
Ciascuno può vedere quanto pesi la lezione d Machiavelli, seppure adoperata in un
contesto diverso dalla prospettiva delineata del Segretario fiorentino.
19 Ivi, p. 69.
17
18
42
Logos
regno il «bisogno presente» consiste «nell’estrazione delle copiose nostre
vettovaglie, e varie derrate di cui va straricchito…, e sono superflue ai
sudditi, come dal corso dell’Opera si ricava…»20. Non si vede, dunque,
conclude Fortunato, come sulla scorta di argomentazioni così deboli, si
possa sostenere che il modello di polizia dei Romani «per noi sarebbe
dell’ultima importanza per la stessa ragion di Stato»21: non si può certo
dimenticare che, attualmente, «…tutto trovasi ridotto in regole, in
precetti, in sodissime massime per la scienza del commercio»22.
Il commercio può funzionare ed essere redditizio solo lì dove non ci
siano barriere che ne vincolino lo sviluppo libero, che lo condannino a
un «duro Ergastolo»23. Carlo III, a differenza del governo austriaco che
«deluse sulle materie di commercio, di Finanze, di loro Polizia»24 ha
promosso iniziative di grande rilievo mirate a costruire e rafforzare il
legame tra polizia e finanze come dimostra l’abbondante legislazione
prodotta sotto la sua guida politica illuminata. Per risolvere
positivamente la grave crisi politico-economica in cui versa il regno, è
opportuno considerare attentamente «la pratica dell’altre Nazioni già nel
commercio provette»25. Carlo III comprende che la Ragione Economica
richiede una totale ristrutturazione delle modalità con cui si deve
esercitare il commercio e, sull’esempio delle nazioni europee più
sviluppate, come l’Olanda e la Danimarca, elabora progetti legislativi
diretti ad incrementare le attività commerciali in genere, marittime in
particolare. Fa ingrandire il «Porto grande per comodo di grossi Legni»
tanto mercantili, «che di poderose Armate Navali»; costruire «un altro
picciol Porto per comodo dei Legni inferiori, come Galeotte, Feluche,
ecc.»; i fortifica questi porti per proteggere «i Legni dalle borasche».
Carlo, inoltre, promuove la costruzione di «un bellissimo Edifizio, per
comodo della Deputazione della Salute». A difesa della città fa
prolungare il Molo, abbellendolo e munendolo «d’un leggiadro Fortino
della Fonderianuova, il quale difende la Città, e i Porti medesimi da ogni
qualunque Nemica sorpresa; vedendosi adorno insieme d’una simbolica
Fontana di finissimi marmi»26. Si tratta di misure fondamentali a
protezione del commercio e delle difese del regno. Al nome di Carlo di
Borbone è legata la costruzione del celebre «Reclusorio, o sia Real
Ivi, p. 39.
Ibid.
22 Ivi, p. 38.
23 Ivi, p. 11.
24 Ivi, p. 26.
25 Ivi, p. 39.
26 Ivi, p. 87.
20
21
Polizia, economia, ragion di Stato. Il regno nelle Riflessioni di Nicola Fortunato
Albergo, affinchè vi potessero, non meno racchiudere i Poveri, che la
Gioventù vagabonda, per occuparla, educarla, ed istruirla nella
squisitezza, delle arti, e de’mestieri»27. Il Real Albergo assurge a luogo di
formazione e riqualificazione dei corpi politici, per questo è affidato alla
cura di uomini illustri quali il marchese D.Niccolò Fraggianni, membro
della Real Camera di S. Chiara, ed il marchese Sarno, presidente della
Regia Camera. Nel 1738, inoltre, come si è visto poc’anzi, il sovrano
istituisce l’ordine moderno di S. Gennaro, che «oscura tutt’i pregi di
polizia antica negl’Ordini Equestri»28, e raccoglie uomini illustri, che si
sono distinti per virtù, dando vigore e gloria alle classi di appartenenza.
Non si può certo dimenticare che, sotto l’accorta guida del sovrano, si
sono fatti «varj Pubblici Trattati di commercio con Principi del
Settentrione, e dell’Oriente…» e, ciò che più conta, «…si è veduto eretto
un Supremo Magistero del Commercio coi Consolati di Mare, e Terra» 29;
contemporaneamente sono sorti organismi assai simili a vere e proprie
assemblee composte da savi per selezionare i soggetti più idonei a far
fiorire il commercio. L’istituzione del magistrato del commercio resta un
punto di svolta fondamentale nella nuova strategia politico-economica
inaugurata da Carlo III . «I Consolati di mare e di terra, i Delegati delle
Nazioni estere, e de’ Consolati delle Arti, e quanto concerneva a ambj fu
rimandato alla sua Ispezione»30; il suo capo fu insignito col nome di Gran
Prefetto del commercio, mentre con il titolo di Ministro il Presidente «che da
quello dipendesse»31. In sintesi la funzione di quest’importante istituto
resta quella di controllare il commercio attraverso l’istituzione di
consolati nelle province, regolando e tassando i diritti delle dogane,
ispezionando merci e bastimenti, stroncando sul nascere ogni tentativo di
frode: in seguito furono poi fissati anche i diritti da pagarsi in questo
nuovo tribunale. Carlo comprende rapidamente in quale misura ed entro
quali termini sia la pratica stessa a determinare la conoscenza delle
attività e delle procedure del commercio: con felice intuizione invia molti
agenti nelle piazze mercantili, Consoli che si recano in luoghi di
fondamentale importanza per i commercio, Venezia, Genova, Roma,
Civita Vecchia, Alicante, Lisbona, Nizza, al fine di ottenere informazioni
utili sulle tecniche più avanzate adoperate dalle nazioni europee. La
politica culturale del sovrano borbonico è volta senz’altro a promuovere
Ivi, p. 88.
Ivi, p. 87.
29 Ivi, p. 88.
30 Id., Istoria delle leggi, cit., p. 27. Il 5 giugno 1743 fu pubblicato il trattato di
commercio e navigazione stipulato dal re con la corona di Svezia (ivi, p. 45).
31 Ivi, p. 28.
27
28
44
Logos
le scienze, mediche, filosofiche, economiche, come dimostra l’alto
numero di insegnamenti qualificati di cui possono giovarsi le Accademie
del regno. «I maggiori vantaggi però speransi dalla nuova Cattedra delle
materie di commercio, che degnamente sostiene l’Abate Genovesi; come
quella che unicamente riguarda la parte Economica, privata, e pubblica
del Regno, state finora tra le tenebre sepolte, quando che riconosciutasi
da per tutto essere questa utilissima facoltà dell’ultima importanza della
Ragion di Stato, oggi è cotanto in voga tra i Dominj della nostra Europa,
ch’è divenuta la facoltà più nerboruta, e ferma, anche la più pregiata, e
sublime; contenendo i mezzi i più diretti, efficaci, ed ubertosi per
l’acquisto della dovizia, e per la tranquillità della pace tra le Nazioni, di
cui è la natura del Commercio solo; e perciò veggonsi per questo da per
tutto, i più bei Regolamenti, veggonsi Camere, e Consigli particolari di
commercio, anche onorati cola presenza Maestosa degli stessi Sovrani»32.
Fortunato coglie l’occasione per ricordare alla reggenza di cui fa
parte, data la giovane età di Ferdinando IV, che, con l’istituzione del
Consiglio di commercio il giovane sovrano fornisce, di fatto, «…il primo
segno che allude alla Pubblica economia, e polizia del Regno»33. Il
progetto di istituire un Consiglio di commercio, come ognuno può
vedere, risale, però, a Carlo III, sempre attento a valutare gli effetti
prodotti dalle politiche economiche adottate dalle nazioni europee più
progredite. Con l’avvento al trono di Carlo di Borbone, a giudizio di
Grimaldi, il regno smette «la squallida divisa di Provincia», diviene
finalmente «Monarchia, la quale dal suo proprio Principe cominciava ad
essere governata». Polizia, osserva ancora il Grimaldi, è anche la decisione
presa dal sovrano di abolire il titolo di viceré; l’iniziativa libera, tra l’altro,
«l’animo de’ Magistrati dal timore di avere Visitatori», che, sebbene privi
di ogni competenza relativa a usi e costumi del Regno, «…disimpegnare
volevano il loro ufficio con inquisire su de’ loro difetti…». In questo
contesto Grimaldi fa esplicito riferimento ai provvedimenti legislativi con
cui Carlo sciolse il Collaterale, vero e proprio luogo di residenza dei
viceré, e ai fondamentali regolamenti con cui introdusse la figura del
magistrato supremo della Real Camera di Santa Chiara, che sostituisce il
Collaterale, nella quale gli stessi vicerè vengono ridotti a semplici
Ivi, p. 83. In materia di istruzione va ricordato il provvedimento tutt’altro che
secondario con cui si dispensano «…gli Studenti forestieri di prendere cinque matricole
per potersi dottorare, onde tre bastar dovevano senza aspettare gl’ altri sei mesi, ed un
giorno di licenziatura…», mentre il vincolo resta «per gli napoletani..», data la diversa
situazione di partenza e le differenti condizioni con cui si sono condotti gli studi (ivi, p.
18).
33 Ibid.
32
Polizia, economia, ragion di Stato. Il regno nelle Riflessioni di Nicola Fortunato
consiglieri, una carica dignitosa, ma che comunque ne limita il prestigio e
ne circoscrive l’autorità pressoché illimitata. Il sovrano borbonico,
inoltre, fa notare ancora Grimaldi, ebbe il merito di alleviare tante
Università “dai pesi”, «…mentre sempre più intenso era in adornare la
nostra Città di magnifiche fabbriche corrispondenti alla Sua Real Sede,
come altresì le Ville con superbi, e mai veduti Edificj…». Incomprensbile
e abbastanza difficile da stablire, sia detto qui di passaggio, è, poi, con
quale e quanta coerenza Grimaldi sostenga, poco prima di esaltare le res
gestae del sovrano borbonico, che l’azione politica di governo di Carlo III
sia stata poca cosa a confronto con quella ben più luminosa ed efficace di
Ferdinando IV34. Fortunato, al contrario, solo per compiacenza dedica la
sua opera al giovane sovrano, il nuovo Salomone, «l’Aurora di
quell’Augusta Prosapia, da cui riconosce l’Europa, anzi il mondo intero,
nuovo lustro di Polizia, nuovi oggetti di umanità e di eccelsa gloria»35. In
seguito, infatti, come avremo modo di vedere, sarà solo silenzio.
Luigi XIV stabilì non prima del 1700 un Supremo Consiglio del
Commercio, composto da tre Membri scelti tra i più illustri in quel
campo, affiancati da altre «Persone, e talenti ausiliari nelle materie di
Commercio sperimentati»36. Tale Consiglio si riuniva ogni quindici giorni
alla presenza del sovrano, che aveva così l’opportunità di verificare a
intervalli di tempo regolare il livello di produttività e di sviluppo
raggiunto dalla nazione. Su questo terreno il modello di polizia adottato
dagli olandesi si rivela assai avanzato e, proprio per questo, anche molto
redditizio. La polizia riconduce all’economia «non meno pubblica, che
privata»37. Fortunato fa riferimento esplicito ad alcuni edifici assai noti in
34Ivi,
pp. 1-2.
Id., Riflessioni, cit., p. 1.
36 Ivi, p. 83.
37 Ivi, p. 22. «È purtroppo noto, che sul principio de’ Dominj qualunque si era la
forma della loro Polizia, l’invenzione della moneta non fu ad altro oggetto, se non pel
favore del solo Trafico, e commercio, facilitandone la compera, e la vendita…» (ivi, pp.
14-15). In seguito le «Città Marittime poderose in Mare per loro famosi Porti» dette
anche Città Navarcali promuovono il conio di medaglie, raffiguranti Nettuno, un
Delfino, o altro simbolo (ivi, p. 15). Questa pratica di polizia rimonta ai Fenici, ma
viene fatta propria dai Greci e dai Romani. In casa Porcinari, osserva Fortunato, esiste
un vero e proprio Museo ricchissimo di medaglie, lucresi, reggine, tarantine; P.Fiore,
nella sua opera Calabria illustrata, inserisce un foglio con la descrizione delle medaglie,
tra cui spicca la X Medaglia della celebre Repubblica di Reggio (ivi, pp. 16-18). Essa
riflette,attraverso una specifica simbologia, tutte le particolarità del commercio e le
modalità per regolarlo. Luigi il Grande, a sua volta, allorché formò il Consiglio di
Commercio «fe coniare una Medaglia imitando gli stessi geroglifici di questo nostro
antichissimo monumento degl’Illustri Reggini, deluse soltanto la Deità fallace di
Castore, e Polluce; mentre con saviezza in lor luogo fe collocarvi la Giustizia…» (ivi, p.
35
46
Logos
Europa quali quello degli Osterlini in Anversa, che «serviva di Banco e
Contadonia per le Città Anseatiche, forniva l’altro oggetto della
magnificenza Mercantilmente contenea i comodi per le mercanzie, altro
per i Negozianti, ed altri per i commessi sin al segno, che potean servire
da delizioso soggiorno per ogni Principe»; oppure l’edificio di Bergen in
Norvegia dato dai sovrani in dono alla Società Anseatica. Al contrario, in
Ancona, Livorno, Genova e Venezia, ci sono solo Bozze o Logge, ovvero
luoghi pubblici dove si radunano i Negozianti e le Giunte di commercio 38.
Nel corso del tempo, in verità, non sono mancati modelli di polizia
privata, ma si sono esercitati in ambiti diversi e con fortuna alterna. Il
principe di Belvedere Francesco Maria Carafa «… tenne vari Legni al
commercio, come Galeotte, Tartane, Navi di suo particolare interesse, e
conto, che fe costruire nel porto di Belvedere, con legname de’ medesimi
Stati…»39. Carafa, però, nonostante la lodevole iniziativa meritasse
attenzione, non potette giovarsi di alcun appoggio da parte «…di un
qualche degno, e capace soggetto negli Stati, per corrispondere alle sue
degne mire; queste piuttosto gli riuscirono di svantaggio, che di profitto,
siccome sapean promettergli»40. Il figlio, Michele d’Anzi, al contrario, pur
seguendo le iniziative paterne «sa anatomizzare i pregi colla polizia
dell’amministrazione, e governo», con «savia e prudente condotta» d’Anzi
getta le basi «per un ricco commercio di cui beneficiano le Finanze di
suoi Stati, e i vassalli tutti»41. Il commercio, dunque, favorisce la crescita
della popolazione, ma soprattutto «…produce la navigazione e seco il
Potere marittimo de’ Popoli e dello Stato, e mercè le classi di guerra, le
Flotte mercantili, le colonie, i Banchi de’ Negozianti al di dentro, ed, al di
fuori de’ Dominj, cose che contribuiscono alla forza, ed alla floridezza
dello Stato, poiché arricchendosi i sudditi, in conseguenza si arricchisce
la Nazione tutta, e seco il suo Sovrano»42. Non va dimenticato che
Jacopo Coeur, mercante di Bruges, «coi suoi Tesori assicurò la corona di
Fiandre a Carlo VII»43, né che i mercanti di S. Malò soccorsero il Gran
Luigi con 32 milioni di oro. Il commercio, ed è ciò che più conta,
«…porta la sovrafina Polizia civile e militare, porta i distintivi, gli onori in
tutte le classi del buon governo civile; e quindi nasce la saviezza delle
19). Nella Discoverta Fortunato ribadisce le ragioni che hanno favorito l’affermarsi della
sovranità delle città Navarcali sulle altre popolazioni italiche.
38 Ivi, p. 32.
39 Ivi, p. 13.
40 Ibid.
41 Ivi, p.13.
42 Ivi, p. 42.
43 Ivi, p. 41.
Polizia, economia, ragion di Stato. Il regno nelle Riflessioni di Nicola Fortunato
leggi, e le scienze in generale…»44. La Scienza del calcolo economico e
politico è indispensabile «pel buon regolamento del commercio e delle
Finanze»45. La scienza nautica, a sua volta, ha favorito il sorgere di altre
scienze non meno importanti, geometria, aritmetica, trigonometria,
algebra, meccanica, soprattutto cosmografia, e idrografia. La scoperta
della bussola ha, di fatto, aperto la strada alla comunicazione tra i popoli
ed i Banchi stessi, seppure nati dalla prepotenza dei Lombardi che li
fecero introdurre nella nostra Capitale, sono poi diventati istituzioni
fondamentali in tutta Europa, il centro propulsore di un’economia
florida e sviluppata, ad Amsterdam, come ad Amburgo, o a Rotterdam. Il
commercio, tra l’altro, produce interessi convergenti tra sudditi e
sovrano che «allontanano dalla Repubblica le congiure, le cabale, le
perturbazioni»46. Oltre a favorire il controllo delle conflittualità «forma
una specie di Repubblica universale fra tutte le Nazioni commercianti;
nella quale Repubblica ciascuna Nazione sembra essere come una gran
Famiglia particolare, Bella e luminosa idea, che forma il solo oggetto
delle leggi di natura e delle genti, colme di umanità, di equità, e di
coltura»47. In questo contesto, allora, «L’Uomo non si circoscrive più
all’antico amore della sua Patria»48. Tra l’altro, osserva Fortunato «si dice
pure che Napoli fosse stata una doviziosa città, quali erano tra il numero
delle Anseatiche. Federazione la quale secondo la comune opinione degli
scrittori nacque nel 1164 nella Germania, che vol dire al principio del
Regno de’ nostri Normanni (cors)…»49. Già prima del 1099, Amalfi si
distinse per alcuni aspetti di vera e propria polizia, due Monasteri ed
«uno spedale per sollievo de’ Pellegrini»50: non ci sarebbe bisogno di
ribadire ciò che ognuno certamente sa bene, quanto siano famose le
Tavole Amalfitane «per la decisione delle contese marittime, a
somiglianza delle leggi Rodiane»51. Fortunato come farà in seguito
Galanti, cita Senofonte che nel Libro delle pubbliche rendite degli
Ateniesi «restringe a cinque tutte le cagioni delle ricchezze, e della
grandezza di una Nazione. Tali sono 1. Governo; 2. Natura del suolo; 3.
Ivi, p. 42.
Ivi, p. 34.
46 Ivi, p. 49.
47 Ivi, p. 45.
48 Ibid. C’è qui indubbiamente una visone del commercio come fenomeno globale
e, insieme, una apertura al cosmopolitismo come conseguenza diretta, sul piano
politico, del processo di estensione delle attività commerciali a tutte le nazioni civili.
49 Ivi, p. 21.
50 Ivi, p. 22.
51 Ivi, p. 23.
44
45
48
Logos
Sito del Dominio; 4. Numero degli Abitanti; 5. Loro industria»52 . È ben
chiaro, quindi, che Carlo III avvia un processo politico nuovo, dal quale
bisogna muovere, per vincere definitivamente la condizione di miseria,
sviluppo, arretratezza in cui versa il mezzogiorno.
Il sovrano deve essere allo stesso tempo panettiere, medico, chirurgo. «Se
la Repubblica è inferma, se famelica, se ferita, il Re sia il medico che la
curi, il panettiere che la sostenti, il chirurgo che la sani»53. In caso di
guerra o di altra calamità «…esche dalla casa Regia il pane e la salute»;
come il medico non apre subito la vena per cavarne il sangue «ma
piuttosto ristora col cibo le abbutute forze; così il Principe sia liberal
Provveditore e perito medico, che’ apporta giovamento e salute venendo
rare volte ai ferri e al taglio»54. L’Architetto politico «procede negli oggetti di
Polizia, a differenza dell’Architetto delle cose materiali»55. Il regno
possiede immense risorse economiche, boschi, ulivi, cereali, acque,
bestiame, che vanno valorizzate e rese funzionali al commercio di
esportazione attraverso la scelta di una politica economica saggia, che
favorisca la libertà degli scambi. Fortunato fa riferimento esplicito a
Colbert, che «…rappresentò al Sovrano, che la via più pronta e la più
sicura per aumentare le ricchezze del Regno era lo stabilimento delle
manifatture» di lana, seta, canapa. Colbert seppe intendere la forza del
commercio, penetrarne «…il fondo per l’aspetto della Ragion di Stato, e
della Ragion Mercantile tra le Industrie de’ Popoli»56. Le cure maggiori
della ragion di Stato, pertanto, «debbono essere nell’Economia Urbana,
Campestre, e Marittima»57. La grande risorsa del mezzogiorno, però,
come sosterrà poi anche Galanti, va cercata nel grande capitale umano,
nell’enorme quantità di braccia da impiegare attivamente nelle attività
lavorative, giacché è proprio l’uomo la mercanzia più utile. Il progetto di
rendere attiva e laboriosa una popolazione che vive di espedienti, quando
non è dedita costantemente all’ozio, richiede alcuni passaggi
fondamentali che vengono affermati in modo netto58. Ci sono due forme
Ivi, p. 47.
Ivi, p. 16.
54 Ivi, pp. 14-16.
55 Id., Discoverta, cit., p. 186.
56 Ivi, p. 92.
57 Ibid.
58 Con una prammatica del 4 dicembre 1738 Carlo vieta «i casini aperti in molti
luoghi della città per vender vino…» e nei quali le occasioni di scatenare risse
divengono frequenti (Id., Istoria delle leggi, cit., p. 27). Nell’ordinanza del 24 ottobre del
1748 la disposizione di chiusura viene confermata, ma si concede alle osterie pubbliche
il beneficio dell’apertura, sotto vigilanza, proprio per evitare i disordini che possono
nascere dalla vita oziosa e sregolata. La funzione di controllo è affidata ai Capitani di
52
53
Polizia, economia, ragion di Stato. Il regno nelle Riflessioni di Nicola Fortunato
di economia, l’una domestica, l’altra pubblica o di Stato. Nel «Governo
Economico» vanno «del pari» il «Padre col Principe, la Famiglia privata
collo Stato pubblico»59, per cui lo Stato ben organizzato deve funzionare
come una famiglia allargata. Nello Stato «…è da tenersi esatto conto
degli Abitanti, delle rendite, del suolo, del prodotto, delle arti, ecc. ed al
contrario tenersi ragione de’ bisogni, e dell’esito, e spesso ridurre tutto a
Bilancio Economico del Calcolator Politico»60. Il governo economico trova
espressione compiuta nella ragione governamentale, da cui deve muovere
e strutturarsi. «Lo stesso rapporto ha l’Economia politica con lo Stato , il
quale, non essendo altro, come si è detto, se non una gran famiglia, o
famiglia molteplice, richiede indispensabilmente un positivo Aritmetico,
che ne formi Bilancio generale e particolare, per ben intendere le forze
de’calcoli, e le utilissime conseguenze di ragguagli attinenti allo Stato»61.
La popolazione ben utilizzata e impiegata è il vero fondamento della
ricchezza di ogni Stato come dimostrano Bruges e Anversa, prima che
«le sedizioni, le vessazioni nel commercio, e nelle arti, che soffrirono
sotto Filippo II, le facessero oscurare»62. Fortunato fa riferimento al
Trattato della moneta di Galiani. «L’uomo solo dovunque abbondi fa
prosperare lo Stato»63. Come Galanti, anche Galiani e Fortunato
ritengono l’uomo la più utile di tutte le mercanzie. In una popolazione
laboriosa e attiva, nella convergenza di interessi tra sovrano e sudditi,
risiede la fortuna della nazione e del sovrano stesso, come dimostra la
politica di Alfonso il Savio. Il monarca deve vegliare alla conservazione
dello Stato come il pastore veglia sulle pecore. Fortunato, però, a
differenza di Galanti, non si pronuncia contro l’abolizione del
baronaggio, che per il pensatore sannita deve avvenire con il concorso
del sovrano cui presenta una serie di relazioni di notevole spessore
politico64. Su questo terreno mi sembra importante sottolineare la novità
giustizia nei quartieri loro assegnati, e agli scrivani della Vicaria nei quartieri di loro
residenza per evitare chiasso, bestemmie, liti omicidi (ivi, p. 64-65). In materia di ordine
pubblico, però, Carlo, pur così sensibile ad accogliere e far circolare nel regno le istanze
culturali europee, emette alcune discutibili disposizioni: con la stessa prammatica del 4
dicembre 1738 vengono messe all’indice anche le Lettere filosofiche di Voltaire, ritenute
empie e piene di falsa dottrina, in una parola estremamente pericolose ai fini della
conservazione della pubblica tranquillità (ivi, p. 27)
59 Ivi, p. 94
60 Ibid.
61 Ivi, p. 94
62 Ivi, p. 95
63 Ivi, p. 97
64 Mi permetto di rinviare, oltre alla vasta e assai nota letteratura prodotta
sull’argomento, anche al mio saggio L’amor della libertà. Saperi di governo e conservazione
politica in Giuseppe Maria Galanti, Napoli, Bibliopolis, 2000, in particolare pp. 77 e sgg.
50
Logos
della proposta di Fortunato, per certi versi abbastanza simile a quella d
Longano, per risolvere la vexata quaestio dei privilegi legati al feudo. Il
barone, in quanto Sovrano mediate, deve applicare le regole del saggio
governo nella propria giurisdizione. «Sarebbe un gran punto di Ragion di
Stato, e dell’ultima importanza pel nostro Regno, ad oggetto del costituto
di sua Polizia, incaricarsi ai Baroni, l’utile occupazione del Vassallaggio,
mercè le industrie urbane, campestri, marittime. Gratificarsi annualmente
colui, che saprebbe distinguersi sopra tutti, ad intenzione de’ saggi
Imperatori chinesi per far fiorire l’Agricoltura, e de’ saggi Inglesi per far
fiorire le Arti, e ‘l commercio…»65. Qui il legame tra polizia e
popolazione è più stretto. La polizia può trasformare i rapporti di
dipendenza e vassallaggio in rapporti utili allo sviluppo economico, e,
allo stesso tempo, le rendite di posizioni passive in unità territoriali
produttivamente autonome. «… Praticandosi tra noi così fatta diligenza,
ed accorta polizia, o quanto, e quanto vedrebbesi aumentata la
popolazione, rinvigorito il Vassallo ed il Barone, e seco loro fiorire il
Sovrano, e ‘l Regno»66. Mentre la «pubblica Economia del Regno» è stata
«…troppo incautamente maneggiata»67, una «saggia polizia delle Finanze»
ha reso la Cina una vera e propria potenza economica. La popolazione
cinese deriva principalmente «dal buon Governo»; in Cina non c’è «un
dito di terra inutile»68. Gli uomini sono ciò che il governo li fa essere, il
motivo è ricorrente nella letteratura settecentesca, lo si ritrova, tra l’altro,
nel Discorso sull’economia di Rousseau69. «I cardini principali della polizia» di
nazioni avanzatissime sul piano economico e commerciale come
l’Olanda e l’Inghilterra, sono due: gli Uomini e il Tempo. I «savj membri»
di questi governi si adoperano affinché ogni momento possa diventare
«utile per i Popoli, non scioperatamente impiegato colla perdita degli
Uomini stessi…»70. In Inghilterra il cavalier Tommaso Lombe introdusse
la «particolare machina da torcere, ed avvolgere le sete…»71 e fu premiato
dal parlamento con un riconoscimento in danaro per la scoperta geniale e
65 Ivi, pp. 98-99. Cfr. anche F. Longano, Vaggi per lo Regno di Napoli, a cura di G.
Gentile, Napoli, Bibliopolis, 2005, in part. pp. 9-46.
66 Ibid.
67 N. Fortunato, Istoria delle leggi, cit., p. 111.
68 Ivi, pp. 110-111.
69 J.J. Rousseau, Discorso sull’economia politica, Scritti politici, a cura di M. Garin, Bari,
Laterza,1971, vol. I. Il motivo è abbastanza ricorrente nelle opere politiche roussoiane,
cfr., in genere, il Discorso sull’origine e i fondamenti della disuguaglianza tra gli uomini, ivi, vol. I,
e il Contratto sociale, ivi, vol. II.
70 N. Fortunato, Istoria delle leggi, cit, p. 99.
71 Ibid.
Polizia, economia, ragion di Stato. Il regno nelle Riflessioni di Nicola Fortunato
innovativa che consentiva di risparmiare «braccia operatrici», e «tempo»72.
Il sovrano deve garantire, innanzitutto, occupazione continua nel tempo.
Fortunato fa riferimento alla legislazione di Solone, un modello di
governo tra i non pochi da prendere in considerazione. «Da questa
egregia Polizia, e condotta economica di quella Sapientissima Repubblica
d’un tempo, risultava che evitavansi i mali, che sono naturali figli
dell’ozio»73. Nella repubblica ateniese, infatti, i figli erano esentati dal
versare ai padri «i dovuti alimenti, allorché questi non curava di far
apprendere ai suoi figli qualche arte, o qualche mestiere, con cui avesse
potuto travagliando camoare la propria vita»74. Per le famiglie povere,
però, provvedeva direttamente l’Areopago. La “savissima idea del
Reclusorio”, o Albergo de’ poveri, ci rimanda alla saggia condotta
economica, alla polizia dell’Areopago75. Guglielmo III e la regina Maria
«donarono al ben pubblico il Palazzo di Greenwich», che aveva iniziato
Carlo II, per la costruzione di un ospedale a sostegno dei marinai rimasti
invalidi. Questo ospedale fu affidato alle cure amministrative di soggetti
che si formano nella pratica dell’amministrazione, sino a diventare grandi
«Ufficiali della Corona…Ministri di Stato, primi Magistrati del Regno»76.
L’ospedale riceve fondi e contributi dal Parlamento. Alfonso e
Ferdinando d’Aragona promossero “la nobile Arte della lana” e della
seta, arti dotate anche di Tribunali propri77. I saggi regolamenti tra cui
quelli di Carlo II d’Angiò che con «…espressi Statuti regolò il modo di
tessere i Drappi con oro, con argento, nonché di sete, e sete…»78 non
durarono a lungo. Le manifatture, dunque, sono il vero sostegno
economico della monarchia. Non a caso, Carlo di Borbone «nel partir da
Napoli il dì 7 ottobre dello scorso anno 1759 per degnamente coronarsi
Monarca delle Spagne…pensò da provvido Padre portar seco tante, e
tante famiglie Napoletane di diverse Arti…»79. È dunque necessario assai
più giudizio ed acume nel Conservare, che nell’Acquistare, perché la
«conservazione de’ Dominj, così come d’ogni altra cosa, non può seguire
senza una profonda saviezza»80. Carlo di Borbone, infatti, ha operato
seguendo i criteri della più saggia polizia, ispirati dai principi di una ragion
di Stato che , seppure entro un orizzonte di conservazione politica,
Ivi, p. 100.
Ivi, pp. 100-101.
74 Ivi, p. 100.
75 Ivi, p. 103.
76 Ibid.
77 Ivi, pp. 104-105.
78 Ibid.
79 Ivi, pp. 118-119.
80 Ivi, p. 212.
72
73
52
Logos
struttura nuovi campi di intervento aprendosi all’accoglimento delle
novità emergenti dal sociale, che pongono l’urgenza del rinnovamento
politico-economico del regno: su questo terreno il sovrano borbonico
produce una legislazione che resta un punto di riferimento fondamentale
per proseguirne la politica amministrativa.
Il Parlamento inglese con un Atto solenne del 1689 provvide a far
rifiorire l’agricoltura dando origine a una vera e propria Agraria Epoca. Il
Parlamento, infatti, accorda «non solo la libertà dell’estrazione delle
vettovaglie in generale, che è lo stimato di tutti i vantaggi; ma altresì
accorda la gratificazione di ogni genere, tanto naturale del suolo
Britannico, quanto industriale, ed artificiale de’ suoi Popoli, che si estrae
per gli altri Dominj»81. Immediatamente dopo Fortunato osserva: «Ed
ecco le primarie cagioni per la diversità eccessiva dell’Agricoltura tra la
nostrale, e quella degl’Inglesi. Polizia che non solo ha fatta sormontare
l’Agricoltura ad un grado sorprendente, ma ben anche non ha mai più
quell’Isola assaggiate le carestie, e seco le vicende degli eccessivi prezzi
incostantemente corsi ne’ precedenti lustri, anzi trovansi oggidì in stato
di fare l’abbondanza in tutte le Piazze bisognose ed indigenti degli altri
Dominj»82. L’agricoltura in Inghilterra è «aumentata» innanzitutto «…per
la libertà nell’estrazione de’ grani, e di ogni altra sorte di vettovaglie»83. È
considerata grand’Arte perché gli Inglesi hanno saputo fare «un nobile
innesto tra la perizia della gente Campagnola, le notizie straniere allo
stesso proposito; e lo studio confacente agli affari Villaneschi, dietro una
fisica ben soda della pratica di rendere i terreni fruttiferi e fertili per
sterili, ed infruttiferi, che mai ‘l fossero»84. Fortunato torna a fare
riferimento alla “saggia polizia” del governo cinese. Secondo le regole del
modello cinese, l’imperatore deve conoscere il nome di chi si è distinto
per merito «nella coltura delle terre» per poterlo nominare Mandarino85.
Il mandarino è un governatore, ma anche un “Magistrato caritatevole”:
visita tutte le campagne, premia lo sforzo e la fatica, punisce gli oziosi,
sostiene con somme di danaro il lavoratore che non ha i mezzi per
rendere fertile il proprio terreno. Il mandarino trattiene per sè solo ciò
che avanza «senza interesse alcuno»86. La gran popolazione della Cina,
attiva e laboriosa, si deve a questa antica forma di polizia, nonostante il
sistema dispotico che la regge, di cui l’imperatore è personificazione
Ivi, p.124.
Ibid.
83 Ivi, p.120.
84 Ivi, p. 125.
85 Ivi, p. 126.
86 Ibid.
81
82
Polizia, economia, ragion di Stato. Il regno nelle Riflessioni di Nicola Fortunato
vivente. Il mandarino compila, inoltre, una specie di memoriale per
l’imperatore, che dalla relazione ricava saperi utili a consolidare le
procedure di amministrazione e di controllo. In Cina c’è anche il Tempio
della Terra: nel giorno dell’incoronazione l’imperatore «…veste un abito
bifolco, e prende in mano un aratro d’argento indorato con cui lavora
una piccola porzione del Campo procinto della misura del Tempio
istesso»87. I Cinesi, infine, «an fatti uscire di molti Fiumi diversi bei
canali» per facilitare il commercio88. Fortunato, però, poco dopo osserva
che «...i mezzi più sicuri per lo stabilimento dell’Agricoltura non abbiam
bisogno di rintracciarli dalla pubblica Polizia degl’Inglesi, e molto meno
de’ Chinesi anzidetti; poiché l’uno e l’altro è copia della Polizia» che si
praticò nel Salento. Fortunato esprime la convinzione che sia stato
Fènelon ad esportare in Francia il modello di polizia pubblica del
Salento: in Italia, dunque, nasce e si impone una pratica governamentale
che, attraverso la Francia, si estende e viene progressivamente a
incorporarsi nell’esercizio di governo dei paesi di tutta Europa. La tesi è
indubbiamente suggestiva ma, per sostenerla, Fortunato si affida alla
leggenda di Idomeneo cui Fènelon fa esplicito riferimento nel Telemaco,
che si può riassumere così. Mentore suggerisce a Idomeneo le modalità
con cui popolare la terra del Salento, e renderla fertile e utile. Il progetto
prevede di trasportare nelle terre salentine «gli Artigiani superfui che
sono nelle città, e i cui mestieri non servirebbero, se non a guastare i
costumi per far, che coltivino questi piani, ed insieme quelle colline»89. La
spartizione delle terre abbandonate e incolte è il primo vero passo da
compiere, mentre in seguito è opportuno chiamare in soccorso «…i
Popoli vicini, i quali faranno sotto d’essi un lavoro faticoso»90. In questo
contesto, poi, è indispensabile favorire i matrimoni e le unioni in genere,
in modo da promuovere la formazione di un corpo specializzato di
agricoltori, la prima risorsa di un paese economicamente attivo. Tra gli
altri “saggi avvertimenti di polizia” Mentore enumera 1. il rispetto delle
leggi inviolabili in rapporto all’educazione dei figli; 2. la necessità di
fondare scuole pubbliche dove si insegni «…il timore degli Dei, l’amor
della Patria, il rispetto delle Leggi…»; 3. costituire un corpo di Magistrati
che veglino sulla condotta e i costumi delle famiglie. 4. Il principio che il
re è tale, cioè vero e proprio “Pastore del Popolo”, per la funzione
specifica di governo che gli compete, «vegliare continuamente la
Ivi, p. 127.
Ibid.
89 Ivi, p. 129.
90 Ibid.
87
88
54
Logos
Gregge»91. La veglia ininterrotta come modalità fondamentale di esercizio
della sovranità consente al re di prevenire disordini e conflitti e di punire
severamente quelli che non si possono prevenire. Sarebbe dunque
sufficiente, conclude Fortunato, «…un sol soffio di favore nella Polizia, e
nella proporzione Economica, colla Rettificazione delle Finanze»92, per
far divenire il regno oltremodo competitivo e simile alla Gran Bretagna.
Ciò significa diffondere l’agricoltura per tutti i luoghi del regno;
promuovere industrie agrarie e campestri in generale; concedere la libertà
di estrazione dei grani, biade, frutta, ecc.; costruire “Legni” per il
trasporto delle merci sfruttando l’immenso patrimonio boschivo. Qui,
chiaramente, la marina mercantile gioca un ruolo fondamentale, ma va
provvista di «saggi Regolamenti assai più Politici, che Economici», sul
modello di quelli antichi delle finanze, che, «sia per l’economia e
Politica», si componevano di «patenti e calcoli» che gli antichi sovrani, fin
dai tempi dei Goti, spedivano «a Gl’Intendenti e Ufficiali»93.
Il ragionamento di Fortunato, d’ora in avanti, ruota principalmente
attorno alle procedure da utilizzare per favorire la più ampia estrazione
dei grani. La libertà di estrazione è condizionata al pagamento di dazi e
tributi. «La soverchia estrazione de’ grani, che fa temere la scarsezza nel
genere, e l’alterazione del suo prezzo, egli è un incauto sopetto, egli è un
vago dubbio, figlio d’un invecchiato pregiudizio; e nasce dal non
riflettersi quali siano i funesti effetti della limitazione, o divieto, e quali i
pregi ed i vantaggi della libera estrazione, supposta poco meno che fetale
per lo Stato, al contrario delle limitazioni, o divieto»94. Fortunato fa
esplicito riferimento agli Essai sur la Police générale des Grains, senza citare il
nome dell’autore, Claude-Jacques Herbert (1700-1758), né l’anno di
pubblicazione dell’opera, il 1753. Genovesi, come fa notare Venturi,
lesse questo testo nell’edizione del 1755, ma lo ritenne «opera del
maggiore degli agronomi francesi», Duhamel du Monceau. Gli Essai di
Herbert restano «la più lucida difesa pubblicata in quegli anni del
liberismo agrario entro i limiti di una concezione popolazionista e tardo
mercantilista. Tanto piacque quest’opera a Genovesi che, una decina
d’anni più tardi, in occasione della grande carestia del 1764, egli ne diede
una versione italiana largamente commentata»95. Nelle Lettere familiari
Ivi, pp. 130-131.
Ivi, p. 131.
93 Ivi, pp. 132-133.
94 Ivi, p. 134.
95 F. Venturi, Settecento riformatore, Da Muratori a Beccarla, Torino, Einaudi, 1969, vol
I, p. 570
91
92
Polizia, economia, ragion di Stato. Il regno nelle Riflessioni di Nicola Fortunato
Genovesi dà notizia della traduzione a Michele Torcia 96. L’abate
salernitano premette al testo di Herbert un discorso preliminare assai
importante e ricco di indicazioni degne di nota97. Genovesi definisce il
testo che, come messo in rilievo poc’anzi non attribuisce a Herbert, un
lavoro grazie al quale è «cambiata in Francia tutta la Legislazione
Economica de’ grani»98. L’editto emesso da Luigi, osserva inoltre
Genovesi, spiega con lucidità impeccabile le ragioni per cui è
indispensabile accogliere le richieste motivate per «ristabilire la maggior
libertà nel commercio de’ grani, e per rivocare quelle leggi, e quei
Regolamenti, che fossero stati antecedentemente fatti per restringerlo fra
limiti troppo angusti»99. La libertà di estrazione e introduzione dei grani e
delle farine è attività volta a «migliorare e a dilatare la coltura delle terre, il
cui prodotto è la più certa e la più sicura sorgente della ricchezza d’uno
Stato; e a mantenere l’abbondanza ne’ magazzini, e a far sì che vi entrino
grani forestieri; a impedir che non li vendano a un prezzo, che scoraggi il
cultore; a bandire il monopolio, escludendovi per sempre tutte le
permissioni particolari, e dandosi libero e intero corso a quelle sorte di
commercio; a mantenere finalmente tra le diverse Nazioni quelle
comunicazioni di cambio del superfluo col necessario» conforme tra
Venturi, a differenza di quanto sostiene Fortunato, afferma con certezza, ed è
vero, che Genovesi, in una lettera datata 1 settembre 1764, avrebbe dato notizia della
traduzione degli Essai di Herbert a Leonardo Cortese, non a Michele Torcia (ivi, p. 616,
ma si cfr. A. Genovesi, Lettere familiari, Napoli, Stamperia Raimondiana, 1774, pp. 3031). Venturi, tra l’altro, come si è appena visto, indica nel 1764, in occasione della
grande carestia, l’anno in cui Genovesi avrebbe dato alle stampe una versione degli
Essai a larga diffusione (ivi, p. 570). Le edizioni, da me consultate, recano però una
datazione diversa rispetto a quella segnalata da Venturi, ovvero 1765, mentre la data del
17 luglio 1764 non può essere certo quella in cui Genovesi dovette terminare la sua
traduzione prima di darla alle stampe, quanto piuttosto quella in cui furono emesse le
ordinanze reali che ispirano il liberismo di Herbert, e che l’abate salernitano inserisce
nel suo lavoro di traduzione come referente da cui muovere per tracciare una personale
idea dell’opera. Infatti, nella raccolta di scritti che dedica alla figura e al pensiero di
Genovesi, Venturi assume il 1765 come data certa di pubblicazione della traduzione
della Police des grains. Cfr. Antonio Genovesi, Scritti, a cura di F.Venturi, (Milano-Napoli,
Ricciardi,1962) Torino, Einaudi, 1977, p. 35.
97 C. Herbert, Riflessioni sull’economia generale de’ grani, tradotte dal francese con un
Discorso preliminare del Signor Abbate Genovesi, Napoli, presso P. Gravier, 1765. Qui
va notato che Genovesi traduce il termine ‘Police’ direttamente con ‘economia’ mentre,
come ho avuto fin qui modo di porre in rilievo, per Fortunato polizia ed economia
certamente non sono sinonimi giacché la polizia ha per oggetto, tra l’altro, il campo
delle finanze e quello dell’economia
98 Ivi, p. 3.
99 Ivi, p. 9.
96
56
Logos
l’altro, «all’ordine della Divina Provvidenza stabilito»100. Genovesi
richiama particolarmente l’attenzione sull’articolo IV in cui vengono
identificati i porti nei quali è possibile procedere all’imbarco de’ grani
che, secondo l’ordinanza, deve avvenire esclusivamente «sopra a Vascelli
Francesi» di cui è responsabile il Capitano insieme con i due terzi
dell’equipaggio, pena la confisca101; e sull’articolo IX in cui si fa
riferimento a queste come a «Regole di polizia» che devono restare in
vigore «fino a tanto che» la pubblica autorità non avesse emesso nuove
ordinanze102. Genovesi sottolinea come, in seguito alle importanti
decisioni prese, il re riceva una lettera dal Parlamento in cui viene
pubblicamente ringraziato ed elogiato per la “grande opera” intrapresa. Il
1764, è superfluo ricordarlo ancora una volta, è l’anno della grande crisi
economica determinata dalla grave carestia da cui il regno uscì
praticamente sconvolto. Se si accetta la tesi di Venturi, che in verità
qualche perplessità la suscita, con la traduzione del testo di Herbert
Genovesi cercherebbe soltanto ed esclusivamente risposte e soluzioni
possibili agli eventi tragici dell’ annus horribilis. In realtà gli elementi di
riflessione e le considerazioni che discendono dall’analisi di Genovesi
sono di portata ben maggiore, in quanto gli consentono di ripensare e
sottoscrivere pienamente le tesi di Herbert. «L’arte di governo» altro non
è che «quella di nutrire in pace e sicurtà i sottoposti popoli»103. Le vere
ricchezze non sono i metalli preziosi, ma quelle che ci «somministra la
Terra ben coltivata»; «..non si mangia oro, né si veste»104. Se l’agricoltura
e le arti possono costituire un baluardo contro le carestie c’è da chiedersi
«perché … non si è lasciato loro libero corso»105. Certamente «..la carestia
fa gran paura», ma «..si è creduto che per iscansarla fosse da incarcerare i
grani, stimandoli il più valevole presidio a difendercene»106. Le carestie
«dopo gli esempj luminosi degl’Inglesi», «le han più prodotte le antiche
leggi, che o la libertà della terra, o l’inclemenza delle stagioni»107. Si
ritiene, dunque, erroneamente che sia solo la sete di guadagno a spingere
l’agricoltore a «faticar con brio»108. Non è così. «…I coltivatori e i
manufattori non guadagneranno mai, che poco o nulla, senza che le
derrate e le manifatture non girino e scorrano per ogni dove colla
Ivi, p. 10.
Ivi, p. 13.
102 Ivi, pp. 17-18.
103 Ivi, p. 2.
104 Ivi, p. 6.
105 Ivi, p. 8.
106 Ivi, p. 9.
107 Ibid.
108 Ivi, p. 11.
100
101
Polizia, economia, ragion di Stato. Il regno nelle Riflessioni di Nicola Fortunato
massima possibile rapidità»109. Proprio da questo «scorrere deriva il
guadagno; gli intoppi, al contrario, provocano accumuli e diventano
inutili, per cui i prodotti stessi vengono abbandonati e letteralmente
strappati dalla fatica»110. Le leggi «di tre secoli addietro», dunque,
conclude Genovesi, non mirano ad altro che ad opprimere l’agricoltore e
«a far incagliare il commercio de’ grani», ad «intimorirlo, ad incatenarlo,
siccome reo di pubblica ruina»111 per cui ci si trova inevitabilmente di
fronte a due alternative possibili, o «rompere i vecchi lacci», o abituarsi
alle carestie frequenti, figlie, peraltro, di «vecchi pregiudizj» che
«inceppano…le menti e i cuori del pubblico..»112. Qui è opportuno
richiamare il nucleo centrale del ragionamento di Herbert, che al di là del
fondamentale spessore economico che gli viene giustamente
riconosciuto, presenta anche risvolti assai significativi sul piano politico,
quelli che Genovesi, probabilmente per prudenza, non coglie. «…Le
Leggi ripiene di nojosi impicci, di replicati divieti, e di molteplici
formalità, produrrai sempre nella mente di qualsiasi nazione idee di
soggezione, e di timidezza, le quali s’imprimono in guisa, che divengono
poi la norma del pensare, e dell’agire»113. Le leggi e il sistema di governo
devono concedere ai sudditi libertà di azione, giacché proprio «…a
seconda delle Leggi nascono.. gli usi e i costumi, i quali formano la
mente, e le condotte dei sudditi stessi…»114. La libertà di commercio non
dipende dalle forma di governo, sia essa repubblicana o monarchica. Le
repubbliche, infatti, fin dalla loro origine, «trovandosi situate in terre
poco feconde, convenne che rintracciassero studiosamente i mezzi da
procacciarsi col travaglio, e coll’industria tutto ciò, che potesse loro
mancare»115. Nelle monarchie, al contrario, prevalgono «le idee della
Grandezza, e dello splendore», per cui si afferma più tardivamente
«quello di un industrioso commercio, che a prima vista non sembra
necessario in questi stati»116. Herbert, dopo aver ribadito che la libertà di
commercio «può in tutti gli stati regnar del pari», sostiene che si
svilupperà meglio «in quegli…ne’ quali vi si trovi un’autorità più assoluta,
e una più grande abbondanza…»117. Napoli e Livorno, come Genova e
Venezia, raggiungeranno gli stessi obiettivi se applicheranno le giuste
Ibid.
Ibid.
111 Ivi, p. 12.
112 Ivi, p. 13.
113 N. Fortunato, Riflessioni, cit., p. 27.
114 Ivi, p. 28.
115 Ivi, p. 30.
116 Ivi, p. 31.
117 Ibid.
109
110
58
Logos
misure commerciali. Le norme proibitive, infine, sono molto antiche:
furono introdotte dagli ateniesi che vietavano «l’estrazion de’ fichi», e ciò
dimostra a sufficienza che «la libertà dipendente dalla pluralità de’ voti»
non sempre produce gli effetti migliori; analogamente la repubblica
romana «non fu governata già con più saviezza ne’ comizi, di quel che ne
fu coll’autorità del Senato»118. A Herbert fa riferimento esplicito Foucault
nell’importante lezione tenuta il 18 gennaio 1978 al Collège de France.
La ratio che giace al fondo della fase che scandisce il passaggio dal
mercantilismo alla fisiocrazia fa emergere una prospettiva interpretativa
del tutto nuova ed originale che si situa «più che in un’archeologia del
sapere» in una «genealogia delle tecnologie di potere». I fisiocrati e i
teorici dell’economia del XVIII «…facendo leva sulla realtà
dell’oscillazione abbondanza/prezzo basso e rarità/caro prezzo, invece
che sul tentativo di vietarla in partenza, hanno tentato di pensare un
dispositivo di sicurezza che si allontana dal sistema giuridicodisciplinare»119. Il «lasciar fare» è, dunque una tecnica, un «dispositivo di
sicurezza» che «lascia fare», «…non che lasci fare tutto, ma a un certo
livello lasciar fare è indispensabile»120.
La lettura delle crisi economiche che Genovesi ci propone è
chiarissima, così come la soluzione da adottare per fronteggiarle. Solo
attraverso un’ arte o tecnologia di governo avanzata che produca libertà
di azione e, nello stesso tempo, favorisca pace e sicurezza, è possibile
creare condizioni di sviluppo e di progresso economico. Fortunato sposa
in pieno il punto di vista di Genovesi, che, se non vado errato, non
prende mai in considerazione l’ordinanza con cui Carlo III dispone di
regolare la vendita dei grani. Il supremo Magistrato del commercio,
secondo la lettura che ne fornisce Grimaldi, prende in cura anche
l’annona, «…facendo sì, che nel Regno non si patisse di scarsezza di
grani, i quali quando per la laboriosa raccolta fattane eccedenza avessero
il necessario bisogno, utile cosa era, che il più si ponesse in commercio
con permetterne l’estrazione»121. L’ordinanza, però, come osserva
giustamente Fortunato, non va in direzione della piena libertà di
commercio, giacché le disposizioni del sovrano borbonico prevedono,
comunque, alcune forme di controllo in certo senso restrittive. Tutte le
rivele del grano raccolto nelle singole Università devono, infatti, essere
Ivi, p. 32.
M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione, Corso al Collège de France (19771978), trad. it. a cura di P. Napoli, Milano, Feltrinelli, 2005, pp. 38-39. Al commento del
testo di Herbert è dedicata ivi, la nota n. 9, p. 298.
120 Ivi, p. 45.
121 N. Fortunato, Istoria delle leggi, cit., p. 46.
118
119
Polizia, economia, ragion di Stato. Il regno nelle Riflessioni di Nicola Fortunato
esaminate dal Priore del Consolato che ha il compito di valutare l’effettivo
fabbisogno, la reale corrispondenza di esso alle esigenze della
popolazione. L’ ordinanza, inoltre, vieta l’accumulo di grano nei
magazzini al fine di farne lievitare il prezzo nei periodi di penuria, ma
richiede contemporaneamente indicazioni precise di previsione da far
pervenire ogni 20 settembre al Magistrato. Il Priore del Consolato ha,
pertanto, il compito di far redigere «un esatto registro dai suoi Officiali»,
di cui relaziona al Magistrato, il cui Precettore ha, a sua volta, il compito di
«farne un altro registro a parte»122. Le Università che non avessero
provveduto alla loro annona recano impedimento alla contrattazione,
giacché vendono poi liberamente il loro grano determinando
ingiustificati aumenti di prezzo. L’ordinanza prevede anche una pena
pecuniaria di 200 doc. per i governatori che non dovessero ottemperare
ai propri obblighi, mentre il Magistrato del commercio ha piena facoltà di
attuare i provvedimenti che ritiene necessari «…per meglio fermare la
sua disciplina, che tutta intera essa dovea al sollecito disbrigo delle
cause»123. I regolamenti del sovrano borbonico sono riflesso del perfetto
stile tardo mercantilista, e il mercantilismo è, a sua volta, una tecnologia
di potere che mira all’accrescimento della potenza del sovrano124.
Fortunato lascia qui filtrare le proprie perplessità e con una punta di
rammarico che equivale a speranza tradita cerca di correggere e integrare
le disposizioni di Carlo III per tentare di utilizzarle in direzione di
equilibri economici più avanzati. La Francia, come la Spagna, ha sofferto
«un antico difetto di Polizia», ovvero quello di imporre vincoli
all’estrazione e al commercio dei grani; sono proprio i vincoli a
determinare la scarsezza, la penuria e la carestia, mentre «…la libertà
dello spaccio è la madre di tutte l’abbondanze…»125. I Francesi
Ivi, p. 47.
Ivi, p. 51.
124 Cfr. M. Foucault, Sicurezza, territorio e popolazione, cit. Oltre alle lezione del 18
gennaio 1978, va tenuta presente anche la successiva del 25 gennaio, pp. 49-69. In
questo contesto tutte le lezioni dell’anno 1977-1978 sono particolarmente ricche di
spunti di notevole rilievo critico.
125 N. Fortunato, Riflessioni, cit., p. 135. In alcune opere quanto meno poco note,
anche di fine settecento, si denuncia l’assenza di polizia come un limite cui il
mezzogiorno non ha saputo mai dare risposta adeguata. «In Inghilterra si compra circa
ducati trecento il diritto di vendere a minuto i liquori forti: par dunque bene fatto
l’esseri fatti contribuire i cantinieri di Napoli al mantenimento della sua Polizia, se non
che dandosi il comodo di tener aperte le cantine nell’ora molto tarda, sembra darsi il
modo di potervisi ricettare i ladri, e di astenersi ad ubriacare nelle ore destinate
piuttosto al riposo, ed al divertimento». Cfr. N. Fiorentino, Riflessioni sul Regno di Napoli,
in cui si tratta degli studj, de’ Tribunali, delle Arti, del Commercio, de’ Tributi, dell’Agricoltura,
Pastorizia, Popolazione, e di altro, Napoli, s.e., 1794, p. 86. «La polizia nel fare il pane è cosa
122
123
60
Logos
comprendono la necessità di rettificare le loro finanze, e rendono così
florida la monarchia. Il modello più avanzato di polizia, tuttavia, resta
sempre quello olandese. In Olanda, infatti, «…oltre alla Borza
menzionata, vi è anche la Borza o Mercato de’ grani, ch’è un edifizio di
legname con suoi sostegni ove unisconsi i Mercanti di tal genere, tanto
della Città, quanto di fuori in tutt’i Luoghi Lunedì, Mercoledì, e Venerdì
dopo le ore dieci di mattina fino al giorno»126. Queste misure vanno in
una direzione ben precisa e sono indicative di come in Olanda, si guardi
la «cosa per l’aspetto del commercio, non già del proprio bisogno»127. Le
limitazioni, al contrario, riducono l’agricoltura allo stato di abbandono,
che significa spopolamento, e, chiaramente, «mancando la popolazione,
manca la Potenza», per cui anche il Principe è «ridotto nello stato di
semplice povero Signore per la misura de’ pochi sudditi, sopra quali
regnerebbe»128. Il vero problema del regno, come s’è già più volte messo
in rilievo, è nel difetto di saggia Polizia di Finanze: se ci fosse libera
estrazione e circolazione, se si potessero sfruttare a dovere le vie del
mare, non ci sarebbe squilibrio tra provincia e provincia, tra capitale e
province. Anche il regno francese si compone di singole province ma
Herbert ha mostrato con grande lucidità i «mali fisici e morali» che soffre
una provincia colpita da indigenza in regime di vincolo: non può essere
soccorsa senza «un ordine espresso» da altra provincia in cui, invece,
regna l’abbondanza e, dunque, languisce «qualche tempo»129. A differenza
molto necessaria, perché ogni assenza antecedente, o fetido odore è pregiudizievole alla
pasta» (ivi, p. 90). Qui andrebbero indagati i percorsi semantici del termine polizia.
Fiorentino se ne serve per invocare regolamenti volti a salvaguardare l’integrità e la
genuinità dei cibi, la loro pulitezza. In queste Riflessioni, tuttavia, non c’è mai una
distinzione netta tra leggi e regolamenti o ordinanze, e scarse sono anche le indicazioni
relative alla libertà di commercio richiamata surrettiziamente attraverso alcuni
riferimenti alle opere di Genovesi. Assai più vicino alle posizioni di Fortunato è, invece,
Venturi, noto come “l’illustre duca di Montervino”. Questi osserva che coloro che sono
«negli affari di Governo versati» non possono non comprendere che i «svantaggi» di cui
soffre il regno rispetto alle altre nazioni derivano dalla carenza strutturale di «quella
saggia polizia di Leggi fisse commerciali» ben nota agli antichi, sulle cui fondamenta le
nazioni europee hanno edificato le loro fortune. Venturi ritiene Acton ministro in grado
di produrre quelle regole di “pulizia” indispensabili a formare un codice idoneo a
rilanciare il commercio interno ed estero. Acton, infatti, rende, seppure in parte,
«l’antico lustro al Tribunale supremo del commercio», «rimasto…per gelosia de’
Ministri lunga serie di anni poco attivo, e depresso…». Cfr. F. S. Venturi, Riflessioni
politico-prattiche sul commercio interno ed esterno del regno di Napoli, Napoli , s.e.,1798, pp. 1011.
126 N. Fortunato, Riflessioni, cit., p. 136.
127 Ivi, p. 137.
128 Ivi, p. 139.
129 Ivi, p. 141.
Polizia, economia, ragion di Stato. Il regno nelle Riflessioni di Nicola Fortunato
della Francia che ha risolto questo difetto di polizia nelle finanze, nel regno
le uniche misure efficaci prese a sostegno dell’agricoltura risalgono al
periodo del “Vice-Regnato” del Carpio che ha combattuto il banditismo
nelle campagne e nei boschi per rinvigorire l’agricoltura nelle singole
Università. Carpio stabilisce di introdurre i cosiddetti Riveli , cioè
«Registri delle Dogane per rapporto all’estrazione de’ Grani»130.
Fortunato, facendo sempre riferimento agli Essai di Herbert, cita gli
Editti di Francesco I e Luigi XIV, che promuovono la libera circolazione
dei cereali, e aboliscono ogni forma di vincolo nell’estrazione dei grani,
ed osserva che la «Stessa Polizia» fu praticata da Filippo V. La Ragione
delle Finanze, è opportuno ribadirlo, deve essere parte integrante della
Ragion di Stato131. Se nel regno di Napoli si fosse applicata la «stessa
polizia di Luigi XIV», immediatamente dopo il fallimento del raccolto
dell’anno 1759, si sarebbero risparmiate molte calamità e, nello stesso
tempo, si sarebbero risolti tanti problemi. L’abbondanza, sottolinea
ancora Fortunato richiamandosi in modo sempre più diretto a Herbert e
a Genovesi, non si fa riempiendo i granai, ma «…per effetto della
concorrenza» da cui discende, per logica conseguenza economica, «la
bassezza del prezzo a favor del compratore»132. Galiani ha più volte
mostrato con lucida puntualità le ragioni per cui la carestia «talvolta
mantiene (?) il prezzo basso, e l’abbondanza il caro»133. Il ragionamento
di Fortunato si conclude con un riconoscimento ad Herbert, cui sente di
dovere molto, che ne esalta anche le lucide intuizioni economiche. «Il
Savio Autore della citata Polizia generale de’ grani conchiude che,
ciascuna Provincia affatto non è uno Stato separato; elle sono tutti i
membri del medesimo corpo, i Figli di una medesima Famiglia; elle non
possono sussistere senza prestarsi giornalmente un vicendevole soccorso.
La varietà delle loro produzioni, l’abbondanza, e la scarsezza rendono
indispensabile la circolazione. Le società civili non sono fondate, che
sopra de’ nostri bisogni; e se quello degli alimenti è il più vivo, il più
pressante, egli è rompere i ligami delle Società; egli è esercitare la
dissenzione …impedire che le derrate le più necessarie alla vita, non si
comunicasse con tutta facilità»134. Su questo terreno Fortunato elabora un
progetto economico funzionale alla realizzazione della libera circolazione
dei grani e delle mercanzie. Ogni dogana dovrebbe essere fornita di un
Ivi, p. 142.
Ivi, p. 145.
132 Ivi, p. 167.
133 Ivi, p. 149. Nel testo la parola è illeggibile e ‘mantiene’ sembra l’unico verbo in
grado di dare senso compiuto al discorso.
134 Ivi, p. 150.
130
131
62
Logos
apposito Registro delle estrazioni annuali, di quelli depositati nella Regia
Camera. In base al Calcolatore le dogane potrebbero concedere alle singole
Università permessi di estrazione di prodotti di ogni genere sino alla
quantità prevista nei calcoli annuali per ciascuna Università stessa, in
modo da incrementare la circolazione interna ed esterna dei prodotti
senza limitarne l’uso al bisogno di sussistenza di ogni Università. Per
incrementare il commercio, tuttavia, è indispensabile seguire l’esempio
degli Olandesi. In Olanda le pratiche di sdoganamento delle merci sono
rapidissime: ad Amsterdam è sufficiente mandare un garzone o un
commesso alla dogana per ottenere il permesso di avviare le operazioni
di importazione ed esportazione. Fortunato fa riferimento a
Montesquieu, esattamente al tredicesimo libro dello Spirito delle leggi, dove
si tratta delle entrate dello Stato, e dove, in particolare nei cap. XII e
XIII, si fa esplicito richiamo al Rapporto della gravezza dei tributi con la
libertà, e In quali governi i tributi sono suscettibili d’aumento135. L’intento di
Montesquieu, com’è del resto evidente, è quello di trattare il problema
delle imposte in rapporto alla forma di governo e alla libertà del
cittadino. Egli giunge ad una conclusione che Fortunato ritiene,
evidentemente, valida sul piano economico e funzionale allo sviluppo
della libertà di commercio: si possono esigere tributi «più forti in
proporzione alla libertà dei sudditi», ma «si è costretti a moderarli nella
misura che la servitù aumenta»136. Stranamente a Fortunato sfugge
l’importantissimo cap. XXIV del ventiseiesimo libro, I regolamenti di polizia
sono d’un diverso ordine in rapporto alle altre leggi civili, che, se richiamato
espressamente, avrebbe di sicuro fornito ulteriore valido supporto alle
argomentazioni già convincenti che sostiene. Vi si legge, infatti, che «…le
questioni di polizia sono cose di ordinaria amministrazione e, in genere,
di poco conto: non richiedono quindi formalità. Le azioni della polizia
sono rapide, esse si esercitano su cose che si ripresentano tutti i giorni:
non le si addicono dunque le gravi punizioni. La polizia si occupa
perpetuamente di particolari: i grandi esempi non sono dunque fatti per
essa. Ha piuttosto regolamenti che leggi»137. Tornando al punto, si può
135 C.L. de Secondat de Montesquieu, Lo spirito delle leggi, trad. it. a cura di B.
Boffito Serra, Milano, Rizzoli, 1989, vol. I, pp. 367-375. Per i capitoli presi in
considerazione da Fortunato si cfr. ivi, pp. 374-375.
136 Ivi, p. 374.
137 Ivi, vol. II, pp. 838-839. Caterina II, «che aveva bisogno di costituire un codice
di polizia», accoglie pienamente questo passo nelle Istruzioni. La polizia, osserva ancora
Foucault, «consiste nell’esercizio sovrano del potere regio sugli individui in quanto
sudditi…. è la governamentalità diretta del sovrano in quanto sovrano…è il colpo di
stato permanente, che si eserciterà in nome e in funzione dei principi della sua stessa
razionalità, senza doversi conformare o modellare sulle regole di giustizia stabilite
Polizia, economia, ragion di Stato. Il regno nelle Riflessioni di Nicola Fortunato
facilmente osservare che proprio la rapidità delle misure di polizia facilita
non di poco il commercio olandese; alla dogana di Napoli, che è nulla in
confronto a quella di Amsterdam, per le stesse operazioni si perde anche
un’intera giornata. Tra i regolamenti di polizia olandese c’è l’abolizione
dei diritti di entrata per la pesca138. In Olanda, le quattro regole
fondamentali di polizia sono Ordine, pace, parsimonia, pietà. Il paese è
dotato di una struttura di governo moderna e avanzata che ruota attorno
ai Consigli supremi di stato e di guerra cui partecipano i Negozianti,
particolarmente quelli che avendo avuto il vantaggio di vivere in paesi
stranieri, hanno acquisito conoscenze teoriche e pratiche di commercio,
che mettono al servizio della nazione. Gli Olandesi, inoltre, grazie alla
qualità genuina dei prodotti e all’onestà commerciale, riescono a stabilire
contatti a largo raggio, senza che ci sia bisogno di ispezionare le loro
merci per verificarne peso effettivo e qualità. Premiano, inoltre, con
esenzioni «gl’inventori di nuove manifatture»; educano i loro figli
secondo criteri funzionali, cioè insegnando loro l’aritmetica e l’uso dei
calcoli, perché questa disciplina è la base di ogni attività commerciale,
non affidano la cura dei poveri alle parrocchie, ma dispongono di banchi,
che, all’occorrenza soccorrono i bisognosi, senza praticare l’odiosa usura
dei Lombardi. Consentono, inoltre, saggiamente, di trasferire le proprie
assicurazioni in tempi rapidi di padre in figlio, che equivale a far circolare
due volte lo stesso danaro, e si servono di Registri pubblici «sopra de’ quali
sono situate tutte le terre e le case, che si vendono, o che si ipotecano.
Questa polizia evita un’infinità di litigi dispendiosi e si può essere certo,
che le terre e le case sopra delle quali si presta, sono tante sicurtà»139. Gli
Inglesi, in definitiva, adottano gli stessi criteri di “saggia Polizia” degli
Olandesi, come pone opportunamente in rilievo Genovesi nel
«Ragionamento del commercio in universale, aligato alla Storia del
commercio della Gran Bretagna»140. Su questo terreno ed in questo
specifico contesto Fortunato fa riferimento esplicito alle modalità con
cui il sovrano deve assumere la direzione e il controllo del processo
economico. Così recupera e fa propria la visione della governamentalità
statale, resa esplicita dal duca di Sully. «Gli Stati affatto non si governano
con risme di carte, con delle pergamene, con degli acuti temperini, e con
tirate speciose di penne, né con parole vane, brevi, con pensieri, con
fantasie, con minacce, e sguardi biechi; ma vi si richiede una sopraffina
altrove» (M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione, cit., p. 246, ma cfr. anche p. 360, n.
18).
138 N. Fortunato, Riflessioni, cit., p. 166.
139 Ivi, p. 232.
140 Ivi, p. 235.
64
Logos
prudenza e savia condotta, e render semplice ed andante ogni operazione
di Finanze»141. A rendere fortuna al commercio, infatti, sono le «acute
speculazioni per la pubblica Economia e Polizia accoppiate da una saggia
direzione, e stabili regolamenti di commercio»142. Non a caso il grande
Luigi «fissò gli occhi sua de’ perspicaci Regolamenti Olandesi, s’illuminò
con l’acutezza degl’Inglesi, e si perfezionò colla direzione del
Colbert…»143, accettando anche i consigli del ministro spagnolo Antonio
Perez, rifugiato in Francia, che gli suggerì i tre principi cardine per
rendere grande la Monarchia: Consejo, Pelago, Roma. Luigi, tra l’altro,
promosse la formazione di un Consiglio privato di commercio, quella di
compagnie di Negoziantj, e stabilì regolamenti finalizzati al controllo degli
abusi144. Consapevole che la scienza nautica debba comprendere la
conoscenza della matematica, della geometria, della trigonometria,
dell’astronomia, Luigi il Grande con «espresso ordinamento stabilì
pubbliche scuole nelle principali città marittime del Regno»145. La
Francia, attraverso l’azione di governo di Colbert e Savary, ha saputo
costruire un vero e proprio punto di fusione tra Ragion di Stato e Ragion
Mercantile146. La saggia politica di Luigi XIV, che si esprime in una serie di
editti volti a favorire e promuovere le attività commerciali, pose fine al
disordine e alla confusione che regnavano in Francia. Luigi stabilì che vi
fossero dei commissari in ogni provincia che esaminassero i debiti e i
carichi di tutte le comunità, il loro patrimonio, e le forme di impiego
delle loro rendite; per risolvere le situazioni debitorie introdusse forme di
«pagamento regolato» al fine di «moderare le cariche e le spese». Favorì le
opere pubbliche ristrutturando strade, porti, scoscese, ristabilendo la
sicurezza «sulle strade principali colla severa punizione de’ladroni»147.
Luigi, inoltre, istituì differenti scuole di formazione professionale
affidandone la direzione ai periti più abili “per insegnare alla gioventù
l’arte della Navigazione, e della fortificazione”; promosse una vera e
propria “Ordinanza della marina” basata su 5 punti fondamentali 1.
Ufficiali dell’Ammiragliato e loro Giurisdizione. 2. Genti di Mare e
Bastimenti. 3. I contratti marittimi. 4. Polizia de’ porti, delle coste, delle
Spiagge, Lidi. 5. La pesca148 . Questi provvedimenti in serie non
Ivi, p. 237.
Ivi, p. 236.
143 Ivi, p. 240.
144 Ivi, p. 241.
145 Ivi, pp. 164-165.
146 Ivi, p. 272.
147 Ivi, p. 275. Nel terzo libro della Discoverta ci sono analoghi positivi riferimenti
all’azione di governo di Luigi XIV (pp. 87 e ss.).
148 Id., Riflessioni, cit., p. 276.
141
142
Polizia, economia, ragion di Stato. Il regno nelle Riflessioni di Nicola Fortunato
esauriscono i positivi interventi del sovrano in ambito pubblico. Luigi,
infatti, istituisce un Consiglio generale del commercio da tenersi una
volta alla settimana aperto alla partecipazione di dodici negozianti di
diverse città del regno, tra i più esperti in materia; nello stesso tempo
forma anche un Consiglio privato di commercio, composto da sei
membri e altre persone di provata capacità «per deliberare sulle
risoluzioni del Consiglio generale; e questo Consiglio si tenea per ogni 15
giorni nella Sua Reale presenza»149. Nelle principali città di commercio,
come Lione, stabilì ci dovessero essere delle Camere particolari
composte da membri di qualità che indicassero cosa fosse più
vantaggioso per il commercio di ogni singola provincia, delle cui effettive
necessità veniva reso consapevole attraverso memorie e atti inviati
periodicamente al Consiglio generale150. Questo gran numero di
regolamenti comprende anche l’invio di lettere circolari a tutti i
negozianti affinché lo informassero di tutto quanto fosse necessario per
favorire «l’aumento del commercio»151. Luigi, infine, destinò «1 milione di
lire di Francia l’anno» per le spese necessarie allo «stabilimento del
commercio, e delle manifatture»152. Il processo economico, il laissez-faire
si svolge, dunque, sotto lo sguardo vigile e onnicomprensivo del sovrano,
giacché conviene sempre che il Principe «….entri per quanto si possa nel
dettaglio degl’impieghi de’ Sudditi»153. Il sovrano è, infatti, artefice e
custode di questo modello di economia pubblica. Fortunato non tralascia
occasione per ribadire con forza la distinzione che corre tra pubblico e
privato, che è anche distinzione di ruoli e di funzioni. L’economia
pubblica è «l’oggetto del Principe, ed abbraccia l’esercizio de’ membri
della Repubblica in tutte le industrie, urbane, campestri marittime in
generale; e seco abbraccia il commercio per lo spaccio di tutte le derrate,
e di tutti i generi e prodotti delle additate industrie»; l’economia privata è,
invece, «l’oggetto del Padre di famiglia, anche si restringe alla Domestica,
Ivi, p. 278.
Ivi, pp. 278-279.
151 Ibid.
152 Ibid. Venturi, al contrario di Fortunato, sostiene che le modalità di credito
allargato hanno fatto la fortuna dell’Inghilterra e dell’Olanda, mentre in Francia, «…per
effetto della sua pulizia con ristrette limitazioni fra il ceto solo de’ marcanti, Banchieri,
ed altre Persone al commercio applicate non si potevano ottenere gli stessi risultati delle
altre nazioni». Le conseguenze sono evidenti; in mancanza di «…un considerevole giro
di credito», il governo francese fu costretto a «sensibilissime stranezze», cioè fu
praticamente obbligato «ad aumentare a misura del bisogno, il valore numerario della
moneta; disordine, che direttamente ferisce, si l’interno, che l’esterno commercio della
Nazione» (F. S. Venturi, op. cit., p. 27).
153 N. Fortunato, Riflessioni, cit, p. 210.
149
150
66
Logos
per l’utile occupazione di tutti i suoi membri…»154. Fra le misure di
polizia degne di nota vanno segnalate anche quelle adottate dal re di
Svezia che ha ridotto il commercio del suo regno alla sola città di
Stokolm, e il “Grand’Atto” inglese del 1660. Non si può certo
dimenticare che la “soda scienza” della “Polizia delle Finanze” è
penetrata anche in una nazione scarsamente civilizzata come la Russia.
L’imperatrice della Russia, per combattere «i di svantaggi, che recava ai
sudditi l’immissione d’ generi stranieri» decise che fossero soppresse tutte
le dogane «stabilite dentro la terra», e che non si dovessero esigere diritti
se non «nelle Dogane di Frontiera, e de’ Porti di mare»155. Fortunato,
come Genovesi, sembra assai vicino a considerare la libertà di
commercio come una vera e propria arte di governo, tecnologia che, se
correttamente intesa e applicata, avrebbe potuto risolvere i mali secolari
del mezzogiorno.
Il commercio, osserva Fortunato, ha due principi fondamentali «la
Ragion di Stato e la Ragione Mercantile». Nell’Introduzione all’opera «si
fa menzione de’difetti dell’antica Polizia rispetto alla Ragion di Stato»; ma
è indispensabile anche esaminare i limiti «per l’aspetto della Ragion
mercantile»156. Egli ribadisce la convinzione già precedentemente
espressa che gli italiani siano stati i primi «Inventori dei Legni» da
commercio. Non a caso è «la Polizia de’ primi nostri Popoli a servir
d’esempio e di imitazione» per la monarchia francese, che su questo
modello ha costruito le sue fortune commerciali e marittime. A sostegno
e a conforto di questa tesi, tuttavia, non può recare altra testimonianza
che la leggenda di Idomeneo e Mentore, già richiamata, cui fa riferimento
Fénelon nel Telemaco157, oppure rimandare direttamente al “corpo delle
Leggi marittime” degli amalfitani senza motivare, però, in quali termini
possano essere a fondamento dei codici marittimi e commerciali di tutte
le nazioni europee. Il commercio assomiglia al flusso delle onde: il flusso
e il riflusso è paragonabile alla libera circolazione delle merci in entrata e
in uscita. Mentore muove dalla “numerazione” della popolazione, cioè
dall’identificazione delle forze produttive da destinare alle attività utili e
redditizie allo Stato. La polizia, dunque va subito posta in relazione con
la popolazione e con le attività che può svolgere. «Andò egli a vedere il
Porto, volle entrare in ogni Vascello. S’informò del paese, dove andasse a
(?) ciascuno di essi…»; «…volle che si castigassero severamente tutti i
Ivi, p. 228.
Ivi, p. 216.
156 Ivi, p. 204.
157 Ivi, pp. 260-261.
154
155
Polizia, economia, ragion di Stato. Il regno nelle Riflessioni di Nicola Fortunato
Falliti, poiché quelli che non sono colpevoli di mala fede, quasi sempre
sono rei di temerarietà. Nel tempo medesimo diè delle regole per fare in
modo che fosse facile non fallire giammai. Stabilì de’ Magistrati, a cui
dovessero i Mercanti dar conto di tutt’i loro capitali, dell’utile, e delle
spese, e de’ negozi, che intraprendessero»158. Non era consentito
arrischiare i capitali degli altri, né tantomeno la metà delle sostanze
proprie. Mentore si mostra convinto che la libertà del commercio si
possa realizzare solo grazie a regole inviolabili: ispeziona, allora,
magazzini e arsenali «per sapere se gli armi fossero pronti» insieme con
«tutte le altre cose, che son necessarie alla Guerra»159, che anche in tempo
di pace va considerata eventualità possibile. Il sovrano ha «la gloria della
Nave politica» e deve reggerne con abilità il Timone160: lo Stato o Dominio,
infatti, rassomiglia ad una «Nave d’alto bordo, la quale affatto non può
solcare né reggersi su l’onde, se non ha pria nel seno proporzionato peso
di zavorra, o altro equivalente»161. «La Polizia dell’imbecille nostra
marina», al contrario, non possiede neppure armate navali degne del
nome, destinate a «tenere in sicurezza» il porto e le coste162. Il regno,
come l’impero romano, è divenuto preda dei barbari quando sono venuti
meno gli stabilimenti di polizia che i «Normandi» e i Principi succedutisi
tennero sotto forma di «poderose Classi, ed Armate Navali»163. Le
deficienze «nella Polizia delle finanze in rapporto al commercio di Mare»
sono una vera e propria piaga che non si riesce a sanare: una «Classe
difettosa» che opera attraverso «fraudolenti disegni a di svantaggio della
Repubblica»164, detiene, di fatto, il monopolio delle attività commerciali.
Un gran numero di incidenti viene preparato e procurato ad arte per
poter frodare le compagnie di assicurazione e saldare i debiti contratti da
cattiva gestione delle attività commerciali. Bastimento scassato, Padrone
salvato, Padrone salvato, barca rotta165. Con un Real Editto di Regolamento per
la navigazione de’ Bastimenti mercantili del 14 agosto 1751, si cerca di porre
rimedio alle frodi e al malaffare: all’Editto avrebbe dovuto far seguito un
Codice di tutte le leggi per regolare il commercio marittimo e la
navigazione, unico strumento indispensabile per stroncare le pratiche di
illegalità diffusissime a Napoli in particolare, nel regno in generale166. Gli
Ivi, p. 262.
Ivi, p. 263.
160 Ivi, p. 265.
161 Ivi, p. 267.
162 Ivi, p. 200.
163 Ivi, p. 202.
164 Ivi, p. 170.
165 Ibid.
166 Ivi, pp. 170-171.
158
159
68
Logos
«Ufficiali» e i doganieri in genere, «profittano ne’ caricamenti» e lucrano
in maniera illegittima: va d sé che i loro miseri espedienti sono contrari
alle leggi della libera circolazione167. Grazie alle innumerevoli formalità,
alla mancanza di “saggia Polizia” i Subalterni, la razza mefitica cui faceva
riferimento Galanti come a un cancro ramificato nel profondo del
tessuto sociale, hanno «l’ispezione sulla Polizia delle Finanze»168,
procurando una rovinosa caduta per il commercio e danni irreparabili
per i popoli e per l’erario reale. La strategia del malaffare segue percorsi
inaccettabili per una nazione civile e retta da regole certe: si lascia
trascorrere il tempo «dell’Esta ed Autunno», il più favorevole «allo
spaccio de’ grani»169, e, per interesse dei subalterni, si giunge a “Vierno”
quando la navigazione e il commercio sono condizionati dal tempo e dal
clima. Accade così che le «…nostre antiche perniciose formalità»
costringano i Negozianti a trasportare il grano nelle “Piazze” che lo
richiedono «fuor di stagione» subendo danni economici notevoli. Già
Teodosio «escluse il più possibile il Verno»170 come periodo di
navigazione, stabilendo, al contrario, che i trasporti marittimi dovessero
tenersi principalmente in estate e, in misura minore, anche in autunno.
Carlo di Borbone, intenzionato ad affrontare il problema e a risolverlo
alla radice, comprende bene come la saggia politica marittima e
commerciale di una nazione civile debba muovere dalla ristrutturazione
dei moli e dei porti. Il sovrano, forte di questa convinzione, «ha praticato
la stessa Polizia nel Molo di Napoli», sull’esempio di Claudio Nerone,
che «fa fabbricare all’entrata del Porto di’Ostia un Molo difeso da dieci
gittate…», e di Traiano, «che si diede il piacere di accrescere, ed abbellire
il Porto di Ancona fino a farlo divenire la meraviglia del Mondo…» 171, e
non a caso Galiani ne celebra ed esalta le virtù politiche. Al contrario, la
maggior parte dei nostri porti resta serrata ai «Legni infelici» dei
«peregrini Nocchieri», o per incuria, o per vendetta dei
contrabbandieri172. La mancanza di regolamenti certi, di polizia, ha anche
altre conseguenze non immediatamente visibili. Tra i compiti dei
subalterni c’è anche quello di misurare la grandezza e la lunghezza dei
mercantili. Il legno «…cresce e decresce a misura del sottomano che si
misura colui, che far deve il rapporto per la capacità del
Ivi, pp. 174-175.
Ivi, p. 178. In proposito rimando al mio saggio già citato, L’amor della libertà, in
particolare pp. 33 e ss.
169 Ibid.
170 Ibid.
171 Ivi, p. 183.
172 Ibid.
167
168
Polizia, economia, ragion di Stato. Il regno nelle Riflessioni di Nicola Fortunato
Bastimento…»173. Pur di non piegarsi a ricatti, e di rimanere leali, molti
padroni di bastimenti «...si sono astenuti dal commerciar nel Regno»174.
Se, infatti, a causa del maltempo una nave mercantile dovesse essere
costretta a riparare in un porto anche vicino a quello di provenienza, pur
avendo ottemperato al pagamento di tutti i diritti, legali, e spesso illegali,
sarebbe costretta a pagare una seconda volta, quasi venisse da altro
continente. Il contrabbando, in generale, oltre a minare le finanze della
nazione, lede fortemente la Ragion di Stato, o, meglio, la Ragione Mercantile
che, a giudizio di Fortunato, è una componente essenziale della ratio
Status175. Ancora una volta Montesquieu funge da punto di il riferimento.
«La finanza distrugge il commercio con le sue ingiustizie, con le sue
vessazioni, con l’eccesso di quello che impone: ma lo distrugge anche,
indipendentemente da questo, con le difficoltà che fa nascere e le
formalità che esige»176. Tutte le irregolarità, soprattutto il contrabbando,
ledono la «sicurezza del cittadino», minano la sua fiducia nell’autorità
pubblica177. Il contrabbando, più che con la severità delle leggi, si arresta
con una saggia Polizia di Finanze, con una saggia condotta del Commercio178. I
tributi sono parte integrante della ragion di finanze; essi vanno distribuiti
in modo equo, in casi eccezionali la «ragion naturale suggerisce
l’esenzione», come durante il periodo di reggenza Tappia, allorché il
Collaterale «con lodevole legislatura del 26 marzo 1632» ordinò
l’esenzione da ogni forma di pagamento a seguito di una memorabile
eruzione del Vesuvio179. Se, dunque, «..la Rettificazione delle Finanze
raggirasi a livellare, ed equilibrare i pesi dello Stato», «..la Rettificazione
della loro Polizia raggirasi nommen ad evitare tutte le spese superflue ed
eccessive, che il restituire utilmente allo Stato tante braccia, che gli sono
inutili; anche di pernicioso carico»180. In questo contesto è indispensabile,
come sostiene anche Giannone, una «nuova Polizia della Milizia»181. La
milizia, infatti, nel corso del tempo si è “rivolta” agli stranieri, mentre
manca un battaglione di difesa terrestre e uno per la «nuda difesa pe’
Mari», formato da soldati, che oltre a sentir vivo il valore della patria,
perché “nostrani”, porterebbero spese assai meno rilevanti per le casse
Ivi, p. 184.
Ibid.
175 Ivi, p. 186.
176 C. L. de Secondat de Montesquieu, Lo spirito delle leggi, cit., vol. II, XX, cap. 13,
p. 658.
177 N. Fortunato, Riflessioni, cit., p. 188.
178 Ivi, p. 193.
179 Ivi, p. 194.
180 Ivi, p. 196.
181 Ivi, p. 199.
173
174
70
Logos
dell’erario regio. Fortunato insiste sul ruolo centrale che riveste il
Calcolatore politico, e sui benefici che ne potrebbero derivare. Evidente il
riferimento al catasto voluto e promosso da Carlo di Borbone, che
consente di conoscere e calcolare i livelli di produttività di ciascuna
industria, il suo grado di salute, il numero esatto delle braccia utilizzate, il
numero di abitanti per provincia, le attività che svolgono, la condizione
sociale, il tasso di mortalità, le ragioni che lo determinano, e tutte le
indicazioni utili ai saperi di governo. Il sovrano deve poi favorire la
«cultura degli ingegni», mirare all’aumento delle industrie, promuovere gli
specialisti e indirizzare tutti verso le professioni utili, per le quali sono
effettivamente tagliati. È questa, evidentemente, la base reale di partenza
da cui muovere per realizzare un progetto avanzato di scienza di governo
delle finanze, in una parola di saggia polizia. Il 7 marzo 1741 è la data in
cui sono pubblicate le fondamentali istruzioni della Regia Camera per la
formazione dei catasti. Esse contengono indicazioni precise per le Riivele,
per descrivere ciò che si possiede e «qual peso si soffra su tai beni» 182, ma
anche importanti normative per snellire le procedure commerciali:
l’abolizione, ad esempio, di alcune figure superflue come l’assistente di
caricamento e i guardiani dei Porti, che gravano economicamente sulle
spese dei commercianti e rallentano le attività portuali183. Le istruzioni
prevedono, inoltre, che nessuno nella medesima dogana o porto,
«potesse tenere due o più Offici tra loro incompatibili» e, per evitare la
pratica odiosa delle estorsioni da parte degli «Officiali delle Dogane» fissa
una tariffa unica da esigersi da parte dei Maestri Portolanoti, o regi
segretari, o dai loro luogotenenti, e da tutti indistintamente i Credenzieri
generali184. Alcuni tra i regolamenti più significativi riguardano
principalmente la marina e il commercio: impongono che si stabiliscano
«i diritti da pagarsi per le patenti da ispedirsi», che queste patenti
dovessero durare due anni, che ove mancassero i consolati dei porti
all’atto dell’approdo, ci si dovesse rivolgere a quello più vicino ecc..
Questi regolamenti trasmessi attraverso un bando suppliscono, di fatto,
un «Codice speciale in forma di legge perpetua concernente all’utile
navigazione, ed al felice commercio», in via di redazione185. L’affare poi
del Catasto, osserva in conclusione Grimaldi, «era molto importante per
la nuova polizia, che doveva praticarsi in appresso, onde fa di mestieri,
che tutta l’applicazione vi si ponesse dal Tribunale della camera, che cura
Id., Istoria delle leggi, cit., p. 32.
Ivi, pp. 33-34.
184 Ivi, p. 35.
185 Ivi, pp. 38-39.
182
183
Polizia, economia, ragion di Stato. Il regno nelle Riflessioni di Nicola Fortunato
avea di disimpegnarlo»186. Il catasto, dunque, si compone di XXVI
Formularj nei quali inserire tutte le indicazioni utili riguardanti le varie
attività delle singole classi di cittadini. Fortunato, tuttavia, guarda
attentamente e in modo particolare soltanto al codice speciale rivolto alla
navigazione e al commercio che deve costituire, evidentemente,
l’ossatura centrale del Calcolatore politico. C’è, però, da osservare che
Galanti, pur apprezzando la scelta politica di Carlo di Borbone di
riordinare la finanza pubblica istituendo il catasto, ritiene ancora
parzialmente inadeguato lo sforzo del sovrano borbonico. Il Calcolatore
politico, nei termini in cui è progettato da Carlo, non scioglie in modo
adeguato il grosso nodo della proprietà feudale né quello del privilegio
legato alla rendita parassitaria. Anche Grimaldi, seppure di sfuggita,
sottolinea come un atteggiamento prudente nei confronti della chiesa
abbia in parte determinato alcune scelte del sovrano borbonico187. D’altra
parte, come ho avuto già modo di sottolineare, Fortunato propone una
via d’uscita dalla questione feudale del tutto diversa rispetto a quella
indicata da Galanti nel Testamento forense188. La cura commerciale in
Inghilterra è affidata a società di vario genere, Collettive, Anonime, in
Comandare189. Al contrario, la «nostra Piazza mercantile» è un vero e
proprio mostro, priva di efficaci regole di polizia, letteralmente ostaggio di
affaristi e speculatori di ogni genere190. Ciò rende indispensabile la
vigilanza dell’autorità pubblica che, come già messo in rilievo, deve
configurarsi come un esercizio di controllo delle attività dei sudditi
costante nel tempo, secondo le modalità indicate da Fortunato. Questi
spera, a sua volta, che la reggenza possa efficacemente guidare la politica
di Ferdinando IV, inducendolo a proseguire quella paterna, rivelatasi
saggia, ma rimasta purtroppo incompiuta. Ferdinando IV, con
l’istituzione del Consiglio di commercio fornisce «…il primo segno che
allude alla Pubblica economia, e polizia del Regno»191. Al di là di questo
riconoscimento, sulle iniziative di Ferdinando cala un silenzio eloquente,
tanto più perché il consiglio di commercio è un’istituzione già voluta e
realizzata da Carlo di Borbone, evidentemente solo riproposta dal
successore nei termini e secondo i criteri già stabiliti dal sovrano
Ibid.
Ibid.
188G. M. Galanti, Testamento forense o saggio sul decadimento del foro napoletano, Venezia,
s.e., 1806, ristampa anastatica, Napoli, Bibliopolis, 1977. Nel Testamento Galanti propone
alla corona di avocare a sé le rendite parassitarie di ogni tipo e di procedere ad una
nuova redistribuzione dei terreni e delle proprietà.
189 N. Fortunato, Riflessioni, cit., p. 207.
190 Ivi, pp. 207-208.
191 Ivi, p. 38.
186
187
72
Logos
borbonico. Non a caso Fortunato distingue la saggia polizia che incide nel
sociale, dalla polizia speculativa, progetto teorico astratto, puro flatus vocis
che non ha alcuna ricaduta concreta nei processi di riorganizzazione
economico-istituzionale. Egli, piuttosto, proponendo una serie di esempi
di amministrazione saggia, sembra indicare a Ferdinando la via da seguire
per interpretare nel migliore dei modi il significato politico dell’azione di
governo di Carlo di Borbone192. In questo contesto la politica savia di
Pietro il Grande ha senz’altro valore normativo di esempio. Questi
incontra un ginevrino, le Firt, «che trovavasi a caso tra le Truppe
Moscovite», e gli «carpisce i primi rudimenti di polizia, degli armi, della
navigazione, delli splendori, e magnificenze dell’altra Corte di
Europa…»193. Pietro, poi, opera con «Generosi Augusti Stimoli» per
raggiungere, innanzi tutto, i cuori dei sudditi. Se a Carlo di Borbone si
debbono alcune fondamentali iniziative, Benedetto XIV è l’autorità che
meglio interpreta la lezione di Luigi XIV. Il glorioso pontefice promosse
lodevoli ordinamenti di economia e polizia nello Stato della chiesa,
soprattutto opere pubbliche, con interventi sul territorio, per rendere
comode e sicure le pubbliche strade; dispose di affrancare i porti di
Ancona e Civitavecchia, di liberalizzare la coltura del tabacco, di
introdurre le manifatture di seta e di lana, e dunque non a caso Galiani ne
Numerose sono le orazioni funebri in cui si esalta la figura e l’opera di Carlo
III. In quella recitata da Pietro Di Felice, Carlo è il sovrano portatore di «civile felicità a’
suoi Regni» attraverso la «politica cristiana». Scopo del generoso e grande monarca fu
quello di «mettere a dovuta armonia il civile governo de’ suoi Stati» movendo innanzi
tutto dal riordino della legislazione, promovendo così la «pubblica gioja» e la «sicurezza
pubblica». Fondamentali sono le opere pubbliche che a lui si devono, la rinascita dei
luoghi d’arte e quanto conduce a «render felice e pulita una nazione». Il «famoso
Reclusorio» eletto da Carlo nella «Dominanza» è il luogo dove i poveri apprendono
anche «ogni genere di arti»: a vantaggio dei poveri, degli artigiani, e dei contadini, Carlo
riesce anche a ottenere dal pontefice la diminuzione delle festività. La polizia cristiana del
sovrano discende direttamente dall’applicazione del dettato delle Scritture ed è sorretta
da ineguagliabile pietas. Cfr. Orazione recitata nella cattedrale di Capua da Pietro Di Felice,
Napoli, presso Pietro Perger, 1789, pp. 3-6, 10-15. Il duca di Monestarace osserva:
«Non fu al giunger di Carlo, e della brillante sua corte, che il rancido zotichismo dell’età
scorsa da voi si partio? Quando fu che rinacquer tra voi colla polizia le bell’arti, colla
leggiadria le scienze, e colla fatica anche i premj?». Il duca, dopo aver sottolineato il
valore politico dell’azione di governo del sovrano, conclude esaltandone la condotta
come fons et origo di positivo esempio da trasmettere ai sudditi. Carlo segue il «cristiano
costume di non chiudere al sonno le luci pria di esaminar sua coscienza del di compito
sulla sincera condotta (?)». Cfr. Orazione del duca di Monestarace D.Domenico Perrelli detta nel
dì 4 marzo 1789 per la solennità de’ funerali dell’Augusto Monarca delle Spagne Carlo III di
Borbone, Napoli, F. Raimondi, 1789, pp. 8-15.
193 Ivi, p. 241.
192
Polizia, economia, ragion di Stato. Il regno nelle Riflessioni di Nicola Fortunato
celebra ed esalta le virtù politiche194. L’analisi politica dei mali del regno
termina praticamente qui. Mi sembra che Fortunato elabori un progetto
politico-economico non meno determinate, se non addirittura per certi
aspetti maggiormente innovativo, rispetto ai contributi prodotti da
Galanti e dai pensatori politici meridionali assai più noti di lui. Averlo
ignorato, al pari di altri, è scelta che probabilmente ha pesato non poco
sui destini del mezzogiorno.
194
Ivi, p. 281.
Antonio Gisondi
«Sana filosofia e sofistica prussiana», «principessa
di sangue e vera regina»
La filosofia italiana tra due «patriarchi»
«Egli non si chiamava Pietro, com’ei sosteneva, ma si chiamava
Paolo, come non s’era fino ad allora udito appellar mai da veruno».
Con questa metafora, di una confusione in apparenza solo
nominalistica, sul n. 33 del «Progresso» di Napoli, del febbraio 1837,
Rosmini «fa querela» e manifesta tutto il suo stupore al Baldassarre-Poli
che, nei Supplimenti al Manuale di storia della filosofia del Tennemann, lo
aveva «collocato nella setta o classe dei Razionalisti e degli Idealisti»1.
Metafora, quindi, di una confusione teoretica, a Rosmini apparsa solo
storiografica. Insieme all’esame di altri testi rosminiani, essa sollecita un
tentativo di rilettura di alcuni aspetti del serrato dibattito tra spiritualismo
ontologistico, idealismo nelle sue diverse forme e «positivo naturale» e
«umano». Dibattito che si sviluppa tra gli anni Sessanta e Settanta, con
ben noti interventi di Bertrando Spaventa, Tommasi e Villari, apparsi su
varie riviste, da «Il Morgagni» alla «Rivista italiana», dal «Giornale
napoletano di filosofia e lettere» alla «Rivista Bolognese».
Lo stupore di Rosmini-Paolo è notevole perché, commenta egli
stesso, «sarebbe un po’ strano il caso ch’io stesso ignorassi il mio nome e
che altri il sapesse». Che fosse, quindi, Paolo, cioè idealista e razionalista,
anziché Pietro, «ristoratore della sana filosofia» ontologica, saldamente
fondata sull’intendimento dell’idea dell’essere, come aveva sempre
affermato. Se il razionalismo teologico «rifiuta ogni mistero superiore alla
ragione umana» e quello filosofico come l’hegeliano «tutto dà
all’elemento razionale è chiaro a tutti», dice Rosmini nella “querela”,
«come il mio sistema non solo differisca dal razionalismo, ma di più
come sia fors’anche il solo che l’abbatte fin dalle radici». E continua:
La “querela” di Rosmini fu pubblicata anche dal «Raccoglitore» di Milano, dello
stesso anno, e riportata infine nella Introduzione alla filosofia, del 1850, nella quale Rosmini
raccolse diversi suoi studi composti dal 1825 in poi. L’opera è ripubblicata ora come
secondo volume della edizione nazionale delle Opere di Antonio Rosmini, a cura di P. P.
Ottonello, Roma, Città Nuova, 1979, pp. 355-363. Il riferimento polemico della
“querela” è il Supplimento IV del Manuale della storia della filosofia, di Guglielmo Tennemann,
tradotto da Francesco Longhena, con note e supplimenti dei Professori Giandomenico Romagnosi e
Baldassarre Poli, Milano, Fontana, 1832-1833, voll. 2.
1
76
Logos
«tanto è lungi che io riduca tutto alla ragione, che anzi sono forse l’unico
che abbia trovato qualcosa che l’altezza della ragione possa emulare, e
con essa per così dire aver comune impero». La sicura autoesclusione dal
razionalismo resta valida anche volendo attenersi alla definizione che di
esso dà lo stesso interlocutore, per il quale, infatti, è razionalista quel
sistema che «usa della sola ragione a conoscere l’essenza od i principi
delle cose». L’inclusione, poi, nella “setta degli idealisti” sorprende
Rosmini ancor più perché, se idealisti sono «quei sistemi che negano la
realità esteriore», un sistema «idealista oggettivo-reale», come nei
Supplimenti è stato classificato il suo, equivale «a idealista-non idealista.
Che è una contraddizione». «La questione - conclude Rosmini - si è: se
egli stia bene ad uno storico della filosofia, volendo distribuire in varie
classi i filosofi, il dar loro un nome ch’essi non diedero a sé medesimi» o,
precisando ulteriormente, «se uno storico della filosofia possa mutare il
significato ai nomi, che contraddistinguono i sistemi nell’uso comune».
A Rosmini, pertanto, la questione appare solo di confusione
nominalistica o di arbitrio dello storico, che può prevalere, purtroppo, in
attesa del «sistema definitivo» della «perfetta filosofia».
Sia lo stupore per l’inclusione in quella setta che la questione ultima,
l’arbitrio dello storico, sono espressi da Rosmini nel 1837, quando, cioè,
il suo «nuovo sistema del sapere», teso appunto alla definizione della
perfetta filosofia, è già delineato e pubblico, nelle sue strutture
fondamentali, con il Nuovo Saggio (1829-1830). In questo è ormai
precisato il rapporto di ancillarità tra la serva Agar-filosofia e la padrona
Sara, sapienza cristiana o teologia, poi ripreso e definito nel 1850 in Degli
studi dell’autore2. A conclusione di questo scritto Rosmini riporta quasi alla
lettera l’immagine kantiana, conosciuta sin dal giovanile Esame della
ragione, del 18163, «dell’ambiziosa pretesa» della «facoltà superiore»,
teologale, nei confronti della «inferiore» filosofica. Mentre, però, Kant
descrive, criticandolo con compiaciuta ironia, l’antico rapporto tra
l’«ancella-filosofia che precede col lume la gentile padrona» o «la segue
reggendo lo strascico», la quale «signora» spesso arriva persino «a cacciare
di casa l’ancella o le tappa la bocca»4, Rosmini non solo conferma
l’ancillarità della serva, ma conviene anche che questa, «se insolentisce o
Questa “autobiografia intellettuale” fu stesa da Rosmini tra maggio e luglio del
1850, quale introduzione al primo volume della collezione delle sue Opere edite e inedite e
riprodotta poi nella già citata Introduzione alla filosofia.
3 Ora in A. Rosmini, Saggi inediti giovanili, t. I, vol. 11 della Edizione nazionale, a
cura di V. Sala, Roma, Città Nuova, 1986, pp. 27-90.
4 I. Kant, Il Conflitto delle facoltà, trad. it. a cura di D. Venturelli, Brescia,
Morcelliana, 1994, p. 83.
2
«Sana filosofia e sofistica prussiana», «principessa di sangue e vera regina»
insuperbisce», è «anco giustamente cacciata di casa». Se è ignobile, quindi,
«per amor della serva a dimettere la padrona», Rosmini, preoccupato,
avverte il bisogno di sollecitare, però, la cultura cattolica a riflettere ormai
attentamente sulla constatazione, anche autocritica, che, sebbene «amica
e fedele ancella della Teologia», cacciata di casa e ripudiata «la serva non
cessa perciò di vivere… e siccome fanciulla derelitta dai suoi genitori e
dai suoi tutori per pane vende a chi ella incontra l’onestà e il decoro»5.
Non è solo, o innanzitutto, la consapevole responsabilità per il facile
traviamento dell’ancella che genera la premura rosminiana. In alcuni
settori della stessa cultura cattolica è matura ormai anche la convinzione,
espressa allo stesso Rosmini dall’amico papa Pio VIII nel 1829, che «gli
uomini al presente voglion esser guidati al bene e alla fede stessa dalla
ragione». A sottolineare ulteriormente quella preoccupazione autocritica,
Rosmini aggiunge che, se questa «è invero sdrucciola per natura», ciò non
toglie che la responsabilità «di ricomporre e ristabilire […] l’unità dei due
rami del sapere» spetti interamente alla padrona, sempreché non ceda alla
baldanza dell’opposta setta dei teologi razionalisti. «La perfezione stessa
della filosofia», che consentirà allo storico «una classificazione perfetta
dei sistemi filosofici e una storia della filosofia», è data dalla
collaborazione della «serva, che non insuperbisca», con la padrona!6.
In attesa di questa perfezione o compimento, che avverrà quando la
filosofia tutta sarà «ridotta ad un semplice principio», i sistemi, per ora come Rosmini aveva scritto già nel 1825 nella lettera a luigi Bonelli 7 Sulla
classificazione dei sistemi filosofici - possono definirsi in base «ai nomi degli
inventori» o anche in base «alla diversità dei principi che pongono».
Questi, a loro volta, si possono suddividere considerando le «differenti
opinioni dei filosofi» intorno alla «potenza del conoscere» o agli «aiuti
esterni» necessari a tale potenza. Rosmini stesso, però, sulla base di tali
differenze, necessariamente ancora precarie, aggiunge anche: «non mi
pare che si possa dir nulla di fermo e senza equivoco sopra i veri sistemi
di filosofia», perché si incontrano «tante difficoltà anche solo in
convenire» in cosa essi differiscano tra loro. Occorre, perciò, considerare
«i sistemi dei filosofi con l’occhio più favorevole», per cui spesso «basta
aggiungere in luogo di mutare, e ricondurre alla naturale interezza i germi
che essi hanno posti in luogo di distruggerli e gettarli di nuovo». Come
succede quando i filosofi trattano argomenti diversi e credono di trattare
lo stesso8.
A. Rosmini, Degli studi dell’autore, cit., pp. 42 e 194.
Ibid.
7 Si può leggere ora in Id., Introduzione, cit., pp. 337-351.
8 Ivi, p. 349.
5
6
78
Logos
Nonostante l’impegno teso a definire una provvisoria metodologia
della classificazione storica dei diversi sistemi del sapere, in attesa di
quello definitivo che sarà tale perché avrà colto il principio unico della
filosofia, Rosmini appare idealista anche al primo Gioberti, e per il
momento con favore, non con l’intento fortemente critico che
contrassegnerà, di lì a poco, l’impegno antirosminiano della cultura
cattolica ufficiale e, con divergenti premesse e conclusioni, anche dello
stesso Gioberti. In prevalenza la filosofia cattolica, non solo in Italia, è
ormai impegnata a «restaurare» il tomismo come unico rimedio per
contrastare i sistemi filosofici fondati sulla sola ragione umana postcartesiana. Tra i quali, oltre al sensismo scettico-materialistico e al
criticismo, i tomisti - in particolare Matteo Liberatore, con Della
conoscenza Intellettuale (1855), e «Civiltà cattolica», sin dai suoi primi anni
napoletani - includono anche il razionalismo, sia come ontologismo che
come idealismo, inteso questo nelle sue diverse forme. Se Rosmini, dice
Liberatore, ha il merito di aver combattuto il sensismo, poi, però,
«estimò potersi mettere impunemente per la via medesima del pensatore
alemanno [Kant] prendendo le mosse dal suo punto capitale intorno agli
elementi apriori della conoscenza»9.
L’inclusione di Rosmini nella setta dei razionalisti e degli idealisti,
fatta dal Baldassarre-Poli, non costituisce, pertanto, una novità assoluta o
una classificazione isolata. Ancora per molti, e per molto tempo - fino
alla recente Nota della Congregazione per la dottrina della Fede del 2001,
firmata dal suo Prefetto, l’allora cardinale Ratzinger10 -, se l’opera di
Rosmini è riproposta allo studio libero dai «pregiudizi» che ne
determinarono la condanna del 1888, comunque i lettori sono avvertiti
che, spesso, egli-Pietro, senza saperlo, può essere confuso con Paolo.
L’autorevole Nota del 2001, insieme ad elementi di autocritica, ancora
sente il bisogno di mettere in guardia, infatti, dalle «rischiose arditezze»
idealistiche rilevabili in Rosmini. Che, invece, sin dal già citato Esame della
ragione, aveva sottolineato con molta forza che il suo percorso di indagine
intendeva segnare consapevolmente un distacco critico netto da ogni
forma di razionalismo: da quello dei teologi del «crollato edifizio della
scolastica», in particolare dei gesuiti, maestri di Voltaire, che per aver
esaltato troppo i poteri della ratio hanno spalancato le porte allo
scetticismo e alla déraison degli esprits forts; da quello critico-kantiano che,
9 M. Liberatore, Della conoscenza intellettuale, Napoli, 1855; cfr. seconda edizione,
Napoli, 1857, vol. I, p. 261.
10 Congregazione per la dottrina della Fede, Nota sul valore dei Decreti dottrinali
concernenti il pensiero e le opere del Rev.do Sacerdote Antonio Rosmini Serbati, a firma di J. Card.
Ratzinger - T. Bertone, pubblicata in «L’Osservatore Romano», Roma (1 luglio 2001).
«Sana filosofia e sofistica prussiana», «principessa di sangue e vera regina»
deprimendo le possibilità della ragione «tapinella», alimenta il
soggettivismo, così come da quello idealistico-assoluto che la eleva a
cornacchia idealistica e fa dello spirito umano finito una «virtù» radicale,
capace di pensare e conoscere l’universale perché lo crea. Il nuovo
sistema del sapere, invece, può far uso della ragione naturale solo se
illuminata dall’agostiniano «lume interiore» e se è sostenuta
dall’intendimento dell’idea dell’essere. Senza «un seme seminato dal
creatore», senza l’intendimento dell’idea dell’essere, la cognizione umana
non è certa, perché la percezione sensibile non supera i limiti del
sensismo scettico e la percezione intellettuale resta preda del
razionalismo astratto, in quanto fondate entrambe solo sulla ragione
naturale. Razionalismo e idealismo da un lato, soggettivismo criticoscettico dall’altro, restano, appunto, vittime di un eccesso o di un difetto
della ragione umana, mentre la sana filosofia, sostenuta da quel seme e
dall’intendimento, supera ambedue quei limiti e consente di costruire il
nuovo sistema del sapere nel quale la scienza (Agar) e la sapienza
cristiana (Sara) sono conciliate, ciascuna nel suo ordine, anche sul piano
filosofico-razionale. Conciliazione che, come è noto, fu il principale
impegno di Rosmini, «ristoratore della sana filosofia» cattolica.
Dalla reazione «baldanzosa» al difetto della ragione kantiana tapinella
nasce, invece, l’eccesso faustiano della cornacchia idealistica, con la quale
Fichte, «allievo» di Kant, proverà, infatti, a «creare lo stesso Dio».
La «discendenza» kantiana della «filosofia prussiana» è individuata
con nettezza da Rosmini sin dall’inizio di tutta la sua vasta impresa di
ristorazione. Ed è definita esemplarmente in quella sorta di rapido
profilo genealogico dell’idealismo che egli delinea nella Lettera ad
Alessandro Pestalozza, del 184511, nella quale profeti e protagonisti della
faustiana «assolutizzazione del pensiero», Fichte, Schelling ed Hegel,
diventano, quindi, anche «allievo», «nipote» e «bisnipote» del «patriarca»
Kant. Si tratta di una genealogia non univoca, da allora in poi, che
interessa direttamente questa indagine perché, pur soggetta a molteplici e
rinnovantesi varianti interne, elaborate sia dalla stessa storiografia
idealistica che da quella neo e post-idealistica, essa resta per lungo tempo
sullo sfondo, sia pure in lontananza, del confronto tra spiritualismo,
idealismo e positivismo. E non solo in quei due decenni centrali
dell’Ottocento. Vi resta, infatti, fino a quando la filosofia italiana ha
saputo guardare al criticismo trascendentale e a Kant (a Rosmini molto
meno) da altre prospettive come la neokantiana, la positiva e la
11
Riportata poi in A. Pestalozza, Elementi di Filosofia, Milano, 1850, pp. 540 e ss..
80
Logos
storicistica, consapevolmente estranee a tutte le varianti del modello
idealistico e neoidealistico12.
Bertrando Spaventa, impegnato a sua volta nella divergente
“ristorazione” idealistica della filosofia italiana, già nel 1856 si imbatte
nella classificazione, teoretica ben prima che storiografica o
nominalistica, del nuovo sistema elaborato dallo stesso Rosmini. E, a
modo suo, prova direttamente a ricondurne alla naturale interezza
idealistica gli stessi germi svolgendoli, cioè, criticamente per poterne far
tesoro ai fini del compimento del patriarca Kant e della genealogia che da
lui trae origine. Spaventa non muta quei germi, né vi aggiunge alcunché:
criticamente li svolge cogliendo in essi la inconsapevole ma feconda
matrice idealistica, facendone emergere anche lui il Rosmini-Pietro,
presente e vivo ma nascosto da Paolo. Nella altrettanto rapida e
documentata configurazione genealogica dell’idealismo Spaventa, quindi,
colloca Rosmini stesso all’origine di quella discendenza e proprio nel
medesimo ruolo primario di allievo, occupato già pure per lui, ma con
ben altre credenziali, da Fichte. L’identica collocazione dei due allievi
rispetto al patriarca non nasconde affatto, però, a Spaventa - a differenza
del Baldassarre-Poli, del primo Gioberti e dei tomisti - le divergenze
interne alla loro lettura del criticismo trascendentale: quella fichtiana
avvia il compimento idealistico di Kant, quella rosminiana, invece, è
capace di originare persino un’altra genealogia della filosofia italiana che,
perciò, pone subito allo stesso Spaventa il problema di verificare «quale
delle due sia la più legittima», dal punto di vista idealistico, teoretico e
storiografico13.
Mosso da tale esigenza di ristorazione idealistica della filosofia
italiana, Spaventa si impegna a realizzare lo svolgimento critico del
rosminianesimo per verificare se, liberato dai residui ontologici e religiosi
che ancora lo condizionano, possa essere “legittimato”, appunto, come
“germe” di matrice kantiana, capace di fecondare quella ristorazione. Per
il momento Spaventa sembra accogliere, in parte, la prudente
metodologia di “classificazione” dei sistemi filosofici proposta da
Rosmini, la quale, in attesa di quello “definitivo”, deve essere rispettosa
dei loro “germi da ricondurre alla naturale interezza”, senza affatto
Non è il caso di richiamare la vasta bibliografia sulla crisi del modello idealistico
e della sua “lunga marcescenza”: si rinvia soltanto a raccolte di studi collettivi recenti: Il
neoidealismo italiano, a cura di P. Di Giovanni, Palermo, 1988; Giovanni Gentile. La filosofia
italiana tra idealismo e antiidealismo, a cura di P. Di Giovanni, Milano, Franco Angeli, 2003;
Idealismo e antiidealismo nella filosofia italiana del Novecento, a cura di P. Di Giovanni, Milano,
Franco Angeli, 2005.
13 B. Spaventa, La filosofia di Kant e la sua relazione colla filosofia italiana, del 1856, ora
in Id., Opere, a cura di G. Gentile, Firenze, Sansoni, 1972, vol. I, p. 176.
12
«Sana filosofia e sofistica prussiana», «principessa di sangue e vera regina»
“mutare o aggiungere”. Lo “svolgimento critico” del rosminianesimo
sembra muoversi, appunto, in questa direzione. Seguiamo il filosofo
abruzzese: Rosmini in Italia come Fichte in Germania sono alla stessa
altezza di discepoli del comune ‘maestro’. Da un lato «Rosmini e Kant
dicono la stessa cosa»: ambedue ammettono un apriori e lo stesso
problema fondamentale della filosofia. Kant, però, ammette un apriori
vero, che non è un concetto o categoria ma l’attività sintetica originaria.
Di questa Rosmini, come vedremo meglio in seguito, coglie l’energia
portentosa che sprigiona, restandone attratto e turbato allo stesso tempo,
ma ne attribuisce, però, la “virtù radicale”, produttiva della certezza delle
cognizioni, all’idea dell’essere oggettivo, intuìta con l’intendimento.
Spaventa, del resto, è ben consapevole che per Rosmini quella energia,
come «percezione intellettuale» e creatività dello spirito, non può essere
prodotta per sintesi meccanica tra sensazione e categoria, che resta
semplice percezione sensitiva, né per processo logico-dialettico o
autoctisi idealistica14. D’altro lato, per lo stesso Spaventa i due “allievi”
leggono il kantismo in maniera opposta. Rosmini si rivela subito
“allievo” incapace di varcare per via idealistica i consapevoli confini,
appunto preidealistici e/o antidealistici, nei quali lo stesso “patriarca”
aveva rinserrato «l’immaginazione produttiva» dell’apriori. Rosmini, in
effetti, si rifiuta di imboccare la via idealistica di uscita dal criticismo e dal
soggettivismo, proprio perché questa comporta il riconoscimento
dell’onnipotenza dello spirito e del pensiero umano. Confini varcati,
invece, e con decisione, secondo Spaventa, dall’altro più audace allievo,
che scopre nell’unità sintetica originaria la creatività dello spirito e il farsi
dialettico dell’autocoscienza assoluta (Thathandlung). «Così in Kant come
nel Rosmini - commenta Spaventa - ci è il concetto dell’unità dello
spirito, ma… ancora oscuro, incompreso». Entrambi, infatti, fanno dei
due elementi di quella unità, l’intuizione sensibile e il concetto puro, «una
semplice applicazione estrinseca d’una cosa ad un’altra», perché manca
tra di loro «il ponte di passo, l’unità sintetica originaria che ponendo gli
opposti gli unifica e così pone se stessa». È in questo modo, invece,
afferma Spaventa con sicurezza nelle lezioni napoletane del 1860-61, che
«l’uno si dualizza e dualizzandosi si unizza», superando, così, ogni
residuo di dualismo ontologico-religioso o kantiano15. «Questo difetto
della filosofia di Kant è notato e posto in chiaro da Fichte, che rinnova e
comprende meglio il concetto di unità sintetica originaria della coscienza
Ivi, pp. 211-212.
Id., Prolusione e introduzione alle lezioni di filosofia, Napoli, Vitale, 1862, ora con il
titolo La filosofia italiana nelle sue relazioni con la filosofia europea, in Id., Opere, cit., vol. II, pp.
573-572.
14
15
82
Logos
che è, perciò, posizione di se stessa, è l’Io, la coscienza di sé,
l’autocoscienza»16. Kant e Rosmini, perciò, dicono la stessa cosa; Fichte,
invece, corregge e completa Kant. Pone, quindi, le premesse per
“correggere e completare” idealisticamente anche Rosmini. Lavoro di
“svolgimento critico” affrontato e realizzato appunto da Spaventa che,
attestato saldamente, per ora, nella genealogia del patriarca, ritiene di
“ricondurre alla loro naturale interezza i germi” del sistema rosminiano,
sviluppandone l’intrinseca fecondità idealistica.
Il divergente rapporto dei due “allievi” con il comune “patriarca”,
nonostante la “legittimazione” idealistica di Rosmini, darà luogo,
comunque, a due opposte genealogie della filosofia italiana, destinate
ambedue a fortune e sfortune, ma anche ad incontri e scontri, a incroci
impropri o confuse sovrapposizioni e rotture nette tra di loro. Ancora
oggi, nei limiti della loro sopravvissuta vitalità e delle loro mutate forme,
esse continuano ad affaticarsi alla ricerca della chiarificazione delle
proprie comuni e/o divergenti origini e/o vittime della loro oscurità17.
Confusione in parte originata dallo stesso lavoro di “legittimazione”
operato da Spaventa. È vero che, consapevolmente impegnato nella
ricerca dell’assoluta unità e immanenza dell’essere-pensiero, egli affronta
lo “svolgimento critico” di Rosmini e la “riconciliazione di Gioberti con
se stesso”, per poi distaccarsi decisamente da entrambi, indicando e
tracciando, comunque, le coordinate, la “genealogia” di un percorso di
indagini che, sebbene, appunto da lui stesso poi abbandonato, in modi
diversi sarà ripreso in seguito dagli idealisti ortodossi e/o critici rimasti a
lui “fedeli”. O che almeno si ritennero tali. Alla ricerca della stessa unità
questi, spesso, procedono inseguendo quella confusa sovrapposizione di
trascendenza ontologica, di origine appunto rosminiana e/o giobertiana,
e di immanenza logico-idealistica, che aveva determinato il convinto
abbandono di Spaventa, sia pure dopo qualche laborioso indugio.
Confusione rilevata, come è noto, dal giovane «erudito» Benedetto
Croce, che la segnalò con sorpresa e stupore al «giovane filosofo già
affermato», Gentile, sin dalle lettere dell’autunno del 1898, e ne individuò
la fonte proprio nel «teologismo chiesastico» e nel «fanatismo
rosminiano-giobertiano», che aveva occupato per troppo tempo la mente
Ivi, p. 566.
Per un ultimo e significativo percorso di ricerca in questa direzione, vedi P. De
Lucia, L’istanza metempirica del filosofare. Metafisica e religione nel pensiero degli hegeliani d’Italia,
Genova, 2005.
16
17
«Sana filosofia e sofistica prussiana», «principessa di sangue e vera regina»
dello zio Bertrando e, poi, dei suoi “fedeli” e scolari18. Anche questi,
quindi, alla ricerca dell’unità e della verità definitiva, che per il maestro
era, però, assolutamente immanente. Ma Gentile, tramite quei “fedeli”,
Jaia e Maturi, è e si sente l’erede diretto del complesso patrimonio
spaventiano. Sin dal lavoro di tesi è da questi, perciò, sollecitato a
riprendere, con convinzione ed entusiasmo, lo “svolgimento” critico di
Rosmini e Gioberti abbandonato da Spaventa, fino a formulare, di lì a
poco, il nuovo idealismo che, «inteso bene» - come avviene con la
prolusione napoletana del 1903, La rinascita dell’idealismo - non può che
essere l’attualismo.
Lo stesso Spaventa, invece, aveva ben colto quella confusione: al
Kant italiano, egli dice, succede Gioberti, che non solo «compie
Rosmini», ma è anche «un po’ confusamente e con un po’ di
abborracciatura tutto insieme, Fichte, Schelling, Hegel». Per cui in questa
linea, nella inesausta e mai soddisfatta pretesa di conciliare per via
filosofico-razionale immanenza e trascendenza, fino alla «marcescenza
del cerchio troppo magico dell’idealismo attualistico» del Novecento
inoltrato, nonostante condanne ex cathedra, ripensamenti critici e abiure
più o meno sofferte, continueranno a incontrarsi e a scontrarsi
ontologismo rosminiano e giobertiano, idealismo ortodosso e critico, ma
anche attualismo cattolicizzante e spiritualistico, tenuti assieme da un
comune sentire antipositivistico e, quasi sempre, avverso alle ‘scienze
empiriche’. Trovandosi perciò spesso, oggettivamente, nella involontaria
e non gradita compagnia dei restauratori del tomismo. Nell’altra linea,
invece, concludeva Spaventa con tacita adesione personale, senza alcuna
«oscurità» o «confusione», «Fichte, Schelling, Hegel compiono Kant».
Questa è, infatti, la linea che egli stesso privilegerà per completare
quell’opera d’individuazione e definizione di una matura filosofia italiana,
in particolare a partire da Fichte e da Hegel. E questo è il compito che
egli si assegna, specialmente dopo il conclusivo studio critico su Gioberti,
uscito nel 1863, ma definito già prima dei corsi napoletani del 1861. Poi,
però, abbandona anche questo, quando diverrà prevalente pure per lui il
forte interesse per le ‘scienze positive’, da Gentile avvertite ancora nel
1903 come «belle e spensierate baccanti». Nonostante ciò, il fascino e la
fecondità di questa linea maestra o genealogia ufficiale resteranno, però,
sempre vivi in Spaventa. Ancora in Kant e l’empirismo (1880)19 si
18 Fondamentale resta, oltre all’epistolario, il racconto autobiografico di B. Croce,
Contributo alla critica di me stesso, del 1915, ora in Id., Etica e politica, Bari, Laterza, 1967,
pp. 311-383.
19 Pubblicato in «Atti dell’Accademia di scienze morali e politiche» di Napoli, vol.
XVI, ora in Id., Opere, cit., vol. I, pp. 259-291, cfr. p. 285.
84
Logos
rammaricherà che «quella linea sia stata lasciata del tutto», buttando via,
«come si dice, l’acqua sporca col bambino». Nell’ampia analisi della
filosofia giobertiana, uscita nel 1863 ma elaborata già nel 1859-60,
facendo tesoro delle Postume, nonostante la loro «farragginosità»,
Spaventa assesta un colpo definitivo al “fanatismo giobertiano”
ortodosso imperante a Napoli e prova ancora a recuperare, almeno in
parte, lo stesso Gioberti alla linea maestra Fichte-Hegel, perché gli
sembra giunto finalmente alla scoperta del divenire, sia pure metessico,
dello spirito. Condanna, così, senza stroncare del tutto, le speranze molto
diffuse e alimentate da più fronti, tendenti a conciliare, confusamente
appunto, le dottrine filosofico-religiose del primo Gioberti con
l’idealismo, in particolare con l’hegelismo dei grandi maestri teologi di
Tubinga, e con la diffusa esigenza di rinnovamento filosofico-razionale
(idealistico) delle dottrine cattoliche.
Nei quattro interventi sulle Psicopatie in generale - pubblicati tra
febbraio, marzo, maggio e giugno 187220, in risposta alla omonima
lezione del «naturalista» Salvatore Tommasi, uscita su «Il Morgagni» a.
XIII/luglio-agosto (1871) - e in alcuni dei saggi raccolti poi, nel 1888, da
Jaja in Esperienza e Metafisica, Spaventa mostra di aver abbandonato
definitivamente il percorso di chiarificazione critica e di legittimazione
idealistica di una delle due genealogie, procedendo decisamente ben oltre
gli «abati» Rosmini e Gioberti, oltre la stessa linea Fichte-Hegel, oltre,
quindi, ambedue le “genealogie”. Non altrettanto faranno, però, quei
suoi allievi diretti, Jaia e Maturi, e quello indiretto, Gentile, che tra Otto e
Novecento ancora si cimenteranno, sia pure con sensibilità diverse, in
un’ulteriore estenuante ‘legittimazione’ neoidealistica e attualizzante di
Rosmini e di Gioberti. Rinnovando, così, quell’iniziale confusione che
ora conduce, però, non più soltanto al “compimento” del ‘patriarca’
Kant e dei suoi discendenti, ma al “compimento” della filosofia stessa,
cioè - come intuisce Croce sin dai suoi primi approcci alla filosofia e ad
Hegel - alla sua «morte», perché conduce alla «filosofia definitiva» o
«perenne» in quanto svelamento dell’essere, razionale o sovrarazionale,
immanente o trascendente, o tutto insieme. Conduce, cioè, alla “filosofia
perfetta”, “perenne” o “sistema definitivo”, ontologico-idealisticoattualistico, auspicato da molti, da Rosmini in poi. Auspicato anche, per
ragioni opposte e simili, dalla reazione anti idealistica di molti fautori del
positivismo.
Quella confusione tra trascendenza e immanenza - operata
dall’incontro tra l’ontologismo degli “abati” e l’idealismo sia critico che
20
Ora in B. Spaventa, Opere, cit., vol. II, pp. 323-404.
«Sana filosofia e sofistica prussiana», «principessa di sangue e vera regina»
ortodosso, secondo la lezione dei maestri teologi di Tubinga, e in Italia di
Augusto Vera - negli stessi anni di Spaventa era diventata visibile e chiara
non solo a Francesco De Sanctis, originale lettore critico dell’idealismo,
del tutto esente e immune da ogni sorta di “fanatismo”, al quale Hegel
«aveva seccata l’anima», ma anche al medico-fisiologo, Salvatore
Tommasi. De Sanctis ministro, del resto, aveva chiamato proprio
Tommasi sulla cattedra napoletana, al termine delle peregrinazioni di
esule politico, ma al termine anche delle peregrinazioni teoriche che per
qualche tempo, tra la prima (1848) e la terza (1860) edizione torinese
delle Istituzioni di Fisiologia, avevano impegnato anche Tommasi nel
tentativo di coniugare idealisticamente l’indagine fisiologico-sperimentale
delle determinazioni dell’essere con la trascendenza del principio ideale
della vita. La fine di quel faticoso tentativo, necessaria per la serietà stessa
dell’indagine scientifica, almeno di quella medico-sperimentale, affrontata
da Tommasi con i successivi interventi su «Il Morgagni», sulla «Rivista
italiana» e con prolusioni accademiche, avviene proprio individuando la
negatività di quella confusione o sovrapposizione. Che, però, egli stesso
non riesce a risolvere o a eliminare del tutto.
Il principio ideale, l’essenza, indagato per via speculativa, nella
concreta indagine fisiologica - precisa Tommasi nella conferenza
Sull’ippocratismo moderno21 alla fine del 1859 e poi agli inizi del 1860, negli
stessi anni in cui Spaventa sta svolgendo criticamente il patrimonio degli
“abati” - «è diventato organismo», per cui è prioritario «studiare questo in
tutte le determinazioni sue, in tutte le sue leggi, in tutti i suoi modi di
essere, e lasciare in riposo il principio speculativo». Pochi mesi dopo
(giugno 1860) questa matura scelta metodologica, ormai diventata
deliberato programma d’indagine, Tommasi, rivolgendosi per lettera
direttamente a Spaventa, conferma: «In fatto di medicina e di fisiologia,
stabilito il concetto del vitalismo e dell’organismo speculativamente, e
quindi stabilita l’identità di ideale e reale, noi dobbiamo lasciare in riposo
queste poche pagine preliminari e interamente darci allo studio minuto
delle determinazioni reali di questo organismo»22. Con le due successive
prolusioni napoletane, Le dottrine mediche e la clinica, del novembre 1865, e
Il naturalismo moderno, del novembre successivo, ambedue pubblicate da
«Il Morgagni», a. VIII (1866), la scelta compiuta è ormai oggettivata in un
percorso tormentato ma visibilmente progressivo. Lo scienziato, se pure
21 La prima edizione di questa conferenza, tenuta a Pavia, è datata 8 dicembre
1859; la seconda, a cura della “Società per la pubblicazione degli Annali universali delle
scienze e dell’industria”, Milano, 1860.
22 La lettera a Spaventa è pubblicata in B. Spaventa, Unificazione nazionale ed egemonia
culturale, a cura di G. Vacca, Bari, Laterza, 1969, p. 226, nota 4.
86
Logos
avverte il bisogno di premettere il principio ideale, deve comunque far
uso di un materialismo metodologico di cui egli enuncia il solenne
manifesto: «In quanto siam medici siam condannati ad essere materialisti.
Noi rispettiamo il cielo della filosofia, serbiamo fede nel progresso delle
scienze morali, ma in quanto siam medici negheremmo noi stessi se non
fossimo materialisti». «Noi non possiamo sorpassare i confini
dell’esperienza. La metafisica, se crede, passerà oltre, e noi la
rispetteremo, ma a noi ci lasci fare»23. La filosofia può essere scienza solo
se a-posteriori rispetto all’esperienza. Essa «idealizzi i dati dell’esperienza, si
elevi a criticismo, ed elimini o dimostri il contraddittorio delle nostre
decisioni», purché sia consapevole «che le leggi del pensiero si devono
riconoscere nelle leggi della natura, ma non devono precederla». La
conclusione è, quindi, la non scientificità di ogni indagine condizionata
da qualsiasi forma di apriori: «La questione dunque è del prima e del
dopo», perché «nessuna intuizione può sostituirsi ai fatti ricercati
coll’esperienza e alle loro leggi», come, per troppo tempo, hanno preteso
le varie forme di dogmatismo e di idealismo metafisico24.
Il richiamo prudenziale al dualismo del “patriarca” avviene, ormai,
saltando tutta la “discendenza” e la confusione genealogica, sulla quale
Tommasi si era intrattenuto per lungo tempo, limitandosi ora a
riproporre consapevolmente la distinzione tra conoscibilità
dell’immanenza fenomenica e inconoscibilità dell’essere indeterminato,
della realtà noumenica. Distinzione invocata innanzitutto, in apparenza,
come cautela metodologica necessaria alla salvaguardia etica e scientifica
dello statuto del sapere e, quindi, dello statuto delle “scienze positive”.
Ma non solo. Essa, infatti, lascia comunque sussistere la possibilità di
quella combattuta ma irrisolta confusione perché, pur avendone
individuate le componenti - ora separate soltanto da “un prima e un
dopo” e nettamente invertite nell’ordine di priorità - queste sono
considerate comunque insopprimibili esigenze vive e contrapposte e,
perciò, destinate a sovrapporsi, a confondersi, a mutare ancora ordine.
Un naturalismo metodologico, quindi, materialistico o meno, che salta
ma non risolve l’esigenza di una filosofia o metafisica come scienza dei
«primi veri, dei primi principi, delle essenze delle cose», sia pure indagati
a partire dalla priorità delle leggi della natura.
23 Cfr. S. Tommasi, Le dottrine mediche e la clinica, prolusione del novembre 1865,
pubblicata in «Il Morgagni», VIII (1866), p. 3.
24 Id., Il naturalismo moderno, prolusione del 15 novembre 1866, in «Il Morgagni», VIII
(1866), pp. 823 e ss..
«Sana filosofia e sofistica prussiana», «principessa di sangue e vera regina»
«Qui è il punto fatale della filosofia, dove tutti i sistemi fanno
naufragio»25: così, aprendo una fase del tutto nuova della ricerca e del
dibattito, afferma con pari solennità l’altro manifesto, ugualmente del
1866, col quale Villari conclude il suo lungo percorso attraverso
l’idealismo e le sue confuse genealogie, approdando alla «filosofia
positiva», oltre la linea Kant-Hegel, e ben oltre gli “abati”. Oltre lo stesso
Comte. «L’esame kantiano della ragione» ha convinto anche Villari che il
tentativo, «fatto e rifatto troppe volte», di arrivare a provare il valore
obiettivo delle idee, dei “primi veri”, per via razionalistica, resta senza
successo. «A che pro ricominciare da capo ora che il mondo è stanco?».
Alla domanda, che si rinnova da Rosmini in poi: «quale modo per
passare dal me al fuori di me» per poter cogliere l’universale26, ormai non
si dà più risposta per via ontologica o con la tentata legittimazione
idealistica dei “germi” rosminiani, né con la pretesa infinità logicodialettica dello spirito o con un malinteso ritorno a Kant. La “filosofia
positiva”, applicando il «metodo storico alle scienze sociali» così come si
applica «il metodo sperimentale alle scienze naturali», trova «i primissimi
germi» di un sapere, capace di dare quella risposta, nell’altro “patriarca”
della filosofia moderna, li trova «nella Scienza Nuova di Vico, che scoprì
che le leggi del mondo delle nazioni sono le stesse dello spirito umano, il
quale ha creato questo mondo sociale». Quei “germi” vanno individuati
in questa “naturale interezza” storico-umana: non nella matrice kantiana
e nella sua “discendenza”, né “svolgendo” quelli rosminiani, siano essi
kantiani o meno. «Il nostro spirito, dunque, si rivolga pure sopra se
stesso, perché sarà sempre un privilegio della nostra natura, e cerchi di
conoscere e studiare l’uomo» col metodo storico, così come Galileo col
metodo sperimentale studiò la natura: col metodo positivo «lo studio
dello spirito umano ha trovato finalmente una via pratica, sicura,
positiva»27.
Rispetto alle «esagerazioni e stranezze» dell’altro versante, dello
stesso Comte, ma anche di Spencer, Villari può altresì affermare che la
metafisica «avrà ancora un nobile ufficio da compiere»: perché l’uomo
continuerà a porsi quelle domande: «che cosa è l’anima, è immortale, vi è
un Dio?». Domande che, anche per Villari, oltrepassano i confini della
rigorosa dimostrazione scientifica, alle quali l’uomo prova a dare risposte
P. Villari, La filosofia positiva e il metodo storico, prolusione fiorentina dell’anno
1865-66, pubblicata in «Politecnico», I (1866), ora in Id., Teoria e filosofia della storia, a
cura di M. Martirano e con Introduzione di G. Cacciatore, Roma, Editori Riuniti, 1999,
pp. 111-148, cfr. p.131.
26 Ivi, pp. 132, 140.
27 Ivi, pp. 149, 140.
25
88
Logos
con la metafisica, la fede, l’immaginazione. Ciò, però, non ostacola il
fatto che «un numero sempre maggiore di scienze morali acquisteranno
una propria personalità, indipendentemente dai sistemi metafisici; perché
s’è trovato il modo di conoscere, fra i dovuti confini, l’uomo e il mondo
morale»28, senza bisogno, quindi, “di uscir fuori di sé” o di rimettersi
all’inconoscibile. La filosofia positiva è proposta dal “manifesto” di
Villari, quindi, come metodo storico che, al pari di quello sperimentale
per le scienze naturali, consente all’uomo di conoscere se stesso senza
bisogno di “uscir fuori di sé per cogliere l’universale”, perché lo stesso
universale è storico. Anzi, con un forte richiamo quasi diretto ad un
autorevole appello di Rosmini - che incontreremo tra poco - ma
capovolgendolo radicalmente, Villari conclude: «si rammenti l’uomo che
è nella storia, e che però in essa egli può riscontrare e provare le verità
delle sue induzioni sull’uomo»29.
L’idealismo, ormai critico, di Spaventa, avviato decisamente ben
oltre lo “svolgimento” idealistico degli “abati”, è chiamato in causa, anzi
interpellato direttamente, innanzitutto dall’esigenza etica e scientifica
materialistica, oltre che «dai soliti tratti spiritosi di Tommasi contro la
filosofia»30 e, ora, anche dal «nostro Pasqualino che sa e scrive e fa di
tante cose» e gridò anche lui Keine Metaphysik mehr 31. Spaventa sa bene
che «l’idealismo e il dinamismo non sono più», che «gli idealisti sono
morti e becchini di se stessi», come dimostra, ad esempio, il superstite
idealismo dei vitalisti che il Bonucci, con la Fisiologia e patologia dell’anima
umana, del 1852, ancora vorrebbe opporre a Tommasi quale premessa
nell’analisi sperimentale fisiologica. Spaventa, però, non solo non segue
Tommasi nella riproposizione implicita del dualismo kantiano («io non
sono dualista») e resiste al fascino del suo materialismo, sia pure
metodologico («io non sono materialista, confesso umilmente di non
avere questo coraggio»)32 - anche perché un «materialismo non assoluto»
che si accorda con qualsiasi sistema filosofico, come Tommasi definisce
Ivi, p. 153.
Ivi, p. 141.
30 B. Spaventa, Sulle psicopatie in generale, I: Il concetto della malattia in generale, in
«Giornale napoletano di filosofia e lettere» (febbraio 1872), ora in Id., Opere, cit, vol. II,
pp. 323-335, cfr. p. 326. Questa serie di quattro interventi furono elaborati in risposta
alla lezione di S. Tommasi, Sulle psicopatie in generale, pubblicata in «Il Morgagni», a. XIII,
luglio–agosto 1871, pp. 445-458.
31 B. Spaventa, Paolottismo, Positivismo, razionalismo. Lettera al prof. A. C. De Meis, in
«Rivista bolognese», II/5 (1868), ora in Id., Opere, cit., vol. I, pp. 479-501, cfr., p. 498.
32 Id., Sulle psicopatie, cit., III, Il concetto dell’organismo e il concetto dello spirito, in
«Giornale napoletano di filosofia e lettere» (maggio 1872), ora in Opere, cit., vol. II, pp.
346-379, cfr. pp. 377-378.
28
29
«Sana filosofia e sofistica prussiana», «principessa di sangue e vera regina»
il suo distinguendolo da quello di De Grecchio, non è materialismo e
Tommasi stesso del resto gli appare soltanto un «naturalista»33 - ma non
segue nemmeno la più insinuante “scoperta” del metodo storico, che
Villari esibisce in nome dell’altro patriarca, Vico, con la quale veramente
si ha il compimento di Kant e, perciò, l’approdo alla filosofia positiva.
A parte l’orgogliosa rivendicazione, esibita come «diploma di
nobiltà», della sua antica «scoperta di una certa relazione estemporanea
tra la Scienza Nuova e la Critica della Ragione» - mai, però, manifestata e ora,
invece, fatta valere come propria da Fiorentino e forse anche da altri Spaventa34 adesso, nel 1868, nota con fastidio che anche l’amico
Pasqualino, ormai oltre l’idealismo, «fa uso anzi abuso» di Vico e Kant,
per relegare nella metafisica l’immaginazione, la fantasia, la fede e per
riservare alla scienza lo studio storico-sperimentale del “positivo
naturale”. Per sperimentare il mondo ‘positivo umano’, osserva Spaventa
quasi risentito, il metodo storico-sperimentale della filosofia positiva non
serve, resta estrinseco, «se manca l’uso della nuova metafisica», proprio di
quella «iniziata da Kant e prevista da Vico», perché proprio questa fonda
la scienza sperimentale del “positivo umano”, del mondo che l’uomo fa,
e facendolo produce se stesso, e la scienza e la coscienza di sé. La «nuova
metafisica» della mente umana è indispensabile per fondare la scienza
storico-sperimentale del positivo umano, oltre le contrapposizioni tra gli
«opposti estremi» ontologico-idealistici o naturalistico-positivi.
Se la sollecitazione di Tommasi sembra aver alimentato
ulteriormente il distacco critico di Spaventa dalle diverse “linee”
idealistiche, dal complesso “compimento” di Kant, inducendolo a
ridefinire in termini nuovi “la vera questione” della scienza che non è
affatto, come voleva l’insigne fisiologo, la “questione del prima e del
dopo”, ora, però, ormai ben esperto sia delle “contraddizioni
dell’idealismo” e dell’ontologismo sia di quelle del materialismo alla
Tommasi, deve affrontare le nuove e più insinuanti contraddizioni
presenti nella scienza sperimentale del “positivo naturale” di Villari. “La
vera questione” ora, per Spaventa, consiste perciò nell’indagare «cosa sia
l’anima», anzi, precisando subito - come aveva già fatto a suo tempo
Genovesi, allievo diretto dell’altro “patriarca” Vico già chiamato in causa
per il suo precoce antidealismo da Rosmini - «cosa sia la sua relazione
con il corpo», e non con il corpo in generale, ma con «il suo corpo»35. Lo
Sul “naturalismo” di Tommasi, cfr. A. Rosmini, Opere, cit., p. 330.
Cfr. B. Spaventa, Paolottismo, cit., in Opere, cit., pp. 489-491, nota 2.
35 Id., Sulle psicopatie, cit., IV, La relazione tra anima e organismo, in «Giornale
napoletano» (giugno 1872), ora in Opere, cit., vol. II, pp. 380-404; cfr. p. 396, ma anche
p. 378.
33
34
90
Logos
studio della «vita, mistero dei misteri della natura»36 - che ha condotto il
«materialista» Tommasi a concentrarsi sull’analisi delle determinazioni
fenomeniche dell’organismo, il positivista Villari alla filosofia positiva
lasciando alla metafisica l’intuizione e lo svolgimento della forma ideale o
l’intendimento della sintesi ideale, apriori o meno - sollecita ancor più
Spaventa a procedere non solo oltre l’idealismo, oltre l’ontologismo, ma
anche oltre ogni forma di materialismo naturalistico o positivo: questo
studio lo conduce, infatti, alla scoperta che «l’anima non è reale senza
l’organismo, e l’organismo non è lì bello e fatto, prima e senza l’anima
per produrre poi i processi psichici; l’unità dell’organismo è l’anima: ecco
tutto»37. Lo studio delle determinazioni fenomeniche dell’organismo e lo
studio delle psicopatie come processi psichici non sono tra di loro
opposti, separati o separabili. Un sano materialismo, o naturalismo, come
preferisce dire Spaventa, come metodologia di approccio alle
determinazioni dell’organismo, non esclude, anzi include lo studio dei
processi psichici e spirituali, e l’inverso: il senso di sé, espressione del
processo vitale o attività corporea degli organismi inferiori, negli
organismi superiori diventa consapevolezza, coscienza di sé (intelletto,
ragione, volere). Per cui «la “vita dell’anima” non è quella sola aperta e
luminosa della coscienza» che può essere indagata solo per via
ontologico-spiritualistica o idealistico-religiosa, esclusivo dominio di
indagine della filosofia. Quale, di lì a poco sarà, infatti, il programma
della neoidealistica filosofia come «scienza della coscienza, scienza del
pensiero, scienza dello spirito». «Questa - continua Spaventa - è, anzi,
solo una piccola parte» della vita dell’anima. «Sotto di essa come base e
principio immanente ci è un’altra vita, più ricca dell’altra, occulta, muta,
cui tutto ciò che accade nella prima e poi sparisce e poi risorge, ha
origine e ritorna e si rinchiude e conserva»38. Si tratta di un’attività vitale
dell’organismo che si stratifica e si conserva come senso di sé, premessa
della coscienza di sé. Il fratello Silvio aveva già scritto che «l’uomo è una
potente creatura che vive di pane e materia, di idea e di spirito».
Il medico materialista Tommasi, attento alle determinazioni
fenomeniche dell’essere e delle leggi dei processi fisici, esclude i processi
psichici e spirituali, se e in quanto indeterminabili sperimentalmente,
dalla conoscibilità scientifica, dal campo di indagine della scienza
sperimentale medica. Il filosofo “naturalista” Spaventa, esperto delle
contraddizioni dell’idealismo e dell’ontologismo ma anche del
materialismo e della scienza sperimentale del “positivo naturale”, coglie,
Ivi, p. 333.
Ivi, p. 402.
38 Ivi, p. 404.
36
37
«Sana filosofia e sofistica prussiana», «principessa di sangue e vera regina»
invece, quei processi nella inscindibile unità dell’organismo come
relazione anima-corpo. «La cagione dell’equivoco o dell’imbroglio», nel
quale si è impigliato non solo l’incerto materialismo di Tommasi,
consiste nell’aver confuso la «principessa» con la «regina». Al termine
dell’altrettanto faticoso attraversamento delle confuse genealogie
kantiano-idealistiche, Spaventa ora, con pari solennità, proclama il suo
manifesto: «Si vedrà ch’ella, la Fisica, non è la Regina, non è tale, ma
semplicemente una principessa del sangue». «La regina vera siede più su,
assai più in alto, in un luogo cui molti mirano, dirò con Bruno, ma pochi
veggono; e che il prof. Tommasi ha visto, ma non molto chiaramente»39.
L’esatta individuazione della “vera regina”, alla fine del suo percorso
tormentato e lineare allo stesso tempo, consente a Spaventa di concepire
sinteticamente e conoscere analiticamente l’organismo come relazione
unitaria di anima-corpo. Che, quindi, non ammette distinzione di “prima
e dopo”. Il materialista Tommasi riteneva di poter realizzare soltanto
l’analisi sperimentale di questa relazione oggettivata e oggettivabile nella
specifica dimensione fenomenica naturale corporea, alla quale riduceva
anche i processi psichici, rinviando poi alla filosofia o metafisica la
possibilità di elaborarne una sintesi ideale aposteriori. Tommasi resta
rigorosamente nel pieno rispetto della “quistione del prima o del dopo”:
afferma, cioè, la priorità «della scienza della natura sulle leggi del
pensiero» che l’idealista critico-naturalista Spaventa coglie, invece, come
divenire organico della relazione anima-corpo. La chiave di lettura che ha
consentito a Spaventa di non confondere ‘la principessa del sangue’, la
Fisica, con la ‘vera Regina’, la Metafisica, «come fanno ancora l’astratto
intellettualismo o la nuda osservazione empirica, il metodo cosiddetto
sperimentale», è data dal definitivo congedo sia dal residuo o rinnovato
dualismo kantiano, sia dalla confusione o sovrapposizione tra
ontologismo e idealismo. Quella confusione si evita, sottolinea Spaventa,
se si riparte da Kant: ma non dalla sintesi originaria superata e integrata
idealisticamente dalla linea Fichte-Hegel, né da quella criticata e integrata
dall’intendimento rosminiano e dall’intuito giobertiano. Bensì se si riparte
«da quello che Kant chiama trascendentale», da quella «metafisica nuova»
iniziata da Kant e prevista dall’altro “patriarca” Vico40, cioè dall’attività
sintetica dello spirito che non è un apriori, ontologico, psicologico, o
logico-idealistico, «rispetto al me e al mondo, che fa il mondo e poi io lo
conosco, ma è il farsi stesso del me e del non-me», che ne ha conoscenza
e coscienza di sé: lo apprende e si apprende, si sa, autocoscienza, perché
lo fa. Se è vero, allora, precisa Spaventa che «ci siamo contentati di
39
40
Ivi, p. 345.
Id., Esperienza e metafisica, a cura di A. Savorelli, Napoli, Morano, 1983, p. 234.
92
Logos
ripetere con più o meno rettorica: prudenza figlioli, temperanza,
moderazione, lasciamo stare le nebbie dei tedeschi; Fichte era un matto
che pretendeva far creare dall’Io ogni cosa e Dio medesimo… che era
matto anche Gioberti… che si riconciliava con Cartesio e con Fichte»,
non va dimenticato che «il guaio è che questa attività produttiva non può
essere il non-Io, che ciò che è posto (il me e il non-me) sia posto da altri
che non è l’Io, da altro che lo spirito. Alcuni, anzi molti, hanno intesa e
intendono ancora così la cosa: un’attività non so quale di chi pone il mondo
e me; né il mondo e me siamo opera mia, ma di essa: io sono fatto per vedere il
mondo e me che non ho fatto io, e il mondo e me stesso siamo fatti per
essere veduti. Ma come ciò è possibile?»41.
Tra gli “alcuni, anzi molti”, c’erano allora il “materialista” Tommasi
e, in parte anche il “nostro Pasqualino”, ma ci saranno poi ancora gli
“allievi” diretti e indiretti di Spaventa. Nonostante gli sviluppi teoretici
impressi dal maestro alla “vera questione”, questi ultimi, di lì a poco,
come sappiamo già, riprenderanno la fatica della “legittimazione”
idealistica, immanente e trascendente insieme, di Rosmini e di Gioberti.
Su sollecitazione di quegli “allievi”, il tentativo spaventiano di
legittimazione o “svolgimento critico” di Rosmini ridiventerà punto di
partenza obbligato anche per il giovane Gentile. Se questi, poi, approderà
alla riforma dell’idealismo stesso, avvertita ormai come necessaria,
avviandone perciò la sofferta conclusione, che si protrae nella «lunga
marcescenza del cerchio troppo magico dell’attualismo»42, il fascino e la
fecondità teoretica della genealogia anche rosminiana e giobertiana
dell’idealismo, assoluto, logico-fenomenologico o fenomenologicologico, razionale, sovrarazionale, immanente e/o trascendente, nuovo,
cristiano, religioso, critico e/o ortodosso, personalistico, realistico o
metafisico, non verrà mai meno, nonostante quella “marcescenza” e
nonostante condanne ex cathedra, ripensamenti, abiure43.
Alla fine del secolo, sin dal Rosmini e Gioberti, Gentile, come per un
tratto limitato del suo percorso aveva fatto anche Spaventa circa
trent’anni prima, vede che «la filosofia risorge in Italia grazie
principalmente al Nuovo Saggio del Rosmini», perché questo ripropone il
problema della conoscenza «quale era stato impostato da Kant» allorché
avviò «la libera navigazione del criticismo e dell’idealismo moderno» e ci
liberò «dalle secche d’una filosofia dommatica, empirica o aprioristica e
Ivi, p. 235.
Per questa “marcescenza” vedi G. Campioni - F. Lo Moro - S. Barbera, Sulla crisi
dell’attualismo, Introduzione di E. Garin, Milano, F. Angeli, 1981, in particolare pp. 19-39.
43 Per una riproposizione di quella esigenza cfr. De Lucia, L’istanza metempirica, cit.
41
42
«Sana filosofia e sofistica prussiana», «principessa di sangue e vera regina»
mistica»44. Insieme a tale “risorgimento” il rosminianesimo accoglie e,
nello stesso tempo, risponde anche «al bisogno universalmente sentito di
ristorazione del sentimento religioso», scosso dagli attacchi illuministici e
sensistico-materialistici45. La comune lotta contro questi nemici e la
“ristorazione della sana filosofia”, che per Rosmini, come sappiamo, è
solo quella cattolica fondata sulla ragione illuminata dall’idea dell’essere,
insieme alla “ristorazione” idealistico-razionale del sentimento religioso,
costituisce per tutti gli allievi di Spaventa un fecondo e privilegiato
terreno d’incontro, purché, appunto, - sulla scia aperta, ma chiusa anche,
da Spaventa -, si sappia «distinguere nel Rosmini e sceverare il contenuto
speculativo dalla forma contingente di cui quel contenuto si rivestì»46. Il
kantismo di Rosmini è ancor più rilevante, dice Gentile, nonostante le
puntuali riserve critiche mosse anche da Credaro nel 1886, se si
considerano sia l’iscrizione all’Indice delle opere kantiane, avvenuta il 22
dicembre del 1817, sia «gli elementi di antikantismo che per motivi
estrinseci al processo logico del sistema egli dovette inserirvi, a causa,
appunto dei tempi e del suo status ecclesiastico»47. Il “compimento”
idealistico della filosofia avviene di nuovo, perciò, come era avvenuto già,
ma solo fino ad un certo punto, anche per il maestro, “svolgendo”
criticamente Kant e Rosmini, superando, cioè, i residui limiti
soggettivistici della sintesi kantiana e il persistente platonismo di
Rosmini. Ancora presente, questo, sia pure come «amminicolo»48, con
l’intuito o intendimento dell’idea dell’essere. Così scrive Gentile sin dal
Rosmini e Gioberti, nel 1897/98, andando anche oltre le prime analisi
spaventiane su Rosmini, poi abbandonate. Da un lato il maestro dice:
«Rosmini è Kant non solo nei pregi, ma anche nei difetti, ed ha più
difetti di Kant» perché, avendo «dinanzi agli occhi un falso Kant, uno
sconcio simulacro di Kant», finisce «col credersi la persona viva, Kant in
persona»49 e coglie il loro maggior limite comune, meccanico, nella
definizione della sintesi di categoria e sensazione, nella loro «applicazione
estrinseca», che avviene “senza ponte di passo”, senza scoprire, cioè,
«l’energia portentosa» che sprigiona la loro unità intima, colta da Fichte.
D’altro lato l’indiretto “allievo”, Gentile, osserva: «ma a tal giudizio, per
verità, si oppone il testo stesso del Rosmini», il quale «ha piena coscienza
G. Gentile, Rosmini e Gioberti, Firenze, Sansoni, 1958, in Id., Opere Complete, vol.
XXV, pp. 56-57.
45 Ivi, p. 205.
46 Ivi, p. 65.
47 Ivi, p. 67.
48 Ivi, p. 207.
49 B. Spaventa, La filosofia italiana nelle sue relazioni con la filosofia europea, cit., p. 571.
44
94
Logos
di quell’unità attiva originaria», «unità originaria dello spirito», quasi «vista
spirituale» da cui, per intrinseco svolgimento, «si produce il conoscere».
Per cui Gentile, differenziandosi dal maestro, conclude: «la percezione
intellettiva rosminiana è, insomma, la vera sintesi a priori di Kant, già
come è posta nel Nuovo Saggio»50. Spaventa, invece, aveva visto la
percezione intellettiva rosminiana molto più “estrinseca” e “meccanica”
rispetto alla kantiana “immaginazione produttiva”, che è il frutto maturo
della unità sintetica originaria. È vero che Rosmini è fortemente attratto da
questo frutto definito “energia portentosa”, “virtù radicale” dello spirito
che, «all’occasione di concepire gli enti dell’esperienza dei sensi», sembra
che «emetta di sé e dia esistenza a forme che prima non esistevano…
sicché egli generi da sé, senza seme per così dire, o, anzi, crei il proprio
sapere intellettuale»51. Ma si tratta di una “virtù radicale”, la creatività
dello spirito, che lo lascia molto perplesso e prudente, fino a condividere
la valutazione critica data già un secolo prima da Genovesi nella lettera
ad Antonio Conti: «No, io mi ci perdo. Questa forza maggiore della
creatrice, aveva detto Genovesi, produce forme di cose che non
intende… questo è un bell’indovinare?»52. Se questa precoce critica
genovesiana sostiene poi Rosmini nel superamento dei limiti
soggettivistico-idealistici permanenti nella forma kantiana del pensare affrontata, infatti, procedendo in opposizione alla direzione assunta
dall’altro ‘allievo’, Fichte - egli, però, procede anche in opposizione alla
direzione assunta a suo tempo dallo stesso Genovesi. Mentre questi alla
«terrigena» ragione naturale, «forza calcolante», «regolo naturale», conatus
naturae , «unica dote» di cui dispone l’uomo per tentare «la scienza dell’io
e del creato», affianca soltanto la naturalità e razionalità del Logos-Phos,
rifiutando quindi decisamente la chaldaica philosophia dei lumi divini,
affermatasi sin dalla schola platonica e poi, attraverso Giamblico, Plotino,
S. Agostino, giunta sino a Malebranche53, Rosmini recupera proprio la
nozione agostiniana di “lume interiore”, “lume della verità”, che
consente l’intendimento dell’idea dell’essere. Lo spirito umano con la
nuda e semplice facoltà della forma naturale della ragione, dice Rosmini,
«non perverrebbe mai a formarsi le idee, non comincerebbe mai a
pensare», se non possedesse «da sé qualche elemento intellettivo ingenito
G. Gentile, Rosmini e Gioberti, cit., pp. 191-192.
A. Rosmini, Nuovo saggio sull’origine delle idee, t. I, a cura di G. Messina, Roma,
Città Nuova, 2003, N. 366.
52 Ibid., nota 143.
53 A. Genovesi, Elementorum metaphisicarum, tomus secundus, Psichesophia, Neapoli,
Typis Benedicti et Ignatii Gessari, 1752, edizione consultata Napoli, 1761, pp. 21-22
nota (a), pp. 171-172.
50
51
«Sana filosofia e sofistica prussiana», «principessa di sangue e vera regina»
e innato», se non avesse in sé «un seme seminato nei nostri animi dal
Creatore», capace di fondare la certezza della «umana cognizione»54. «In
quanto forma, senza quel lume ingenito, la filosofia trascendentale è […]
intrinsecamente assurda e ripugnante» e il kantismo, infatti, «si appoggia
tutto sopra un gioco di immaginazione», valorizzato poi ed enfatizzato
dalla “filosofia prussiana”55. La forma kantiana della conoscenza,
comunque, consente a Rosmini, «impegnato nel più grande tentativo di
riforma filosofica del pensiero cattolico compiuto dall’interno del
cattolicesimo»56, di procedere oltre la sua definizione aristotelicotomistica, ormai crollata. Ma essa potrà diventare veramente feconda se
la ragione naturale viene sottratta al soggettivismo di «nuda facoltà»
kantiana e se, agostinianamente, viene vivificata «dal fatto ovvio e
semplicissimo, che l’uomo pensa l’essere in un modo universale»57. La
distinzione rosminiana tra sentire (l’esperienza del me senziente) e
intendere (l’idea dell’essere) conferma la valutazione critica spaventiana
che Rosmini “ha maggiori difetti” di Kant, perché se il sentire è passivo e
solo l’intendere è attivo, grazie, però, al “seme seminato”, ne deriva che
la conoscenza sensibile non supera il soggettivismo sensistico e la
conoscenza intellettuale trova fondamento e validità di scienza nella
intuizione ontologico-razionale e non nell’attività creativa logicosintetica, critica e idealistica, dello spirito. Spaventa conclude: «Forse
erriamo, ma a me pare che questa sia l’opinione dello stesso Rosmini»58.
Né possono esservi dubbi sulla natura ontologica dell’idea dell’essere
colta per intendimento sovrannaturale, grazie al “lume interiore”, che per
Spaventa costituisce un arretramento, un “difetto” ulteriore rispetto a
Kant. Anche quando Rosmini è sollecitato a riflettere sulla possibile
natura solo finita, filosofico-razionale, dell’intendimento, “potenza
dell’anima”, come idealistico «occhio», platonico o moderno, «che vede
se stesso», «occhio che è due occhi in occhio solo»59, che perciò «merita
tutta l’attenzione del filosofo», egli però non è mai disposto ad
abbandonare la sua canonica accezione tomistica. Se è vero che “l’energia
portentosa” dell’attività creatrice dello spirito può pensare gli universali
anche «praeter tutti i particolari finiti», come riconosce anche Tommaso,
la questione per Rosmini diventa appunto questa: «Come può lo spirito
Id., Nuovo saggio, cit., t. II, a cura di G. Messina, Roma, Città Nuova, 2004, NN.
389, 394.
55 Id., Nuovo Saggio, cit., t. III, a cura di G. Messina, Roma, Città Nuova, 2005, NN.
1110,1089.
56 P. Piovani, Giusnaturalismo ed etica moderna, Bari, Laterza, 1961, p. 46.
57 A. Rosmini, Nuovo Saggio, t. III, cit., N. 1239.
58 B. Spaventa, La filosofia di Kant e la sua relazione colla filosofia italiana, cit., p. 211.
59 A. Rosmini, Nuovo Saggio, t. III, cit., N.1437; cfr. anche t. II, cit., N. 124.
54
96
Logos
uscir fuori di sé? come può creare gli universali che prima non
possedeva?». Ma è vero altresì che Rosmini non lascia spazio ad alcun
dubbio: la questione è risolvibile solo con il “lume soprannaturale”,
“lume ingenito” e con “l’intuizione interiore essenziale”. Questo lume, e
non lo spirito come pretesa creatività dell’attività sintetica originaria, è
l’unica base certa del sapere, dal quale «conviene mover come suo
principio la filosofia». Questo è il «cominciamento» del sapere, sia per il
«bifolco», quindi, che per il «savio» 60. Come sappiamo, gli sviluppi del
dibattito vedono, da un lato, le successive forme dell’idealismo, e poi
l’attualismo gentiliano in tutte le sue varianti, impegnate a conciliare o
legittimare ancora quella doppia genealogia, sottovalutando non solo
l’abbandono spaventiano degli “abati”, ma anche la costante e univoca
definizione rosminiana di “intendimento”, che fonda l’attività sintetica
dello spirito e la percezione intellettuale. Dall’altro vedono tutta, o quasi,
la cultura cattolica del secondo Ottocento ormai impegnata in prevalenza
nella solidissima “restaurazione” del tomismo per riaffermare in funzione
antimoderna la validità della aeterna ratio e della Verità perenne, a scapito,
quindi, della “rinascita” del tomismo stesso, auspicata in parte dallo
stesso Rosmini, quale metodologia utile per misurarsi, invece, con la
ragione moderna post-cartesiana, anche con quella idealistica.
Nella divergente e reiterata “legittimazione” di Rosmini si può
cogliere non solo uno dei punti di diversificazione maggiore e decisiva
tra i percorsi di Spaventa e Gentile ai fini del “risorgimento” teoretico e
storiografico della filosofia italiana, ma anche la premessa che segnerà la
definizione stessa del nuovo idealismo o attualismo, la cui matrice
genealogica è, appunto, quella carica di confusione tra l’esigenza di
immanenza idealistica filosofico-razionale, avvertita a partire dalla
scoperta del trascendentale kantiano e sviluppata dalla “discendenza” del
“patriarca”, e l’esigenza spiritualistica, ontologico-trascendente, che con
quella viene confusamente intrecciata e coniugata. Se Kant, come dice
Spaventa, ha posto nella sintesi tra categoria e sensazione la base
originaria del conoscere, della quale però ha colto in modo “oscuro”
“l’energia portentosa” dell’io penso che essa sprigiona, Rosmini ha
definito altresì, e allo stesso modo, quella sintesi originaria della
conoscenza, che si regge, però, sul recupero dell’agostiniano “lume
interiore”, che, a sua volta, rende possibile l’intendimento dell’idea
dell’essere e il sentimento fondamentale. “L’energia portentosa”, quasi
“vista spirituale”, che la sintesi kantiano-idealistica sprigiona, a Rosmini
crea quasi trepidazione: ne è attratto ma non sa o non osa spiegarla al di
60
Ivi, N. 251, nota 25; N. 257; t. III, cit., N. 1437.
«Sana filosofia e sofistica prussiana», «principessa di sangue e vera regina»
fuori del tomismo e dell’intendimento soprannaturale. O, almeno,
l’analizza ma non l’accetta come via filosofico-razionale alla conoscenza,
come farà Spaventa. Quella “energia portentosa” genera «il giudizio
dunque sull’esistenza delle cose», dice Rosmini, così come dirà poi
Spaventa. Ma, «a differenza di tutti gli altri giudizi, produce egli
medesimo il proprio oggetto; e mostra con ciò di avere una virtù sua
propria, quasi una energia creatrice» che, come abbiamo visto, arriva
persino ad impegnare “tutta la meditazione del filosofo”. Ma non di più:
Rosmini non va oltre. «Quest’oggetto che non esiste precedentemente a
un tal giudizio su di lui portato, esiste poi in virtù, e, perciò, al più,
contemporaneamente del giudizio stesso». Questa contemporaneità, o
“attualità”, solo ipotizzabile per Rosmini, costituisce il contatto più
ravvicinato possibile tra le due diverse concezioni della sintesi. La
definizione spaventiana della virtù generatrice di tale giudizio differisce
totalmente da quella di Rosmini che afferma: «somigliante giudizio è
dunque una potenza singolare dell’intendimento nostro», e non
semplicemente della sintesi primitiva. Esso è possibile, infatti, perché
«l’intendimento è la facoltà di percepire le cose come esistenti in se
stesse», «di vedere le cose in sé esistenti», arrivando persino a ritenere che
«l’intendimento nostro dunque percepirà i sensibili in sé esistenti, non
più nell’intima relazione che hanno con noi in quanto sono sensazioni» 61.
Esso è «facoltà di pensare: non percepisce le sensazioni particolari, ma è
l’anima, nella quale vi è l’intendimento, che percepisce l’universale, senza
ponte di comunicazione»62.
A fronte delle oscillazioni e ambiguità insite nelle diverse e
richiamate “legittimazioni” idealistiche di Rosmini, tentate dallo stesso
Spaventa e abbandonate a partire dal 1860-61- ma sopravvissute a lui e
persino enfatizzate è - opportuno e anche doveroso rilevare che il
giudizio negativo rosminiano sui limiti del criticismo kantiano, espresso
nel 1850 nel rapido profilo genealogico della “discendenza” del patriarca,
era maturato già nel giovanile Esame della Ragione, del 1816, ed è
confermato poi con costanza quale imprescindibile fondamento di tutto
il suo nuovo “sistema del sapere”. Quei limiti, inoltre, non sono costituiti
da un difetto di audacia del “patriarca” o di autocensura, bensì dall’eccesso
di potere della ragione umana che «pretende di portar giudizio della
stessa ragione tutta intera». Si tratta, quindi, di un evidente abuso, di
un’audacia, «perché la ragione umana può ben asserirsi ma non
criticarsi», in quanto «una parte non può giudicare il tutto». Abuso che
non può che condurre alla dichiarazione di impotenza della ragione
61
62
Ivi, NN. 124, 128.
Ivi, NN. 252, 253.
98
Logos
stessa “ad uscir fuori di sé”, condannata, quindi, a restare prigioniera del
soggettivismo e incapace di fondare l’universalità e l’oggettività dei
giudizi della mente umana. Il limite kantiano che nel 1861 per Spaventa è
“difetto”, per Rosmini, sin dal 1816, era “eccesso” della ragione. Il
contrasto è netto: per Spaventa, Kant ha scoperto l’attività sintetica
originaria dello spirito ma senza coglierne “l’intima potenza produttiva di
sé stessa” («Kant va a Roma senza vedere il papa, cioè la produttività del
pensiero»); per Rosmini, sulla scia rassicurante di Tommaso, «nonostante
il crollo del glorioso edifizio della scolastica», questa attività, cioè la
possibilità della cognizione, è data dall’intendimento, “facoltà
dell’anima”, “capacità di applicar l’essere alle cose”, “potenza singolare”,
“intuizione interiore essenziale dell’essere universale”, agostiniano “lume
conceduto alla mente”, e quindi «vero principio dal quale conviene
mover la filosofia»63. Solo “l’intendimento” porta a riconoscere che «v’ha
indubbiamente una prima verità la quale comunica senza mezzo termine
con tutte le menti»64. La certezza della cognizione e la produttività del
pensiero sono fondate su questa prima verità che si coglie per
intendimento, non per ragionamento logico-razionale, come vuole Kant.
Con il solo ragionamento la mente non può uscire fuori dai limiti
soggettivistici empirico-sensoriali. Mentre Spaventa “legittima” Kant
perché il suo “difetto” era stato risolto poi idealisticamente da Fichte,
Rosmini al “gran sofista” Kant riconosce l’unico merito di aver saputo
rifiutare, appunto, “la taccia di idealista” che proprio il primo allievo gli
voleva attribuire. Merito, comunque, relativo perché ormai il danno era
inevitabile: sul suo falso sistema fondato sulla possibilità di giudizi
sintetici apriori i “discendenti”, infatti, poi pretesero dimostrare la
creatività dello spirito umano come capacità sua di «mettere nel subietto
ciò che nel subietto per sé non è, […] quasi emanandolo da sé»65.
«Sgraziatamente» questo ragionamento «rende assurda ed impossibile» la
cognizione e produce «uno scetticismo assai più tristo del comune» e,
sotto forma di criticismo, «è lo scetticismo perfezionato» che porta al
fallimento la filosofia moderna66. La “gran questione” della cognizione,
di conoscere il conoscere o di “come uscir fuori di noi” non ammette
alcun ponte di comunicazione: si tratta di una questione impossibile a
risolversi per via di ragionamento solo “materiale o meccanico”, a
partire, cioè, dalla sola creatività logico-razionale dello spirito finito. Essa
è, invece, «un fatto puramente spirituale», che avviene perché l’uomo
Ivi, NN. 124, 128, 250, ma anche t. III, cit., NN. 1437, 1407, 1197.
Id., Introduzione alla filosofia, cit., N. 32, p. 64.
65 Id., Nuovo Saggio, t. I, cit., NN. 328, 346, 356.
66 Ivi, N. 330.
63
64
«Sana filosofia e sofistica prussiana», «principessa di sangue e vera regina»
porta «innato in se medesimo questo ponte di comunicazione» col «quale
percepisce l’ente in sé, come qualità comune e più essenziale di tutte le
cose»67.
La valutazione della filosofia del “patriarca”, divergente da quella
data da Fichte, è compiuta da Rosmini sin dal 1816, agli inizi del suo
percorso teoretico, ma quando è già consapevolmente impegnato nella
“ristorazione” della “vera e sana filosofia”, che non è né scettica, né
razionalista, né può essere ancora “il crollato edifizio della scolastica”:
una filosofia è sana solo se fondata sul “fatto primigenio del sentimento
fondamentale” e sulla “intuizione dell’idea dell’essere”. Spaventa avvia il
confronto con Rosmini sin dalla metà degli anni Cinquanta, dopo le
prime decisive esperienze hegelo-idealistiche, che egli compie
nell’ambiente napoletano, gravido di idealismo e di hegelismo in
particolare. Dove, però, il vecchio barone Galluppi, saldamente attestato
sulla solida elaborazione della «filosofia dell’esperienza», nelle
Considerazioni sull’idealismo trascendentale e sull’idealismo assoluto, del 1841,
aveva autorevolmente messo in guardia contro «l’infelicissima filosofia»
alemanna del razionalismo assoluto, perché l’idealismo che esso ha
prodotto, «tanto il trascendentale che il trascendente, sono assurdi» in quanto
entrambi negazione di qualunque realismo. Per ambedue, quindi, Kant
non esce dal soggettivismo: per Rosmini, perché egli è ancora razionalista
e sensista; per Spaventa, perché ancora “empirista”, sia pure di tipo
nuovo, cioè esperto di Condillac, capace comunque, quindi, di andare
oltre Cartesio e Locke, grazie alla scoperta dell’apriori.
La precoce preoccupazione antidealistica aveva consentito al giovane
Rosmini di vedere nella “sofistica” della scuola tedesca la riduzione della
filosofia a scienza del pensare puro, che rompe così l’inscindibile unità
del “consoggetto”, assicurata «dalla legge di compagnia anima-corpo» che
egli, nonostante la lucida consapevolezza del crollo irreversibile
dell’edificio plurisecolare della scolastica, accoglie nella definizione
tomistica della mixtio mente-corpo. Differenziandosi in ciò dalla
ragionata e originale acquisizione genovesiana, in funzione
antirazionalistica e anti idealistica, del «mutuo commercio mente-corpo»
o «accavigliamento che così è anche se non so spiegarlo, ma solo perché
è troppo corto il nostro intendimento». “Accavigliamento” individuato
grazie alla mediazione della lettura antropologica del tomismo data da
Raimond de Sabunde, che consente all’abate salernitano di affrontare sia
la crisi della ratio aristotelico-tomistica, sia l’irrompere del sensismo
scettico e/o razionalistico della raison critique, ma anche l’ontologismo e i
67
Ivi, N. 82.
100
Logos
primi conati idealistici. Come per Genovesi, anche per Rosmini, quella
“scissione” idealistico-razionalistica del “consoggetto” «separa la parte
intellettiva dalla parte attiva e morale dell’uomo» che, così, si crede
«divenuto puro pensiero, si lascia divorare dalla rabbiosa fame della
coscienza di sé stesso», novello Faust, creatore di una nuova forma di
«antropolatria»68. Come separazione tra l’idea e la realtà, tra il pensiero
assolutizzato e lo spirito, quella scissione è individuata dal giovane
Rosmini nell’esame dei “baldanzosi” sviluppi idealistico-trascendentali
prospettati dall’altro “allievo”, Fichte, impegnato nel tentativo di
superare i limiti o i “difetti” soggettivistici del “patriarca”. Fichte
esaspera le potenzialità dell’elemento attivo dello spirito umano nella
conoscenza del “fuori di noi” e trascura del tutto l’elemento passivo,
imprimendo all’apriori kantiano un “entusiasmo” e una “baldanza”, «una
avidità di usurpata grandezza», esorbitante rispetto alle capacità e alle
possibilità dell’immaginazione intellettiva che, comunque, è e resta
espressione di una umanità pur sempre colpevole, perché figlia di
Adamo69. Per cui, il suo appello uguale e opposto a quello di Villari: «Si
ricordi il mortale che egli non è nel centro del gran mare dell’essere, ma
in un angolo, e che solo da quest’angolo egli dirige il suo sguardo alle
cose, e non al centro». «Dare, invece, allo spirito umano la virtù di
produrre l’essere, una cotal virtù radicale per la quale egli generi di sé
senza seme per così dire, il proprio sapere intellettuale è l’errore che
ingenuamente confessarono di volere i filosofi tedeschi, da Fichte
all’Hegel»70.
Rosmini, opportunamente, evoca a suo sostegno lo stupore, già
espresso da Antonio Genovesi, di fronte alla pretesa del Gallus
Metaphisicus di attribuire alla ragione una «forza ancora maggiore della
creatrice, che produce forme di cose che non intende, né le produce
come possibili, ma come esistenti. No, io mi ci perdo», aveva affermato
Genovesi. «Questo è un bell’indovinare non altrimenti che un pittore che
pretende di averci fatto dei ritratti di cose di cui egli non ebbe giammai
idea». E così concludeva: «Questo è un rivoltarsi nel più tenebroso
scetticismo»71. Va sottolineato, però, che Rosmini fa un utilizzo parziale e
anche riduttivo delle ragioni fondative del precoce antidealismo maturato
dall’originale allievo dell’altro “patriarca”, nella lotta contro «zelanti» e
tradizionalisti da un lato, e contro esprits forts e raison critique dall’altro.
Riduzione rilevabile, del resto, anche in quasi tutta la storiografia
Id., Introduzione, cit., N. 67, pp. 126; N. 79, p. 147.
Id., Nuovo saggio, t. III, cit., NN. 1393, 1394.
70 Id., Nuovo saggio, t. I, cit., Preliminare, NN. 29, 27, 366.
71 Ivi, N. 366.
68
69
«Sana filosofia e sofistica prussiana», «principessa di sangue e vera regina»
genovesiana. Se Gentile concorda con Francesco Fiorentino allorché
questi, sulla scia di Spaventa, rileva, comunque, «nell’empirismo
genovesiano, un soffio preannunzio della Critica e dell’apriori kantiano»,
perché «svolge fecondamente quello lockiano in direzione opposta a
quello materialistico condillachiano»72, poi, però, aggiunge che, a causa
del «suo animo pio», Genovesi restò comunque «schietto empirista» e,
inoltre, siccome ebbe «poco attitudine alla finezza delle analisi
gnoseologiche, fu più propenso agli studi di economia». Da un lato
Rosmini ignora il preciso intento antiontologico di Genovesi ed accoglie
quello anti-idealistico; dall’altro Gentile, a sua volta, concorda sul “soffio
preannunzio” della Critica, ma inteso come opposto a quello intravisto da
Rosmini: per Gentile si tratta, infatti, di un “preannunzio” di Kant, non
critico della ragione, ma “patriarca” della genealogia idealistica, poi
“svolto” pienamente dalla “discendenza” che nel “risorgimento” della
filosofia italiana è fecondata innanzitutto dallo stesso Rosmini. La
genovesiana ragione “terrigena”, “regolo naturale”, conatus naturae, che sa
“di aver finita atmosfera”, non è colta come “preannunzio” critico, sia
pure soltanto “soffio”, dell’assolutizzazione del pensiero, critico della
scissione del mutuo commercio mente-corpo e della evanescenza della ragione
“cornacchia”, che si cimenta a «schiccherar carte o cicalar all’aria».
Nella definizione della “ragione terrigena”, effettuata nelle
Meditazioni Filosofiche del 1748, Genovesi aveva presentato il “misterioso
accapigliamento” del mutuo commercio mente-corpo come l’imprescindibile
fondamento della ragione e dei suoi poteri conoscitivi, che non le
consentono di “uscir fuori atmosfera”, di ‘schiccherar carte o cicalar
all’aria”: essa è, perciò, “regolo naturale”, ma anche “sol dell’universo”,
«unica mia dote di sé signora perché sa di aver finita atmosfera». Nel
1747, nella Psychesophia, aveva definito altresì il rifiuto dell’idealismo e
dell’ontologismo, nell’esaminare il sistema, puerile, secum pugnans, incertum,
absurdum, del Gallus metaphisicus, Malebranche, che communi sensu plane caret.
Rosmini coglie l’autocritica genovesiana della ragione, ma la ritiene
pericolosamente incline allo scetticismo e al soggettivismo. Pur
valorizzando la critica genovesiana alle forme innate e alla potenza
creatrice della “virtù radicale”, poi perfezionata da Kant, Rosmini non
coglie, invece, nella originale fondazione “terrigena” della “ragione” il
sicuro antidoto non solo antiscettico, antimaterialista e antidealistico, ma
precocemente anche antiontologico, che consentì all’abate salernitano di
affrontare gli opposti furori dei lumi. Questa “ragione” si definisce,
innanzitutto come “terrigena forza calcolante”, “dono di Dio e sole
Cfr. F. Fiorentino, Compendio di Storia della filosofia italiana, a cura di A. Carlini,
Firenze, Vallecchi, 1924, vol. II, pp. 318-319.
72
102
Logos
dell’universo”, “spirituale e immateriale”, ma anche “regolo naturale del
mutuo commercio mente-corpo che il mio corpo informa e signoreggia”.
Per Genovesi la ragione naturale opera col solo “aiuto” del lume naturale
o Logos-Phos: non può fare affidamento sui lumi divini, incerti, lontani e
di difficile intendimento. In quanto conatus naturae all’esse, esse bene, esse
beate, essa regola “il misterioso accavigliamento mente-corpo” che, come
la «quadratura del cerchio, è tale anche se è troppo corto il nostro
intendimento» per poterlo spiegare. «Benché il modo di unirsi mi sia
ignoto, noi - dice Genovesi - comprendiamo interamente quanto allo
spirito e al corpo si appartiene»73. L’esigenza critica, antirazionalistica e
antimaterialistica, ma anche anti-idealistica, di Genovesi trova nella
“ragione terrigena” - “di sé signora”, quasi kantianamente avvertita di
aver “finita atmosfera”, di “non poter schiccherar carte e cicalar all’aria”
- il fondamento certo che permette di sfuggire quegli “opposti estremi”,
combattuti, poi, con divergenti premesse e prospettive, sia da Rosmini
che da Spaventa e, quindi, dall’idealismo. È l’originale lettura
antropologica, “post-tomistica”, esperta della spinoziana corporeità della
ragione e della lumière naturelle del cartesianesimo fisico, che consente a
Genovesi la rimodulazione originale della mixtio come mutuo commercio
mente-corpo, “accavigliamento” che può apparire «misterioso ma solo
perché è troppo corto l’intendimento umano». Genovesi evita in tal
modo l’enfatizzazione e la contrapposizione di una sull’altra delle due
parti, l’attiva o la passiva, del “composto umano” o “consoggetto”.
Evita, così, lo squilibrio che, appunto, dà luogo agli “opposti estremi” e
opposti sistemi di pensiero nascenti dalla confusione tra le genealogie dal
“patriarca”: per Rosmini esso può essere superato solo con l’ausilio del
lume divino, come “lume interiore”, che assicura l’intendimento dell’idea
dell’essere, vero principio del filosofare e fonte della certezza della
cognizione.
Ancor meno, per Rosmini, è possibile l’altra ipotesi, ancora più
assurda, della «mescolanza», che si realizza quando «indarno l’uomo,
come l’ubriaco, mesce due liquori in un sol bicchiere, farnetica di
mescere insieme il soggetto umano e l’essere, il finito e l’infinito, la
creatura e il creatore, perché un abisso li parte, e non può conoscerlo,
non può immaginarlo». «Farneticazione» che, come la confusione
presente tra le divergenti genealogie idealistiche, è presente nel
razionalismo dei teologi scolastici e nella “sofistica prussiana”: del quale
73 A. Genovesi, Meditazioni filosofiche, Bassano, 1748, p. XXV. Sulla genovesiana
ragione terrigena, sia consentito rinviare ad una indagine dello scrivente, Ragione naturale
e lumi per Alfonso De Liguori e Antonio Genovesi, in «Archivio di storia della cultura», XVI
(2003), pp. 169-218.
«Sana filosofia e sofistica prussiana», «principessa di sangue e vera regina»
razionalismo, però, egli stesso sarà accusato, da “destra” e da “sinistra”,
nonostante sin dal 1837 avesse “fatto querela” col Baldassarre-Poli che,
per primo, aveva “mescolato” il suo pensiero dando avvio alla
confusione “genealogica”. Eppure egli, ancora nel 1850, individua e
combatte quella farneticazione o confusione nella superbia soggettivistica
«del piccolo titano del secolo XVIII, Faust, un vero professore
dell’università tedesca, senza solido sapere, d’immensa ma sregolata
immaginazione, credulo, voluttuoso, ambizioso, visionario, pazzo. Faust
è il capo d’opera del poeta prodotto dal panteismo germanico»74.
L’interpretazione idealistico-fichtiana di Kant è errata e combattuta da
Rosmini, senza ambiguità. Anzi, egli si compiace di riportarne il rifiuto
espresso dallo stesso Kant, che la «disdisse come quella di un figlio che
traligna dal padre»75. Posta la riflessione del pensiero su se stesso a
cominciamento del filosofare e del ragionamento, al Fichte sfugge la
differenza tra spirito e pensiero e, quindi, sfugge la priorità del
sentimento sul ragionamento, della “potenza singolare” che è
l’intendimento immediato dell’essere: intendimento, precisa Rosmini,
come «lume interiore che tocca immediatamente l’anima, lume comune a
tutti gli uomini», che opera senza «ponte di mezzo o di comunicazione».
I “sofisti prussiani”, in particolare i discepoli di Hegel «ingozzati di
soggettivismo intimarono esplicitamente la guerra più accanita
all’immediatezza, come qualcosa di divino che eleva la mente dell’uomo
più su della coscienza scientifica»76.
Schelling, “allevato” da Fichte e, perciò, anche per Spaventa
“nipote” del “patriarca”, secondo Rosmini “avverte l’errore” del
maestro, ma sbaglia ancora perché sostituisce radicalmente il sentimento
al pensiero, nel tentativo di sfuggire alla dialettica fichtiana tra Io e nonio, tutta interna al pensare finito. L’intuizione sentimentale dell’assoluto,
fuori dal pensiero, come pura identità noumenica, non dimostrata per via
di ragionamento, si rivela errore ancor più radicale di quello fichtiano ed
opposto a quello kantiano. Kant nega la conoscibilità delle realtà
noumeniche, Fichte pretende risolverla nella dialettica del pensare,
Schelling «pretese di ragionar come se l’essenza stessa reale di esse intuir
si potesse». Di fronte a «questo corso delle idee filosofiche in Germania»
Rosmini conclude che «troppo piccolo era lo spirito umano per poter
concentrare in se stesso l’universo». «La tendenza fu questa, ma le penne
mancarono al volo». Al contrario, rovesciando l’appello, simile e
opposto, di Villari, Rosmini continua: «essendo uomini, dobbiamo
A. Rosmini, Introduzione, cit., N. 65, p.123, e Id., Nuovo saggio, t. III, cit., N. 1402.
Id., Introduzione, cit., p. 353; Id., Nuovo saggio, cit., N. 1388.
76 Id., Nuovo Saggio, t. III, NN. 1390, 1197, 1456; Id., Introduzione, N. 85, p.155.
74
75
104
Logos
partire dall’investigazione della mente, da quel principio che le è stato
conceduto per suo lume77, perché per conoscere non possiamo far uso di
altro che di ciò di cui siamo dotati, della ragione». L’intuizione, come
«affermazione gratuita, arbitrio, fu il gran peccato» di Schelling,
rimproveratogli da tutta la Germania, pur messo in essere nell’intento di
sfuggire al soggettivismo critico del patriarca e all’idealismo del maestro.
Il “nipote” finì col riproporre il Sistema dell’identità assoluta, «con la quale
aveva esordito la filosofia italica per mezzo di Parmenide»78.
Per Spaventa, come è noto, in Italia è Gioberti il filosofo dell’intuito
dell’identità assoluta: a differenza di Schelling, nelle Postume il pensatore
italiano è andato oltre Galluppi e Rosmini, così come Hegel è andato
oltre Kant, Fiche e Schelling. Ha scoperto l’autonomia e la libertà
assoluta dello spirito, colto nel suo divenire, sia pure solo metessico 79.
Nella “legittimazione” idealistica della filosofia italiana, Gioberti
“compie” Rosmini, mentre questi vede nel giobertismo la trasposizione
di tanta parte della filosofia alemanna in Italia, cioè di quei «mostruosi
sistemi stranieri che straziano sì crudelmente i visceri della Germania»
che ora minacciano di invadere anche «la nostra terra italiana» pur non
seconda a nessuno «per pietà e buon senso». Ma quel che conta di più, in
questo divergente esame di Gioberti e Schelling, è la constatazione
espressa da Rosmini nel 1846, e già maturata da tempo, che di quei
sistemi «indubitabilmente il Gioberti s’industria di trapiantare almeno le
frasi, se non i concetti, nel nostro suolo»80. In particolare perché,
nonostante «tutta la buona volontà di Gioberti di non essere panteista»,
tutta «la sua filosofia tende a separare l’ideale dal reale», ciò che «è un
manifesto assurdo, sia poi un assurdo panteistico, o d’altro genere».
Nella divergente ricerca della “sana filosofia” e della legittimazione
idealistica della filosofia italiana il contrasto più netto, nell’attribuzione di
meriti e responsabilità ai discendenti del ‘patriarca’, si manifesta
ovviamente sul suo “bisnipote” Hegel: il Faust “piccolo titano,
d’immensa ma sregolata immaginazione”, «non conosce e non ammette
che il pensiero e prende i fatti del pensiero per fatti ontologici», come è
già avvenuto per le scuole indiane e la scuola di Elea. Questa «mostruosa
dottrina tedesca si basa sul pregiudizio che il primo fondamento» della
cognizione è dato «dall’intendimento del soggetto», che muove dal finito,
dalla soggettività e sensorialità trascesa per via razionalistica, non
Id., Nuovo Saggio, t. III, NN. 1405, 1406, 1407.
Id., Introduzione, cit., p. 353.
79 B. Spaventa, La filosofia italiana nelle sue relazioni, cit., p. 581.
80 A. Rosmini, Vincenzo Gioberti e il panteismo, a cura di P.P. Ottonello, Roma, Città
Nuova, 2005, NN. 95, 99.
77
78
«Sana filosofia e sofistica prussiana», «principessa di sangue e vera regina»
dall’idea dell’essere, universale e oggettiva81. «L’illusione della filosofia
prussiana», che confonde l’idea con la realtà, porta perciò alla
«divinizzazione dell’uomo, alla scalata al cielo», a «mostruose aberrazioni
e assorbe tutte le cose nella scienza e nel pensiero che la produce» 82. «La
logica hegeliana in particolare divora la metafisica come Saturno i suoi
figliuoli. Indi le rovine della filosofia e di tutto ciò che è vero e santo»83,
mentre basterebbe la «semplice logica naturale dell’uomo della vita
comune per evitare sì strane allucinazioni e mantenere congiunti l’ideale
e il reale». Secondo Rosmini, la stessa esperienza soggettiva di Kant è un
forte invito ad abbandonare la sofistica prussiana. Sul fine della vita,
«quando sperava di cogliere immenso il frutto dei suoi travagli, Kant
conchiude, invece, col confessare l’impotenza e nullità [della ragione
critica] paragonando la filosofia precedente all’opera temeraria e
impossibile della torre di Babele». Quella ragione, consapevolmente
impossibilitata a conoscere la realtà noumenica, è ristretta alla semplice
certezza sensibile dei fenomeni, oltre i quali nemmeno il criticismo,
perciò scettico, riesce ad andare, delineando, quindi, un «idealismo…
universale, una illusione soggettiva profonda che ci rinserra in un cerchio
di sogni da cui non è dato trascendere». Impotenza ad uscire dal
soggettivismo e nullità della ragione, da Kant stesso presentata come
“massima e ultima delle sue scoperte”, e che per Rosmini è «la massima
umiliazione dello spirito umano, miserabile e ultimo risultato della
sapienza umana con la quale si compie l’opera della filosofia moderna» 84.
Si tratta «dell’errore fondamentale di questa scuola e il peccato originale
di tutte le filosofie tedesche che comparvero dopo la kantiana»85.
«L’estremo supplizio della filosofia moderna»86, cui conduce la
rivoluzione della Germania, si realizza, però, dopo Kant, proprio per
sfuggire a tale soggettivismo e impotenza della ragione, allorché i filosofi
moderni sono costretti, «come fa il filosofo di Stuttgarda, chiuso in quella
sfera del suo pensiero, dalla quale cade facilmente nella illusione di
riputarsi solo pensiero»87, fino ad ammettere ingenita nel pensiero «una
virtù radicale che all’occasione di concepire gli enti dell’esperienza dei
sensi emetta da sé e dia esistenza alle forme che prima non esistevano.
Sicché generi di sé, senza seme per così dire od, anzi, crei il proprio
Id., Introduzione, cit., N. 64, p. 121; N. 63, p. 120.
Ivi, N. 64, p. 122; N. 65, p. 123.
83 Ivi, N. 65, p. 124.
84 Id, Nuovo Saggio, t. I, cit., NN. 330, 331.
85 Ivi, N. 331.
86 Id., Introduzione, cit., N. 33, p. 65.
87 Ivi, N. 63, pp. 119-120.
81
82
106
Logos
sapere intellettuale, e con ciò lo stesso mondo»88. Nel “viaggio filosofico
per uscir fuori di sé”, l’uomo viene guidato dal desiderio di «raggiar luce
fuori di sé in tutte le regioni a cui pervenisse». L’immaginazione non
ebbe più limiti o confini: «l’assoluto dunque dei filosofi non fu, e non
poté essere che una composizione, un rimpasto del mondo e dell’uomo:
ecco il Dio, o veramente l’idolo della Filosofia, l’opera delle mani
dell’uomo: os habet, et non loquetur»89. Per sola via di ragionamento, e
rifiutando l’intendimento che è “la capacità di dar l’essere alle cose senza
ponte di comunicazione”, “lume dato all’uomo dall’essere”, la sofistica
prussiana si affatica a costruire la via razionale “per uscir fuori di sé”, a
trascendere la propria finitudine soggettiva in cui il ‘patriarca’ l’ha
rinserrata. Per Rosmini si tratta, invece, di un trascendimento che la
mente può realizzare solo “senza ponte di comunicazione”, perché essa
«ha la mirabile proprietà o virtù di convertirsi sopra se medesima: tale la
mirabile proprietà dell’essere […] d’ingenerare in se medesimo, quasi con
una fecondità verginale, il ragionamento»90. Consapevole dell’”arditezza”,
Rosmini stesso aggiunge: «fatto, mirabile sì, ma fatto», nel quale l’idea
dell’essere si applica a se stessa, riconosce se stessa, «fa da predicato e da
subietto», è regola di giudicare e cosa giudicata, che fonda la certezza della
cognizione per via di intendimento e non per via di sviluppo razionale di
una pretesa “virtù radicale” ingenita del pensiero umano. Su questo
“fatto”, come intuizione interiore essenziale dell’essere in universale, si
fonda, quindi, la concezione prima che muove i ragionamenti di ogni
uomo, il cominciamento stesso del filosofare «tanto del bifolco che
discorre degli armenti e delle glebe solcate, quanto del savio che medita
intorno al giro degli astri e alla divina natura»91.
È proprio la via logico-razionale, invece, il procedimento adottato
dal “filosofo di Stuttgarda”: armato della «forte dialettica dell’inventore»
egli non riconosce per esistente quello che non è ancora oggetto del suo
pensiero, ritiene che gli oggetti del pensiero siano da questi prodotti e
quindi creati, che il pensiero dal NULLA li fa passare all’ESSERE92.
Questa “scienza” così aberrante, o “ciò che si usa di chiamar scienza”, è
quella «maga che ha virtù di convertire gli uomini in bestie, e in vari
generi di mostri, ed anche di demoni e di farli poi ritornare uomini, ma
d’una statura maggiore di quella di prima»93. Se in tale magico “furore” Id., Nuovo Saggio, t. I, cit., N 366, nota 143.
Id., Nuovo Saggio, t. III, cit., N. 1403.
90 Ivi, N. 1456.
91 Ivi, N. 1437.
92 Id., Introduzione, cit., N. 63, p. 120.
93 Ivi, N. 65, p. 124.
88
89
«Sana filosofia e sofistica prussiana», «principessa di sangue e vera regina»
che evoca le ascendenze ermetico-magico-neoplatoniche dell’assolutezza
del pensiero e, allo stesso tempo, prefigura lo sbocco nel “cerchio
magico” di parte dell’idealismo novecentesco - «il pensiero sembra a se
stesso così potente, in verità è reso schiavo della volontà pervertita, fino
all’antropolatria»94. Come succede, appunto, alle divergenti genealogie
idealistiche, confuse e sovrapposte tra loro ma in egual modo
“baldanzose”, ignare della matrice “terrigena” della ragione, conatus
naturae, che l’allievo diretto del “patriarca” napoletano, a metà del secolo
dei lumi, aveva elaborato per tentare una “scienza” storico-razionale
“dell’io e dell’uomo” lontana dagli opposti “furori”; che Rosmini ha
accolto solo per la sua feconda critica antirazionalistica e antidealistica95;
da Villari accolta, sia pure solo come “soffio preannunzio” della Critica
del “patriarca” di Königsberg, per definire la scienza sperimentale del
“positivo umano”; da Spaventa - orgoglioso della sua antica ma
sottaciuta “scoperta di una certa relazione estemporanea tra la Scienza
Nuova e la Critica della Ragione” -, assunta a principio euristico per
individuare nella vita “dell’organismo dello spirito” la matrice della “Vera
Regina”96. Oltre la quale prevale «la sciaurata idolatria dei sensi e delle
idee» e «chi troppo s’affina si scavezza».
Ivi, N. 67, p. 126.
Per il vichismo di Rosmini e per il suo parziale, specifico accoglimento del
“metodo storico”, restano fondamentali le riflessioni di P. Piovani, Rosmini e Vico, in
«Rivista Internazionale di Filosofia del diritto», XXX (1953), 3, pp. 293-322, ora in Id.,
La filosofia nuova di Vico, a cura di F. Tessitore, Napoli, Morano, 1960, pp. 209-263, in
particolare pp. 250-251.
96 Sul vichismo di Spaventa, “battistrada insostituibile” del Vico di Gentile e
dell’idealismo, il cui “disegno ermeneutico” e le cui “tesi maggiori sono già tutte in
Spaventa”, vedi ancora P. Piovani, op. cit., pp. 263-321, in particolare pp. 268-269, che
prescinde dalla riflessione spaventiana sulla “Vera Regina” svolta in Sulle psicopatie in
generale, cit.
94
95
Louis Begioni
Le operazioni memoriali del linguaggio
nell’ambito della psicomeccanica del linguaggio
di Gustave Guillaume: esempi di applicazione alla
temporalità in francese ed in italiano
Nella prima metà del secolo XX il linguista francese Gustave
Guillaume, nei suoi scritti teorici sulla “psicomeccanica del linguaggio”, è
stato uno dei primi ricercatori à prendere in considerazione la
costruzione del linguaggio umano nella temporalità delle operazioni del
pensiero. I suoi principi teorici poggiano sui seguenti concetti
fondamentali:
il tempo operativo: tempo infinitesimale delle operazioni mentali
relative alla costruzione del linguaggio
il rapporto reciproco fra lingua e discorso che permette di
considerare la costruzione del discorso ma anche i cambiamenti
linguistici strutturali dal discorso verso la lingua
la successione delle due fasi fondamentali della costruzione della
lingua: l'ideogenesi o semantogenesi (costruzione semantica) e la morfogenesi
(istituzione delle operazioni morfosintattiche: sintagma nominale,
sintagma verbale).
Sarebbe oggi opportuno rivedere i concetti di Gustave Guillaume
per ridefinirli nel quadro di una psicomeccanica del linguaggio che possa
prendere in considerazione le ricerche delle scienze cognitive nonché
quelle sul funzionamento del cervello umano. Il tempo operativo resta il
concetto centrale di questo approccio teorico. Con Gustave Guillaume,
si distinguerà l’ideogenesi o semantogenesi, costituita dall'insieme delle
operazioni memoriali, che porta all'organizzazione del senso (andando
dal particolare al generale in un sistema di relazioni binarie) e al lessema;
la lessicogenesi è l'ultima fase della semantogenesi. Le memorie semantiche che
riguardano il linguaggio potrebbero essere comparate a banche dati
costituite di elementi semici, destinati a caratterizzare il lessema, i quali
saranno strutturati nel corso delle diverse tappe dell'acquisizione del
linguaggio. I dati semici possono essere modificati e/o arricchiti durante
tutta la vita dell'individuo.
110
Logos
Ci proponiamo di analizzare tutto ciò in questa nostra riflessione
attraverso l’esempio della costruzione semantica e del funzionamento:
- del verbo italiano “andare”
- del verbo francese venir (venire)
in particolare quando in alcune costruzioni linguistiche sono quasi
diventati dei nuovi ausiliari,
- e dell’uso dell’indicativo imperfetto per l’espressione dell’irreale
dopo la congiunzione ipotetica francese SI (SE).
Cercheremo, seguendo i principi della psicomeccanica del linguaggio,
di evidenziare ed esplicitare le varie fasi di costruzione relative a questi
fenomeni.
1. Il contesto linguistico di riferimento
In francese e in italiano troviamo dei verbi di movimento che hanno
perso il loro significato originale mantenendone solo la parte temporale.
È per esempio il caso del verbo aller (andare) in francese. Seguito
dall’infinito ha in un primo momento potuto esprimere un futuro
immediato e in un secondo momento un futuro vero e proprio:
Le train va partir dans quelques instants
Dans 15 ans, je vais partir en retraite
(il treno partirà fra qualche istante)
(fra 15 anni, andrò in pensione)
In italiano, i verbi ‘andare’ e ‘venire’ possono funzionare come degli
ausiliari. ‘Venire’ più il participio passato assume un valore aspettuale
progressivo per le forme passive: “la porta viene aperta”, che è la forma
progressiva omologa di: “la porta è aperta”.
Le grammatiche tradizionali rendono conto di questo tipo di
struttura ma non spiegano i meccanismi semantici diacronici e sincronici
che hanno reso possibile questi mutamenti. Dobbiamo quindi
interrogarci sui processi semantici e sistemici che permettono di dare
spiegazioni soddisfacenti.
Nell’ambito della psicomeccanica del linguaggio definita da Gustave
Guillaume, alla quale ci riferiamo molto spesso nelle nostre ricerche,
dobbiamo mettere in rilievo le debolezze dell’approccio semantico.
Gustave Guillaume evidenzia l’ideogenesi (processi di costruzione
semantica del significato) o semantogenesi, come preferiamo chiamarla
con Alvaro Rocchetti, come fase che precede la morfogenesi ma senza
specificare i meccanismi di una fase iniziale così fondamentale per la
costruzione della lingua.
Le operazioni memoriali del linguaggio nell’ambito della psicomeccanica
Prima di presentare i principi semantici sui quali basiamo le nostre
riflessioni, ci sembra opportuno ricollocare ed esplicitare la nozione di
sistema linguistico in particolare in diacronia. Pensiamo che sarebbe
interessante per l’evoluzione sistemica delle lingue, fare riferimento alla
teoria delle catastrofi di René Thom1. In effetti, nella linguistica moderna,
saussuriana e post-saussuriana, la nozione di sistema si trova alla base
della comprensione del funzionamento della lingua.
In questa prospettiva, le evoluzioni sull’asse del tempo
corrispondono ai passaggi successivi da un sistema all’altro. La lingua che
è in equilibrio sistemico ad un’epoca t1, subisce cambiamenti linguistici
soprattutto al livello morfologico e sintattico. Tali cambiamenti in un
primo momento costituiscono soltanto microvariazioni che man mano
prendono più importanza. Queste ultime provocano uno squilibrio del
sistema che è costretto a cambiare alcune regole di funzionamento al fine
di ritrovare un nuovo equilibrio ad un’epoca t2. Tutte le lingue romanze
che abbiamo studiato fino ad ora hanno seguito questo modello di
evoluzione. In alcune epoche sarebbe possibile assistere a squilibri tali da
poter minacciare il futuro di una lingua o provocare mutamenti
strutturali profondi. È per esempio il caso del francese parlato
contemporaneo, che evidenzia notevoli scarti linguistici con la norma
scritta. Nell’opera di Gustave Guillaume, la nozione di sistema è al
centro della riflessione teorica. Nel capitolo «La langue est-elle un
système?»2 de Langage et science du langage3, espone chiaramente il suo
pensiero. Rimprovera a Saussure e a Meillet di non andare oltre questa
affermazione sul piano scientifico. Propone un modello «concentrico»4 in
cui la lingua viene definita come
«un système de systèmes – un assemblage systématisé de systèmes
contenants (ayant un contenu propre de positions intérieures) s’emboîtant
les uns dans les autres et qui, inscrits chacun dans un plus étendu, le plus
étendu de tous étant celui de l’assemblage qu’en fait la langue, différent
entre eux sous toutes sortes de rapports, sauf celui de leur forme commune
de contenant, laquelle se répète identique à elle-même, et en réalité
invariante, du plus étendu au moins étendu, de sorte que celle du plus
étendu, la langue, assemblage de tous, serait connue au cas où l’on réussirait à
Alcune opere di Réné Thom: Stabilité structurelle et morphogenèse, Paris,
Interéditions, 1977; Prédire n'est pas Expliquer, Paris, Eshel, 1991; Paraboles & Catastrophes,
Paris, Flammarion, 1980; Théorie des catastrophes et biologie, Copenhague, s.e., 1979.
2 Trad.: «La lingua è un sistema?».
3 G. Guillaume, Langage et science du langage, Paris, Nizet e Québec, Presses de
l’Université Laval, 1964, pp. 220-240.
4 Ivi, p. 224.
1
112
Logos
voir en traits nets la forme de l’un de ceux, riche ou pauvre de substance,
qu’elle contient5».
In questo suo modello, egli afferma che i sistemi si dotano di
meccanismi semplici e ricorrenti per costruire le strutture della lingua.
Uno di questi meccanismi è il tenseur binaire radical (tensore binario
radicale) che viene esemplificato nel rapporto plurale interno/plurale
esterno6 e nel sistema dell’articolo in francese7. Tuttavia non li applica
alla fase operativa della costruzione del significato, alla quale ha dedicato
pochissimi studi. Per questa ragione, prenderemo in considerazione gli
studi di Alvaro Rocchetti, che sviluppa ricerche sulla semantica
nell’ambito di una psicomeccanica del linguaggio rinnovata8. In
particolare mostra come avviene la costruzione del significato sull’asse
del tempo operativo, cioè utilizzando il meccanismo semplice
dell’intercettazione anticipata. Tale intercettazione, che qualificheremo di
«desemantizzante» (poiché opera una riduzione della quantità di
significato), permette, partendo da un significato potenzialmente pieno,
di creare per uno stesso significante, nuovi significati su assi metaforici,
dove il significato in potenza viene semanticamente ridotto.
2. Per una semantica psicomeccanica operativa
I principi di base
I principi sui quali ci basiamo si riferiscono direttamente alla
psicomeccanica del linguaggio e ai concetti di semantogenesi e di
metaforogenesi.
5 Ivi, p. 223. Trad.: «Un sistema di sistemi – un assemblaggio sistematizzato di
sistemi (che hanno un proprio contenuto di posizioni interne) che si incastrano gli uni
negli altri e che, iscritti ognuno in un altro sistema più esteso, il più esteso di tutti
essendo quello dell’assemblaggio fatto dalla lingua, differiscono fra di loro sotto ogni
tipo di rapporto, salvo quello della loro forma comune di contenitore, la quale si ripete
identica a se stessa, e in realtà invariante, dal più esteso al meno esteso, di modo che
quella del più esteso, la lingua, assemblaggio di tutti loro, sarebbe conosciuta nel caso in
cui si riuscisse ad osservare in tratti netti la forma di ognuno di quelli, ricca o povera di
sostanza, che contiene».
6 Ivi, p. 236.
7 Ivi, p. 237.
8 A. Rocchetti, sito Internet http://chercher.marcher.free.fr.; Id., Sens et acceptations
d'un mot: un noyau commun? un parcours? Réflexions sur la méthodologie de l'analyse des rapports
signifiant/signifié, in «Cahiers de linguistique analogique», 2 (dicembre 2005).
Le operazioni memoriali del linguaggio nell’ambito della psicomeccanica
a) Il significato di una parola è caratterizzato da una traiettoria
temporale sull’asse del tempo detto “operativo” durante il quale vengono
costituite le impressioni associate al significante. Il primo movimento che
genera significato verrà chiamato semantogenesi ed è responsabile della
genesi del senso. Qualora il contesto lo permetta o quando non esista
alcun contesto, questo movimento procede fino alla fine senza
interruzione. Ed è in questo modo che il significato di una parola viene
costruito.
b) Nell’ambito della comunicazione linguistica si fa spesso
riferimento a nuovi significati ottenuti grazie allo sviluppo di nuove
accezioni e ciò a partire da parole già esistenti nella lingua. In questo
caso, il movimento della semantogenesi si interrompe prima del suo termine
e dà luogo per metaforogenesi ad una nuova accezione appropriata ai nuovi
bisogni comunicativi9.
Per l’applicazione di questi principi in particolare al lessico, ci
riallacciamo agli studi di Alvaro Rocchetti che si riferisce in primo luogo
al concetto di subduction (“subduzione”):
«Nous partageons un autre postulat avec l’école que nous examinons:
celui de la subduction. Ce nom, proposé par Gustave Guillaume, s’applique
au cas de mots qui sont conduits à “descendre en dessous d’eux-mêmes”,
c’est-à-dire à perdre une part de leur contenu sémantique pour devenir, par
exemple, des mots-outils. C’est le cas, entre autres, de l’auxiliaire “avoir” qui
est un verbe plein (sémantiquement) dans “il a une belle voiture”, mais a
perdu une partie de sa matière notionnelle — tout en gagnant, en revanche,
des fonctions formelles — lorsqu’il devient auxiliaire dans “il a bien
9 L. Begioni, Les constructions verbales Verbe + Indicateur Spatial: des dialectes de l’Italie du
nord à la langue italienne, in Actes du XIe Colloque international de l'AIPL (Association
Internationale de Psychomécanique du Langage, Montpellier, 8-10 juin 2006), Limoges,
Lambert-Lucas, 2007.
114
Logos
mangé”. Lorsqu’on postule que le signifié lié à un signifiant est le noyau
sémantique commun à tous les emplois qu’il peut avoir, on raisonne en pure
synchronie, sans prendre en considération l’évolution diachronique. Or
celle-ci n’a pas mis en place au même moment les signifiants avec leurs
signifiés: ainsi la punaise est un insecte qui a toujours existé, bien avant que
l’homme n’existe et surtout bien avant que celui-ci n’invente “la punaise”
pour accrocher toutes sortes de choses aux murs. Depuis quand existe le
noyau commun? Depuis que la punaise-animal est nommée par l’homme?
ou depuis que l’homme a utilisé ce nom pour la “punaise murale”? Cette
dernière emprunte, en effet, plusieurs de ses caractéristiques à la punaiseanimal: elle pique, elle est ronde, plate, s’écrase avec le pouce, etc. (mais elle
ne sent pas, n’est pas animée, ne se déplace pas la nuit, ne suce pas le sang
des pauvres humains, etc.). Il est évident que les hommes qui ont donné le
nom de “punaise” à l’insecte n’ont pas prévu qu’un autre type de “punaise”
verrait le jour, qui ne serait pas animée, piquerait certes, mais pas les êtres
humains, ne se déplacerait pas la nuit, etc. Si on recherche le noyau
sémantique commun, on est donc conduit à penser que le contenu
sémantique du mot “punaise” a changé lorsqu’on a inventé la punaise
murale — et qu’il serait susceptible de changer chaque fois qu’une
utilisation impossible jusque là devient possible. Pourquoi dès lors ne pas
limiter la réduction de sens à cette dernière seulement (selon le phénomène
de la subduction), en laissant la punaise-animal continuer sa vie linguistique
avec son signifiant et son signifié plénier?»10.
A. Rocchetti, Sens et acceptations d'un mot […], cit., pp. 5-6. Trad.: «Condividiamo
un altro postulato con la scuola che esaminiamo: quello della subduzione. Questa
definizione, proposta da Gustave Guillaume, si applica ai casi che sono portati a
«scendere sotto se stessi», cioè a perdere una parte del loro contenuto semantico per
diventare, per esempio, parole-utensili. È il caso dell’ausiliare avoir (avere) che può
essere semanticamente definito come un verbo pieno in il a une belle voiture (ha una bella
macchina), ma ha perso una parte della sua materia nozionale — pur guadagnando
invece funzioni formali — quando diventa ausiliare in il a bien mangé (ha mangiato bene).
Quando si postula che il significato legato ad un significante sia il nocciolo semantico
comune a tutti gli usi che può assumere, si ragiona in pura sincronia, senza prendere in
considerazione l’evoluzione diacronica. Invece, questa non ha realizzato nello stesso
momento i significanti con i loro significati: così la punaise (cimice) è un insetto che è
sempre esistito, molto prima dell’apparizione dell’uomo sulla terra e soprattutto molto
prima che questi inventi la punaise (la puntina) per applicare varie cose sui muri. Da
quando esiste il nocciolo comune? Da quando la punaise-animal (cimice-insetto) è stata
nominata dall’uomo? o da quando l’uomo ha usato questo nome per la punaise murale (la
puntina)? In effetti, quest’ultima assume più caratteristiche della punaise-animal (cimiceinsetto): punge, è tonda, piatta, può essere schiacciata con un dito, ecc. (ma non puzza,
non è animata, non si sposta la notte, non succhia il sangue dei poveri esseri umani,
ecc.). È evidente che chi ha dato il nome di punaise (cimice) all’insetto non ha previsto
che sarebbe nato un altro tipo di punaise, che non sarebbe stata animata, che avrebbe
potuto pungere ma non gli esseri umani, che non si sarebbe spostata la notte, ecc. Se si
vuole evidenziare il nocciolo semantico comune, siamo indotti a pensare che il
contenuto semantico del termine punaise sia cambiato quando è stata inventata la punaise
10
Le operazioni memoriali del linguaggio nell’ambito della psicomeccanica
Poi continua la sua dimostrazione esplicitando l’analisi dei diversi
significati della parola francese punaise (l’insetto “cimice” in italiano):
le signifiant français punaise s’applique à l’insecte piqueur (acception
finale), mais reçoit aussi plusieurs autres acceptions: la punaise que l’on
achète dans les papeteries, les qualificatifs “punaise de sacristie”, “cette fille
est une vraie punaise”, et les exclamations négatives ou positives: “punaise!
j’ai perdu mes clés!” ou “punaise! qu’elle est belle”. On peut représenter la
structure sémantique de la manière suivante:
Q’y a-t-il de commun entre l’exclamation négative ou positive “punaise!” et la
punaise qui sert à fixer sur les murs? Pratiquement rien. Il n’en est pas de même,
comme on l’a vu, si on passe par l’insecte qui est l’origine de ces acceptions, tant sur le
plan diachronique que sur le plan synchronique. L’exclamation négative, la première,
historiquement, des deux exclamations, garde de l’insecte la notion d’embêtement (on a
du mal à se débarrasser des punaises!). Mais cette notion n’aurait sans doute pas suffi
pour créer l’exclamation si la ressemblance formelle de la première syllabe du signifiant
avec une exclamation que l’on voulait éviter (putain!) n’avait pas joué un rôle
déterminant. Ainsi est née l’exclamation négative. Par la suite, comme putain! avait aussi
un emploi positif (putain, que c’est beau!), on est passé à l’exclamation positive Punaise!
qu’elle est belle! Il convient donc de distinguer deux temps dans la construction du
signifié: d’une part, la mise en place de l’ensemble des impressions liées au signifiant et
qui ne sont acquises qu’au terme du premier mouvement, d’autre part l’utilisation
métaphorique de ce même signifiant, avec, comme dans le mot punaise ci-dessus,
plusieurs métaphores successives. On observera que d’autres signifiants peuvent entrer
en concurrence avec l’exclamation punaise! comme, par exemple purée! qui possède aussi
la même syllabe initiale ‘pu”. La connotation négative est, pour ce dernier mot,
introduite par le fait que la purée détruit toute structure d’un objet (légume, fruit, etc.)
et que, en présence d’une purée, on ne reconnaît plus rien, on ne s’y retrouve plus.
murale (puntina), e che sarebbe possibile cambiare ogni volta che un uso impossibile fino
a quel momento divenga realizzabile. Ma allora perché non limitare la riduzione
semantica soltanto a questo impiego (secondo il fenomeno di subduzione) lasciando
che la punaise-animal (cimice-insetto) continuasse la sua vita linguistica con il suo
significante ed il suo significato pieno?».
116
Logos
D’où, aussi, les exclamations qui s’enchaînent l’une à l’autre. Ce deuxième mouvement,
constitué de saisies de plus en plus anticipées, reprend le premier à rebours pour
s’éloigner progressivement de la saisie finale: ainsi, “punaise de sacristie” garde encore
beaucoup d’impressions communes avec la punaise-insecte: par exemple, la “punaise de
sacristie” passe le plus clair de son temps dans l’église ou la sacristie, comme la punaise
reste dans la chambre ou dans le lit. Dans “cette fille est une vraie punaise”, le lieu n’est
plus évoqué, mais il reste l’idée d’une personne qui, comme la punaise, s’accroche et
empoisonne la vie. Avec l’exclamation négative “punaise! j’ai oublié mes clés!”, on s’est
encore éloigné de l’acception finale et enfin, avec l’exclamation positive “punaise!
qu’elle est belle!” on n’a plus gardé de la précédente métaphore que l’exclamation (en
perdant la connotation négative)11.
11 Ivi, pp. 12-13. Trad.: «Il significante francese punaise si applica all’insetto che
punge (accezione finale) ma riceve anche numerose altre accezioni: la punaise (puntina)
che si compra nelle cartolerie, le espressioni punaise de sacristie (bigotta maldicente), cette
fille est une vraie punaise (questa ragazza è una vera calamità), così come le esclamazioni
positive o negative: punaise! j’ai perdu mes clés! (porca miseria! ho perso le chiavi) o punaise!
qu’elle est belle! (diavolo!com’è bella!). Cosa c’è in comune tra l’esclamazione negativa o
positiva punaise! e la punaise che serve a fissare oggetti sui muri? Praticamente nulla. Non
è la stessa cosa, come abbiamo visto, se si passa dall’insetto che è all’origine di queste
accezioni tanto sul piano diacronico quanto su quello sincronico. L’esclamazione
negativa, storicamente la prima delle due esclamazioni, mantiene dell’insetto la nozione
di fastidio (è difficile sbarazzarsi delle cimici!). Ma forse questa nozione non sarebbe
bastata a creare l’esclamazione se la somiglianza formale della prima sillaba del
significante con un’esclamazione che si voleva evitare, cioè putain! (Porca puttana!) non
avesse avuto un ruolo determinante. Così è nata l’esclamazione negativa. In seguito
visto che putain! aveva anche un impiego positivo come putain que c’est beau! (Porca
miseria che bello!), si è passati all’esclamazione positiva Putain! qu’elle est belle! (porca
miseria! quant’è bella!). È quindi opportuno distinguere nella costruzione del significato
due tempi: da un lato, la definizione dell'insieme di impressioni collegate al significante
le quali saranno acquisite solo al termine del primo movimento, dall’altro, l’uso
metaforico di questo stesso significante con, come nella parola punaise, diverse metafore
successive. Si può osservare che altri significati possono entrare in concorrenza con
l’esclamazione punaise! come per esempio purée! (trad.: «puré» e che significa «porca
miseria») che possiede la stessa sillaba iniziale «pu». La connotazione negativa è per
questa parola introdotta dal fatto che la purée «il puré» implica la distruzione della
struttura dell'oggetto (verdura, frutta, ecc.) e che, in presenza di une purée, non si
riconosce più niente, non vi ci si ritrova più. Da qui la successione delle esclamazioni.
Questo secondo movimento costituito da intercettazioni sempre più anticipate riprende
il primo movimento in senso contrario allontanandosi progressivamente
dall’intercettazione finale: in questo modo, punaise de sacristie (bigotta maldicente)
conserva ancora molte impressioni comuni con la punaise-insecte (cimice-insetto): per
esempio, la punaise de sacristie passa la maggior parte del suo tempo in chiesa come la
punaise (cimice) rimane nella camera o nel letto. Nell’espressione cette fille est une vraie
punaise (questa ragazza è una vera calamità), il luogo non è più preso in considerazione,
ma rimane l’idea di una persona che, come una punaise, si attacca e rovina la vita altrui.
Con l’esclamazione negativa punaise! j’ai oublié mes clés! (porca miseria! ho dimenticato le
chiavi!), ci si è allontanati ancora di più dall’accezione finale e alla fine con
l’esclamazione positiva punaise! qu’elle est belle! (porca miseria! quant’è bella!) si è
Le operazioni memoriali del linguaggio nell’ambito della psicomeccanica
Questa lunga citazione assume una dimensione essenziale nelle
ricerche in semantica operativa. Si tratta di principi fondatori che
vogliamo seguire nelle nostre ricerche. Presentiamo una sola obiezione
formale legata allo scorrimento del tempo operativo: le intercettazioni
anticipate che abbiamo qualificato di “desemantizzanti” devono essere
rappresentate sul grafico a destra e non a sinistra dell’intercettazione
finale del significato pieno, poiché non è concepibile sul piano temporale
il tornare indietro. Proponiamo quindi per la parola punaise la seguente
rappresentazione:
Questo approccio metodologico può essere generalizzato in questo
modo:
conservata dalla metafora precedente solo l’esclamazione (perdendo invece la
connotazione negativa)».
118
Logos
Una delle ultime operazioni effettuate in semantogenesi è costituita
dall'eventuale aggiunta dell'aktionsart (si tratta dell'inserimento del
semantismo relativo al modo del processo) che permette di distinguere i
lessemi che possiedono i tratti semantici del processo indipendentemente
dal tempo “esterno” e dal tempo “cronologico”. È grazie all'aktionsart
che la morfogenesi può costruire il verbo e tutte le operazioni che
riguardano la temporalità verbale. In seguito, per il verbo, viene la fase
detta cronogenesi. Questa è costituita nella maggior parte delle lingue (in
particolare quelle indoeuropee) di tre cronotesi: la cronotesi 1 o modo quasi
nominale (infinito), la cronotesi 2 o modo virtualizzante (congiuntivo), la
cronotesi 3 o modo attualizzante (indicativo). L'aktionsart è un invariante
universale mentre gli aspetti e i tempi verbali sono legati alle operazioni
morfosintattiche di ogni lingua. Sarà postulata anche l'esistenza di
memorie di controllo dove sono immagazzinati degli enunciati (recenti o
meno) in situazioni linguistiche che tengono conto della complessità
comunicativa, in particolare di tutti gli elementi sensoriali non verbali).
3. La semantica operativa in morfosintassi: esempi in
francese e in italiano
Sul piano diacronico, possiamo osservare fenomeni di mutamenti
sistemici che si richiamano direttamente ai principi che abbiamo appena
presentato.
Il
meccanismo
di
intercettazione
anticipata
“desemantizzante” può anche essere applicato a elementi grammaticali
funzionali della lingua, e ciò molto spesso allo scopo di stabilire un
Le operazioni memoriali del linguaggio nell’ambito della psicomeccanica
nuovo equilibrio o una maggior precisione ad un sottosistema linguistico.
Prenderemo l’esempio della costruzione verbale francese ALLER +
INFINITO e quella italiana di VENIRE + PARTICIPIO PASSATO
per mettere in rilievo la ricorrenza di un tale meccanismo.
a) La costruzione verbale francese ALLER + INFINITO.
La costruzione verbale ALLER + INFINITO del francese
moderno è sempre più usata al posto del forma verbale del futuro. Per
esempio, oggi si può dire:
Dans 15 ans, je vais partir à la retraite (Fra 15 anni andrò in pensione)
senza introdurre la minima sfumatura di futuro immediato. In questa
frase, il verbo aller ha perso semanticamente il suo valore spaziale (cioè la
parte puramente spaziale dello spostamento) di verbo di movimento per
diventare un verbo-strumento dal funzionamento simile a quello di un
ausiliare. Cos’è quindi successo per poter avere una forma di questo tipo?
Postuleremo che un’intercettazione anticipata “desemantizzante” è
all’origine di questo mutamento semantico. In effetti, tutti i verbi di
movimento che implicano uno spostamento nello spazio sottintendono
per definizione uno scorrimento temporale. Se ammettiamo che nella
fase di semantogenesi, lo spostamento nello spazio è intimamente legato
a uno scorrimento temporale, possiamo anche accettare l’idea che gli
elementi semantici della temporalità precedono quelli della spazialità
sull’asse del tempo operativo. In questo caso, l’operazione di
intercettazione anticipata “desemantizzante” riduce la componente
spaziale e conserva quella temporale che permette allora al verbo aller di
poter assumere un significato di futuro (più o meno immediato). Nel
grafico illustrativo che proponiamo qui sotto, si può determinare
esattamente in quale punto avviene intercettazione anticipata
“desemantizzante”:
120
Logos
b) La costruzione verbale italiana VENIRE + PARTICIPIO
PASSATO.
La costruzione verbale VENIRE + PARTICIPIO PASSATO
caratterizza le forme verbali dei tempi semplici dell’indicativo passivo dei
verbi italiani transitivi. La frase:
“La mela è mangiata da Paolo”
è simile alla frase:
“La mela viene mangiata da Paolo”.
In questo caso, il verbo “venire” funziona quasi come un ausiliare.
La sfumatura semantica tra i due enunciati riguarda elementi di tipo
aspettuale e più precisamente la progressività. L’introduzione di questo
significato aspettuale avviene tramite l’aktionsart imperfettivo e molto
“progressivo” del verbo “venire”. Come per la costruzione francese
ALLER + INFINITO, possiamo considerare che siamo davanti ad
un’intercettazione anticipata “desemantizzante” che tende a ridurre il
significato pieno del verbo “venire” ai tratti semantici di “progressività”
Le operazioni memoriali del linguaggio nell’ambito della psicomeccanica
del suo aktionsart. L’azione dei verbi coniugati ai tempi semplici
(dall’aspetto morfologico “incompiuto”) della forma passiva assumono
in questo modo un’aspettualità progressiva. Ovviamente, nei tempi
composti, una tale associazione diventa impossibile a causa della forte
incompatibilità tra l’imperfettività progressiva del verbo “venire” e
l’aspetto morfologico compiuto dei tempi verbali composti.
Ecco la rappresentazione grafica che proponiamo per esplicitare
questo meccanismo:
c) L’uso dell’imperfetto dell’indicativo per l’espressione
dell’irreale dopo la congiunzione ipotetica francese SI (SE)
Fino alla fine del '600, la lingua lingua francese del periodo classico
usa per l’espressione dell’irreale il congiuntivo imperfetto o
piuccheperfetto nella proposizione ipotetica e il condizionale nella
proposizione principale. Abbiamo ad esempio:
S’il eût plu, je serais resté
(se fosse piovuto, sarei rimasto)
Per l’espressione dell’irreale nelle proposizioni subordinate
ipotetiche, la lingua francese ha scelto l’imperfetto dell’indicativo che
perde il suo valore temporale di passato mantenendo soltanto il valore
aspettuale d’incompiuto, diventando così accettabile per esprimere un
processo irreale:
122
Logos
S’il avait plu, je serais resté
(se fosse piovuto, sarei rimasto)
Al livello del significato, si tratta di una operazione di riduzione
semantica che permette all’imperfetto e al piùcheperfetto dell’indicativo
francese di essere limitati al loro valore aspettuale. Ecco lo schema
psicomeccanico che proponiamo:
4. Conclusione
Queste nostre riflessioni sulla psicomeccanica del linguaggio di Gustave
Guillaume e sul nuovo modello semantico proposta da Alvaro Rocchetti
permettono di evidenziare la centralità del concetto di tempo operativo in un
approccio teorico-linguistico di questo tipo. I meccanismi semantici di
intercettazione anticipata desemantizzante che riguardano le fasi della
semantogenesi e della metaforogenesi sono principi fondamentali che possono
spiegare numerosi fenomeni linguistici nell’ambito dell’evoluzione diacronica e
sistemica delle lingue.
Piero Marino
Edmund Husserl e l’umanità europea
“Freude, schöner Götterfunken
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder
Wo dein sanfter Flügel weilt.”
A mia madre…
Le opere di Edmund Husserl in cui appare con estrema chiarezza la
sua concezione del telos della cultura europea sono principalmente due. Si
tratta della conferenza tenuta a Vienna il 7 Maggio del 1935 dal titolo La
Crisi dell’umanità europea e la filosofia e delle riflessioni husserliane dello
stesso anno sul concetto di storicità1. Proprio perché entrambi i testi si
occupano di questioni essenziali nell’ultima fase della speculazione del
filosofo, hanno visto la luce all’interno del volume dell’Husserliana che
contiene la famosa opera sulla Crisi delle scienze europee.
Dando, inoltre, uno sguardo ai lavori husserliani del decennio
precedente, sembra che Husserl abbia inteso mostrare l’evoluzione di tale
telos ricostruendo il complicato intreccio tra il piano ideale e razionale
dell’evoluzione dello spirito europeo ed il piano empirico degli eventi
storici. A questo proposito sarà interessante far riferimento agli articoli
pubblicati negli anni ’20 sulla rivista giapponese «Kaizo»2 nei quali
La prima di queste due opere, dal titolo originale Die Krisis der europäischen
Menschentums und die Philosophie è stata pubblicata in E. Husserl, Die Krisis der europäischen
Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die Phänomenologische
Philosophie (Husserliana VI), hrsg.von di W. Biemel, Den Haag, 1959, pp. 314-318, ed é
disponibile in traduzione italiana in E. Husserl, La Crisi delle scienze europee e la
fenomenologia trascendentale: introduzione alla filosofia fenomenologica, a cura di E. Filippini,
Milano, 1997, pp. 328-358 e in Id., Crisi e Rinascita della cultura Europea, a cura di R.
Cristin, Venezia, 1999, pp. 47-92. Le riflessioni sulla storia sono invece pubblicate in
appendice a Id., Die Krisis der europäischen Wissenschaften, cit., e sono disponibili in
traduzione italiana in Id., La crisi delle scienze europee, cit., pp. 529-541.
2 Si tratta di: Id., Aufsätze und Vorträge (1922-1937) (Husserliana XXVII), hrsg. von
T. Nenon, H. R. Sepp, Dordrecht\Boston\London, 1989, pp. 3-94. La traduzione
1
124
Logos
Husserl traccia un’interpretazione filosofica dell’evoluzione della storia
europea dalle sue origini nella cultura greca fino all’età della crisi,
passando per la Riforma protestante, la Modernità e l’Illuminismo.
I suddetti articoli non sono però gli unici dai quali emerge la
concezione husserliana della storia europea. Di questa questione si
occupa interamente lo scritto L’idea di una cultura filosofica del 19243 che ha
visto la luce nel volume dell’Husserliana dal titolo Erste Philosophie.
Un’altra fonte dalla quale è possibile ricavare la concezione
husserliana del telos europeo è Storia critica delle idee4, sempre degli anni ’20,
in cui Husserl mostra l’evoluzione della filosofia dal mondo classico sino
all’era moderna.
Se da un lato queste riflessioni husserliane sulla storia della filosofia
esulano dal tema che ci accingiamo a trattare, dall’altro saranno utili per
mostrare con maggiore chiarezza quale è, secondo Husserl, il ruolo della
filosofia nella formazione della cultura europea. Questo ruolo apparirà
assolutamente centrale tanto da poterci permettere di affermare che, per
il filosofo moravo, l’idea di Europa si risolve interamente nell’ambito
dello sviluppo del pensiero filosofico.
A questo proposito saranno utili un altro paio di riferimenti. Si tratta,
in primo luogo, della comunicazione che nel 1934 Husserl spedì all’VIII
Congresso Internazionale di Filosofia a Praga dal titolo Über den
gegenwärtige Aufgabe der Philosophie 5 ed, in secondo luogo, di alcuni inediti
degli anni ’30 di recente pubblicati in Italia con il titolo La storia della
filosofia e le sue finalità6.
Proprio perché il telos della cultura europea appare determinato
dall’incontro tra elementi ideali ed elementi storico-empirici, ne
tratteremo l’evoluzione mostrando, in primo luogo, la concezione
generale della storicità europea secondo Husserl, ed, in secondo luogo,
soffermandoci sui singoli elementi che, a partire dalla cultura greca e
passando per il Medioevo, la Riforma protestante, la Modernità e
l’Illuminismo, giungono fino alla crisi contemporanea.
italiana dalla quale si daranno le citazioni è Id., L’Idea di Europa, a cura di C. Sinigaglia,
Milano, 1999, pp. 3-110.
3 Id., Die Idee einer philosophischen Kultur, in Id., Erste Philosophie (1923-24). Erster Teil:
Kritische Ideengeschichte (Husserliana VII), hrsg. von R. Boehm, Den Haag, 1956, pp. 8-17
e 32-36. La traduzione italiana è: Id., Crisi e Rinascita della cultura europea, cit., pp. 29-44.
4 Id., Erste Philosophie (1923-24). Erster Teil: Kritische Ideengeschichte (Husserliana VII),
cit. La traduzione italiana è: Id., Storia critica delle idee, a cura di G. Piana, Milano, 1989
(traduzione delle pp. 3-199).
5 Id., Über den Gegenwartige Aufgabe der Philosophie, in Id., Aufsätze und Vorträge (19221937), cit., pp. 184-221.
6 Id., La storia della filosofia e le sue finalità, trad. it. a cura di N. Ghigi, Roma, 2004.
Edmund Husserl e l’umanità europea
L’idea di Europa
1. Il “telos” europeo come “telos” filosofico
L’incipit della conferenza di Vienna del 1935, incentrata sulla
questione della crisi, mostra l’importanza della filosofia per la definizione
della natura della cultura europea7. Husserl scrive: «In questa conferenza
oserò tentare di suscitare un nuovo interesse per il tema, tanto discusso,
della crisi europea, e di sviluppare l’idea storico-filosofica (ovvero il
senso teleologico) dell’umanità europea. Mostrando la funzione
essenziale che devono esercitare in questo senso la filosofia e tutte le sue
ramificazioni, cioè le nostre scienze, riuscirò anche a mostrare la crisi
europea in una nuova luce»8.
Da quest’inizio appare chiaro che il problema della definizione del
telos e dell’identità della storia europea, a parere di Husserl, passa per la
filosofia in quanto fondamento di tutto il sapere. In particolare, il
compito di spiegare l’essenza teleologica della cultura europea passa per
una scienza dello spirito che abbia bandito qualsiasi elemento di
naturalismo o riduttivismo9. Infatti il filosofo scrive che il tema è
rappresentato dall’Europa spirituale e che quindi deve essere trattato dal
punto di vista della storia dello spirito10. Secondo Husserl, «questa
indagine rivelerà una sorprendente teleologia propria soltanto
dell’Europa, una teleologia strettamente connessa alla nascita e
all’affermazione della filosofia e delle sue ramificazioni, alle scienze
dell’antica Grecia»11.
Segue la definizione del campo d’essenza all’interno del quale è
possibile parlare di una peculiarità della cultura europea: «Come si
caratterizza la forma spirituale dell’Europa? Europa qui non va intesa
geograficamente, […] come se fosse possibile circoscrivere su questa
base gli uomini che vivono sul territorio europeo e considerarli l’umanità
europea. In un certo senso è evidente che rientrano nell’Europa i
Dominions inglesi, gli Stati Uniti, ecc., ma non gli esquimesi o gli indiani
7 A proposito del contesto nel quale Husserl pronunciò il discorso che stiamo
commentando, si veda P. Malina, Der “Österreicher Kulturbund”, in M. Benedikt, R.
Burger, Die Krisis der Phänomenologie und die Pragmatik der Wissenschaftsfortschrifft, Wien,
1986, pp. 250-272.
8 E. Husserl, La crisi dell’umanità europea e la filosofia, in Id., Crisi e rinascita della cultura
europea, cit., p. 47.
9 Cfr. ivi, pp. 48-52.
10 Cfr. ivi, p. 52.
11 Ivi, pp. 52-53.
126
Logos
che ci vengono mostrati nei baracconi delle fiere, o gli zingari che da
sempre vagabondano per l’Europa. Il termine Europa allude
evidentemente all’unità di una vita, di un’azione, di un lavoro spirituale,
con tutti i suoi fini, gli interessi, le preoccupazioni e gli sforzi, con le sue
conformità finali, i suoi istituti, le sue organizzazioni. […] Si tratta di
mostrare l’idea filosofica immanente alla storia dell’Europa (dell’Europa
spirituale), oppure, il che è lo stesso, la sua immanente teleologia, che, dal
punto di vista dell’umanità universale in quanto tale, si rivela con la
nascita e con l’inizio dello sviluppo di una nuova epoca dell’umanità; di
un’epoca in cui l’umanità vuole e può vivere ormai soltanto nella libera
costruzione della propria esistenza, della propria vita storica, in base alle
idee della ragione, in base a compiti infiniti»12. La cultura europea è
essenzialmente una cultura filosofica.
Per Husserl, «l’appartenenza all’Europa è qualcosa di estremamente
peculiare, qualcosa di tangibile anche per gli altri gruppi umani, i quali,
nella costante volontà della preservazione spirituale e a prescindere dal
calcolo dell’utilità, possono sentirsi indotti al tentativo di europeizzarsi»13,
mentre noi europei difficilmente saremmo portati a rinunciare alla nostra
forma culturale, giacché «sentiamo […] che nella nostra umanità […] è
innata un’entelechia che permane attraverso tutti i mutamenti delle forme
di vita europee e conferisce ad essi il senso di uno sviluppo verso quella
forma di vita e di essere che costituisce il suo eterno polo ideale»14.
Il senso profondo di tale entelechia non risiede in «una sorta di
sviluppo biologico graduale, dalla forma germinale alla maturazione e poi
fino alla vecchiaia e alla morte»15, giacché «per essenza non esiste una
zoologia dei popoli»16. Nella concezione husserliana i popoli sono unità
Ivi, pp. 53-54.
Ivi, p. 55.
14 Ibid. La questione della particolarità dell’appartenenza all’umanità europea ed il
rapporto tra questa e l’umanità in generale sono stati oggetto di una serie di studi volti a
mostrare, da un lato, il sostanziale eurocentrismo del pensiero husserliano (che risulta
abbastanza marcato se si fa riferimento alle citazioni precedenti circa l’esclusione dalla
spiritualità europea di zingari ed esquimesi), dall’altro la sua struttura aperta. Tra questi
ricordiamo: E. Holenstein, Europa und Menscheit. Zur Husserls kulturphilosophischen
Meditationen, in Phänomenologie in Widerstreit, hrsg. von C. Jamme, O. Pöggeler,
Frankfurt\München, 1989, pp. 40-64; K. Held, Husserl These von Europäisirung der
Menschheit, in Phänomenologie in Widerstreit, cit., pp. 13-39. Si vedano inoltre: B.
Waldenfels, L’Europa di fronte all’estraneo e R. Cristin, L’Europa, la fenomenologia e le ragioni
dell’interculturalità, entrambi in AA.VV., La Fenomenologia e l’Europa. Atti del convegno
Internazionale di Trieste 1995, a cura di R. Cristin, M. Ruggenini, Napoli, 1999, pp. 45-59 e
257-271, e E. Franzini, Oltre l’Europa. Dialogo. Differenze dello spirito, Milano, 1992.
15 E. Husserl, La crisi dell’umanità europea e la filosofia, cit., p. 55.
16 Ivi, pp. 55-56.
12
13
Edmund Husserl e l’umanità europea
spirituali ed in essi non si raggiunge mai una forma pienamente
determinata ed «il telos spirituale dell’umanità europea […] è un’idea
infinita verso cui tende segretamente, per così dire, l’intero divenire
spirituale»17.
Di seguito Husserl traccia un’analisi della genesi della cultura
europea, o per meglio dire, dello sviluppo teleologicamente orientato
della sua idea: «L’Europa spirituale ha un luogo di nascita. Non parlo di
un luogo geografico, di un paese, per quanto anche questo sia legittimo;
parlo di una nascita spirituale che è avvenuta in una nazione, o meglio in
singoli uomini e in singoli gruppi di uomini di questa nazione. Questa
nazione è l’antica Grecia del VII e del VI secolo a. C. In essa si delinea
un nuovo atteggiamento di alcuni uomini nei confronti del mondo
circostante. Da questo atteggiamento derivò una formazione spirituale di
genere completamente nuovo, la quale si trasformò rapidamente in una
forma culturale sistematicamente conclusa. I Greci la chiamarono filosofia.
Nella sua traduzione esatta, conforme al testo originario, questo termine
non significa altro che scienza universale, scienza del cosmo, della totalità
di ciò che è. Molto presto nasce l’interesse per il tutto, e perciò si pone
ben presto il problema del divenire onnicomprensivo e dell’essere nel
divenire, del suo particolarizzarsi in forme generali e nelle regioni
dell’essere. Così la filosofia si ramifica, la scienza unica si trasforma in
una serie di scienze particolari»18.
Per quanto possa sembrare paradossale, nella comparsa della
filosofia come scienza della totalità delle esperienze Husserl intravede il
fenomeno originario dell’Europa spirituale19.
La nascita della filosofia e della scienza, la diffusione di queste nuove
idee, determina un cambiamento essenziale nella vita degli uomini e delle
culture: «Con la prima concezione delle idee, l’uomo diventa a poco a
poco un uomo nuovo. Il suo essere spirituale entra nel movimento di
una progressiva trasformazione. Questo movimento avviene fin
dall’inizio nella comunicazione; nel proprio ambito di vita, risveglia un
nuovo stile di esistenza personale e, nella successiva comprensione, un
altrettanto nuovo divenire. In esso (e successivamente anche al di là di
esso) si diffonde anzitutto una particolare umanità che, vivendo nella
finitezza, vive protesa verso i poli dell’infinità. Cresce così un nuovo
modo di accomunamento e una nuova forma di comunità duratura, la cui
vita spirituale, nella comunione dell’amore per le idee, per la produzione
di idee e per la normatività ideale di vita, porta con sé l’orizzonte di un
Ivi, p. 56.
Ivi, pp. 56-57.
19 Cfr. ivi, p. 57.
17
18
128
Logos
futuro all’infinito: l’orizzonte di una infinità di generazioni che si
rinnovano nello spirito delle idee. Tutto ciò avviene dunque dapprima
nello spazio spirituale di una singola nazione, della Grecia, come
sviluppo della filosofia e delle comunità filosofiche. Al tempo stesso
sorge in questa nazione, per la prima volta, uno spirito culturale generale
che attrae nella sua orbita l’umanità intera, e si delinea così una
progressiva evoluzione nella forma di una nuova storicità»20.
L’idea della civiltà europea nasce pertanto alla luce del compito
infinito ed ideale della filosofia che consiste essenzialmente nel formare
una nuova umanità ed aprire per l’umanità europea una dimensione
storica di tipo assolutamente universalistico. La nuova storicità viene a
caratterizzarsi per il suo atteggiamento prettamente scientifico e
rigorosamente filosofico. Infatti: «La cultura extra-scientifica, non ancora
sfiorata dalla scienza, è un compito e un’operazione dell’uomo nella
finitezza. L’orizzonte infinitamente aperto in cui egli vive non è ancora
dischiuso; i suoi scopi e le sue azioni, le sue attività e i suoi cambiamenti,
la sua motivazione personale, di gruppo, nazionale o mitica, tutto si
muove nella dimensione del mondo circostante, finito e controllabile. In
questo ambito non ci sono compiti infiniti o acquisizioni ideali»21. Al
contrario, «con la nascita della filosofia greca e con la sua prima
configurazione, attuata attraverso una conseguente idealizzazione del
nuovo senso dell’infinità, si compie, da questo punto di vista, una
progressiva trasformazione che finisce con l’attrarre nel proprio ambito
tutte le idee della finitezza e perciò la cultura spirituale complessiva e
l’umanità che la rappresenta»22. La conseguenza di questo rivolgimento di
atteggiamento è che «per noi europei esistono anche al di fuori della sfera
filosofico-scientifica molte altre idee infinite […], ma esse devono i loro
analoghi caratteri di infinità […] soltanto alla trasformazione dell’umanità
che è avvenuta per mezzo della filosofia e delle sue idealità»23. La
conclusione è che «la cultura scientifica retta dall’idea dell’infinità
equivale a un rivoluzionamento totale dei modi dell’umanità in quanto
umanità creatrice di cultura»24.
L’atteggiamento proprio di questo rivolgimento essenziale è
l’atteggiamento teoretico che, nato in seno alla cultura greca, rappresenta il
superamento dell’atteggiamento naturale proprio del comportamento
Ivi, p. 58.
Ivi, p. 61.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid.
20
21
Edmund Husserl e l’umanità europea
spontaneo di popoli e culture, il «modo storico fondamentale
dell’esistenza umana»25.
La dimensione propria dell’atteggiamento naturale è dunque quella
della prassi, del libero orientamento nel mondo concreto e della
finalizzazione concreta del proprio comportamento e dei propri scopi. Al
contrario, «l’atteggiamento teoretico»26 - che si è visto prescrivere norme
infinite ed assolute - «è del tutto non-pratico»27 giacché «si fonda […] su
una epochè volontaria nei confronti di qualunque prassi, e perciò anche da
qualunque prassi di grado più elevato che, nell’ambito della vita
professionale, si proponga di servire alla dimensione naturale»28.
Secondo Husserl, l’identità teoretica dell’Europa - fondata sulla
scoperta filosofica della possibilità di andare oltre il mondo miticoreligioso, caratterizzato da una mancata razionalizzazione ed
universalizzazione dei propri principi – consiste nel tendere verso una
scienza fondante ed assoluta che si pone come meta l’elaborazione di
verità e valori assoluti, razionalmente fondati29.
Al termine della prima sezione della conferenza sullo spirito
europeo, Husserl conclude che l’Europa deve essere considerata come
«uno spirito nuovo che proviene dalla filosofia e dalle scienze particolari
che ne fanno parte, lo spirito della libera critica e della libera normatività,
uno spirito impegnato in un compito infinito, che permea tutta l’umanità
e crea nuovi e infiniti ideali»30. In una società così idealmente orientata «la
filosofia e, in essa, il suo peculiare e infinito compito, esercitano una
funzione di guida; la funzione di una libera ed universale riflessione
teoretica, che abbraccia anche tutti gli ideali e l’ideale complessivo:
dunque l’universo di tutte le norme»31.
La funzione che la filosofia deve costantemente esercitare all’interno
dell’umanità europea è una «funzione arcontica per l’umanità intera»32.
2. Il Telos storico dell’umanità
Nell’appendice alla Crisi delle scienze europee dal titolo Gradi della
storicità, cui si è fatto riferimento in precedenza, Husserl distingue tre
Ivi, p. 64.
Ivi, p. 66.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Cfr. ivi, pp. 67-77.
30 Ivi, p. 76.
31 Ivi, pp. 76-77.
32 Ivi, p. 77.
25
26
130
Logos
gradi nella formazione storica delle culture umane. Per il momento ci
occuperemo delle prime due fasi per tornare sulla terza fase nelle
conclusioni del saggio.
Il primo è rappresentato dalla storicità generativa originaria. Husserl
scrive: «La storicità generativa originaria, l’unità della vita spirituale, in
quanto vita di una comunità totale di persone umane generativamente
congiunte che […] riplasmano quel mondo circostante unitario che è il
loro mondo in un mondo circostante culturale, in un mondo che è
divenuto e continua a divenire in base alla loro attività; e ciò in un
duplice senso. Il mondo circostante delle cose della cultura (Kultur,
Sachen, Umwelt) è il mondo dei prodotti tramandati, dei risultati di passate
attività e delle forme tramandate di un agire conforme a un senso, di un
divenire delle cose della cultura […]. Ciò rende l’esistenza umana, e
correlativamente il mondo umano circostante, in quanto mondo
circostante di cose e in quanto mondo circostante personale, un che di
storico; l’esistenza umana è sempre un che di storico, in questo senso
lato, un che di inferiore, di primitivo, o di superiore, con una forma
spirituale misera o ricchissima, la cui ricchezza si basa su una tradizione
che continua a valere per quanto sedimentata e in costante
trasformazione. […] La storicità in questo senso generalissimo è già da
sempre in atto, e, in atto, è appunto un che di generale che inerisce
all’esistenza umana»33.
Questa prima fase della storicità viene a coincidere pienamente con
ciò che precedentemente abbiamo trovato indicato da Husserl come
forma naturale della storicità. Essa è propria delle culture pratiche e prescientifiche che guardano al mondo con atteggiamento ingenuo e
pragmatico. In una parola, con un atteggiamento naturale. Infatti in
questa forma di storicità «gli uomini non sono i funzionari di una idea
finale che abbiano voluto e realizzato»34.
L’idea finale compare proprio con la nascita della filosofia e della
cultura scientifica: «Può tuttavia sorgere negli uomini singoli e a partire
dagli uomini singoli […] una nuova vita finale, che non si limita ad
articolarsi nella totalità storica; correlativamente, quando queste
formazioni finali di nuovo genere vengono a inserirsi nella molteplicità
delle formazioni di senso già tipicamente valide, tessono un nuovo filo
nell’ordito della cultura, una nuova figura nella molteplicità delle figure;
questo fine, questo prodotto di nuovo genere, attribuisce qualcosa del
suo senso d’essere a tutto ciò che è già essente, e correlativamente: nello
33 Id., Gradi della storicità. Prima storicità, (Appendice XXVI al § 73), in Id., La crisi delle
scienze europee, cit., p. 529.
34 Ivi, p. 530.
Edmund Husserl e l’umanità europea
sviluppo della società organica, da quelle singole persone che creano il
nuovo senso finale emana l’impulso a una riplasmazione dell’intera
umanità, dell’associazione totale della generatività (dell’unità storica), che
crea poco a poco una nuova umanità, che ha come obbiettivo una
cultura di nuovo genere, che non soltanto è organica, ma che ha anche
attinto all’azione creativa dei singoli in un senso totale di tipo nuovo.
Filosofia e formazione della cultura europea. La filosofia al suo primo
grado, conoscenza del mondo, conoscenza degli uomini; è questo il
secondo grado della storicità, e insieme un secondo grado
dell’umanità»35.
Per Husserl il vivere umano è essenzialmente connotato dalla
dimensione del divenire storico ed in questo senso ogni civiltà umana è
una civiltà storica. Tuttavia il senso specificamente storico del vivere
umano è dato dalle forme scientifiche – e quindi filosofiche dell’umanità. Infatti: «La vita umana è necessariamente storica, in
generale e, in quanto vita culturale, lo è con una particolare pregnanza.
Ma la vita scientifica, la vita degli scienziati nell’orizzonte degli altri
scienziati, comporta una nuova storicità»36.
Ed infatti altrove Husserl scrive: «“La cultura specificamente
storica”: secondo il suo senso finale è una connessione delle operazioni,
che dà a tutte le operazioni una posizione nel tempo storico in quanto
continuità dei presenti comuni»37.
Se dunque, da un lato, la storicità è una caratteristica primaria del
vivere sociale e culturale di tutte le forme e civiltà dell’umanità, dall’altro
lato, per Husserl, si può parlare di un vero e proprio senso della storicità
unicamente quando siamo di fronte ad una civiltà e ad una comunità che
si ponga dei fini e degli obbiettivi di tipo assoluto che la dirigano e le
donino un senso assoluto ed infinito. Pertanto la cultura europea, figlia
dell’infinitezza ed universalità della tensione del pensiero filosofico, non
è, a differenza della altre culture, un mero tipo empirico, ma piuttosto la
forma universale e razionale del vivere umano e scientifico che reca in sé
una forma assoluta38.
L’aspetto più interessante del discorso è che in queste appendici al
testo della Crisi, diversamente che nella conferenza viennese del ’35,
Husserl ha inteso mostrare il telos ideale ed assoluto dell’umanità intera al
di là della specifica genesi all’interno del mondo greco ed europeo.
Ibid.
Id., Appendice XXVII (al § 73), cit., p. 535.
37 Ivi, p. 458.
38 Cfr. Id., La crisi delle scienze europee, cit., p. 44.
35
36
132
Logos
Si configura così in qualche modo una distinzione tra il piano
dell’evoluzione della civiltà europea ed il piano ideale della storicità
universale. Sotto quest’ultimo aspetto, il telos dell’intera umanità viene a
coincidere con la progressiva evoluzione del sapere filosofico e
scientifico di tipo rigoroso che permea ogni aspetto della vita culturale.
3. Le fasi della storia europea
All’interno dell’evoluzione culturale del mondo europeo, Husserl
individua essenzialmente tre fasi storiche: la greca, la medievale e la
moderna. A queste si deve aggiungere la riflessione sulla crisi della
cultura moderna. Ognuna di queste fasi occupa, nello svolgersi del telos
europeo, un suo ruolo peculiare. Come si è già accennato, la cultura
greca rappresenta la culla della civiltà europea, perché in essa si rendono
manifeste le caratteristiche essenziali del nostro mondo: l’interesse per il
sapere inteso in senso teoretico e l’interesse per la verità assoluta ed
incontrovertibile.
Il Medioevo, al contrario, rappresenta la fase della cultura europea in
cui fa irruzione il Cristianesimo, la religione rivelata che sottrae alla
ragione teoretica il ruolo predominante, attribuendolo alla fede. Il
superamento della fase storica del Medioevo è determinato dall’avvento
del Rinascimento e della Riforma protestante. Entrambe le forme
storiche, ognuna a suo modo, attribuiscono nuovamente autonomia alla
scienza, alla ragione e all’esperienza religiosa, quest’ultima intesa in senso
intimistico e non dogmatico. Ma è proprio lo spirito rinascimentale, e
con esso ciò che Husserl qualifica come Illuminismo, a caratterizzare la
modernità come autentica rinascita a perfezionamento dell’ideale
scientifico e teoretico della cultura classica.
Un ultimo punto sarà dedicato all’analisi della crisi del mondo
culturale contemporaneo, che egli individua nella mancata realizzazione
delle promesse della modernità.
4. La Grecità – L’origine teoretica
Il saggio del 1923, dal titolo L’idea di una cultura filosofica, al quale si è
già fatto riferimento in precedenza, tratta della nascita della cultura
filosofica nell’antica Grecia. Husserl scrive: «Il carattere fondamentale
della scienza greca […] è la “filosofia”, la sistematica ripercussione di un
interesse teoretico svincolato da qualsiasi altra finalità, dell’interesse cioè
per la verità puramente per amore della verità […]. Essa prepara una
Edmund Husserl e l’umanità europea
svolta per lo sviluppo dell’intera cultura che la conduce, nella sua
interezza, verso una destinazione superiore»39.
Il primo vero e proprio filosofo è rappresentato dalla figura di
Socrate: «Socrate fu il primo a riconoscere […] quelle questioni che
riguardavano il destino degli uomini nel loro cammino verso un’autentica
umanità»40. La filosofia, caratteristica peculiare della cultura greca, si pone
come obbiettivo, già dai tempi dei greci, la realizzazione di un’autentica
umanità. Socrate stesso viene definito un «riformatore pratico»41. Infatti:
«La riforma etica di Socrate è caratterizzata dall’aver inteso come vita
veramente appagante una vita fondata sulla pura ragione. Ciò significa:
una vita in cui l’uomo esercita, in un’incessante autoriflessione e in un
radicale render ragione [Rechenschaftsabgabe], una critica […] dei propri
scopi vitali e […] una critica delle proprie vie e dei propri mezzi vitali.
Questo render ragione, questa critica si realizza come processo
conoscitivo, e precisamente, secondo Socrate, come ritorno metodico
alla fonte originaria di ogni diritto e della sua conoscenza; detto nel
nostro linguaggio: mediante il ritorno alla completa chiarezza, alla
“comprensione intuitiva”, all’”evidenza”»42. Lo scopo etico del pensiero
socratico si realizza in un processo critico di autoriflessione che segue un
metodo di completa chiarificazione razionale: «In esso, a ciò che si
presume bello e buono vengono contrapposti in senso normativo il bello
e il buono che emergono dal chiarimento pieno, diventando così oggetti
di un vero sapere»43.
Volendo esemplificare il ruolo storico del pensiero socratico – che
viene ad essere paradigmatico del pensiero e della cultura greca nella sua
genesi - Husserl scrive: «Socrate, il moralista pratico, ha posto al centro
dell’interesse (etico-pratico) l’opposizione fondamentale di ogni vita
personale desta, cioè quella tra l’opinione oscura ed evidenza. Egli per
primo ha riconosciuto la necessità di un metodo universale della ragione,
riconoscendo il senso fondamentale di questo metodo come critica
intuitiva e a priori della ragione; ossia, con parole più precise, come
metodo di autoriflessioni che apportano il chiarimento e che si
compiono nell’evidenza apodittica, intesa come fonte primigenia di
qualsiasi definitività. Egli per primo intuì il consistere-in-sé delle
essenzialità pure e generali in quanto assolute autodatità di un’intuizione
generale e pura. In rapporto a questa scoperta il radicale render ragione
Id., L’idea di una cultura filosofica, cit., p. 29.
Ibid.
41 Ibid.
42 Ivi, p. 34.
43 Ivi, p. 35.
39
40
134
Logos
che Socrate richiede in senso universale per la vita etica ottiene eo ipso la
forma significativa di una normativa di principio, ossia di una
legittimazione di principio della vita attiva secondo le idee generali della
ragione, che devono essere messe in luce per mezzo dell’intuizione
eidetica pura»44.
D’altro canto, Husserl osserva come «solo con Platone le idee pure
di scienza, di teoria, di conoscenza autentica e […] di filosofia autentica,
siano entrate nella coscienza dell’umanità»45. Inoltre: «Platone è anche il
creatore del problema filosofico e della scienza del metodo; cioè del
metodo per realizzare sistematicamente l’idea finale della “filosofia”
insita nell’essenza della conoscenza stessa. La conoscenza autentica, la
verità autentica (valida in sé, determinante in modo definitivo), l’essente
in senso vero e autentico (in quanto sostrato identico delle verità
determinanti in senso definitivo) diventano per lui correlati eidetici. Il
sistema complessivo di tutte le verità valide da conseguire in un possibile
conoscere autentico, forma necessariamente un’unità teoreticamente
connessa e che deve diventare metodicamente operante: l’unità di
un’unica scienza universale. Questa è la filosofia nel senso di Platone. Il
suo correlato è dunque la totalità di tutto ciò che è in senso vero»46.
Il senso profondo della filosofia socratico-platonica si riassume in
queste ultime battute: «L’elevazione dell’uomo all’altezza di una vera e
autentica umanità presuppone lo sviluppo della scienza autentica nella
sua totalità universale, radicata nei principi. Essa è la sede conoscitiva di
ogni razionalità; a essa coloro che sono chiamati a guidare gli uomini - gli
arconti - attingono quelle intuizioni evidenti secondo le quali
conferiscono un ordine razionale alla vita della comunità»47.
La nascita delle idee socratiche e della filosofia platonica
determinano lo sviluppo della civiltà greca ed europea in un senso ben
preciso. Husserl scrive che «attraverso queste visioni del mondo si
delinea l’idea di una cultura di nuovo genere; cioè di una cultura in cui
non soltanto si sviluppa, tra le altre forme culturali, anche la scienza che
tende sempre più consapevolmente al suo telos di “scienza autentica”, ma
in cui la scienza è destinata ad assumere e tende sempre più
Ivi, p. 36.
Ivi, p. 38.
46 Ibid. Un’analoga riflessione husserliana sul metodo scientifico universale della
scienza filosofica greca la ritroviamo nel già citato Storia critica delle idee, nel terzo
capitolo, pp. 52-68. In particolare il ruolo della dialettica nel platonismo è analizzato alle
pp. 56-62. Lo stesso è rintracciabile in E. Husserl, Über den Gegenwartige Aufgabe der
Philosophie, in Id., Aufsätze und Vorträge (1922-1937), cit., pp. 187-197, in cui Husserl
tratta il concetto di episteme nella filosofia platonica ed in quella aristotelica.
47 Id., L’idea di una cultura filosofica, cit., pp. 40-41.
44
45
Edmund Husserl e l’umanità europea
consapevolmente ad assumere la funzione di ηγεμονικóν dell’intera vita
della comunità e quindi anche della cultura in generale»48. Infatti: «La
suprema condizione di possibilità della sua formazione culturale fino al
livello di una cultura vera e “autentica” è la creazione di una scienza
autentica. Essa è lo strumento necessario per l’elevazione e per il miglior
raggiungimento possibile di ogni altra cultura autentica, di cui essa è al
tempo stesso un’espressione. Tutto ciò che è vero e autentico deve
potersi mostrare come tale, e lo può soltanto come libera produzione,
sorta dall’evidenza dell’autenticità dei fini. La dimostrazione ultima, la
conoscenza ultima di ogni autenticità assume la forma della conoscenza
giudicativa e, in quanto tale, è subordinata a norme scientifiche. Essa ha
la propria massima forma razionale nella legittimazione di principio,
quindi nella filosofia»49.
Per tutti questi motivi Husserl considera la cultura greca come una
cultura che, più delle altre, è stata segnata dalla necessità di
razionalizzazione ed universalizzazione del vivere individuale e
comunitario, entrambi da sottoporre ad una normatività universale ed
assolutamente valida. La cultura greco-europea è, secondo Husserl, da
considerarsi una cultura pienamente filosofica. A questo proposito la
conclusione del testo è molto interessante e ci introduce al tema dello
sviluppo del telos europeo nel corso della storia: «Il carattere
fondamentale della cultura europea può essere delineato come
razionalismo, e la sua storia può essere considerata dal punto di vista
della lotta per imporre e per ampliare il suo senso peculiare, dal punto di
vista del conflitto con la razionalità. Infatti tutte le battaglie per
un’autonomia della ragione, per la liberazione dell’uomo dai vincoli della
tradizione, per la religione “naturale”, per il diritto “naturale” ecc. sono,
in ultima istanza, battaglie, o rinviano a battaglie, per la funzione
normativa universale delle scienze che vanno sempre di nuovo fondate e
che, infine, abbracciano l’universo teoretico»50.
Anche nell’articolo dei primi anni ’20, dal titolo Tipi formali di cultura
nello sviluppo dell’umanità, Husserl si occupa di delineare le caratteristiche
essenziali della cultura greca e, anche in questo caso, le ritrova
nell’approccio prettamente teoretico della filosofia e della scienza greca.
Esso si fonda su di un moto di libertà che pone come obbiettivo la
Ivi, p. 41.
Ibid.
50 Ivi, p. 44.
48
49
136
Logos
liberazione dell’uomo e della comunità dai pregiudizi irrazionali della
tradizione e del sentire comune51.
A proposito di questo Husserl scrive: «Con Socrate nasce, per
giungere con Platone al suo compimento, la grande idea che la filosofia
ingenua, la conoscenza che si dispiega nell’ingenua attuazione
dell’interesse teoretico, non permette ancora una filosofia autentica, un
sistema di validità oggettive che chiunque sia atteggiato e pensi in modo
puramente oggettivo debba riconoscere come necessariamente
vincolante, per sé come per chiunque altro. La filosofia è possibile
soltanto se preceduta da una considerazione critica delle condizioni
generali di possibilità della conoscenza oggettivamente valida in quanto
tale; deve essere perfettamente chiarito il senso di tale conoscenza, il
rapporto tra il conoscere e ciò che è conosciuto, tra il giudizio e la verità,
nell’adeguazione di un’intenzione giudicante di un’opinione ottenuta in
un modo qualsiasi alla cosa nel suo essere data in sé, nonché l’essenza
della fondazione indiretta, e devono essere determinate le norme
essenziali e i metodi che le appartengono»52.
Il discorso prosegue mostrando come la grande novità del pensiero
socratico–platonico stia nell’avere messo al centro dell’interesse
scientifico la stessa idea di scienza, la sua metodologia, la sua necessità di
evidenze originarie53. La cosa ha, secondo Husserl, delle chiare ricadute
sull’intera civiltà greca ed europea: «La gloria imperitura della nazione greca
non è dovuta soltanto all’aver fondato una filosofia nella forma di una
cultura determinata da un interesse puramente teoretico, ma all’aver
compiuto, con le sue due stelle, Socrate e Platone, la creazione, unica nel
suo genere, dell’idea della scienza logica e di una logica intesa come
dottrina universale della scienza, come scienza centrale e normativa della
scienza in generale. In tal modo il concetto di logos, nel senso di una
ragione autonoma e, innanzitutto teoretica, quale facoltà di un giudicare
“disinteressato” che, in quanto giudicare sulla base della pura
comprensione evidente, presta ascolto unicamente alla voce delle cose
“stesse”, prende la sua versione originaria e al contempo la forza
destinata a dar forma al mondo»54.
Si può dire che il mondo greco, nella scoperta della filosofia come
metodologia critica universale, scopra l’idea stessa di verità che ha delle
ricadute concrete anche nel mondo della comunità, nella vita dei singoli
51 Cfr. Id., Tipi formali di cultura nello sviluppo dell’umanità, in Id., L’idea di Europa, cit.,
pp. 86-93.
52 Ivi, pp. 95-96.
53 Cfr. ivi, pp. 96-98.
54 Ivi, p. 98.
Edmund Husserl e l’umanità europea
individui e nella proposizione di valori etici. La filosofia come
metodologia critica universale nasce con il compito di superare, sulla
base di un metodo puramente razionale e logico, il relativismo e lo
scetticismo della filosofia sofistica, contro il quale nulla aveva potuto fare
la filosofia ingenua e naturalistica dei pensatori pre-socratici. Tale lotta al
relativismo sofistico è, al tempo stesso, la lotta al dogmatismo e alla
limitazione autoritaria delle possibilità di apertura del pensiero
razionale55. Infatti, «col nome di filosofia, l’idea di una scienza rigorosa fondata
sulla libera ragione è l’idea culturale imperante e dominante»56.
Husserl mostra in modo assolutamente chiaro la differenza che
passa tra la concezione greca della scienza e della filosofia e la
concezione dei popoli non europei anche nelle parole pronunciate alla
conferenza di Vienna nel 1935. Egli, infatti, si riallaccia alla distinzione
tra il pensiero proprio dell’atteggiamento naturale e quello criticospeculativo: «Un’umanità che vive in modo naturale […] include motivi
mitico-religiosi e una prassi mitico-religiosa. L’atteggiamento miticoreligioso si produce semplicemente quando il mondo diventa tematico in
quanto totalità, e cioè tematico in senso pratico […]. All’atteggiamento
mitico-naturale ineriscono preliminarmente e anzitutto non solo gli
uomini e gli animali e altri esseri subumani, ma anche esseri sovraumani.
Lo sguardo che li abbraccia tutti nella loro totalità è uno sguardo pratico
[…]. In quanto l’intero mondo risulta […] dominato da forze mitiche, e
nella misura in cui il destino umano è direttamente o indirettamente
dipendente da questo dominio, è possibile che la prassi susciti una
considerazione mitico-universale del mondo, che nutre a sua volta un
interesse pratico. È evidente che a essere motivati in questo
atteggiamento mitico-religioso siano anzitutto i sacerdoti, un clero che
amministra gli interessi mitico-religiosi, la loro tradizione e la loro
unitarietà»57. Il pensiero delle culture pre-europee ed extra-europee è
essenzialmente un pensiero pratico di tipo mitico-religioso e, quando
decide di elevare le proprie conoscenze pratiche ad un piano
maggiormente universale che dia una spiegazione della totalità del
mondo, raggiunge comunque il livello elevato di una cultura pur sempre
miticamente orientata, vale a dire non giustificata alla luce della ragione.
Per questo le acquisizioni culturali e scientifiche di queste culture «sono e
rimangono nozioni mitico-pratiche, ed è errato, è una falsificazione di
senso parlare, educati come siamo al pensiero scientifico nato in Grecia e
rielaborato nella scienza moderna, di una filosofia e di una scienza (di
Cfr. ivi, pp. 99-105.
Ivi, p. 105.
57 Id., La crisi dell’umanità e il destino della filosofia, cit., p. 68.
55
56
138
Logos
un’astronomia, di una matematica) indiane, cinesi, e interpretare l’India,
la Babilonia, la Cina in senso europeo»58.
Al contrario, da questo atteggiamento mitico-pratico «si stacca
decisamente l’atteggiamento “teoretico” […] a cui i grandi pensatori del
primo apogeo della filosofia greca, Platone e Aristotele, fanno risalire la
filosofia»59, giacché in esso «l’uomo è preso dalla passione per una
considerazione e per una conoscenza del mondo che si stacca da tutti gli
interessi pratici e che, nell’ambito circoscritto delle sua attività
conoscitive e nei tempi ad esse dedicati, persegue e produce soltanto una
pura teoria»60.
Una delle conseguenze essenziali della nascita del pensiero filosofico
occidentale è il cambiamento del rapporto con la tradizione. Infatti, «in
virtù dell’esigenza di sottoporre tutta l’empiria a norme ideali, cioè alle
norme della verità incondizionata, si delinea rapidamente una profonda
trasformazione dell’intera prassi dell’esistenza umana, e quindi di tutta la
vita culturale. Tale prassi non deve più accettare le norme dell’empiria
ingenua quotidiana e della tradizione, ma soltanto quelle della verità
oggettiva»61. Pertanto «o la filosofia rifiuta completamente la tradizione,
oppure ne riprende il contenuto e lo riplasma nello spirito dell’idealità
filosofica»62.
Forse il testo che mostra in modo più preciso la peculiarità dello
spirito greco è contenuto in un inedito del 1936-37, dal titolo La teleologia
dei mestieri ed il senso originario della filosofia. A proposito della
trasformazione essenziale che la filosofia opera nel mondo greco,
Husserl scrive così: «La questione concerne dunque la nota distinzione di
senso emersa all’inizio della filosofia antica, tra i titoli tramandati di δóξα
e ‘επιστήμη; l’una riguardante le verità (e le non verità) naturali pratiche,
58 Ivi, p. 69. La stessa riflessione a proposito del sapere dei popoli non europei si
trova nel già citato E. Husserl, Tipi formali di cultura nello sviluppo dell’umanità, p. 87.
59 Id., La crisi dell’umanità e il destino della filosofia, cit., pp. 69-70.
60 Ivi, p. 70.
61 Ivi, p. 75.
62 Ibid. Sul concetto di tradizione nella fenomenologia husserliana si veda A.
Ponsetto, Die Tradition in der Phänomenologie Husserls. Ihre Bedeutung für die Entwicklung der
Philosophiegeschichte, Meisenheim am Glan, 1978. I primi due capitoli si occupano
specificamente del ruolo che gioca la tradizione filosofica all’interno della
fenomenologia husserliana e dell’idea che di essa ha Edmund Husserl (pp. 11- 91),
mentre i restanti quattro capitoli (pp. 92-183) estendono il problema al concetto storico
di tradizione, occupandosi di analizzare la posizione husserliana in merito al rapporto
tra conservazione e riforma all’interno del mondo storico. Sul problema del rapporto
fra Husserl e la tradizione filosofica, si veda anche D. Heinrich, Über die Grundlagen von
Husserls Kritik der Philosophische Tradition, in «Philosophische Rundschau», 6 (1958), pp. 126.
Edmund Husserl e l’umanità europea
l’altra indicante una nuova verità specificamente filosofica, la quale
doveva essere in maniera assoluta quella valida per ognuno ed in ogni
tempo […]. Ed è così che si sposta dunque il concetto naturale della
ragione: dalla ragione spontanea e schietta dell’intelletto umano, naturale
e genuino, scaturisce ora la ragione scientifica, quella filosofica. Ma che
cosa motiva la distinzione? E cos’è che, nella donazione originaria del
senso, determina tale validità definitiva? Questo affrancamento dalla
relatività delle verità situazionali determina dunque, immediatamente, il
senso chiaramente nuovo dell’”ognuno e dell’in-ogni-tempo”, che non
può più certamente essere riferito alle mutevoli società-del-Noi, come
portatrici delle relative tradizioni. Il che meglio espresso, dicendo pur
sempre la medesima cosa, significa: come l’essere umano che conosce
supera le finitezze con cui ha a che fare nella vita pratica, come egli
“scopre” il mondo in quanto tema gnoseologico opposto al mondo
circostante particolare e come il mondo stesso è nella sua infinitezza»63.
Il pensiero filosofico determina il superamento della dimensione dei
singoli punti di vista particolari, siano essi propri di una cultura o del
singolo individuo, per elevarli alla comprensione di una dimensione
ulteriore, di tipo universale. Infatti: «Il greco prova disprezzo per i
barbari e […] le mitologie a lui estranee […] valgono per lui innanzitutto,
appunto, come barbariche, come stupide, come false di principio. Ma,
nell’ […] interazione tra i diversi popoli […] era certo possibile ad un
certo punto […] rendersi conto del fatto che in tutte le diversità dei
mitologemi propri e stranieri […] emergesse comunque sempre anche un
nucleo extra-mitologico, che tuttavia li include, avente il medesimo
contenuto come quell’identico che, in questi diversi popoli e mitologie,
viene soltanto diversamente appercepito. Si tratta certamente dello stesso
sole, della stessa luna, della stessa terra, dello stesso mare, ecc., che
diviene oggetto del mito così in maniera diversa nei diversi popoli, a
seconda, certamente della loro tradizione […]. Da allora in poi si compie
la prima scoperta della differenza tra un essere identico in sé e i
molteplici modi soggettivi di apprensione o di manifestazione […]. Con
ciò dunque si compie un’autentica rivoluzione nella costituzione del
senso del mondo. Prima il mondo era comprensibile per ognuno a
partire dalla sua tradizione nazionale come mondo circostante
infinitamente aperto e, anche relativamente alle regioni sconosciute,
l’essere insito in esse in maniera completamente indeterminata, era
comunque anticipato nell’aderenza ad un senso della tradizione. Ora,
E. Husserl, La teleologia dei mestieri ed il senso originario della filosofia, in Id. La storia
della filosofia e le sue finalità, cit., pp. 90-91.
63
140
Logos
invece, il mondo è l’universo di tutte le cose identiche, dell’”essente”nel nuovo senso
filosofico, il cui essere proprio è ritenuto diverso da tutte le apprensioni tradizionali»64.
Per questo motivo, Husserl definisce rivoluzionario «il cambiamento
del modo di pensare nel senso originario della filosofia presso i greci»65.
5. Il Medioevo e la Riforma – La religione
Come si è precedentemente accennato, Husserl considera il
Medioevo l’epoca della storia europea in cui la religione cristiana assume
un ruolo centrale e predominante.
Pertanto, per comprendere pienamente le riflessioni husserliane sul
Medioevo, è necessario intrecciarle con le riflessioni dello stesso filosofo
sulla religione e sul cristianesimo66.
La più importante testimonianza della concezione husserliana del
cristianesimo e della religione si trova nel già citato articolo sul
rinnovamento dal titolo Tipi formali di cultura nello sviluppo dell’umanità.
In primo luogo è opportuno segnalare come la religione in questo
testo sia considerata uno stadio nello sviluppo culturale dell’umanità.
Tale stadio culturale è, in prima istanza, rappresentato dalla religione
sorta in “modo naturale”. Questa forma di religione è caratteristica di un
popolo o di una comunità e non parte da un bisogno dei singoli individui
o persone, ma piuttosto dalla necessità di dare regole e norme ad un
gruppo. Inoltre, questo primo stadio della cultura religiosa è per sua
intrinseca natura caratterizzato da una struttura gerarchica, secondo la
quale ogni forma di espressione culturale – sia essa la morale, l’arte, la
filosofia - è sottoposta all’elemento religioso che viene a rappresentare
un sistema universale e dogmatico di validità assolute ed inconfutabili,
all’interno del quale non è possibile per il soggetto alcuna tensione tra
autorità e libertà67. Al contrario la seconda fase di sviluppo culturale è
occupata dalle religioni che nascono per un’istanza di libertà. Tra queste
64 Ivi, pp. 91-93. Il corsivo è mio. Si faccia riferimento, a tal proposito, all’articolo
di K. Held, La scoperta del mondo come nascita dell’Europa, in AA.VV., La Fenomenologia e
l’Europa. Atti del convegno Internazionale di Trieste 1995, cit., pp. 5-23.
65 Ivi, p. 93. A proposito della concezione husserliana della cultura greca, si veda
K. Held, Husserl und die Griechen, in «Phänomenologische Forschungen», 22 (1989), pp.
137-176. Il corsivo è mio.
66 Dal punto di vista personale Husserl si era formalmente convertito al calvinismo
prima di sposare sua moglie Malvine, ma non aveva deciso veramente di aderire ad
alcuna religione positiva e ad alcun dogma religioso. (Cfr. K. Schumann, Malvine Husserls
Skizze eines Lebensbildes von E. Husserl, in «Husserl Studies», 5 (1988), pp. 106-125).
67 Cfr. E. Husserl, Tipi formali di cultura nello sviluppo dell’umanità, cit., pp. 71-74.
Edmund Husserl e l’umanità europea
religioni Husserl annovera il cristianesimo che nasce dal libero bisogno
interiore della salvezza e, per questo, ha come propria tendenza evolutiva
l’espansione e diffusione in tutto il mondo antico che, invece, era
essenzialmente caratterizzato dalla prima forma di religiosità. Infatti, per
Husserl, il messaggio centrale della predicazione del Cristo sta nel
rapporto diretto con Dio che viene a realizzarsi nella sua vita e nella sua
predicazione68.
Il riferimento a Cristo fa la sua apparizione in questi termini:
«Il senso della nuova religione, in virtù del quale rappresentava un
nuovo tipo religioso, era che essa voleva essere una religione fondata non
sulla tradizione irrazionale, ma sulle fonti (razionali in un certo qual senso)
dell’originaria esperienza religiosa. Infatti, anche chi era cresciuto nella
religione doveva guadagnare il proprio personale rapporto con Cristo e,
tramite Cristo, con Dio, sulla base dell’originaria intuizione religiosa;
producendo effettivamente l’intuizione religiosa tramite il messaggio
evangelico a lui destinato, i racconti tramandatigli della vita di Cristo, delle
sue parabole e delle sue testimonianze, ecc., doveva intimamente prendere
una libera posizione, sentirsi unito a Dio e cercare l’accesso al regno di Dio
seguendo nella vita cristiana la norma intuitiva» 69.
È evidente che Husserl fa riferimento alla genesi della religione
cristiana nell’ambito della cultura ebraica. Questa nuova religione, nata
dalla predicazione del Cristo, si presenta come una religione non
dogmatica, come una religione della libertà. Husserl scrive:
«Non appena il nuovo movimento, quello della libera religione, si
diffonde vittoriosamente nel mondo antico, e in esso la coscienza della sua
vocazione a religione mondiale assume la forma di sicura speranza, si profila
necessariamente all’orizzonte anche il compito di una concreta formazione
dell’intera vita culturale, compreso ogni suo ordinamento statale, nel senso
della visione del mondo cristiana, e deve assumere la forza di una entelechia
che domini l’evoluzione dell’umanità culturale. La nuova Chiesa deve
<cercare> di diventare influente sugli stati esistenti e soprattutto
sull’impero romano, e deve a sua volta fare propria l’idea di un impero
mondiale, di una Chiesa che domini sul mondo intero - che domini nella
piena accezione del termine e non nel senso di un potere che determini e
regoli certe convinzioni private degli uomini. Alla Chiesa che deve formarsi
in modo nuovo è così indicata la via di una Chiesa gerarchica e le è
assegnato il compito di una fondazione di uno Stato mondiale gerarchico, di
una civitas dei, in cui tutte le attività sociali umane, tutti gli ordinamenti
sociali e tutte le istituzioni, tutte le operazioni culturali, siano sottoposti a
norme religiose. La novità di questa idea gerarchica […] consiste nel fatto
che la religione […] si sa come una religione creata sulla base di originarie
68
69
Cfr. ivi, pp. 75-81.
Ivi, p. 79.
142
Logos
intuizioni religiose, di libere prese di posizione intuitivo-razionali, come una
religione fondata su di una fede libera e razionale, e non su di una cieca
tradizione»70.
La cultura medievale nasce dunque dallo sviluppo universale di quel
movimento di libertà che è rappresentato dalla religione cristiana, dalla
sua irruzione nel mondo classico greco-romano. E tuttavia essa non è
priva dell’influenza culturale di tale mondo, giacché «questa evoluzione si
compie realmente, intrecciandosi però con quell’altro movimento di
libertà […] che ha le sue fonti non nella fede, ma nel sapere, più
precisante nello sviluppo di ciò che noi oggi chiamiamo semplicemente
filosofia e scienza»71. Infatti, «nel momento in cui […] la diffusione
mondiale della cultura greca, scientificamente formata, e quella della
religione cristiana, si incontrano, e la razionalità intuitiva della fede si lega
simpateticamente con la razionalità della filosofia e della scienza o, come
anche potremmo dire, la libertà del cristiano con la libertà del filosofo,
diventando entrambe consapevoli della loro stretta parentela nasce il
“Medioevo”»72. Husserl considera la civiltà medievale la sintesi degli
elementi del mondo classico con la religione cristiana.
Husserl però non si limita a mostrare come gli elementi in questione
coabitino armonicamente in questa fase della storia europea, ma
sottolinea anche come ci siano, in tale forma di sintesi storico-culturale,
aspetti di tensione e contraddizione. Infatti:
«La religione, per sua stessa essenza, non può ammettere un’autonomia,
indipendente dalla fede, dal pensiero scientifico, ma deve necessariamente
interpretare ogni norma di validità in senso religioso, e nel far propria la
libera scienza deve al contempo limitarne la libertà con la norma creata sulla
base dell’intuizione religiosa e consolidata dai dogmi. Per altro essa non può
a sua volta fare a meno di elaborare concettualmente i contenuti intuitivi, ha
bisogno di una teologia […], intesa come scienza che doveva fissare
concettualmente e oggettivamente i contenuti di fede, dispiegarne le
conseguenze implicite e indagare gli effetti del divino nel mondo, nonché i
rapporti che ne risultano con l’uomo. Nel caso della teologia cristiana
questo fu lo scopo […] dell’apologetica, in risposta agli attacchi della
filosofia non cristiana, che andavano respinti se si voleva conquistare questo
mondo educato alla filosofia. Rispetto alle teologie appartenenti alle altre
cerchie culturali più antiche, la teologia cristiana non ha soltanto la
peculiarità derivatale dalla libertà cristiana (dalla presa di posizione religiosa
sulla base della fonti della razionalità intuitiva), ma soprattutto quella di
essersi appropriata nel metodo e nei fini della filosofia nata dallo spirito
Ivi, p. 80.
Ivi, pp. 80-81.
72 Ibid.
70
71
Edmund Husserl e l’umanità europea
della libertà teoretica, benché […] dotati di un nuovo spirito normativo e,
pertanto, […] essenzialmente trasformati. Essa riprendeva persino le norme,
conosciute nell’evidenza puramente teoretica, valide per ogni conoscenza
teoreticamente evidente (e, di conseguenza, libera). Per altro, faceva proprio
il fine di un’universale conoscenza teoretica del mondo - fine che non
poteva non alimentare un interesse teoretico destinato a svilupparsi
liberamente -, e al contempo il fine, cresciuto insieme a quello, di una
tecnologia universale, di un’indagine teoretica delle norme pratiche in base
alle quali l’uomo, sul fondamento della conoscenza del mondo, e dunque
anche di sé, doveva ordinare razionalmente la propria vita e trasformare
razionalmente il mondo circostante, trasformandolo in maniera costante» 73.
L’opinione di Husserl, in fondo, è che nella relazione e
fusione tra lo spirito filosofico proprio del mondo antico e lo
spirito religioso del cristianesimo, il cristianesimo stesso finisca
col prendere caratteristiche che progressivamente lo allontanano
dalla sua genesi unicamente religiosa. D’altro canto, la sintesi che
viene a prendere forma presenta comunque degli squilibri e
contraddizioni:
«Per quanto all’inizio l’interesse fosse concentrato sulla tutela
dell’intuizione originaria, della fede originaria, e sull’efficacia di questa su di
sé e su gli altri, e fosse dunque rivolto alla realizzazione dell’unificazione
con Cristo e, tramite Cristo, con Dio, nonché alle promesse di una felicità
eterna nell’Aldilà - il Cristianesimo, che era in via d’espansione, doveva pur
insediarsi in questo mondo, e per la vita di una comunità cristianizzata
divenne necessaria una forma religiosa razionale. Inoltre, il contenuto
fattuale e il corso naturale della natura, dell’intero Universo, in quanto
creato da Dio, dovevano essere compresi nell’unità della razionalità
religiosa. Le funzioni naturali dell’uomo, e specialmente l’intelletto umano,
non potevano restare escluse; quello che l’uomo spacciava per giustizia e
bene naturale, e considerava principio di assoluta validità, doveva dunque
essere ricondotto a Dio in quanto fonte di ogni norma e, dal punto di vista
soggettivo, alla fede in quanto fonte assoluta di conoscenza in cui avvertire
Dio. In tale modo la filosofia, la scienza dei greci, la creazione della ragione
naturale, viene ripresa, praticata con profitto e interpretata religiosamente
nelle sue fonti di validità sovrannaturali, ma al contrario viene anche
normata e delimitata dal contenuto della fede. Quest’ultimo, a sua volta, è
colto mediante concetti filosofici e scientificizzato, venendo a costituire
però, in quanto norma di fede oggettivamente consolidata, un ostacolo alla
libertà scientifica»74.
73
74
Ivi, pp. 81-82.
Ivi, pp. 82-83.
144
Logos
L’aspetto espressamente dogmatico della cultura medievale per Husserl
è rappresentato dal ruolo che la teologia svolge in relazione alle altre
forme scientifiche:
«La teologia, coerentemente, diviene sempre scienza universale […] e
ogni scienza […] ha la propria matrice teologica. Anche la conoscenza delle
scienze naturali, così come ogni altra conoscenza in generale, è una
funzione della religione e ha libertà soltanto nella forma della libertà
religiosa, cioè sulla base della fede. E allo stesso modo ogni prassi diventa,
secondo quell’idea, una funzione della religione, deve essere una prassi
teoretica, guidata dalla teologia»75.
Tuttavia Husserl, pur essendone estremamente critico, non vuole qui
soffermarsi sul processo di dogmatizzazione che ostacola la libertà
dell’interpretazione razionale e distoglie e allontana la vita religiosa del
credente dalle fonti originarie76. Ciò che invece gli preme è mostrare «il
forte slancio che caratterizza lo sviluppo della cultura medievale e che
per secoli non ha tuttavia sofferto di tale esteriorizzazione, nonché l’idea
centrale che conferisce alla vita medievale tale slancio»77.
Il discorso husserliano a tal proposito è di particolare interesse:
«Benché non riesca a fondersi, non solo dal punto di vista ecclesiastico
ma anche da quello politico, in un’unità statale, l’”Occidente” medievale
costituisce un’unità di cultura gerarchica, ed è, in senso ancor più elevato e
più ricco al suo interno di differenziazioni rispetto alle antiche culture
gerarchiche, una cultura che reca in sé un’idea teleologica che
consapevolmente la guida, un’idea che, dunque, è realmente concepita nella
coscienza della comunità occidentale e ne motiva realmente lo sviluppo allo stesso modo di uno scopo pratico consapevole del singolo soggetto.
L’Occidente medievale ha innanzitutto nella Chiesa un potere spirituale che
si estende al di là di ogni singolo Stato e che comunque interviene nella vita
delle comunità nazionali dei singoli Stati, una comunità sacerdotale
sovranazionale, organizzata in modo imperialistico, che produce tra le
nazioni una coscienza comune sopranazionale e che è ovunque riconosciuta
alla stesso modo, quale portatrice dell’autorità divina e organo deputato alla
guida spirituale dell’umanità. Ma in questa comunità particolare, nella
Chiesa, l’idea teleologica che regna consapevolmente è l’idea della civitas dei,
e questa lo è, in modo indiretto, anche per l’intero Occidente accomunato
nella religione. Un impero politico in cui la Chiesa rappresenti l’autentico
potere o, ancor prima, diventare in ogni Stato il potere che lo avvicini
all’ideale della civitas dei, fare ogni cosa al servizio di questa cristianizzazione
dell’intera cultura, creare anche una teologia universale, nella forma di una
scienza universale teoretica e pratica, e di indagare scientificamente, e in
Ivi, p. 83.
Cfr. ivi, pp. 83-84.
77 Ibid.
75
76
Edmund Husserl e l’umanità europea
tutte le sue vere forme normative, la vita politica: sono questi gli scopi che
determinano essenzialmente la vitalità del movimento spirituale del
Medioevo. Non si tratta di vuoti ideali, ma di finalità che si crede di
raggiungere nel corso del tempo e per le quali si lavora con gioia
considerandole una missione religiosa» 78.
Il discorso si conclude assegnando al mondo medievale un ruolo
essenziale nello svolgersi dell’idea di ragione nella storia europea:
«Questa è dunque la forma in cui nel Medioevo l’umanità europea si
organizza come umanità razionale alla luce di un’idea di ragione, e cerca di
realizzare una vita comune conforme al suo scopo»79.
Se dunque, da un lato, il Medioevo è caratterizzato dalla
contraddittoria presenza di elementi propri della cultura filosofica greca,
basata secondo Husserl sulla libera possibilità di utilizzo della ragione e
sulla centralità della scienza, e di elementi propri di un pensiero
essenzialmente religioso fondato sul primato dogmatico del pensiero
teologico, d’altro canto in esso si rende manifesta una tendenza
teleologica all’universalità e all’unità che, seppur alla luce del pensiero
teologico e sacerdotale, rappresenta una fase fondamentale nel cammino
del pensiero occidentale caratterizzato - come abbiamo visto in
precedenza - da una tensione essenziale all’universalizzazione di scopi e
principi.
La relazione tra il pensiero filosofico ed il pensiero religioso è ben
espressa da questa riflessione husserliana degli anni ’20:
«Al concetto di Dio inerisce per essenza il singolare. Ad esso inerisce
anche il fatto che la sua validità d’essere e di valore viene esperita dall’uomo
come un vincolo interiore assoluto. A questo punto avviene la fusione tra la
sua assolutezza e l’assolutezza dell’idealità filosofica. Nel processo generale
di idealizzazione che emana dalla filosofia, Dio subisce per così dire una
logicizzazione, diventa cioè il rappresentante del logos assoluto. Io vedrei un
elemento logico già nel fatto stesso che la religione si richiama
teologicamente all’evidenza della fede»80.
Da questo passo estremamente sintetico si possono ricavare delle
conseguenze che vanno a toccare la concezione husserliana della società
religiosa medievale. Se, infatti, la concezione di Dio del mondo
medievale era basata su un fondamento essenzialmente fideistico, allo
stesso tempo esso aveva bisogno di un sostegno razionale, di tipo
78 Ivi, pp. 84-85. Un’analisi analoga del mondo culturale medievale è rintracciabile
in E. Husserl, Beilage V (zu S. 68), Kirche und christliche Wissenschaft <1922-23>, in Id.,
Ausätze und Vorträge (1922-1937), cit., pp. 103-105.
79 Id., Tipi formali di cultura nello sviluppo dell’umanità, cit., p. 85. Il corsivo è mio.
80 Id., La crisi dell’umanitá europea e il destino della filosofia, cit., p. 75.
146
Logos
prettamente filosofico. Allo stesso modo in cui l’intero mondo culturale
teologicamente orientato del Medioevo si era appropriato del pensiero
razionale proprio della civiltà classica. La conseguenza di questo incontro
non privo di contrasti è stata la civiltà medievale coi suoi propositi di
tipo universalistico. Ma è proprio da queste contraddizioni che emerge,
per Husserl, la maggiore fondatezza e razionalità intrinseca del pensiero
filosofico di origine greca. Come nel determinare l’idea di Dio,
l’elemento logico e razionale gioca, secondo Husserl, un ruolo
preminente rispetto alla fede, così la razionalità scientifica, con la fine del
Medioevo, deciderà di liberarsi dal velo teologico del pensiero medievale.
Questo avviene essenzialmente nelle due tappe della Riforma
protestante e del Rinascimento.
La Riforma protestante «rivendica contro la Chiesa così come è
storicamente divenuta il diritto originario dell’intuizione religiosa e
propugna l’originaria “libertà del cristiano”»81. Essa «non fa appello ad
una nuova rivelazione, né si identifica in un nuovo Messia, ma restaura
soltanto le fonti ancora vive e attive della tradizione originaria [al fine] di
istaurare, a partire da esse, un rapporto vivo con Cristo e con l’originaria
comunità cristiana tramite l’esperienza religiosa delle origini»82.
La Riforma, in qualche modo, rappresenta per Husserl una forma di
religione fondata sull’esperienza evidente ed originaria della vita religiosa
(privata della mediazione sacerdotale) e pertanto maggiormente vicina
alla forma della libera razionalità.
Tuttavia la concezione luterana della religione, pur rappresentando
un superamento della Civitas dei, è pur sempre un’espressione culturale
incentrata sull’esperienza della fede, alla quale deve essere sottoposta
qualunque espressione della vita umana. In particolare la religione
cristiana riformata è pur sempre basata sul primato del problema della
salvezza dell’anima dell’uomo, e non sul principio assoluto della
conoscenza teoretica disinteressata. Anche per questo, secondo Husserl,
«la Riforma non si impone in maniera incondizionata e duratura,
arenandosi in una nuova Chiesa che, nonostante l’efficacia […] delle idee
riformatrici, non è in grado di istillare nella Modernità alcuna nuova idea
teleologica››83. La Riforma non può riuscire nel suo radicale obbiettivo di
autentica riforma della cultura occidentale, giacché la forza che, secondo
Husserl, è destinata a raggiungere tale scopo, è quella che nasce dal libero
Id., Tipi formali di cultura nello sviluppo dell’umanità, cit., p. 85.
Ivi, p. 85-86.
83 Ivi, p. 85.
81
82
Edmund Husserl e l’umanità europea
utilizzo della ragione non in campo puramente teologico-religioso, ma in
campo filosofico e scientifico84.
Questa la conclusione del discorso husserliano sul Medioevo che val
la pena di citare per intero:
«Ben differente è la situazione per l’altro movimento di libertà che lotta
contro i vincoli dello “spirito” medievale e contro l’idea di un impero
ecclesiastico – il movimento di libertà della ragione naturale proprio della
filosofia e della scienza […]. Ciò che riforma o restaura è la scienza: rifiuta
la scienza medievale, considerandola teologia non libera (o scienza
teologicamente improntata), e recupera l’idea di filosofia nella sua accezione
antica, intesa come una scienza che non è determinata dalla fede, di
qualunque forma essa sia, né dalle motivazioni dell’animo, dal bisogno di
salvezza che ha origine nell’indigenza umana, ma è puramente oggettiva, ed
è funzione dell’interesse puramente teoretico»85.
Il Medioevo, sotto il profilo concettuale ed ideale, si sgretola di
fronte a due movimenti di rinascita che, ognuno a modo proprio, si
richiamano da un lato al ritorno alle origini, dall’altro a un utilizzo libero
della razionalità. Con la fine del Medioevo scompare la forma teologica
della civiltà europea, ma non scompare assolutamente l’influsso
essenziale del cristianesimo che, trasformato nelle forme proprie di un
pensiero moderno, prosegue nel suo ruolo fondativo della civiltà
occidentale. Senza dubbio ed in questo senso, proprio in quanto religione
nata da un movimento di libertà, il Cristianesimo va ad inserirsi nello
sviluppo teleologico della ragione europea, rappresentandone un punto
centrale ed essenziale.
Questo è il giudizio conclusivo da parte di Husserl circa il ruolo
svolto dalla cultura medievale sulla spiritualità europea e circa il suo
declino:
«Si può ora comprendere l’enorme mutamento dovuto allo sviluppo
dello spirito medievale. L’antico spirito della libera cultura dell’umanità, e
dunque l’idea di una vera humanitas che reggeva la pura grecità, l’idea cioè di
un’autentica vita della cultura fondata sulla libera ragione filosofica, perde la
propria forza e non è più parte integrante della coscienza generale. Se in
precedenza erano i filosofi a rappresentare il principio normativo
Ciononostante, è evidente la simpatia nutrita da Husserl per lo spirito della
Riforma protestante. Altrove, scrive che «il protestantesimo della Riforma é la nascita di
una libera presa di posizione nei confronti della tradizione ecclesiastica e la messa in
atto di un libero esame del contenuto della fede testimoniato dalle scritture, ovvero il
compimento dell’esperienza di fede originaria delle più antiche comunità nella nuova
rivelazione e il rifiuto del tradizionalismo dei dogmi», Id., Beilage V (zu S. 68): Kirche und
christliche Wissenschaft <1922-23>, cit., p. 104.
85 Id., Tipi formali di cultura nello sviluppo dell’umanità, cit., p. 86.
84
148
Logos
dominante della libera ragione (in quanto rappresentavano, in base all’idea,
la forma dell’autentico essere umano), ora sono i sacerdoti i rappresentanti
del nuovo principio fondamentale di ogni norma, la civitas dei. Se la
comunità filosofica era, per così dire, comunistica e l’idea guida non era
retta da alcuna volontà sociale onnicomprensiva, ora la comunità
corrispondente, quella dei sacerdoti, è imperialistica e dominata da una
volontà unitaria. La loro idea della civitas dei viene da essa incorporata nella
vita complessiva della comunità medievale come un’idea teleologica
normativa, destinata a determinare in generale, dal punto di vista pratico, il
movimento della cultura, e questo in virtù della sua posizione autoritaria
nella coscienza pubblica. L’umanità europea, nella forma dell’umanità
medievale, mantiene però una stretta continuità con quella antica,
soprattutto perché la filosofia greca continua a modellare la vita spirituale
[…]. Ma il mutamento di senso reca in sé l’intenzionalità del mutamento,
conservando di nascosto le motivazioni atte a operare la svolta inversa. Là
dove non è spento, il lume naturale della ragione non smette di essere tale e
di illuminare, anche se viene interpretato in chiave mistica come
irraggiamento del lume sovrannaturale E questa interpretazione può
nuovamente venir meno […]. È compito dello storico mostrare la rinascita
dello spirito antico, le motivazioni effettive che storicamente hanno agito
nel contesto concreto dello sviluppo e dei singoli casi. Ciò che a noi
interessa è il fatto che una tale rinascita abbia avuto luogo nella forma di un
grande movimento di libertà […]. L’antica idea culturale ritorna ad essere
viva e scaccia l’idea medievale dal suo trono. La Chiesa e la teologia non
rappresentano più lo spirito che domina la cultura dell’umanità, e l’idea
teleologica centrale che in esse è cresciuta non è più, tramite loro, l’idea
teleologica dell’umanità europea, ma sopravvive unicamente quale elemento
costitutivo della mera dottrina e teologia ecclesiastiche, la quale rappresenta
ora un ambito della cultura tra gli altri, e non può avanzare la pretesa che la
sua idea della civitas dei sia qualcosa di più di una norma che la comunità dei
sacerdoti vorrebbe imporre al mondo che la circonda, ma non può più
farlo. Da allora in poi, la Chiesa lotta di principio per il rinnovamento del
Medioevo, ma il Medioevo rappresenta la realtà soltanto finché l’intera
umanità […] riconosce nella pratica questa idea, ponendosi volontariamente
al suo servizio»86.
L’idea portante del Cristianesimo diventa così un’idea pratica e
svolge la sua funzione all’interno dell’umanità rinnovata come una parte
di essa e non più come un principio assoluto.
86
Ivi, pp. 106-107.
Edmund Husserl e l’umanità europea
6. Modernità - Rinascimento, Illuminismo e ragion
pratica
La fase storica della Modernità – che comprende in sé il
Rinascimento e la Riforma protestante - rappresenta un momento di
libertà per la storia europea. Husserl scrive così:
«La modernità intesa […] come movimento di libertà e, in particolare
come movimento filosofico di libertà, cioè in quanto rinascita della vita
dell’antica cultura, di una vita dell’umanità razionale fondata sulla ragione
filosofica (sulla scienza), e come movimento religioso di libertà, cioè in
quanto rinascita dell’ideale religioso paleocristiano (o considerato tale) di
una religione fondata sull’esperienza religiosa delle origini, sulle fonti
originarie della fede»87.
Come abbiamo già segnalato, le due esperienze della Modernità
finiscono per divergere a causa dei loro diversi presupposti che sono, in
un caso, la pura ragione, nell’altro, la giustificazione assoluta della fede88.
Husserl scrive che «lo spirito della libera ragione, la rinascita dell’antica
libertà dello spirito, di quella della filosofia, prevale e diviene lo spirito
dell’epoca moderna»89, e osserva che questa vittoria della libera ragione
non consiste in un rifiuto dell’esperienza religiosa, ma unicamente nel
sottoporre anch’essa al vaglio critico della ragione stessa90.
Al vaglio critico della ragione del resto viene sottoposto anche il
concetto di scienza così come inteso dagli antichi:
«La modernità si distingue dall’Antichità per il modo in cui la filosofia o
la scienza rappresentano l’autonomia della ragione in quanto fonte di ogni
autorità e di ogni validità in generale, e precisamente sulla base della
differenza tra scienza antica e scienza moderna»91. Infatti: «Il tratto
universalistico, che sin dall’inizio attraversa la matematica e la scienza della
natura, rappresenta il carattere generale della filosofia e della scienza
moderna. Per quanto esso fosse già presente nell’idea platonica di filosofia,
la volontà di una conoscenza universale e metodicamente unitaria, di una
scienza rigorosa capace di affrontare ogni ambito in maniera sistematica e di
abbracciare compiutamente ogni singolo campo grazie a una problematica e
a un metodo universali, non era nell’Antichità ancora predominante in
“filosofia”. E l’epoca moderna è guidata dall’ideale non solo di una scienza
universale, ma di una scienza universale in grado di spiegare ogni cosa in
Ivi, p. 107.
Ibid.
89 Ibid.
90 Ibid.
91 Ivi, pp. 108-109.
87
88
150
Logos
maniera rigorosa a partire dai principi ultimi e di giustificarsi in ogni suo
passo»92.
Tale ideale deve molto allo sviluppo della matematica e delle scienze
sperimentali della natura che proprio nell’epoca moderna ottengono
un’autonomia di ricerca che non era loro mai stata concessa. Sul modello
della geometria e della nuova scienza matematica, la cultura moderna
mira a una universalis scientia93. Per questi motivi Husserl sostiene che «alla
testa del movimento moderno delle scienze stanno l’institutio magna di
Bacone, in quanto tentativo, compiuto sulla base di principi generali, di
ripartire i compiti scientifici nel quadro di un sistema della scienza, e
l’idea di Cartesio di una scienza universale, che sola si divide in tutte le
cosiddette singole scienze, e che è uno così come è una la ragione da cui
scaturisce ogni conoscenza»94. Lo spirito della libera ricerca e della totale
autonomia della ragione rispetto a fonti esterne porta così alla nascita di
una forma universale di scienza che, alla luce di un’unica metodologia
rigorosa, si espande in tutti i campi del sapere.
A questo proposito sono assolutamente essenziali due testi degli anni
’20, pubblicati come appendici agli articoli sul rinnovamento. Si tratta dei
Ivi, p. 110.
Ibid.
94 Ibid. Le analisi husserliane della matematica moderna e della scienza
sperimentale non sono oggetto di questo lavoro. Pertanto, in questa sede, si può
unicamente far riferimento all’opera in cui Husserl affronta la questione del metodo
galileiano, della matematizzazione del mondo naturale e della nascita delle scienze
sperimentali. Si tratta del già citato La Crisi delle scienze europee e la fenomenologia
trascendentale, pp. 51-90, 297-309 e 405-410. Sempre nella Crisi, alle pp. 101-128 e 410456, troviamo le riflessioni husserliane sulle caratteristiche della filosofia moderna e sui
singoli pensatori che l’hanno rappresentata. Sullo stesso tema si confrontino le
posizioni husserliane in Id., Storia critica delle idee, cit., pp. 74-212. Husserl, come è noto,
si occupa in particolare della differenza tra il razionalismo e l’empirismo, soffermandosi
in particolar modo sul pensiero di Cartesio, Hume e Berkeley per poi giungere all’analisi
del pensiero kantiano. Nell’ultimo testo citato sono presenti anche delle lezioni su
Leibniz. Un’altra interessante riflessione sulla filosofia moderna è presente in E.
Husserl, Über den Gegenwartige Aufgabe der Philosophie, cit., pp. 197 e ss. e in Id., Beilage
XVI (zu S. 187), Das Altertum kennt keine Korrelationsforschungs von Subjektivität und Welt, in
Id., Aufsätze und Vorträge (1922-1937), cit., pp. 228–231, nel quale Husserl si sofferma su
quella che egli ritiene la differenza fondamentale tra la filosofia classica e quella
moderna, vale a dire il ruolo della soggettività. Infine un’interessante analisi della
teleologia insita nella filosofia moderna a partire da Cartesio è rintracciabile in E.
Husserl, La fondazione originaria della filosofia e la teleologia insita nella filosofia moderna, in Id.,
La storia della filosofia e la sua finalità, cit., pp. 98-110.
92
93
Edmund Husserl e l’umanità europea
testi Sull’idea dell’assoluta giustificazione, e di La cultura moderna in quanto
cultura fondata sulla ragion pratica, entrambi del ’22 - ’23 95.
Nel primo Husserl scrive che «nell’epoca moderna la cultura europea
ha rivelato il carattere fondamentale che già le era stato istillato dalla
filosofia greca»96. Infatti: «Nel suo senso più intimo essa è una cultura
fondata sulla ragione autonoma, e unicamente su essa. Già il XVII e,
soprattutto, il XVIII secolo diedero alla nuova epoca e alla rinascita dello
spirito libero (della ragione autonoma) degli antichi il nome di epoca
dell’Illuminismo»97. Il concetto husserliano di Illuminismo si estende oltre
la connotazione storiografica andando a designare il senso e l’entelechia
della ragione europea. Infatti Husserl, al termine del testo, si domanda:
«Che cosa vuole dunque l’”Illuminismo”? La chiarificazione dei fini
ultimi della vita dell’umanità, del senso ultimo del mondo pratico
dell’uomo, del senso del mondo pre-dato, la critica radicale?»98. Secondo
Husserl, la rinascita della concezione classica e filosofica nel mondo
moderno si sviluppa sino al periodo dell’Illuminismo proseguendo nell’idea
della progressiva liberazione del pensiero dai pregiudizi e nel tentativo –
autenticante razionalista – di comprendere tutto alla luce di una scienza
metodologicamente e rigorosamente fondata. Inoltre, tale movimento di
chiarificazione è essenzialmente un movimento anche pratico giacché si
occupa degli aspetti concreti e morali della vita delle persone e della
comunità.
L’altro testo cui si è fatto riferimento ci mostra in modo chiaro come
il riferimento alla ragion pratica rappresenti per il pensiero moderno il
suo nucleo essenziale. Husserl, parlando del rinascimento, scrive:
«La Renaissance non si definisce come nascita di una forma culturale
semplicemente nuova, bensì come rinascita di quella degli antichi. Essa
stessa vede nel principio della libertà, nonché, soprattutto, della libertà
fondata sulla ragione scientifica […], la ripresa del principio della cultura
degli antichi tanto ammirati […]. Già in Platone è pienamente sviluppata e
inoltre approfondita nel ricco dispiegamento sistematico l’idea di una
cultura che venga formata sulla base della libera ragione, nella forma
pregnante di una cultura filosofico-scientifica. In questa pregnanza essa non
solo opera da ora in poi nel chiuso degli studi filosofici, ma ottiene anche
Id., Beilage VI (zu S. 94): Zur Idee absoluter Rechtfertigung <1922/23>, e Id., Beilage
VIII (zu S. 94): Die neuzeitliche Kultur als Kultur aus praktischer Vernunft <1922/23>,
entrambe in Id., Aufsätze und Vorträge (1922-1937), cit., pp. 107–109. Le versioni italiane
sono Id., Sull’idea di assoluta giustificazione e Id., La cultura moderna in quanto cultura fondata
sulla ragion pratica, entrambe in Id., L’idea di Europa, cit., pp. 113-115 e pp. 119-121.
96 Id., Sull’idea di assoluta giustificazione, cit., p. 113.
97 Ibid.
98 Ivi, p. 115.
95
152
Logos
una forza potente, capace di determinare l’evoluzione generale della cultura
[…]. La rinascita di questa volontà greca di cultura non ha il senso di una
debole ripresa o di una continuazione; essa accade in una norma di volontà
che conferisce all’epoca moderna uno slancio incomparabilmente maggiore
nella razionalizzazione della vita della comunità e della cultura rispetto a
quello che possiamo ritrovare nell’Antichità» 99. Tale slancio, dunque, sta alla
base delle maggiori potenzialità della filosofia e delle scienze dell’era
moderna rispetto alle potenzialità proprie della filosofia e delle scienze
dell’antichità100. Esso sta alla base di «una fede generale in una nuova epoca
dell’umanità, l’epoca dell’”Illuminismo” o, come potremmo meglio dire,
della cultura fondata sulla ragion pratica, di un’umanità che modella
razionalmente e attivamente se stessa insieme con il mondo che la circonda,
in un progressivo innalzamento»101.
La conclusione del testo mostra come per Husserl, nell’era moderna,
appaia centrale il ruolo della morale della ricerca scientifica:
«Pur non condividendo le varie esagerazioni di autostima proprie
dell’epoca moderna circa l’ideale già quasi raggiunto o da raggiungere a
breve, ne accettiamo però la stessa fede nelle idee che la guidano.
Ammettiamo di possedere nel suo senso l’assoluta validità dell’idea di una
tale cultura come norma alla quale deve essere commisurata ogni altra
cultura e in base alla quale deve esser formata la nostra. Lasciamo valere
insieme anche la fede nella possibilità pratica di una tale formazione, sia
pure almeno nella forma di un progresso infinito, e ancor più lasciamo
valere la fede nel nostro dovere incondizionato di realizzazione pratica, in
questo, per così dire, “imperativo culturale categorico”. Questa presa di
posizione […] giustifica la nostra interpretazione della cultura europea in
quanto interpretazione del suo vero senso storico-filosofico. La cultura
fondata sulla libera ragione e, al massimo suo grado, sulla libera scienza che
aspira all’universale, rappresenta l’idea teleologica assoluta, l’assoluta ed
efficace entelechia, che definisce l’idea della cultura europea come un’unità di
sviluppo»102.
La cultura della Modernità è essenzialmente una cultura della
rinascita e, come tale, non è il frutto di un evento storico empirico o
meccanico, ma piuttosto della rivisitazione riflessiva e critica del mondo
antico e della filosofia antica. Questo significa che essa finisce col
coincidere pienamente con l’idea di rinascita e rinnovamento culturale,
giacché in essa, per la prima volta, l’umanità europea ha ri-scoperto le
Id., La cultura moderna in quanto cultura fondata sulla ragion pratica, cit., p. 120.
Cfr. ivi, pp. 120-121.
101 Ibid., p. 121.
102 Ibid. Sulle origini essenzialmente morali della cultura europea moderna nel
pensiero husserliano, si veda J. M. Gómez - Heras, Europa como utopia moral. Variaciones
sobra un tema husserliano, in AA.VV., Etica dia tras dia, ed. J. Muguerza, F. Quesada, R. R.
Aramayo, Madrid, 1991, pp. 201-220.
99
100
Edmund Husserl e l’umanità europea
proprie radici filosofiche con un atto che non può essere configurato
come puramente teoretico e intellettuale, ma che presenta la
partecipazione di una volontà guidata dal fermo proposito di riscoprire il
fondamento scientifico ed universale del proprio essere culturale e
storico. In questo senso la cultura della Modernità è una cultura
essenzialmente fondata sul principio della ragion pratica.
L’ultimo riferimento importante per comprendere a pieno la
concezione husserliana della Modernità è rappresentato dalla Crisi delle
scienze europee nel quale Husserl scrive:
«Come è noto, l’umanità europea attua durante il Rinascimento un
rivolgimento rivoluzionario. Essa si rivolge contro i suoi precedenti modi di
esistenza, quelli medievali, li svaluta ed esige di plasmare se stessa in piena
libertà. Essa riscopre nell’umanità antica un modello essenziale. Su questo
modello essa vuole elaborare le nuove forme di esistenza. Che cosa
considera essenziale dell’uomo antico? Dopo qualche esitazione, nient’altro
che la forma “filosofica” dell’esistenza: la capacità di dare liberamente a se
stessa, a tutta la propria vita, regole fondate sulla pura ragione, tratte dalla
filosofia. La prima cosa è la teoresi filosofica […]. All’autonomia teorica
succede quella pratica. Nell’ideale del Rinascimento l’uomo antico è quello
che plasma se stesso esclusivamente in base alla libera ragione. Per il
rinnovato “platonismo” ciò significa: occorre riplasmare non soltanto se
stessi eticamente, ma anche l’intero mondo circostante, l’esistenza politica e
sociale dell’umanità in base alla libera ragione, in base alle intellezioni di una
filosofia universale»103. Husserl prosegue mostrando come tale ideale ideale
scientifico di tipo teoretico-pratico proprio della riscoperta degli antichi da
parte dei moderni sia assolutamente distante da una concezione meramente
tecnica e positivistica della scienza e come esso, al contrario, si configuri
come una forma rinnovata di philosophia perennis, arrivando a porsi tutte le
questioni fondamentali delle filosofie passate, quali Dio, la libertà e
l’immortalità104.
La conclusione husserliana è affidata al bel passo che segue: «Su
questa base è agevole comprendere lo slancio che animò tutte le imprese
scientifiche, anche quelle che rientravano, in quanto concernenti fatti,
nell’ordine inferiore, uno slancio che nel secolo XVIII, il quale si
autodefiniva secolo filosofico, riempì cerchie sempre più larghe
dell’entusiasmo per la filosofia e per le scienze in quanto sue diramazioni.
Di qui quell’acceso bisogno di sapere, quello zelo per una riforma
dell’educazione e delle complessive forme sociali e politiche di esistenza
dell’umanità, uno zelo che rende degna di venerazione l’epoca tanto
103
104
E. Husserl, La crisi delle scienze europee, cit., p. 37.
Cfr. ivi, pp. 37-39.
154
Logos
diffamata dell’illuminismo. Una testimonianza perenne di questo spirito è
costituita dallo splendido inno Alla gioia di Schiller e Beethoven»105.
Le ultime parole della riflessione husserliana ci introducono al tema
della crisi: «Oggigiorno quest’inno non può che suscitare in noi dolorosi
sentimenti. È impensabile un contrasto maggiore con la nostra attuale
situazione»106.
7 La Crisi
La presenza di una crisi nel mondo culturale europeo per Husserl è
assolutamente evidente nonostante gli apparenti successi delle scienze
della natura e della tecnica che esse orientano. Secondo il filosofo, nel
mondo scientifico europeo si è smarrito il fondamento universalistico
della cultura greca e rinascimentale, riducendo la filosofia e le scienze
dello spirito a copie sbiadite delle discipline naturali e matematiche. Si è
così dato vita a scienze di puri fatti, dimenticando che solo una scienza di
idee può dar vita ad un sapere autenticamente rinnovato ed
universalmente fondato. E giacché «a scienze di fatto, corrispondono
uomini di fatto»107, la conclusione husserliana è che alla crisi delle scienze
europee corrisponde una autentica crisi dell’intera umanità europea108.
Husserl percepiva lo stato di crisi del mondo culturale europeo già
dagli anni della prima guerra mondiale109. Nelle analisi contenute ne La
Crisi delle scienze europee Husserl cerca le cause di tale situazione (nonché la
possibile via d’uscita) unicamente all’interno del mondo delle scienze e
della filosofia. Se, infatti, l’idea di Europa è un’idea prettamente filosofica
costituitasi nel corso dei secoli attorno alla preminenza del pensiero
scientifico, la causa della sua decadenza non può che essere imputata
all’abbandono da parte degli scienziati degli obbiettivi di una scienza
autentica ed universale. Coerentemente con il pensiero husserliano, sono
il naturalismo e l’obbiettivismo le autentiche cause della degenerazione
105 Ibid., p. 39. Sul giudizio husserliano del pensiero della modernità, si veda A.
Pazanin, Husserl und das Denken der Neuzeit, Den Haag, 1959.
106 E. Husserl, La crisi delle scienze europee, cit., pp. 37-39.
107 Ivi, p. 35.
108 Ivi, pp. 33-47.
109 Si vedano a tal proposito le lezioni di Husserl su Fichte del 1917, dal titolo
Fichtes Menschheitsideal. <Drei Vorlesungen>, in Id., Aufsätze und Vorträge (1911-1921)
(Husserliana XXV), hrsg. von T. Nenon e H. R. Sepp, Dordrecht\Boston\London,
1986, pp. 267-293, in cui il filosofo moravo esorta il popolo tedesco alla guerra per la
difesa della propria tradizione filosofica e culturale. La traduzione italiana è: E. Husserl,
Fichte e l’ideale di umanità. Tre lezioni, a cura di F. Rocci, Pisa, 2005.
Edmund Husserl e l’umanità europea
del pensiero filosofico moderno e, nello stesso tempo, il suo
trascendentalismo non ancora pienamente sganciato dal processo di
matematizzazione del mondo. Il pensiero filosofico moderno ha
conosciuto, secondo Husserl, sia lo slancio universalistico verso la meta
ideale di un’autentica filosofia, sia il processo di rinascita della
matematica e delle scienze esatte alla luce del metodo sperimentale
galileiano. Ma le scienze empiriche della natura si sono progressivamente
trasformate nello schema universale di tutte le scienze, compresa quella
filosofica, dimenticando che, al contrario, esse erano il frutto di un
processo di matematizzazione nato proprio da una scienza filosofica tesa
alla costituzione di una autentica mathesis universale110. Il pensiero
filosofico moderno, che aveva fatto propria la scoperta della struttura
trascendentale della soggettività, si ripiega in tali fraintendimenti
naturalistici occultando il senso autentico e più profondo della scoperta
del senso del trascendentale: l’idea di una forma di soggettività fungente
originaria che, operante nel mondo della vita, rappresenti l’assoluto ed
autentico fondamento delle molteplici forme di senso e di valore del
mondo. Per questo motivo, Husserl vede la possibilità di dar vita a un
movimento di rinascita che abbracci l’intero mondo culturale europeo
unicamente nel ritorno alle sue origini filosofiche e spirituali111.
Sul problema della matematizzazione del mondo naturale nella fisica moderna
si veda G. H. Vásquez, Intentionalität als Verantwortung, Den Haag, 1976, pp. 40-52. In
relazione a questo stesso problema si vedano di A. A. Bello, L’oggettività come pregiudizio,
Roma, 1982 e Id., Husserl, oltre le scienze verso il MDV, a cura di R. Brambilla, Assisi, Pro
civitate Cristiana, 1989.
111 Questa, in estrema sintesi, la posizione espressa da Husserl in La Crisi delle
scienze europee. Si confrontino soprattutto ivi le pp. 51-215. Si è scritto molto sulla
questione della crisi delle scienze europee. Un commento puntuale al testo husserliano
del 1935 è sicuramente rappresentato da E. W. Orth, Edmund Husserls “Krisis der
Europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie”, Darmstadt, 1999, nel
quale l’autore affronta tutti gli aspetti del lavoro husserliano, sottolineando come sia
assolutamente da abbandonare la tesi secondo la quale la crisi rappresenterebbe per
Husserl la fine del sogno di dar vita ad un’autentica scienza fenomenologica
trascendentale. Tra gli altri lavori ricordiamo: H. Lubbe, Husserl und die europäische Krise,
in «Kant Studien», 49 (1957-58), pp. 225-237; G. Forni, Il sogno finito, Bologna, 1967; A.
Gessani, La crisi della cultura europea e la filosofa di Husserl, Roma, 1977; E. Garulli, The
Crisis of Sciences as a Crisis of Teleological Reason, in «Analecta Husserliana», 9 (1979), pp 91104; E. Ströker, Husserls letzter Weg zur Transzendentalphilosophie in Krisis Werk, in
«Zeitschrift für philosopische Forschung», 35 (1981), pp. 165-187; A. A. Bello, Wir
Europaer nei manoscritti inediti contemporanei alla crisi, in AA.VV., E. Husserl “La Crisi delle
Scienze Europee e la responsabilità storica dell’Europa”, Milano, 1985, pp. 53-72; K. Held, La
diagnosi fenomenologica dell’epoca presente in Husserl ed Heidegger, in AA.VV., E. Husserl “La
Crisi delle Scienze Europee e la responsabilità storica dell’Europa”, cit., pp. 125-142; A. Pazanin,
Responsabilità storica dell’Europa. Il tema fondamentale della crisi, in AA.VV., E. Husserl “La
110
156
Logos
Di maggiore interesse per noi è però il testo della conferenza tenuta
a Vienna nel 1935. A proposito della crisi della cultura europea - che
costituisce il tema centrale della conferenza – Husserl scrive:
«Anch’io sono certo che la crisi europea affonda le sue radici in un
razionalismo erroneo. Ma ciò non vuol dire che la razionalità come tale sia
una calamità o che rivesta un’importanza soltanto subordinata per
l’umanità. La razionalità: nel senso più alto e autentico in cui noi ne
parliamo, nel senso di quell’ideale originario che si delineò nell’epoca
classica della filosofia greca, la razionalità aveva indubbiamente bisogno
ancora di molti chiarimenti, di molte riflessioni, ma nella forma matura è
chiamata a guidare tutti gli sviluppi successivi. D’altra parte noi ammettiamo
di buon grado (e da questo punto di vista l’Idealismo tedesco ci ha
preceduto di molto) che lo stadio di sviluppo della ratio costituito dal
razionalismo del periodo illuministico era un errore, per quanto fosse un
errore comprensibile»112.
L’idea della perfetta armonia della ragione moderna, culminante nella
cultura illuministica, sembra dunque essere messa in crisi dall’idea
secondo la quale tale forma di razionalità avrebbe rappresentato, in
fondo, un errore. Si tratta però di stabilire di che errore si tratta. Husserl
scrive che «“la filosofia” […] in quanto fatto storico inerente a una
determinata epoca va distinta dalla filosofia come idea, idea di un
compito infinito»113. Infatti:
«Le singole filosofie concrete storiche rappresentano sempre un
tentativo più o meno riuscito di realizzare l’idea dell’infinità o addirittura la
Crisi delle Scienze Europee e la responsabilità storica dell’Europa”, cit., pp. 20-28; G. Forni,
Commento alla crisi di Husserl, Bologna, 1986; E. Ströker E., Edmund Husserls
Phänomenologie: Philosophia perennis in der Krise der europäischen Kultür, in «Husserl Studies», 5
(1988), pp. 197-217; A. A. Bello, Modernità e crisi. La lettura husserliana della nostra epoca, in
«Per la filosofia», 3 (1989), pp. 3-35; O. Poggeler, Die Krise des phänomenologischen
Philosophiebegriff, in Phänomenologie in Widerstreit, cit., pp. 255-276; A. Ponsetto, Von der
Welt der Sinndeutigen zur Welt der Daten. Die Krise der Moderne und ihre Überwindung in der
Phänomenologie, in «Phänomenologische Forschung», 24-25 (1991), pp. 200-229; R. P.
Buckley, Husserl, Heidegger and the Crisis of Philosophical Responsability, Dordrecht, 1992; E.
Ströker, The Husserlian Fondation of Science, Dordrecht/Boston/London, 1997, pp. 271289; E. Ströker, Krise der Wissenschaft-Wissenschaft der Krisis?, Bern, 1998. Per quanto
concerne la critica husserliana allo sviluppo della scienza galileiana nella modernità, si
veda G. Soffer, Phenomenology and Scientific Realism: Husserl’s Critique of Galielo, in «The
rewiew of Metaphysic», XLIV, 1 (1990), pp. 67-94.
112 E. Husserl, La crisi dell’umanitá europea e il destino della filosofia, cit., p. 78. Si veda a
tal proposito M. Vajda, Husserls Lebenswelt-Kritik der Aufklärung?, in AA.VV.,
Gelebtenrepublik. E. Husserl und A. Shutz in der Krisis der phänomenologische Bewegung, hrsg.
von M. Benedikt, A. Bäumer, Wien, 1993, pp. 219-224.
113 E. Husserl, La crisi dell’umanitá europea e il destino della filosofia, cit., p. 79.
Edmund Husserl e l’umanità europea
totalità della verità. Gli ideali pratici, considerati come poli eterni, da cui per
tutta la vita non ci si può scostare senza pentirsene, senza diventare infedeli
a se stessi e quindi infelici, in questa visione non sono affatto chiari e
determinati, ma semplicemente anticipati in un’ambigua generalità. La
determinatezza si produce soltanto quando ci si accinge a realizzarli e
quando si agisce con un certo successo. Esiste continuamente il rischio di
cadere in unilateralità e di darsi troppo in fretta per soddisfatti; ma il cadere
in tali equivoci porta inevitabilmente a contraddizioni»114.
Fin qui è chiaro che Husserl distingue il piano dell’idea dal piano
della realtà. Lo spirito della filosofia moderna rappresenta la perfetta e
piena razionalizzazione dell’umanità. Ma questo progetto ideale e
assoluto, sul piano concreto, non è esente da errori, contraddizioni e
unilateralità. Infatti Husserl scrive che «una razionalità unilaterale può
trasformarsi in un male»115. Una razionalità di tal fatta si è manifestata,
secondo Husserl, in modo assai chiaro nel pensiero moderno
rappresentandone al tempo stesso la causa fondamentale di crisi. Husserl
scrive:
«É qui il luogo […] di svelare l’ingenuità di quel razionalismo che in
genere viene scambiato per la razionalità filosofica come tale e che, del
resto, è effettivamente caratteristico dell’intera filosofia moderna a partire
dal rinascimento e che si considera il vero, l’universale razionalismo. In
questa ingenuità […] sono impigliate tutte le scienze […]. Più precisamente:
il titolo generale per designare quest’ingenuità è l’oggettivismo, che si
manifesta nei diversi tipi di naturalismo e di naturalizzazione dello
spirito»116.
Husserl ribadisce la stessa posizione espressa nella Crisi delle scienze
europee. La scienza moderna si è rifugiata in un matematismo e fisicalismo
sterile (che Husserl chiama oggettivismo) dimenticandosi della sua
grande scoperta filosofica: l’idea che la soggettività trascendentale sia il
vero fondamento di qualsiasi idea autenticamente scientifica. Così
facendo, la cultura moderna degrada se stessa ad un pensiero di tipo
prettamente cosmologico, il superamento del quale era già stato
rappresentato dalla svolta socratico-platonica117.
Come si può notare, la mancanza del pensiero moderno non sta,
secondo Husserl, nel suo eccessivo razionalismo, ma piuttosto nel suo
essere stato poco razionalistico. La prima conseguenza di ciò è l’assenza di
Ibid.
Ibid.
116 Ivi, p. 80.
117 Ivi, pp. 80-87.
114
115
158
Logos
un’autentica scienza dello spirito, problema che neanche pensatori del
livello di Dilthey, Windelband o Rickert sono riusciti a risolvere118.
Husserl scrive che, al contrario del mondo naturale, «lo spirito, e
soltanto lo spirito, è essente in se stesso e per se stesso; lo spirito è autonomo e in
questa autonomia, e soltanto in essa, può essere trattato in modo veramente razionale,
veramente e radicalmente in modo scientifico»119. Il tema della necessità di dar
vita ad una scienza dello spirito si intreccia col tema dell’assenza
dell’indagine sulla soggettività operante all’interno dell’oggettivismo
moderno, giacché «solo nella conoscenza pura nel campo delle scienze
dello spirito lo scienziato non è investito dall’obiezione che riguarda
l’autonascondimento del suo operare»120. Per questo le scienze dello
spirito non devono cadere nell’errore di ispirarsi metodologicamente alle
scienze della natura giacché «soltanto se lo spirito recede da un atteggiamento
rivolto verso l’esterno e ritorna a sé e rimane presso di sé, esso può dar ragione di se
stesso»121. Il senso autentico della ratio che dev’essere recuperato «non è
altro che l’autocomprensione realmente universale e radicale dello spirito,
che assume la forma di una scienza universalmente responsabile, e in cui
si attua un modo completamente nuovo di scientificità, in cui trovano il
loro posto tutti i possibili problemi, quelli concernenti l’essere, le norme,
la cosiddetta esistenza»122.
Pertanto la cultura moderna può uscire dalla sua crisi profonda solo
procedendo ad un nuovo movimento di rinascita che, al tempo stesso, la
conduce al di là della Modernità stessa, secondo il telos ideale dell’umanità
filosofica. Infatti, per Husserl, la “crisi” può così «rivelarsi come un
apparente fallimento del razionalismo»123, giacché «la causa del fallimento di
una cultura razionale risiede, come abbiamo detto, non nell’essenza del
razionalismo stesso, ma soltanto nella sua manifestazione esteriore, nel suo
decadere a “naturalismo” e “oggettivismo”»124.
Ivi, pp. 87-88.
Ivi, p. 88.
120 Ivi, p. 89.
121 Ibid.
122 Ivi, p. 90.
123 Ivi, p. 91.
124 Ibid. Un’analisi assolutamente analoga delle mancanze del pensiero filosofico e
scientifico della modernità è presente in E. Husserl, Beilage X (zu S. 94) <1922\23>:
Zum Versagen in der neuzeitlichen Kultur-und Wissenschaftsentwicklung, das Telos der europäischen
Menschheit zu verwirklichen. Fünf Texte, in Id., Aufsätze und Vorträge (1922-1937), cit., pp.
113-118. La traduzione italiana é Id., Sulla fallita realizzazione nello sviluppo della cultura e
della scienza moderna del “Telos” dell’umanità europea. Cinque testi, in Id., L’idea di Europa, cit.,
pp. 129-136. Un discorso sostanzialmente simile é presente inoltre in Id., Über den
Gegenwartige Aufgabe der Philosophie, cit., pp. 197-221 e in Id., Beilage XIX: Der neuzeitliche
118
119
Edmund Husserl e l’umanità europea
Oltre che dal punto di vista strettamente teoretico, Husserl analizza
la crisi della cultura europea anche dal punto di vista morale. Si è visto,
infatti, come la cultura della Modernità fosse per Husserl essenzialmente
fondata sul primato della ragion pratica e sull’assolutezza dell’obbedienza
all’imperativo categorico che prescriveva l’assoluta chiarificazione
razionale. Husserl scrive:
«L’umanità europea si è allontanata dal telos che le è innato. È caduta in
una colpevole degenerazione perché, pur essendo già divenuta consapevole
di questo telos (avendo mangiato dell’albero della conoscenza), non lo ha
portato alla più piena coscienza né ha insistito nel tentativo di realizzarlo
come proprio senso vitale pratico, ma gli è diventata infedele»125.
Pertanto l’abbandono della stretta osservanza di tale imperativo
categorico – del quale si è detto nel paragrafo precedente - diventa la
causa principale della decadenza della cultura del mondo moderno.
Infatti:
«Se l’etico ha ragione, la forma di vita dell’imperativo categorico è non
solo migliore di ogni altra, ma è quella assolutamente richiesta, e ogni altra può
avere valore in generale solo se assume la forma categorica in quanto forma
di tutti i valori possibili e ammissibili nella vita umana […]. Un uomo, una
vita umana, non può essere, ma solo divenire razionale, e può diventarlo
soltanto se nel suo divenire segue od obbedisce all’imperativo categorico
ormai reso consapevole. Ha così la forma suprema di sviluppo, la quale a
sua volta è una forma categoricamente richiesta. Tutto ciò vale anche per
l’”uomo in grande”»126.
L’idea husserliana è che per l’intera umanità valga lo stesso principio
che vale per il singolo individuo; vale a dire che una vita razionale è una
vita che si rivolge verso il pieno compimento della propria razionalità alla
luce universale ed assoluta di un imperativo categorico.
Entrando nello specifico caso dello sviluppo e della crisi della cultura
moderna, Husserl scrive:
«Ecco però la difficoltà: quando questa comunità ha un’estensione tale
da poter affermare che l’intera umanità culturale relativa (nazione o umanità
europea) [è] consapevole della propria entelechia e la riconosce in quanto tale,
in quanto proprio imperativo categorico? O è soltanto une façon de parler?
Nell’epoca dell’illuminismo “regna” lo spirito della ragione autonoma. Ma
Rationalismus erfüllt nicht den Ursprungsinn der Rationalität, in Id., Aufsätze und Vorträge
(1922-1937), cit., pp. 236-238.
125 Id., Sulla fallita realizzazione nello sviluppo della cultura e della scienza moderna del
“Telos” dell’umanità europea. Cinque testi, cit., p. 136.
126 Ibid.
160
Logos
alla fine vi furono troppi uomini che nulla sapevano dell’entelechia, e interi
strati chiusi e comunità (quella tradizionalistica della Chiesa) che si
opponevano a questo nuovo spirito. Ciononostante li giudichiamo membri
di questa nuova comunità razionale quando consideriamo il XVIII secolo.
Oppure entriamo nel merito di tale valutazione (sia anche per ipotesi) e
notiamo allora che questa idea viene rapidamente adottata e ripresa in
cerchie sempre più ampie, forma ambiti culturali sempre più vasti e ha
luogo così uno sviluppo progressivo attraverso cui l’umanità e la sua cultura
assumono sempre più il carattere di una cultura razionale, di una cultura
dunque retta dallo spirito dell’imperativo categorico» 127.
Lo sviluppo ideale è dunque una linea di tendenza della civiltà
moderna e, in quanto tale, non è indipendente dall’azione morale degli
individui e dalle circostanze storiche.
La conclusione del testo riconduce al fondamento essenzialmente
pratico della cultura moderna, che resta, nonostante la crisi, una cultura
fondata sul primato della piena razionalità:
«Lo spirito etico, lo spirito della volontà di una cultura fondata sulla
ragione assoluta, non smette di operare nel singolo, ma combatte una
battaglia difensiva, invece di avanzare vittoriosamente. Possiamo, dunque,
ben designare come epoca della ragione un’epoca in cui l’idea di umanità
razionale abbia un’efficacia progressiva (e formi in modo nuovo ambiti
culturali universali e comunità sempre maggiori entro la comunità
complessiva). Tale idea è allora quella che determina in maniera
predominante lo sviluppo complessivo, e rappresenta lo spirito del tempo.
Andrebbe designata come tale, nel tipo supremo, un’epoca della ragione in
cui sia già radicato in tutte le comunità parziali questo spirito e sia diventato
motore dello sviluppo. Nel caso ideale tale spirito dovrebbe vivere in ogni
individuo e dovrebbe essere considerato nella coscienza generale come
caratteristica naturale dell’individuo normale» 128.
Inoltre, sempre negli anni ’20, Husserl riflette sulla crisi del mondo
europeo distinguendo Cultura [Kultur] e Civilizzazione [Zivilitation]. Per
Husserl la «vita della cultura originariamente sgorgante» è l’«originaria
spiritualità creativa, volta a valori originariamente intuiti, trasformandoli
(oggettivandoli) in beni permanenti dell’attività poetica»129. Al contrario la
civilizzazione rappresenta «la vita secondaria della cultura, quella
Ivi, pp. 140-141.
Ivi, p. 142. Sulla questione dell’universalità della cultura europea, si veda U.
Ferrer, La vocazione universale dell’Europa, in AA.VV., La fenomenologia e l’Europa. Atti del
convegno internazionale di Trieste, 22-25 novembre 1995, cit., pp. 225-240.
129 E. Husserl, Beilage IX (zu S. 94): Ursprüngliche Kultur und Zivilisation. Können die
neuzeitlichen Wissenschaften “selig” machen?, in Id., Aufsätze und Vorträge (1922-1937), cit., p.
109. La traduzione italiana é Id., Cultura originaria e civilizzazione. Possono le scienze moderne
rendere felici?<1922/23>, in Id., L’idea di Europa, cit., p. 123.
127
128
Edmund Husserl e l’umanità europea
esteriorizzata di una tradizione che ha perduto il senso intimo della
propria formazione ed è degenerata in attività priva di valori, cultura di
surrogato, pseudocultura, valori atrofizzati»130.
Ciò detto, Husserl si chiede a proposito di una cultura che, come
quella europea, ha il suo fondamento nel pensiero scientifico:
«Quando la cultura scientifica è originariamente sgorgante, autentica
nella radice e nel fine, autentica nel metodo e nella produzione?» 131. Husserl
scrive: «E’ naturale pensare qui al noto tentativo di distinguere tra cultura
[Kultur] e civilizzazione [Zivilisation] […]. Un popolo ha […] cultura nella
misura in cui, in quanto popolo, mette in atto una spiritualità
originariamente creativa e, creando, la incorpora in un’espressione carnale e,
mosso da questo eros creativo, procede a sempre nuove creazioni spirituali.
Ha una cultura viva finché questo eros, questo impulso d’amore per il
“bello” trova compimento relativo nelle opere; ma sempre e di nuovo viene
spinto da esso a fini e forme d’opere superiori, possibili in primis grazie a
questo. In quanto popolo, vuol dire che la vita comune […] è attraversata
da una spiritualità comune superiore, da una abitualità legata e mediata dalle
relazioni comunitarie, sempre pronta a passare alla viva nostalgia, agli attivi
impulsi e alle attività creative, e a essere entusiasta di tutte quelle opere che
sono scaturite da tale disposizione, stimolata a riviverle attivamente e a
seguirle nella pratica, al risveglio spirituale e a produzioni spirituali più
elevate […]. Ma la cultura ha sempre il suo milieu di civilizzazione, la vitalità
produttiva ha sempre il suo milieu di vitalità esteriorizzata, il suo milieu di
spiritualità scomparsa, “convenzionale”, meramente “tradizionale”, non più
o a mala pena ancora compresa, di una spiritualità che è sì espressa, ma il
cui contenuto spirituale non può più essere riprodotto con le sue
motivazioni originarie, che sono forse svanite o del tutto morte: potranno
venir ricompensate dall’erudizione storica, ma non più come riattivabili
nella forma della viva presa di posizione e della disposizione fondata in
modo nuovo, originariamente giustificata e formata» 132.
Indubbiamente, tramite la dicotomia tra cultura e civilizzazione,
Husserl intende mostrare la decadenza della civiltà moderna dovuta
all’allontanamento dal suo vivo fondamento etico. Sicché la posizione
husserliana circa la crisi sembra qui assumere un netto rivolgimento
pessimistico: la civiltà europea sarebbe giunta al tramonto, avendo
abbandonato il suo fondamento vitale.
Ma è utile sottolineare che Husserl allarga il discorso anche al
destino delle scienze. Nella sua visione, «una specie di stanchezza per la
scienza si è potuta impadronire del nostro tempo; una disposizione
d’animo e una corrente ostili alla scienza, il cui grido di battaglia è: le
Ibid.
Ibid.
132 Ivi, pp. 125-126.
130
131
162
Logos
scienze non ci hanno reso più saggi né ci offrono una conoscenza
autentica, ci permettono di calcolare il corso della natura, ma non di
comprenderlo, ci danno conoscenze ordinate di fatti possibili e reali, ci
donano leggi come regole d’ordine, consentono di orientarsi nel campo
dell’essere reale e possibile; hanno formato una tecnica meravigliosa del
pensiero ordinante e concettualmente determinante, in tutti gli ambiti
della natura e dello spirito, hanno organizzato la cooperazione degli
scienziati che in precedenza operavano isolatamente, il lavoro scientifico,
l’organizzazione, la disciplina, sia anche l’autodisciplina, che assegna ad
ogni scienziato il proprio ambito scientifico delimitato, e in questo i suoi
problemi, il suo posto di lavoro, rendendo ciascuno soldato e, nel
migliore dei casi, ufficiale di una potente organizzazione mondiale questo è il carattere della scienza moderna»133. E tuttavia, in questo
sistema armonico ed universale «non vi è nessuno che abbia visione
dell’intero, quella stessa visione di cui si parla qui, ossia dell’universalità
della produzione esteriore dell’ordine e della fissazione; ma, il che è
ancora peggio, ogni produzione è possibile soltanto grazie a una
successione senza fine di gradi e di operazioni che sfruttano le ricadute di
vecchie operazioni in forma simbolica e senza la necessità di portare il
loro senso originario a un’esibizione ultima, per operazioni di ordine
superiore»134. La conclusione è che «l’uomo di scienza si è tramutato in
lavoratore dedito unicamente ad un grande ingranaggio, che poteva
amare finché le operazioni di questo potevano strabiliare lui e gli altri
[…] e che non può amare del tutto seriamente e in senso alto, dato che la
sua conoscenza è priva della comprensione più profonda che gli rivela in
essa una spiritualità che ha una funzione necessaria per le più profonde
ragioni spirituali, una necessità della teleologia che rimanda a ciò che
ultimo, a ciò per cui solo l’uomo in quanto tale può avere un interesse
definitivo: detto in breve, per la sua eterna felicità»135. Si domanda
Husserl:
«Siamo felici dei nostri progressi, del fatto di poter telefonare e di
parlare via radio a chilometri di distanza? Saranno felici i posteri di potersi
intrattenere con gli abitanti di Marte e di Sirio? Saremo felici se verranno
esaminate tutte le lingue della Terra, risalendo fino a diecimila anni fa, se
riusciremo a stabilire i nomi di tutti i loro re, di tutti i macelli, di tutte le città
santuario, di tutte le arti, ecc.? Se aumentiamo in infinitum le forze umane a
forze gigantesche, se facciamo sì che le forze di chicchessia crescano al
punto da poter studiare a fondo la scienza di ogni tempo e l’universo di
Ivi, pp. 126-127.
Ivi, p. 127.
135 Ibid.
133
134
Edmund Husserl e l’umanità europea
ogni scienza, e addirittura fondare sempre qualsiasi enunciato, e rifare ogni
operazione tecnica riuscita da solo o insieme ai suoi simili: costui sarà in
questo migliore di noi. Ma ciò lo renderà felice?»136.
La risposta di Husserl è insolita. Scrive infatti: «Voi direte che la
felicità è una questione e una grazia […]. Ma non è necessario che mi
chieda come divengo felice? Come posso diventarlo, e come mi libero
della mia infelicità?»137. Questa risposta, e l’intero articolo in questione,
meritano senza dubbio una riflessione. In primo luogo è chiaro come qui
Husserl avanzi allo sviluppo delle scienze moderne la stessa critica che
abbiamo ritrovato negli scritti degli anni ’30. Le scienze naturali, ed
anche tutte le altre scienze empiriche, hanno occluso la strada ad
un’autentica scienza filosofica della soggettività fondante. Così facendo
hanno trasformato il movimento scientifico originario in una semplice
tecnica, lontana dalla vita e dagli autentici interessi dell’umanità. La
risposta ambigua e titubante di Husserl alla sua stessa domanda circa il
problema della felicità confermerebbe una lettura del testo in una
direzione nettamente pessimistica. Se infatti le scienze moderne sono
ridotte solo ad una tecnica civilizzatrice, da dove nascerebbe la possibilità
di riattivarne il senso autentico originario?
E tuttavia Husserl sottolinea come gli scienziati stessi, a causa del
loro lavoro, anelino ad una forma di conoscenza e di vita spirituale più
elevati. In questo senso sembrerebbe non del tutto sopito lo slancio
vitale originario del pensiero scientifico moderno. Del resto è senza
dubbio questa la posizione che Husserl esprime al termine della succitata
conferenza del 1935 a Vienna:
«La crisi dell’esistenza europea ha solo due sbocchi: il tramonto
dell’Europa, nell’estraneazione rispetto al senso razionale della propria vita,
la caduta nell’ostilità allo spirito e nella barbarie, oppure la rinascita
dell’Europa dallo spirito della filosofia, attraverso un eroismo della ragione
capace di superare definitivamente il naturalismo. Il maggior pericolo
dell’Europa è la stanchezza»138.
E qui Husserl si lancia in un discorso dai toni assolutamente
toccanti:
Ivi, p. 128.
Ivi, p. 128.
138 E. Husserl, La crisi dell’umanità europea e il destino della filosofia, in Id., p. 92. Il
riferimento alla stanchezza del mondo europeo e la necessità di superarlo con una
rinascita della filosofia sono al centro dell’articolo di F. De Natale, La fenomenologia come
critica della ragion pigra, in AA.VV., E. Husserl “La Crisi delle Scienze Europee e la responsabilità
storica dell’Europa”, cit., pp. 311-319.
136
137
164
Logos
«Combattiamo contro questo pericolo estremo, da “buoni europei”, con
quella fortezza d’animo che non teme nemmeno una lotta destinata a durare
in eterno. Allora dall’incendio che distruggerà la miscredenza, dal fuoco
soffocato dalla disperazione per la missione umanitaria dell’Occidente, dalla
cenere della grande stanchezza, rinascerà la fenice di una nuova interiorità di
vita e di una nuova spiritualità, il primo annuncio di un grande e remoto
futuro dell’umanità: perché soltanto lo spirito è immortale» 139.
Il naturalismo è sempre quel pensiero che nega la necessità di porre
l’idea di umanità in senso spirituale al centro dell’autentico discorso
filosofico e politico, ed insieme quel pensiero che riduce il ruolo del
momento etico all’interno della vita scientifica, laddove, come abbiamo
avuto modo di vedere, per Husserl il fondamento di un’autentica
filosofia razionale sta proprio nel suo porsi principalmente come filosofia
pratica e morale. L’intera storia europea moderna è basata secondo
Husserl sul principio della ri-attivazione del pensiero originario del
mondo classico, e tale ri-attivazione è possibile unicamente grazie ad uno
slancio essenzialmente etico, allo stesso modo in cui solo un forte slancio
etico – potremmo anche dire prometeico - può riportare la cultura europea
al suo fondamento originario e vitale.
8. Il senso della storia
Alla luce di quanto scritto è possibile trarre qualche conclusione
circa il senso del telos storico all’interno del pensiero husserliano.
Appare chiaro come tale telos rappresenti essenzialmente lo sfondo
ideale dell’evoluzione dell’umanità stessa. Allo stesso tempo, dal punto di
vista empirico, Husserl ha inteso mostrare come esso abbia effettivamente
presieduto alla nascita della cultura europea, individuata nella fondazione
greco-antica del sapere filosofico e scientifico. La storia concreta dunque
appare come il luogo d’incontro tra il piano ideale (rappresentato dal
senso idealmente evolutivo del telos della cultura filosofica e scientifica)
ed il piano effettivo dei singoli eventi che risultano leggibili ed
interpretabili solo alla luce dell’evoluzione di tale telos. Al telos cui fa
riferimento Husserl non è possibile rinunziare se non rinunziando al
fondamento e alle radici della propria civiltà ed umanità. E tuttavia, come
si è potuto osservare nelle riflessione sulla crisi della scienza europea e
dell’umanità europea, una simile rinunzia è pur sempre possibile. In
139 E. Husserl, La crisi dell’umanitá europea e il destino della filosofia, cit., p. 92. Si veda a
tal proposito: J. San Martin, La fenomenologia de Husserl como utopia de la razòn, Madrid,
1987.
Edmund Husserl e l’umanità europea
questo senso, possiamo parlare di una forma ideale di necessarismo e di
una struttura assolutamente non necessaria ed aperta del divenire storico.
Come si è potuto notare, infatti, il senso ideale della storia europea e
più in generale della storia umana consiste, per Husserl, nella progressiva
manifestazione della razionalità scientifica e filosofica e nella sua
applicazione a tutti i campi del vivere umano. Tuttavia, nella storia
mondiale come nella storia europea, dipende dalla volontà degli uomini
la concreta realizzazione di tale razionalità filosofica. La mancanza
dell’impegno etico, dell’obbedienza all’imperativo categorico che, come visto,
prescrive di perseguire in ogni scelta e comportamento il senso della
razionalità, avendo fede nella manifestazione progressiva del suo senso
storico, ha determinato l’imbarbarimento e la crisi della civiltà europea. E
tuttavia, anche la crisi ed il conseguente processo di imbarbarimento di
tale civiltà possono essere compresi ed interpretati solo facendo
riferimento al senso ideale ed evolutivo che ne ha presieduto la nascita,
giacché la forza della razionalità può essere sì eclissata, ma mai
pienamente sconfitta.
Quanto il telos della storia appaia in una struttura aperta e
squisitamente ideale è dimostrato dalla conclusione della già citata
riflessione husserliana del 1935 dal titolo Gradi della storicità. Intendendo
mostrare la terza ed ultima tappa evolutiva della storicità umana, Husserl
scrive:
«Il terzo grado è la trasformazione della filosofia in fenomenologia, con
la coscienza scientifica dell’umanità nella sua storicità e con la funzione di
trasformarla in un’umanità che si faccia guidare coscientemente dalla
filosofia in quanto fenomenologia»140.
Da questo passo risulta particolarmente chiaro come il telos
husserliano non rappresenti né una giustificazione postuma degli eventi
storici, né una semplice legge evolutiva di tipo metafisico. Al contrario
esso rappresenta il luogo ideale all’interno del quale si muove l’agire
storico e culturale dell’umanità europea e dell’umanità intera. La
trasformazione dell’umanità in un’umanità consapevole che si faccia
guidare in ogni sua azione dalla filosofia fenomenologica rappresenta
infatti la meta assoluta della storia umana e della storia europea. Tale
meta non si raggiunge concretamente; essa rappresenta semplicemente
l’idea guida della storia umana ed europea.
E. Husserl, Gradi della storicità. Prima storicità, (Appendice XXVI al § 73), in Id., La
crisi delle scienze europee, cit., p. 530.
140
166
Logos
Nella storia europea si manifesta concretamente il valore assoluto della
scienza e della filosofia ed unicamente in essa - e nel suo telos evolutivo –
risulta presente questo slancio alla formazione di una cultura universale
ed infinita. Husserl non intende affatto dar ragione dell’evoluzione
storico-empirica del mondo europeo, quanto piuttosto metterne in luce
la peculiarità essenziale: la presenza di un Logos assoluto ed universale al
cui interno si genera una forma altrettanto universale ed assoluta di
storicità. Tale storicità è la storicità propria della scienza e della
filosofia141.
Sulla concezione della storia nella filosofia di Husserl si vedano: P. Ricoeur,
Husserl und der Sinn der Geschichte (1949), in AA.VV., Husserl, hrsg. von H. Noack,
Darmstadt, 1963, pp. 231-276; E. Filippini, Sull’idea di una storiografia teleologica nella Krisis,
in «Aut-Aut», 54 (1959), pp. 20-35; H. Hohl, Lebenswelt und Geschichte. Gründzuge der
Spätphilosophie Edmund Husserls, Freiburg, 1962; G. Piana, Esistenza e storia negli inediti
husserliani, Milano, 1965; L. Landgrebe, Phänomenologie und Geschichte, Gütersloh, 1967; B.
M. D’Ippolito, Ontologia e storia in Husserl, Salerno, 1968; P. Jansenn, Geschichte und
Lebenswelt. Ein Betrag zur Diskussion von Husserls Spätwerk, Den Haag, 1970; A. Pazanin,
Wissenschaft und Geschichte, Den Haag, 1972; G. Forni, Il soggetto e la storia, Bologna, 1972;
P. Jannsen, Ontologie, Wissenschaftstheorie und Geschichte im Spätwerk Husserls, in Perspektiven
tranzendentalphänomenologischer Forschung, hrsg. von K. Held, U. Claesges, Den Haag, 1972,
pp. 145-163; G. H. Vásquez, Intentionalität als Verantwortung. Geschichtsteleologie und
Teleologie der Intentionalität bei Husserl, Deen Haag, 1976; A. A. Bello, Husserl e la storia,
Parma, 1976 (del quale si veda anche la recensione di M. Malatesta, Edmund Husserl e la
Storia, in «Rassegna di scienze filosofiche», XXVI, 1-2 (1973), pp. 171-176); A. Pazanin,
Die Phänomenologie als transzendentale Theorie der Geschichte, in «Phänomenologische
Forschung», 3 (1976), pp. 17-47; L. Landgrebe, Lebenswelt und Geschichtlichkeit menschlichen
Daseins, in AA.VV., Phänomenologie und Marxismus 2: Praktische Philosophie, hrsg. von B.
Waldenfels, J. M. Broekman, A. Pazanin, Frankfurt, 1977, pp. 13-58; G. Brand,
Horizont, Welt, Geschichte, in «Zeitschrift für Phänomenologische Forschung», 5 (1978),
pp. 14-89; R. L. Kelken, History as Teleology and Escatology. Husserl and Heidegger, in
«Analecta Husserliana», 9 (1979), pp. 381-411; B. M. D’Ippolito, The Theory of The Objekt
and The Teleology of History in Edmund Husserl, in «Analecta Husserliana», 9 (1979), pp.
271-274; E. Ströker, Geschichte und Lebenswelt als Sinnesfundament der Wissenschaften in
Husserls Spätwerk, in Lebenswelt und Wissenschaft in der Phänomenologie E. Husserls, hrsg. von
E. Ströker, Frankfurt, 1979, pp. 107-123; R. Bernet, Differenz und Anwesenheit. Derridas
und Husserls Phänomenologie der Sprache, der Zeit, der Geschichte, der Wissenschafts Rationalität,
in «Zeitschrift für Phänomenologische Forschung», 18 (1986), pp. 51-112; E. Garulli,
Husserl e la filosofia della storia, in AA.VV., E. Husserl. “La Crisi delle scienze europee e la
responsabilità storica dell’Europa”, cit., pp. 173-193; M. Signore, Problema teleologico e
fenomenologia della temporalità, in AA.VV., E. Husserl “La Crisi delle Scienze Europee e la
responsabilità storica dell’Europa”, cit., pp. 157-172; A. Rizzacasa, Life World, History, and
Ethics in a Husserlian Perspective, in «Analecta Husserliana», 22 (1987), pp. 509-517; K. H.
Lembeck, Gegenstand Geschichte, Dordrecht/Boston/London, 1988.
Si vedano inoltre i più recenti: E. Ströker, The Husserlian fondation of Science,
Dordrecht/London/Boston, 1097, pp. 207-250; R. Cristin, Fenomeno storia. Fenomenologia
e storicità in Husserl e Dilthey, Napoli, 1999; T. Stähler, Die Gerichtheit der Geschichte bei Hegel
und Husserl, in AA.VV., Subjektivität-Verantwortung-Wahrheit. Neue Aspekte der
141
Edmund Husserl e l’umanità europea
Phänomenologie Edmund Husserls, hrsg. von D. Carr, C. Lotz, Band I, Frankfurt, 2002, pp.
261-279; T. Wolf, Vom Sinnesding zur Sinngeschichte. Narrative Phänomenologie bei Husserl und
Schapp, in Subjektivität-Verantwortung-Wahreit. Neue Aspecte der Phänomenologie Edmund
Husserls, Frankfurt, cit., pp. 303-323.
La questione della diatriba tra Husserl e Dilthey era già stata trattata, con dei
riferimenti alla questione della storicità, in B. M. D’Ippolito, Il sogno del filosofo: Husserl e
Dilthey, Napoli, 1987, che in appendice riporta anche la corrispondenza tra i due filosofi,
e in G. Cacciatore, Il fondamento dell’intersoggettività tra Dilthey e Husserl, in Id., Storicismo
problematico e metodo critico, Napoli, 1993, pp. 249-288.
Sulla questione del telos europeo si veda in particolare V. Costa, La fenomenologia
della contaminazione, Introduzione a J. Derrida, Il problema della genesi nella filosofia di Husserl,
Milano, 1992, pp. 11-18, nel quale l’autore mostra come Derrida accusi la posizione
husserliana di essere sostanzialmente figlia di un idealismo di stampo hegeliano.
Quest’accusa coincide in sostanza con la critica presente nel testo di Ricoer sul senso
della storia nella fenomenologia husserliana che si è precedentemente citato. Al
contrario si confronti la posizione di R. Cristin, La filosofia come lingua europea, in E.
Husserl, Crisi e Rinascita della cultura europea, cit., pp. 9-26, nel quale l’autore individua,
nella concezione husserliana della storia europea, l’idea della filosofia intesa non come il
principio metafisico dell’evoluzione storica di quel mondo, ma piuttosto come la sua
grammatica di pensiero. Su questa linea si vedano anche R. Cristin, S. Fontana, Europa al
plurale, Venezia, 1997; S. Fontana, L’Europa luogo dello spirito, in AA.VV., La fenomenologia
e l’Europa, Atti del convegno internazionale di Trieste, 22-25 novembre 1995, cit., pp. 391-410 e
R. Cristin, La rinascita dell'Europa: Husserl, la civiltà europea e il destino dell'Occidente, Roma,
2001. A proposito della teleologia della cultura europea, si veda anche A. G. Marqués,
L’Europa e la teleologia della ragione in Husserl, in AA.VV., La fenomenologia e l’Europa, Atti del
convegno internazionale di Trieste, 22-25 novembre 1995, cit., pp. 331-343.
Christoph Jamme
Pensée des origines et cosmopolitisme.
Hölderlin et la destruction de l’humanisme chez
Heidegger
On rencontre couramment le concept d’humanisme dans les
discussions de pédagogie portant sur le concept d’éducation [Bildung]; c’est
sous le terme de «Théorie de l’éducation de l’humanisme allemand» que,
par exemple, Clemens Menze réunit les conceptions de Herder,
Humboldt, Friedrich Schlegel, Schiller et Fichte1. Il est toujours
également question à ce sujet du débat concernant les relations entre la
pédagogie des Lumières et la conception classique de l’éducation
allemande. Ce débat remonte à Friedrich Immanuel Niethammer, qui
forgea le néologisme «humanisme» (1808) et le légua aux discussions des
sciences de l’éducation2. Dans le contexte politique, le concept
d’humanisme - que ce soit aux Pays-Bas ou en France - indiquait
infailliblement une position anti-chrétienne, ou du moins athée. Dans les
sciences historiques, «humanisme» fait référence au renouveau des études
antiques («studia humanitatis», «studi humanista») – ce mouvement
scientifique de l’Italie du XIVème siècle, étroitement lié à la Renaissance,
qui s’attacha à l’Antiquité romaine, puis également grecque à partir du
XVe siècle.
Cet humanisme italien fut transmis à Heidegger, à partir de 1929
environ, par Ernesto Grassi, qui s’y associait encore lorsque parut l’écrit
de Heidegger sur La doctrine de Platon sur la vérité.
Concernant le débat philosophique allemand, la problématique de
l’humanisme vint de l’étranger, plus précisément de France, après 1945.
La France est le destinataire de la Lettre sur l’Humanisme de Heidegger
d’un double point de vue: d’une part, la Lettre fut à l’origine une réponse
à la question de Jean Beaufret: «Comment redonner un sens au mot
“humanisme”? ». D’autre part, elle est dirigée contre l’ouvrage de Sartre
Article «Culture» in Handbuch Pädagogischer Grundbegriffe, J. Speck et G. Wehle
(eds.), Vol. I, München, Kösel, 1970, pp. 134-84.
2 F. Niethammer, Der Streit des Philanthropinismus
und Humanismus, Jena,
Frommann, 1808 (réimp. d. Id., Texte zur Schulreform, hrsg. von W. Hillebrecht, BerlinBasel, Weinheim, 1968), pp. 71 sq. Je suis redevable des remarques suivantes à Otto
Pöggeler.
1
170
Logos
L’existentialisme est un humanisme: la pensée de Être et Temps s’y voit
annexée sous le nom d’«existentialisme athée» et mise en parallèle avec
celle des existentialistes français, de Sartre lui-même notamment. La
question de Beaufret, selon Heidegger, «dénote l’intention de maintenir
le moi lui-même. Je me demande si c’est nécessaire» (56)[70]3. Que cela
ne soit pas nécessaire, c’est ce que montre la vie philosophique des trente
années suivantes, au cours desquelles le concept d’ «humanisme» ne joua
pas – plus – un très grand rôle.
Emmanuel Levinas fut, en 1972, une exception. Le point de départ
de son livre Humanisme de l’autre homme est la thèse selon laquelle la
conception de l’homme de l’humanisme classique (l’homme comme être
souverain, autonome, libre) est devenue obsolète. Mais pour autant, nous
ne pouvons pas renoncer à chercher la détermination essentielle de
l’homme. Dans cette recherche, ni le structuralisme ni Heidegger ne
peuvent nous guider, étant tous deux des pensées de la totalité aux
conséquences funestes. Le problème gagne en acuité du fait de la
désintégration de la conscience de soi à laquelle a procédé la
psychanalyse - et qui a substantiellement préparé le terrain à l’«antihumanisme». Les événements historiques du XXe siècle ont fait le reste:
«la crise de l’humanisme à notre époque a, sans doute, sa source dans
l’expérience de l’inefficacité humaine qu’accusent l’abondance même de
nos moyens d’agir et l’étendue de nos ambitions […] Les morts sans
sépulture dans les guerres et les camps d’extermination accréditent l’idée
d’une mort sans lendemain et rendent tragi-comique le souci de soi et
illusoires la prétention de l’animale rationale à une place privilégiée dans le
cosmos et la capacité de dominer et d’intégrer la totalité de l’être dans
une conscience de soi»4. Lévinas entrevoit la solution dans l’examen du
«préoriginel de la responsabilité pour les autres». Le sujet «est
responsabilité avant d’être intentionnalité». Précisément par ce que le
«Moi» «est acculé à la responsabilité», il «introduit dans l’être un sens».
L’origine de l’exigence d’horizon surgit de ce que l’autre homme, parce
que vulnérable et mortel, s’adresse à moi –j’en suis responsable. Lévinas
mentionne comme conditions de ce nouvel horizon de l’humanité la
chair et la susceptibilité, qui se justifient par le fait qu’avec elles, c’est à un
être existant dans le temps que nous avons à faire. L’humanisme de
Les pages indiquées dans le corps du texte sont celles de l’édition suivante: M.
Heidegger, Platons Lehre von der Wahrheit. Mit einem Brief über den „Humanismus” 2ème
Edition, Bern, Francke, 1954 [et sont suivies entre crochets de celles de leur traduction
française: Lettre sur l’humanisme, in Id., Questions III et IV, Paris, Gallimard, 1990].
4 E. Lévinas, Humanisme de l’autre homme, Montpellier, Fata Morgan, 1972, pp. 67
sq., 75, 81, 47, 57, 82.
3
Pensée des origines et cosmopolitisme
Lévinas culmine dans l’exigence du visage nu: il déploie le «sens» à partir
de «l’épiphanie du visage». C’est «l’an-archie» qui est en vue: l’ordre
qu’énonce le visage n’a pas de commencement, pas de principe duquel il
pourrait tirer son origine. Du fait de la pré-originarité de l’appel du
visage, «l’anti-humanisme moderne n’a peut-être pas raison de ne pas
trouver à l’homme, perdu dans l’histoire et dans l’ordre, la trace de ce
dire pré-historique et anarchique». «L’humanisme», complète Lévinas
dans Au-delà de l’essence, «ne doit être dénoncé que parce qu’il est
insuffisamment humain»5.
Cette tentative de réhabilitation de l’humanisme resta pourtant sans
postérité et ne permit pas de s’opposer sur le fond à la thèse de Peter
Strasse, selon laquelle le mot humanisme est devenu au cours du siècle
un slogan pour intellectuels paresseux et politiques tièdes; depuis
l’époque romantique, «depuis Nietzsche, la décadence et les deux guerres
mondiales», l’intelligence critique a entretenu un regard «anti-humaniste»,
qui porte par delà l’Homme, et loin de lui. Dans le domaine des idées, les
livres cultes contemporains se plaisent à apprendre à l’Homme que son
visage va disparaître, «comme sur le rivage un visage de sable»6. C’est
seulement en 1985, et, ce n’est pas un hasard, à nouveau de la France,
que fut amorcé un nouveau débat, avec le livre de Ferry et Renaut: La
pensée 68. Essai sur l’anti-humanisme contemporain. La question était de savoir
si les «maîtres à penser» français s’inspirant de Marx et de Heidegger,
dans un ensemble d’œuvres «chronologiquement proches de Mai, et,
surtout, dont les auteurs se sont reconnus, le plus souvent explicitement,
une parenté d’inspiration avec le mouvement»7 ne se sont pas faits
complices, par leurs plaintes contre l’humanisme traditionnel, de la
préparation réelle de l’inhumanité politique effective. Les partisans de
Foucault, Derrida ou Lacan répondirent avec un silence glacé ou une
vive indignation. La question gagna une certaine actualité dans le débat,
réouvert par Farias, de la compromission de Heidegger avec le régime
E. Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Paris, Le Livre de Poche, 2001,
p. 203.
6 P. Strasse, Das Menschmögliche. Späte Gedanken über den Humanismus, Wien,
Deuticke, 1996. L’idée d’un «changement de perspective» faisant passer d’un
économisme sans âme à l’humanisme comme nouvelle culture dominante est pourtant
actuellement propagée par Julian Nida-Rümelin: Humanismus als Leitkultur, München,
Beck, 2006. Le terme d’humanisme doit être compris ici comme un ensemble de
procédures orientées vers la compréhension mutuelle des hommes, comme une culture
de l’argumentation publique et de l’intégration, qui rendent possible la société
civile. Tolérance, respect et amitié en sont les valeurs directrices.
7 L. Ferry, A. Renaut, La pensée 68. Essai sur l’anti-humanisme contemporain, Paris,
Gallimard/NRF, 1985, p. 12.
5
172
Logos
nazi. Dans leur livre Heidegger et les Modernes, ils tentent de penser le
rapport de Heidegger à Hitler à partir de la critique de fond du premier
de ce qui est caractérisé comme un «projet moderne» (Habermas), ou
comme procès d’une modernité culturelle (Adorno/Jauss). Ils
soutiennent cette thèse, à méditer: «a critique romantique de l’Aufklärung
anticipe sur la déconstruction heideggerienne de la subjectivité»8. On
peut néanmoins, par un regard sur l’histoire intellectuelle de l’Allemagne
à l’orée du XIXe siècle, émettre des doutes sur cette comparaison entre
Aufklärung et Modernes d’une part, romantiques et anti-modernité
d’autre part: la rémanence, précisément, de motifs des Lumières dans la
pensée pré-romantique, celle d’un Schlegel ou d’un Novalis, a été
démontrée.9
I
Pour pouvoir éprouver la validité de la thèse de Renaut et Ferry, il
est important, en premier lieu, de jeter un oeil sur la façon dont
Heidegger lui-même définit sa relation au dit «humanisme». Dans la Lettre
sur l’Humanisme, c’est tout à fait clair: «Tout humanisme», est-il dit de
manière définitive, «se fonde sur une métaphysique ou s’en fait lui-même
le fondement» (63 sq.)[77 sq.]. Dans un état d’effondrement physique et
psychique directement lié à l’interdiction d’enseigner qui lui est signifiée
(fin décembre 1946), lourdement accusé par Jaspers de collaboration
avec le national-socialisme, Heidegger cherche dans ce texte à préserver
sa réputation. Loin de procéder à son auto-critique, comme pouvait
l’espérer Jaspers (et plus tard Celan) il compte montrer la continuité
ininterrompue de sa pensée, et, ce faisant, il essaie d’occuper de nouveau
une place centrale dans les débats qui agitent l’Europe intellectuelle10. Il
explique que l’objet de sa réflexion depuis Être et Temps est le
décentrement du sujet et l’adieu à la philosophie de la subjectivité. On
peut ainsi comprendre la nécessité de sa prise de position contre
l’Humanisme de la Modernité, qui trouve son fondement dans le
caractère ultime et indépassable du «cogito» cartésien.
L. Ferry, A. Renaut, Heidegger et les Modernes, Paris, Grasset, 1988, p 193.
Cf. le volume Idealismus und Aufklärung, hrsg. von. C. Jamme/G. Kurz, Stuttgart,
Klett-Cotta, 1988.
10 V. Gerhardt [Der Rest ist Warten. Von Heidegger führt kein Weg in die Zukunft in
«Merkur», 55 (2001), pp. 189-202, ici p. 195] remarque de manière polémique: «On ne
peut nier que la lettre d’Heidegger vise à porter secours, mais non pas tant à l’Homme
qu’à une personne singulière – en fait à lui-même».
8
9
Pensée des origines et cosmopolitisme
Le centre de la Lettre sur l’Humanisme est le dépassement conséquent
de la séparation entre agir et penser, théorie et praxis. Heidegger puise en
quantité dans le cours sur le Sophiste, de 1924/25, où il était question de
l’opposition entre phronésis et sophia, ou plutôt entre phronésis et technè. Le
contenu de la phronésis est pourtant la praxis. «L’épistemè est […] ellemême une praxis, une praxis qui n’a point pour but la production d’un
quelconque résultat mais vise purement et simplement à conquérir l’étant
comme aléthès […] L’alétheuein est partie prenante du mode d’effectuation
d’une poiésis ou d’une praxis»11. Ce qui est discuté chez Aristote sous le
nom de «phronésis» et de «sophia», prendra bientôt le nom de raison
«théorique» et «pratique». Chez Aristote, la sophia occupe un plus haut
rang que la phronésis. La thèse de Heidegger dans la Lettre sur l’Humanisme
est qu’agir et penser sont identiques, ce en tant qu’alétheuein, en tant
qu’accomplissement de la relation à l’Être. Pour trouver le lieu adéquat
de la rencontre de l’Homme et de l’Être, il faut laisser derrière soi aussi
bien la théorie «pure» que la praxis «efficace».12 La pensée «agit» en ce
qu’elle pense, mais l’agir contient également son sens «pensant», pour
autant qu’il se meut dans l’authentique accomplissement. C’est également
de l’agir qu’effectuent dans le langage les penseurs et poètes: «Le penser
effectue ce faire» par lequel l’art (comme poiésis: laisser se faire l’advenir de
l’étant [Geschehenlassen des Seiendes]) est pensé». Penser signifie pour
Heidegger se laisser revendiquer par l’Être, et n’est relatif ni à la praxis ni
à la théorie.
Parce qu’Heidegger oppose sèchement à tout «interprétation
technique du penser» une fin de non-recevoir, il doit également rejeter
l’humanisme, pour lequel la pensée est une technique et la philosophie
une science. L’humanisme restant prisonnier du domaine de la
métaphysique, la question décisive qui porte sur la vérité de l’Être n’est
pas davantage prise en considération. Dans la mesure où l’Homme perd
progressivement de vue son destin à venir, «qu’il trouve dans la vérité de
l’Être», dans la mesure où il oublie qu’ «il est le berger de l’Être»
(90)[101]13, la question qui porte sur le sens de l’Être dans le domaine de
11 M. Heidegger, Platon: Sophistes, Frankfurt a. M., Klostermann, 1992 (= GA
II/19), p. 38. [M. Heidegger, Platon: Le Sophiste, trad. J.-F. Courtine, P. David, D.
Pradelle, P. Quesne, Paris, Gallimard, 2001, pp. 44-45].
12 Cf. pour ce qui suit A. R. Rodriguez, Die Technikdeutung Martin Heideggers in ihrer
systematischen Entwicklung und philosophischen Aufnahme, Dortmund, Projekt-Verlag, 1994,
pp. 53 sq.
13 Cf. E. Jünger, Les Titans: «La terre a besoin de l’homme comme pourvoyeur de
soins et comme berger. Nous devons réapprendre à la traiter comme une mère». L’idée
que «berger» a quelque chose à voir avec «élevage», comme on l’affirme depuis peu, est
aberrante.
174
Logos
la pensée métaphysique n’a plus de sens pour lui. Plus l’Homme étend
son pouvoir sur terre, plus il s’éloigne du domaine de la «proximité» de
l’Être, et plus il se rapproche de «l’impasse» totale. Seul un «dépassement
de la métaphysique» peut parvenir à faire retourner le Dasein dans «la
proximité du proche». Cela implique une «relégation» de la subjectivité,
qui peut également conduire à une nouvelle expérience de l’Homme,
ainsi qu’à une nouvelle fondation de l’humanisme. Si l’ancien humanisme
a pour point de départ la définition de l’Homme comme animal
rationale, le nouvel humanisme doit prendre pour point de départ la
compréhension de ce que «l’essence de l’Homme […] [est] essentielle
pour la vérité de l’Etre» (94)[105]. En son centre réside «l’interprétation
de l’essence de l’Homme à partir de la relation de cette essence à la vérité
de l’Etre» (101)[111]. Par cette interprétation est garanti que la pensée de
l’Être se garde à distance de l’illusion anthropologique de l’Homme
comme «centre de l’étant».
C'est dans ce contexte que surgit à bon droit le problème de l'éthique.
Ce problème doit être considéré à la lumière de la relation originaire de
l'éthique à l'ontologie. Heidegger trouve l'essence de l'ethos dans la pensée
d'Héraclite (cf. fragment 119). Seule une pensée qui médite la question
qui porte sur la vérité de l'Etre peut être caractérisée comme une
«éthique»; en d'autres termes, l'ontologie(-fondamentale) est déjà en ellemême l'éthique originaire14 car elle pense la vérité de l'Être comme
l'élément originel de l'Homme en tant qu'ek-sistant (109)[118].
L'ontologie fondamentale n'est «ni éthique, ni ontologie» (110)[119]. La
pensée de Heidegger se situe en deçà, ou au-delà, de la distinction
théorique/pratique; elle va plus loin que la théorie et la pratique. Cette
pensée «conduit» l'Homme «au domaine où se lève l'aube de l'indemne»
(112)[121]. Cette pensée simple ne doit pas être confondue avec la
philosophie (cf. 119)[127]. C'est en cela que la pensée telle que la
caractérise Heidegger dans la Lettre sur l'Humanisme s'avère être un
dépassement du clivage entre théorie et praxis: en ce qu'elle tente de
conserver la signification originelle de l'agir comme «accomplissement».
Contre la métaphysique et l'humanisme que fonde cette dernière,
Heidegger pose une «pensée qui pense à partie de la question portant sur
la vérité de l'Être», et qui pour cette raison, «questionne plus
originellement que ne peut le faire la métaphysique» (102)[112]. Seules
14 Dans sa dernière leçon de Marbourg (Metaphysische Anfangsgründe der Logik im
Ausgang von Leibniz [1928]; GA II/26), Heidegger donne systématiquement comme lieu
de l’éthique la met-ontologie, et plus spécifiquement la métaphysique de l’existence. Je
suis redevable de cette remarque à F. W. von Hermann.
Pensée des origines et cosmopolitisme
ces questions originelles parviennent à obtenir des réponses aux
questions qui sont pour Heidegger centrales: celles, notamment, portant
sur le «sacré», la «divinité», et finalement «Dieu» (ibid.). Il en va de la
«relation du Dieu à l'Homme», d'une réponse à la question décisive de
savoir «si le Dieu s'approche ou s'il se retire» (102)[112].
C’est cette dimension du «sacré» (ibid.) que l’humanisme n’atteint
jamais. Heidegger en donne pour exemple les deux poètes Goethe et
Hölderlin. Hölderlin n’appartient pas à «l’Humanisme du XVIIIe siècle,
tel que l’illustrent Winckelmann, Goethe et Schiller», pour la bonne
raison qu’ «il pense le destin de l’essence de l’Homme plus originellement
[!] que cet ”humanisme” ne peut le faire» (63)[76]. Pourquoi «plus
originellement» ? Parce que toute l’œuvre poétique d’Hölderlin est
déterminée par la question de savoir «si le jour du sacré se lève et
comment il se lève, si dans cette aube du sacré une apparition du dieu et
des dieux peut à nouveau commencer et comment» (85)[97]15. Heidegger
le montre ici –comme dans son discours en souvenir du poète à
l’occasion du centenaire de sa mort en 1943– à propos de l’élégie
Heimkunft, où Hölderlin thématise sous le nom de patrie la «proximité à
l’Être» (85)[97]16. Ailleurs, Heidegger donne pour preuve du caractère
«pré-métaphysique» de la poésie d’Hölderlin le poème Andenken: «la
pensée de Hölderlin, aux dimensions de l’histoire du monde», qui trouve
ici son expression, «est essentiellement plus originelle [!] et de ce fait
même, plus future que le pur cosmopolitisme de Goethe» (86)[98].
C’est justement grâce à l’exemple du poème Andenken que devient
clair ce que vise Heidegger: sa critique de l’humanisme vise rien de moins
qu’une discussion portant sur la compréhension de l’essence de la raison
et de la conscience de soi. Cette discussion est aujourd’hui ranimée par le
livre de Dieter Henrich Der Gang des Andenkens (1986): pour Heidegger, la
grandeur d’un poème comme Andenken vient de ce que «dans la poésie
d’Hölderlin sont pour la première fois dépassés l’art, la beauté, et toute la
métaphysique dans laquelle ils ont leur lieu»17. A l’opposé, Henrich
maintient le concept (idéaliste) de la subjectivité consciente de soi et les
catégories de l’individualité. C’est la raison pour laquelle Hölderlin
constitue pour lui non pas la grande alternative à la pensée métaphysique
Cf. également M. Heidegger, Holzwege, Frankfurt a.M., Klostermann, 19634, p.
248 [Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard, p. 323].
16 Cf. Id., Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, 4ème édition, Frankfurt a.M.,
Klostermann, 1971, p. 9 sq.
17 Id., Hölderlins Hymne “Andenken”, Frankfurt a.M., Klostermann, 1982 (=GA
II/52), p. 63.
15
176
Logos
occidentale, mais au contraire un trait d’union vers un renouvellement,
en accord les standards actuels de la connaissance, de la métaphysique –
c’est-à-dire une tentative d’ébauche de philosophie moniste, qui
permettrait de reconduire en une unité les tendances conflictuelles de la
«vie consciente».18
Pour mieux comprendre l’argumentation de Heidegger, il nous faut
interroger le sens de son appel à ne pas nous méprendre sur l’originel de
la poésie d’Hölderlin –ce que nous risquons de faire si nous pensons
l’essence de cette poésie à partir de l’essence métaphysique bien connue
de l’art. L’expérience que l’Homme occidental fait du monde depuis
2000 ans étant métaphysique, l’essence de l’art se détermine également
par la distinction fondamentale de l’intelligible et du sensible19. L’art est
symbole [Sinn-Bild]: présentation d’un sens intelligible dans du sensible –
en image, en son, en pierre. Chez Platon comme chez Hegel, la
composante simplement sensible de l’art a été dévalorisée au profit de la
pure apparition de l’Idée, telle que peut la saisir la pensée. Lorsque
Nietzsche renverse cette dévalorisation du Beau et de l’Art, il se meut
pourtant encore au sein de cette approche métaphysique. C’est à cette
essence métaphysique de l’art que ne se rattache pas la poésie
d’Hölderlin. Le dit poétique d’Hölderlin est un nommer, «une
détermination spécifique, qui ne peut d’office être mise sur le même plan
que d’autres poésies et d’autres poètes. L’être historique de la poésie de
Goethe et de Schiller est tel qu’il ne peut ni ne doit être un nommer,
quand bien même Goethe et Schiller sont contemporains de
Hölderlin»20.
Cette remarque, en 1942, est typique de son époque, dans la mesure
où la germanistique national-socialiste avait également dénoncé la «poésie
didactique» [Bildungsdichtung], celle de Goethe par exemple, comme
littérature «sans lien avec la grande communauté du peuple», sans
«contact direct avec la terre» (d’après l’histoire littéraire à succès de
l’écrivain et rédacteur Paul Fechter, Dichtung der Deutschen, 1932). Le
germaniste Hans Naumann accompagna de ces mots l’autodafé de la
place du marché de Bonn, le 10 mai 1933: «Nous avions autrefois
Walther von der Vogelweide et ses disciples, tout comme nous avons eu
Cf. à ce sujet ma contribution Hölderlin und das Problem der Metaphysik in
«Zeitschrift für philosophische Forschung», 42 (1988), pp. 645 sq.
19 M. Heidegger, Hölderlins Hymne „Der Ister”, Frankfurt a.M., Klostermann, 1984,
(= GA II/53), p. 18.
20 Ivi, p. 24. Sur le rapport entre Schiller et l’humanisme, cf. à présent M.
Heidegger, Übungen für Anfänger. Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen,
hrsg. von U. v. Bülow, Marbach a. Neckar, Dt. Schillerges., 2005, p. 10.
18
Pensée des origines et cosmopolitisme
plus tard Klopstock et Hölderlin, Schiller et Kleist. Ils étaient le savoir
vivant de la nation»21. Les visions humanistes de Goethe, dans Faust et
Wilhelm Meister, n’allaient pas sans difficultés (comme on put s’en rendre
compte par la réaction officielle très succincte à la traduction du travail
de référence de Bruford, Die gesellschaftlichen Grundlagen der Goethezeit,
Weimar 1936). Le Völkische Beobachter excuse dans sa recension le
«cosmopolitisme de nos classiques» par les «relations basses et étroites
des anciennes patries allemandes. Car il n’y avait pas encore de nation
purifiée». Pourtant, Heidegger ne doit pas être mis sans regarder plus
avant en parallèle avec la germanistique nazie –cela pourrait
éventuellement être fait pour le rejet du cosmopolitisme de Goethe; mais
pas pour sa compréhension d’Hölderlin. La relation de Heidegger au
marginal Kommerell est ici significative; Heidegger entretient avec lui en
1941 un dialogue intense, grâce à sa conférence, tenue plusieurs fois
entre 1939 et 1940, sur l’Hymne Wie wenn am Feiertage. Mais Kommerell
se ligua finalement avec Bultmann contre Heidegger et, contre ce
dernier, il soutient que «l’attitude anti-christique» de Goethe était bien
moins «hybride et entêtée» que celle de Hölderlin22.
L’affinité de Heidegger avec Hölderlin et son rejet de Goethe ne
sont pourtant pas, en dernière instance, à ranger, d’après leurs motifs,
dans le champ des études littéraires ou dans celui de l’histoire littéraire
(même si Heidegger, dans sa première leçon sur Hölderlin, cherche à
discréditer la poésie lyrique de Goethe en la qualifiant de «sonnerie
rimée» et de «mélopée»23), mais doivent être traités de manière
philosophique. Quand Heidegger glorifie la poésie de Hölderlin en tant
que «nommer», il pense à la nomination des divinités et de la nature,
c’est-à-dire du sacré. Ce nommer, comme «dit» poético-historique,
montre la vérité originelle, qui reste pour toute pensée scientifiquemétaphysique l’indépassable origine. C’est la raison pour laquelle ce dit
ne peut être correctement saisi à partir d’une approche intellectuelle
métaphysique.
C’est le penser, qui est plus originel que la métaphysique, qu’a tenté
de fonder Heidegger depuis les années ‘30; et cette fondation, qui, de
manière centrale, bourgeonne chez Hölderlin, est à prendre en
Cité d’après Klassiker in finsteren Zeiten 1933-1945, Marbacher Katalog Vol. 1,
Marbach, 1983, p. 281.
22 M. Kommerell, Briefe und Aufzeichnungen, Freiburg, Olten, 1967, p. 452.
Concernant la rencontre de Kommerell et Heidegger, cf. également «Marbacher
Magazin», 34 (1985), pp. 80 sq.
23 G. Gadamer, Die Logik des verbum interius. Hans-Georg Gadamer im Gespräch mit
Gudrun Kühne-Bertram und Frithjof Rodi, in «Dilthey–Jahrbuch», 11 (1997/98), p. 24.
21
178
Logos
considération quand on veut enquêter sur les causes de la destruction
heideggerienne de l’humanisme. C’est dans ce contexte également que
Goethe succombe à la critique.
Il faut néanmoins reconnaître chez le second Heidegger un tournant
significatif dans l’appréciation de Goethe. Depuis 1964 (l’année de sa
jaunisse), il a, comme l’a rapidement raconté Gadamer, «beaucoup lu et
laissé agir Goethe»24. Y ont contribué les contacts avec Emil Staiger, qui
a trouvé pour Heidegger un chemin d’accès au Goethe tardif du Wilhelm
Meister et du Voyage en Italie. «Il est allé», selon Gadamer, «jusqu’à lire et
admirer Le divan occidental»25, après n’en avoir apprécié, dans les années
‘30, que les «notes».
II
Ce revirement du dernier Heidegger n’est pourtant lié à aucune
revalorisation de l’humanisme ni même à un retour sur son rejet de la
responsabilité éthique. Qui agit est responsable et peut être appelé à
assumer cette responsabilité. Heidegger ne le conteste pas. Mais au lieu
d’en faire l’occasion d’une réflexion sur ses liens avec le régime hitlérien,
il comprend littéralement le terme de responsabilité [Ver-antwort-ung] et
s’en tient à l’agir «le plus simple et le plus haut», le penser. Quand
Heidegger considère le penser comme une forme d’agir, auquel peut se
rattacher la responsabilité, se pose la question de savoir si les hommes
peuvent être considérés comme responsables de ce qu’ils pensent. Chez
Heidegger, la responsabilité du penseur consiste à se conformer à
«l’essence» de l’homme, en tant qu’il la pense. A ne pas s’acquitter de
cette tâche, il échoue comme homme, perd sa destination, entre dans
«l’oubli de l’Être». A côté de la responsabilité pour cette tâche
[Auftragsverantwortung], qui implique de devoir à l’Être comme mandant
des comptes pour une tâche qu’on assume, il faudrait compter les
destinataires de la responsabilité [Adressatenverantwortung]. C’est en tous
Ibid.
Ibid. Sur Staiger, cf. la lettre de Heidegger à Staiger du 30.4.1959, publiée à
présent par W. Wögerbauer dans Der Briefwechsel zwischen Martin Heidegger und Emil
Staiger, in «Geschichte der Germanistik. Mitteilungen», 25/26 (2004), pp. 34-79, ici pp.
50 sq. Relativement à sa conférence sur Hebel, Heidegger lut Goethe «assez souvent»;
cf. la lettre à sa femme Elfride du 18.4.1956, in „Mein liebes Seelchen!” Briefe Martin
Heideggers an seine Frau Elfride. 1915-1970, G. Heidegger (ed. et commentaires),
München, btb, 2007 (2005), p. 312. Cf. sur toutes ces relations. C. Pornschlegel,
Versgehüpfe, Reimgeklingel, Singsang. Heideggers Auseinandersetzung mit Goethe, in Goethes
Kritiker, hrsg. von K. Eibl, B. Scheffer, Paderborn, Mentis-Verlag, 2001, pp. 117-134.
24
25
Pensée des origines et cosmopolitisme
cas ce que pense Dieter Thomä, qui définit la responsabilité envers ses
destinataires comme responsabilité envers ceux, qu’ils le veuillent ou
non, qui sont engagés par la réalisation de la tâche dans une communauté
de souffrance. Cette responsabilité ne fait pas partie des préoccupations
d’Heidegger. Puisque tous les hommes ont en commun la tâche de
penser «l’essence de l’Être», aucun conflit ne peut, pour Heidegger, surgir
entre eux. Thomä26 va jusqu’à demander si le présupposé d’Heidegger,
selon lequel le penser est une forme d’agir, est même seulement
plausible.
Le penser est un correspondre [Ent-sprechen], se laisse revendiquer et,
en conséquence, porte à la parole –quoi ?– «le destin de l’Être». Le
penser est «asservi» [hörig] à l’Être. Il est ce qui, «obéissant, appartient à
l’Être» [hörend dem Sein Gehörende]. Le seul agir salvateur: comme humble
quant-à-soi, comme penser de l’origine indisponible. C’est en cela que
réside l’appel, aujourd’hui pleinement actuel, à l’abandon de la volonté de
puissance néfaste et du caractère productiviste de la civilisation technique
et scientifique moderne. Sa métaphore célèbre de l’Homme comme
«berger de l’Être» [Hirt des Seins] est dirigée contre la domination de la
rationalité scientifique et technique dont Heidegger traque les racines
par-delà Descartes jusqu’aux ontologies de Platon et Aristote. La
technique sous cet aspect, bien connu chez Heidegger, apparaît comme
l’achèvement et l’apogée de la métaphysique. Dans son œuvre tardive, il
s’agit pour lui, de plus en plus, de chercher une compréhension posttechnique de la nature. En opposition au projet technique de maîtrise de
la nature, Heidegger évoque la possibilité d’une relation à la nature qui la
sauve, l’épargne et la soigne –comme c’est le cas des jardins de Vallier
chez Cézanne– ; d’un habiter-en-elle [Auf-ihr-Wohnen]27. Heidegger a
montré que les racines de notre problème actuel plongent profondément
dans l’histoire de la métaphysique et dans ses origines grecques. Mais
simultanément, il a développé une éthique du sol, qui, comme l’a
remarqué Werner Marx, s’est efforcée pour sa part, de fonder une
26D. Thomä, Was heißt‚Verantwortung des Denkens’? Systematische Überlegungen mit
Berücksichtigung Martin Heideggers, in «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», 45 (1997),
pp. 559-572.
27 Une situation menaçante recèle une incitation à la liberté et à la responsabilité.
C’est là que pourrait résider l’origine d’une éthique de l’événement historique qui,
comme la proposé F.W. v. Hermann, culminerait dans les nouveaux impératifs
catégoriques suivants: «Agit de façon à faire de l’attention portée à l’essence de chaque
étant et à son dévoilement la maxime de ta volonté, qui contribue à une législation
universelle». F.W. v. Herrmann, Die Gefahr im Ereignis, in «Existentia», 1-2, 15 (2005),
pp. 1-14, p. 6.
180
Logos
éthique post-métaphysique. La recherche de Marx est éminemment digne
de considération, et particulièrement en ce qu'elle tente de prendre en
compte les objections dont Heidegger lui-même avait envisagé qu'elles
pouvaient être faites à sa propre position. Il avait ainsi expressément
rejeté le reproche selon lequel «le contraire de l' “humanisme” […] recèle
la défense de l'inhumain» (98). Mais il faut bien plutôt être attentif aux
«autres perspectives» qui sont ouvertes: un penser dirigé «contre la
subjectivation de l'étant en un simple objet», qui «[amène] devant le
penser l'éclaircie de la vérité de l'Être» (99). Le «penser en valeurs» serait
à ce titre (contre Scheler) «le plus grand blasphème qui se puisse proférer
à l'égard de l'Être». L'ontologie est plus originaire que l'éthique, elle est
même l'éthique originaire («le penser qui pense la vérité de l'Être en tant
qu'élément originaire de l'Homme comme ek-sistant, [est] en soi-même
déjà l'éthique originaire» [dasjenige Denken, das die Wahrheit des Seins als das
anfängliche Element des Menschen als eines eksistierenden denkt, [ist] in sich schon
die ursprüngliche Ethik] [109]), car le penser (de l'Être) se situe avant la
dissociation de la théorie et de la praxis (ce que fonde l'analyse du monde
ambiant de Être et Temps à laquelle il est fait recours).
Néanmoins, la tentative de fondation d’une pensée an-humaniste
chez Heidegger reste en un point éminemment central profondément
problématique. «Le philosopher de Heidegger», selon Otto Pöggeler dans
sa postface à la troisième édition de son livre La pensée de Martin Heidegger,
un cheminement vers l’Être, «ne s’expose pas concrètement à une révision
par Autrui […]»28. Contre Heidegger, Werner Marx atteint la dimension
éthique justement à partir de l’accent qu’il met sur Autrui. L’angoisse,
qui, comme angoisse devant la mort, constitue l’expérience de notre
mortalité constante, conduit selon Marx à un «effroi» ; cet effroi nous
arrache à notre indifférence à l’égard des autres, qui sont mortels au
même titre que nous le sommes. Cet effroi nous donne la capacité de
compatir et, ce faisant, nous transforme. Mais cette transformation ne
peut être enseignée. Car cette expérience d’abord individuelle n’est pas
une idée de la raison, ni un simple calcul sur l’assistance mutuelle en cas
de
détresse,
mais
surtout
et
en
premier
lieu
une
«disposition» [Gestimmtheit], une émotion clairvoyante, un sentiment
pensant.
La fondation par Marx d’une nouvelle morale axée sur la solidarité
humaine est post-métaphysique dans la mesure où elle doit prendre en
28 O. Pöggeler, Der Denkweg Martin Heideggers. 3ème édition, Pfullingen, Neske, 1990,
p. 387 [La pensée de Martin Heidegger, un cheminement vers l’Être, trad. M. Simon, Paris,
Aubier-Montaigne, 1967].
Pensée des origines et cosmopolitisme
compte la critique heideggerienne de la conscience de soi moderne du
sujet et dans la mesure où la philosophie morale est liée à une critique
fondamentale de l’époque. Le noyau de la critique heideggerienne de
l’«arraisonnement» [Ge-stell] de la technique réside dans l’appel adressé à
l’homme d’«habiter» finalement humainement, «en poète» [dichterisch], la
terre. La critique selon laquelle il n’est plus question du savoir de soi et
de la réalisation de soi du sujet, mais de manières de penser qui
surenchérissent sur la scission moderne de l’objet et du sujet reçoit l’aval
de Werner Marx, mais ce dernier met également en garde contre les
extrémités auxquelles elles peuvent mener. Nous devons laisser «être» la
terre comme terre, le penser subjectif doit se reprendre, devenir pour
ainsi dire pauvre. Pour ces autres manières de penser, Marx n’en appelle
pas seulement à Heidegger mais également à des penseurs qui lui sont
aussi opposés que Rosenzweig, Marcel, Lévinas: des penseurs qui ont
mis l’accent sur le dialogique et par là sur la différence, et qui ont du
pour cette raison poser à Heidegger la question de savoir si son
dépassement de la métaphysique n’en restait pas à la recherche
métaphysique de l’identité.
Marx se rattache surtout à Hölderlin. C’est de son poème In lieblicher
Bläue qu’est tirée la question qui sert de titre à son livre Gibt es auf Erden
ein Mass ? (question qu’Heidegger avait déjà évoquée pour son
interprétation du poète dans ses cours sur Hölderlin de 1934/35). Selon
l’interprétation de Heidegger, le sujet du poème est l’habiter poétique de
l’Homme dans le «quadriparti» [Geviert], qui place les mortels devant les
dieux et laisse la terre s’ouvrir face au cieux.29 Werner Marx lit Hölderlin
d’après Heidegger. Comme Heidegger, il comprend «ein Mass» à partir de
«mesure» [Maßnehmen]. Mais contre Hölderlin et Heidegger, il souligne
qu’existe sur terre une mesure. Ce ne sont pas seulement l’harmonie de la
terre et du ciel, c’est-à-dire la tradition religieuse, qui conduisent à une
mesure; cette dernière peut être gagnée dans la vie quotidienne et peut
également conduire ensuite à un comportement éthique, lorsque les
traditions religieuses sont devenues douteuses. Selon Marx, on n’a pas le
droit de rejeter en bloc la liberté de la raison pratique, qui reste porteuse
de la responsabilité des convictions de chacun. Le concept heideggerien
d’une «garde» [Wächterschaft], reconnaissante, de la vérité qui «éclaire» et
«cèle» à la fois [lichtend-verbergend] contient des restes de morale rationnelle
idéaliste, mais ne limite plus ouvertement cette dernière dès lors
29 O. Pöggeler discute la validité de cette interprétation: „Gibt es auf Erden ein
Maß?”, dans Sterblichkeitserfahrung und Ethikbegründung. Ein Kolloquium für Werner Marx,
hrsg. von W. Brüstle et L. Siep, Essen, Die Blaue Eule, 1988, pp. 127-163.
182
Logos
qu’Heidegger renonce véritablement à toute éthique. Marx ne suit pas
Heidegger sur ce point. Le miracle de l’autonomie personnelle et de la
liberté doit être conservé au sein du dépassement du sujet. Qui est
d’abord auprès de soi ne peut alors qu’être hors de soi, au sein d’une
totalité pensée de manière non-objective. Quand Hans Jonas requiert des
sociétés de l’âge technologique une responsabilité ayant également en vue
les temps à venir, Werner Marx voudrait enraciner cette éthique du
lointain dans une éthique de la proximité. Ce moment de modernité
rationnelle doit survivre à toutes les révisions post-modernes.
Rocco Pititto
Comprensione linguistica e comprensione
musicale.
Ludwig Wittgenstein filosofo della musica?
I temi musicali sono, in un certo senso, proposizioni.
Conoscere l’essenza della logica porterà quindi a conoscenza l’essenza della musica.
La melodia è una specie di tautologia, è conclusa e compiuta in sé; basta a se stessa.
L. Wittgenstein, Quaderni 1914-1916
Parole come “melodia”, “contrappunto”, “fisionomia”, “suono
proposizionale”, “comprendere con l’orecchio interno”, “familiarità”, “la
proposizione come frase musicale”, “temi musicali”, “comprensione e
spiegazione di una frase musicale” sono termini ed espressioni riferibili
all’ambito del sapere della musica e ricorrenti in Wittgenstein. Ma cosa
significano e, soprattutto, riflettono soltanto gli interessi musicali del
filosofo o hanno una qualche attinenza con la ricerca filosofica di
Wittgenstein? E, se invece, il mondo della musica rivelasse qualcosa di
più e fosse strettamente connesso al mondo filosofico e linguistico di
Wittgenstein?
I termini e le espressioni, su riferite, si ritrovano assai di frequente, e
non a caso, nel lessico di Ludwig Wittgenstein, soprattutto nei suoi diari
e nelle lettere ad amici e familiari, in un periodo temporale che copre per
intero tutta l’esistenza del filosofo. Considerati insieme nella loro
articolazione significativa, volendolo essi possono costituire, di fatto, le
linee di una forma di grammatica più generale, che non riguarda soltanto
il campo del sapere della musica, ma anche altri tipi di saperi, oggetto
della stessa ricerca del filosofo. La grammatica come sistema di regole e
norme di uso, cui Wittgenstein fa costante riferimento nel suo approccio
filosofico alle diverse questioni e ai problemi che affronta, può essere
estesa, infatti, a tutti i tipi di sapere, che sono stati esplorati dal filosofo
Il testo di questo saggio riprende in forma più ampia l’intervento tenuto al IX
Convegno internazionale di studi in onore di Olivier Messiaen, sul tema Filosofia della
musica e Musica della Filosofia, organizzato dal Conservatorio Statale di Musica “F.
Torrefranca” di Vibo Valentia nei giorni 23-26 maggio 2008, con la partecipazione di
numerosi e qualificati studiosi, filosofi, musicologi e musicisti.
184
Logos
austroinglese nel corso di tutta la sua ricerca. Questi diversi saperi hanno
in comune una stessa grammatica, le cui regole devono essere
riconosciute e messe in atto, come condizione di una loro intelligibilità. È
per questo che la ricerca di Wittgenstein si sviluppa nella direzione di un
“mostrare” quasi la forma grammaticale che soggiace ad ogni sapere. Sul
piano della grammatica “ritrovata” c’è il punto di convergenza dei saperi
diversi, che concorrono a delimitare il campo più generale degli interessi
del filosofo.
Riconsiderare sotto un’unica e comune grammatica queste parole ed
espressioni, sparse numerose nelle pagine wittgensteiniane, tutte
riconducibili al campo semantico del sapere musicale, ricollocarle nel
discorso più ampio delle concezioni del filosofo e dare loro una
articolazione più compiuta, costituisce un’operazione, da cui potrebbero
derivare una serie di risultati positivi in ordine alla comprensione di
Wittgenstein e della sua opera, sia sul piano teoretico più generale, sia sul
piano della conoscenza stessa delle concezioni filosofiche del pensatore
austroinglese. Un’operazione di questo tipo consente, da una parte, di
dare alla filosofia di Wittgenstein una misura originale più comprensiva,
certamente più adeguata rispetto alla vulgata comune tradizionale, e,
dall’altra, di poter accedere, nello stesso tempo, a una comprensione
migliore e anche più ampia della stessa filosofia wittgensteiniana. Nel
campo del sapere musicale Wittgenstein trova, infatti, non soltanto, degli
esempi particolarmente efficaci per chiarire aspetti importanti della sua
filosofia, ma, soprattutto, significative assonanze e convergenze con le
sue stesse concezioni filosofiche. Sotto quest’aspetto, la stessa
produzione musicale nella sua accezione più ampia, se considerata
attentamente nella sua valenza specifica di essere e di rappresentare un
tipo di sapere, che ha sempre intrigato il filosofo austriaco, potrebbe
diventare una chiave interpretativa della stessa filosofia di Wittgenstein.
È una chiave che, se utilizzata, consentirebbe di poter spiegare in tal
modo certe scelte del filosofo, sia di contenuto che di metodo, in ordine
ai problemi della logica, della filosofia, dell’etica e dell’estetica1.
1 Non si tratta, come è ovvio, di fare di Wittgenstein un filosofo della musica,
quanto di stabilire, ammesso che ci sia stato, il ruolo che la musica ha svolto nella
determinazione e nella chiarificazione della filosofia di Wittgenstein. Da questo punto
di vista, il ruolo della musica appare quanto mai importante e sorprende che di esso si
sia parlato poco nell’ambito degli studi su Wittgenstein, fatte poche eccezioni, come si
avrà modo di sottolineare. Si vedano i saggi di: S. Worth, Wittgenstein’s Musical
Understanding, in «British Journal of Aesthetics», 37, 2 (1997) pp. 158-167; B.
Szabados, Wittgenstein the Musical : Notes toward an Appreciation, in «Canadian Aesthetics
Journal/Revue canadienne d’esthetique», 10 (2004); D. L. Gorlée, Wittgenstein as
Mastersinger, in «Semiotica», 172 (2008), pp. 97-150; P. Niro, Ludwig Wittgenstein e la
Comprensione linguistica e comprensione musicale
Considerando le parole e le espressioni, su riportate, nella loro
articolazione interna come facenti parte di un campo semantico
determinato, riconducibile in particolare all’ambito del sapere musicale, si
può constatare come esse facciano riferimento ad un tipo di grammatica,
proprio quella stessa grammatica filosofica, che si ritrova in opera nella
ricerca di Wittgenstein. Quella seguita dal filosofo austriaco è una
grammatica filosofica costruita su un registro interno, che seleziona e
ordina gli stati mentali degli individui e dà loro una forma particolare,
propria ad ognuno di loro. È attraverso questo registro interno, come
fosse uno strumento o un criterio di classificazione, che si rende
possibile la stessa formulazione linguistica degli stati mentali del
soggetto. Non diversamente accade per gli stessi stati mentali,
riconducibili a una formulazione di tipo musicale nella forma di una
riproduzione musicale, quale essa sia, oggettiva o soggettiva. C’è sempre
in atto nell’individuo un registro interno, che rende possibili queste
operazioni mentali, sia che si tratti di una frase linguistica, sia che si tratti
di una frase musicale, o di un’altra frase ancora. Le stesse leggi logiche
regolano la costruzione delle frasi, sia nella loro formulazione linguistica,
sia nella loro formulazione musicale. Ed è così che in Wittgenstein si dà
una continuità sorprendente tra sapere linguistico e sapere musicale.
L’associare sotto uno stesso comune denominatore, - come fa
Wittgenstein -, formulazione linguistica e formulazione musicale, o, più
semplicemente, linguaggio verbale ed espressione musicale rappresenta,
soprattutto per le implicazioni che presenta, un guadagno teoretico, e sul
piano linguistico, e sul piano musicale. Sotto questo aspetto, c’è, da parte
del filosofo austriaco, soprattutto, il rifiuto di considerare «le definizioni
di stati mentali, desideri, sensazioni, affetti e sentimenti in termini di
entità trascendenti e indipendenti dai nostri paradigmi linguistici: non c’è
la sensazione da un lato e la parola dall’altro che la denota, rispecchia,
rappresenta o raffigura»2. I paradigmi linguistici “vestono” e “mostrano”
in un certo modo gli stati mentali dell’individuo, che a loro volta fanno
riferimento al mondo dell’esperienza. Sotto quest’aspetto, secondo
Wittgenstein, la ricerca delle condizioni di possibilità della formulazione
linguistica degli stati interni non è diversa dalla ricerca delle condizioni di
possibilità della formulazione musicale degli stessi stati interni. È la sfera
musica. Osservazioni filosofiche e riflessioni estetiche sul linguaggio musicale negli scritti di Ludwig
Wittgenstein, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008.
2 A. G. Gargani, Wittgenstein. Musica, parola, gesto, Milano, Raffaello Cortina, 2008, p.
1. Si veda C. O. Nussbaum, The musical representation. Meaning, Ontology, and Emotion,
Cambridge, Mass. The MIT Press, 2007.
186
Logos
interna del soggetto nella sua capacità riproduttiva, che è chiamata in
causa sia nella produzione linguistica, che nella produzione musicale.
Come una particolare esperienza interna (sensazione, riflessione,
emozione e simili) e secondo quale logica acceda alla coscienza del
soggetto e trovi espressione nel linguaggio verbale o nel linguaggio
dell’etica, dell’estetica e della musica è la questione decisiva che è
necessario qui affrontare3. La soluzione, che si intravede nella concezione
del filosofo, va vista nel tentativo di riassorbire «l’esperienza vissuta nella
parola, che la comunica in un contesto di relazioni con altre espressioni e
costellazioni simboliche, con le circostanze della nostra vita e i dintorni
del nostro agire»4. Lungo tutta la sua riflessione, Wittgenstein non vede
una differenza sostanziale tra la produzione di una frase linguistica e la
produzione di una frase musicale. Al contrario trova, invece, una
notevole somiglianza, quasi una forma di compenetrazione tra le due
produzioni, fino a ritenere che l’una spieghi l’altra e viceversa. La
filosofia tende alla musica, come questa tende alla filosofia, perché tutto
è linguaggio e tutto è da comprendere sotto un’unica cifra. La musica è
un parlare con dei suoni, organizzati in un certo modo. «La musica, o
almeno, sicuramente, una certa musica, - afferma Wittgenstein -,
vorremmo chiamarla un linguaggio»5.
Quest’assunto esce anzi confermato riflettendo sul senso del
significato della cosiddetta “svolta linguistica”, avvenuta nella filosofia
del Novecento, un’operazione che si è resa possibile con il contributo
determinante, anche se non del tutto consapevole, di Wittgenstein. Se da
una parte non si può, infatti, non sottolineare quanto la musica abbia
segnato e influenzato la vita e l’opera del filosofo e ne abbia anche
determinato i percorsi più significativi, in ordine anche alla “svolta
linguistica”, non si può, dall’altra, non sottolineare il rapporto di
convergenza che lega insieme filosofia e musica. La musica costituisce,
infatti, lo sfondo, - l’ambiente naturale del filosofo -, entro cui nascono e
si sviluppano le
concezioni linguistico-filosofiche del pensatore
austriaco. La musica, se assunta nella forma intesa da Wittgenstein,
Come afferma Paul Johnston «l’enigma relativo alla nostra esperienza non è che
quest’ultima sia privata, bensì che essa risulti esprimibile; il vero mistero dell’interno è il
mistero di come esso trovi espressione nel linguaggio», P. Johnston, Wittgenstein.
Rethinking the Inner, London, Routledge, 1993, p. 149 (cit. in A. G. Gargani, Wittgenstein.
Musica, parola, gesto, cit., p. 1).
4 A. G. Gargani, Wittgenstein. Musica, parola, gesto, cit., p. 3.
5 L. Wittgenstein, Pensieri diversi, trad. it. a cura di M. Ranchetti, Milano, Adelphi,
1980, p. 117.
3
Comprensione linguistica e comprensione musicale
diventa, allora, la sua cifra ultima, la chiave di lettura per la comprensione
della frase linguistica e della stessa filosofia di Wittgenstein6.
1. Ludwig Wittgenstein: un “cercatore di verità”
L’influenza, esercitata da Ludwig Wittgenstein sul pensiero del
Novecento, è stata enorme e non ha affatto esaurito il suo corso, se essa
continua ancor oggi più di prima, estendendosi anche ad altri campi del
sapere, diversi da quello più strettamente filosofico. Questa influenza,
soprattutto, non è stata inferiore a nessuna altra, nemmeno a
quell’esercitata da uno tra quelli, che possono essere considerati a ragione
i maggiori pensatori del secolo, si pensi a Russell, a Husserl, a Scheler, a
Bergson, a Heidegger, a Merleau-Ponty, a Gadamer, tanto essa è stata
profonda, incisiva e di lunga durata. Piuttosto, rispetto a questi e ad altri
pensatori rappresentativi del Novecento, contemporanei o meno del
filosofo, la influenza di Wittgenstein sulla cultura del suo tempo è stata
più decisiva nella determinazione e nella rappresentazione dei nuovi
scenari, maturati nell’ambito dei diversi saperi, non soltanto filosofici. Gli
scenari dei saperi “contagiati” da Wittgenstein sono proprio quelli che
avrebbero caratterizzato il mondo della cultura del secolo passato e
accompagnato le sue trasformazioni più significative, in ordine,
soprattutto, alla comprensione di sé, degli altri, dell’etica, della credenza
religiosa, dell’estetica, del mondo e, forse, anche, della teologia e di Dio.
È, soprattutto, per questa “contaminazione” dei saperi del Novecento
che la filosofia di Wittgenstein stesso si è costituita come una cifra del
nostro tempo.
La vastità degli interessi, coltivati dal filosofo nell’arco di una vita
“singolare”, e la notevole risonanza delle sue concezioni, suscitata nella
filosofia europea e nordamericana, fanno di Wittgenstein un
interlocutore di primo piano del secolo passato, un pensatore attento a
cogliere ciò che stenta, o è impedito, ad emergere dal “sottosuolo”
dell’anima, per riportarlo all’attenzione di una coscienza vigile come
problema da riconsiderare e da risolvere, visto, però, alla luce di una
diversa concezione filosofica, costruita e proposta dallo stesso
Wittgenstein. Contemporaneamente, nel corso degli anni, matura e si
Joachim Schulte ha sottolineato l’importanza della funzione della musica
nell’opera complessiva di Wittgenstein e ha rilevato, nello stesso tempo, la difficoltà
dello stesso Wittgenstein nello spiegare questa stessa funzione. È una funzione, che si
mostra, ma non si può enunciare o spiegare. Al riguardo, si veda J. Schulte, On Wittgenstein,
in «Philosophical Investigations», 24, 2 (2001), pp. 162-69. Si veda anche B. Szabados,
Wittgenstein and Musical Formalism, in «Philosophy», 81 (2006), pp. 649-658.
6
188
Logos
rafforza nel filosofo austriaco la consapevolezza che «i problemi della
vita sono insolubili, alla superficie, e si possono risolvere solo in
profondità. Nelle dimensioni della superficie essi sono insolubili»7.
Mettendo “ordine tra i pensieri”, Wittgenstein raggiungerà il suo
obiettivo di chiarificazione e darà forma ad una filosofia che non cessa di
interrogare e di porre domande, spingendosi ad evidenziare e a risolvere i
problemi del vivere là dove essi si originano e non dove si manifestano,
nella profondità del loro essere, non nella superficie del loro apparire. Il
mondo viene come rivoltato, quasi “squadernato”, allo scopo di
ritrovarvi un ordine, in grado di ridare un senso al vivere stesso
dell’uomo nel mondo.
Di un secolo dalle “passioni tristi”, così inquieto, travagliato e
dilacerato, - come il Novecento -, il filosofo austriaco è diventato,
nonostante le sue reticenze e, forse, anche suo malgrado, uno dei
maggiori e più ascoltati “maestri”. Oltre che “maestro” del suo tempo,
Wittgenstein è stato anche testimone e interprete, nello stesso tempo,
della stessa “crisi della civiltà” di quegli anni, che in Germania aveva
avuto, allora, non pochi teorici, primi fra tutti Spengler e Kraus, dei quali
lo stesso Wittgenstein era stato un attento lettore, subendone anche il
fascino e riprendendone nei suoi scritti alcune delle tonalità affettive più
significative8. Filosofo della crisi, Wittgenstein considerò suo compito
l’indicare una via d’uscita alla crisi della civiltà, mettendo ordine nel
mondo del linguaggio e, di conseguenza, nel mondo della vita della
mente, di cui il linguaggio è un riflesso. L’esperienza del mondo passa
attraverso il mondo degli oggetti, filtrati dal mondo del linguaggio.
L’assunzione del mondo è linguistica, perché dietro e accanto agli oggetti
del mondo c’è il linguaggio.
Nel tempo della finis Austriae il declino della civiltà occidentale era
assai più generale e coinvolgeva tutto il mondo dell’uomo, i suoi
presupposti, i suoi valori e le sue attese. L’uomo stesso era come rimasto
schiacciato sotto il peso di un “crollo della civiltà”, divenuto
insopportabile, dagli esiti imprevedibili, che si annunciava, ormai, come
imminente e, ancor di più, devastante. La sensazione, avvertita e rivissuta
L. Wittgenstein, Pensieri diversi, cit., p. 136.
Wittgenstein non si sentiva un vero maestro nel senso in cui intendeva questo
termine. Il maestro, secondo il suo punto di vista, è colui che riesce a portare gli allievi
ad un’altezza per loro innaturale, curandone lo sviluppo fino a consentire loro di poter
camminare con le proprie gambe. Per il conseguimento di questo compito, Wittgenstein
si sentiva inadeguato. Egli si sentiva un po’ come Mahler, del quale affermava che le
esecuzioni didattiche «erano splendide, quando dirigeva lui; ma l’orchestra sembrava
subito precipitare quando non era lui stesso a dirigerla» (Id., Pensieri diversi, cit., pp. 7677).
7
8
Comprensione linguistica e comprensione musicale
da Wittgenstein, era quella di trovarsi ad operare nel mezzo di un
“castello di carte” o di un “dedalo di strade”, una specie di “cantiere”
aperto, dove tutto era da ripensare e da ricostruire daccapo, tanto
profonde erano le rovine e le devastazioni, cui dover far fronte
nell’immediato futuro. Seguendo taluni degli orientamenti del
movimento analitico, fatti propri dal filosofo, bisognava lasciare «parlare
solo la natura»9 e privilegiare il solo linguaggio come via di accesso alla
soluzione dei problemi, perché i problemi erano soprattutto di carattere
linguistico. Dietro tutti gli usi delle singole parole, che compongono un
enunciato, c’è, - sostiene Wittgenstein -, una “grammatica”, la descrizione
delle regole che danno vita ad un insieme degli usi linguistici accettati
convenzionalmente, e creano, nello stesso tempo, un campo di significati
condivisi. È qui, a livello dell’esistenza di regole comuni e del loro
riconoscimento, che si stabilisce il punto di contatto tra produzione
linguistica e produzione musicale, in un rapporto quasi simmetrico.
La curiosità intellettuale, - come fosse una forma naturale di
irrequietezza, che, fin da giovane, Wittgenstein si portava con sé -, e
l’acutezza del suo sguardo portavano il filosofo a rompere gli
“incantesimi” di un “intelletto stregato” da falsi problemi, filosofici
prima ancora che linguistici, che si annidano, spesso inconsapevolmente,
nelle pieghe più profonde della psiche dell’uomo, fino a condizionarne i
vissuti e la loro stessa espressione e rappresentazione, sul piano
individuale, come su quello sociale. Il ricorso alla metafora della mosca
dentro una bottiglia permette al filosofo di rappresentare la condizione di
un insetto, che, nonostante tutti i suoi tentativi, non riesce a fuoriuscire
dal collo della bottiglia, nella quale si è venuto a trovare. Nell’esempio
riportato dal filosofo, la metafora sta ad indicare assai bene la
condizione dell’uomo del Novecento, che, trovatosi in uno stato di
incapacità a comprendere gli usi linguistici delle singole parole usate, non
sa come uscire fuori dai tanti problemi e dalle circostanze, che lo
limitano e lo rendono prigioniero. Solo la rottura della bottiglia potrà
liberare la mosca, - sottintende il filosofo -, come solo la dissoluzione dei
problemi potrà liberare l’uomo dai falsi problemi, con i quali convive.
L’analisi linguistica, sotto questo aspetto, è il farmaco necessario, forse
l’unico, per guarire le malattie del pensiero, perché rimette le cose “al
loro posto”.
Riportare alla luce questi problemi, osservarli e descriverli fino a
quando svaniscano come problemi, è quanto il filosofo si ripromette di
fare nella sua “ricerca di verità”. Un lavoro questo molto difficile da
9
Ivi, p. 16.
190
Logos
portare avanti, dagli esiti ancora più incerti, perché «Gli aspetti più
importanti delle cose, - come osserva Wittgenstein -, sono nascosti, non
nel senso che sono sotto o fuori, ma che sono nella loro semplicità e
quotidianità; a sua volta semplicità e quotidianità nascondono tali aspetti:
l’evidente e il più visto non ci colpiscono ed è qui che la filosofia deve
intervenire gettando luce, guardando nuovamente, guardando attraverso
il velo che l’immagine ha posto»10. C’è, in fondo, una opacità che si
frappone tra l’intelletto e le cose e che, per questo, il filosofo deve
superare.
Rompere gli “incantesimi” dell’intelletto è, perciò, il compito, che
Wittgenstein assegna alla ricerca filosofica, alla cui realizzazione lo stesso
filosofo non si è mai sottratto, fino ad identificarsi totalmente con il suo
stesso compito, soprattutto negli ultimi anni della sua vita. Questa sua
lezione non è passata, perciò, invano sulla cultura filosofica del
Novecento, considerata la vasta e profonda incidenza esercitata da
Wittgenstein sul pensiero del suo tempo, un’incidenza che non ha eguali
tra i maggiori filosofi suoi contemporanei. Da questo punto di vista,
prendendo atto dei risultati conseguiti nel campo più generale della
cultura filosofica, riconducibili a parte della sua eredità, non c’è dubbio
che il filosofo sia riuscito a realizzare pienamente il suo compito,
favorendo in particolar modo la “svolta linguistica”, che ha caratterizzato
la filosofia del Novecento.
Contro le derive di una “malattia del pensiero”, pervasiva e assai
diffusa, che confina l’uomo entro un orizzonte di senso assai angusto e
limitato, sempre alle prese con problemi di difficile soluzione come
risultato dei “crampi mentali”, dei quali era affetto l’uomo del suo tempo,
il filosofo cercava una risposta risolutiva nel ritrovamento di una “parola
liberatrice”, quella parola «che ci consente infine di concepire ciò che
fino ad ora ha gravato, inafferrabile, sulla nostra coscienza»11, liberandola
dalle”sedimentazioni” del passato e dalle “false illusioni”, create
artificiosamente da una filosofia ora non più proponibile. Rendere
possibile il raggiungimento, - come il filosofo affermava di volersi
adoperare -, della «pace nei pensieri» (Friede in den Gewdanken), era il
compito assegnato alla filosofia da Wittgenstein, un obiettivo possibile da
raggiungere solo dopo una sorta di purificazione, cui doveva essere
sottoposta la filosofia stessa, attraverso l’analisi linguistica12. E la musica,
quella “vera”, non era forse essa stessa un’altra delle vie per raggiungere
10 Id., Ricerche filosofiche, trad. it. a cura di M. Trinchero, Torino, Einaudi, 1996, §.
129, p. 70
11 Id., Filosofia, trad. it. di M. Andronico, Roma, Donzelli Editore, 1996, p. 13.
12 Id., Pensieri diversi, cit., p. 86.
Comprensione linguistica e comprensione musicale
la “pace nei pensieri”, se non l’unica via, dopo che le altre erano venute
meno ?
Wittgenstein era consapevole, d’altra parte, che «La malattia di
un’epoca si guarisce cambiando il modo di vita degli uomini; la malattia
dei problemi filosofici si potrebbe guarire solo cambiando il modo di
pensare e di vivere, non con una medicina trovata da un singolo»13. È in
quest’ottica, per certi versi così rivoluzionaria, che si colloca e si può
comprendere la lezione più profonda di Wittgenstein, come lo sforzo di
rispondere ad una domanda di senso, che lo sviluppo della cultura del
Novecento rendeva ormai ineludibile e che la filosofia del tempo, così
come si era andata sviluppando, non era più in grado di dare. Era,
soprattutto, una nuova “forma di vita”, non tanto una filosofia, la
richiesta che il filosofo poneva come inizio di un diverso modo di essere
dell’uomo e del mondo.
Tracce delle sue concezioni sono disseminate un po’ dappertutto
nella più vasta cultura del Novecento, tanto da poter circoscrivere con
esse i confini di una cultura filosofica, una cultura i cui esiti si prestano
ad essere considerati diversamente, se collocati in termini temporali tra
un prima e un dopo Wittgenstein. Dopo Wittgenstein, infatti, la filosofia
non poteva non essere così diversa; era cambiato il suo oggetto, era
cambiato il suo metodo, erano cambiati i suoi presupposti e, anche, le
stesse aspettative degli individui. Le interpretazioni date al suo pensiero
sono, per questo, innumerevoli e, spesso, diametralmente opposte, in
relazione, soprattutto, ai diversi punti di vista e alle attese degli
interpreti14.
La filosofia, l’etica, la religione, l’estetica, la musica, l’antropologia, la
psicologia, la stessa teologia hanno trovato in Wittgenstein un pensatore
attento che ha portato “oltre” i pensieri tradizionali propri di questi
ambiti del sapere, liberandoli dal già dato e dal presupposto, chiedendo e
interrogando. Spesso le sue riflessioni sono solo brevi accenni, piccoli
squarci di luce che si aprono all’improvviso e aprono agli individui
mondi di comprensione insoliti, dopo che gli stessi individui hanno
sperimentato la sensazione di aver assistito al crollo di castelli di sabbia,
13 Id., Osservazioni sopra i fondamenti della matematica, trad. it. di M. Trinchero, Torino,
Einaudi, 1971, p. 132.
14 Dare ragione della bibliografia su Wittgenstein è impresa molto ardua, quasi
disperata, considerata la sua vastità. Ai fini di una prima ricostruzione bibliografica si
veda il mio: La fede come passione. Wittgenstein e la religione, Cinesello Balsamo, S. Paolo,
1997. Si vedano anche i miei saggi: Wittgenstein. Voce per il Dizionario interdisciplinare di
Scienza e Fede, vol. II, Roma, Città Nuova – Urbaniana University Press, 2002, pp. 21512163; Wittgenstein: A Religious Thinker?, in «Metalogicon. Rivista internazionale di logica
pura e applicata, di linguistica e di filosofia», 14, 2 (2001), pp. 167-180.
192
Logos
nei quali l’uomo, per pigrizia o per paura, si era rinchiuso, illudendosi di
salvarsi così dalle intemperie del tempo. Sono squarci che danno a
pensare, perché con essi gli individui possono riscrivere la loro vita e
disegnare un mondo “altro”, nel quale sia possibile coltivare ancora la
speranza di dare significati più adeguati al mondo degli oggetti e di
comprenderne la logica e le dinamiche.
«Cercate l’uso» era l’invito, quasi ossessivo, che Wittgenstein, sul
finire della sua vita, rivolgeva ai suoi amici più intimi, quasi ad
esorcizzare la paura della fine e a voler indicare le linee di una filosofia,
che rinuncia alle grandi questioni del passato, perché irrisolvibili, per
concentrare la sua attenzione sul linguaggio e sulla sua articolazione nella
frase, come ciò che appartiene immediatamente alla piena disponibilità
dell’uomo. Il ricorso alla musica, tanto presente nella vita e nell’opera del
filosofo, poteva rappresentare lo sforzo di mettere insieme esperienze
diverse, al fine di una maggiore comprensione della questione più “dura”
della filosofia. Nella ricerca del filosofo, la musica cessava di essere un
fatto privato del filosofo e veniva assunta a pieno titolo nel discorso
filosofico, fino a diventare parte integrante di uno stesso discorso.
Wittgenstein aveva intravisto quei fili sottili che legano insieme musica e
linguaggio e fanno degli esseri umani delle «creature musicali non meno
che linguistiche»15.
2. Wittgenstein tra filosofia e musica
Ludwig Wittgenstein è noto, soprattutto, per essere stato uno dei
maggiori filosofi del linguaggio in epoca contemporanea, il filosofo che,
forse senza nemmeno averlo voluto, almeno esplicitamente, ha
contribuito più di ogni altro alla cosiddetta “svolta linguistica” della
filosofia, una trasformazione in senso linguistico della filosofia che ha
interessato tutto il pensiero filosofico del Novecento, aprendolo a nuove
suggestioni, disancorate in parte dalla stessa tradizione del pensiero
filosofico. Meno noto è, invece, come filosofo della musica, nonostante
la vastità e la profondità dei suoi interessi musicali, anche di tipo teorico,
manifestati nel corso della vita. Sono interessi, - quelli del filosofo -, non
certo da dilettante, di cui c’è ampia traccia in alcune delle sue opere
biografiche e nella sua stessa biografia, segnatamente nei Pensieri diversi, in
15 O. Sacks, Musicofilia, trad. it. di I. Blum, Milano, Adelphi, 2008, p. 15. Sacks
continua affermando che «Siamo tutti in grado […] di percepire la musica: l’altezza delle
note, il timbro, l’ampiezza degli intervalli, i contorni melodici, l’armonia e (forse nel
modo più primordiale) il ritmo».
Comprensione linguistica e comprensione musicale
Vostro fratello Ludwig. Lettere alla famiglia 1908-1951 e nei Movimenti del
pensiero. Diari 1930-1932 /1936-1937 16. Secondo Wittgenstein, «la
comprensione della musica è una manifestazione vitale dell’uomo»17 e
richiede una descrizione, facendo vedere come gli uomini si comportano
nei suoi confronti.
La trama di tutta l’opera di Wittgenstein vive sotto il segno musicale,
una specie di contrappunto, da cui mutua gli elementi più importanti, tali
da configurare lo “spazio” stesso della filosofia come “spazio musicale”.
La comprensione della sua filosofia sarebbe, perciò, monca senza il
riferimento alla sua trama, che le fornisce il canovaccio, sul quale
prendono corpo tutte le sue possibili variazioni e si costruisce il discorso
filosofico wittgensteiniano. Wittgenstein costruisce, pertanto, la sua
filosofia, facendo continui richiami alla musica e dando ad essa una
connotazione musicale. Il confronto tra filosofia e musica in
Wittgenstein pone in giusto risalto una originaria e costitutiva
“somiglianza di famiglia” tra i due saperi. La variazione nei giochi
linguistici non sarebbe stata forse nemmeno formulata, o almeno sarebbe
stata formulata in maniera molto diversa, se Wittgenstein non avesse
potuto usufruire della conoscenza dei movimenti musicali.
La musica, nella sua peculiarità e nei suoi diversi aspetti, è un tema
sempre presente nel discorso del filosofo: di musica Wittgenstein parla
con i suoi interlocutori. – familiari e amici -, e con se stesso; dalla musica
egli riprende numerosi esempi per chiarire il suo pensiero; della musica si
serve per concentrarsi meglio nel suo lavoro; all’ascolto della musica
ricorre per diletto e per riposarsi. Parlando di musica, Wittgenstein
dimostra di possedere di essa una conoscenza di tipo superiore. È una
conoscenza che si manifesta essere presente in lui a più livelli, sia come
semplice fruitore, che come esecutore, e, ancora, come concertista, come
direttore e come critico musicale. Sappiamo di certo, come confermano
persone che lo hanno conosciuto e frequentato con assiduità, che se egli
si fosse impegnato maggiormente e con più costanza in campo musicale
avrebbe potuto raggiungere anche qui, come in altri campi del sapere, dei
Di Wittgenstein si vedano al riguardo Pensieri diversi, cit. e Vostro fratello Ludwig.
Lettere alla famiglia 1908-1951, trad. it. di G. Rovagnati, Milano, Archinto, 1998;
Movimenti del pensiero. Diari 1930-1932/1936-1937, trad. it. di M. Ranchetti, Macerata,
Quodlibet, 1999. È noto come Ludwig Wittgenstein, non diversamente da altri
componenti della sua famiglia, fosse intollerante per un modo di suonare meno che
perfetto, tanto da non riuscire a prendere in mano uno strumento musicale fino a
trent’anni.
17 Id., Pensieri diversi, cit., p. 128.
16
194
Logos
livelli di particolare eccellenza, com’era nelle sue possibilità18. Forse,
però, Wittgenstein, incostante com’era, più che essere considerato
filosofo della musica, volle essere filosofo del linguaggio, anche se con
pronunciati interessi musicali, nella consapevolezza che la musica, o la
sua comprensione, potesse costituire la base stessa della filosofia del
linguaggio.
Wittgenstein poteva intervenire con una certa competenza sul
dibattito in atto sulla “nuova musica” ed era in grado, anche, di
giustificare da vero esperto le sue scelte musicali e le sue preferenze,
anche con giudizi taglienti sulla qualità della produzione musicale degli
autori, da lui frequentati, e sulla sua esecuzione. Le valutazioni del
filosofo entrano nel merito fino a riguardare aspetti distintivi dei
musicisti considerati, attribuendo loro certe caratteristiche e stabilendo
confronti tra un musicista e un altro. Tra Brahms e Mendelssohn vedeva,
per esempio, delle affinità, non tanto in singoli passi di ciascuno, quanto,
invece, nel fatto che «Brahms fa con assoluto rigore ciò che
Mendelssohn ha fatto con rigore insufficiente. Oppure: spesso Brahms è
un Mendelssohn senza errori»19. Non mancava, poi, di sottolineare «la
forza di pensiero in Brahms» o «la sconvolgente capacità in Brahms»20. Su
Anton Bruckner osservava, invece, che la sua musica «non ha più nulla
del volto lungo e magro (nordico?) di Nestroy, Grillparzer, Haydn, ecc.,
ha invece senz’altro un volto rotondo, pieno (alpino?), di un tipo ancora
più puro di quello di Schubert»21, mentre «si può dire, delle melodie di
Schubert, che sono piene di pointes, il che non si può dire delle melodie di
Mozart: Schubert è barocco. Si possono indicare certe parti di una
melodia di Schubert e dire: vedi, l’arguzia di questa melodia sta qui, qui il
pensiero si affila»22.
Come in altri ambiti del sapere, nei quali Wittgenstein si è distinto,
anche in campo musicale non era certamente un dilettante e poteva
18 Sul talento musicale di Wittgenstein scrive al riguardo von Wright: «Wittgenstein
era eccezionalmente portato per la musica, anche giudicando in base ai criteri più severi.
Sonava il clarinetto e per qualche tempo desiderò diventare direttore d’orchestra.
Fischiava con raro talento. Era una grande piacere udirlo fischiettare un intero
concerto, interrompendosi solo per richiamare l’attenzione dell’ascoltatore su qualche
particolare dell’ordito musicale» (G. H. von Wright, Ludwig Wittgenstein. Breve schizzo
biografico, in N. Malcolm, Ludwig Wittgenstein. Una biografia, trad. it. di B. Oddera, Milano,
Bompiani, 1964², p. 14). L’unica musica che Wittgenstein gradiva era la musica da
camera di Labor, celebre organista e amico di famiglia. Si veda McGuinness, Movimenti
del pensiero, cit., p. 190.
19 L. Wittgenstein, Pensieri diversi, cit., pp. 48-49.
20 Ivi, pp. 54-57.
21 Ivi, p. 50.
22 Ivi, p. 92.
Comprensione linguistica e comprensione musicale
parlare con assoluta cognizione di causa su Beethoven, Brahms,
Schönberg, Schubert, Bruckner, Mendelssohn e su tanti altri musicisti,
vecchi e nuovi, alcuni dei quali conosceva personalmente per aver alcuni
di loro frequentato con assiduità casa Wittgenstein. Ricordava a memoria
sinfonie e concerti ed era in grado, perfino, di fischiettare una intera
sinfonia, come ricorda Malcolm23. La corrispondenza con le sorelle
Hermine (o Mining), Helene e Margaret (o Gretl) e il fratello Paul rivela
un Ludwig interlocutore ascoltato su temi musicali più svariati, dalla
conoscenza della musica, all’acquisto di dischi e di partiture e alla
partecipazione a concerti. Lo sfondo di molte lettere indirizzare ai
familiari è musicale. Si parla, si discute, si scambiano impressioni e
opinioni sulla musica ascoltata. La musica diventa per Wittgenstein una
dimora originaria, come lo è, per un altro verso, il linguaggio.
Nell’analizzare i tanti musicisti, che aveva frequentato o che lui
conosceva profondamente, Wittgenstein non mancava di mettere
insieme e di confrontare tra loro Mozart e Bach, come non mancava di
parlare di Beethoven, di Mozart e di Wagner. Su Wagner ebbe a dire in
presenza di Drury che era stato il primo dei grandi compositori con un
carattere sgradevole24. Riteneva che il movimento lento del quarto
concerto di Beethoven fosse una delle più grandi opere musicali.
«Beethoven, - afferma Wittgenstein -, è totalmente realista; voglio dire, la
sua musica è proprio vera, vale a dire: vede la vita propria come essa è e
poi la eleva. È tutta religione e niente affatto poesia religiosa. Perciò può
consolare i dolori reali quando gli altri falliscono, e di fronte a loro
bisogna dirsi: ma in realtà non è così. Egli non ci culla in nessun bel
sogno ma redime il mondo in quanto lo vede, da eroe, così come esso
23 Nell’estate del 1949, Wittgenstein, ospite di N. Malcolm negli Stati Uniti,
durante un lungo viaggio in treno da New York a Ithaca parlò con lui sempre di musica
e «fischiettò per me, con una precisione e una espressione sorprendenti, alcune parti
della settima Sinfonia di Beethoven» (N. Malcolm, Ludwig Wittgenstein, cit., p. 115).
Wittgenstein, afferma Engelmann, «sapeva fischiare magnificamente. Una volta,
essendo la conversazione caduta sulla parte per viola nel terzo movimento di un
quartetto d’archi di Beethoven, egli fischiò la parte dall’inizio alla fine, con un timbro
puro e forte come quello di uno strumento. E questo gliel’ho sentito fare diverse volte»
(P. Engelmann, Lettere di Ludwig Wittgenstein, trad. it. di Isabella Roncaglia Cherubini,
Firenze, La Nuova Italia, 1970, p. 62). Wittgenstein imparò a suonare strumenti
musicali più tardi. Nel periodo di apprendistato per l’insegnamento elementare,
Wittgenstein scelse come strumento il clarinetto e il suo repertorio comprendeva
Brahms e Schumann, ma anche Schubert e Beethoven. Si veda L. Wittgenstein, Vostro
fratello Ludwig. Lettere alla famiglia 1908-1951, cit., p. 18
24 Si veda R. Rhees, Ludwig Wittgenstein: Personal Recollections, Oxford, Blackwell,
1981, p. 126.
196
Logos
è»25. Un’altra volta osservò che se «Mozart ha creduto tanto al cielo
quanto all’inferno, Beethoven invece ha creduto solo al cielo e al nulla»26.
Parlando di Mahler, Wittgenstein affermava, in modo certamente non
generoso, che «la musica di Mahler non vale niente», e si chiedeva «che
cosa avrebbe dovuto fare Mahler con il suo talento», se scrivere le sue
sinfonie e bruciarle, oppure farsi violenza, evitando di scrivere altre
sinfonie27; nello stesso tempo doveva prendere atto che per comprendere
Mahler bisognava essere buoni intenditori di musica, della sua storia e del
suo sviluppo28. Sono giudizi apparentemente paradossali, ma pertinenti,
perché pronunciati da un uomo che aveva una sua concezione della
musica, non legata a schemi comuni, e portava avanti il suo modo di
comprendere la musica.
Tra questi due aspetti biografici di Wittgenstein, - l’essere filosofo
del linguaggio e l’essere conoscitore e filosofo della musica -, c’è un’unità
profonda, più di quanto possa sembrare a prima vista. Quest’unità si
traduce in una consapevolezza ermeneutica, che ha portato il filosofo a
leggere il linguaggio, - ciò che noi diciamo -, in filigrana con la musica, ciò che noi udiamo -, sovrapponendo insieme parola e musica nel segno
del suono, aspetto comune ad entrambi, che manifesta, nello stesso
tempo, il suono della parola, la sua sonorità, e il suono della musica.
Wittgenstein va oltre questa semplice consapevolezza, perché lega
insieme la comprensione della frase del linguaggio alla comprensione
della frase musicale e stabilisce tra i due tipi di comprensione una
relazione profonda, come fosse il risultato di una forma di inveramento o
di reciproco riconoscimento29. Una stessa logica, come fosse una
corrente, passa dalla frase del linguaggio alla frase della musica e dalla
frase della musica alla frase del linguaggio, quasi a voler affermare tra
loro la presenza di una “somiglianza di famiglia”, quella stessa
“somiglianza” che Wittgenstein riscontrava analizzando “giochi
L. Wittgenstein, Movimenti del pensiero. Diari 1930-1932/1936-1937, cit., p. 41.
Si veda R. Rhees, Ludwig Wittgenstein:Personal Recollections, cit., p. 126.
27 L. Wittgenstein, Pensieri diversi, cit., p. 127 e sgg.
28 R. Rhees, Ludwig Wittgenstein: Personal Recollections, cit., p. 86.
29 Sacks si domanda se «la competenza musicale sia un potenziale umano
universale, come quella linguistica». La risposta è in parte positiva ed è molto simile alla
risposta di Wittgenstein, quando mette insieme comprensione linguistica e
comprensione musicale. Come l’apprendimento del linguaggio nel bambino non può
svilupparsi in mancanza di stimoli, così anche l’apprendimento della musica. Secondo
Sacks, però, la musica, diversamente dal linguaggio, non ha un periodo critico di
apprendimento e, soprattutto, il suo mancato apprendimento non è un “evento
catastrofico”, come nel caso dell’apprendimento del linguaggio. Si veda O. Sacks,
Musicofilia, cit. p. 120 e sgg.
25
26
Comprensione linguistica e comprensione musicale
linguistici” diversi. La comprensione della frase del linguaggio si chiarisce
avvicinandola alla comprensione della frase musicale. Wittgenstein
compie questo passaggio nella consapevolezza di aver trovato una chiave
interpretativa comune ad entrambe, all’esperienza linguistica e
all’esperienza musicale30.
Wittgenstein ha fatto del linguaggio e della sua articolazione nella
frase l’aspetto centrale della sua concezione fino a dare alla sua filosofia
una caratterizzazione linguistica assolutamente originale, i cui sviluppi
hanno interessato gran parte della filosofia del Novecento. Nel
linguaggio articolato della frase c’è tutto il mondo dell’uomo, la
rappresentazione di sé, degli stati mentali, del mondo degli oggetti.
Partire dalla frase è la pretesa di Wittgenstein, attraverso cui guardare ciò
che viene detto, come lo è anche mettere in relazione la frase linguistica
con la frase musicale. Un aspetto quest’ultimo così rilevante, anche se
non molto considerato dagli studiosi di Wittgenstein31.
Dalle biografie di Monk e di McGuiness emerge l’entusiasmo di
Wittgenstein per la musica, una vera passione. La musica rappresenta per
il filosofo una seconda esistenza, tanto è stata pregnante di musica tutta
la sua vita, a cominciare dai primi anni vissuti in famiglia. Rilevante è lo
“spazio” occupato dalla musica in casa Wittgenstein: nella casa paterna ci
sono sette pianoforti a coda e la musica, più che un passatempo, è vissuta
come una autentica vocazione. Mettendo insieme una serie di
informazioni, sparse nelle sue opere, relative alla vocazione musicale dei
componenti della famiglia di Wittgenstein, si delinea un quadro musicale
della famiglia di Wittgenstein. Tra tutti i componenti un ruolo particolare
spetta alla madre Leopoldine (Poldy). La madre di Wittgenstein era una
donna con talento musicale: aveva creato attorno a sé un circolo
musicale, frequentato da Brahms32, Mahler, Schönberg, Berg, Webern,
Richard Strauss, dal compositore e organista Josef Labor, da Bruno
Walter33. Casa Wittgenstein sulla vecchia Alleegasse, grazie a lei, era
A Cambridge Wittgenstein, oltre che occuparsi di musica, si occupa anche di
ricerche sperimentali di psicologia. Come rileva von Wright, il filosofo «nel laboratorio
di psicologia fece indagini sul ritmo della musica; aveva sperato che gli esperimenti
potessero far luce su alcuni problemi di estetica che lo interessavano» (G. H. von
Wright, Ludwig Wittgenstein. Breve schizzo biografico, in N. Malcolm, Ludwig Wittgenstein. Una
biografia, cit., p. 14).
31 Il recente volume di Aldo Gargani colma questa lacuna. Si veda A. G. Gargani,
Wittgenstein. Musica, parola, gesto, cit. Altri contributi saranno indicati di volta in volta.
32 La prima esecuzione del Quintetto per clarinetto di Brahms ebbe luogo a “Casa
Wittgenstein”. Lo stesso Brahms dava lezioni di pianoforte ai piccoli Wittgenstein.
33 Leopoldine Wittgenstein era stata allieva di Goldmark e partner di Bruno
Walter. Per lei «la musica fu forse la principale molla della vita. Rappresentò lo
30
198
Logos
diventata un centro musicale di prestigio, dove si ascoltava buona musica
(Brahms soprattutto) e si dava spazio, nello stesso, alle nuove tendenze,
rappresentate dalla musica atonale. La crisi, - il senso della fine
dell’impero -, che stava distruggendo l’Austria si rifletteva anche in “casa
Wittgenstein” nei gusti musicali dei suoi componenti, gusti diversi
rispetto a quelli degli anni precedenti. Lo stesso Brahms aveva perso il
suo fascino, cedendo il passo ai nuovi gusti musicali, veicolati anche dal
clima di decadenza di quegli anni. L’esperienza musicale, anche nelle sue
più diverse forme, è, pertanto, parte costitutiva della biografia di
Wittgenstein. Il tema della musica è una presenza costante in tutta l’opera
del filosofo. La musica appassiona Wittgenstein; la sua famiglia è al
centro dell’attività musicale di Vienna34.
Wittgenstein ritorna spesso sui suoi autori preferiti, fino a costruire
con essi una galleria di quadri, entro cui attribuire loro una collocazione
adeguata. Mendelssohn e Brahms sono in cima ai gusti del filosofo. A
Mendelssohn si sente particolarmente vicino nel carattere e nello stile di
vita, perché questi «è come uno che è allegro solo se tutto va comunque
bene, oppure è buono se tutti sono buoni attorno a lui; non è certo come
un albero che sta fermo al suo posto, qualsiasi cosa gli succeda intorno.
Anch’io sono molto simile a lui e tendo al esserlo»35. Brahms possiede,
secondo il filosofo, una «sbalorditiva capacità»36, anche se è “troppo
astratto” e non adatto per accompagnare dei film, al contrario delle
musiche di Beethoven, Schubert e dello stesso Bruckner37. Su
quest’ultimo osserva che una sua sinfonia «ha due inizi, l’inizio del primo
pensiero e quello del secondo. Questi due pensieri non si comportano
fra loro come consanguinei, ma come marito e moglie», mentre rileva
che la sua Nona Sinfonia è come una protesta contro la Nona di
Beethoven e diventa, per questo, sopportabile, cosa che non sarebbe tale
strumento primario di contatto reale con il marito e anche con i figli[…] Davanti a uno
spartito musicale, anche i suoi limiti intellettuali, veri o apparenti che fossero,
svanivano: lei che, come racconta sua figlia, seguiva a fatica un periodare complesso,
sapeva suonare a vista i pezzi musicali più elaborati» (B. McGuiness, Wittgenstein. Il
giovane Ludwig (1889-1921), trad. it. di R. Rini, Milano, Il Saggiatore, 1990, p. 34). Tra i
Wittgenstein a manifestare maggiore talento musicale fu il fratello Paul, che prima della
guerra, duettava al piano con Richard Strauss. Prokofiev e Ravel composero una
composizione per la mano sinistra, dopo che Paul aveva perso il braccio destro in
un’azione di guerra. Paul eseguì la composizione di Ravel, ma non quella di Prokofiev.
34 Si veda C. Sjögren, Die Familie, in Wittgenstein. Biographie, Philosophie, Praxis, Wien,
Wiener Secession, 1989, pp. 98-117.
35 L. Wittgenstein, Pensieri diversi, cit., p. 18.
36 Ivi, p. 55.
37 Si veda ivi, p. 56.
Comprensione linguistica e comprensione musicale
se fosse una semplice imitazione38. Parlando di Mendelssohn e della sua
musica, - una musica facile da capire -, Wittgenstein afferma di
considerarlo come il «compositore meno tragico che ci sia»39 e di sentirsi,
come si è appena visto, “molto simile” a lui e di tendere “a esserlo”40.
Non si può esimere, però, dall’affermare che «la musica di Mendelssohn,
quando è riuscita, è fatta di arabeschi musicali. Per questo ci risulta
penosa in lui ogni mancanza di rigore»41 e si chiede in forma retorica se
alla musica di Mendelssohn manchi una “melodia coraggiosa”.
Wittgenstein, parlando con l’amico Drury nel 1930, confidava che «il
concerto per violino di Mendelssohn è degno di nota perché è l’ultimo
grande concerto per violino che sia stato scritto. C’è un passaggio nel
secondo movimento che è uno dei grandi movimenti della musica. La
musica è finita con Brahms; e anche in Brahms comincio a sentire il
suono delle macchine»42. La musica, in questo contesto, rappresentava
come un ritorno a una condizione umana, dove la parola non è urlata.
Già dopo Brahms sulla musica prevale il suono della civiltà industriale,
una civiltà che ha poco a che fare con la vera musica. Non mancava di
sottolineare come «Fra Brahms e Mendelssohn esiste decisamente una
certa affinità, e non intendo quella che si manifesta in singoli passi nelle
opere di Brahms che ricordano passi di Mendelssohn; si potrebbe invece
esprimere l’affinità di cui parlo dicendo che Brahms fa con assoluto
rigore ciò che Mendelssohn ha fatto con rigore insufficiente. Oppure:
spesso Brahms è un Mendelssohn senza errori»43.
3. Wittgenstein: una vocazione musicale
Wittgenstein era consapevole del ruolo svolto dalla musica nella sua
vita, anche se non sapeva definirne e quantificarne l’entità. La
confessione resa all’amico Drury, quando egli stava lavorando alla
seconda parte delle Ricerche filosofiche, dà una traccia indicativa su quanto il
filosofo riteneva a proposito del rapporto tra filosofia e musica e sul
fatto che riconoscere il ruolo della musica nella sua vita significava poter
comprendere la sua filosofia. Se non era possibile riconoscere questo
ruolo, come era possibile comprendere la sua filosofia? Soprattutto, - si
chiedeva Wittgenstein -, in questa condizione «come posso sperare di
Si veda ivi, p. 69.
Ivi, p. 17.
40 Ivi, p. 18.
41 Ivi, p. 39.
42 R. Rhees, Ludwig Wittgenstein: Personal Recollections, cit., p. 127.
43 L. Wittgenstein, Pensieri diversi, cit., pp. 48-9.
38
39
200
Logos
essere capito?»44. La musica era qualcosa di centrale e di profondo nella
vita del filosofo.«Non potrò mai dimenticare, - ricorda Drury -, l’enfasi
con la quale citava il detto di Schopenhauer “la musica è un mondo in se
stesso”»45. Diventa, perciò, sorprendente la posizione di Tanner quando
parlando del ruolo della musica in Nietzsche e in Wittgenstein afferma
che è di poco conto quanto Wittgenstein afferma della musica46.
Nel definire la musica del passato contrapponendola alla musica più
recente, Wittgenstein fornisce una specie di giustificazione, non sempre
chiara, dei suoi gusti musicali e del perché egli manifesti a più riprese
forme di disapprovazione verso la musica “moderna”. Egli non trova
una soluzione definitiva, se ritorna sempre sull’argomento, quasi per
rincorrere una soluzione soddisfacente più adeguata. Forse, egli stesso è
consapevole di non poter arrivare a tanto, limitandosi per questo a
introdurre delle valutazioni di tipo etico-culturale. Le composizioni dei
contemporanei, per essere qualcosa di “buono”, dovrebbero scagliarsi
contro ogni dettato morale elaborato in questo presente, perché, in caso
contrario, è soltanto del “lerciume”. Secondo Wittgenstein, il buon
compositore moderno deve essere, quindi, essenzialmente antimoderno,
anch’egli in lotta contro un linguaggio, quello fatto di formule morali
assurde e false. L’assurdità della musica moderna deve rimanere tale nella
sua assurdità, ma può diventare positiva solo se nel sentire
contemporaneo appare insignificante e non se si maschera di una
“assurdità attraente”.
Come appare dai suoi scritti, il punto di vista di Wittgenstein sulla
musica a lui contemporanea è sempre stato molto ristretto in senso
negativo e, in parte, anche ingeneroso. Uno dei suoi bersagli preferiti fu
Mahler. Si può affermare, però, che «nonostante Wittgenstein amasse
poco la musica post-brahmsiana l’affinità di atteggiamento spirituale con
i musicisti della Nuova Musica è profondo»47.Wittgenstein, in realtà, si
poneva nei riguardi della musica dei suoi contemporanei con lo stesso
atteggiamento di insofferenza con il quale reagiva al proprio tempo, ed
anche alla propria persona. Wittgenstein non si riconosce nella nuova
musica, poiché ha un ideale di musica confortante, lontano (brahmsiano)
e vicino (bruckneriano), che rappresenta il desiderio di un volto, cioè il
«È impossibile, - confessa Wittgenstein a Drury -, dire qualche parola su quanto
la musica ha significato nella mia vita. Come posso allora sperare di essere capito?», ivi,
p. 94.
45 K. T. Fann (ed.), Ludwig Wittgenstein: The Man and His Philosophy, New York, DellPublishing Co., 1967, p. 67-68.
46 M. Tanner, Schopenhauer, London, Phoenix, 1988, p. 43.
47 L. V. Distaso, Estetica e differenza in Wittgenstein, Roma, Carocci, 1999, p. 151.
44
Comprensione linguistica e comprensione musicale
desiderio di una armonia tra azioni e pensieri, inseguita per una vita e mai
completamente raggiunta, un ideale che trovava nella musica del passato,
ma non del presente. «Mi scrivi, - dice alla sorella -, che voi ora siete
abituati a musica con forti contrasti. Io credo che a me risulterebbe
insopportabile. Credo che nutrirei la massima diffidenza nei confronti di
una simile concezione. Ma forse anche no; e forse non capisco neppure
l’epoca più recente»48.
L’attenzione di Wittgenstein verso la musica non è stata mai
episodica, né è stata marginale rispetto alla costruzione e agli sviluppi
della sua filosofia, soprattutto non è stata divergente rispetto alle sue
concezioni filosofiche più generali. Wittgenstein non era solo un grande
conoscitore di musica e un buon esecutore di interi concerti e sinfonie,
che conosceva a memoria e che spesso fischiettava, quasi per
accompagnare i suoi pensieri a suon di musica. Nel pensatore è sempre
presente il tema musicale nelle sue accezioni più diverse, dai riferimenti ai
musicisti più noti del suo tempo, operanti in Austria, verso i quali
manifestava le sue predilezioni o le sue critiche più severe, ad una
discussione su partiture e su esecuzioni, ad una lettura precisa della sua
“musica” preferita. Prima di essere un filosofo della musica, Wittgenstein
è stato un esperto di musica. Le sue riflessioni, anche se non hanno nulla
di sistematico e non preludono ad una determinata teoria musicale, sono
ugualmente importanti, perché congiungono insieme mondi, - linguaggio
e musica -, apparentemente diversi e dischiudono nuovi orizzonti di
comprensione.
Sotto quest’aspetto, sarebbe possibile, perciò, costruire, a partire
dalle sue riflessioni, un’estetica musicale più “larga” per dare ragione di
altri aspetti teoretici che confluiscono in essa. Ma più che a costruire
un’estetica musicale, il ricorso di Wittgenstein alla musica serve, in
definitiva, per affermare che la comprensione di una proposizione è un
processo analogo alla comprensione del tema di una frase musicale. La
musica, allora, non sarebbe più un sapere che dà al filosofo materiali ed
esempi per chiarire il suo pensiero, ma è la trama sonora di un discorso, quello musicale -, attraverso cui accedere alla comprensione più
profonda della frase. La comprensione della lingua avrebbe a che fare
con la comprensione della musica. «Comprendere una proposizione è
come comprendere una poesia o un tema musicale. È una comprensione
estetica, che guarda attraverso, getta lo sguardo su ciò che è, getta luce e
chiarisce ciò che è sotto i nostri occhi»49. Come questo sia possibile e in
L. Wittgenstein, Vostro fratello Ludwig. Lettere alla famiglia 1908-1951, cit., p. 232.
Id., Ricerche filosofiche, trad. it. a cura di M. Trinchero, Torino, Einaudi, 1996, §.
531, p. 189.
48
49
202
Logos
che modo lo si manifesta è la questione che qui bisognerà affrontare,
analizzando i testi più significativi del filosofo austriaco.
La musica, come sequenza di suoni organizzati attorno ad un tema,
ha avuto un ruolo assai importante, molto di più di quanto si possa
pensare, nella determinazione della stessa filosofia di Wittgenstein. La
musica fornisce al filosofo degli esempi, che gli permettono di chiarire
meglio le sue posizioni filosofiche; nello stesso tempo la musica è
avvicinata alla filosofia, avendo entrambe, secondo il filosofo, la stessa
logica. Mettere insieme filosofia e musica significa per Wittgenstein
aprire reciprocamente l’una all’altra nella consapevolezza di trovare una
unità più profonda, che attraversa e caratterizza entrambe.
La questione della musica e del suo ruolo nella filosofia di
Wittgenstein può essere affrontata secondo due diversi approcci. Da una
parte, mettendo in risalto la vocazione musicale di “casa Wittgenstein”50,
si sottolinea l’importanza della musica nella vita della famiglia di
Wittgenstein, e, in particolare di Ludwig; dall’altra, approfondendo il
senso dell’affermazione del filosofo austriaco secondo cui la
comprensione del linguaggio ha a che fare con la comprensione della
musica, si dà alla filosofia wittgensteiniana un’interpretazione più ampia,
collegata a un diverso sapere. I due approcci, in realtà, non sono tanto
contrapposti, perché nel filosofo convergono nel riconoscere una sicura
“vocazione” musicale, che si estende e si realizza in tutta la sua portata
nella riflessione sul linguaggio. Forse, Wittgenstein ha potuto partecipare
da protagonista alla “svolta linguistica” avvenuta nella filosofia del
Novecento, perché è riuscito a riversare in essa la sua vocazione musicale
in una forma di “contaminazione”. La musica si salda insieme al
linguaggio come due voci che provengono da un solo soggetto, un
soggetto, - come quello umano -, che nel parlare e nell’ascoltare produce
dei suoni e vive per ciò stesso in un contesto sonoro e, perciò,
“musicale” per eccellenza. La produzione delle parole è legata alla
sonorità delle corde vocali, che vibrano con il passare dell’aria. La
musica, in questo caso, è tutt’uno con la produzione linguistica, perché,
di fatto, è all’origine della produzione linguistica.
“Casa Wittgenstein” «era una casa musicale. Oltre alle visite di Brahms, essa
conobbe le esibizioni del giovane Casals, del quartetto Rosé e di Josef Labor. Una
posizione privilegiata vi ebbero la violinista preferita di Brahms, Marie Soldat-Roeger, e
la pianista Marie Baumayer […]. Ma organo e pianoforti erano soprattutto per la
famiglia. Il violino Karl lo portava con sé dovunque; quando era in vacanza con la
moglie eseguiva delle sonate, quando era lontano da casa per affari, delle suite senza
accompagnamento» (B. McGuiness, Wittgenstein. Il giovane Ludwig (1889-1921), cit., pp.
33-34).
50
Comprensione linguistica e comprensione musicale
Nei Quaderni 1914-1916 Wittgenstein definisce le tautologie dei “temi
musicali” (musikalische Themen)51. Più tardi nel Libro Marrone il filosofo
amplia la sua prospettiva a questo riguardo affermando che la
comprensione di un enunciato presenta una profonda affinità con la
comprensione di un tema musicale. L’enunciato esaurisce il suo
significato entro lo spazio dell’enunciato stesso, perché non ha alcun
significato all’esterno di se stesso. L’accostamento potrebbe sembrare
irrituale, considerando la difficoltà di collocare sullo stesso piano due
cose, - l’enunciato di una frase e un tema musicale -, tanto eterogenee tra
loro. E, invece, afferma Wittgenstein, «Ciò che noi chiamiamo
“comprendere un enunciato” è, in molti casi, molto più simile al
comprendere un tema musicale di quanto penseremmo. Ma non voglio
dire che il comprendere un tema musicale corrisponda all’immagine che
noi tendiamo a farci della comprensione d’un enunciato; ciò che voglio
dire è, piuttosto, che quest’immagine della comprensione di un enunciato
è errata e che il comprendere un enunciato è molto più simile di quanto
sembri a prima vista a ciò che nella realtà accade quando noi
comprendiamo una melodia. Infatti, comprendere un enunciato, noi
diciamo, indica una realtà fuori dell’enunciato. Mentre invece si potrebbe
dire: “Comprendere un enunciato significa afferrare il suo contenuto; e il
contenuto dell’enunciato è nell’enunciato”»52. Se la melodia trova il suo
significato in se stessa, così anche l’enunciato trova il suo significato in se
stesso. Come afferma Gargani, «La musicalità della proposizione consiste
nell’afferrare il contenuto della proposizione, in quanto tale contenuto è
immanente e inerente alla proposizione stessa, e non richiede alcun
ricorso a istanze esterne e comunque ulteriori»53.
La domanda sulla frase musicale, e più in generale sulla
comprensione della musica, è assai ricorrente negli scritti di Wittgenstein.
«In che cosa consiste, - egli si domanda -, il seguire una frase musicale e
nello stesso tempo comprenderla? Osservare un volto e sentire la sua
espressione? Imbeversi dell’espressione del volto?». Sarà una esperienza
interiore? E, ancora, «in che consiste seguire una frase musicale e
contemporaneamente comprenderla, oppure eseguirla e comprenderla?
Non guardare in te stesso. Chiediti, piuttosto, che cosa ti fa dire che
l’altro lo sta facendo. E che cosa ti consente di dire che lui sta vivendo
un’esperienza particolare? Non dovrei piuttosto dire di quell’altro che sta
51 L. Wittgenstein, Quaderni 1914-1916, trad. it. a cura di A. G. Conte, Torino,
Einaudi, 1974, p. 132.
52 Id., Libro Blu e Libro Marrone, trad. it. a cura di A. G. Conte, Torino, Einaudi,
1983, p. 213.
53 A. G. Gargani, Wittgenstein. Musica, parola, gesto, cit., p. 4.
204
Logos
vivendo una quantità di esperienze? Forse potrei dire: “Egli sente
intensamente il tema musicale”; ma rifletti su come questo si esprima»54.
Wittgenstein sa solo che riflettere sul tema musicale non è poi così
semplice e che la sua comprensione non è affatto immediata. Si lega
piuttosto al contesto culturale nel quale quel tema è nato ed è in
relazione alle attese di quella cultura che nasce e assume la sua forma
determinata. Partecipa, in altri termini, alla dinamica delle regole del
gioco linguistico, perché esso stesso non è altro che un gioco linguistico.
Wittgenstein si rende conto delle difficoltà in cui si è venuto a
trovare a proposito della comprensione del tema musicale e ritorna più
volte sull’argomento negli anni ’46-’48. Una “spiegazione rassicurante”
potrebbe essere affermare che «l’esperire intensamente quel tema
“consista” nelle sensazioni dei movimenti, ecc., con cui lo
accompagniamo […]. Ma hai forse un motivo qualsiasi per credere che
sia così? Voglio dire, per esempio, un ricordo di tale esperienza? Questa
teoria non è forse ancora una immagine? No, non è così: la teoria è solo
un tentativo di connettere i movimenti espressivi con una “sensazione»55.
4. L’”orecchio interno” luogo della musica
Wittgenstein dedicava, - come è noto -, una parte tanto rilevante del
suo tempo libero alla musica nella varietà delle sue forme espressive e
viveva, per questo, in un’atmosfera, che si potrebbe caratterizzare come
“musicale”. Leggeva, ascoltava e faceva musica e, soprattutto, pensava in
musica. Una partitura musicale, un concerto, una esecuzione
discografica, un direttore d’orchestra, un musicista erano argomenti che
lo appassionavano molto e ai quali si dedicava non certamente da
dilettante, ma da competente, discutendo con i suoi interlocutori, fossero
i suoi familiari, i suoi amici o i suoi allievi. Ascoltare musica e discutere di
musica erano le sue occupazioni preferite, soprattutto in alcuni momenti
particolari della sua vita. La passione, che animava il filosofo in queste
discussioni, non era minore rispetto a quando egli parlava di problemi
filosofici. Le sue riflessioni e i suoi ripensamenti su argomenti collegati
alla musica ritornano di continuo negli scritti autobiografici e nelle
lettere, nei quali sono ampiamente attestati gli interessi musicali di
Wittgenstein. Sono interessi convergenti, che si saldano insieme ad altri
interessi del filosofo, determinando un campo unitario di interessi, dove
tutto è finalizzato alla chiarificazione delle sue concezioni filosofiche più
54
55
L. Wittgenstein, Pensieri diversi, cit., p. 98.
Ivi, p. 99.
Comprensione linguistica e comprensione musicale
generali. Anche la musica, nella accezione più ampia, diventa funzionale
alla determinazione e alla comprensione della filosofia di Wittgenstein.
Si comprende da qui come la musica, da questo punto di vista, fosse
uno degli argomenti di maggiore interesse cui il filosofo faceva ricorso
nelle discussioni con i suoi allievi, al di fuori delle sue lezioni, e nelle
conversazioni sugli argomenti più svariati, che intratteneva con i suoi
amici e con i suoi familiari. Su temi a carattere musicale il dialogo con i
suoi fratelli, soprattutto con la sorella Helene, era continuo e
appassionato. Non era certamente l’unico argomento o il preferito in
assoluto, ma era senz’altro quello che gli permetteva di entrare in
contatto e di instaurare una migliore relazione comunicativa con i suoi
interlocutori, fossero i suoi familiari o i suoi amici. Soprattutto, era
l’argomento di cui spesso si serviva per chiarire meglio i temi della sua
filosofia. Il suo sforzo di mettere insieme, quasi sullo stesso piano,
comprensione linguistica e comprensione musicale era il risultato di una
sua forma mentis, su cui ritornava di frequente, perché non riusciva ad
articolare in forma completa la sua concezione ed era costretto a
ricorrere alla musica, un campo nel quale si muoveva con una certa
disinvoltura, date le sue specifiche competenze in materia. Sotto
quest’aspetto era evidente che, servendosi di esempi, tratti dall’ambito
della musica, Wittgenstein si proponeva di chiarire a se stesso e ai suoi
interlocutori la sua filosofia. La musica diventava decisiva, soprattutto
quando il filosofo si rivolgeva ad essa ponendola accanto alla filosofia,
come fosse una interlocutrice di pari grado della stessa filosofia. Filosofia
e musica non erano facilmente separabili, se presentavano tra loro delle
connessioni, anche se non immediatamente percepibili.
Comprendere la musica, come anche comprendere uno stato come
l’umorismo, era per Wittgenstein il movimento della comprensione
filosofica stessa. Ogni processo di comprensione, qualunque esso sia,
avviene entro una stessa forma di vita, una specie di forma psichica. Si
tratti della musica, dell’etica, della religione, dell’estetica, della psicologia,
o di una semplice espressione linguistica. Se manca questa forma di vita
più generale, come comprendere espressioni ricorrenti del tipo “suonare
con espressione” o “non avere ritmo? «Se ascolto una melodia, - scrive
Wittgenstein -, e la capisco, in me non accade qualcosa di particolare –
qualcosa che non accade se la sento senza capirla? E che cosa? Non
trovo risposta: oppure quello che mi viene in mente è insulso». Allo
stesso modo, «Che cosa succede, - si domanda il filosofo -, quando due
persone non hanno lo stesso senso dell’umorismo? Reagiscono tra loro
in modo sbagliato. È come se tra certe persone ci fosse l’uso di lanciarsi
la palla: uno la lancia, l’altro la rimanda. Ma ci sono alcuni che non la
206
Logos
rimandano e, invece, se la mettono in tasca»56. Il problema qui, - osserva
Wittgenstein -, non è di tipo filosofico, meno che mai dipende da
opinioni filosofiche errate o insufficienti, perché è di tipo culturale,
proprio del mondo di cui si fa parte, sapendo che la cultura non è
qualcosa che uno possa imparare, non è un filo che uno possa riprendere
a suo piacimento; come non è possibile scegliersi a piacimento i propri
antenati.
La musica è, soprattutto, linguaggio, afferma Wittgenstein, e quella
che più si avvicina ad esso è la musica di Bach, non quella di Mozart e di
Haydn57. Essa ha a che fare come movimento sonoro, almeno a quanto
riferisce lo stesso Wittgenstein parlando della sua esperienza musicale,
con il movimento che si produce battendo i denti. «Quando immagino
una musica, e lo faccio tutti i giorni e spesso, batto aritmicamente gli
incisivi – credo sempre. Me ne ero già accorto, ma di solito mi capita di
farlo del tutto inconsapevolmente. Ed è davvero come se i suoni
immaginati venissero prodotti da questo movimento. Questo modo di
ascoltare musica, nel proprio interno, credo sia molto comune. Posso
naturalmente immaginare una musica anche senza battere i denti, i suoni
però sono allora molto più fantomatici, molto più indistinti, meno
pregnanti»58. In definitiva, Wittgenstein fa esperienza musicale nell’atto
del movimento di sfregamento dei denti.
Questo sfregare di denti può essere interpretato come il sintomo
della estrema concentrazione e del dispendio “energetico” che
l’immaginare musica richiede, il prolungamento della rappresentazione
musicale sul piano sonoro. Lo sfregamento, è, forse, soprattutto, il
tentativo meccanico e ripetitivo di eludere ogni altra musica, ogni
articolazione verbale, ogni altro “rumore” di musica. La musica
immaginata da Wittgenstein nasce davvero da quello sfregamento
ripetitivo ed estraniante. Proponendo con ironia paradossale che l’origine
della vivacità dei suoni immaginati gli derivi da uno stridere di denti,
Wittgenstein rivela la profondità dell’importanza dell’orecchio interno
nella sua esperienza musicale. Perciò se per Wittgenstein si dà una “forza
del pensiero musicale”, allora deve anche esserci uno sforzo di memoria
musicale, che sia all’origine di una forma di riconoscimento.
Wittgenstein insiste nell’affermare che la musica è linguaggio e nel
rapportare il linguaggio alla musica. Quanto il filosofo riferisce, parlando
delle esecuzioni di Labor, costituisce una esemplificazione indicativa
delle concezioni wittgensteiniane al riguardo. Il modo di suonare di
Ivi, p. 151.
Si veda ivi, p. 70.
58 L. Wittgenstein, Pensieri diversi, cit., pp. 59-60.
56
57
Comprensione linguistica e comprensione musicale
Labor aveva, secondo il filosofo austriaco, una valenza particolare, tanto
da poter affermare che il suo modo di suonare era un parlare. «Che cosa,
- si chiede Wittgenstein -, in quel modo di suonare, ricordava a tal punto
il parlare? Ed è straordinario che la somiglianza del parlare non sia per
noi qualcosa di accessorio, ma d’importante, grande! La musica, o
almeno, sicuramente una certa musica, vorremmo chiamarla un
linguaggio; ma una certa altra musica senz’altro no»59. Il collegamento
linguaggio-musica è un dato di fatto e Wittgenstein ritorna più volte
sull’argomento, quasi a voler dare della musica un’idea che faccia
esplicito riferimento al linguaggio come suo fondamento. Tra linguaggio
e musica c’è una continuità e il suono costituisce il punto di maggiore
contatto tra loro, ciò che fa sì che essi si possano manifestare all’esterno,
senza che siano semplici esperienze interiori, destinate ad essere
incomunicabili.
Se musica e linguaggio sono così connessi tra loro, si comprende
perché lo sforzo di definire la musica, - la sua natura, la sua funzione
nella società -, sia una costante della ricerca di Wittgenstein. La musica
non è certamente un’arte primitiva, né un’arte povera, perché essa
esprime l’epos di una cultura e di un popolo, allo stesso modo dei grandi
poemi dell’umanità. Sotto questo aspetto, - come rileva Wittgenstein -,
Beethoven, come nessun filosofo, fatta eccezione per Goethe, esprime al
meglio “l’epos di tutta una civiltà”, proprio perché «la cultura del
progresso deve avere il suo poeta epico in anticipo»60 e, certamente,
Beethoven lo è per la sua epoca. «La musica sembra a qualcuno un’arte
primitiva, povera com’è di suoni e ritmi. Povera è però solo la sua
superficie, mentre il corpo, che consente l’interpretazione di quel
contenuto manifesto, possiede la piena infinita complessità che troviamo
indicata nell’aspetto esteriore delle altre arti, e che la musica cela. In un
certo senso è la più raffinata di tutte le arti»61. La musica è legata alla vita:
«i sentimenti accompagnano la comprensione di un pezzo di musica così
come accompagnano i processi della vita»62.
Nella musica, così come la considera Wittgenstein, il ricordo gioca
un ruolo decisivo. La comprensione della musica è legata all’esperienza di
un ricordo che affiora nella mente dell’ascoltatore, permettendo di
ricollegare il testo musicale ascoltato nel contesto dei vissuti riemersi
Ivi, pp. 116-117. Secondo McGuinness la musica da camera di Labor era l’unica
musica contemporanea che Wittgenstein apprezzava. Si veda B. McGuiness, Wittgenstein.
Il giovane Ludwig (1889-1921), cit., p. 190.
60 L. Wittgenstein, Pensieri diversi, cit., pp. 28-29.
61 Ivi, p. 28.
62 Ivi, p. 31.
59
208
Logos
dalla memoria in conseguenza dell’ascolto. È per questo che,
nell’esprimere particolari giudizi sulle composizioni e sulle esecuzioni
musicali, come nello stabilire dei confronti tra composizioni ed
esecuzioni diverse, Wittgenstein fa sempre riferimento al “suo orecchio
interno”, il luogo interno all’individuo nel quale nasce la musica e
avviene il suo riconoscimento. L’ “orecchio interno” è l’esperienza del
ricordare musica. Parlando, per esempio, del concerto in do maggiore
per tre pianoforti di Bach, il filosofo afferma di sentire nel “suo orecchio
interno” «solo l’inizio di uno dei due concerti per tre pianoforti», ma non
la tonalità63. Qui il riconoscimento del concerto nel suo insieme non
avviene, perché non passa attraverso il filtro dell’ “orecchio interno” e il
filosofo raggiunge solo una comprensione parziale.
Secondo Wittgenstein, la comprensione musicale è assicurata solo se
l’ascolto passa attraverso il “suo orecchio interno”, perché è nel
passaggio attraverso il “suo orecchio interno” che il testo musicale viene
riconosciuto. L’ “orecchio interno” funziona come un filtro. Se l’ascolto
della musica è legato ad un fatto contingente, come poteva essere
l’occasione di un concerto, o il consiglio di un amico, o l’acquisto di un
disco, l’esperienza del ricordare musica assume spesso nel filosofo il
carattere della involontarietà, della “illuminazione” improvvisa, è
qualcosa che si presenta immediatamente e si impone alla sua attenzione
come qualcosa di unico. È la stessa esperienza del “mostrare” ad entrare
qui in gioco e ad avvicinare l’ascolto musicale a ciò che non si può dire,
come il senso del limite, l’ “avventarsi contro il linguaggio”, il mistero
stesso dell’indicibile, che si “mostra”, ma non si “dice”. Nell’esperienza
della memoria musicale, attraverso cui Wittgenstein opera una specie di
“ricostruzione della musica”, si ritrova lo stesso tipo di attività filosofica
che il filosofo porta avanti nel suo lavoro filosofico, che consiste «nel
mettere insieme ricordi»64, ricostruendo il campo della significazione. La
produzione musicale, vista sotto quest’aspetto, non è forse essa stessa
l’esperienza dell’indicibile?
La musica, secondo Wittgenstein, nasce, perciò, nell’ “orecchio
interno”, che diventa, per questo, il suo vero luogo d’origine e questo è
vero sia per l’autore della musica, sia per l’ascoltatore della musica. È
nella memoria dell’ “orecchio interno”, infatti, che nascono, prendono
forma le idee musicali e avviene il loro riconoscimento nella forma di una
comprensione da parte dell’ascoltatore. Nello stesso tempo, il passaggio
del testo musicale attraverso l’orecchio interiore finiva per diventare il
criterio che permetteva al filosofo di poter distinguere lo stile dei
63
64
Id., Vostro fratello Ludwig, cit., p. 240.
Id., Ricerche filosofiche, cit., § 127, p. 70.
Comprensione linguistica e comprensione musicale
compositori o la natura delle loro composizioni con l’attribuire o meno
l’orecchio interiore al loro comporre. Da questo deriva che la memoria
musicale, allora, non è solo il segno di un’attività riproduttiva, ri-creatrice
e ricreativa, ma è propriamente una modalità creativa, generativa. La
memoria, in altri termini, compone il testo musicale65. «Io credo proprio
che Bruckner abbia composto solo con l’orecchio interno e
immaginando l’orchestra che suona, Brahms con la penna. Detto così,
naturalmente, la cosa appare più semplice di come è in realtà. Però se ne
coglie una caratteristica»66. Alla sorella Helene così scrive il filosofo: «Da
circa due mesi mi succede qualcosa di strano: non mi passa quasi più per
la testa nessuna musica a parte lo scherzo del Sogno di una notte di mezza
estate! Naturalmente è molto bello, ma di certo non è una musica che mi
tocchi molto da vicino; non corrisponde al mio stato d’animo. Ci devono
dunque essere ragioni extramusicali perché esso mi torni in mente in
continuazione. Freud direbbe forse, e forse a ragione, che con questa
musica io voglio dirmi sempre: “Sono un asino”; perché molto spesso mi
passa per la testa il pezzo in cui raglia l’asino»67.
Più di una volta negli scritti di Wittgenstein compare il concetto di
“orecchio assoluto”, qualità che demarca l’accesso a certi giochi
linguistici a partire dal possesso di una abilità, come capacità di
riconoscere l’esatta altezza di un suono oppure l’identità di un accordo in
mancanza di riferimenti esterni. Dal modo come Wittgenstein si esprime
a questo riguardo, il fratello Paul possedeva l’abilità dell’ “orecchio
assoluto”, mentre lui stesso possedeva l’abilità dell’ “orecchio interno”.
La frase è regolata da regole che ne costituiscono il senso; lo stesso
potrebbe dirsi per il tema musicale che «ha in minore un carattere
65 Pelliti scrive che «la memoria di Ludwig è padrona di ogni sfumatura
dell’espressione musicale, trattiene e ricostruisce quelle sfumature e quella forma, che
consentono di riportare il “senso” della musica attraverso la sua esecuzione. Per
Wittgenstein il significato, l’espressione musicale non deve solo guidare l’esecuzione,
ma potrebbe addirittura indirizzare l’ascolto» (M. Pelliti, La musica di Wittgenstein. Appunti
per un saggio potenziale, in http://modulazioni.splinder.com/).
66 L. Wittgenstein, Pensieri diversi, cit., p. 33. Wittgenstein ritorna sullo stesso
argomento nei Movimenti del pensiero. Diari 1930-1932/1936-1937, cit. Parlando di
composizioni composte al pianoforte, Wittgenstein afferma che alcune di loro sono
«pensate con la penna, altre composte solo con l’orecchio interno». Come tali «devono
avere un carattere del tutto dissimile, e produrre un’impressione del tutto diversa. Io
credo fermamente che Bruckner abbia composto con l’orecchio interno e immaginando
l’orchestra che suona, Brahms con la penna. Detta così, la cosa appare naturalmente
molto più semplice di come è in realtà. Però così se ne coglie una caratteristica» (Ivi, p.
43).
67 Id., Vostro fratello Ludwig, pp. 231-232.
210
Logos
diverso che in maggiore, ma è del tutto falso parlare di un carattere del
minore in generale»68.
L’espressione wittgensteiniana “suonare con espressione” traduce
ciò che Wittgenstein intendeva quando parlava di musica. Da
testimonianze di amici e di conoscenti sappiamo come il filosofo fosse in
grado di suonare “con espressione”. Egli «era in grado di comprendere la
musica nei termini in cui ci ha descritto consistere tale complessa
capacità: riuscire ad esprimersi in modo personale sulla musica e sul
contesto in cui essa si produce, offrire una visione dell’opera d’arte, reagire ad essa in modo appropriato e personale»69.
La musica, forse, avrebbe la capacità di liberare gli uomini dalle
“confusioni filosofiche, cioè grammaticali”, nelle quali essi sono come
“irretiti”. Ma «liberarli presuppone che li si strappi alla straordinaria
molteplicità di vincoli nei quali sono incappati. Si deve, per così dire,
riordinare l’intero loro linguaggio», consapevoli che «il linguaggio ha
pronte per tutti le stesse trappole: la straordinaria rete di strade sbagliate
ben tenute //praticabili//»70.
Id., Pensieri diversi, cit., p. 154.
M. Pelliti, La musica di Wittgenstein. Appunti per un saggio potenziale, cit.
70 L. Wittgenstein, Filosofia, cit., p. 55 passim.
68
69
Antonello Giugliano
Et.Quid.Amabo.Nisi.Quod.Rerum.Metaphysica.
Est?
de Chirico e Nietzsche
Autoritratto 1920:
Et.Quid.Amabo.Nisi.Quod.Rerum.Metaphysica.Est?
Autoritratto 1911:
Et.Quid.Amabo.Nisi.Quod.Aenigma.Est?
Friedrich Nietzsche 1882 (Foto di Gustav-Adolf Schultze).
Testo dell’intervento tenuto al Convegno di studio su «Nietzsche in Italia»,
Università degli Studi di Palermo, Palazzo Steri, 6-7 novembre 2008.
212
Logos
È un dato ormai definitivamente acquisito dalla ricerca specialistica
internazionale, benché forse poco noto al grande pubblico, che l’artista
greco-italiano Giorgio de Chirico fu, come è stato osservato, «un
nietzscheano fin nel più intimo. […] Egli arrivò al punto di vedere in se
stesso una reincarnazione dell’anima del filosofo – che aveva perso il filo
d’Arianna nei labirinti della follia a Torino nel preciso momento [l’anno
1888] in cui de Chirico nasceva in una piccola città della Tessaglia»1.
L’autoritratto del 1911, in cui de Chirico riprende una celebre posa
fotografica di un Nietzsche del 1882 ritratto con la mano appoggiata su
una guancia e lo sguardo affiso nell’infinito (ripetizioni entrambe a loro
volta della famosa posa malinconica di Dürer, la cui orrida melancholia
derivava dall’esperienza vissuta dell’essenza infinitaria del numero), reca
sul suo lato inferiore un cartiglio con l’epigrafe quasi illeggibile:
ET.QUID.AMABO.NISI.QUOD.AENIGMA.EST?
Questo autoritratto farà il paio con l’autoritratto del 1920 che
rappresenta il culmine e lo scioglimento dell’enigma – aenigma è la
metaphysica rerum – e perciò stesso il punto di una ulteriore ripartenza
metafisico-artistica annunciata dalla tavola della legge che il pittore tiene
ben in evidenza in primo piano e che reca la scritta:
ET.QUID.AMABO.NISI.QUOD. RERUM.METAPHYSICA.EST?
Era questo uno dei modi di celebrare esplicitamente l’importanza
che l’esperienza della intensa lettura delle opere filosofiche di Nietzsche
(dagli scritti sui filosofi presocratici e sulla Nascita della tragedia ad Umano,
troppo umano, da Aurora alla Gaia scienza, dallo Zarathustra agli scritti su
Wagner, da Al di là del bene e del male ad Ecce homo) aveva avuto per il
giovane de Chirico e per lo sviluppo del suo pensiero pittorico a partire
dal periodo trascorso a Monaco di Baviera nel 1906-1909 dopo la morte
del padre (1905) ed il conseguente trasferimento della famiglia dalla
Grecia in Italia. È vero che il giovane de Chirico legge assiduamente, tra
l’altro, anche gli scritti di Schopenhauer e di O. Weininger, ma
purtuttavia sempre di nuovo a loro volta mediati dalla lettura di
Nietzsche che costituirà per lui una costante apertura verso la
concettualizzazione ed espressione dei motivi più profondi del suo fare e
pensare pittorico: innanzitutto quello della visione dell’enigmatico
apparire delle cose, dell’uomo e del mondo nello spettro della loro
1 Cfr. P. Baldacci, The Function of Nietzsche’s Thought in de Chirico’s Art, in A. Kostka
& I. Wohlfarth (Eds.), Nietzsche and “An Architecture of Our Minds”, Los Angeles, The
Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities, 1999, pp. 91-113,
qui p. 91.
Et.Quid.Amabo.Nisi.Quod.Rerum.Metaphysica.Est? de Chirico e Nietzsche
epifanicità misteriosa2, della loro vita-silente che, sospendendo i
lineamenti delle fattezze tradizionali e quotidiane, accenna ogni volta di
nuovo all’apparire della propria essenza transeunte e transitoria:
all’enigma che rappresenta se stesso, il suo essere che è solo apparendo
appunto come enigma («aenigma» che Aristotele, nella Poetica, 1458a 2627, definisce nel modo seguente: «ainígmatós te gàr idéa áutee estí, tò légonta
hypárchonta adúnata synápsai / difatti la natura [l’eidos] dell’enigma è questa:
nel dire cose reali congiungere cose impossibili»)3.
In effetti è proprio sulla scia della sua intima conoscenza dei testi
filosofici e poetici di Nietzsche (conoscenza condivisa con suo fratello
minore Andrea, noto poi come Alberto Savinio, al quale si deve una
altrettanto originale, produttiva e creativa lettura e metabolizzazione,
specialmente in termini di nuova letteratura, della complessiva opera
filosofica nietzscheana) che il pensiero pittorico di de Chirico produrrà
attraverso interventi scritti e opere figurative una delle più originali e
feconde recezioni europee del pensiero nietzscheano: forse quella sola
che (assieme agli scritti di Alberto Savinio e di pochi altri) nel panorama
italiano (ben al di là dunque del coevo contesto dannunziano, papiniano
vociano, lacerbiano-futuristico etc.) rimarrà a lungo ancora in futuro,
proprio in quanto capace di non soffocare il pensiero di Nietzsche sotto
la lastra pseudoscientifica e conformista dell’erudizione interpretativolibresca ed esegetico-accademica (di marca, con tutti gli accorgimenti del
caso, prevalentemente cristianeggiante e/o cattolicheggiante, idealistica
e/o spiritualistica), bensì di mettere fedelmente e letteralmente in opera
quelli che sono i caposaldi di un pensiero che come pochi ha tentato di
pensare in estrema profondità epperò con suprema incantata leggerezza
l’enigma dell’autoapparire delle cose – e antiumanisticamente della storia
dell’uomo tra esse – nella terribilità del loro orrido fondamento
temporale. Come si esprimeva il giovane de Chirico, in uno dei suoi
manoscritti parigini dei primi anni ’10 del Novecento, sotto il titolo di
Méditations d’un peintre, a proposito della questione di «quel sera le but de
la peinture de l’avenir?»:
«Le même que celui de la poésie, de la musique et de la philosophie. […]
supprimer complètement l’homme comme point de repère […]. Se libérer
Cfr. W. Schmied, Die metaphysische Kunst des Giorgio de Chirico vor dem Hintergrund der
deutschen Philosophie: Schopenhauer, Nietzsche, Weininger, in AA. VV., Giorgio de Chirico der
Metaphysiker, hrsg. von W. Rubin, W. Schmied und J. Clair, München, Prestel, 1982, pp.
89-107. Altresì in W. Schmied, De Chirico und sein Schatten, München, Prestel, 1989, pp.
41-56.
3 Cfr. G. Colli, La sapienza greca, vol. I, Milano, Adelphi, 1977, pp. 356-357, 7 [A
26].
2
214
Logos
une bonne fois de […] l’anthropomorphisme. Voir tout, même l’homme, en
tant que chose. C’est la méthode nietzschéenne. Appliquée en peinture, elle
pourrait donner des résultats extraoirdinaires. C’est ce que je tâche de
produire avec mes tableaux»4.
Tutto ciò rinvia all’emblematica a agli emblemi propri della Visione
dell’Enigma
intenzionato
nel
dispositivo
metafisico-artistico
nietzscheano della diade Apollineo–Dionisiaco di cui La Visione e
l’Enigma (nel Così parlo Zarathustra) rappresenta l’estrema condensazione
che potentemente ha agito sul pensiero pittorico di de Chirico, come
risulta anche da alcune lettere del giovane de Chirico indirizzate in
tedesco da Firenze all’amico e collega pittore Fritz Gartz di Monaco di
Baviera. In una lettera del 26 gennaio 1910 si legge tra l’altro:
«der tiefste Dichter heißt Friedrich Nietzsche. […] die Tiefe so wie ich
sie verstanden habe und so wie sie Nietzsche verstanden hat steht anders als
da wo sie man bis jetzt gesucht hat. Meine Gemälde sind klein […] aber
jedes ist ein Rätsel, jedes enthält eine Poesie, eine Stimmung, eine
Versprechung […]. Ich studiere auch viel, besonders Literatur und
Philosophie und beabsichtige später Bücher zu schreiben (ich will Ihnen
jetzt etwas ins Ohr sagen: ich bin der einzige Mann der Nietzsche
verstanden hat – alle meine Werke beweisen das)»5.
E, ancora da Firenze allo stesso Gartz, ai primi di gennaio del 1911:
«aber eine neue Luft hat jetzt meine Seele überschwommen – einen
neuen Gesang hab’ich gehört – und die ganze Welt sieht jetzt für mich ganz
verändert aus – der Herbstnachmittag ist angekommen – die langen
Schatten, die klare Luft, der heitere Rimmel – in einem Wort Zarathoustra
ist gekommen […]. was für Rätsel dieses Wort enthält – Der große Sänger
ist angekommen, der von der ewigen Wiederkehr spricht, dessen Gesang
4 Cfr. G. de Chirico, Il meccanismo del pensiero. Critica, polemica, autobiografia 1911-1943,
a cura di M. Fagiolo, Torino, Einaudi, 1985, p. 31.
5 Cfr. G. Roos, Giorgio de Chirico e Alberto Savinio. Ricordi e documenti. Monaco–Milano–
Firenze 1906–1911, Bologna, Edizioni Bora, 1999, p. 424. «Il poeta più profondo si
chiama Friedrich Nietzsche. […] la profondità come la concepisco io e come l’ha
concepita Nietzsche possiede un aspetto diverso rispetto a quello in cui la si è cercata
fino ad oggi. I miei dipinti sono piccoli […] ma ciascuno costituisce un enigma,
ciascuno contiene una poesia, un’atmosfera, una promessa […]. Studio anche molto, in
particolare letteratura e filosofia e intendo in seguito scrivere dei libri (Le voglio mettere
una pulce nell’orecchio, io sono l’unica persona che ha compreso Nietzsche – tutti i
miei quadri lo dimostrano)», ivi, p. 310, p. 312.
Et.Quid.Amabo.Nisi.Quod.Rerum.Metaphysica.Est? de Chirico e Nietzsche
den Laut der Ewigkeit hat – […]. Nur mit Nietzsche kann man sagen, daß
ein wirkliches Leben angefangen hat»6.
Ed appunto sempre sotto il segno di Nietzsche e dell’enigmatica
visione del suo pensiero abissale dell’eterno ritorno sta anche «die tiefste
Musik»7 composta assieme al fratello Andrea/Alberto, la «musica più
profonda» di cui de Chirico parla nel gennaio 1910 nella già citata lettera
a Gartz, riferendosi al concerto orchestrale del fratello che si sarebbe
dovuto tenere a Firenze il 9 gennaio 1911 ma che invece si tenne poi il
23 gennaio 1911 a Monaco. Nei programmi in italiano e tedesco di
questo concerto (intitolato «Poema fantastico») troviamo una composizione
intitolata «Rivelazioni sull’”enigma dell’eterno ritorno”» / «Enthüllungen über das
“Rätsel der ewigen Wiederkehr”» / «Enthüllungen vom Rätsel der ewigen
Wiederkehr»8.
L’incontro con gli scritti di Nietzsche significa dunque per de
Chirico simultaneamente la riscoperta di quella grecità mitico-metafisica
presocratica, che pure aveva inconsapevolmente permeato la sua infanzia
e adolescenza greche tra la tessala Volos ed Atene, e la rivelazione della
metafisica artistica dell’apparenza apollineo-dionisiaca col suo culmine
cronomantico nell’enigma dell’eterno ritorno. Di ciò i suoi dipinti
vorranno essere visione, incorporazione visiva, messa-in-opera figurativa
ed immaginale. Come per es. nei quadri delle piazze italiane, Torino,
Ferrara, Firenze, dove l’architettura viene da lui usata come scheletro del
tempo, i portici, le arcate, le finestre sono come passaggi tra il tempo
fuori e il tempo dentro di noi, con le ombre come immagini non
rassicuranti, misteriose, piene di presagi e, appunto, di enigmi. Nei quadri
di de Chirico il tempo si manifesta con gli orologi (come segno del
tempo attuale), con le ombre (come segno del tempo passato) e con le
architetture, che sono senza età e come un ponte collegano, attraverso il
presente, il passato al futuro.
In quanto segue vorrei ripercorrere i punti salienti dell’esperienza
metafisica di de Chirico quale risulta da alcuni suoi scritti in cui è
racchiusa la chiave filosofica della messa in opera pittorica figurativo6 Ivi, p. 428. – Cfr. ivi, p. 318: «ma c’è un vento nuovo che mi porta via – ho
sentito un canto nuovo – e tutto il mondo ha assunto un altro aspetto per i miei occhi –
il pomeriggio d’autunno è arrivato – le ombre lunghe, l’aria limpida, il cielo sereno – per
dirlo in una parola sola: è arrivato Zarathustra […]. quale enigma contiene questa parola
– È arrivato il grande cantore, colui che parla dell’eterno ritorno, il cui canto ha il suono
dell’eternità. […] Si può dire che solo con Nietzsche è iniziata una vera vita».
7 Ivi, p. 424, e cfr. p. 315.
8 Cfr. ivi le tavole fotografiche che riproducono i suddetti programmi e materiali
de «Il concerto di Alberto de Chirico», e cfr. inoltre ivi, pp. 315-324.
216
Logos
immaginale del dispositivo metafisico nietzscheano dionisiaco-apollineo
e della sua peculiare imago/corona cronomantica infinitaria.
Così nella prima parte della sua autobiografia de Chirico osserva:
«tutti quelli che hanno letto Nietzsche, non [hanno] affatto capito in che
cosa consiste la vera novità scoperta da quel filosofo. Tale novità è una
strana e profonda poesia, infinitamente misteriosa e solitaria, che si basa
sulla Stimmung ([…] questa parola tedesca molto efficace […] si potrebbe
tradurre con la parola: atmosfera nel senso morale) si basa, dico, sulla
Stimmung del pomeriggio d’autunno, quando il cielo è chiaro e le ombre
sono più lunghe che d’estate, poiché il sole comincia ad essere più basso.
Questa sensazione straordinaria si può provare […] nelle città italiane ed in
qualche città mediterranea, come Genova o Nizza; ma la città italiana per
eccellenza ove appare questo straordinario fenomeno è Torino»9.
«A Firenze […] avevo cominciato a dipingere soggetti ove cercavo di
esprimere quel forte e misterioso sentimento che avevo scoperto nei libri
di Nietzsche: la malinconia delle belle giornate d’autunno, di pomeriggio,
nelle città italiane. Era il preludio alle piazze d’Italia dipinte un po’ più
tardi a Parigi e poi a Milano, a Firenze ed a Roma»10.
Nel 1913 al Salon d’Automne di Parigi manda un suo «autoritratto e
due piccole composizioni, una ispirata dalla Piazza Santa Croce a Firenze
e contenente quella poesia eccezionale che avevo scoperto nei libri di
Nietzsche, l’altra invece, che avevo intitolato L’enigma dell’oracolo,
conteneva un lirismo di preistoria greca»11.
Ricordando il suo viaggio del 1935 negli Usa: «Ancora meno […]
troverai a Nuova York, in autunno, quell’ineffabile malinconia, quella
strana, lontana e profonda poesia che Nietzsche ha scoperto nei
pomeriggi chiari di autunno, soprattutto quando si distendono su certe
città italiane come Torino»12. Un giudizio che, in effetti, si ritroverà quasi
capovolto in un articolo dechirichiano del 1938 sulla metafisica
dell’America.
Nel breve romanzo autobiografico Il signor Dudron (risalente agli inizi
degli anni ’40 ma la cui prima edizione italiana completa postuma è
appena del 1998), de Chirico puntualizza con nettezza la sua acuta
consapevolezza della peculiare specificità di filosofia ed arte e del loro
stretto rapporto di intimità: «Si nasce filosofi come si nasce pittori. Oggi
sfortunatamente ci sono persone che si dichiarano filosofi ma che in
9 Cfr. G. de Chirico, Memorie della mia vita (1945, 1962), Milano, Bompiani, 2002,
pp. 73-74.
10 Ivi, p. 79.
11 Ivi, p. 85.
12 Ivi, p.p. 161-162.
Et.Quid.Amabo.Nisi.Quod.Rerum.Metaphysica.Est? de Chirico e Nietzsche
fondo non sono che professori di filosofia. Il filosofo, quando è
veramente tale, è soprattutto un artista, perché la filosofia è un’arte»13.
E richiama il medium di questa identificazione, la intuizione e
rivelazione dell’enigma, in quanto metafisica delle cose:
«il fenomeno della rivelazione ha cominciato a manifestarsi nel
diciannovesimo secolo in alcune opere di pittori, di filosofi e di poeti. Il
momento in cui l’uomo ha una rivelazione lo possiamo definire come
l’attimo durante il quale egli ha potuto intravedere un mondo esistente al di
fuori delle cose conosciute dallo spirito umano. È un mondo che la logica
umana non può concepire e che non esiste per i mortali, visto che per noi
esiste effettivamente soltanto quello che noi conosciamo o tutt’al più quello
di cui possiamo concepire la possibile esistenza. Quel mondo metafisico,
inesistente per noi, ovvero quel mondo completamente al di fuori delle
conoscenze e delle concezioni umane e di cui noi, col nostro cervello, non
percepiamo nulla, è il mondo che un Nietzsche o un Hölderlin ci hanno
fatto intravedere in qualche frammento e qualche poesia. […] Si tratta di un
mondo inesplicabile che l’intelligenza può solamente sentire attraverso
l’intuizione ma che è impossibile comprendere e spiegare a mezzo della
logica. Il quadro dipinto da un pittore in seguito ad una rivelazione ci
mostra l’aspetto di un mondo che è per noi sconosciuto e strano. […] La
rivelazione [permette] di vedere un mondo metafisico, esistente al di fuori
degli uomini»14.
Ciò ci riconduce direttamente a testi parigini giovanili di de
Chirico dei primi anni ’10:
«Une révélation peut naître tout à coup, quand nous l’attendons le
moins, et peut être aussi provoquée par la vue de quelque chose comme un
édifice, une rue, un jardin, une place publique etc. Dans le premier cas elle
appartient à un genre de sensations étranges que moi, je n’ai observé que
dans un seul homme: Nietzsche. Lorsque ce dernier parle de la conception
de son Zarathustra et qu’il dit: j’ai été surpris par Zarathustra, dans ce
participe surpris se trouve toute l’énigme de la révélation qui vient
soudainement»15.
«Pour qu’une œuvre d’art soit vraiment immortelle il faut qu’elle sorte
complètement des limites de l’humain: le bon sens et la logique y front
défaut. – De cette façon elle s’approchera du rêve et aussi de la mentalità
enfantine». «Je me rappelle qu’après avoir lu l’œuvre immortelle de
Nietzsche Ainsi parlait Zarathustra je sentis dans différents passages de ce
livre une impression que j’avais déjà éprouvée, étant enfant, quand je lisais
un livre italien pour les petits, qui a pour titre Le avventure di Pinocchio.
Cfr. G. de Chirico, Il signor Dudron (1945, 1954), Firenze, Le Lettere, 1998, p. 80.
Ivi, pp. 75-76.
15 Cfr. G. de Chirico, Il meccanismo del pensiero. Critica, polemica, autobiografia 19111943, cit., p. 13.
13
14
218
Logos
Etrange ressemblance qui nous revèle la profondeur de l’œuvre: […]
l’œuvre a une étrangeté qui s’approche de l’étrangeté que peut avoir la
sensation d’un enfant, mais on sent en même temps [que] celui qui la créa le
fit sciemment»16.
E in quella metà degli anni ’10 la presenza di Nietzsche
nell’orizzonte del pensiero pittorico dechirichiano come suo possente
motivo ispiriratore è attestata qui e altrove da ulteriori molteplici
riferimenti stilistici, poetici, testuali, e innanzitutto da quella verticale
esperienza dei «cercles horribles» della «éternité» evocata in una coeva
poesia intitolata Mélancolie, cerchi eternitari il cui precipitato pittorico
saranno le incorporazioni figurali di alte ciminiere rosse, fumo solido di
un treno a vapore che fischia lungo un muro, carciofi di ferro occhiuti
(«Beauté des longues cheminées rouges. / Fumée solide. / Un train siffle. Le mur. /
Deux artichauts de fer me regardent»)17 oppure quelle altre che subito aveva
notato Guillaume Apollinaire che su «L'Intransigeant» del 9 ottobre del
1913 scriveva:
«Il signor de Chirico espone nel suo studio al 115 di Rue Notre-Damedes-Champs una trentina di tele la cui arte interiore non deve lasciarci
indifferenti. L'arte di questo giovane pittore è un'arte interiore e cerebrale
che non ha alcun rapporto con quella dei pittori che si son rivelati in questi
ultimi anni. Non viene né da Matisse né da Picasso, e non deriva dagli
impressionisti. Questa originalità è talmente nuova che merita di essere
segnalata. Le sensazioni molto acute e molto moderne del signor de Chirico
prendono in genere una forma architettonica. Sono stazioni ornate da un
orologio, torri, statue, grandi piazze deserte; all'orizzonte passano treni delle
ferrovie. Ecco alcuni titoli singolari per questi dipinti stranamente metafisici:
L'énigme de l'oracle, La tristesse du départ, L'énigme de l'héure, La solitude e Le
sifflement de la locomotive»18.
Tutte queste ultime figure costituiscono ripetizioni e incorporazioni
immaginali delle eternitarie circolarità di quell’Ora inquietante cantata in
una omonima poesia dechirichiana, presumibilmente del 1918, secondo
cui «anche l’immortalità è morta / in quest’ora senza nome sui quadranti / del
tempo umano»19.
Non disponendo purtroppo qui in questa sede di un apparato
iconografico che scorra automaticamente sullo sfondo in parallelo alla
discussione dei temi della pittura metafisica di de Chirico, riprendo da
Ivi, p. 15.
Cfr. ivi, p. 30.
18 Cfr. in http://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_metafisica
19 G. de Chirico, Il meccanismo del pensiero. Critica, polemica, autobiografia 1911-1943,
cit., p. 54.
16
17
Et.Quid.Amabo.Nisi.Quod.Rerum.Metaphysica.Est? de Chirico e Nietzsche
Apollinaire il tentativo di darne almeno una fenomenologia evocativa
nominando in ordine cronologico i titoli delle composizioni pittoriche
fondamentali limitatamente a questo periodo più intensamente
nietzscheano di de Chirico che va approssimativamente dal 1910 al 1920
ed elencando poi anche tutti quelli che sono gli oggetti principali di
quelle composizioni che al pari dei loro titoli costituiscono dei veri e
propri emblemi e eidos filosofici della metafisica artistico-pittorica
dell’apparenza apollineo-dionisiaca intenzionata da de Chirico per vedere
l’enigma dell’eterno ritorno nelle sue strabilianti
e labirintiche
incorporazioni.
1910:
L’enigma dell’oracolo, Il segreto di un pomeriggio d’ autunno
1911:
L’enigma dell’ora, Autoritratto
1912:
La nostalgia dell’infinito, La stanchezza dell’infinito, Melanconia,
Meditazione autunnale
1913:
Arianna o La statua silenziosa, Il pomeriggio di Arianna, Il viaggio
inquietante, L’incertezza del poeta, Autoritratto, Il sogno trasformato,
La torre, La grande torre, La torre rossa
1914:
Il giorno di festa, Canto d’amore, Il cattivo genio di un re, L’enigma
della fatalità, Le caserme dei marinai, Mistero e malinconia di una
strada, L’enigma di una giornata, Torino in primavera, Il filosofo e il
poeta, La conquista del filosofo, Ritratto premonitore di Guillaume
Apollinaire, Gare Montparnasse/La malinconia della partenza
1914/15: Natura morta “Torino 1888”, Il veggente/Le vaticinateur
1915:
I manichini della torre rosa/Le duo, La tristezza dell’ignoto
1916:
La malinconia della partenza
1917:
Le muse inquietanti, Interno metafisico con piccola fabbrica, Il grande
metafisico
Emblemi: stazioni ferroviarie, orologi di stazioni, locomotive a
vapore e vagoni ferroviari, muri, vele e velieri, nuvole che si rincorrono
nell’etere, stendardi e oriflamme che garriscono al vento in cima a cupole
e torri, portici, anditi e arcate, statue e statue equestri, busti in gesso,
capitelli e colonne, piazze e prospettive, lembi di mare e scorci di cielo,
architetture e ogive, manichini, ore, ombre lunghe, cavalletti, interni e
finestre, giocattoli e costruzioni colorate di legno, silhouettes, ciminiere e
opifici, fabbriche, teste, piedi, mani, carciofi di ferro, palle e cannoni,
guanti, rocchetti, frutta esotica, caschi di banane, pesci e biscotti,
autoritratti, righe, squadre e aste, [oggetti simbolici e indecifrabili di
Dioniso]: uova, sfere, cilindri, carciofi, lenti, pince-nez, assi, frecce, stelle,
rotoli, carte astronomiche e geometriche etc.
Nel celebre articolo del 1919 intitolato Noi metafisici, contro
l’eticismo e moralismo de «l’arte confusa col misticismo e considerata
220
Logos
una specie di scala, di funicolare, di trampolo per innalzarsi alla
conoscenza del sommo bene»20 de Chirico fa valere che «l’arte fu liberata
dai filosofi e dai poeti moderni. Schopenhauer e Nietzsche insegnarono il
profondo significato del non-senso della vita e come tale non-senso
potesse venir trasmutato in arte, anzi dovesse costituire l’intimo scheletro
di un’arte veramente nuova, libera e profonda. I buoni artefici nuovi sono dei
filosofi che hanno superato la filosofia. Sono tornati di qua; […] hanno
superato la contemplazione dell’infinito. Il terribile vuoto scoperto è la
stessa insensata e tranquilla bellezza della materia»21, ossia sono diventati
essi stessi produttori/proiettatori/lanciatori dell’infinito che si rivela nella
insensatezza dell’autoapparire della materia stessa: è questo il significato
artistico-postfilosofico della parola «metafisica» che non intenziona
affatto un «metà ta fusikà (“dopo le cose fisiche”), […] quelle cose che
trovansi dopo le cose fisiche [e che stanno a] costituire una specie di
vuoto nirvanico»22, bensì «è la stessa tranquillità ed insensata bellezza
della materia che mi appare “metafisica”»23.
Così de Chirico nel 1918, nell’articolo Zeusi l’esploratore, descrive il
nucleo di questa metafisica proiettivo-immaginale collocata tra visione ed
enigma:
«“Il mondo è pieno di demoni”, diceva Eraclito l’efesio, passeggiando
all’ombra dei portici, nell’ora gravida di mistero del meriggio alto, mentre
nell’abbraccio asciutto del golfo asiatico, l’acqua salsa bollicava sott’il
libeccio meridiano. Bisogna scoprire il demone in ogni cosa. Gli antichissimi
cretesi stampavano un occhio enorme [su ogni cosa, utensile, vaso, parete,
etc.]. Anche il feto d’un uomo, d’un pesce, d’un pollo, d’un serpente, allo
stadio primo, è tutt’occhio. Bisogna scoprire l’occhio in ogni cosa»24.
In un testo del 1924, su Gustave Courbet, de Chirico osserva che
«l’artista [metafisico] più d’ogni altro ha il potere di intendere il canto
segreto che sorge da certi aspetti del mondo mutante senza posa nel
volgersi dei secoli»25, sia esso quello della «Grecia preistorica»26 o quello
di «certe stagioni»27; laddove l’enigma metafisico si fenomenizza «manca
allora l’aspetto umanamente logico [e] appare invece quella forma
spettrale, ma tanto vera e viva, ineffabile e dolce nel suo sapore d’eternità,
Ivi, p. 68.
Ibid.
22 Ivi, p. 70.
23 Ibid.
24 Ivi, p. 81.
25 Ivi, p. 247.
26 Ibid.
27 Ibid.
20
21
Et.Quid.Amabo.Nisi.Quod.Rerum.Metaphysica.Est? de Chirico e Nietzsche
che […] è il segno indubbio per cui si riconosce tutto quello, sia esso
opera d’arte o fatto storico o aspetto della natura o […] costruzione
umana, […] che il destino sceglie per difendere dall’oblio ed eternare nel
ricordo»28; e in tal senso «Nietzsche [è] il filosofo-poeta, scopritore della
divina felicità autunnale: Seid mir gegrüsst, ihr plötzlichen Winde… Geister des
Nachmittags!»29, dell’«autunno mediterraneo; [della] terribile bellezza
dell’autunno scoperto da Nietzsche»30.
Vedremo in seguito come e da quale de Chirico questa concezione
della metafisica artistica dell’apparenza in quanto enigmatica eternità
terrestre, sempre sotto la viva ispirazione apollineo-dionisiaca di
Nietzsche, verrà ulteriormente precisata.
Per de Chirico il Nietzsche metafisico-poeta della meridianità
autunnale fa automaticamente tutt’uno con la sua fatale incorporazione
architettonico-immaginale in «Torino la metafisica […] (Torino è la città
pomeridiana per eccellenza); […] la capitale piemontese: la città
monarchica con le sue piazze abitate da scienziati e re, da politici e da
guerrieri, fermi in pose stanche e solenni sui loro piedistalli di pietra;
[con] tutto lo strano lirismo della sua fatale costruzione geometrica.
Torino è ancora una città italiana e, malgrado certi aspetti ingannevoli
nordici e occidentali, una città mediterranea»31 (così, per es., in Vale
Lutetia, del 1925).
E in un successivo testo ricapitolativo intitolato Quelques perspectives
sur mon art (apparso in francese a Praga [altra città magico-metafisica per
eccellenza] nell’aprile del 1935 sulla rivista «L’Europe Centrale»), de
Chirico aggiungeva:
«C’est Turin qui m’a inspiré toute la série des tableaux que j’ai peints de
1912 à 1915. A la vérité j’avouerai qu’ils doivent beaucoup également à
Frédéric Nietzsche dont j’étais alors un lecteur passionné. Son Ecce Homo,
écrit à Turin peu avant qu’il ne sombrât dans la folie, m’a beaucoup aidé à
comprendere la beauté si particulière de cette ville. La vraie saison pour
Turin, celle à travers laquelle apparaît le mieux son charme métaphysique,
c’est l’automne»32.
Ed esplicitando retrospettivamente l’arché di questa rivelazione
scriveva inoltre:
Ibid.
Ivi, p. 248.
30 Ivi, p. 252.
31 Ivi, p. 267.
32 Ivi, pp. 320-321.
28
29
222
Logos
«Mais c’est seulement dans l’art moderne que l’on rencontre le
phénomène de la révélation. Du moins Frédéric Nietzsche est le premier qui
l’ait décrit et distingué entre tous les autres aspects du génie créateur. Dans
son dernier livre, Ecce Homo, il lui consacre tout un chapitre. La révélation
est quelque chose qui se présente soudain à l’artiste, comme si on avait tiré
un rideau, ouvert une porte; qui lui apporte une grande joie, un grand
bonheur, un plaisir presque physique et le pousse au travail. Il est étonné et
content comme un enfant auquel on a donné un jouet. Cette ressemblance
entre la joie de l’artiste touché par la révélation et celle de l’enfant surpris
par un cadeau dépend […] du fait que toutes deux sont pures […]» 33.
La sottile presenza di Nietzsche risulta evidente anche in un articolo
del 1938 sulla Metafisica dell’America in cui de Chirico osserva che «a
Nuova York il soffio di metafisica più potente si sprigiona
dall’architettura […]: l’omogeneità e la monumentalità armonica, formata
da elementi disparati ed eterogenei. […] l’architettura dei grattacieli o di
quegli edifici enormi che, pur non essendo dei veri grattacieli,
impressionano per le loro eccezionali proporzioni. È soprattutto su
questo […] lato che passa il soffio enigmatico del pomeriggio d’autunno;
serenità nostalgica e nietzscheana delle costruzioni rischiarate dal sole
dell’autunno soffuse di quel chiarore di convalescenti che cielo e terra
hanno dopo il febbrone dell’estate»34. Il cuore di New York è pertanto il
luogo di «costruzioni altamente liriche e metafisiche»35, con «gli archi o il
vuoto degli intercolunnî, […] finestre aperte sull’aere sereno, […] parti di
mondo che si presentano dietro i muri alti»36, elementi architettonici
attraverso cui «l’alta metafisica di Nuova York […] appare in tutto il suo
splendore»37.
Ma è innanzitutto e sempre di nuovo Torino («ce mystère, cette
énigme sabaudienne ou cavourienne»38) la città metafisica cui il nome di
Nietzsche è per il pensiero pittorico di de Chirico indissolubilmente
legato, come viene rimarcato anche nella sua prefazione del 1939 ad un
libro di pitture di Paola Levi-Montalcini, in cui riprendendo anche
proprie reminiscenze ed immagini degli anni ’10 scrive:
«Torino è la città più profonda, la più enigmatica, la più inquietante non
solo d’Italia ma di tutto il mondo. Colui che per primo scoprì l’ermetica
Ivi, p. 318.
Ivi, pp. 351-352.
35 Ivi, p. 352.
36 Ivi, p. 353.
37 Ivi, p. 354.
38 Cfr. [A. Bardi], La vie de Giorgio de Chirico (1929), in: G. de Chirico, Scritti/1
Romanzi e Scritti critici e teorici 1911-1945, a cura di A. Cortellessa, edizione diretta da A.
Bonito Oliva, Milano, Bompiani, 2008, pp. 830-837, qui p. 833.
33
34
Et.Quid.Amabo.Nisi.Quod.Rerum.Metaphysica.Est? de Chirico e Nietzsche
bellezza di Torino fu un poeta-filosofo tedesco […]. È stato Nietzsche che
per primo indovinò l’enigma di quelle vie diritte, affiancate da case rette da
portici sott’i quali, anche con tempo di pioggia, si può passeggiare
tranquillamente […], discutendo d’arte, di filosofia e di poesia […]. La
bellezza di Torino è difficile a scorgere; talmente difficile che fuori di
Nietzsche e di me stesso non conosco nessuno che se ne sia preoccupato
finora. […] La bellezza di Torino non si svela che poco per volta, simile a
una Gorgone buona e onesta che sa quanto costa a quelli che hanno la
disgrazia di vedere la sua faccia interamente ed a un tratto. È infatti una
bellezza che in alcuni casi può essere fatale. È ciò che successe a Federico
Nietzsche. Già indebolito da una vita di emozioni violente causategli dalle
sue scoperte metafisiche e dalle sue avventure intellettuali di pensatore, non
poté resistere a lungo alla contemplazione totale della bellezza torinese ed
affondò nella demenza durante uno di quegli autunni in cui […] l’occulta
bellezza di Torino [è] al suo più alto grado di espressione» 39.
Questa occulta bellezza di Torino è legata appunto all’emblematica
del senso del suo nome: in quanto «Torino vive sotto il segno del Toro. I
primi abitanti ebbero come emblema un toro. Erano i Taurini
(Taurinorum Gens), donde Torino. […] il toro è uno [degli] animali più
enigmatici della creazione»40. La chiave di questo enigma che tiene
insieme la terribile bellezza della ben squadrata capitale sabauda, il suo
nome teriomorfo, la metafisica dell’apparenza di Nietzsche, la cima
abissale del suo sprofondamento mentale e le immagini misteriche dei
giovanili quadri dechirichiani (innanzitutto la malinconica statua di
Arianna e la sua ombra lunga) è forse indicata in un passo del romanzo
dechirichiano intitolato Ebdòmero (1929, 1942) allorché la figura
zarathustriana del protagonista nomina «quel minotauro che gli uomini
chiamano il Tempo»41: qui la bellezza meridiana (l’epifania della
metaphysica rerum) è quella del proteiforme apparire della vertigine propria
del labirinto dionisiaco e del suo mostro primordiale: l’animale-tempo
(con le sue proteiformi incorporazioni ed imago cronomantiche).
Il nome stesso di de Chirico intenziona in effetti un proprio doppio
pittorico-letterario. Infatti parallelamente alla messa-in-opera immaginale
da parte del pensiero pittorico di Giorgio de Chirico del motivo di fondo
della metafisica artistica nietzscheana dell’apparenza culminante
nell’autoritratto del 1920 con l’emblema evocante la metafisica delle cose,
il concetto di quest’ultima viene precisato ulteriormente in quanto
enigmatica eternità terrestre, e sempre sotto la viva ispirazione del
39 G. de Chirico, Il meccanismo del pensiero. Critica, polemica, autobiografia 1911-1943,
cit., pp. 361-362.
40 Ivi, p. 361.
41 Cfr. G. de Chirico, Ebdòmero (1929, 1942), a cura di J. de Sanna e P. Piccozza,
Milano, Abscondita, 2003, p. 114.
224
Logos
dispositivo manifestativo metafisico-apparenziale apollineo-dionisiaco
nietzscheano, da Andrea de Chirico, musicista (che da giovane a Parigi
nel 1914 si firmava «artisan dionysiaque» in occasione di una esecuzione
pianistica di musica minimalistico-sperimentale «disarmonica») e poi
pittore noto con lo pseudonimo di Alberto Savinio42, in una molteplice
serie di interventi critici, letterari e poetico-narrativi che a loro volta si
configurano come una enorme incorporazione e trasfigurazione (e
parodia metamorfico-minimalistica) della metafisica nietzscheana
dell’apparenza e dell’eterno ritorno dell’eguale.
Innanzitutto lo scritto del 1919 su Anadioménon. Principî di valutazione
dell’arte contemporanea, in cui, a rinforzo esplicativo del concetto di
metafisica, viene introdotto da Savinio il termine «fantasmico, per:
incipiente fenomeno di rappresentazione; genesi di ogni aspetto. E,
rispetto all’uomo: stato iniziale del momento di scoperta, allor che
l’uomo trovasi al cospetto di una realtà ignota a lui dapprima. / Il mondo
è di continuo – come Venere – anadioménon: ché di continuo, su da
qualche mar che lo gestiva in un travaglio misterioso, si suscita un
novello dio»43.
Fantasmico è sinonimo dunque di anadioménon ovvero di surgens, vale a
dire di oriens (anatolé, anadolu: oriente): tale apparenzialità è l’orizzonte
propriamente metafisico anche dell’arte pittorica. «Questa parola,
impiegata già dalla trattazione filosofica nei termini di un bilancio più che
altro sostanzialmente fisico ripresa poi dalla teologia, trovò, per primo, in
Nietzsche, una ragione spirituale libera. Con l’acquistare questo senso
nuovo e vasto in una realtà più vasta, metafisico or non accenna più a un
ipotetico dopo-naturale; significa bensì, in maniera imprecisabile –
perché non è mai chiusa, ed imprecisa dunque, è la nostra conoscenza –
tutto ciò che della realtà continua l’essere, oltre gli aspetti
grossolanamente patenti della realtà medesima»44.
Questa forma espansiva ed enigmatica (se aenigma è preso
nell’accezione aristotelica) del filosofare metafisico-artistico (che in Noi
metafisici del 1919 de Chirico aveva visto come autosuperantesi
“inesteticamente” nell’arte filosofica dei «buoni artefici nuovi [che] sono
dei filosofi che hanno superato la filosofia») Savinio la caratterizza in
Se ne vada la breve caratterizzazione in A. Breton, Antologia dello humour nero
(1966), a cura di M. Rossetti e I. Simonis, Torino, Einaudi, 1971 (1970), pp. 303-305,
con il celebre attacco «Tutta la mitologia moderna ancora in formazione ha le sue fonti
nelle due opere, quasi indiscernibili nello spirito, di Alberto Savinio e di suo fratello
Giorgio De chirico».
43 Cfr. A. Savinio, La nascita di Venere. Scritti sull’arte, a cura di G. Montesano e V.
Trione, Milano, Adelphi, 2007, p. 46.
44 Ivi, p. 48.
42
Et.Quid.Amabo.Nisi.Quod.Rerum.Metaphysica.Est? de Chirico e Nietzsche
termini di “forma spirituale” (kandiskijanamente, «epperò dichiaro, una
volta per sempre, di non ammettere la spiritualità che in quanto
congiunta direttamente alla materia, e, con questa, costituente un’unità
indivisibile»)45:
«La filosofia spiritualista, dopo la sua immensa fioritura in Grecia,
emigra in Occidente ed ivi rifiorisce. (Non si dimentichi quella filosofia –
chiamiamola napoletana – dei Vico, Campanella, Bruno…). Non giunge in
Francia. […] Ma la vediamo spandersi in Germania, fino a che tocca alla sua
fase estrema (Nietzsche) nella formula: metafisica»46.
Ciò è possibile chiamare anche la «spettralità» delle cose: «la
spettralità è l’essenza vera, spirituale e sostanziale di ogni aspetto» 47. Un
aspetto però sempre ironico, giacché, come Savinio qui subito sottolinea,
«Eraclito, in un frammento […] dice, per la Natura, ch’essa ama
nascondersi. […] Che la Natura ami celarsi a sé – per un fenomeno di
auto-pudore»48.
Questo concetto portante è ribadito da Savinio anche nei Primi saggi
di filosofia delle arti (Per quando gli italiani si saranno abituati a pensare) del
1921: «Prenderò a considerare il singolarissimo e misterioso fenomeno
delle arti nel loro lato spirituale o, per meglio dire, metafisico. […] uso
l’aggettivo metafisico per qualificare la qualità intima, ossia la sostanza lirica
delle cose. […] Le arti non si rivalgono della qualità materiale e tangibile
delle cose, sebbene di quella impalpabile, ma più intima e profonda: si
rivalgono della qualità metafisica delle cose»49. In quanto si tratta della
«rappresentazione non della realtà quale essa è naturalmente visibile, ma
di quella particolare realtà plastica che è l’aspetto ineffabile dell’eternità
terrestre»50. Questa significa appunto però, come Savinio scriverà oltre
un ventennio più tardi, «avere la nostra propria sorte nella sorte di tutte
le cose, dalle massime alle minime, e di essere noi soli come voleva essere
Nietzsche, come una volta erano gli dèi: dappertutto e in nessun
luogo»51.
E ciò perché «la poesia non viene da fuori, ma nasce dentro la cosa
stessa: dal fondo di ciascuna cosa. Questa la proprietà della poesia
“metafisica” […]. Ricordo l’insistenza di mio fratello e mia, al tempo in
Ivi, p. 56.
Ivi, pp. 54-55.
47 Ivi, p. 61.
48 Ivi, p. 62.
49 Ivi, p. 77.
50 Ivi, p. 99.
51 Cfr. A. Savinio, Dieci litografie di Fabrizio Clerici, Milano, 1942, cit. in V. Trione,
L’ellisse e il cerchio, in appendice a: A. Savinio, La nascita di Venere, cit., p. 130 e n. 2.
45
46
226
Logos
cui di conserva illustravamo e commentavamo il carattere della “nostra”
poesia metafisica, a parlare dello “spettro” delle cose, ossia della loro
sembianza interna. […] La poesia metafisica, come scoperta ed
espressione della psiche delle cose (di una statua, di un monumento, di
una piazza, di una città, di un paesaggio, di un oggetto, di un cielo) ossia
della poesia “interna” dell’universo, […] ha preannunciato, e in campi di
là dall’umano e più vasti, la rivoluzione recata di poi dalla psicanalisi […].
Ha saldato l’antica frattura tra fisico e metafisico, ha arricchito il fisico di
una “metafisica” continuità, ha mobilitato il finito per concessione di un
prolungamento infinito» (Talete e Pitagora, 1948)52.
Insomma, osservava de Chirico/Savinio, «non si tratta di negare
l’infinito, non si tratta di sottrarsi all’infinito: si tratta di considerare
l’infinito come una infinita continuazione di quello che è. Si tratta di non
frapporre una soluzione di continuità tra quello che è e l’infinito. Si tratta
di non pensare quello che chiamiamo finito, diverso da quello che
chiamiamo infinito. Si tratta di non considerare l’infinito come un’altra
cosa» (Europa, 1948)53. Giacché «noi, abbiamo l’immortalità terrestre. […]
L’arte stessa richiede la “permanenza sulla terra”. Un artista serio, degno
di questo nome, non sconfina dalla terra, non evade, non èsula, ma sulla
terra, nelle cose terrestri e a portata di mano trova mistero e lirismo,
stupore e profondità. Sconfinano dalla terra gli esteti, ossia i falsi artisti,
coloro i quali credono che l’arte è un al di là, una cosa “non da tutti i
giorni”, uno stato ineffabile, un ideale»54 (proprio come la tarda musica
wagneriana, e segnatamente quella del mistico Parsifal). In tal senso
occorre «snidare l’idealismo dai suoi nidi più riposti: questo doveva fare
Nietzsche» (Ecce homo, 1950)55.
Lungo questa potente e costante traccia nietzscheana Savinio
promuove una linea metafisico-artistica anti-idealistica netta e senza
sconti: «L’anno passato si è tenuto a Roma un congresso internazionale
di filosofia. Non sembrava un congresso di filosofia, sembrava un
concilio. Come stupirne? Oggi tutto è “concilio”. Tutto è “chiesa”. Tutto
è “reazione”. Tutto è “organizzazione e sistemazione del fittizio”.
Prevale oggi, spaventosamente, quella immoralissima, quella
pericolosissima, quella dannosissima propensione a non guardare la vita
Cfr. A. Savinio, Scritti dispersi 1943-1952, a cura di P. Italia, Milano, Adelphi,
2004, pp. 737-738.
53 Ivi, p. 711.
54 Cfr. A. Savinio, Ascolto il tuo cuore, città (1943), Milano, Adelphi, 2001(4) (1984), p.
198.
55 Id., Scritti dispersi 1943-1952, cit., p. 1432.
52
Et.Quid.Amabo.Nisi.Quod.Rerum.Metaphysica.Est? de Chirico e Nietzsche
com’è, ma come si vorrebbe che fosse» (Agli scrittori dico, 1948)56; e ciò vale
anche per «Benedetto Croce (questo Vaticano laico)»57, «quell’ambiguo
don Benedetto [che non ha] sensi né per la musica né per la pittura né
per la poesia, e né pure per l’arte del pensare» e che Savinio accusa di
«essere il gran sacerdote della scolastica odierna, e di ostacolare con la
sua opera meno grande che voluminosa la passeggiata mentale
degl’Italiani» (Città di fantasmi, 1948)58.
Anche Savinio non mancherà in più di un’occasione di ricordare il
fatale binomio metafisico di Nietzsche&Torino, epperò con un’esplicita
e cordialmente vibrante aggiunta postrisorgimentale-umbertina: «Nella
parola “cuore” pronunciata come titolo di un’opera scritta, noi non
intendiamo nient’altro che il Cuore di Edmondo de Amicis, questo libro
caldo di talento e fedelissimo al titolo che oggi fingono di disprezzare,
raro esempio di prosa narrativa in una letteratura poverissima di
narrazione, e che in talune pagine, come quella intitolata “Valor civile”
[…], sale alla metafisica della Torino scoperta e amata da Nietzsche,
“Classica ai piedi e classica agli occhi”»59. Giacché è proprio «in de
Amicis [che] si ritrova, qualche volta, l’aura del Nietzsche torinese
(leggete nel Cuore il corsivo su la premiazione di un salvatore), delle
“Piazze d’Italia” di Giorgio de Chirico, di quel poetismo detto da noi
“metafisico”, di cui cominciammo a dare i primi modelli intorno al
1909»60.
Tuttavia Savinio va ben oltre nella sua eterodossa e raffinata
recezione di Nietzsche. Il suo peculiarissimo passo in avanti consiste nel
dissolvere anche il mitema filosofico-concettuale e storiograficofilosofico del pensatore Nietzsche in quanto tale (cioè in quanto
filosofema acquisito, idea conchiusa, fissa), coll’incorporare e
metabolizzare la metafisica-artistica e cronomantica nietzscheana nel
personaggio ironico-caricaturale e “paratemporale” di Nivasio
Dolcemare («Superato il traguardo del mezzo secolo, la vita di Nivasio
Dolcemare continua più che mai a svilupparsi nel senso dell’adolescenza»61)
quale reincarnazione e riesecuzione di Nietzsche e sua «continuazione
ineffabile»62 nonché immemore avatar dello stesso Savinio.
Ivi, p. 721.
Ibid.
58 Ivi, p. 777.
59 Cfr. Id., Palchetti romani, a cura di A. Tinterri, Milano, Adelphi, 1982, p. 225.
60 Id., Scritti dispersi 1943–1952, cit., p. 904 (Si capisce in Val d’Aosta perché i quattro
non s’accordano, 1948).
61 Cfr. Id., Maupassant e “l’Altro” (1944), Milano, Adelphi, 1995(4) (1975), p. 9.
62 Ivi, p. 10.
56
57
228
Logos
Questo bizzarro gesto minimalistico–iperletterario, che è
simultaneamente una emendazione e un perfezionamento, permette a
Savinio di cancellare una volta e per tutte lo stesso Nietzsche come
cristallizazione storiografica e figura filosofico-aletheiologica scientificoaccademica dotata di senso, ma in modo da far saltare effettivamente il
pensiero metafisico-artistico di Nietzsche al di là della propria ombra
(conformemente alla sua verticale disintegrazione torinese che lo fa
essere «ogni nome della storia»63), e cioè con l’”inverarlo”/precipitarlo in
triviali e «mostruose mescolanze»64 dell’infinita apparenzialità quotidiana,
nella cui opaca ed insensata e multiversa temporalità precipita
innanzitutto ogni orizzonte significativo, eternalistico, universale,
veritativo, finalistico, assiologico, filosofico e teologico unitario.
Ciò equivale a tematizzare in termini di pura sorgimentalità ubiqua e
molteplice, di puro anadioménon appunto, il cuore stesso della massima
eraclitea physis kryptesthai philéi65. Il numinoso nascere ama nascondersi
sotto l’apparenza più triviale e mostruosa, e tale segreta ironia metafisica
della physis è conoscibile a sua volta solo sotto il con-apparire di un
analogo deformante travestimento (ossia tutto ciò che è l’altro assoluto
rispetto alla filosofia e all’antifilosofia). Perciò Savinio può scrivere che
«nella formula di là dal bene e dal male, Nietzsche ha significato la
condizione di perfetta libertà morale; nella formula di là dal bello e dal
brutto, si può significare la condizione di perfetta libertà estetica» (Fine dei
modelli, 1947)66. Cosicché grave e leggero, Nivasio Dolcemare, quale
riesecuzione eccentrico-metafisica del pensiero di Nietzsche, ha imparato
a nascere eternamente sempre di nuovo, a conoscere il tutto attraverso il
tutto, entrando in comunione «con le creature e le cose di là dall’uomo:
animali, piante, minerali; e con le particelle che compongono le creature
e le cose; fino alle cellule e agli atomi; e di là dalle cellule e dagli atomi; e
allora solamente sarà raggiunto il pieno, profondo sentimento cristiano
della vita» (Europa, 1948)67. Quel sentimento ateo (giacché «ateo è il
63 Cfr. la lettera di Nietzsche a Burckhardt del 6 gennaio 1889 da Torino, in J.
Burckhardt–F. Nietzsche, Carteggio, a cura di M. Ghelardi, Torino, Aragno, 2002, p. 46.
64 Cfr. A. Savinio, Tragedia dell’infanzia (1937), in Id., Hermaphrodito e altri romanzi, a
cura di A. Tinterri, Milano, Adelphi, 1995, p. 545.
65 Nel 1948 Savinio dedica una recensione sul «Corriere della Sera» all’omonimo e
coevo libro di Giorgio Colli, cfr. A. Savinio, Natura ama nascondersi, ora in: Id., Scritti
dispersi 1943–1952, cit., pp. 920-924.
66 Cfr. A. Savinio, Scritti dispersi 1943–1952, cit., p. 567.
67 A. Savinio, Scritti dispersi 1943–1952, cit., p. 702. – Cfr. lo stesso testo anche nella
raccolta postuma di A. Savinio, Nuova enciclopedia (1977), Milano, Adelphi, 2005(6)
(1941–1948, 1977), p. 142 (s. v.: Europa).
Et.Quid.Amabo.Nisi.Quod.Rerum.Metaphysica.Est? de Chirico e Nietzsche
Cristianesimo»68) per cui la vita, la sua autoapparizione ubiqua, molteplice
ed ironica, non ha alcun senso, non vuol dire niente: proprio un bel
niente, un insensato niente che solo appare e riappare nel vuoto di se
stesso, nascondendosi nel suo contrario e nell’opposto del suo contrario.
Di questa saggezza metafisico-politeistica eracliteo-presocratica – in cui
la «vita era guardata, pensata, esaminata in quello che è, un fisico
infinito»69 – per Savinio, non meno che per de Chirico, Nietzsche
rappresenta il culmine. «Ergo la filologia, la filosofia, la politica di
Nietzsche vanno considerate more lyrici, sciolte da qualunque idea di fine,
prese come gioco. Perché Nietzsche è lirico. È soltanto lirico. […] È
“soltanto” lirico, cioè a dire sciolto da qualunque fine pratico. Diciamo la
parola giusta: è “gratuito”. Onde il suo pensiero, la sua parola vanno
presi gratuitamente, come pure illuminazioni liriche. Mai domandarsi
davanti a un pensiero di Nietzsche: “Che significa?”»70.
Conseguentemente a questa profonda comprensione della
disintegrazione del senso provocata ed evocata da Nietzsche, nell’esergo
di Maupassant e “l’Altro”, dopo aver citato una frase di Ecce homo in cui
Nietzsche chiama Maupassant «un vero romano»71, Savinio aggiungeva
che «le epigrafi sono poste in testa agli scritti, perché ne chiariscano in
pochissime parole il contenuto: questa epigrafe di Nietzsche illumina
tanto meglio la figura di Maupassant, in quanto non si capisce che cosa
voglia dire»72. E poi annotava: «La illumina tanto meglio, in quanto non
si sa quello che Nietzsche abbia voluto dire dando del “romano” a
Maupassant – e forse non ha voluto dire niente, come spesso accade a
Nietzsche. Ma posso sperare di farmi capire […] se […] dico che si dice
di più non dicendo niente?»73. Di più non dicendo niente, ma appunto solo
mostrando la metafisica della vita-silente che appare a se stessa.
A. Savinio, Scritti dispersi 1943–1952, cit., p. 703. – Cfr. A. Savinio, Nuova
enciclopedia, cit., p. 143.
69 A. Savinio, Scritti dispersi 1943–1952, cit., p. 707. Cfr. A. Savinio, Nuova
enciclopedia, cit., p. 146.
70 Cfr. Id., Nuova enciclopedia, cit., p. 270 (s. v.: Nietzsche).
71 Id., Maupassant e “l’Altro”, cit., p. 9.
72 Ibid.
73 Ivi, p. 91.
68
Renata Viti Cavaliere
Una scelta di lettere di Carlo Antoni a Raffaello
Franchini
Offro qui al lettore una scelta di lettere di Carlo Antoni a Raffaello
Franchini, tra le cui carte ho rinvenuto una custodia, di color verde
sbiadito, contenente la preziosa raccolta1. Sul risvolto di copertina
Franchini annotava: «Sono 48 lettere di Antoni. Pubblicabili solo dopo
molto tempo: mutilarle sarebbe un grave errore». Poco più sotto
aggiungeva la seguente postilla: «+ 3 reperite in seguito. Sul non mutilarle
farei riserve. + 1 reperita il 6-2-‘66». In spirito di fedeltà, dunque, alla
palese intenzione di vedere un giorno stampate le lettere di Antoni, e
consapevole della difficoltà a pubblicare ancor oggi integralmente il
lascito epistolare, ho preservato intatte alcune lettere ora destinate
all’attenzione degli studiosi, mantenendo la massima discrezione su quei
contenuti “riservati” a cui si allude nell’appunto manoscritto.
Le lettere abbracciano un arco temporale che va dal 1948 al 19592. Si
è fatto in modo che non si perdesse - nella scelta operata - il filo “logico”
di uno scambio epistolare intenso, che purtroppo conosciamo solo
unilateralmente3, riguardante pensieri e dottrine che in quegli anni
avevano impegnato molto Antoni incidendo non poco sull’assai più
giovane Franchini che per tanti versi si considerò sempre idealmente suo
allievo. Proprio allo scopo di non interrompere il dialogo sotteso al
carteggio, non sono ovviamente state escluse, solo per il fatto di essere
state già edite, le 6 lettere di Antoni che Franchini riportò quasi per
intero all’interno del saggio in memoriam, scritto nel ‘69 nel decimo
anniversario della morte dello studioso triestino, costruendo intorno ad
esse per buona parte l’affettuoso ricordo di una magistrale lezione4.
1 Un sentito ringraziamento ai figli Laura e Vincenzo per avermi messo a
disposizione i materiali dell’Archivio Franchini.
2 Su alcune buste compare l’indirizzo vomerese di via Michetti, ma per lo più le
lettere erano indirizzate a «Il Giornale» in via Roma, e poi in via Nardones, nel cuore
dei Quartieri spagnoli a Napoli.
3 Non è stato in alcun modo possibile reperire le lettere di Franchini. Esse non
sono presenti nel Fondo Antoni conservato a Roma a Villa Mirafiori, e si deve
seriamente ritenere che siano andate perdute.
4 Il saggio dal titolo Carlo Antoni, lo storicismo e la dialettica
è nel volume R.
Franchini, Interpretazioni. Da Bruno a Jaspers, Napoli, Giannini, 1975, alle pp. 355-379.
Era già uscito, con titolo diverso, nella miscellanea di AA. VV., Umanità e Storia. Scritti
232
Logos
Dieci anni addietro infatti, nel corso del 1959, Franchini si era
trovato ad intervenire sul pensiero e l’opera di Carlo Antoni a distanza di
appena un mese: nel mese di luglio aveva recensito il volume La
restaurazione del diritto di natura, edito con Neri Pozza, in una lunga nota
sul «Mondo» dal titolo Le leggi di Antigone, e nell’agosto fu chiamato
purtroppo a scrivere nel giro di poche ore, con sincero rammarico, In
morte di Carlo Antoni. Amico della verità5, un corposo necrologio rivolto a
celebrare la maestria del grande discepolo di Croce, così fedele e al
tempo stesso molto originale. Le lettere qui pubblicate aiutano a
focalizzare, per brevi spazi di luce, quel tratto di strada relativo ai
precedenti anni cinquanta, vissuti da entrambi per lo più all’interno della
tradizione crociana, dalla quale sentirono di non dover prescindere, a
partire dagli ultimi anni di vita del filosofo sino alla prematura scomparsa
di Antoni.
Sorprende per certi aspetti l’incipit della lettera del 6 novembre 1948:
«È da tempo che seguo con vivo interesse la Sua attività di studioso….»,
se si considera la giovane età di Franchini, allora ventottenne. Pur
tuttavia egli poteva già vantare una significativa produzione scientifica,
tra articoli di giornale e saggi, non più soltanto di esordio, se è vero che i
primi scritti risalgono al 1944. Franchini aveva infatti pubblicato una
serie di brevi articoli su quotidiani napoletani come «Il Corriere» e «La
Voce», e saggi su riviste di pregio come «Ethos» diretta da Gabriele Pepe
e «Lo Spettatore italiano» curato da Elena Croce e Raimondo Craveri6.
Non credo si sbagli ad indicare nella recensione al volume di Antoni
Considerazioni su Hegel e Marx del ’46 (pubblicata in quell’anno su «Ethos»)
l’atto d’inizio di un dialogo filosofico che andrà via via intensificandosi.
Si può presumere infatti che Carlo Antoni, nella prima lettera della
raccolta da me rinvenuta, esprimesse un giudizio assai positivo sul lavoro
del giovane studioso avendo anche chiaro il ricordo di quell’articolo di
due anni addietro, nel quale si tracciava di lui un bel profilo con
riferimento ai precedenti volumi Dallo storicismo alla sociologia (del 1940) e
in onore di A. Attisani, Napoli, Giannini, 1971, vol. I, pp. 507-527. A quarant’anni dalla
stesura, il testo di Franchini su Antoni appartiene ad un legato non agevolmente
reperibile, per cui le lettere in esso contenute risultano per i lettori d’oggi “come se”
inedite.
5 Franchini racconta nelle sue note autobiografiche di aver redatto in breve tempo,
rinunciando ad andare ai funerali, l’ampio articolo commemorativo per «Il Mondo».
Cfr. R. Franchini, Autobiografia minima, Roma, Bulzoni, 1973.
6 Sulla prima produzione di Franchini si veda il volumetto di G.M. Pagano,
Storicismo e azione. Gli scritti giovanili di Raffaello Franchini (1940-1955), Roma, Cadmo,
1983. Il periodo dal ’40 al ’43 fu di formazione e di studio tra le difficoltà della guerra,
privo però di documentazione a stampa.
Una scelta di lettere di Carlo Antoni a Raffaello Franchini
La lotta contro la ragione (del 1942). In realtà Franchini da allora in poi, e in
più d’una occasione, ebbe sempre gran cura di rievocare i pensieri di
Antoni sia in segno di consenso sia comunque per un doveroso
riconoscimento dei suoi meriti d’interprete. Valga ad esempio la
recensione allo Hegel di De Ruggiero (in «Lo Spettatore Italiano», 19487)
dove compare un significativo riferimento alla lettura che Antoni aveva
dato del carattere intellettualistico e astrattivo della hegeliana dialettica
nella prima triade della Scienza della logica. In quella occasione, peraltro,
Franchini non si limitò ad illustrare i termini di una questione dai risvolti
complessi, ma suggeriva d’intendere il rapporto dell’essere col nulla, reali
solo nel divenire, come la prova evidente dell’uscita dalla immobilità
tautologica della vecchia identità senza vita. In altre parole egli non
mostrò di approvare del tutto l’idea di un “tradimento” della dialettica
operato da Hegel nei confronti della sua creatura più preziosa, perché
l’essere e il nulla in quanto opposti, o contrari, animano il movimento
della realtà lungi dal fissarlo per dir così in uno schema triadico posticcio.
Non per caso, nell’esaminare i saggi raccolti da Antoni nel ’46, Franchini
mirò subito al problema-Hegel che per il filosofo triestino rappresentò a
lungo un cruccio insuperabile, anche negli anni a venire. Tra critiche
all’illuminismo e all’irrazionalismo romantico si può dire che Hegel abbia
redatto la magna charta della speculazione moderna che è la dialettica,
quasi un segreto di difficile decriptazione. Mentre, però, Antoni si
arrovellava sul “rompicapo” che è l’essere da cui sprizza la scintilla del
divenire vitale, cogliendo in Hegel il restauratore della metafisica
tradizionale, Franchini mostrava maggiore apertura alla nuova logica che
di fatto assorbe la metafisica in una logica non più matematizzante.
Molto acuta gli era pertanto sembrata la critica di Antoni al «ritmo
dialettico hegeliano come risultante da una sorta di contaminazione tra
sillogistica e dialettica degli opposti»8, perché in tal caso cominciava ad
emergere il problema di una preferenza del filosofo di Stoccarda rivolta
in ogni modo al sillogismo piuttosto che al giudizio.
Il tema della dialettica si trova al centro dello scambio epistolare dei
primi anni Cinquanta. Croce, nonostante l’età avanzata e gli acciacchi che
lo assillavano, aveva scritto nuove e profonde analisi intorno all’origine
della dialettica in Hegel e sul tema della vitalità che per un verso
complicava il sistema, mentre, peraltro, lo arricchiva ulteriormente
7 Ristampato nel volume Esperienza dello storicismo, Napoli, Giannini, 1953, pp. 181185. Il ricordo di De Ruggiero: lo studioso e l’uomo sta nel volumetto Dalla filosofia della storia
alla ragione storica, Napoli, Giannini, 1953, pp. 115-118.
8 Cfr. R. Franchini, Il razionalismo hegeliano, in Id., Dalla filosofia della storia alla ragione
storica, cit., p. 67.
234
Logos
dall’interno. Nella recensione all’ultimo libro di Croce Indagini su Hegel e
schiarimenti filosofici Franchini aveva chiamato ancora una volta in causa
Antoni, attribuendogli finanche il merito di aver suscitato nel maestro il
bisogno di un ripensamento della questione della dialettica9. Antoni ne fu
lusingato ma al tempo stesso si preoccupò dell’opinione del vecchio
filosofo. Scrisse al Croce un biglietto di scuse per avere impropriamente
adoperato l’espressione “dialettica” dei distinti, e a Franchini una lunga
lettera (del 31 marzo 1952) in cui chiariva forse anche a se stesso che la
differenza da lui messa in luce, alla fine degli anni Quaranta, tra la
dialettica hegeliana della contraddizione e la crociana dialettica
dell’opposizione, comunicata a Croce pur con molta discrezione, aveva
forse finito per condurre il filosofo proprio là dove egli non avrebbe
voluto e dove per la verità non si sentì mai di seguirlo: vale a dire ad una
sorta di primato della vitalità nel suo dialettico rapporto con la vita
morale10.
Intorno alla metà degli anni Cinquanta, come si legge nelle lettere dal
’54 al ‘57, l’intreccio di varie vicende offre snodi teorici, e non solo
teorici, particolarmente interessanti. Direi che tre possono essere
considerate le questioni più significative, che di necessità coinvolgono
filosoficamente il lettore al di là dell’apparenza di alcune diatribe
contingenti. In primo luogo si deve collocare il fatto importante della
pubblicazione del libro di Carlo Antoni Commento a Croce (1955), coevo al
Congresso di filosofia che si svolse a Napoli (con la relazione
introduttiva di Antoni) sul tema della “conoscenza storica”. Connessa
alla stampa del libro di Antoni è la vicenda relativa al caso-Fiore (1957),
che com’è evidente molto amareggiò l’Antoni, e, infine, la questione,
aperta da Croce molti anni addietro (che per ovvi motivi torna in queste
9 Vedi R. Franchini, La crudele dialettica, in «Il Mondo» (29 marzo 1952). Si chiedeva
Franchini: che cosa è accaduto nei quarantasei anni che intercorrono tra il Saggio sullo
Hegel del 1907 e gli ultimi scritti crociani su Hegel? Cosa ha spinto Croce a tornare sul
tema della dialettica in Hegel? Certo non la pubblicazione degli scritti giovanili di Hegel,
neppure il cosiddetto rinascimento esistenzialistico-fenomenologico del filosofo di
Stoccarda, e neppure i brillanti saggi di De Negri. Semmai era stato Carlo Antoni a
sottolineare l’aporia intellettualistica nella hegeliana formulazione del movimento
dialettico. Croce, pur non rispondendo direttamente alla questione posta da Antoni,
aveva voluto infine includere l’opposizione nella logica dei distinti in modo che non si
perdesse di vista la drammaticità dell’atto generativo del prodursi del reale nel suo
significato logico-spirituale.
10 Rimando alla monografia di G. Sasso, L’illusione della dialettica. Profilo di Carlo
Antoni, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1982. Si veda anche l’esauriente saggio di M.
Biscione, Carlo Antoni interprete di Hegel, in «Filosofia», XLVII, II (1996), pp. 173-192,
con particolare riferimento al volume postumo di C. Antoni, Lezioni su Hegel 1947-57,
Napoli, Bibliopolis, 1988.
Una scelta di lettere di Carlo Antoni a Raffaello Franchini
lettere), intorno al significato dell’insegnamento della “filosofia della
storia” nelle università italiane. Gustosa, infine, l’osservazione ironica di
Antoni a proposito del libro di Sprigge dedicato a Croce, relativa al
celebre saggio del ’42 Perché non possiamo non dirci cristiani. Val la pena,
quando ancor oggi si torna spesso a discettare sul senso e sul ruolo di
quello scritto, commentare la strana insinuazione sui motivi prettamente
politici, benché anacronistici, che l’avrebbero, secondo lo studioso
inglese, ispirato.
La recensione di Franchini al Commento a Croce uscì dunque nel
giugno del ’55 sulla «Nuova Antologia». Non so se furono pochi i lettori
che ne presero visione, come ipotizzava Antoni; certo è che ampia fu
l’analisi di quel libro all’interno del puntuale racconto (non però un
esaustivo resoconto) scritto da Franchini sul congresso napoletano di
Filosofia, racconto-resoconto che uscì negli «Atti» dell’Accademia
Pontaniana l’anno seguente11. L’illustre interprete di Croce dichiarò poi
onestamente, con l’umiltà dello studioso intelligente, di aver visto così
più chiaro nei suoi pensieri, quasi in virtù del diradarsi di una sorta di
nebbia, attraverso l’illustrazione che ne aveva fatta il giovane discepolo.
Che posto ebbe dunque il Commento a Croce nella discussione svoltasi
durante il XVII Congresso di filosofia intorno al grande problema della
conoscenza storica?12 Anzitutto Franchini poneva una questione di
politica culturale, assegnando alla relazione introduttiva di Antoni un
significato di “riscatto” del valore filosofico dello storicismo crociano
rispetto alle posizioni “sistematiche” o, che è lo stesso,
“problematicistiche”, di coloro cioè che comunque presuppongono un
assoluto, sia esso raggiungibile oppure no. Franchini vide in Antoni una
voce laica in grado di contrastare dogmatismi annosi e quelle forze
culturali poco sensibili alle inquietudini dello spirito liberale anche
nell’organizzazione degli studi. La scelta di chiamare Antoni ad aprire i
lavori del Congresso era stata “politicamente” rilevante e teoreticamente
acuta, perché si trattò del riconoscimento di una linea di ricerca
filosofica, tutt’uno con la ricerca storiografica, che appunto Antoni – così
scriveva Franchini - «ha spinto alle estreme conseguenze […] nei capitoli
11 R. Franchini, La conoscenza storica, in «Atti» dell’Accademia pontaniana, N.S., V,
Napoli, 1956, pp. 277-288 (rist. in Metafisica e Storia, Napoli, Giannini, 1958, da cui si
cita).
12 Il Congresso affiancò al tema della conoscenza storica quello su “Arte e
linguaggio”. Era stato organizzato da Felice Battaglia e dalla SFI napoletana, e vide
partecipi i principali esponenti degli schieramenti filosofici del tempo, come Stefanini,
Bontadini, Spirito, Calogero, Fazio Allmayer, Paci, Filiasi-Carcano, e tra gli
organizzatori Cleto Carbonara. Antoni fu primo relatore e animatore, con numerosi
interventi, delle accese discussioni sino alla fine dei lavori.
236
Logos
dedicati all’origine storica della distinzione e ai rapporti tra l’Assoluto e la
storia»13. Il Commento a Croce fu in quell’occasione lo strumento di una
militanza filosofica di tenore essenzialmente etico-politico. «Solo un
flosofo della storia, nel senso metodologico e non metafisico
dell’espressione, poteva in piena consapevolezza gridare alto e forte il no
dell’Etica contro le usurpazioni del politicismo comunista»14. Così
Franchini, forse con enfasi eccessiva ma correttamente, collocava Antoni
dalla parte dell’antitotalitarismo, anche memore degli studi da lui fatti
sulla tragedia totalitaria della Germania nazista. Sull’ibridazione di
socialismo e liberalismo Antoni non era d’accordo, come si sa, pur
tuttavia mai egli aveva negato il carattere solidaristico di una politica
economica curvata sul sociale, come infatti emerge in alcuni tratti delle
lettere a Franchini. Antoni fu lieto d’aver partecipato al Congresso
napoletano, sì da trarne soddisfazione morale e politica, benché anche
dopo abbia continuato a vedere nella cultura italiana sempre e solo
schiere di combattenti non proprio ad armi pari, se le idee
“confessionali” per lo più riuscivano ogni volta di nuovo a compattarsi in
vista di un certo potere.
La presenza di Antoni aveva ottenuto un esito importante: aveva
consentito agli esponenti di una tradizione storicistica sui generis, alla quale
Franchini si univa seguendo il cammino già di Ciardo, Attisani, Parente,
di testimoniare la volontà di un confronto con le altre correnti della
filosofia italiana e straniera. D’altronde, al solito pregiudizio che tende a
stanziare gli studi “crociani” nel Sud dell’Italia, era stato proprio l’Antoni,
nel discorso di chiusura delle sessioni del Congresso, ad opporre la realtà
del pensiero di Croce, per eccellenza europeo e mondiale nell’ispirazione
e nei suoi fecondi risultati. Franchini non si fece tuttavia sfuggire
l’occasione di denunciare i limiti di presunte filosofie d’avanguardia. Tra
l’altro lo stesso problema della conoscenza storica, così posto nella sua
purezza, poteva indurre nell’errore di non considerarne il rapporto con la
volontà e la vita morale, di trascurare cioè il ruolo dell’individuo umano,
che è un nulla se si vuole rispetto all’infinito, ma è quel tutto che si
realizza nell’opera singola e si trasmette storicamente alle generazioni
future in nome di una tradizione critica15. Non aveva forse Croce detto
chiaramente che «Storicismo è creare la propria azione, il proprio pensiero,
la propria poesia, muovendo dalla coscienza presente del passato»? Chi,
se non un individuo concreto e responsabile, potrebbe esser mai
Ibid., p. 305.
Ibid.
15 In particolar modo Calogero e Attisani avevano messo in discussione la
concezione dell’individuo in Croce e Antoni.
13
14
Una scelta di lettere di Carlo Antoni a Raffaello Franchini
l’artefice di tanta “proprietà”? Cos’è lo storicismo se non il vero
umanismo dei nostri giorni?16 Ad Antoni Franchini tributava in definitiva
il migliore degli omaggi sottolineando la teoreticità del libro su Croce, di
quel “commento” messo lì a dissimulare forse con un eccesso di pudore
la nuova filosofia che nasceva dalla lettura intrinseca del grande
pensatore. I capitoli sulla Distinzione e sul Giudizio sono cruciali nel
libro di Antoni, profondi e utili quelli sull’individuo nella Storia e
sull’idea di progresso. Più d’ogni altro principio quello della distinzione è
appartenuto allo spirito italiano, da Machiavelli a Galilei, da Vico a Croce
attraverso Labriola e De Sanctis. Nella logica crociana poi la distinzione
correggeva, secondo Antoni, gli effetti indebiti di una contraddizione
perenne pur nell’unità che ne è lo sfondo. L’identità allora diventa non
già l’accordo presupposto dei contrari ma il reale incontro dell’universale
col concreto nella forma conoscitiva del giudizio storico. Croce
restaurava così – secondo Antoni - il principio d’identità, rigenerandolo
tuttavia nella nuova vita di un rapporto asimmetrico racchiudibile nella
formula a=A. E tra le categorie non passa spazio come per un salto da
uno ad altro contesto. «In realtà il sistema – scriveva Antoni – è quello di
un’unica categoria reale e attiva, che è l’Io, di cui le categorie sono
articolazioni. Lo stesso trapasso della conoscenza nell’azione non può
essere inteso come un passaggio radicale da una categoria all’altra, quasi
che la conoscenza d’una situazione storica non fosse già guidata da una
volontà e da un interesse e l’azione non fosse guidata, lungo l’intero suo
svolgimento, dalla conoscenza»17. La lettera del 2 luglio del ’56, più avanti
riportata, è davvero illuminante a tal proposito: Antoni, platonicamente,
indicava nell’Idea del Bene l’idea-guida dello spirito umano, incisa in noi
per definirsi nel tempo in quella che felicemente chiamiamo “storia della
civiltà”.
Profonda fu l’amarezza di Antoni dopo aver letto la recensione di
Tommaso Fiore al suo “Commento” sul numero di dicembre della
rivista «Il Ponte» del ‘5618. Il suo dispiacere nasceva anche dal fatto che i
direttori, succeduti al Calamandrei nella direzione della rivista, erano
almeno dichiaratamente suoi amici19. Nella recensione non si
sottolineavano, com’è pur giusto fare, eventuali spunti critici per una
B. Croce, La storia come pensiero e come azione (1938), Bari, Laterza, 1966: Storicismo e
umanismo, p. 286.
17 Franchini cita da Antoni, Commento a Croce, Venezia, Neri Pozza, 1955, p. 170.
18 Vedi T. Fiore, rec. a C. Antoni, Commento a Croce, in «Il Ponte», 12 (1956), pp.
2155-2157.
19 Tumiati assunse la direzione della rivista fondata da Calamandrei, in un primo
tempo, dal ‘56 fino al 1965, insieme con Agnoletti.
16
238
Logos
filosofica discussione, ma si assumeva nei confronti dell’Autore un
atteggiamento ostile in partenza, probabilmente per motivi che non si
direbbero solo di carattere teorico. E difatti si accusava Antoni, «l’unico
superstite del crocianesimo in un mondo che crociano non è» (come se il
mondo aspettasse di assumere un colore politico o una preferenza
culturale per decreto della Storia) di aver discettato di problemi morali e
politici in maniera distaccata dalla realtà, realtà che pure in gioventù lo
aveva attratto e animato. Le “infedeltà” o presunte tali riscontrate dal
recensore nei riguardi di Croce venivano prima denunciate in nome di un
crocianesimo fossilizzato, quasi che lo si volesse difendere a tutti i costi,
e poi segnalate come devianze, talvolta vere e proprie concessioni a un
larvato gentilianesimo. Inutile dire che questo avveniva, e poteva esser
fatto, solo sminuzzando il discorso di Antoni e calcando la mano su
alcune frasi o concetti che risultavano distorti nel loro effettivo
significato. Date le premesse, non stupisce la conclusione cui giunge il
recensore quando si chiede: ma quale crocianesimo è questo? se, difatti,
Antoni si era permesso di seminare dubbi, di rivelare incertezze e
contraddizioni nel sistema. La peggior cattiveria nello scritto del Fiore
consistette però nell’attribuire ad Antoni una sorta di astenia emotiva,
ben altra cosa rispetto alla passione democratica del De Ruggiero e al
civismo mazziniano dell’Omodeo, entrambi già scomparsi. Eppure
Tommaso Fiore era andato da amico e sodale ad accoglierlo a Bari in una
precedente visita dell’Antoni nella città pugliese; Fiore era un antifascita
convinto e aveva fatto parte del movimento democratico meridionale
con De Martino, Dorso, in continuità con Salvemini, Gobetti e Carlo
Rosselli20. Un po’ d’anni addietro, nel ’40 Guido Calogero e nel ’41
Tommaso Fiore si videro rifiutare e aspramente criticare il manifesto
liberalsocialista da Croce, il quale tendeva a separare il concetto di libertà,
per lui superiore, dall’idea di giustizia. Dissonanze politiche pesarono
probabilmente più del dovuto sulla “scombinata” e certo solo
velatamente scientifica recensione che il Fiore aveva redatto nel ’56 sul
libro di Antoni.
Per una curiosa ironia della sorte sia Antoni che Franchini hanno
ricoperto, a distanza di un decennio, incarichi universitari nell’ambito del
settore filosofico21 sulla disciplina, tanto avversata da Croce, della
Filosofia della storia. Pur tra molte difficoltà burocratico-istituzionali
Antoni riusciva nel ’54 a cambiare titolarità (adempiendo ad un impegno
preso col filosofo), chiamato infine sulla cattedra di Storia della filosofia
20 A Tommaso Fiore è stato dedicato nel ’67 un intero fascicolo della «Rivista
Pugliese» di Bari, comprensivo del carteggio con Carlo Rosselli e con Guido Dorso.
21 Antoni aveva insegnato Letteratura tedesca a Padova dal 1942.
Una scelta di lettere di Carlo Antoni a Raffaello Franchini
moderna e contemporanea nell’Università di Roma. Franchini ottenne
l’incarico didattico nell’Università di Napoli dopo aver conseguito la
libera docenza, inaugurando il corso nel ’56 con una prolusione sulla
Filosofia della storia, materia che si accingeva ad insegnare. Antoni non
riuscì a recarsi a Napoli per assistervi, ma poté leggerne il testo su
«Criterio» con sincero compiacimento22. Franchini tracciò in
quell’occasione il profilo storico della questione, dai pensatori cristiani
fino a Hegel, a Spengler e Toynbee, difendendo l’insegnabilità di una
disciplina che mira a conoscere «un secolare bisogno dell’animo umano»
rivolto a dare un senso generale alle epoche storiche. S’intende che, in
quanto caso particolare della metafisica, la filosofia della storia andava
svecchiata e in un certo senso riformulata attraverso la metodologia
storica non disgiunta dalle sempre essenziali ricerche di storia della
storiografia. Egli si appellava alla tradizione “locale” ma europea di Vico,
De Sanctis, Bertrando Spaventa, Omodeo. Non faceva perciò il nome di
Antonio Labriola, ricordato invece da Antoni (lettera del 14 gennaio
1956) insieme al caso Ferrero e alla, oramai lontana nel tempo, battaglia
crociana contro la filosofia della storia in un celebre discorso di Croce al
Senato del Regno nel maggio del 191323. La prolusione si chiudeva con
un omaggio «al primo docente ufficiale che di questa materia l’Italia
abbia avuto, il nostro Maestro ed Amico Carlo Antoni…»24.
La recensione al libro di Sprigge merita qualche nota in margine,
anche a difesa dell’interprete inglese sul quale potrebbe pesare fin troppo
l’icastica osservazione di Antoni che gli attribuisce una lettura del
rapporto di Croce col cristianesimo sulla base di mere considerazioni
politicistiche. Franchini cercò allora di dipanare la controversa materia25,
riconoscendo allo Sprigge la buona fede pur nella ripetizione del luogo
22 La Prolusione uscì in due puntate su «Criterio», la rivista diretta a Firenze da
Ragghianti, nel ’57, I, n. 4, pp. 277-284 e I, n. 5, pp. 354-363. «Criterio» fu poi ripresa
da Franchini nella Nuova Serie Filosofica, e da lui diretta dal 1983 al 1990.
23 Il discorso in Senato non conteneva, contrariamente a quanto talvolta si è
lasciato intendere, alcun riferimento a Ferrero (per il quale si veda invece la nota di
Croce in Conversazioni critiche, serie I, Bari, Laterza 1918. Il testo del discorso in Senato
del 29 maggio 1913 si può leggere in Discorsi parlamentari, con un saggio di M. Maggi,
Bologna, Il Mulino, 2002. Su Croce e Ferrero si veda la nota di F. Tessitore in «Rivista di
Studi crociani», 1 (1964), pp. 147-150. Sulla riconciliazione di Croce e Ferrero, in nome
di un comune sentire negli anni bui del fascismo, rimando a A. Parente, Croce per lumi
sparsi, Firenze, La Nuova Italia, 1975, pp. 270-273.
24 La Prolusione fu poi ristampata in Franchini, Metafisica e Storia, cit., pp. 105-133.
25 La recenzione al libro di C. Sprigge, Benedetto Croce, l’uomo e il pensatore (Napoli,
Ricciardi, 1956) apparve su «Criterio» con il titolo Un profilo del Croce, 2 (1957), pp. 165167 e fu ristampata nel volume L’oggetto della filosofia, Napoli, Giannini, 1962, pp. 253258.
240
Logos
comune per il quale si attribuivano a Croce inclinazioni e spirito
conservatori. In effetti Croce aveva mostrato già da prima
“comprensione” per la Chiesa cattolica, ciò non pertanto lo scritto del
’42, che pure piacque molto per evidenti ragioni a taluni cattolici, fu una
risposta alla sfida dei fatti sulla base di principi teorici che sempre
ispirarono il filosofo, il cui sguardo per necessità mirava ad assumere
connotati universali “oltre” la mera contingenza delle circostanze
politiche. E tuttavia il contenuto di quel testo è sempre “presente” nel
suo significato inequivocabile. La figura di Gesù, al centro del
cristianesimo, ha rappresentato un messaggio ancora fermamente iscritto
nel cuore della modernità e dentro la storia del mondo contemporaneo,
sia per gli appartenenti ad una chiesa sia per i laici credenti e non
credenti. Non in poco conto pertanto dev’essere tenuto il plurale
espresso in quel “noi” (Perché [noi] non possiamo non dirci cristiani), che
difatti esclude il discorso in prima persona, ed esclude che si tratti della
confessione di un sentimento segreto. Parimenti estranee all’argomento
crociano furono le polemiche anticlericali, del tutto fuori luogo in un
contesto che, come può verificare ogni attento lettore, fu di carattere
teoretico e storiografico. Il cristianesimo non è stato un miracolo, ma un
processo storico; anche se proprio il suo aver intersecato profondamente
le vicende storiche di una così vasta parte del mondo lo rende una sorta
di evento straordinario, non però diversamente, in chiave ontologica, dal
miracolo che ogni ente è, e dall’eccezione che noi tutti siamo.
Le lettere, fattesi più rare tra il ’58 e i primi mesi del ’59, raccontano
di vicende accademiche e di fatti quotidiani, di brevi viaggi e di alcuni
malanni che affliggevano Antoni già da qualche tempo. Al centro tuttavia
sta la figura di Luigi Scaravelli, scomparso tragicamente nella primavera
del 1957. Nella Commemorazione pisana26 Antoni aveva tracciato dello
Scaravelli, a pochi mesi dalla morte, un profilo davvero partecipe, in
spirito di amicizia e di stima per un uomo schivo e assai colto,
conversatore brillante che sapeva «passare dalla musica classica al
romanzo francese, dalla pittura alla fisica nucleare». Giunto alla filosofia
da studi scientifici, di matematica e di medicina, egli si era infatti
misurato con i grandi della tradizione filosofica specie su temi di logica
pura per certi versi, ma in virtù dell’intento di far precedere il capire
sull’esistere. A Croce e Gentile aveva dedicato con acume le sue fatiche
d’interprete, non meno che a Platone, Cartesio, Kant, Heidegger,
Heisenberg. In ogni modo egli cercò di risolvere un suo problema
26 La commemorazione letta nella Sala degli Stemmi della Scuola Normale
Superiore il 23 novembre 1957 è nel volume di C. Antoni, Gratitudine, Milano-Napoli,
Ricciardi, 1969, pp. 32-52.
Una scelta di lettere di Carlo Antoni a Raffaello Franchini
teoretico. Antoni scrive a Franchini (lettera del 3 dic. 1958): «Il problema
di Scaravelli era quello di dedurre il molteplice dall’identico, cioè di
scoprire o “capire” come la grande madre genera i suoi figli». Problema
insolubile perché pur muovendo dal principio d’identità indispensabile
per la comprensione dei significati, Scaravelli dovette infine arrendersi
alla sua dissolvenza aprendosi piuttosto al giudizio delle forme concrete
dell’esistere storico. Si trattava del problema della creazione del mondo,
concludeva Antoni, riassumendo così in una formula efficace le puntuali
analisi da lui precedentemente svolte sulla Critica del capire27, ch’ebbero il
merito di rompere il silenzio con cui il libro fu accolto, nonostante il
parere molto positivo espresso nel ’42 dallo stesso Croce.
Mancò, infine, il tempo per discutere tra amici intorno all’ultimo
libro di Antoni La restaurazione del diritto di natura. Franchini ne aveva
parlato sul numero di luglio del «Mondo», accogliendo senza riserve la
proposta, in apparenza assai poco storicistica, di un “ritorno” al principio
dell’etica universalmente umana, la sola capace però «di evitare le
pericolose conseguenze del predominio della tecnica e della civiltà di
massa». Egli ebbe forse bene a mente le parole adoperate da Antoni in
una lettera di qualche anno prima28: alla base del giudizio storico e
dell’azione morale e politica sta la luce di un concetto universale dello
spirito umano che tuttavia, proprio nella forma di un umanesimo
rinnovato, non contrasta affatto con la visione storicistica e dialettica
della vita con tutte le sue imprevedibili e particolarissime circostanze.
***
Roma, 6 novembre 1948
Caro dott. Franchini,
è da tempo che seguo con vivo interesse la Sua attività di studioso.
Così ho letto la Sua bella recensione del libro del Ciardo29 e il Suo
articolo sul Gramsci, comparso sullo «Spettatore»30. Ho ricevuto oggi la
27 Si veda la lunga recensione di Antoni a L. Scaravelli, Critica del capire, in
«Giornale critico della filosofia italiana», Seconda serie, II (1942), pp. 232-234.
28 Vedi lettera del 2 luglio 1956, più avanti riportata.
29 La recensione al libro di M. Ciardo, Le quattro epoche dello storicismo, era uscita in
«La parola del passato», 6 (1947), pp. 368-373 (rist. nel volume R. Franchini, Esperienza
dello storicismo, Napoli, Giannini, 1953).
30 Si tratta dell’articolo La “metodologia dell’azione” di A. Gramsci, uscito in «Lo
Spettatore italiano», 6 (1948). La rivista si pubblicava a Roma per iniziativa di Elena
Croce, figlia maggiore del filosofo, e del marito Raimondo Craveri.
242
Logos
sua memoria su Storicismo e relativismo31, che ho letto subito. Penso che il
suo esame del rapporto e la differenza tra “storicismo” e “istorismo”
ossia relativismo storicistico sia molto opportuno oltre che acuto.
Ella mi muove un lieve appunto: quello di aver attribuito al
Troeltsch il merito di aver introdotto nell’uso comune il termine di
“storicismo”. Mi sembra però di aver detto una verità incontestabile:
anche se al termine il Troeltsch continuava a dare un significato
deteriore, tuttavia egli ha introdotto l’uso del termine stesso nel dominio
della storiografia e della riflessione sui metodi della storiografia. Soltanto
dopo di lui si parla di storicismo moderno, di problemi, crisi ecc. dello
storicismo.
Se Ella ha occasione di venire a Roma, sarò assai lieto di vederla e di
conversare con lei.
Con cordiali saluti
Suo
Carlo Antoni
***
Roma, 12 marzo 1950
Caro Franchini,
di ritorno da Bari, dove sono stato a tenere una conferenza agli
“Amici della cultura”, trovo la sua lettera e mi affretto a rispondere, ossia
a rilasciarle il “certificato” che desidera32.
Con cordialissimi auguri
Suo
Carlo Antoni
***
Roma, 12 marzo 1950
È da qualche anno che seguo con molta attenzione gli scritti che il
prof. Raffaello Franchini va pubblicando nelle riviste. Alcuni di essi,
31 Cfr. R. Franchini, Storicismo e relativismo, in «Atti» dell’Accademia Pontaniana,
N.S., I (1949), pp. 241-255 (rist. in Esperienza dello storicismo, cit.).
32 Segue la lusinghiera lettera di presentazione di Antoni sull’operosità del giovane
Franchini, il quale di lì a poco entrò a far parte del corpo docente del liceo classico della
Scuola militare napoletana.
Una scelta di lettere di Carlo Antoni a Raffaello Franchini
infatti, hanno già recato un contributo di chiarificazione e di critica assai
notevole nel campo degli studi storico-filosofici: Tutti, poi,
indistintamente sono la testimonianza d’un ingegno assai vivace, fine,
sensibile ai più urgenti problemi della filosofia e della vita. Oltre a
rivelare una preparazione culturale assai ricca e sostanziosa, essi indicano
anche un raro senso di umanità. Tra i giovani dell’ultima generazione il
Franchini è certamente uno dei più promettenti. Per le sue doti
intellettuali e morali ritengo anche che possa essere un magnifico
insegnante, tale da mantenere alto il prestigio di cui ha sempre goduto il
collegio della “Nunziatella”.
Carlo Antoni
***
Roma, 1 ottobre 1951
Mio caro Franchini,
ho letto con grande interesse il Suo saggio33 e soprattutto la parte che
mi riguarda. Ella ha afferrato perfettamente il mio pensiero (La ringrazio
anche per averne messo in rilievo la novità), tanto perfettamente da
trarne le conseguenze, che io non avevo voluto trarne, malgrado che mi
avvedessi che c’erano. In effetti Le confesso che ho i miei dubbi intorno
ad una “dialettica” dei distinti. Di questo dubbio Lei trova traccia del
resto nella recensione che feci allo “Hegel” di De Ruggiero.
In ogni caso sono assai lieto della penetrante attenzione che Ella
dedica ai miei scritti.
Suo
Carlo Antoni
***
Il saggio è: Morte e resurrezione della dialettica da Hegel a Croce, in «Letterature
moderne», 3 (1951), pp. 292-302 (rist. in Esperienza dello storicismo, cit.).
33
244
Logos
Roma, 25 marzo 1952
Mio caro Franchini,
il Suo articolo34 mi ha fatto, com’è naturale, un immenso piacere.
Attribuirmi il merito di aver provocato in Croce il bisogno di riesaminare
la questione della dialettica è, non occorre dirlo, rendermi il massimo
degli onori. Ma Croce stesso che ne dice? Vorrei sapere se approva il Suo
articolo.
Con saluti cordialissimi
Suo
Carlo Antoni
***
Roma, 31 marzo 1952
Mio caro Franchini,
La ringrazio per la Sua lettera e per le notizie che mi dà. Come Ella
può comprendere, la questione, da Lei sollevata nel Suo articolo, ha per
me una grande importanza. Le dirò come io veda la cosa. Quando
pubblicai nel ’45 il mio saggio sulla Dialettica di Hegel, in cui ne
denunciavo il carattere intellettualistico, saggio ristampato nel ’46 nelle
mie “Considerazioni”35, Croce ne prese conoscenza, tanto che mi
segnalò il Suo articolo in proposito, ma non si propose il problema.
Erano tempi in cui Croce, tutto preso dall’attività politica, non aveva
probabilmente l’agio di ritornare sulle sue idee intorno alla dialettica. Il
mio scritto suscitò l’interesse di De Ruggiero, che lo ha citato con molta
lode nel suo “Hegel”, ma senza prender posizione. Per quanto riguarda
questa mia prima osservazione, penso che Croce abbia ragione nel
negare che la sua revisione sia stata provocata da me.
Ma nel ’49 io giunsi all’altra osservazione e cioè alla netta distinzione
tra la hegeliana dialettica della contraddizione e la crociana dialettica
dell’opposizione. Essa si connetteva alla mia precedente attribuzione (del
’46) a Croce della restaurazione del principio d’identità.
Il riferimento è all’articolo: La crudele dialettica, uscito su «Il Mondo» il 29-3-’52.
Tutti gli scritti di Franchini che uscirono nella rivista di Mario Pannunzio dal 1950 al
1966 sono raccolti nel volume Pensieri sul “Mondo”, a cura di R. Viti Cavaliere, C. Gily, R.
Melillo, con una Presentazione di G. Cotroneo, Napoli, Luciano, 2000.
35 C. Antoni, La dialettica di Hegel, in «Poesia e verità», 1 (1945); rist. in Id.,
Considerazioni su Hegel e Marx, Napoli, 1946. Si ricorda che Franchini aveva recensito le
Considerazioni nella rivista «Ethos», II (1946), pp. 87-90.
34
Una scelta di lettere di Carlo Antoni a Raffaello Franchini
Ero molto incerto se comunicare o no a Croce questa mia
osservazione, che avevo svolto nel corso universitario di quell’anno. Mi
rendevo conto, cioè, che essa avrebbe provocato un grave turbamento ed
un bisogno di una radicale revisione del pensiero crociano nei confronti
di Hegel e della dialettica in generale. Mi consultai con parecchi amici.
Tra costoro Riccardo Bacchelli, al quale ricorsi e per la sua sensibilità
umana e psicologica e per la devozione che aveva per la persona di
Croce, mi dissuase dal farlo, dicendo che oramai era meglio lasciare
tranquillo il glorioso vegliardo e non costringerlo alla sua età a un siffatto
sforzo. Tuttavia la cosa mi tormentava, dato che ritenevo che Croce
avesse attribuito a Hegel la sua propria gloria e mi dispiaceva che potesse
morire senza essersi reso conto della propria originalità nei confronti di
quel suo maestro. Dopo che si fu ripreso dalla grave malattia, che lo
colpì, mi feci coraggio e gli scrissi. Croce mi rispose con una lettera che
era un’accettazione di massima, ma contenuta in termini un po’ generici.
Si vedeva che si riservava di meditare per suo conto l’intera questione. E
infatti poco dopo cominciarono a uscire i suoi nuovi scritti intorno alla
vitalità e al suo carattere dialettico, e in genere intorno a Hegel e alla
origine della dialettica hegeliana. Il punto di partenza di questi scritti,
però, è fornito dal momento della vitalità, al quale Croce riporta tutta la
dialettica: sia la teoria hegeliana per sé stessa, sia la dialettica della vita e
dello spirito in sé. In questo modo Croce andava, in certo senso, più in là
della mia osservazione, scavalcandola e prendendo tutt’altra direzione. Le
dirò che, invece, per mio conto ho proseguito in direzione ben diversa.
Nel corso di quest’anno ho svolto un esame dell’intera questione, che mi
ha portato a risultati che contrastano con le tesi recentissime espresse da
Croce.
Per concludere penso che Croce, pur essendo stimolato dalla mia
seconda osservazione, a riproporsi lo studio della natura della dialettica, è
stato condotto alle sue nuove idee dal senso più accentuato
dell’importanza della vitalità.
Con cordialissimi saluti
Suo
Carlo Antoni
***
246
Logos
Roma, 2-12-52
Mio caro Franchini,
La ringrazio di aver pensato a me in questi giorni. Come sempre
succede, nei primi momenti dopo la scomparsa di persona cara, non ci si
rende conto del tutto della perdita. Il senso di vuoto viene dopo. Così
accadrà per noi tutti: ma dovremmo anche cercare di restare uniti.
Il Suo articolo comparso nel «Mondo»36 mi è molto piaciuto. Vorrei
vedere il fondo del «Times»: non potrebbe spedirmelo in prestito? Glielo
restituirei subito.
Arrivederci tra breve
Suo
Carlo Antoni
***
Roma, 6 ottobre 1953
Caro Franchini,
ho ancora sul mio tavolo la lettera, che ho ritrovato al mio ritorno
dalle vacanze. Vorrei che Lei mi desse qualche notizia sul concorso, di
modo che io possa eventualmente intervenire presso i commissari.
Ho letto con piacere i Suoi due articoli: quello su Mann37 e quello sul
libro del Sainati38. Sulla personalità di Mann faccio molte riserve. Si parlò
di lui con Croce, l’ultima volta che lo vidi, ed in fondo Croce era
d’accordo, quando dicevo che dagli scritti di Mann veniva su un certo
lezzo di frollo, se non addirittura di marcio.
Attendo il Suo volume.
Suo
Carlo Antoni
R. Franchini, Benedetto Croce tra i due secoli, in «Il Mondo», 29-11-’52.
Su Mann era uscito l’articolo Nobiltà dello spirito sia in «Il Giornale» del 30-9-‘53
sia in «Il Giornale di Trieste» del 6-10-‘53.
38 Di Sainati si parlava a lungo nell’articolo Studi crociani, apparso su «Il Mondo»
del 6 ottobre 1953.
36
37
Una scelta di lettere di Carlo Antoni a Raffaello Franchini
***
Roma, 11 aprile 1954
Caro Franchini,
con l’editore Pozza, che era qui in questi giorni, ho esaminato la
questione della traduzione d’una scelta di lettere di Hegel39. I due volumi
della nuova edizione del Meiner, curata da Hoffmeister, arrivano al 1822.
Sono previsti altri due volumi. La nuova edizione reca il copyright con
espressa riserva dei diritti di traduzione. Per mia esperienza prevedo che
le pretese del Meiner sarebbero esose. Da un rapido confronto con la
vecchia edizione del 1887, curata dal figlio, ho tratto l’impressione che la
nuova non rechi molto di nuovo. In ogni caso, se ci si volesse attenere a
quest’ultima, si dovrebbe attendere l’uscita dei due ultimi volumi, che chi
sa quando si attuerà.
Con Pozza sono quindi giunto alla conclusione che ci conviene
rifarci alla prima edizione, che reca anche sufficienti note. Ove risultasse
qualche nuova lettera molto importante nella nuova edizione, il Pozza
chiederebbe il diritto di traduzione per essa.
Ella dovrebbe quindi cominciare il lavoro di scelta. Non le nascondo
che dalla lettura delle lettere il compito della traduzione mi è apparso
molto arduo.
Con cordiali saluti
Suo
Carlo Antoni
***
Roma, 5 maggio 1955
Caro Franchini,
grazie per le Sue parole. Si tratta in fondo d’un semplice
cambiamento del titolo della mia cattedra, che era poi una sorta
d’impegno che avevo assunto con Croce. Ancora l’ultima volta che lo
Il progetto di curatela dell’Epistolario hegeliano presentava più d’una difficoltà:
la nuova edizione dell’Hoffmeister avrebbe dovuto far fede, assai più dell’edizione
curata dal figlio del filosofo, ma era al momento incompleta. L’idea allora di rifarsi alla
precedente edizione, da integrare eventualmente con le lettere ritenute significative, si
mostrò impraticabile. Franchini avrebbe dovuto occuparsi della traduzione di una scelta
di lettere e della stesura dell’introduzione storico-critica. Non se ne fece nulla,
nonostante la buona disposizione dell’editore Pozza e l’interessamento di Ragghianti.
39
248
Logos
vidi, Croce mi raccomandò di fare cambiare quel titolo di “filosofia della
storia”, che proprio non gli andava giù40. Gli spiegai allora che la
procedura non era facile, ed infatti ci sono voluti parecchi anni, con
modifiche allo statuto, per raggiungere il risultato41.
Sono ansioso di leggere sulla «Nuova Antologia» la Sua recensione:
peccato che sarà letta da pochi!
L’intervento di Tagliacozzo mi ha sorpreso: è un esempio del cattivo
modo in cui un discepolo può seguire un maestro, cui è affezionato.
Con cordialissimi saluti,
Suo
Carlo Antoni
***
Roma, 22 maggio 1955
Mio Caro Franchini,
bellissima la Sua recensione, per cui Le sono molto grato42. Mi
dispiace soltanto che essa compaia nella «Nuova Antologia», dove sarà
letta da pochi. La Sua osservazione o previsione sulla sorpresa di molti
che scopriranno quanto complessa sia la filosofia crociana, mi ha
divertito e fatto ricordare come spesso mi sia toccato di sentire che
quella filosofia non era interessante, perché non era “problematica”. Mi è
piaciuto anche il modo, assai fine, con cui Ella ha saputo definire la mia
posizione verso le dottrine del Maestro.
Ottimo pure l’articolo sulla Storia economica del Kulischer43, anche
dal punto di vista giornalistico.
Alla notizia dell’ottenuto conferimento della cattedra di Filosofia della storia
nella Facoltà di Lettere dell’Università di Roma, Croce nel congratularsi con l’Antoni,
così gli scriveva: «Se la parola sociologia è screditata per la sua volgare origine
positivistica, quella di Filosofia della storia è del pari screditata per la sua origine teologica
e metafisica. Lei si deve subito dar da fare per cangiarlo». Cfr. Lettera di Croce ad
Antoni, 26 dicembre 1946, in Carteggio Croce-Antoni, a cura di M. Musté, introduzione di
G. Sasso, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 73.
41 Dal 1954 Antoni fu chiamato alla cattedra di Storia della filosofia moderna e
contemporanea.
42 La recensione al libro di Antoni Commento a Croce uscì con questo titolo sulla
rivista «Nuova Antologia» nel giugno di quell’anno.
43 Antoni si riferiva all’articolo dal titolo Una storia del progresso uscito su «Il
Giornale» del 13-5-‘55 (rist. in R. Franchini, L’oggetto della filosofia, cit.).
40
Una scelta di lettere di Carlo Antoni a Raffaello Franchini
Sarà bene che ci vediamo prima della scadenza dei termini per la
presentazione delle domande di libera docenza44. Il 26 mi reco a Firenze
per incontrarmi con Ragghianti e Pozza, e sarò di ritorno soltanto il 30.
Cordialmente
Suo
Carlo Antoni
***
Roma, 14 gennaio 1956
Mio caro Franchini,
una bronchite con i fiocchi – si direbbe che quest’anno sono iettato
– mi ha tenuto a letto per una settimana e ancora non so quando potrò
uscire di casa. Prevedo che dovrò rinunciare al progetto di venire a
Napoli per la Sua prolusione45: è un vero dispiacere per me, perché ci
tenevo ad essere presente.
Il primo insegnante di “filosofia della storia” è stato, a quanto mi
consta, Terenzio Mamiani, poi a Roma Labriola tenne tale insegnamento
per incarico, con molto successo. Nella mia prolusione del 194646 tenni
ad accennare alla continuità ideale, tramite Croce.
La proposta di attribuire la cattedra a Ferrero, provocata da un
clamoroso intervento del presidente Teodoro Roosevelt, fu bocciata dal
Senato. Croce tenne allora un famoso discorso47, che valse a far cadere la
proposta, del resto poco gradita dal mondo accademico di allora.
Suo
Carlo Antoni
44 Antoni si era prodigato l’anno prima per l’inserimento della Filosofia della storia
nell’elenco delle libere docenze. Nel 1956 Franchini sostenne gli esami di abilitazione
alla libera docenza in Filosofia della storia superandoli brillantemente. Tra i commissari
Felice Battaglia, Adelchi Attisani e lo storico Giorgio Falco.
45 Franchini inaugurò il suo Corso di Filosofia della Storia nell’Università di Napoli
nel 1956 con una prolusione dal titolo La Filosofia della storia, il cui testo uscì poi, nel
1957, sulla rivista «Criterio» diretta da C.L. Ragghianti, in due puntate. Il testo della
lezione inaugurale venne infine ristampato nel volume Metafisica e Storia, cit..
46 La Prolusione dal titolo La dottrina dialettica della storia è nel volume postumo
Storicismo e antistoricismo, a cura di M. Biscione, introduzione di A. Pagliaro, Napoli,
Morano, 1964, nella Collana di Filosofia diretta da E.P. Lamanna e P. Piovani.
47 Antoni si riferisce al celebre discorso di Croce al Senato del Regno, nella seduta
del 29 maggio 1913, Sul disegno di legge “Istituzione di una cattedra di Filosofia della storia presso
la Università di Roma”, che ora è possibile leggere nel volume Benedetto Croce. Discorsi
parlamentari, con un saggio di M. Maggi, cit., pp. 59-64.
250
Logos
***
Roma, 14 giugno 1956
Mio caro Franchini,
Ella può ben immaginare con quanto piacere ho letto e riletto la Sua
memoria alla Pontaniana48. Anzitutto essa mi ha confortato confermando
l’utilità del mio intervento al Congresso di Napoli. Ma anche la parte che
più propriamente riguarda il mio “Commento” mi è stata di grande
vantaggio. In fondo, si guardano i propri scritti sempre un po’ attraverso
una nebbia: un osservatore acuto ed esperto, come Lei, è di grande aiuto
a discernere le linee principali del proprio pensiero.
La ringrazio, dunque, con molto affetto
Suo
Carlo Antoni
***
Roma, 2 luglio 1956
Mio caro Franchini,
la Sua osservazione tocca un punto, che aveva già suscitato le
perplessità del mio amico Attisani. Nel mio articolo esso era trattato
troppo sommariamente. Bisognerà che ci ritorni sopra. In ogni caso
voglio subito avvertirla che non penso a qualcosa di medio tra
conoscenza storica e azione, ma al semplice fatto che noi pensiamo e
giudichiamo la storia alla luce di quel concetto universale dell’uomo o
dello spirito umano, che è il medesimo che orienta la nostra azione
morale e politica. Questo concetto, in quanto principio dell’azione
morale, è l’idea del Bene. Essa è vera, anzi è la verità che abita in noi, ma
si va definendo e chiarendo attraverso la storia, che per questo è storia
della civiltà. Aggiungo che non vi è distinzione tra categoria e coscienza
della categoria, anche se la prima appare eterna e l’altra storicamente
La memoria accademica di cui si parla riguardava l’ampio resoconto critico che
Franchini scrisse intorno al XVII Congresso di Filosofia che si era tenuto a Napoli nel
marzo del 1955, dove Antoni era stato invitato a tenere la relazione introduttiva sul
tema della conoscenza storica. Antonio Aliotta sul «Giornale d’Italia» del 26 marzo
1955 aveva sottolineato l’importanza di una tradizione di storicismo crociano
nell’ultimo decennio. La memoria di Franchini, dal titolo La conoscenza storica, uscì negli
«Atti» dell’Accademia Pontaniana, N.S., V, 1956, pp. 277-288 (rist. in Metafisica e Storia,
cit.).
48
Una scelta di lettere di Carlo Antoni a Raffaello Franchini
relativa: la categoria è sempre coscienza di sé, ma si va rendendo sempre
più cosciente, come, mi sembra, sia insegnato da Croce nelle parti
storiche dei suoi trattati.
Ha fatto bene ad accettare l’invito al “Simposio” laterziano. Sono
curioso di sapere quali sono gli altri invitati. Ella non manca di
combattività, sicché sono tranquilli per la buona causa.
Non sono sicuro di resistere al caldo fino alla fine del mese. Tuttavia
la prego di telefonare a casa mia al Suo passaggio da Roma
Suo
Carlo Antoni
***
Roma, 28 luglio 1956
Caro Franchini,
ho letto la recensione, che Le restituisco. Mi rallegro con Lei per il
fatto che il Suo libro sia stato recensito dalla «Historische Zeitschrift»,
che resta tuttora la migliore rivista tedesca di studi storici49. È un onore
per Lei. In quanto alla recensione stessa, essa ha il consueto carattere
informativo delle recensioni tedesche, nelle quali di rado si prende
posizione. Naturalmente noi, abituati allo stile delle recensioni crociane,
ci impazientiamo dinanzi a tanta acriticità. Ignoro chi sia questo Funke.
Con i più cordiali saluti
Suo
Antoni
Ha visto il mio Tramonto delle ideologie sul «Mondo»?50
***
Si tratta della recensione di G. Funke al libro di Franchini Esperienza dello
storicismo, in «Historische Zeitschrift», Bd. 181, 3, (1956), pp. 596-600. Antoni aveva
scritto sul «Mondo» (marzo 1954) un lungo e denso articolo sul volume di Franchini,
che si può leggere nella raccolta Il tempo e le idee, a cura di M. Biscione, Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 1967, pp. 447-451.
50 Vedi «Il Mondo», luglio 1956, in Il Tempo e le idee, cit., pp. 232-243.
49
252
Logos
Roma, 4 sett. 1956
Mio caro Franchini,
grazie per la Sua lettera di consenso al mio articolo sul socialismo51.
Era una conferenza, che tenni nel gennaio dell’anno scorso a Zurigo e
che poi fu raccolta in un volume pubblicato in Svizzera. Avendo avuto
una certa eco in Svizzera e Germania, pensai che era utile farla
conoscere, anche in relazione alla situazione dei “radicali”. In effetti mi
sembra di aver ottenuto qualcosa: un socialista come Silone ha sentito il
bisogno di telefonarmi per dirmi che era d’accordo. Come Ella si sarà
accorto, la parte più importante è l’ultima, dove io cerco di venire
incontro alle “istanze” sociali senza cadere nelle confusioni del liberalsocialismo calogeriano. Mi sembra che proprio avendo attribuito al
liberismo un carattere etico-politico, si possa dargli anche un nuovo
carattere positivo, liberatore, “sociale”.
In quanto all’indirizzo del «Mondo», alcuni amici mi hanno fatto
osservare che da alcune settimane era piuttosto “moderato”. Poiché le
critiche, che io Le esposi nella nostra conversazione per strada, le vado
facendo a Pannunzio appunto da alcune settimane, forse non è
presunzione la mia, se suppongo di aver ottenuto qualcosa anche in
questo senso.
Va benissimo per la recensione allo Sprigge52, dove c’è da obiettare
ad una sorta d’insinuazione (Croce avrebbe scritto l’articolo sul perché
non possiamo non dirci cristiani – che sappiamo aver avuto carattere
anti-nazista – perché prevedeva l’alleanza con la Dem. Cristiana, nel
1942!)
Suo
Antoni
Le convinzioni di Antoni sul socialismo, sul liberalismo e sulla incongruità di un
liberalsocialismo furono sempre chiare e lineari. Franchini concordava. Qui esse
emergono nella concretezza del dibattito politico che coinvolse gli intellettuali del
«Mondo».
52 La recensione di Franchini alla traduzione italiana del libro di C. Sprigge,
Benedetto Croce, l’uomo e il pensatore (Napoli, Ricciardi, 1951) uscì su «Criterio» con il titolo
Un profilo del Croce, 2 (1957), pp. 165-167 (rist. nel volume L’oggetto della filosofia, cit., pp.
253-258).
51
Una scelta di lettere di Carlo Antoni a Raffaello Franchini
***
Roma, 24 nov. 1956
Caro Franchini,
l’infiammazione agli occhi, che mi aveva impedito di venire a Napoli
e che sembrava scomparsa, mi dà nuovamente fastidio, sicché devo
riguardarmi.
Penso che Ella dovrebbe scrivere l’articolo sul primo decennio
dell’Istituto53. Come forse Ella sa, nei tempi in cui Croce stava
progettandolo, io insistetti presso Mattioli, affinché scoraggiasse
l’iniziativa. Infatti non avevo nessuna fiducia nella utilità dell’istituzione.
Devo riconoscere che mi ero sbagliato, anche se difatti, errori,
inconvenienti non sono mancati. In complesso, mi sembra, il nostro
giudizio deve essere positivo. Anche se ne hanno profittato alcuni
furfantelli, se, cioè, l’eterogenesi dei fini o l’astuzia della ragione hanno
operato in senso negativo, parecchi bravi giovani hanno avuto modo di
studiare e lavorare. In quanto all’indirizzo “storico” dell’Istituto, esso
non soltanto corrisponde al nome, ma al preciso pensiero di Croce.
Con i più cordiali saluti
Suo
Carlo Antoni
***
Roma, 18 gennaio 1957
Mio caro Franchini,
purtroppo devo rinunciare definitivamente alla mia gita a Napoli:
non sono ancora completamente ristabilito e devo riguardarmi da una
ennesima ricaduta. Non ho ancora ripreso ad uscire di casa. Le faccio
quindi per lettera gli affettuosi auguri che avrei voluto farle a voce.
Spero di leggere la Sua prolusione in «Criterio»54. Le sono grato per il
Suo proposito di propormi per la “Pontaniana”: onore che accetto e che
mi è molto gradito55. Eccole i miei dati biografici:
53 Il 17 dicembre del ’57 fu pubblicato infatti sul «Mondo» l’articolo di Franchini
Dieci anni nell’anniversario della fondazione dell’Istituto Italiano di Studi Storici
avvenuta nel 1947 nella sede di Palazzo Filomarino in Napoli.
54 Cosa che avvenne. Vedi sopra la nota 44.
254
Logos
nato a Senosecchia (Trieste) il 15-8-1896;
volontario nella guerra ’15-’18, ferito, medaglia di bronzo e croce di
guerra;
laureato in Filosofia a Firenze nel 1928;
professore nei Licei scientifici dal 1924 al 1932 a Messina e a Roma;
assistente dell’Istituto Italiano di Studi Germanici dal 1932 al 1942.
Libero docente di Storia della filosofia nel 1937;
professore di Letteratura tedesca a Padova nel 1942;
membro della Giunta del Partito Liberale, Consultore nazionale,
Commissario dell’IRCE nel periodo 1944-1946;
chiamato nel 1946 alla cattedra di Filosofia della storia di Roma.
Premio Einaudi per la filosofia 1952;
socio corr. dell’Accademia dei Lincei, dell’Arcadia, dell’Acc.
Peloritana, socio della Mont-Pelagia Society e dell’Archäologische
Institut.
Chiamato alla cattedra di Storia della filosofia moderna e
contemporanea 1954.
Suo
Carlo Antoni
***
Roma, 15-2-‘57
Caro Franchini,
sono lieto per la notizia che Ella mi dà: così Ella potrà assumere
l’incarico, che, mi auguro, sia anche compensato. Lessi con piacere le
notizie della Sua prolusione. Esse mi diedero qualche conforto in un
momento di amarezza, quando cioè mi capitò di leggere sul «Ponte» la
cattiva e balorda recensione di Tommaso Fiore al mio Commento56. E dire
che costui, appena letto il libro, mi scrisse una lettera entusiastica!
Franchini era diventato socio ordinario dell’Accademia Pontaniana di Napoli nel
1954 su proposta di Fausto Nicolini. Rinvio per queste ad altre notizie biografiche al
volumetto R. Franchini, Autobiografia minima, Roma, Bulzoni, 1973. Antoni fu dal ’57
socio della prestigiosa Accademia.
56 La recensione di T. Fiore al Commento a Croce (1955) di Antoni era uscita in «Il
Ponte/Rivista mensile di politica e letteratura», a. XII (12 dicembre 1956), pp. 21552157.
55
Una scelta di lettere di Carlo Antoni a Raffaello Franchini
Tumiati57, al quale avevo espresso la mia sorpresa per la pubblicazione di
siffatta sconcezza, mi scrisse una lettera piena di deplorazioni o scuse.
Ma chi mi ha recato la serenità è stato Ragghianti, che, dopo aver fatto
un breve ritratto del Fiore, mi ha suggerito di seguire l’aurea massima di
Flaubert: «Mon cul vous contemple».
Ottimo il Suo articolo in «Criterio»58.
Suo
Carlo Antoni
***
Roma, 23 maggio 1957
Caro Franchini,
non ho voluto che Ella attendesse il mio libro dalla ERI e Le ho
spedito oggi una delle copie a mia disposizione. Pannunzio accoglierà
volentieri la Sua recensione59.
Suo
Antoni
***
Roma, 13 ott. 1957
Mio caro Franchini,
è da un pezzo che non mi faccio vivo con Lei. Non Le scrissi
quando Ella mi annunciò la fine del «Giornale», ultimo quotidiano
liberale, che, oltre a tutto, era un bel giornale, assai bene redatto. Faceva
onore a Napoli60. Per Lei, forse, l’esser costretto ad abbandonare una
57 Corrado Tumiati assunse la direzione della rivista «Il Ponte», fondata da Piero
Calamandrei, a partire dal 1956, direzione che condivise per un certo periodo con
Agnoletti (fino al ’65).
58 Antoni si riferisce all’articolo di Franchini sul libro di Sprigge (vedi nota 51).
59 Si tratta del libro di Antoni Lo storicismo, pubblicato nel ’57 dalle edizioni ERI, in
cui sono raccolte le conferenze da lui tenute nell’estate dell’anno precedente per il
Terzo Programma della Radio italiana; la recensione di Franchini dal titolo Una storia
dello storicismo uscì puntualmente su «Il Mondo» nel giugno del ’57 (rist. in Metafisica e
Storia, cit.).
60 «Il Giornale», quotidiano liberale come ben sottolineava Antoni, uscì a Napoli
dal 1954 al 1957. Fu fondato da Quinto Quintieri e Tommaso Astarita. Franchini
256
Logos
continuata attività giornalistica è stato un vantaggio. Ella è ad un punto
in cui deve concentrare i suoi spazi.
Non le ho neppure scritto che la prefazione al Suo nuovo libro mi
ha dato molta soddisfazione e mi ha trovato pienamente consenziente.
Attendo ora il libro61, di cui voglio occuparmi in un articolo sul «Mondo»
oppure in «Criterio» (che, dopo un intervallo dovuto a indisposizioni di
Ragghianti, riprende ora ad uscire). Sono d’accordo con Lei anche per
quanto riguarda i collaboratori del «Mondo», tra i quali la qualità non
corrisponde spesso alla quantità.
Tornato dalla villeggiatura – sono stato sul lago di Como e in
Svizzera -, ho avuto la sessione d’esami e una sessione del Consiglio
Superiore. Altra sessione di detto Consiglio è prevista per il 23 c.m. Alla
fine del mese sarò a Marburgo, invitato dai filosofi tedeschi a partecipare
ad un loro congresso e a intervenirvi con una conferenza. Cercherò
d’istruirli.
Con affettuosi saluti
Suo
Carlo Antoni
***
Roma, 14 febbraio 1958
Caro Franchini,
La ringrazio per aver pensato a me per una conferenza alla Società
filosofica di Napoli e ringrazio pure l’amico Carbonara e gli altri
componenti del Consiglio. La prego, anzi, di esprimere loro la mia più
viva gratitudine per un invito che mi lusinga. Ma è da un pezzo che non
accetto di tenere conferenze. Esse mi recano, infatti, molta tensione e
fatica: non amo leggere, ma il parlare richiede uno sforzo, che mi lascia
prostrato. La prego quindi di scusarmi presso la Società filosofica. Mi
auguro di vederla tra breve qui a Roma.
Con saluti affettuosi
Suo
Carlo Antoni
lavorò nella redazione del «Giornale» dal ’49 alla fine: vi era entrato su pressione e
interessamento dello stesso Croce.
61 Il libro di Franchini in uscita era Metafisica e Storia, edito poi nel ’58 presso
l’editore Giannini di Napoli.
Una scelta di lettere di Carlo Antoni a Raffaello Franchini
***
Roma, 20 marzo 1958
Caro Franchini,
ho una certa intenzione di muovermi per Pasqua, anche per
togliermi di dosso una certa malinconia e irritazione, ma penso che sarò a
Roma per l’assemblea dell’Associazione. In caso contrario La avvertirei
in tempo. Ho un vivo desiderio di parlare a lungo con Lei di molte cose,
anche perché mi vado sempre più isolando62: ciò che non fa bene alla
salute.
Con cordialissimi saluti
Suo
Carlo Antoni
***
Roma, 22 sett. ‘58
Caro Franchini,
La ringrazio anzitutto per il Suo interessamento al caso del ragazzo,
che Le avevo raccomandato. Ella ha fatto più di quanto potessi sperare.
Il trafiletto mi sembra andare benissimo: contiene alcune frecciate
brillanti. Naturalmente recherà un dispiacere al nostro Battaglia. Il quale
potrà sempre rispondere che l’organizzazione del Congresso è stata
diretta da un comitato, che conteneva fior di laici e che costoro sono
stati sempre consenzienti63. A mio avviso il difetto sta nell’assurdo di un
congresso filosofico, dove i filosofi laici, se decidono di intervenire, si
presentano necessariamente in ordine sparso, ciascuno con idee proprie,
mentre le chiese vi inviano schiere compatte e disciplinate. Ho pure
qualche riserva da fare sulle parole dell’amico Calogero, che hanno un
significato che non condivido: dialogare sta bene, ma bisogna guardarsi
dal ridurre la filosofia a mero dialogo, ché si rischia di ridurla ad un
attualismo del dialogare, dove il dialogo stesso diventa fine a sé stesso.
Ma questo è un altro discorso.
Con cordialità
Suo
Carlo Antoni
62 Trovano in un certo modo conferma le considerazioni sulla “nobile solitudine”
tipica di uno studioso schivo e riservato come fu l’Antoni. Rinvio alla Introduzione di
G. Sasso al Carteggio Croce-Antoni, cit., p. XVIII.
63 Ancora strascichi polemici sui Congressi di filosofia in Italia.
258
Logos
***
Roma, 3 dic. 1958
Mio caro Franchini,
in effetti quella mia frase sull’insolubilità del problema di Scaravelli è
piuttosto sibillina e può sembrare campata in aria. Mi piace molto che
Ella me ne faccia quasi un rimprovero. Tuttavia in una commemorazione
non potevo passare ad una critica e soprattutto non potevo affrontare
per mio conto l’intera questione64.
Il problema di Scaravelli era quello di dedurre il molteplice
dall’identico, cioè di scoprire o “capire” come la grande madre genera i
suoi figli. Era, insomma, il problema della creazione del mondo. Se
vogliamo, era anche il problema di derivare l’estetica dalla logica,
l’individuale esistenza dall’universale categoria. Questo, se non erro, era
per lui il problema del “capire”, che, come Ella ben vede, era insolubile.
Ma Ella vede anche che se avessi dovuto spiegare perché il problema era
mal posto, avrei dovuto tenere una vera e propria lezione.
Con saluti cordialissimi
Suo
Carlo Antoni
***
Roma, 8 gennaio 1959
Caro Franchini,
eccellente il Suo articolo su M. Weber65. Ella ha indubbiamente
ragione nel trovare un presupposto kantiano o neo-kantiano nella sua
teoria del tipo ideale. Io ne avevo avvertito la presenza, ma non vi avevo
insistito. Assai utile il Suo articolo per quei fessi in mala fede che
pretendono di scoprire Weber e di utilizzarlo, assieme a Dilthey, contro
64 Antoni aveva tenuto una splendida commemorazione di Luigi Scaravelli nella
Sala degli Stemmi alla Scuola Normale di Pisa il 23 novembre 1957. Scaravelli era
scomparso tragicamente nella primavera di quell’anno. Così Antoni scriveva a Franchini
in data 8 maggio ’57: «Ella avrà saputo della tragica morte del mio vecchio, carissimo
amico Scaravelli. Sono stato a Firenze ai suoi funerali. Era uno spirito amabile, brillante,
fine, buono e un galantuomo anche nelle cose filosofiche: era uno dei nostri ed io
contavo su di lui. Per me è una perdita dolorosissima».
65 L’articolo di Franchini su Weber e il “regresso” era uscito nel gennaio del ’59 su «Il
Mondo».
Una scelta di lettere di Carlo Antoni a Raffaello Franchini
Croce. Raramente il rancore, l’arrivismo, la petulanza hanno messo
insieme tanta stupidità. Ma che cosa credono di concludere con questa
impresa sballata?
Suo
Carlo Antoni
***
Roma, 3 marzo 1959
Caro Franchini,
penso anch’io che la Sua appartenenza alla Nunziatella possa essere
d’ostacolo ad un alleggerimento dei suoi incarichi scolastici, reso urgente
dai suoi incarichi universitari.
Ho ricevuto il Suo Kant66, ma Le devo confessare che non ho trovato
il tempo per leggerlo. Lo farò nei prossimi giorni.
Alla fine di gennaio sono stato a Zurigo, dove ho tenuto una
conferenza e ho parlato alla radio: è stata una gita splendida, un tempo
magnifico, nella Svizzera coperta di neve.
Suo
Carlo Antoni
Si tratta del volume: I. Kant, Critica della ragion pratica, a cura di R. Franchini,
Bari, Laterza, 1959.
66
Note
Alessandro Barbone
La teoria pitagorica dell’armonia celeste
Come gli occhi sono destinati all’astronomia,
così le orecchie sono destinate al moto armonico,
e l’astronomia e la musica sono sorelle,
come dicono i pitagorici.
Platone, Repubblica VIII 530 d
Una teoria dell’armonia celeste non è documentata nella filosofia
greca al di fuori della scuola pitagorica, e la ragione è essenzialmente
questa: l’armonia è anzitutto un fatto musicale, e il peso attribuito dai
pitagorici alla musica non si riscontra in nessun altro filosofo prima di
Platone, che non a caso riproporrà la teoria dei suoni celesti sotto le vesti
di un mito orfico-pitagorico nel racconto di Er l’armeno (Resp. X, 617 b).
Aristotele, per la caratteristica enciclopedica della sua opera, dove non
mancano i primi tentativi di storia della filosofia, ci offre un’interessante
testimonianza sul modo in cui i pitagorici intendessero l’armonia celeste:
«L’affermazione che dal moto degli astri si generi armonia, in quanto i
rumori da essi prodotti sarebbero tra loro consonanti, è una trovata graziosa
e originale, ma non corrisponde al vero. Credono infatti taluni [scil. i
pitagorici] che lo spostamento di corpi così grandi debba necessariamente
produrre rumore, poiché lo producono anche i corpi qui da noi, sebbene
non abbiano quella mole né si muovano con quella velocità. Ora, rotolando
il sole e la luna, e in più tanti astri, e così grandi, è impossibile che non si
produca un fragore straordinariamente grande. Ammesso ciò, e ammesso
inoltre che le velocità determinate dalle distanze stiano tra loro secondo i
rapporti delle consonanze, quei filosofi affermano che la rotazione degli
astri genera un suono armonioso. Ma poiché sembrerebbe strano che noi
non sentissimo questo suono, dicono che la causa di ciò è che esso esiste già
al momento in cui nasciamo, sicché non è reso percepibile dal contrasto col
silenzio; infatti le percezioni del suono e del silenzio sono correlative. E
come ai fabbri per la consuetudine sembra di non avvertire più il rumore
che fanno, così accadrebbe, secondo loro, a tutti gli uomini 1».
Aristot. De caelo B 9, 290b 12-291a 29 (VS 58 B 35 DK), trad. di A. Jori, in Aristotele,
De Caelo, Rusconi, Santarcangelo di Romagna, 1999.
1
264
Logos
Lo Stagirita non approva la teoria pitagorica dell’armonia degli astri,
perché essa invalida uno dei princìpi della sua astronomia, che cioè gli
astri siano fissi, mentre le sfere (i cieli) siano mobili di moto circolare, e
portino in circolo gli astri in esse conficcati. La spiegazione del perché gli
astri, pur così grandi e movendosi con una velocità più elevata di
qualsiasi altro corpo terrestre, non producano tuttavia alcun suono, è
fornita da Aristotele immediatamente dopo: sulla terra un corpo in
movimento produce un suono perché si muove in ciò che non si muove,
e solo in questa circostanza ci sarà l’urto (plhghv) necessario affinché
si produca un suono; gli astri, al contrario, si muovono sì, ma non in un
mezzo immobile bensì mobile e, ciò che più conta, mobile della stessa
loro velocità: in queste condizioni non si verifica quell’urto da cui si
genera il suono2. In una situazione siderale come quella descritta da
Aristotele, dunque, delle due condizioni necessarie e sufficienti per cui
possa prodursi un suono è presente il movimento ma manca l’urto. La
conclusione tratta dallo Stagirita è dunque che la teoria pitagorica
dell’armonia delle sfere è molto poetica, ma fantasiosa.
Se ascoltiamo Aristotele, dobbiamo credere che i pitagorici
attribuissero agli astri rotolanti, non alle sfere rotanti, la causa
dell’armonia siderale. Se però confrontiamo la testimonianza aristotelica
con un’analoga testimonianza di Porfirio, scorgiamo, al di là delle
notevoli somiglianze, una differenza proprio a proposito del movimento
delle sfere:
«Pitagora udiva l’armonia dell’universo, cioè percepiva l’universale
armonia delle sfere, e degli astri moventisi con quelle (th'“ tou'
panto;” aJrmoniva” hjkroa'to suniei;” th'“ kaqolikh'“
tw'n sfairw'n kai; tw'n katΔ aujta;” kinoumevnwn
ajstevrwn aJrmoniva”); la quale noi non udiamo per la limitatezza
della nostra natura (dia; smikrovthta th'“ fuvsew”)3».
Porfirio ha in mente il sistema astronomico comune alla sua epoca,
cioè quello aristotelico, che prevede sfere concentriche sulle quali sono
incastonati, come gemme, i corpi celesti. Ma mentre Aristotele ci dice
che solo al movimento degli astri i pitagorici assegnavano la causa dei
suoni siderali, Porfirio parla insieme delle «sfere, e degli astri moventisi
Aristot. De caelo B 9, 291a 6-28, trad. di A. Jori, in Aristotele, De Caelo, cit.
VS 31 B 129 DK (Porph. Vit. Pyth. 30), trad. di M. Timpanaro Cardini, in Ead.
Pitagorici. Testimonianze e frammenti, 3 voll., La Nuova Italia, Firenze, 1958-1964, I, p. 17.
L’espressione «th'“ kaqolikh'“ tw'n sfairw'n kai; tw'n katΔ
aujta;” kinoumevnwn ajstevrwn aJrmoniva”» si ritrova identica in Iambl.
Vit. Pyth., 65.
2
3
La teoria pitagorica dell’armonia celeste
con quelle» come cause dell’armonia celeste. Parrebbe anzi che qui il
ruolo principale venga assegnato proprio alle sfere, piuttosto che agli
astri. In verità, se la critica di Aristotele, nell’ottica del suo sistema
astronomico, può essere accettata, considerando i pianeti e non le sfere
cause degli urti siderali, essa può bensì essere aggirata se si prendono le
sfere quali corpi causanti gli urti, come fa Porfirio; le sfere, infatti, sono
allo stesso diritto dei pianeti, corpi in movimento, e siccome i movimenti
celesti si comunicano, secondo Aristotele, dal primo mobile sino al cielo
della Luna, che è l’ultimo in ordine di distanza dal primo motore e il più
vicino alla Terra, può ben essere ammesso un urto tra le sfere che si
muovono con velocità differenti. Perché era proprio questo
l’impedimento opposto da Aristotele a che si producesse l’urto tra i
pianeti e l’etere: entrambi si muovono della stessa velocità, come la nave
e il suo albero; ostacolo che, ci pare, verrebbe circuito se si ponessero
come corpi urtantisi le sfere: per meglio intenderci, qui noi pensiamo
quasi a uno sfregamento tra le sfere, che è indispensabile ammettere se
tra di essi reciprocamente i cieli si comunicano il movimento. Né questa
discussione risulta oziosa, dal momento che si tratta di capire in che
modo precisamente i pitagorici concepissero i movimenti e gli urti
siderali, e quindi la generazione di quell’armonia celeste che nessun
pitagorico avrebbe mai rinunciato a difendere, nonostante gravasse su di
essa la pesante e autorevole condanna di Aristotele. La questione
primaria da risolvere, dunque, è quale fosse il sistema astronomico
pitagorico, al quale s’attaglia la teoria dell’armonia celeste. Una
testimonianza assai celebre vuole che Pitagora sia stato il primo a
nominare l’ordine dei corpi celesti col nome di cosmo:
«Pitagora per primo chiamò l’insieme di tutte le cose cosmo, per l’ordine
che vi regna (prw'to” wjnovmase th;n tw'n o{lwn perioch;n
kovsmon ejk th'“ ejn aujtw/' tavxew”)4».
La notizia, secondo noi, è solo in parte verace: Pitagora usò
certamente il termine kovsmo” per indicare l’insieme di tutte le cose e
per il motivo spiegato da Aezio, ma non dové tuttavia essere il primo,
poiché questo temine, nel suo impiego cosmologico, è attestato almeno
in Anassimene5, che fiorì prima di Pitagora, in Eraclito6, che fu pressoché
contemporaneo del Samio, e ancora in Empedocle7 e Parmenide8, a lui di
VS 14 A 21 DK (Aet. II 1, 1), trad. di M. Timpanaro Cardini, in Ead., op. cit., I, p. 67.
Cfr. pure Diog. Laert. Vit. phil. VIII 48 (VS 28 A 44 DK).
5 VS 13 B 2 DK.
6 VS 22 B 124 DK.
7 VS 31 B 26 DK.
4
266
Logos
poco posteriori. La questione della priorità dell’impiego del termine
kovsmo” non c’importa però più di tanto, quel che ci preme
sottolineare è l’uso del termine in ambito pitagorico, per le sue
implicazioni con la teoria dell’armonia celeste: kovsmo” e
aJrmoniva, nel linguaggio astronomico pitagorico, vengono quasi a
coincidere per significato, l’armonia che i pitagorici riscontravano nei
fenomeni musicali non era che il riflesso terreno dell’armonia cosmica
verificata nei movimenti celesti, resa possibile dalla regolarità e
dall’ordine vigenti nel cosmo.
L’idea della sfericità del cosmo è assai antica e comune alla maggior
parte dei filosofi greci, così anche ai pitagorici9. Bisognava quindi
decidere quale pianeta posizionare nel mezzo dello sfero. A questo
proposito la scuola pitagorica non ha espresso opinioni unanimi nel
corso della sua storia. Una tradizione molto consolidata nella Scuola
poneva al centro del mondo il fuoco cosmico; questa teoria la si ritrova
soprattutto in Filolao10, ma noi crediamo sia presente in germe già in
Ippaso11, che al fuoco assegnava un ruolo cosmogonico identico a quello
attribuitogli dal contemporaneo Eraclito12. Ma Filolao elaborò la teoria
del fuoco cosmico, che posizionò al centro dello sfero, per ragioni che
esulano da qualsiasi discorso fondato sull’osservazione dei fenomeni;
anzi, proprio dalle speculazioni del “correligionario” Ippaso e di Eraclito
sul ruolo cosmogonico del fuoco, il filosofo crotoniate dovette essere
indotto ad assegnare quel posto al fuoco. La teoria del fuoco cosmico
centrale non fu però quella dominante né nella scuola pitagorica, né
altrove, soprattutto dopo la sanzione apposta da Aristotele sulla
centralità della Terra. Il fatto è che l’osservazione comune ci presenta la
Terra immobile e gli astri che le ruotano attorno in circolo, e viene
immediatamente di concludere, in assenza di osservazioni più accurate e
di geniali intuizioni, che in un cosmo sferico la Terra è posta al centro,
attorno al quale ruotano tutti gli altri astri. Il primitivo pitagorismo fu
sostenitore di una cosmologia geocentrica13.
Ai fini dell’armonia celeste, però, sia che la Terra venga posta al
centro dello sfero, sia che venga pensata mobile intorno a un fuoco
VS 28 B 8 DK.
Cfr. VS 12 A 26 DK; VS 31 B 28 DK; VS 31 A 20 DK; VS 31 A 27 DK. Plat. Tim. 33
b; 62 d-63 a; Aristot. De caelo, B 4, 286 b 10-287 b 21; B 13, 295 b 10-296 a 23.
10 VS 44 A 16 DK, VS 44 A 21 DK, e VS 44 B 7 DK.
11 VS 18 A 7-8 DK.
12 Test. 30-32, 38-40 in Eraclito. I frammenti e le testimonianze, a cura di G. Diano-Serra,
Milano, Mondadori, 2002, pp. 74-76.
13 Cfr. Diog. Laert. VIII 25.
8
9
La teoria pitagorica dell’armonia celeste
centrale, non cambia nulla, se non il numero dei pianeti “utili”
all’armonia, che nemmeno è elemento da trascurare. Solo che né per
Filoalo, né per Ippaso, né per qualcun altro dei pitagorici più antichi si
parla mai nelle fonti di armonia celeste, se si esclude la testimonianza
molto romanzata di un Pitagora capace di tendere le orecchie fino a udire
il suono armonioso degli astri. In effetti il primo riferimento alla teoria
dell’armonia celeste si trova nella Repubblica di Platone14, che però
l’attribuisce genericamente ai pitagorici, come anche Aristotele nel De
caelo15. Questi due testimoni sono più che sufficienti perché si possa
parlare di una teoria professata almeno dai pitagorici del V sec.
Per quanto riguarda il numero dei corpi celesti e delle rispettive sfere
orbitanti nel cosmo, esso era comunemente fissato a otto: la Luna, il
Sole, i cinque pianeti, cioè Venere, Mercurio, Marte, Giove e Saturno, più
il cielo delle selle fisse, secondo l’ordine più diffuso16. Questa serie dei
corpi celesti si ritrova, per esempio, nel sistema astronomico di Filolao,
che però, avendo posto al centro del cosmo il fuoco, pensava mobile
anche la Terra, e ai nove cieli visibili aggiungeva il decimo invisibile
dell’Antiterra17. La stessa serie fu condivisa da Platone nel Timeo (38 c-e),
e nel mito di Er contenuto nel X libro della Repubblica (616 c-617 b),
nonché da Aristotele nel De caelo (B 10, 291 a 29-291 b 10), che non si
preoccupa di fornire egli stesso uno schema dell’ordine degli astri, perché
condivide quello fornito dai trattati astronomici di chi lo ha preceduto
nello studio del cielo: in particolare egli ricorda, quasi come un’autorità in
questo campo, i matematici (oiJ maqhmatikoiv), e si potrebbe
pensare che si tratti dei pitagorici, nonostante le numerose polemiche che
contro di essi Aristotele intavola in quest’opera.
Ritornando alla testimonianza aristotelica del De caelo, due passaggi di
quel brano vanno ora ben ponderati, per capire in che modo i pitagorici
concepissero la generazione dell’armonia dal moto degli astri; si tratta dei
due passaggi in cui Aristotele mette in rapporto l’armonia prodotta dagli
astri con la loro velocità di rivoluzione determinata dalle diverse distanze
dalla Terra, e questi rapporti sono tali che i suoni siderali risultino
consonanti:
«[Affermano che] dal moto degli astri si generi armonia, in quanto i rumori
da essi prodotti sarebbero tra loro consonanti [...] [e che] le velocità
VII 530 d, X 616 c-617 c.
B 9, 290 b 12-291 a 10.
16 Per le varianti tardo-antiche dell’ordine dei corpi celesti, cfr. J. L. E. Dreyer, Storia
dell’astronomia da Talete a Keplero, trad. it. di L. Sosio, Milano, Feltrinelli, 1970, p. 38.
17 Alex. in Metaph. A 5, p. 38, 20 Hayd., e VS 44 A 16 DK.
14
15
268
Logos
determinate dalle distanze stiano tra loro secondo i rapporti delle
consonanze18».
Una cosa è dunque chiara: per i pitagorici, tanto amanti di
corrispondenze e analogie numeriche a livello cosmico, se il cielo
produce le stesse armonie che si possono ascoltare sulla Terra, le regole
armoniche in base alle quali tali armonie sono prodotte saranno le stesse
per entrambi i luoghi. Se dunque un’armonia si ha solo in presenza di
suoni consonanti, i suoni degli astri dovranno tra di loro essere
consonanti alla perfezione, e cioè stare tra di loro secondo i rapporti di
ottava, quarta e quinta; e se, inoltre, l’altezza dei suoni, più acuti o più
gravi, dipende dalla lunghezza delle corde (o, negli auli, dalla distanza dei
fori dall’imboccatura), allora, per analogia, nel cielo l’altezza dei suoni
dipenderà dalla distanza dei pianeti dalla Terra; ma è anche vero che
l’altezza dei suoni dipende dalla velocità del movimento sonoro: dunque
saranno più acuti i suoni prodotti da quei pianeti che si muovono a una
velocità maggiore. Ciò detto, l’affermazione del Reinach, che «non è
l’astronomia che ha dettato le sue condizioni alla musica, al contrario, è
la pratica musicale che ha lasciato traccia nelle teorie astronomiche»19, la
quale a prima vista potrebbe sembrare esagerata, si comprende
chiaramente almeno per quanto riguarda le distanze dei pianeti e le loro
velocità, che dipendono dalle leggi dell’acustica. Tutto questo è
confermato da Alessandro di Afrodisia, il quale, da ottimo
commentatore, sviluppa più ampiamente le questioni affrontate da
Aristotele20.
Se si vuole gettare una luce sulla mentalità pitagorica che è all’opera
in queste speculazioni astronomiche musicali e matematiche allo stesso
tempo, bisogna chiamare in causa un principio di analogia: solo in base a
una pretesa analogia vicendevole di tutte le parti del cosmo, si capisce
perché i pitagorici sostennero a spada tratta, anche contro l’autorità di
Aristotele, l’armonia cosmica. Il loro ragionamento doveva essere
pressappoco questo: poiché sulla terra urto e movimento di corpi
generano un suono, e poiché i corpi celesti movendosi urtano l’aria, ci
deve essere un qualche suono anche in cielo; gli astri sono entità divine,
eterne e incorruttibili, dunque i suoni da essi prodotti non possono
essere suoni qualsiasi, ma devono generare un’armonia altrettanto divina
e perfetta; poiché le regole dell’armonia valgono universalmente – è
De caelo, B 9, 290b 12-291a 29, trad. di A. Jori, in Aristotele, De Caelo, cit.
T. Reinach, La musique des sphères, in «Revue des études grecques» 13 (1900), 432-449,
p. 438. Cfr. inoltre P. Boyancé, Le culte des muses chez les philosophes grecs, Paris, Edition E.
de Boccard, 1972, p. 102.
20 Alex. ad h. l. p. 38, 10 Hayduck.
18
19
La teoria pitagorica dell’armonia celeste
inconcepibile, infatti, che vi siano altri numeri che esprimano diversi
rapporti armonici per i suoni celesti –, allora le velocità dei pianeti e le
loro distanze reciproche, non apprezzabili altrimenti, devono rispettare le
leggi dell’acustica e poter esser ricavate, nei loro rapporti, dai rapporti
delle consonanze musicali. Aristotele e il suo commentatore Alessandro,
nel riferire la teoria dell’armonia celeste dei pitagorici, seguono proprio
questo schema. Alessandro aggiunge anche un esempio del modo in cui
procedevano i pitagorici: assegnavano alla distanza dalla Terra alla Luna
l’unità, e dicevano che la distanza del Sole dalla Terra era il doppio della
prima, le due distanze stavano cioè nel rapporto di 2:1, che è il rapporto
dell’ottava: il Sole, pertanto, nel suo girare attorno alla Terra, dava un
suono che era più acuto di un ottava rispetto a quello emesso dalla Luna;
Venere, invece, trovandosi a una distanza tripla dalla Terra rispetto alla
Luna, emetteva un suono che era nel rapporto di 3:1 con quello della
Luna (cioè si trovava a una distanza corrispondente all’intervallo di
quinta aggiunta all’ottava, ovvero di dodicesima) e di 3:2 con quello del
Sole (si trovava, cioè, a distanza di una quinta). Così, procedendo per
tutti i pianeti, stabilivano il suono emesso da ciascuno in rapporto alle
velocità di rivoluzione e alle distanze reciproche.
Il problema delle distanze siderali connesso alla teoria dell’armonia
celeste ritorna pure nel Timeo platonico (35 a-c). Siamo al punto in cui
Platone illustra i criteri che il demiurgo seguì per la divisione dell’anima
del mondo, quando compare una serie di numeri rappresentanti il
rapporto tra le parti in cui l’anima del mondo fu divisa: i numeri sono 1, 2,
3, 4, 8, 9, 27: si tratta di due serie geometriche (1, 2, 4, 8 e 1, 3, 9, 27), la
prima costituita da intervalli doppi (diplavsioi), la seconda da intervalli
tripli (triplavsioi). È opinione che Platone abbia voluto attribuire alla serie
numerica 1, ..., 27 un significato musicale21: il filosofo, nell’ambito di un
Cfr. A. E. Taylor, A commentary on Plato’s Timaeus, Oxford, Clarendon Press, 1928, pp.
138-140. L’idea del Taylor è che il numero 27 possa essere pensato come un rapporto
27 : 1, e che tale rapporto esprima un intervallo musicale costituito di quattro ottave più
una quinta più un tono maggiore (16/1 + 3/2 + 9/8 = 27/1). La scala di Platone
risulterebbe assai più ampia di quella ammessa da Aristosseno circa un secolo più tardi,
la quale si estendeva per due ottave e una quinta; questo elemento rende problematica
l’interpretazione della serie numerica del Timeo come rappresentazione di una scala
musicale, conoscendo le riserve che frequentemente Platone ha espresso sull’evoluzione
musicale, accusata di corrompere i costumi: come poteva poi lui stesso essere artefice di
un ampliamento della scala così notevole? Si può allora ipotizzare che qui Platone abbia
semplicemente voluto offrire, nell’ambito del mito, un modello matematico del cosmo,
senza troppo soffermarsi sulle sue implicazioni musicali, che invece sono il principale
obiettivo nella ulteriore suddivisione degli intervalli, la quale rispetta perfettamente la
scala musicale di Filolao. Cfr. inoltre F. M. Cornford, Plato’s cosmology, London,
Routledge and Kegan, 1937, pp. 66-70; L. Brisson, Platon. Timée, Critias, Paris,
21
270
Logos
mito cosmologico connesso alla teoria pitagorica dell’armonia celeste,
volle rappresentare in quei numeri le distanze tra i pianeti; il debito che
Platone dové alla tradizione matematica pitagorica si evince anche da
questo passo del Timeo, dove il filosofo ateniese assegna astrattamente e
aprioristicamente, alle distanze tra i pianeti, dei numeri che hanno il solo
pregio di rispettare delle proprietà matematiche, ma non hanno niente a
che vedere con effettive misurazioni astronomiche o con scale musicali
praticamente impiegate ai suoi tempi. L’unico vero obiettivo del
pitagorico Platone è ritrovare nell’ordinamento divino dell’universo il
kovsmo” tanto osannato dalla scuola italica, e il solo modo che un
pitagorico concepiva per descrivere l’ordine era esprimerlo mediante
numeri e proprietà matematiche.
Il testo platonico prosegue con l’esposizione delle relazioni
matematiche in base a cui il demiurgo procedette alla suddivisione degli
intervalli tra le parti, cioè tra i pianeti: si tratta delle due medietà
tradizionalmente riscontrate dai pitagorici nei rapporti degli intervalli
musicali, la medietà armonica e la medietà aritmetica, con le quali, dice il
testo, vengono «riempiti» gli intervalli doppi e tripli, in modo che ciascun
intervallo sia diviso da un medio armonico e da uno aritmetico. Che
significa tutto questo discorso? Che ognuno degli intervalli iniziali (1:2,
1:3, etc.) si trova suddiviso in intervalli più piccoli, secondo i rapporti 3:2
(hJmiovlion), 4:3 (ejpivtriton) e 9:8 (ejpovgdoon), che sono
rispettivamente i rapporti degli intervalli di quinta, di quarta e di tono. E
volendo procedere all’ennesima suddivisione, il dio «riempì» gli intervalli
maggiori (3:2 e 4:3) con tante volte quello minimo (9:8), in modo che da
quest’ultima divisione risultasse ancora un’altra piccola parte, la più
piccola questa volta, pari a 256:243, che non è altro che la diesis. A questo
punto il demiurgo dovette rendersi conto che non era possibile andare
avanti nella suddivisione dell’anima del mondo, e perciò si fermò qui.
Questa suddivisione della scala musicale impiegata da Platone era
quella teorizzata da Filolao22 (44 B 6 DK), che evidentemente aveva fatto
Flammarion, 1992, pp. 284-287; P. Varvaro, Studi su Platone, 2 voll., Palermo, Mori,
1965-1967, II, pp. 1540-1564.
22 VS 44 B 6 DK: «La grandezza armonica [l’ottava] (aJrmoniva” de; mevgeqo”)
è formata dagli intervalli di quarta (sullabav) e di quinta (diΔ ojxeia'n); la
quinta è maggiore della quarta di un tono (ejpovgdoon). Infatti dalla corda più alta
(hypate) alla media (mese) c’è una quarta; dalla media all’ultima (nete) c’è una quinta; poi
dall’ultima alla terza (trite) c’è una quarta, e dalla terza alla più alta una quinta.
L’intervallo tra media e terza è di un tono. La quarta è espressa dal rapporto epitrito
(4:3), la quinta dall’emiolio (3:2), l’ottava dal doppio (2:1). Così la scala armonica
(aJrmoniva) comprende cinque toni e due semitoni minori (dievsei”); la quinta
La teoria pitagorica dell’armonia celeste
scuola ed era stata assunta come suddivisione canonica dell’ottava23. Del
resto, Proclo, nel suo Commento al Timeo, non mancò di notare che «la
maggior parte dei termini [degl’intervalli] scritti nel Timeo derivano
manifestamente da Filolao»24. Platone, per il quale l’uomo ajcovreusto”,
cioè non educato nella coreiva (l’insieme di danza, canto e musica), è
assolutamente ajpaivdeuto”, cioè non educato affatto25, doveva ben
conoscere le teorie musicali dei massimi esperti in materia, cioè i
pitagorici, e quindi il modo da essi adottato di suddividere l’ottava in toni
e semitoni: le teorie musicali dei pitagorici, se avevano fatto presa su
Platone, dovevano senza alcun dubbio godere di una stabile e inconcussa
autorevolezza, la quale, per mezzo dell’adesione da parte di un filosofo del
calibro dell’Ateniese, da autorevolezza dovette diventare presto autorità,
fissandosi in numerosi trattati, quali quelli di Aristosseno e Euclide.
Ritornando alla serie numerica 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27, se essa va
interpretata, come crediamo, nell’ottica della teoria dell’armonia celeste,
non si può non integrarla al sistema astronomico platonico secondo il
quale, come si evince dal mito di Er, anche l’ultimo cielo, quello delle
stelle fisse, produce un suono. Presentiamo qui la nostra interpretazione
della serie numerica del Timeo, la quale in alcuni punti si discosta da quelle
già offerte da altri studiosi:
Platone pose come distanza unitaria di riferimento quella tra i primi
due pianeti più vicini alla Terra, vale a dire la Luna e il Sole, e proseguì poi
assegnando i rimanenti numeri della serie alle distanze tra gli altri pianeti,
secondo l’ordine stabilito dagli astronomi del suo tempo e che risulta
anche da altri passi delle sue opere26: Sole-Venere (2), Venere-Mercurio
(3), Mercurio-Marte (4), Marte-Giove (8), Giove-Saturno (9), SaturnoCielo delle stelle fisse (27). In altre parole, la distanza tra il Sole e Venere è
doppia di quella tra la Terra e la Luna, quella tra Venere e Mercurio è
tripla, e così via. Quest’interpretazione ci sembra supportata dalle parole
che Platone scrive poco oltre, al passo 36 d: «...divise sei volte il
movimento interno facendone sette circoli disuguali, secondo gl’intervalli
tre toni e un semitono minore; la quarta due toni e un semitono minore», di M.
Timpanaro Cardini, in Ead., op. cit., II, pp. 207-211.
23 Cfr. P. Tannery, A propos des fragments philolaïque sur la musique, in «Revue de philologie,
de littérature et d’histoire anciennes» 28 (1904), 233-249, pp. 241-242, e C. A. Huffman,
Philolaus of Croton Pythagorean and Presocratic, Cambridge, Cambridge University Press,
1993, pp. 149-151.
24 VS 44 A 26a DK.
25 Leg. II, 654 a. Cfr. E. Moutsopoulos, La musica nell’opera di Platone, trad. it. di F. Filippi,
Milano, Vita e Pensiero, 2002, pp. 186-252, e J. Stenzel, Platone educatore, trad. it. F.
Gabrieli, Bari, Laterza, 1936, pp. 60-78.
26 Tim. 38 c-e, Resp. X 616 c-617 b.
272
Logos
del doppio e del triplo...»: il «movimento interno», chiamato in altri luoghi
del dialogo «circolo dell’altro» (38 c) è quello che comprende le sette
orbite dei sette pianeti, i «sette circoli» sono ovviamente le orbite dei sette
pianeti, mentre gli «intervalli del doppio e del triplo» sono rispettivamente
la serie geometrica originata dal numero due, e la serie geometrica
originata dal numero tre, cioè i numeri della nostra serie 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27;
in questo passo manca il cielo delle stelle fisse, che è l’ottavo circolo,
limite estremo del settimo “spazio siderale” (espresso dal numero 27),
perché non fa parte del circolo dell’altro, bensì costituisce da solo il
circolo del medesimo27, che mescolato col circolo dell’altro e coll’essenza,
aveva dato i sette “spazi siderali” visti sopra. Il motivo per cui secondo
noi Platone escluse dal conto delle distanze la Terra, cioè considerò non
otto “spazi siderali”, bensì sette, cominciando dal cielo della Luna, risiede
nell’intento che egli si era assunto procedendo alla descrizione del cielo
secondo un sistema astronomico che non aveva formulato lui, ma aveva
ereditato da un circolo pitagorico: quello di descrivere il movimento dei
pianeti e delle rispettive sfere attorno alla Terra, unico corpo celeste
immobile posizionato al centro dello sfero, di spiegare cioè in maniera
particolareggiata quel moto di rivoluzione attorno a un centro, unico
perfetto tra i sette (34 a), che il demiurgo aveva voluto assegnare al cielo.
Per questa prima ragione Platone, pensiamo, non considerò la Terra,
perché essa non è dotata di quella specie di moto propria a tutti gli altri
corpi celesti. Ma una seconda ragione, che poggia sulla prima e di quella
assai più importante, era che rimanendo immobile, la Terra non genera
alcun suono, a differenza degli altri astri il cui continuo e ininterrotto
moto di rivoluzione attorno alla Terra genera una perenne armonia
cosmica. Per quale altra ragione, altrimenti, Platone avrebbe diviso le
distanze tra i pianeti secondo gli intervalli della scala musicale diatonica di
Filolao, se non perché egli credeva, come aveva appreso da qualche
pitagorico, che il movimento degli astri dà vita a un’armonia celeste?
Bisognava dare una risposa alla domanda perché un astro desse un suono
piuttosto che un altro. Nel racconto di Er la spiegazione era stata affidata
al mito delle Sirene, ognuna delle quali produce un’unica nota sempre
della stessa altezza e della medesima intensità. Evidentemente nel Timeo,
opera successiva alla Repubblica, Platone volle fornire, sempre sotto la
veste del mito, una spiegazione più scientifica del fenomeno, e ricorse alle
teorie di qualche circolo pitagorico che facevano leva sulle distanze e le
velocità dei pianeti per dar ragione della diversa altezza dei suoni siderali.
27
Cfr. P. Varvaro, Studi su Platone, cit., I, p. 977.
La teoria pitagorica dell’armonia celeste
Una simile spiegazione la danno J. L. E. Dreyer28, T. Reinach29 e A.
E. Taylor30, ma tutti assegnano i numeri della serie 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27 ai
raggi delle orbite planetarie, ognuno dei numeri cioè corrisponderebbe
alla distanza di un pianeta dalla Terra; ma, essendo sette i numeri della
serie, essi devono escludere dal novero dei cieli quello delle stelle fisse,
compromettendo la completezza del sistema astronomico di Platone, e,
ciò che per noi più conta, finiscono per spezzare l’armonia celeste di cui,
come sappiamo dal mito di Er, il cielo delle stelle fisse produce l’ottavo
suono. Nessuno dei tre sembra curarsi dell’inconveniente. Dreyer, infatti,
affermava che nel Timeo «Platone... non sembra condividere la credenza
pitagorica nei suoni musicali prodotti dal moto dei pianeti»31. Noi siamo
di opinione diversa. Il Reinach, dal canto suo, sosteneva che «è un fatto
molto curioso che nella ricca collezione delle varietà di queste scale
siderali, non ce n’è nessuna, ad eccezione del tipo falsamene attribuito da
Boezio a Cicerone, che si compone di otto suoni: si passa senza
transizione dalla scala di sette suoni [...] a quella di nove suoni»32; e
qualche pagina prima aveva detto che «un po’ di attenzione basta a
mostrare che i differenti tipi proposti per la melodia delle sfere non sono
altro che la proiezione, nello spazio infinito, delle scale che furono in un
dato momento più in voga sul nostro piccolo pianeta, o piuttosto nel
piccolo mondo greco»33. Ora, una scala a otto suoni esisteva fin dal
tempo di Filolao, e una teoria dell’armonia delle sfere fondata su una
scala di otto suoni è proprio quella presentata nel mito di Er! Taylor,
infine, pur notava che «Timeo prudentemente si astiene dal dire qualcosa
circa la distanza dell’ajplanev” [il cielo delle stelle fisse] dal centro, o, ciò che
è lo stesso, la misura dell’oujranov”»34, e che, benché «egli lasci la
distanza dell’ajplanev” dal centro pienamente indeterminata,
difficilmente possiamo dubitare che egli abbia voluto assegnare
all’ajplanev” un ruolo nella musica [celeste]»35. Ma la stranezza di tutto
questo discorso, secondo noi, sta proprio in ciò che Taylor pare giudicare
normale, cioè che Platone-Timeo, pur attribuendo al cielo delle stelle
fisse un ruolo nella scala cosmica, riportando i numeri di questa scala,
soltanto all’ultimo cielo non ha assegnato un numero. E perché?, «perché
J. L. E. Dreyer, Storia dell’astronomia..., cit., pp. 56, 62.
T. Reinach, La musique des sphères, cit., pp. 445-447.
30 A. E. Taylor, A commentary on Plato’s Timaeus, cit., pp. 162-167.
31 J. L. E. Dreyer, Storia dell’astronomia..., cit., p. 56.
32 T. Reinach, La musique des sphères, cit., p. 438.
33 Id., p. 434
34 Id., p. 164.
35 Id., p. 167.
28
29
274
Logos
è troppo più lontano rispetto al più remoto dei pianeti»36. Forse che gli
antichi potevano stimare la distanza dei pianeti diversamente che
immaginandosela? E come Platone si era figurato che le distanze dei
pianeti corrispondono ai numeri di due progressioni matematiche, allo
stesso modo poteva assegnare un numero anche al cielo delle stelle fisse:
per esempio, procedendo nella serie geometrica del 3, assegnargli il
numero 81.
Il passo di Alessandro di Afrodisia richiamato poco sopra37 potrebbe
mettere in discussione e invalidare questa nostra interpretazione della
serie numerica del Timeo. Alessandro infatti, commentando la teoria
dell’armonia celeste dei pitagorici, scrive che «essi dicevano, poniamo,
che la distanza del sole dalla terra è il doppio di quella della luna, il triplo
quella di Venere, il quadruplo quella di Mercurio, etc.». Stando a queste
parole, l’interpretazione corretta dovrebbe essere quella sostenuta dal
Dreyer, dal Reinach e dal Taylor, benché non sia pacifico che Alessandro
abbia voluto intendere i raggi orbitali piuttosto che le distanze reciproche
trai pianeti38. Per quanto ci riguarda, alla ragione principale che abbiamo
portato a sostegno della nostra ipotesi, – e cioè che, se Platone nel Timeo
voleva abbracciare la teoria pitagorica dell’armonia degli astri, non poteva
computare sette distanze per sette cieli, corrispondenti a sette suoni,
perché in tal caso mancherebbe l’ottavo suono prodotto dal cielo delle
stelle fisse, altrove presente nell’opera di Platone (mito di Er) –,
aggiungiamo che le tradizioni sulle distanze siderali erano diverse, e può
essere che alcuni pitagorici, tra i quali quelli menzionati da Alessandro
che seguivano il sistema filolaico, calcolassero i raggi delle orbite
planetarie, altri invece, seguiti da Platone, le distanze reciproche tra i
pianeti.
Dobbiamo ora affrontare la questione della velocità dei pianeti e
della loro distanza in rapporto all’altezza dei suoni emessi. La domanda è:
quali pianeti emettono i suoni più acuti, i più vicini o i più distanti dalla
Terra, ovvero i più veloci o i più lenti? Stando alle teorie acustiche dei
pitagorici, universalmente ammesse dagli antichi teorici musicali, il suono
acuto corrisponde a uno spostamento d’aria più repentino di quello d’un
suono grave; di conseguenza i pianeti dovrebbero emettere un suono
tanto più acuto quanto maggiore è la loro velocità di rivoluzione. Se però
ritorniamo alle prime teorie acustiche pitagoriche, secondo le quali
l’altezza del suono dipende dalla maggiore o minore lunghezza della
Id., p. 164.
Cfr. nota 20.
38 Questa perplessità manifesta, per esempio, M. Timpanaro Cardini, Pitagorici.
Testimonianze e frammenti, 3 voll., Firenze, La Nuova Italia, 1958-1964, III, p. 68 nota.
36
37
La teoria pitagorica dell’armonia celeste
corda, allora dovremmo stabilire un’analogia tra le distanze dei pianeti e
l’altezza dei suoni da essi emessi: siccome il suono prodotto da una corda
fatta vibrare per la sua intera lunghezza è più grave del suono emesso da
quella stessa corda, fatta però vibrare per una parte della sua lunghezza,
allora la stessa regola dovrebbe valere analogicamente anche per le
distanze siderali: maggiore è la distanza di un pianeta dalla Terra, più
grave è il suono da esso prodotto. Ma vediamo cosa ci dicono al riguardo
le fonti.
La testimonianza aristotelica del De Caelo ci conferma che i
pitagorici, per stabilire l’altezza dei suoni prodotti dal movimento dei
pianeti, ricorrevano ai princìpi della loro acustica, basata sui concetti di
distanza e velocità:
«I rumori da essi [cioè i pianeti] prodotti sarebbero tra loro consonanti... e
ammesso inoltre che le velocità determinate dalle distanze stiano tra loro
secondo i rapporti delle consonanze, quei filosofi affermano che la
rotazione degli astri genera un suono armonioso 39».
L’armonia delle stelle si basava dunque sulle consonanze. Sappiamo
che le consonanze riconosciute dagli antichi erano tre: l’ottava,
considerata la più perfetta tanto da esser chiamata aJrmoniva, la quarta e
la quinta. In seguito allo sviluppo della tecnica esecutiva e con la
complicazione delle regole melodiche, si era usciti dalla gabbia dell’unica
ottava, e ci si era aperti alle altre ottave, nel senso che vennero
riconosciuti come sinfoni anche quegli intervalli composti dagli intervalli
consonanti fondamentali: per esempio l’undicesima (un’ottava più una
quarta), la dodicesima (un’ottava più una quinta), la doppia ottava, e così
via. Le velocità di rivoluzione dei corpi celesti, determinate dalle distanze,
erano stabilite, ci dice Aristotele, proprio secondo i rapporti delle
consonanze; per cui dobbiamo pensare che i pitagorici ragionassero in
questi termini: un pianeta che rispetto a un altro si muove a una velocità
doppia, emette un suono che è di un’ottava più acuto rispetto al suono
prodotto dall’altro pianeta; un pianeta che rispetto a un altro si muove a
una velocità che è i 3/4 della velocità dell’altro pianeta, emette un suono
di una quarta più grave rispetto a quello emesso dall’altro pianeta; e
procedendo in questo modo dovevano stabilire il rapporti tra le altezze
dei suoni siderali – né ci è detto da alcuna fonte classica quali poi fossero
in effetti queste altezze.
Alessandro di Afrodisia aggiunge che per i pitagorici i pianeti più
lontani ruotano più velocemente, più lentamente i più vicini; in base a
39
De Caelo B 9, 290b 12-291a 29.
276
Logos
questi rapporti, i pianeti più vicini e più lenti producono un suono più
grave, i più veloci e più lontani un suono più acuto.
Bisogna aggiungere che le teorie pitagoriche riferite da Aristotele
sulla velocità degli astri in rapporto alla loro distanza erano condivise
dallo Stagirita stesso, e dovevano essere cognizione comune a quel
tempo se, come vedremo fra breve, anche Platone ne fa menzione. Nel
De caelo (II 10, 291 a 30-291 b 10), infatti, Aristotele rimanda alle
dimostrazioni fornite dagli astronomi e dai matematici, cioè i pitagorici.
Se facciamo un salto indietro, andando al mito di Er della Repubblica
(X, 616 c-617 d), che contiene il primo vero riferimento alla teoria
dell’armonia celeste, troviamo un discorso simile sulle velocità delle sfere
celesti in rapporto alle distanze, ma anche con qualche differenza
decisiva. Er racconta la struttura del fuso di Ananke che, fuori del mito,
rappresenta uno schema del planetario platonico, il quale prevede otto
sfere celesti mobili. La velocità di queste sfere è anche qui in rapporto
alle distanze, solo con una particolarità: dopo l’ottavo cerchio (la sfera
delle stelle fisse) che è il più veloce, il settimo cerchio (Saturno) ruota
della stessa velocità del sesto (Giove) e del quinto (Marte), in maniera tale
che il quarto cerchio (Mercurio) sembra occupare, per velocità, il terzo
posto, il terzo cerchio (Venere) il quarto posto, il secondo cerchio (il
Sole) il quinto posto – il primo cerchio (la Luna) non viene nominato,
ma deve comunque occupare il sesto e ultimo posto per velocità. Se si
passa al dialogo successivo alla Repubblica, cioè al Timeo, si ritrova la stessa
idea: ai sette circoli (qui è escluso quello delle stelle fisse) il demiurgo
impose diverse velocità, in modo che «tre avessero uguale velocità,
mentre gli altri quattro avessero velocità disuguale l’uno rispetto all’altro
e rispetto agli altri tre»40.
Sulla base di quanto abbiamo appreso dalle testimonianze di
ambiente aristotelico, che cioè per i pitagorici alle diverse velocità dei
pianeti corrispondono differenti suoni, dovremmo concludere che i tre
pianeti che per Platone si muovo della stessa velocità emettono sì tre
suoni distinti, ma tutt’e tre della medesima altezza, cioè tre suoni identici.
Nel mito di Er, Platone assegna a ognuna delle sfere celesti una Sirena
«che emetteva un’unica nota, con un unico suono; ma tutte otto insieme
formavano un’armonia» (X 617 b): volendo esser puntigliosi, qui Platone
non dice di che natura siano gli otto suoni emessi dalle Sirene, se tutti
diversi o meno; se però volessimo seguire il criterio delle velocità,
dovremmo concludere che la musica delle sfere platoniche si compone di
soli sei suoni differenti, che vanno a costituire un’unica armonia.
Tim. 36 d, trad. di E. Pegone, in Platone, Tutte le opere, 5 voll., a cura di E. V. Maltese,
Newton & Compton, Roma, 1997.
40
La teoria pitagorica dell’armonia celeste
Possiamo però aggiungere un’ulteriore notizia, che ricaviamo dalla Vita
pitagorica di Giamblico, la quale potrebbe farci superare la difficoltà
platonica dei tre suoni identici:
«[L’armonia è] il prodotto dei suoni celesti, i quali traggono sì origine
dalle ineguali e in vario modo tra loro differenti velocità, grandezza e
posizione dei corpi, ma sono nondimeno collocati in reciproca relazione nel
modo più armonico41».
I fattori che Giamblico chiama in causa per giustificare la
molteplicità dei suoni celesti sono tre, due dei quali ci erano già noti dalla
tradizione più antica, mentre il terzo, secondo nell’ordine dato da
Giamblico, ci era ignoto: parliamo, rispettivamente, della velocità e della
distanza dei pianeti, e della loro grandezza. Se ci appellassimo a questo
nuovo criterio della grandezza, potremmo risolvere il problema sorto in
ambito platonico riguardo ai tre pianeti (Saturno, Giove e Marte) che,
movendosi della stessa velocità, dovrebbero produrre la medesima nota:
se questi tre pianeti sono di diversa grandezza, pur viaggiando alla stessa
velocità, generano contro l’etere un urto di diversa entità, e di
conseguenza tre suoni di diversa altezza.
Né Platone, che pure abbracciava la teoria dell’armonia celeste, né
alcuno dei più antichi commentatori di questa teoria, come Aristotele o
Alessandro, ci hanno lasciato se non accenni riguardo a essa: le loro
notizie si limitano all’essenziale, e può ben darsi che abbiano trascurato
qualche aspetto della teoria, in presenza del quale l’avremmo potuta
comprendere nella sua pienezza. Riguardo a Platone, non ci è concesso
sapere di che tipo fosse l’armonia celeste, perché egli non precisa di quali
note essa sia composta: si limita a dire che ogni Sirena emette
inflessibilmente sempre la stessa nota. Il testo greco dice solo che gli otto
suoni «mivan aJrmonivan sumfwnei'n », espressione che
potremmo rendere così: «consuonano secondo un’unica armonia». Si
potrebbe pensare che si tratti anche in questo caso di suoni consonanti,
ma l’unico indizio che confermerebbe questa ipotesi è il verbo
sumfwnei'n. Un’altra ipotesi che potremmo avanzare si basa sul
modo differente d’intendere quell’espressione: il termine aJrmoniva,
nel linguaggio dei musicisti, stava ad indicare il modo di una melodia, se
frigio o dorico o lidio o altro42. Platone ha potuto voler dire, allora, che le
stelle producono una musica secondo un modo ben preciso, quale in
Iambl. Vit. Pyth., 65, trad. di M. Giangiulio, in Id., Pitagora. Le opere e le testimonianze, 2
voll., Mondadori, Milano, 2000.
42 Questo è il senso in cui Platone usa il termine aJrmoniva, tra gli altri luoghi, in
Resp. III 398 e.
41
278
Logos
particolare non ha potuto dircelo, perché nessuno l’ha mai sentita quella
musica. Quest’ipotesi non è affatto peregrina, perché anzi renderebbe
conto di due elementi costitutivi della teoria dell’armonia celeste presso
gli antichi: a) il fatto che i suoni emessi dagli astri siano sempre detti
consonanti, si accorda con l’ipotesi che la musica siderale rispetti uno dei
modi classici, le cui regole di composizione si fondavano sulle
consonanze; b) il fatto che la musica celeste è considerata divina per la
sua armoniosità, ma non si dà nessuna armoniosità con la produzione
simultanea degli otto suoni di una gamma musicale, mentre una melodia
che rispetti le regole di uno dei modi, risulta armoniosa per sua natura.
Un altro spunto di riflessione ci è offerto da una notizia
tramandataci da quasi tutti i testimoni della teoria dell’armonia celeste: ci
riferiamo alla ragione addotta dai pitagorici del perché sulla Terra non si
percepisce quell’armonia cosmica che pur dovrebbe avere un’intensità
enorme, date la mole e la velocità dei corpi celesti, vale a dire
l’insufficienza della nostra natura di uomini. L’argomento riferitoci da
Aristotele, e ripreso poi dal suo commentatore Alessandro, si basa sul
fatto che i suoni celesti sono eterni e continui, per cui noi nasciamo già
con tali suoni nelle orecchie, e non potendo mai percepire la differenza
tra la loro presenza e la loro assenza, per la nostra percezione è come se
non esistessero. L’esempio dei fabbri che s’abituano al rumore dei
martelli, fino a non accorgersene più, o l’esempio riportato da Cicerone
di quegli uomini che, vivendo sempre in prossimità di una cascata, non
ne percepiscono il rumore che per altri risulterebbe assordante43,
confermano che questa era la spiegazione più comune dello strano
fenomeno del “silenzio assordante” degli astri.
Il fr. VS 47 B 1 DK di Archita contiene un’altra possibile
spiegazione del fenomeno, alla base della quale c’è comunque la
limitatezza della nostra natura, ma declinata diversamente:
Molti di questi rumori non possono essere percepiti dalla nostra natura,
alcuni per la debolezza dell’urto, altri per la grande distanza da noi, alcuni
anche per l’eccesso stesso della loro intensità; perché non penetrano nel
nostro orecchio i rumori troppo grandi, così come anche nel collo stretto di
un vaso, quando vi si versi qualcosa in massa, nulla vi entra 44.
Ricordiamo che al principio di questo brano Archita aveva ammesso
di riferire i risultati cui erano giunti gli studiosi di cose matematiche suoi
predecessori, cioè i pitagorici. Delle tre ragioni per cui noi non
percepiamo certi suoni, la prima riguarda i suoni troppo piccoli, e quindi
43
44
Somnium Scipionis, 19.
Trad. di M. Timpanaro Cardini, in Ead., op. cit, II, p. 365.
La teoria pitagorica dell’armonia celeste
non fa al caso nostro; la seconda e la terza possono invece attagliarsi al
fenomeno dei suoni siderali: noi non li sentiremmo o perché troppo
lontani, o perché troppo intensi45. A noi interessa notare che questo
piccolo passaggio di Archita è per il nostro argomento una testimonianza
fondamentale. Da esso noi traiamo le seguenti conclusioni: a) quei rumori
troppo intensi, tanto da non poter essere percepiti, possono essere
soltanto i suoni emessi dai corpi celesti, che per la massa e la velocità di
rivoluzione dei loro generatori dovevano risultare straordinariamente
potenti; b) se Archita sta riferendo le conquiste dei pitagorici suoi
predecessori, vuol dire che già prima di lui la teoria dell’armonia celeste
era un insegnamento della scuola pitagorica. È curioso notare che Archita,
nel presentare gli studiosi di cose matematiche, li qualifica, prima ancora
che come aritmetici, geometri e musici, anzitutto come quelli che «sulla
velocità degli astri, sul loro sorgere e tramontare ci hanno fornito chiare
nozioni»: combinando insieme la notizia sullo studio della velocità degli
astri e quella sui suoni impercettibili per la loro eccessiva intensità, l’unica
conclusione che ci viene naturalmente di trarre e che quegli uomini
sapienti di cose matematiche avevano professato la teoria dell’armonia
celeste. Questa nostra conclusione è molto importante, perché ci consente
di retrodatare l’epoca della nascita dell’armonia celeste in seno alla scuola
pitagorica: almeno alla generazione di pitagorici anteriore ad Archita, cioè
all’epoca di Filolao. Quanto stiamo per dire ci induce, però, a ritenere che
la teoria dell’armonia celeste è stata addirittura un insegnamento della
prima cerchia pitagorica.
Nella Vita pitagorica (82) Giamblico, nel suddividere in tre specie gli
acusmata del catechismo del gruppo dei pitagorici acusmatici, riporta
questo acusma:
«Cos’è l’oracolo di Delfi? La tetractys, cioè l’armonia, nella quale sono le
Sirene (Tiv ejsti to; ejn Delfoi'“ mantei'on…
Tetraktuv”: o{per ejsti;n hJ aJrmoniva, ejn h/| aiJ
Seirh'ne”)46».
L’analogia tra tetractys e armonia si spiega notando che i numeri di cui
si costituisce la celebre figura pitagorica, cioè 1, 2, 3 e 4, che
costituiscono i rapporti numerici di consonanza: 2:1 e 4:1 esprimono
l’ottava, 3:2 la quinta, 4:3 la quarta. La tetractys è dunque il simbolo
numerico dell’armonia musicale.
45
46
Quest’ultima spiegazione ritorna in Censor. De die natali, XII 1.
Trad. di M. Giangiulio, in Id., op. cit.
280
Logos
Le Sirene sono esseri mitologici la cui indole musicale ci è nota fin
dall’Odissea, ma che nel mito platonico di Er trovano il loro impiego più
immediato nell’ambito di un discorso musicale. Se il Delatte aveva
ragione di credere che il mito di Er della Repubblica deriva dalle apocalissi
dei misteri orfico-pitagorici del VI-V sec., allora il ponte tra le Sirene del
mito di Er e quelle del nostro acusma è presto gettato: si tratta di un
acusma sull’armonia delle sfere, che avvalora ancor più la tesi della
dipendenza di Platone dalla tradizione pitagorica. Ma ciò per cui questo
acusma risulta maggiormente prezioso è che, in virtù della sua antichità,
esso testimonia che la teoria dell’armonia celeste era un possesso della
prima tradizione pitagorica47. L’ipotesi che il nostro acusma contenga un
riferimento all’armonia delle stelle ci è testimoniato indirettamente anche
da un antico teorico musicale e commentatore delle dottrine pitagoriche,
Teone di Smirne, vissuto tra il I e il II secolo d.C.:
«Alcuni poi dicono che sirene non si chiamino gli astri ma, secondo la
dottrina pitagorica, i suoni e le note prodotti dai movimenti di quelli, i quali
risultano armonizzati e consonanti, e dai quali si genera una musica
perfettamente armoniosa48».
L’acusma pitagorico riferitoci da Giamblico, però, contiene un
elemento che colla teoria dell’armonia celeste sembra non avere niente a
che vedere, ed è l’oracolo di Delfi. Un possibile legame tra Apollo, il dio
di Delfi e Pitagora è la credenza dell’antico pitagorismo che Pitagora
fosse l’incarnazione del dio delfico, da cui l’inverosimile etimologia,
sostenuta da qualche antico commentatore, che trae il nome di Pitagora
(Puq<agovra”) da uno degli attributi del dio (Puvq<io”)49. Il
Boyancé50 ricorda che tre statue campeggiavano sulla porta del tempio a
Delfi, le quali rappresentavano «“Muse” d’un tipo particolare, che
avevano i nomi delle corde della lira e forse certe caratteristiche delle
Sirene», mentre il Delatte, citando Pindaro, ricordava che «il tempio di
Apollo a Delfi, contemporaneo del poeta, era ornato, sulla facciata, di
Cfr. A. Delatte, La tétractys pythagoricienne, in Études sur la littérature pythagoricienne,
Genève, Slatkine Reprints, 1974, p. 260; P. M. Schuhl, Essai sur la formation de la pensée
grecque, Paris, Presses Universitaires de France, 1949, pp. 262-263; C. H. Kahn, Pitagora e
i pitagorici, in Le radici del pensiero filosofico, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana
Treccani, 1993, II, p. 23.
48 Theo Smirn. expos. rer. math., p. 147.
49 Iambl. Vit. Pyth. 7.
50 P. Boyancé, Note sur la tétractys, in «L’Antiquité classique», 20 (1951), pp. 421-425.
47
La teoria pitagorica dell’armonia celeste
statue dorate di Keledones, esseri favolosi che l’antichità ha identificato con
le Sirene»51.
Delatte, La tétractys pythagoricienne, cit., p. 261. Cfr. inoltre D. Musti, I Telchini, le Sirene,
Pisa-Roma, Ist. Editoriali e Poligrafici, 1999, passim, e V. Gigante Lanzara, Il segreto delle
Sirene, Napoli, Bibliopolis, 1986, passim.
51
Ciro Asproso
Giordano Bruno e il Dio in-esistente
Sembra che sia quasi inevitabile cedere alla retorica delle celebrazioni
e dei giudizi entusiastici, per chi si accosta, da laico, al pensiero di
Giordano Bruno, perché si ha sempre davanti agli occhi il martire e
l’icona del libero pensiero, ossia quello che il filosofo nolano è diventato
per la storiografia tradizionale. Probabilmente, ciò è dovuto alla nostra
indignazione di uomini abituati a vivere nella democrazia e nella
tolleranza e alla nostra paura di non essere capaci di avere, di fronte alla
violenza di un potere ottuso, il coraggio di operare la sua scelta. Ma,
anche il suo particolarissimo stile pregnante ed oscuro, che inquieta ed
esalta con una sorta di “ridondanza scarna”, contribuisce non poco alla
scelta della scorciatoia celebrativa, invece della faticosa ricerca del senso
autentico del suo filosofare: sembra che attraverso la pletora
dell’aggettivazione e dell’arditezza sintattica, Bruno voglia quasi
occultare, insieme per sfida e per paura, la scarna lucidità del messaggio
filosofico. Della sua vita si sa tutto, ormai. Fu monaco per vocazione, poi
gettò la tonaca alle ortiche, per amore del suo bel “sole intelligenziale”:
La voce del mio cor per l’aria sento:
ove mi porti, temerario ? China,
che raro è senza duol troppo ardimento.
Non temer, rispond’ io, l’alta ruina!
Fendi sicur le nubi e muor’ contento,
s’il ciel si illustre morte ne destina.
Fuse insieme neoplatonismo, pitagorismo, anassagorismo e
atomismo in una concezione panenteistica. Non fu, certamente, un
rivoluzionario, fu un ribelle; uno che nel tempo della confusa transizione
rinascimentale, seppe riproporre la filosofia socratica, come ricerca
“eroica” della verità. Fu antipedante fino alla pedanteria, polemico per
amor di pace: aveva qualcosa di simile all’ “orgoglio dei dannati” di cui
parla Baudelaire nei Fiori del male. Viaggiò per mezza Europa e si
considerava, in quanto filosofo, cittadino del mondo. Ebbe pochi seguaci
e scarsa attitudine all’organizzazione politica: si proclamò araldo di una
nuova religione, quella “egizia”, che, in fondo, era la sua “nolana
filosofia”, ma, in concreto, poté fare ben poco per diffonderla. Il suo
Giordano Bruno e il Dio in-esistente
merito più grande, secondo Cassirer, consiste nell’aver preparato
nell’ontologia ciò che Galilei porterà a compimento nella logica delle
scienze, con l’estensione della causalità matematica alla realtà fisica,
brunianamente unificata.
Per Bruno, l’intera realtà è materia intelligente che si autorganizza,
perfetta identità di movente e di mosso, di attivo e di passivo, di unità e
di molteplicità: in quanto unità, essa è relazione immediata e
metatemporale tra le parti, dunque Monade Divina; in quanto
molteplicità, è trama di rapporti mediati tra infinite individualità
originarie, i minimi, cioè, modalità del Divino, che pur restando se stessi,
cambiano identità - funzione, col variare del quadro di relazioni entro cui
sono inseriti, secondo la Giustizia della Vicissitudine eterna, o ruota del
Destino, vale a dire, dell’infinita attività dell’Intelligenza Universale, che
con il fenomenizzarsi, l’esteriorizzarsi, si manifesta a se stessa come Vita
ed infinita possibilità di essere. La realtà è la manifestazione del
comprendersi dell’Intelligenza, che è attività incessante, perfettamente
immobile nella sua identità. La “mano” organo de gl’organi di cui parla nella
Cabala del cavallo Pegasèo è “figura” del reale in atto, che è Materia
intelligente o Intelligenza che utilizza se stessa come materia, è
l’Intelligenza che esplora le sue possibilità, ed è “figura” dell’innesco del
circolo virtuoso della produzione del reale,così come , nell’uomo, il
configurarsi della mano rappresenta, in un “hic et nunc” il momento
dell’innesco del progresso, in vista della realizzazione di una delle infinite
possibilità, apicali e provvisorie, di espressione dell’esteriorità
dell’Intelligenza nel Finito.
Fu ateo, nel senso che viene dato al termine dalle Chiese cristiane e
dalla opinione comune: ciò appare evidente anche se si legga, delle sue
opere, soltanto il Candelaio, opera nella quale si ridicolizza la concezione
della Divinità, secondo la religione: si pensi alla “Pulvis Christi” (la
polvere di … Gesù Cristo) e al «luto delle potte sudate al viaggio di
Piedigrotta!». Il pellegrinaggio delle donne alla Madonna di Piedigrotta,
per lui, non è altro che un sudar di «potte»!
«Cenc.: Dovete saper, per la prima, che messer Bartolomeo, li ebbe
tutta la ricetta in mano, dove si contiene ed il modo di operare e le cose
che vi concorreno; lui mandava al speciale per le cose che bisognano, il
suo putto; lui è stato presente al tutto che si faceva; lui faceva tutto; e da
me non volea altro che la dechiarazione, con dirgli: Fa’ in questo modo,
fa’ in quello, non far cossì, fa’ colà, or applica questo, or togli quello: - di
sorte ch’al fin con allegrezza grande ha ritrovato l’oro purissimo e
probatissimo al fondo della vitrea cucurbita, rinsaldata luto sapientiae […]
284
Logos
Gio.B.: Luto della polvere delle potte sudate al viaggio di Piedigrotta!»
(Candelaio, Atto I, Scena XI).
A proposito del Candelaio vale la pena di sottolineare che senza
blasfemia (dal verbo greco βλάπτω, impedire, nuocere, offendere,
invalidare, ostacolare, smentire, danneggiare, avere il coraggio di
contestare, ma anche calunniare, dire il falso, per Bruno, nel significato di
smentire energicamente), senza “parresia” (linguaggio libero, sboccato,
veritiero, coraggio di parlare) e “anaideia” (comportamento libero,
licenzioso, osceno, coraggio di agire), elementi costitutivi del
comportamento “cinico” (Bruno spesso si definisce “cinico”, nel
significato più autentico del termine), la commedia non avrebbe spessore
e originalità perché consisterebbe in una trama più che scontata ed in un
assunto filosofico poco persuasivo.
Si tratta di blasfemia ? Decisamente, sì!
La “parresia”, il linguaggio sboccato e irriverente, appunto come la
“parresia” dei cinici, ha fatto storcere il naso a parecchi studiosi
perbenisti ed “accademici” che con l’accusa di “blasfemia” (intesa come
mancanza di rispetto per la religione e l’autorità) rivolta a Bruno, hanno
contribuito non poco alla scarsa comprensione della sua filosofia e
soprattutto hanno impedito che si potesse riconoscere la grandezza e la
poesia di quel capolavoro della letteratura mondiale che è il Candelaio, una
sorta di “satura”, di pot-pourri filosofico, a cui Bruno volle dare la
“veste” di commedia, quasi come un’esplicitazione di senso della frase:
“in tristitia hilaris, in hilaritate tristis”. D’altra parte, il ricorso al
linguaggio “popolare e antiaccademico” (osceno?) nolano-napoletanolatino-francese è quanto di più tipico dello stile bruniano che, appunto, si
definisce «academico di nulla academia». E il gusto dell’antiaccademismo
lo si ritrova, spesso, anche in opere latine: all’inizio del Dialogo Quarto
del De la Causa, Principio e Uno per irridere il concetto di materia dei
peripatetici dice: «Et os vulvae numquam dicit: sufficit: id est, scilicet, videlicet,
Giordano Bruno e il Dio in-esistente
utpote, quod est dictu, materia (la quale viene significata per queste cose)
recipiendis formis numquam expletur». La materia per Aristotele è potenza
pura, cioè aspirazione alla perfezione attuale che, però, non sarà mai
quella dell’atto puro o forma pura che in quanto perfezione in atto,
esaurisce del tutto l’essere della perfezione come perfezione dell’essere.
L’atto puro o forma pura è già da sempre quello che la materia vorrebbe
essere e non potrà mai essere. Materia e forma sono, in quanto puri,
sempre distinti: sebbene coeterni e proprio perché qualitativamente
differenziati, dal punto di vista teoretico l’essere dell’atto o della forma
pura precede l’essere della materia prima e ne rappresenta la causa e lo
scopo del divenire e del trasformarsi per l’eternità. Per Bruno la materia mai
sazia di accogliere nuove forme è come una vulva che non è possibile soddisfare!
In che consiste la blasfemia di Bruno? Quella di Bruno è una
blasfemia che non mira ad ingiuriare, ma a dimostrare che il bersaglio
contro cui è rivolta l’ingiuria è inesistente. La sua blasfemia non solo ha
una efficacia argomentativa straordinaria, ma diventa il banco di prova
della laicità e della aconfessionalità dell’uomo moderno! La filosofia è
blasfemia! Il Dio “persona” è inesistente! E se non esiste Dio,
figuriamoci che cosa sono santi, diavoli e Madonne! La ridicolizzazione
di comportamenti e credenze del popolino alimentati, in buona o cattiva
fede, dalle gerarchie politiche ed ecclesiastiche è blasfemia? C’è forse
qualcosa filosoficamente più efficace della “blasfemia comica”, della
dissacrazione della religione che, personalizzando la divinità,
inevitabilmente, conduce alle ridicolaggini della superstizione? La vera
empietà e, dunque, la vera blasfemia veramente oscena, dal punto di vista
di Bruno, è la “preghiera” e la concezione che il volgo, i preti e i falsi
filosofi hanno della divinità! «Blasphemia vero est facere deum alium a deo».
E’ blasfemica, cioè è falsa la distinzione scolastica tra potentia absoluta
e ordinata di Dio perché necessariamente Dio produce uno spazio-tempo
infinito (l’universo infinito è uno, ingenerato, omogeneo, eterno). Se si
ammette la distinzione fra potentia absoluta e potentia misurata, l’universo
fisico non è infinito, imago Dei, attuazione di tutta la infinita potenza di
Dio, ma un mondo finito e unico come manifestazione di una presunta
libera volontà del creatore: è l’universo aristotelico. L’unità e semplicità
di Dio, implicano un'identica estensione dei suoi attributi, per cui nella
divinità la potenza non può essere più ampia che la volontà ad extra;
questo rifiuto va inoltre ricondotto all’esigenza di un’adeguata
concezione della libertà divina, identica alla necessità e scevra da ogni
deformazione antropomorfica («sed illius generis est libertas [Dei], quae
idem est quod ipsa necessitas», De immenso, I,12).
286
Logos
«Neque distinctionem potentiae in absolutam et ordinatam, vel
ordinariam introducamus illo [i. e. Deo], ubi non libertatem protestetur, sed
implicet apertam contradictionem. Est perfectio in nobis (si ita placet) ut
possimus multa facere quae non facimus: blasphemia vero est facere Deum
alium a Deo: voluntatem eius aliam atque aliam, unam quae currit cum
potentia, aliam quae abhorreat a potentia, in melius contradictoriorum
alterum, vel deterius» (De immenso, III,1).
Non distingueremo la potenza in assoluta, ordinata o ordinaria là
dove non si affermi la libertà ma si presupponga una aperta
contraddizione. Anche in noi è la perfezione (se così piace) dal momento
che possiamo fare molte cose che non facciamo; è una bestemmia
pensare Dio diverso da quello che è e la sua volontà diversa da come si
attua, ora in conformità alla potenza,ora in disaccordo da essa, secondo il
migliore o il peggiore dei due opposti.
La vera blasfemia è fare di dio una “persona”, ovvero, un essere
dotato di una volontà che è arbitrio. Uno che ha orecchie per sentire,
occhi per vedere e che calibra la sua potenza in modo, appunto,
personale, discrezionale, arbitrario. «Qual raggione vuole che vogliamo
credere, che l'agente che può fare un buono infinito, lo fa finito? E se lo
fa finito, perché doviamo noi credere che possa farlo infinito, essendo in
lui il possere ed il fare tutto uno? » (De l’Infinito, Dialogo primo).
«Blasphemia vero est facere verum alium a vero!».
Ci si ricordi anche delle parole di un altro famoso “ateo”, Epicuro
di Samo: «Empio non è colui che gli dei del volgo rinnega, ma colui che
le idee del volgo attribuisce agli dei!». Se Dio ascoltasse le preghiere di
alcuni e non di altri sarebbe un Dio “parziale” e ingiusto, un Dio
“obbediente” alle nostre preghiere! Cioè non sarebbe Dio! Se, poi,
ascoltasse le preghiere di tutti, addirittura, cesserebbe di esistere il genere
umano, perché, come dice giustamente Epicuro : «Se gli dei dessero
ascolto alle preghiere degli uomini, non ci sarebbe più il genere umano,
perché sempre gli uomini si augurano la morte l’un l’altro!».
La morale della religione, proprio con il suo Dio-persona e la
giustificazione della preghiera, è il contrario della morale razionale e
abituando l’individuo al rapporto con un “Tu” assolutamente distante e
categorico nei suoi imperativi, lo costringe a riflettere continuamente
solo sulla qualità di tale rapporto e lo distoglie dalla riflessione sulla
qualità dei rapporti con gli altri esistenti. E’ così che si spiega che le
religioni e le “fedi” sono alla base di ogni intolleranza e giustificano ogni
violenza! Il Dio di tutti, il vero Dio, il Dio giusto non interessa a
nessuno! E’ un Dio Panteista, uno e plurale, la sua divina esistenza
consiste nel coincidere con la totalità degli esistenti, ma come “persona”
Giordano Bruno e il Dio in-esistente
non ha esistenza! Solo il Dio in-esistente*, immanente e coincidente con
tutti gli esistenti è l’Essere ed è l’esser da solo perché è l’esser tutto.
I motivi della morte
Bruno, certamente, si era persuaso - era pur sempre un monaco ed
uomo del suo tempo - di aver fornito una giustificazione razionale
dell’ontologia cristiana ed aveva finito per credere che la gerarchia
cattolica potesse condividere la sua idea, secondo la quale c’era una
religione per gli incolti, essenzialmente “instrumentun regni”, ed una
religione dei dotti, una “vera religione”, che, infondo, era la sua filosofia.
Gli fu fatale la sopravvalutazione della “dottrina” degli avversari,
unitamente alla mancanza di una seria riflessione, concreta e non
“metafisica ed astratta” sul potere e sugli uomini di potere. Bruno,
teorico della Vicissitudine, ne interpretò il significato solo in senso
metafisico e non concreto e storico! La Verità va solo contemplata e, per
il resto, «il mondo sta bene come sta!», come dice Vittoria nel secondo
atto del Candelaio.
Invece, il concetto di Vicissitudine, presente nella sua filosofia, non
solo comporta la perfetta parità e dignità ontologica fra tutte le forme
viventi e quindi nega, necessariamente, ogni forma di antropocentrismo e
antropocrazia, ma rappresenta la più chiara negazione del Dio persona e
quindi la più seria delegittimazione dell’autorità religiosa e politica del
tempo. In quanto trascendente, Dio non è da nessuna parte, perché un
tale Dio è nient’altro che l’impossibilità della Mente Immanente di
contraddirsi, cioè di non garantirsi l’Essere e in questo senso il
“trascendente”, in termini parmenidei, equivale a dire l’impossibilità del
non-essere di poter essere, ossia, che Dio è trascendente nel senso che “è
l’essere l’impossibilità di non essere”. Il suo “essere” è tutto nel suo
288
Logos
“significato” che è l’attività di assicurare a sé come molteplicità
intelligente un comportamento sempre intelligente, nel senso che ogni
esistente anche “ab-norme”, “sub specie temporis”, ed ogni
comportamento, anche quello che “sub specie temporis” appare come il
più nefasto, sono “modi” dell’intelligenza e, dunque, Bene. Il
comportamento del molteplice è sempre solo apparentemente
contraddittorio, perché l’agire di tutti gli “esistenti” è, per l’eternità,
concertato ed armonico, come quello di uno solo, che è in perfetto
accordo con se stesso.
In quanto immanente, Dio è l’Anima del mondo o l’Ordine del
mondo: è un Dio plurale e monotèletos: Plurale, in quanto Unità presente
nella molteplicità infinita degli enti semplici, monotèletos (si ricordi
l’obiezione ockamiana alla unicità di Dio: per il francescano Ockam non
è possibile neppure dimostrare che Dio è uno, perché nulla vieta che
possa essere Molteplice o Plurimo, che, cioè, potrebbero esserci
innumerevoli Dei e comportarsi come se fossero Uno solo, con una sola
volontà, ed essere, nello stesso tempo, un Dio Plurale e Uno, in quanto
Monotèletos) perché assolutamente uno e “trascendente”, nel senso
chiarito sopra, persino a se stesso in quanto Essere presente nel
molteplice, e, perciò, inconcepibile, o concepibile solo come
“assolutamente altro” rispetto alla pluralità che ne rappresenta la
manifestazione.
Il fatto che Bruno abbia voluto salvaguardare la trascendenza di Dio,
non ne abbia chiarito fino in fondo il significato e le conseguenze, lo
accosta al neoplatonismo e lo induce a ritenere di poter accordare la sua
filosofia con la dogmatica cristiana. È per questo che ho ritenuto più
proprio definire ‘penenteista’ il suo sistema filosofico e non ‘panteista’. Il
termine ‘panenteismo’ (πα̃ν ε̉ν θεω̣̃) è stato introdotto nel linguaggio
filosofico da K. Krause per designare il proprio sistema filosofico, da lui
non considerato panteistico, perché riteneva di aver di differenziato
l’essenza dell’Assoluto dalle sue manifestazioni. Renouvier ne dà la
seguente definizione: «Il panenteismo consiste nel supporre tra l’Unità e
la Pluralità non una relazione tale che la pluralità sia derivata in una
maniera o nell’altra dalla prima, ma una relazione di una necessità
reciproca, congiunta ad una subordinazione costante, eterna del
Molteplice in rapporto all’Uno» (Logique, tomo III, pag. 220). J. Lachelier,
considerando che il termine dica troppo poco per Spinoza e troppo per
Malebranche, non lo ritiene adeguato ad esprimere quel che intende dire.
Al contrario, il termine a me pare utile ed efficace, perché preciso ed
appropriato per designare le filosofie di Plotino e di Bruno del De la
causa, prima della sua finale adesione al materialismo. D’altra parte, basta
Giordano Bruno e il Dio in-esistente
attenersi al significato etimologico del termine panenteismo (πα̃ν ε̉ν θεω̣̃ ),
tutto, cioè il mondo, è in Dio, ed appare del tutto evidente che esso
esprime la non perfetta identità di Dio col Mondo come avviene con la
distinzione bruniana fra Dio come causa e Dio come principio. Con il
panteismo [πα̃ν (ε̉στι) θεός, tutto è Dio] si vuole dire, invece, che Dio e il
mondo sono una cosa sola, cioè che il mondo è “divino”, nel senso che è
eterno e ingenerato, immobile (ossia che, come totalità, sta sempre
dov’è), “omogeneo” (nel senso che non c’è parte più o meno divina di
un’altra), perfetto e finito (perché è esattamente quel che deve essere), e
che la parte e il tutto, in quanto divini, sono perfettamente identici. Nel
panteismo non c’è assolutamente alcuna distinzione tra causa e principio
e la trascendenza, anche nel senso sopra chiarito, non è assolutamente
presa in considerazione, perché sarebbe come parlare del non-essere: il
panteismo, a partire da Senofane di Colofone, segna la nascita della
filosofia, come distacco appunto dal Mythos e come costante vigilanza
contro il ricorrente, subdolo rischio dell’antropomorfismo, ossia, della
proiezione nell’oggetto in sé delle rappresentazioni o idee del soggetto.
L’atto spontaneo dell’esistenza è giustificato dall’infinità dell’Essere
in atto che diviene se stesso appunto attraverso le esistenze provvisorie e
transeunti, le quali, una volta compiuto il loro percorso di esistenza, sono
idee perfette e compiute nel loro significato all’interno del significato
dell’Essere di Dio. Ogni idea di esistenza compiuta diviene risorsa
dell’essere così come ogni atto dell’esistente è per l’esistente una
possibilità di interagire (memoria ed esperienza) col mondo esterno con
il ricorso allo stesso atto.
290
Logos
Questo è, in sostanza, il senso della cosiddetta “metempsicosi” e
dell’eternità delle idee platoniche, di ciò che Bruno chiama Vicissitudine
o della teoria dell’eterno ritorno dell’identico: «dall’altro canto , io spero
di ricovrare il lardo, dove ho perso l’erba, non sott’un mantello, sotto un
altro, si non in una, in un’altra vita» (Candelaio, Epistola dedicatoria). Così
il Dio-tutto, in quanto infinita possibilità di essere, pone la sua esistenza
come spontanea scaturigine di tutte le esistenze possibili nelle quali è
presente nell’atto spontaneo della loro esistenza. In quanto Dio esistente,
è in tutte le esistenze, ma in quanto “essere” non può avere una sua
propria esistenza separata! E’ la totalità presente in ogni atto
dell’esistente e in quanto tale causa dell’agire e del moto e della vita
universale. Ma non è assolutamente Persona, cioè uno al quale si possa
parlare o in nome del quale parlare, o uno che si possa distinguere,
essendo egli l’Uno che è assolutamente tutto, o, per dirla con Hegel,
Spirito Assoluto, identità dell’identità e della non identità, è idea e natura:
in termini bruniani, è Causa e Principio. E’ auto-provvidenza e in quanto
tale non ha bisogno di sedicenti interpreti pazzi, santi o invasati di vario
genere, i suoi disegni non sono concepibili per l’uomo comune e, perciò,
nessuno può arrogarsi il diritto di parlare in nome di Dio.
Chi riesce a vedere Dio, fa la fine di Atteone, da cacciatore diviene
preda, nel senso che da spettatore diventa spettacolo, da soggetto
vedente diventa oggetto visto, perché Dio è il Soggetto Assoluto, può
vedere senza essere visto. Dio lo si può “vedere” come Immanente,
come Natura, come “Diana Ignuda”, come Ordine del mondo, come
trama di rapporti logici che tengono insieme le cose e delle quali
determinano la nascita e la trasformazione.
Giordano Bruno e il Dio in-esistente
Gli eroici furori, Dialogo quarto
A le selve i mastini, e i veltri slaccia
Il giovan Atteon, quand’il destino
Gli drizza il dubio e incauto cammino,
Di boscarecce fiere appo la traccia.
Ecco tra l’acque il più bel busto e faccia,
Che veder possa il mortal e divino,
In ostro ed alabastro e oro fino
Vidde, e ‘l gran cacciator dovenne caccia.
Il cervio, ch’a’ più folti
Luoghi drizzava i passi più leggieri
Ratto voraro i suoi gran cani e molti.
I’ allargo i miei pensieri
Ad alta preda, ed essi a me rivolti
Morte mi dan con morsi crudi e fieri.
Dunque, secondo Bruno, l’intuizione intellettuale, la Mens tuens, è
superiore alla ragione discorsiva, alla Diάnoia, e consente all’apice
dell’Eroico Furore la contemplazione di sé e del Tutto “sub specie
aeternitatis”, cioè come se si fosse Dio, e in concreto, comporta una
μετάνοια, un cambiamento di vita del soggetto individuale, vale a dire
della prospettiva morale del singolo, divenuto capace di comprendere
l’identità di libertà e necessità. Appare chiaro che Bruno, dando il
primato all’intuizione intellettuale sulla ragion discorsiva, confina nella
sincategorematicità le scienze naturali induttive, e per quanto abbia avuto
qualche brillante intuizione scientifica, sta all’interno di un quadro
filosofico neoplatonico, perché la natura è il luogo dell’esercizio della
libertà-necessità insieme a tutti gli altri esistenti e non il luogo dei corpi
dei quali bisogna scoprire le regole comportamentali per piegarli alle
esigenze umane. La finalità del suo filosofare è la felicità individuale,
“catastematica” e perciò la scienza vera è quella che ci rende
collaboratori di Dio, nel senso che la collaborazione è la comprensione
giustificatrice dell’esistente in atto e non anche dell’esistente-mondo
come possibilità di libertà-dominio dell’uomo. Con il suo monismo
organicistico, Bruno ribadisce che Dio, in quanto totalità intelligente
garantisce all’individuo, cioè alla “parte” che trae la sua identità dalla
capacità di interagire con gli altri, di vivere l’esperienza del suo
significato: dall’individuo “minimo” fino al più complesso, all’uomo e
all’uomo d’eccezione che con una “fuga da solo a solo” ha percorso fino
in fondo la via dell’eroico furore: un progresso che è regresso, un nόstos
dal molteplice all’uno, all’ “indiamento”, cioè della giustificazione del
292
Logos
Reale nel senso dello spinoziano Amor dei intellectualis. In sintesi, la sua
gnoseologia dà il primato alla intuizione intellettuale sulla ragione
discorsiva e mira a fondare una morale attivistica che, attraverso la
“metànoia”, porti alla felicità dell’indiamento. La sua concezione
dell’uomo rappresenta la parte più originale del suo pensiero, perché
manifestamente deantropocentrizza il reale, e, con i concetti di
Vicissitudine e Giustizia, elimina da esso ogni residuo antropomorfico,
mostrando la precarietà e la labilità di ogni gerarchia.
L’Universo aristotelico col suo “Divenire”, fatto di “potenze” ed
“atti” viene completamente disarticolato, perché l’Universo bruniano
contiene al suo interno l’Atto puro ed è così veloce ed intelligente che, in
quanto manifestazione di Dio, o Dio manifesto, non può mai fissarsi in
una rappresentazione esterna di Dio che sia definitiva. Il concetto
aristotelico-tomista di gerarchia è, palesemente, un concetto di “ordine”
di livello inferiore, rispetto al concetto di “ordine infinito” o “divino”, o
infinito attuale, così come nella filosofia dello spirito di Hegel la
“Rappresentazione”, che è il modo con cui la religione coglie l’Assoluto,
è inferiore al “Concetto” che è il modo con cui l’Assoluto viene colto
dalla filosofia!
I concetti di μετάνοια e di “indiamento” attestano che il suo interesse
speculativo è essenzialmente di natura morale, di una morale
individualistica o, al più, aristocratica, nel senso degli “Άristoi” platonici e
che l’attivismo e la libertà non possono che inverarsi nell’accettazione
libera della Necessità che è l’unica felicità possibile per l’essere finito.
All’apice dell’eroico furore, cioè, alla fine del percorso di
coscientizzazione, si diventa, dunque, collaboratori di Dio, nel senso che
si comprende che il senso della vita è desiderare di essere quello che si è,
vale a dire intelligenza, cioè capacità di trascendersi e trasformarsi in
quello che l’Intelligenza infinita ha deciso per noi: è riuscire a guardarsi
dal punto di vista della Totalità, “sub specie aeternitatis”, è conoscere se
stessi, indagare fino in fondo, eroicamente, il proprio significato.
Il pensiero di Bruno, nella “complessione” spazio-temporale della
sua esistenza, implicava una fine da eretico. Consapevole del suo destino,
Giordano Bruno si avviò verso la morte, felice come il Sisifo di Camus,
«perché anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un
uomo», e, nello stesso tempo, con la stessa sovrana indifferenza che
mostrerà Giulio Cesare Vanini, un altro eretico considerato “ateo” che,
mentre veniva lambito dalle fiamme del rogo, esclamò: “Mio Dio!”. Ma,
poi, quando si accorse che quelli che assistevano al suo supplizio si
davano da fare per spegnere le fiamme perché pensavano che si fosse
pentito, si affrettò a precisare: “Ma era solo un modo di dire!”. E finì
Giordano Bruno e il Dio in-esistente
bruciato! Come Vanini, sul rogo, Giordano Bruno era indifferente al
mondo e felice. Aveva scelto liberamente il suo destino, se n’era
innamorato! Alla faccia di tutti i fanatici, degli ipocriti, degli ignoranti e
dei pretacchioni “candelai” di tutte le chiese, per l’amante della Verità, la
Felicità può essere anche la Morte sul rogo!
Salvatore Principe
L’uomo di Kant.
Note in margine all’antropologia kantiana
«Nessuna epoca ha avuto, come l’attuale, nozioni così numerose e
svariate sull’uomo. Nessuna epoca è riuscita, come la nostra, a presentare il
suo sapere intorno all’uomo in modo così efficace e affascinante, né a
comunicarlo in modo tanto rapido e facile. È anche vero, però, che nessuna
epoca ha saputo meno della nostra che cosa sia l’uomo. Mai l’uomo ha
assunto un aspetto così problematico come ai giorni nostri» 1
(M. Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik)
«L’uomo è un ente così vasto, vario e poliforme che ogni definizione si
mostra troppo limitata. I suoi aspetti sono troppo numerosi» 2
(M. Scheler, Zur Idee des Menschen. Abhandlungen und Aufsätze)
1. Introduzione storica: sul ruolo dell’Antropologia nella
filosofia sistematica di Kant.
1.1 Kant e il metodo antropologico3.
«Risoluto a non cercare più altra scienza al di fuori di quella che si
potesse trovare in me stesso oppure nel gran libro del mondo impiegai il
M. Heidegger, Kant e il problema della metafisica, trad. it. di M. E. Reina, Roma-Bari,
Laterza, 2004, p. 181.
2 M. Scheler, Zur Idee des Menschen. Abhandlungen und Aufsätze, Vol. I, Bern und
München, Franke, 1915, p. 319.
3 A proposito della trattazione della problematica antropologica nella filosofia di
Kant si vedano: P. Salvucci, L'uomo di Kant, Urbino, Argalia Editore Urbino, 1963; I.
Raimondi, L’Antropologia Pragmatica kantiana: «Lebenswelt», «prassi» o «autocoscienza storica»?
Note su alcune interpretazioni recenti dell’Antropologia di Kant, in Studi kantiani, Pisa-Roma,
Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2002; J. Concill, La Antropologìa y
Antroponomìa de Kant, in Pensar lo humano, Actas del II Congreso Nacional de Antropologìa
Filosofica, Madrid, Septiembre de 1996, Iberoamericana, Madrid 1997, Madrid, Iberoamericana,
1997, pp. 281-285; J. Didier, La Question de l’homme et le fondement de la philosophie (Réflexion
sur la philosophie pratique de Kant et la philosophie spéculative de Fichte), Paris, Aubier éditions
Montaigne, 1964; P. Escudero, L. Fernando, Antropologìa Filosofica y Acciòn humana, in
Pensar lo humano, Actas del II Congreso Nacional de Antropologìa Filosofica, Madrid, Septiembre
de 1996, Madrid, Iberoamericana, 1997, pp. 287-290; P. R. Frieson, Freedom end
Anthropology in Kant's Moral Philosophy, New York, Cambridge University Press, 2003; T.
Japaridze, The Kantian subject. Sensus Communis, Mimesis, Work of Mourning, New York,
State University of New York Press, 2000.
1
L’uomo di Kant
resto della mia gioventù a viaggiare, a visitare corti ed eserciti, a frequentare
uomini di indole e condizioni diverse».
Così Descartes, nel Discorso sul Metodo4, racconta la delusione della
cultura libresca della sua giovinezza e la ricerca di vie nuove del sapere.
Nel secolo seguente Kant non ritenne più indispensabile, per divenire
esperto del mondo abbandonare la sua città; trovò più comodo aspettare
che il mondo venisse da lui, sia sotto forma di visitatori (Königsberg era
allora un porto piuttosto frequentato) sia sotto forma di resoconti di
viaggi, dei quali era appassionato lettore: «Fra i mezzi adatti ad allargare il
campo della antropologia – osserva – c’è il viaggiare, o almeno la lettura
dei resoconti di viaggio. Ma occorre prima acquistare in patria,
frequentando i propri concittadini e compatrioti, la conoscenza degli
uomini, se si vuol sapere dove cercare altrove il maggiore ampliamento di
essa»5. E in nota a questa affermazione aggiunge:
«Una grande città, al centro di uno Stato, in cui si riuniscono gli organi
di governo di esso, che ha una Università (per la cultura scientifica) e che è
sede di commercio marittimo, collegata per via fluviale con l’interno e coi
paesi vicini di diverse lingue e costumi, una simile città, come è Königsberg
sul Pregel, può essere ritenuta adatta allo sviluppo della conoscenza degli
uomini e del mondo anche senza viaggiare» 6.
A differenza di molti di noi, mobilissimi viaggiatori del secolo XX,
egli preferiva capire senza viaggiare piuttosto che viaggiare senza capire:
praticamente senza muoversi, riuscì a farsi un'invidiabile (relativamente ai
tempi) conoscenza di paesi e popoli vicini e lontani, conoscenza che
emerge con chiarezza nei suoi corsi di geografia e di antropologia,
nonché in alcune pagine della Critica del Giudizio7, e nelle pagine sui
caratteri degli uomini di diverse nazionalità delle Osservazioni sul Sentimento
del Bello e del Sublime8. Il legame tra geografia e antropologia è ancora
stretto ai giorni nostri (in particolare negli USA si suole indicare come
antropologia culturale quella che di solito noi chiamiamo etnologia); la
connessione tra queste due materie era ancora più stretta nel ‘700, un
4 Cfr. R. Descartes, Discorso sul Metodo, trad. it. a cura di I. Cubeddu, Roma, Editori
Riuniti, 1996, p. 64.
5 I. Kant, Antropologia dal punto di vista pragmatico, trad. it. a cura di P. Chiodi,
Milano, TEA, 1995, p. 4.
6 Ibid.
7 Cfr. Id., Critica del Giudizio, trad. it. di A. Gargiulo, riveduta da V. Verra, RomaBari, Laterza, 2002.
8 Cfr. Id., Osservazioni sul sentimento del Bello e del Sublime, trad. it. di L. Novati,
Milano, Rizzoli, 2002.
296
Logos
secolo nel quale i viaggi di esplorazione destavano un interesse
paragonabile a quello delle esplorazioni spaziali del nostro secolo: non
solo si scoprivano o esploravano nuove terre, ma si veniva anche in
contatto con popoli la cui esistenza era prima del tutto sconosciuta
oppure conosciuta solo vagamente. Per la prima volta diventava possibile
rappresentarsi l'unità del globo terraqueo e dell'umanità che lo popola,
dando in questo modo una base empirica e storica al cosmopolitismo
illuministico.
Il sapere antropologico kantiano ha una caratteristica a prima vista
dissonante con l’osservazione antropologica in generale. Esso, infatti,
non si basa sull’osservazione autoptica ma sulla testimonianza di altri.
Eppure Kant, perfino nelle osservazioni sulle caratteristiche di popoli
lontani riesce ad essere sempre molto vicino al vero.
L'antropologia di cui si occupa non è quella fisica o fisiologica che
riguarda l'uomo in quanto essere naturale, quindi la sua particolarità
rispetto agli altri animali, la differenza tra le razze umane ecc. (temi questi
cui del resto Kant dedica diversi saggi9). Non è neppure l'antropologia
pratica che studia l'uomo come essere libero e morale, ma in una
prospettiva empirica, formando così la parte empirica dell'etica (il
compito di quest'antropologia morale viene delineato in particolare nel
secondo paragrafo dell'introduzione alla Metafisica dei Costumi10). Egli
intitola il suo corso di lezioni Antropologia dal punto di vista pragmatico e
intende con questo termine la conoscenza di ciò che l'uomo in quanto
essere libero fa o può fare o deve fare di se stesso. L'antropologia pragmatica
prende in considerazione perciò il gioco tra le varie dimensioni di quella
complessa creatura che è l'uomo, essere sensibile razionale: la
dimensione corporea e sensibile, quella della conoscenza intellettuale,
nella quale l'uomo si distacca già decisamente dalla natura attraverso il
pensiero che si ancora a concetti e idee, infine quella etica o della libertà,
nella quale l'uomo si pone come legislatore e suddito di un mondo
noumenico, di un regno dei fini. Per Kant non si tratta di sapere sic et
simpliciter la differenza di colore della pelle, modo di vivere e carattere, ma
di guardare l’uomo nella sua interezza e complessa varietà pur sempre da
9 Cfr. §§ 89-90 della Critica del Giudizio, e il saggio sulla Determinazione del concetto della
razza umana (1785), Inizio congetturale della storia degli uomini (1786). Per questi ultimi due
saggi si fa qui riferimento alla traduzione italiana a cura di F. Gonnelli in I. Kant, Scritti
di storia, politica e diritto, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 87-119. Per un ulteriore
approfondimento sulla genesi di questi scritti si veda anche I. Kant, Scritti politici e di
filosofia della storia e del diritto, con un saggio di C. Garve, trad. it. di G. Solari e G. Vidari,
edizione postuma a cura di N. Bobbio, L. Firpo e V. Mathieu, Torino, Utet, 1956.
10 Cfr. Id., La Metafisica dei costumi, trad. it. di G. Vidari, revisione a cura di N.
Merker, Roma-Bari, Laterza, 2001.
L’uomo di Kant
un punto di vista trascendentale. È pur vero che nella seconda parte
dell’Antropologia l’Autore si lascia andare alla descrizione dei vari caratteri
e delle varie razze, ma ciò sempre con l’intento di rinvenire attraverso
l’osservazione dei caratteri e delle razze quanto detto sull’armonia delle
facoltà, e perciò sempre con un intento trascendentale, e mai con intento
semplicemente etnologico. Bisogna pur ammettere il gusto di Kant,
secondo la moda all’epoca, per le argomentazioni riguardanti le
particolarità di popoli stranieri, come si nota soprattutto nelle Osservazioni
sul sentimento del Bello e del Sublime, ma le riflessioni antropologiche di Kant
non vanno considerate a mio avviso come qualcosa di avulso dal restante
edificio critico, bensì come il punto di confluenza e realizzazione di tutta
la filosofia espressa nelle tre Critiche ed anche lo spazio risolutivo dei
numerosi problemi lasciati aperti dalle tre Critiche come ad esempio il
problema dell’unità della ragione e dell’unità della parte sensibile e di
quella soprasensibile dell’uomo.
Il fermento di idee che caratterizzò l’età dei lumi, ebbe profonde
influenze sullo sviluppo del pensiero antropologico e pose una serie di
problemi, che ancora oggi sono al centro del dibattito delle scienze
umane. I principali temi di discussione che emersero in questo periodo
riguardarono sostanzialmente la definizione dell'aspetto “morale” della
vita dell'uomo, inteso in un senso nuovo, che prelude alle moderne
definizioni dell'aspetto “culturale” del fenomeno sociale totale, e la critica
della posizione etnocentrica caratteristica della nostra società, che si lega
a quello che venne chiamato il “mito del buon selvaggio”, e infine il
metodo scientifico applicato all'osservazione dei fenomeni umani. Si
ebbe così, la definizione di un campo di ricerca che avesse come oggetto
specifico non solo l'uomo come organismo biologico e l'ambiente
naturale, nel quale egli vive, ma anche i suoi “costumi”, il suo “moral”,
per usare un termine del tempo; atteggiamento che prese le mosse dalla
filosofia di Locke11 e, successivamente, di Hume12, ma in modo
particolare dal pensiero di Condillac13. La Antropologia dal punto di vista
pragmatico di Kant si iscrive a pieno titolo entro questa tradizione, e ne
rappresenta – come dice E. Cassirer14 – la massima espressione. In essa
Cfr. J. Locke, Saggio sull’intelletto umano, trad. it. a cura di M. e N. Abbagnano,
Torino, UTET, 1971.
12 Cfr. D. Hume, Opere filosofiche, a cura di E. Lecaldano, Roma-Bari, Laterza, 2008,
vol. 2.
13 Cfr. E. B. de Condillac, Opere di Etienne Bonnet de Condillac, a cura di G. Viano,
introduzione di C. A. Viano, Torino, Utet, 1976.
14 Cfr. E. Cassirer, La filosofia dell’Illuminismo, trad. it. di E. Pocar, Padova, Sansoni,
2004. A proposito della lettura cassireriana della filosofia kantiana si ricorda il celebre
11
298
Logos
sono presenti infatti la tensione alla definizione dell'aspetto “morale”
della vita dell'uomo, la visione dell’uomo come cittadino del mondo, e il
suo evolversi come fenomeno sociale, inoltre la critica alle posizioni di
Rousseau e al mito del buon selvaggio.
1.2 Il ruolo dell’Anthropologie nella sistematica della filosofia
trascendentale di Kant.
Se si tiene conto del fatto che il corso di antropologia e quello di
geografia si erano alternati regolarmente, l'uno nel semestre invernale,
l'altro nel semestre estivo, per circa trent’anni15 e che l’Antropologia dal
punto di vista pragmatico vede la luce a Königsberg nel 1798, come opera
che raccoglie i risultati di oltre trent'anni di insegnamento di questa
dottrina nell’università come Kant fa notare, nella prefazione16, allora ci
si renderà conto che le lezioni di antropologia hanno accompagnato il
periodo di stesura delle tre Critiche e che perciò esse rappresentano con le
altre Vorlesungen, quell’officina, per così dire, nella quale Kant limava
pazientemente concetti e tesi, che sarebbero ricomparsi in forma
definitiva nei suoi scritti “ufficiali”. Infatti, come documenta l’epistolario,
per esempio nella lettera a Marcus Herz del 21 febbraio 177217, questi
corsi di antropologia e di geografia erano svolti di pari passo con lo
svilupparsi del pensiero di Kant.
testo del filosofo di Marburgo, Vita e dottrina di Kant, trad. it. di G. A. De Toni, Firenze,
La Nuova Italia, 1997.
15 In realtà, sappiamo che Kant teneva corsi di geografia dal 1755-56, mentre quelli
di antropologia sarebbero iniziati solo nel 1772-73.
16 «Nel mio insegnamento – prima libero e poi ufficiale – di filosofia pura, ho tenuto, per circa
trent'anni, due corsi sulla conoscenza del mondo dedicati, nel semestre invernale, all'antropologia e nel
semestre estivo alla geografia fisica; questi corsi destarono interessi anche negli ambienti esterni dato il
loro carattere popolare. Il primo è raccolto in questo manuale. La pubblicazione del secondo, contenuto
in un manoscritto decifrabile solo da me, è quasi impossibile data la mia età», I. Kant, Antropologia
dal punto di vista pragmatico, cit., p. 6.
17 Nella lettera a Marcus Herz del 21 febbraio 1772 Kant scrive: «Già molto tempo fa
avevo anche delineato in modo per me assai soddisfacente i principi del sentimento, del
gusto e delle facoltà di giudicare insieme ai loro effetti: il piacevole, il bello, il bene. Ora
progettai il piano di un’opera che avrebbe potuto portare un titolo come il seguente: I
limiti della sensibilità e della ragione. Pensai di suddividerla in due parti, una teoretica ed una
pratica. La prima, divisa in due sezioni, conteneva; 1. La fenom[en]ologia in generale; 2.
La metafisica, e precisamente solo secondo la sua natura ed il suo metodo. La seconda,
parimenti in due sezioni, conteneva: 1. I principi generali del sentimento, del gusto e dei
desideri sensibili; 2. I fondamenti primi della moralità», I. Kant, Lettere, trad. it. di V.
D’Agostino e G. Piccoli, a cura di A. Pastore, Torino, Paravia, 1924, pp. 23-25.
L’uomo di Kant
Già nell’introduzione al corso di logica, a proposito dello sviluppo
del concetto di filosofia in generale, si legge:
«Il campo della filosofia, secondo questo significato cosmopolitico, si
può ridurre alle seguenti domande:
Che cosa posso sapere?
Che cosa devo fare?
Che cosa posso sperare?
Che cos’è l’uomo?
[…] In fondo, tutto ciò si potrebbe mettere in conto all’antropologia,
giacché le tre prime domande si rapportano all’ultima» 18.
Queste stesse tre domande vengono menzionate anche nella Kritik
der Reinen Vernunft ma senza essere legate alla quarta domanda, “che cosa
è l’uomo?”.
Difatti lì Kant diceva:
«Ogni interesse della mia ragione (così lo speculativo come il pratico) si
concentra nelle tre domande seguenti:
1.
2.
3.
Che cosa posso sapere?
Che cosa devo fare?
Che cosa possa sperare?»19
Ora «Bisogna – con Heidegger – chiedersi: perché le tre domande (1.
Che cosa posso sapere? 2. Che cosa devo fare? 3. Che cosa posso
sperare?) “si lasciano rapportare” alla quarta? Perché “tutto ciò si
potrebbe mettere in conto all’antropologia”? Che cosa c’è di comune in
queste tre domande, e sotto quale riguardo esse formano un tutto
unitario, al punto da essere ricondotte a una quarta? Come deve essere
formulata questa quarta domanda, per poter assumere da sola, in modo
unitario, la portata delle altre tre?»20. E la risposta più plausibile è che «le
tre domande, in sé, non sono altro che la quarta domanda: non solo
possono, ma devono per essenza essere rapportate a quest’ultima. Tale
riferimento, però, diviene essenziale e necessario soltanto qualora la
quarta domanda abbia perduto la sua iniziale generalità e
indeterminatezza e sia stata ridotta all’univocità di un’interrogazione sulla
finitezza dell’uomo. Trattandosi d’una domanda di tal fatta, il suo giusto
18
19
495.
Id., Logica, trad. it. a cura di L. Amoroso, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 19.
Id., Critica della ragione pratica, trad. it. di F. Capra, Roma-Bari, Laterza, 2000, p.
20 M. Heidegger, Kant e il problema della metafisica, cit., p. 186. A proposito della
interpretazione heideggeriana della filosofia di Kant, si veda anche P. Colonnello,
Heidegger interprete di Kant, Genova, Studio editoriale di cultura, 1981.
300
Logos
posto non è in coda alle tre precedenti; essa diventa la prima, dalla quale
le altre tre prendono avvio»21.
Compendio e insieme bilancio della ricerca filosofica kantiana, la
Antropologia è, infatti, la sintesi unitaria dell’intero sistema della filosofia
kantiana critica e precritica. Tutte le tematiche in essa trattate sono
riscontrabili in ognuna delle opere precedenti ed in essa presentate come
un corpo unico intorno ad un nodo concettuale fondamentale: l’uomo. È
nell’uomo, nella sua struttura, che Kant individua il fondamento
trascendentale del prodursi di una esperienza teoretica, pratica, religiosa
ed estetica. D’altronde tutto ciò è molto più chiaro se leggiamo la lettera
a Carl Friedrich Stäudlin del 4 Maggio 1793:
«Onorato signore, consideri il ritardo della mia [risposta], alla sua
[lettera] scrittami il 9 Novembre 179122 e al regalo di valore delle sue Idee di
una Critica etc., una risposta non colpevole di mancanza di attenzione e
gratitudine; avevo intenzione di spedirgliela in aggiunta con una sorta di
regalo di contraccambio, la qual cosa però ho dovuto rimandare finora a
causa di alcuni intercorsi lavori. – Già da lungo tempo [infatti] il progetto
che mi ero proposto della trattazione del campo della filosofia pura mi ha
condotto ad occuparmi della soluzione delle tre questioni: 1) Cosa posso
sapere? (Metafisica) 2) Cosa devo fare? (Morale) 3) Cosa mi è lecito
sperare?(Religione); alle quali infine dovrebbe seguire la quarta: Cosa è
l’Uomo? (Antropologia; sulla quale già ormai da più di 20 anni, ogni anno
ho letto un collegio [corso di lezioni annuali]23».
M. Heidegger, Kant e il problema della metafisica, cit., p. 187.
Da notare il ritardo triennale col quale Kant rispondeva a questa lettera, il che
sottolinea ulteriormente, a mio avviso la profonda valenza che l’autore delle Critiche
riteneva avesse il problema della risposta a quella quarta: Che cos’è l’Uomo? Che in
fondo altro non è se non che l’unica vera domanda di cui le altre sono derivati.
Rispondere a quella domanda significava dunque per Kant dare unità al sistema del
sapere critico trascendentale che senza sarebbe risultato solo un insieme incompleto;
una costruzione di cui si vedono alcuni segmenti isolati ma non l’insieme completo e
organico della struttura totale nel suo insieme; come un azione cui manchino il motivo
e il movente, la causa e l’effetto.
23 Ciò ribadisce l’indicazione precedentemente fornita circa l’insegnamento
accademico che Kant tenne con le sue lezioni di Antropologia con scadenza annuale. I.
Kant, Brief an Carl Friedrich Stäudlin 4. Mai 1793 (1793. [574]° XI429), in Kant im Kontext
plus, Werke auf cd-rom; traduzione mia del testo seguente: «Sehen Sie Verehrungswürdiger
Mann, die Verspätung meiner, auf Ihr mir schon d. 9. Nov. 1791 gewordenes Schreiben und werthes
Geschenk Ihrer Ideen einer Kritik etc. schuldigen Antwort nicht als Ermangelung an
Aufmerksamkeit und Dankbarkeit an; ich hatte den Vorsatz, diese in Begleitung mit einem, jenem
gewissermaßen ähnlichen Gegengeschenk an Sie ergehen zu lassen, welche aber durch manche
Zwischenarbeiten bisher aufgehalten worden. — Mein schon seit geraumer Zeit gemachter Plan der mir
obliegenden Bearbeitung des Feldes der reinen Philosophie ging auf die Auflösung der drei Aufgaben:
1) Was kann ich wissen? (Metaphysik) 2) Was soll ich thun? (Moral) 3) Was darf ich hoffen?
21
22
L’uomo di Kant
Tenendo conto della datazione notiamo facilmente che quanto qui
espresso è il nucleo problematico che ha accompagnato Kant fin dal
1772 (Logica), presente ancora nel 1781 (Critica della ragione pura) e, infine,
nella lettera citata del 1793 ovvero ben tre anni dopo la fine del suo
lavoro “critico”.
2. ‘Uomo’, ‘Persona’, ‘Io penso’ e ‘soggetto
trascendentale’: quattro concetti differenti24.
Prima di provare a dare con Kant risposta alla domanda “che cosa è
l’uomo?”, è necessario un chiarimento terminologico. Se guardiamo alle
tre Critiche vediamo che ognuna di esse risponde ad una delle tre
domande fondamentali della filosofia poste nella Critica della Ragione pura.
Se il soggetto generale delle tre domande è l’uomo, che si pone le tre
domande fondamentali, nel dare risposta ad ognuna di tali domande
Kant specifica anche la struttura metafisica, o lo statuto ontologico, del
soggetto che compie ciascuna delle operazioni di cui la domanda pone il
quesito. Perciò ciascuna delle tre critiche non ci parlerà mai dell’uomo
inteso come tale, ma sempre solo dell’uomo in quanto soggetto
trascendentale, oppure solo dell’uomo in quanto soggetto conoscitivo
autocosciente, cioè l’Io-penso in quanto unità sintetica dell’appercezione;
oppure solo dell’uomo in quanto soggetto morale, ovvero della persona
morale o giuridica; oppure solo dell’uomo in quanto fine ultimo della
creazione. Insomma ognuna delle tre critiche risponde ad una delle tre
domande della filosofia, e ognuna ci parla solo di un aspetto particolare
dell’uomo. Ne risulta una visione frammentaria del soggetto totale e
multivario (mannigfaltig) che è l’uomo, per cui Kant sente il bisogno di
fornire una visione unitaria del soggetto che si pone le tre domande.
Nell’uomo vivente sono tanto l’Io-penso quanto la persona morale e il fine
ultimo della creazione, che risultano essere solo astrazioni metodologiche
trascendentali le quali certamente da sole, ognuna presa per sé, non
esistono in quanto oggetti di concetti ma solo in quanto concetti (senza
oggetto), e trovano la loro realtà solo se pensate come unità armonica
(Religion); welcher zuletzt die vierte folgen sollte: Was ist der Mensch? (Anthropologie; über die ich
schon seit mehr als 20 Jahren jährlich ein Collegium gelesen habe)» tratto dall’epistolario
completo secondo l’indicazione epistolare su riportata.
24 Per un profilo più esteso dei termini ‘Uomo’, ‘Persona’, ‘Io penso’ e ‘soggetto
trascendentale’ entro il quadro complessivo della filosofia di Kant si vedano le definizioni
risultanti ai lemmi corrispondenti in lingua tedesca in R. Eisler, Kant-Lexikon,
Hildesheim, Georg Olms Verlag, 2002.
302
Logos
nell’uomo che invece è realmente esistente e che nella sua multivarietà si
sottrae costantemente a qualsiasi tentativo di definizione.
Non potendo definire cosa è l’uomo, non resta a Kant, perciò, altra
scelta di descrivere cosa sono gli uomini nella loro realtà storica vivente,
e rinvenire negli uomini e nelle loro azioni, usi e costumi ciò di cui aveva
parlato nelle tre critiche; ed è proprio questo ciò che fa l’Antropologia
pragmatica. Se ora poniamo mente al fatto che l’Autore teneva i corsi
confluiti nell’Antropologia contemporaneamente alla stesura delle tre
critiche, ci rendiamo conto di come esse fossero frutto di un’astrazione
operata rispetto alle osservazioni condotte da Kant. Si determinava, così,
un circolo ermeneutico tra Vorlesungen sull’antropologia, le tre Critiche, e
l’Antropologia pragmatica, nel senso che le astrazioni espresse nelle critiche
trovavano conferma attraverso gli studi di antropologia e conducevano al
contempo tali studi secondo un’ottica critica ritornando poi ad influire
sul prosieguo della stesura delle tre Critiche. Ciò che avvalorerebbe
ulteriormente la nostra ipotesi storiografica circa il ruolo dell’Antropologia
nell’edificio della filosofia di Kant.
3. L’Uomo di Kant
3.1 L’unità dell’Io e la multivarietà (die Mannigfaltigkeit) dell’Uomo;
l’uomo come fine in sé
La domanda è: “Chi è l’uomo di Kant?” La risposta più semplice e
anche più sintetica sarebbe: “L’uomo di Kant è Kant stesso, come il
Cogito di Descartes è Descartes stesso che pensa”. Avremmo dato così
una risposta sagace ma poco esaustiva. Ammettiamo che l’uomo di Kant
sia Kant stesso e allora ci domanderemo chi è Kant in quanto uomo;
rieccoci di nuovo al punto di partenza, perciò la domanda si ripropone e
si amplia: “Chi è, e che cosa è l’uomo di Kant?”
È l’Io, non però solo come soggetto trascendentale, ma come Io che
si trova a vivere nel mondo, e che nel suo agire si trova a dover attuare il
proprio dovere morale incondizionato (in quanto comandatogli
incondizionatamente dalla legge morale), nel condizionato/condizionante (in
quanto la realtà ci preme con la sua insistenza e urgenza di decisione per
l’azione) della realtà fenomenica multivaria del mondo, non in idea bensì
in concreto. L’io, perciò, come soggetto conoscente/morale concreto,
esposto anche all’impulso naturale, ovvero l’uomo.
L’uomo di Kant
«Nella sua analisi delle “faccende umane” si intrecciano, in realtà, tre
accezioni differenti dell’uomo e dell’umanità in generale: Kant si riferisce
ora al genere umano nel suo insieme (connotato in maniera essenziale dalla
tendenza al progresso della specie), ora all’uomo come soggetto morale, ora
agli uomini quali esseri concreti viventi sulla terra. Nella seconda parte della
terza Critica, il riferimento è all’umanità nel primo senso; la seconda
definizione contrassegna la riflessione delle prime due critiche [in special
modo della seconda], ove l’uomo è concepito e descritto come “essere
ragionevole, sottoposto alle leggi della ragion pratica, che egli dà a se stesso,
autonomo, scopo in sé, appartenente ad un ‘Geisterreich’, regno degli esseri
intelligibili”; la terza accezione, infine, è adottata nella Critica del Giudizio
estetico, ove gli uomini vengono rappresentati, appunto, non come individui
razionali astrattamente presenti o possibili nell’universo, bensì come
“creature legate alla terra, viventi in comunità, dotate di senso comune,
sensus communis, senso della comunità; non autonomi, bisognosi di
socialità anche per pensare25».
L’uomo di cui qui si parla è il soggetto dell’interpellanza morale,
ovvero il soggetto moralmente implicato, ma nel contempo anche il
soggetto empirico, fatto di corpo, che sottostà alle leggi della natura e
che, in questa radicale duplicità tra legislazione della natura e legislazione
della libertà, vive una profonda contraddizione, o meglio una antinomia,
a cui solo il giudizio può rimediare. È il soggetto di cui si parla nella
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten dove, data la distinzione tra mondo
sensibile e mondo intelligibile, tale distinzione sussiste anche a livello
dell’essenza del soggetto, il quale si trova anch’esso ad essere fenomeno e
noumeno, dimensioni che sottostanno a due legislazioni diverse, quella
della natura e quella della libertà: «Considerandosi, dunque, come
appartenente al mondo sensibile in relazione alla pura percezione e
recettività delle sensazioni, e come appartenente al mondo intellettuale o
intelligibile in relazione a ciò che può essere in lui attività pura (che egli
non coglie mediante l’affezione dei sensi, bensì mediante la coscienza
immediata): anche se, di questo mondo intelligibile, non sa null’altro» 26.
«In considerazione di ciò, – dice Kant sempre nella Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten – un essere razionale, come intelligenza (quindi non
sotto l’aspetto delle sue facoltà inferiori), deve considerarsi come
appartenente, non al mondo sensibile, bensì all’intelligibile. Pertanto, egli
dispone di due punti di vista, da cui considerare se stesso e riconoscere le
leggi dell’uso delle sue facoltà e, pertanto, di tutte le sue azioni: da un lato,
in quanto appartiene al mondo sensibile, si riconosce sottoposto a leggi
di natura (eteronomia); dall’altro lato, in quanto appartiene al mondo
M. A. La Torre, L’etica nella terza critica. Il «Giudizio» kantiano e le recenti
interpretazioni francesi, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, p. 134.
25
304
Logos
intelligibile, si riconosce sottoposto a leggi che, indipendentemente dalla
natura, non si fondano sull’esperienza, ma esclusivamente sulla
ragione»27. E, più avanti, si legge:
«[…] se noi ci pensiamo come liberi, ci trasponiamo, come membri, nel
mondo intelligibile, e riconosciamo l’autonomia del volere insieme con la
sua conseguenza, che è la moralità; se, per contro ci pensiamo come
obbligati, ci consideriamo come appartenenti al mondo sensibile, ma anche
al mondo intelligibile nello stesso tempo»28.
Alla pagina seguente dice ancora:
«L’essere razionale, come intelligenza, si ascrive al mondo intelligibile, e
chiama volontà la propria causalità solo come causa efficiente che appartiene
a un tal mondo. D’altro canto, esso è consapevole di sé anche come
elemento del mondo sensibile, in cui s’incontrano, bensì, le sue azioni come
meri fenomeni di quella causalità, ma la loro possibilità non può venir
desunta da quella, causalità che non conosciamo; mentre, al contrario, quelle
stesse azioni, in quanto appartenenti al mondo sensibile, devono esser viste
come determinate da altri fenomeni, e cioè dai desideri e dalle inclinazioni.
Come proprie di un puro membro del mondo intelligibile, dunque tutte le
mie azioni sarebbero perfettamente conformi al principio dell’autonomia
della volontà pura; come proprie di un elemento del mondo sensibile, esse
dovrebbero essere assunte come interamente conformi alla legge naturale
dei desideri e delle inclinazioni, e, perciò, alla eteronomia della natura. (Le
prime si fonderebbero sul principio supremo della moralità, le seconde su
quello della felicità). Ma poiché il mondo intelligibile contiene il fondamento del
mondo sensibile e, perciò, anche delle sue leggi, e perciò dà immediatamente la legge
alla mia volontà (che appartiene interamente al mondo intelligibile), e come
tale deve anche venir pensato, così io, nonostante che per un altro verso
appartenga al mondo sensibile, come intelligenza mi riconoscerò sottoposto
alla legge del primo, cioè della ragione, che racchiude la sua legge nell’idea
della libertà e, quindi, della autonomia del volere: sicché le leggi del mondo
intelligibile devono essere considerate, rispetto a me come imperativi, e le
azioni conformi a questo principio come doveri 29».
26 I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, trad. it. di V. Mathieu, Milano,
Rusconi, 1994, pp. 197-199.
27 Ivi, p. 199.
28 Ivi, p. 201.
29 Ivi, p. 203.
L’uomo di Kant
Dalla prima e dalla seconda Introduzione alla Kritik der Urteilskraft
sappiamo che il passaggio dalla legislazione della libertà alla legislazione
della natura, cioè la realizzazione spazio-temporale dell’imperativo
morale, è operato dalla capacità di giudicare in quanto “termine medio”.
Ora la Kritik der Urteilskraft nel porre a tema l’unità della ragione (in
senso lato), come unità del sistema in quanto unità della ragione nel suo
uso teoretico e della ragione nel suo uso pratico e, perciò, unità del
mondo sensibile e del mondo intelligibile nel passaggio tra natura e
libertà, pone a tema in ciò anche l’unità del soggetto, per cui il soggetto
del giudizio non è solo colui che spera, cioè il soggetto della domanda
“che cosa posso sperare?”, né è solo colui che è obbligato dalla legge
morale, cioè il soggetto della domanda “che cosa mi è lecito fare?” e
neppure solo colui che conosce, o il solo Io penso, cioè il soggetto della
domanda “che cosa posso conoscere?”. È l’uomo, non semplicemente
un soggetto astratto, ma il vivente in tutta la sua complessità che
risponde alla domanda, proprio perciò sintetica di tutte le altre, “chi è
l’uomo?”. E vi risponde col proprio vivere che non è solo conoscere, né
solo sperare, né solo agire moralmente, ma è tutto questo e insieme
molto altro. Non è il solo essere razionale di cui Kant parla in ambito
morale, come nella precedente citazione per fondare l’universalità della
legge morale valida per ogni essere razionale, ma è il soggetto del
giudizio.
«Con ciò la Critica del Giudizio dischiude, a partire dalla riflessione su
una specifica facoltà dell’animo umano, un accesso non generico, ma
affrontato su una molteplicità di fronti che è ardua impresa tenere aperti
insieme, alla domanda filosofica sull’essenza dell’uomo, un accesso al chi è
questo singolo individuo, la cui conoscenza cozza contro una datità
originaria che gli impone limiti invalicabili, la cui azione è continuamente
esposta all’accidentalità, al rovesciamento di ciò che era nell’intenzione
dell’agente in qualcosa di radicalmente diverso. È quest’opera di riflessione
e comprensione, in cui si saldano in unità le diverse componenti dell’animo
umano, ciò che consente all’individuo di dare un senso al suo essere e
operare nel mondo»30.
Per tutto ciò l’uomo risulta essere non solo il soggetto ma anche, in
un certo senso, l’oggetto del giudizio, lo scopo finale della sua azione.
L’uomo in quanto unione antinomica di natura e libertà è il soggetto del
giudizio, e in quanto unione realizzata e risolta di natura e libertà, in quanto
realizzazione della libertà nella natura, è lo scopo del giudizio. Per cui
30
39-40.
F. Menegoni, Critica del giudizio. Introduzione alla lettura, Roma, Carocci, 1998, pp.
306
Logos
l’uomo realizza se stesso nell’attività di giudicare. Nel risolvere il
problema dell’attuazione della libertà nella natura attraverso il giudizio,
infatti, egli realizza se stesso in quanto risolve la sua essenza antinomica.
Nell’adempiere alla legge morale nella realtà sensibile per mezzo del
giudizio, l’uomo non solo risolve la sua natura antinomica, ma si avverte,
realmente e non solo intenzionalmente, come scopo finale, come fine in
sé, della legge morale, ed in ciò realizza la propria autentica libertà in
quanto la sua volontà sottostà ad una legge che si dà da sé per (cioè con
lo scopo di) sé, per cui il motivo (non movente) dell’azione morale è
l’uomo stesso e la formula, in fondo un po’ viziata e frustrante, “il
dovere per il dovere”, potrebbe trasformarsi in quella “il dovere
dell’uomo in vista dell’uomo” propria di una moralità realizzata secondo
lo “scopo finale della creazione”31 che è appunto l’uomo in quanto essere
dotato di “dignità”, cioè morale, perciò libero. Già nella Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten lo scopo finale della legge morale è l’uomo:
«Gli esseri razionali son chiamati persone[…]. Questi non sono, dunque,
scopi puramente soggettivi, la cui esistenza, come effetto della nostra
azione, abbia un valore per noi: sono scopi oggettivi, cioè cose la cui esistenza è
un fine in sé, tale che al suo posto non se ne può mettere nessun altro, e del
quale i fini soggettivi dovrebbero stare al servizio, come semplici mezzi,
perché senza di esso non vi sarebbe, in generale, nessun valore assoluto. […]
Se ha da esservi, dunque, un principio pratico supremo, e un imperativo
categorico che comanda alla volontà dell’uomo, questo deve derivare dalla
rappresentazione di ciò che è necessariamente uno scopo per ognuno,
essendo fine in se stesso: e, come tale, costituire un principio oggettivo della
volontà, che serva di legge pratica universale»32.
Perciò l’uomo in quanto fine in sé è principio soggettivo e, insieme,
principio oggettivo di tutte le leggi della volontà. «L’imperativo pratico –
dice Kant di seguito – sarà, dunque, il seguente: Agisci in modo da
considerare l’umanità, sia nella tua persona, sia nella persona di ogni altro, sempre
anche al tempo stesso come scopo, e mai come semplice mezzo»33.
Nella Kritik der Urteilskraft, poi, riguardo all’uomo come scopo ultimo
della natura, da un lato, e come scopo finale della creazione dall’altro, si
osserva: «l’uomo […] è lo scopo ultimo della creazione, perché è l’unico
essere, tra quelli che qui si trovano, il quale possa farsi il concetto di uno
A proposito dei concetti di scopo e di finalità della natura si vedano: P. Menzer,
Kants Lehre von der Entwicklung in Natur und Geschichte, Berlin, Reimer, 1911; K. Düsing,
Die Teleologie in Kants Weltbegriff, Bonn, Bouvier, 1968; F. Menegoni, Finalità e destinazione
morale nella “Critica del Giudizio” di Kant, Trento, Pubblicazioni di Verifiche, 1988.
32 I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, cit., p. 143.
33 Ivi, p. 145.
31
L’uomo di Kant
scopo»34, mentre dall’altro lato «come l’unico essere che sulla terra abbia
un’intelligenza, e quindi una facoltà di porsi volontariamente degli scopi,
egli [l’uomo] è, in verità, il ben titolato signore della natura; e, se questa si
considera come un sistema teleologico [quello che Kant chiama regno dei
fini nella Grundlegung zur Metaphysik der Sitten], egli ne è, per la sua
destinazione [morale], lo scopo ultimo [della natura]»35. Ma ancor più
chiaro il rimando alla destinazione morale risulta essere nel §84 della
Kritik der Urteilskraft:
«Ora noi non abbiamo nel mondo se non un’unica specie di esseri, la cui
causalità sia teleologica, cioè diretta a scopi, e tali tuttavia che si
rappresentino la legge secondo cui debbono determinare i propri fini, come
posta incondizionatamente da loro stessi e indipendentemente dalle
condizioni della natura, eppure come in se stessa necessaria. L’essere di
questa specie è l’uomo, ma considerato come noumeno; è l’unico essere
della natura in cui possiamo riconoscere, come suo carattere proprio, una
facoltà soprasensibile (la libertà) ed anche la legge della causalità e l’oggetto
di questa che egli si può proporre come fine supremo (il sommo bene nel
mondo). Ora, dell’uomo (e così di ogni essere ragionevole del mondo), in
quanto essere morale, non si può domandare ancora per qual fine (quem in
finem) esiste. La sua esistenza ha in se stessa lo scopo supremo, al quale, per
quanto è in sua facoltà, egli può sottomettere l’intera natura, o, almeno,
rispetto al quale non c’è alcuna influenza contraria della natura, a cui l’uomo
debba ritenersi soggetto. – Ora, se le cose del mondo, in quanto esseri
condizionati relativamente alla loro esistenza, abbisognano di una causa
suprema che agisca secondo fini, l’uomo sarà lo scopo finale della creazione:
perché senza di esso la catena dei fini subordinati l’uno all’altro non avrebbe
un vero principio, e solamente nell’uomo, ma nell’uomo in quanto soggetto
della moralità, si può trovare questa legislazione incondizionata
relativamente ai fini, che rende lui solo capace di essere uno scopo finale,
cui la natura sia teleologicamente subordinata» 36.
Perciò, considerando entrambe gli aspetti, tra loro complementari, di
scopo ultimo della natura e di scopo finale della creazione, Kant può concludere
che: «senza uomini, tutta la creazione sarebbe un semplice deserto, vano
e senza scopo finale»37. L’uomo da qui viene fuori come quell’essere
capace di porsi degli scopi, che siano tali, però, da essere conformi alla
rappresentazione di quella legge, la legge morale che è “posta
incondizionatamente da loro stessi e indipendentemente dalle condizioni
della natura”, eppure “necessaria”, secondo cui gli uomini devono
determinare i propri fini. Ora però, come abbiamo già visto, nella
Id., Critica del Giudizio, cit., p. 539.
Ivi, p. 547.
36 Ivi, pp. 555-557.
37 Ivi, p. 571.
34
35
308
Logos
realizzazione della propria intenzione in vista di uno scopo, l’uomo si
trova a dover operare nel mondo sensibile, caratterizzato da una
multivarietà individuale e accidentale che rischia di farlo cadere in fallo.
Quella multivarietà che costituisce il “fattore contingenza”, e che viene a
caratterizzare l’essere dell’uomo nel mondo, e che richiede di essere
compresa perché sia possibile in essa la realizzazione dell’intenzione.
«Quest’accesso alla comprensione del significato dell’individuale e
dell’accidentale, che caratterizzano l’essere dell’uomo nel mondo, viene
affidato non alla facoltà di giudicare in generale, ma ad una sua specifica
modalità: il Giudizio riflettente»38.
Ma fin qui abbiamo avuto una determinazione quasi solo morale.
Solo apparentemente. Quando abbiamo individuato il Giudizio come ciò
che permette l’unione della parte sensibile e di quella soprasensibile
nell’uomo, abbiamo toccato il proprium dell’uomo. Solo l’uomo è infatti
l’essere capace di giudicare, nel senso di porsi programmaticamente dei
fini e trovare dei mezzi per realizzare questi fini. Il Giudizio allora non è
il punto di unione tra sensibile e soprasensibile solo a livello morale, ma
anche a livello teoretico. L’Io-penso riesce ad unirsi alla sensibilità dell’Ioempirico solo nel giudizio per mezzo dell’immaginazione in quell’accordo
delle facoltà che è il senso comune, come osserva Deleuze39. Ed è
proprio del Giudizio in quanto accordo delle facoltà nel loro utilizzo
nella conoscenza che Kant parla nella prima parte dell’Antropologia
pragmatica, dove egli fa una ricognizione di tutte le facoltà superiori
(Intelletto/Ragione/Giudizio/ Immaginazione/ Sensibilità) nel loro
utilizzo corretto, e nelle loro patologie osservate nei diversi tipi di
uomini. Ed è in virtù di questo accordo delle facoltà che nelle prime
pagine a proposito dell’unione dell’Io-penso e dell’Io-empirico Kant può dire
che:
«Io, in quanto essere pensante, sono un unico e stesso soggetto con me
in quanto essere sensibile; ma in quanto oggetto dell’intuizione empirica
interna, cioè nella misura in cui sono internamente affetto dalle sensazioni
nel tempo, siano esse simultanee o successive, io mi conosco soltanto come
appaio fenomenicamente a me stesso, non come cosa in sé» 40.
Ciò che caratterizza primariamente l’uomo come essere unitario di
Persona/Sensibilità/Io-penso è il Giudizio riflettente, che è la capacità di
F. Menegoni, Critica del giudizio. Introduzione alla lettura, cit., p. 40.
Cfr. G. Deleuze, La filosofia critica di Kant, trad. it. di M. Cavazza e A. Moscati,
Napoli, Cronopio, 1997.
40 I. Kant, Antropologia dal punto di vista pragmatico, cit., p. 24.
38
39
L’uomo di Kant
raziocinio e di discernimento. A proposito del Giudizio come capacità di
porsi scopi di qualsiasi tipo, non solo morali ma, che determinino l’unità
e la natura dell’uomo e che rappresenti come tale il suo prius, nel saggio
del 1786 dal titolo “Inizio congetturale della storia degli uomini” il filosofo
scrive:
«La prima volta che egli disse alla pecora: il vello che tu porti, la natura
non te lo ha dato per te, ma per me, la spogliò di esso e se ne vesti (Genesi
III, 21), egli ebbe coscienza di una prerogativa che, grazie alla sua natura,
aveva su tutti gli altri animali, i quali da allora non considerò più come i suoi
compagni nella creazione, ma come mezzi e strumenti lasciati al suo volere
per il raggiungimento degli scopi che preferiva»41.
L’uomo è, perciò, l’unico essere sulla terra capace di ragionare e di
porsi degli scopi e finalizzare cose. In tal senso Kant, nell’ultima parte
della Antropologia pragmatica può concludere che:
«Per classificare l’uomo nel sistema della natura vivente e poterlo così
definire, si può dire semplicemente che egli ha un carattere che si forgia da
sé perché è capace di perfezionarsi secondo fini scelti da lui stesso; a causa
di ciò egli, in quanto animale fornito di razionabilità(animal rationabile), può
fare di se stesso un animale ragionevole(animal rationale); così egli: in primo
luogo conserva se stesso e la sua specie; in secondo luogo esercita, istruisce
ed educa questa specie in vista di una società domestica; in terzo luogo la
governa come un tutto sistematico (ordinato secondo principi razionali)
qual è richiesto dalla società. […] Fra gli esseri viventi che abitano la terra
l’uomo si distingue nettamente per la sua attitudine tecnica (attitudine
meccanica congiunta a coscienza) a manipolare le cose, per la sua attitudine
pragmatica (impiego degli altri uomini ai propri fini) e per l’attitudine
morale (agire nei confronti di se stesso e degli altri secondo il principio della
libertà in conformità a leggi); ciascuno di questi tre gradi è sufficiente a
caratterizzare l’uomo nei confronti degli altri abitatori della terra» 42.
E in seguito, sempre riguardo alla capacità che l’uomo ha di
utilizzare le cose per i propri fini, Kant dice:
«La caratteristica dell’uomo in quanto animale ragionevole si vede già
nella forma e nell’organizzazione della m a n o , delle dita e delle falangi e
consiste in parte nella loro struttura e in parte nella delicatezza della loro
sensibilità; mediante ciò la natura ha reso l’essere umano capace di ogni tipo
di manipolazione, quindi capace di impiegare la ragione, dimostrando così
41 Id., “Inizio congetturale della storia degli uomini”, in Scritti di storia, politica e diritto, cit.,
pp. 107-108.
42 Id., Antropologia dal punto di vista pragmatico, cit., pp. 206-207.
310
Logos
che la sua attitudine tecnica e la sua abilità sono quelle di un animale
ragionevole»43.
4. L’Uomo e gli uomini, sull’Io e gli altri secondo la
definizione dell’uomo come fine in sé.
Proprio la capacità di finalizzare, di cui fin qui si è fatto menzione,
ovvero la capacità di porsi dei fini e di determinare i mezzi atti al
conseguimento di essi, è ciò che ultimamente caratterizza l’uomo in
quanto tale e lo distingue dagli altri esseri viventi ma irragionevoli.
L’uomo può finalizzare l’animale ed usarlo come mezzo-per-scopo,
l’animale non può finalizzare l’uomo e non può usarlo come mezzo-perscopo. Come si è già ricordato proprio nel saggio del 1786 dal titolo
“Inizio congetturale della storia degli uomini” Kant sottolineava che:
«il quarto ed ultimo passo che la ragione umana compì nel sollevare
interamente l’uomo al di sopra della comunità con gli animali, fu questo: egli
comprese (per quanto solo oscuramente) di essere davvero il fine della
natura, e che nulla di quello che vive sulla Terra poteva in ciò costituire per
lui un rivale. La prima volta che egli disse alla pecora: il vello che tu porti, la
natura non te lo ha dato per te, ma per me, la spogliò di esso e se ne vesti
(Genesi III,21), egli ebbe coscienza di una prerogativa che, grazie alla sua
natura, aveva su tutti gli altri animali, i quali da allora non considerò più
come i suoi compagni nella creazione, ma come mezzi e strumenti lasciati al
suo volere per il raggiungimento degli scopi che preferiva» 44.
La domanda che sorge a questo punto nell’uomo è: “Ma l’uomo può
finalizzare l’uomo (inteso come altro uomo), e dunque usarlo come
mezzo per uno scopo che non è suo proprio?”. Risposta: “no, secondo
l’imperativo categorico l’uomo è già fine in sé, e va trattato come tale!”.
Difatti Kant, a proposito di quella capacità dell’uomo di usare gli animali
come strumenti o mezzi atti alla realizzazione dei propri scopi dice che
«Questa rappresentazione contiene (per quanto oscuramente) il concetto
dell’inverso: che egli non potesse dire nulla di simile a nessun uomo, ma che
dovesse considerarlo come egualmente partecipe del dono della natura; una
lontana preparazione alle limitazioni che la ragione avrebbe in futuro
imposto alla volontà riguardo al suo prossimo, e che è di gran lunga più
necessaria della benevolenza e dell’amore all’instaurazione della società» 45.
Ivi, p. 208.
Id., “Inizio congetturale della storia degli uomini”, cit., pp. 107-108.
45 Ibid.
43
44
L’uomo di Kant
L’altro per Kant è un altro essere capace di finalizzare e che, però,
non deve essere da me finalizzato. Questo essere capace di finalizzare
viene alla mia coscienza dal fatto che io per primo mi riconosco come
essere finalizzante la natura, e per riflesso da me, vedendo l’altro come
me (altro che fino al momento in cui io mi riconosco come essere
finalizzante e poi riconosco lui, è da un lato solo un fascio di nervi, ed è
ciò che io vedo [il fenomeno], e dall’altro lato è un in conoscibile cosa in
sé in quanto alla sua coscienza, che io non vedo [il noumeno]) posso
postulare, quasi questa fosse un’idea della ragione che anche l’altro sia un
essere finalizzante la natura, e allora nelle sue opere io trovo la sua traccia
in quanto opere da lui finalizzate. Esso è in ciò pari a me, e come tale
possiede dignità pari alla mia. In quanto tale esso è da considerarsi per
mezzo del concetto di persona come un essere libero, capace di dare
inizio a “catene” di consequenzialità. In ciò la personalità, definendosi a
partire dalla capacità di finalizzare eventi a scopi, la quale è propria del
Giudizio (nel suo rispetto pratico), trova in questo la sua
caratterizzazione primaria, per cui “persona” è un essere ragionevole
ovvero giudicante.
Alfonso Mirto
La fortuna editoriale dei Saggi di naturali
esperienze nei secoli XVII-XIX
Alessandro Segni1, primo segretario dell’Accademia del Cimento,
nonché cruscante, apatista ed appartenente all’Accademia fiorentina,
nell’ottobre del 1665, partiva per un “tour” europeo, per accompagnare il
marchese Francesco Riccardi2 che, come tutti i rampolli della nobiltà
fiorentina, si apprestava ad entrare nella vita politica dello Stato
granducale. Le tappe stabilite erano: Torino, Parigi, Amsterdam, Praga,
Vienna e Venezia. Prima di giungere a Parigi, si trattenne per qualche
tempo a Lione, dove non mancò di salutare, in nome del principe
Leopoldo, personaggi che erano in contatto con questi e con gli eruditi
fiorentini, a cominciare da Carlo Dati e Francesco Redi3. A Parigi ebbe
1 Alessandro Segni (1633-1697), erudito al servizio dei Medici, appartenne
all’Accademia Fiorentina e fece parte di quella della Crusca, nella quale fu massaio nel
1653-54, consigliere nel 1658-59 e nel 1664-65, segretario dal dicembre 1666, avendone
svolto le funzioni in qualità di vice a partire dal 1676, subito dopo la morte di Carlo
Dati. Su di lui manca uno studio specifico, per il momento, vedi A. Mirto, Alessandro
Segni e i suoi corrispondenti, in «Atti e memorie dell’Accademia toscana di scienze e lettere
“La Colombaria”», LXVII, nuova serie LIII (2002), pp. 193-214. Una versione ridotta
di questo saggio, in lingua inglese, è stata pubblicata negli atti del convegno, The
Accademia del Cimento in the European Context (1657-2007), Florence, Biblioteca degli
Uffizi, December 14-15, 2007 (A. Mirto, Genesis of the Saggi and its Publishing Success in the
Seventeenth through Nineteenth Centuries, in AA.VV., The Accademia del Cimento and its
European Context Sagamore Beach, Science History Publications, 2009, pp. 135-149).
Ringrazio i curatori, prof. Marco Beretta, prof. Antonio Clericuzio e Lawrence M.
Principe, che mi hanno permesso di utilizzare il materiale per questa sede;.
2 Francesco Riccardi (1648-1719) fu affidato, per la sua educazione, al dotto
Alessandro Segni, con il quale intraprese, nel 1665, un lungo viaggio per l’Europa. Al
ritorno, a partire dagli anni ’70, entrò a far parte dell’apparato politico granducale; fu
inviato dal Granduca come ambasciatore straordinario presso Clemente X e nel 1673 a
Vienna, presso l’imperatore Leopoldo, a congratularsi per le sue nozze con Claudia
Felice di Insbruch. Su di lui, vedi M. J. Minicucci, Il Marchese Francesco Riccardi. Studi
giovanili, esperienze di viaggio, attività diplomatica del fondatore della Biblioteca Riccardiana,
Firenze, Olschki, 1985; P. Malanima, I Riccardi di Firenze. Una famiglia e un patrimonio nella
Toscana dei Medici, Firenze, Olschki, 1977; cfr. anche A. M. Zandri, Famiglie storiche toscane.
I Capponi, Firenze, Edizioni Polistampa, 2004.
3 Quest'aspetto è stato trattato da S. Camerani, Amicizie e studi di Leopoldo de' Medici
in un suo carteggio con Alessandro Segni, in «Archivio Storico Italiano», XCVII (1939), pp.
28-40 e da A. Mirto, La biblioteca del cardinal Leopoldo de’ Medici. Catalogo, Firenze, Olschki,
La fortuna editoriale dei Saggi di naturali esperienze nei secoli XVII-XIX
l’occasione di incontrare i più importanti intellettuali francesi, molti dei
quali erano conosciuti a Firenze, ed alcuni addirittura accademici della
Crusca (Gilles Ménage4, Jean Chapelain5). Tra questi dotti vi era
Melchisédec Thévenot, personaggio poliedrico, zio di Jean Thévenot,
uomo famoso per i suoi viaggi in Oriente, di cui si conservano varie
relazioni6. Nel 1654, per ordine di Luigi XIV, troviamo Melchisédec a
Roma per il conclave che portò al soglio di Pietro Fabio Chigi, che prese
1990. Per gli studi su Carlo Roberto Dati e Francesco Redi, vedi A. Mirto, Lorenzo Legati
e Firenze: carteggio con Francesco Redi e Antonio Magliabechi (1667-1676), in «Studi
secenteschi», L (2009), pp. 261-316; Id., Carlo Roberto Dati e Vincenzio Viviani: carteggio
(1659-1672), in «Studi secenteschi», LI (2010), di prossima pubblicazione.
4 Gilles Ménage (1613-1692), erudito francese, letterato di primo piano, mordace e
caustico, non ebbe molti amici in patria, tanto che gli vennero chiuse le porte
dell'Accademia di Francia. Al contrario in Italia ebbe estimatori sia tra i letterati che tra i
principi, e fino dal 1654 appartenne all'Accademia della Crusca. Su di lui vedi AA. VV.,
Menagiana, Paris, Florentin Delaulne, 1715; AA.VV., Gilles Ménage (1613-1692). Le
rayonnement de son œuvre linguistique. Actes du colloque international tenu à l’occasion du
tricentenaire du Dictionnaire étymologique ou Origines de la langue françoise (1694), (Université
Jean Moulin Lyon III, 17-19 mars 1994), Lyon, Société d’Etudes Historiques et
Linguistiques des Dictionnaires Anciens Université Jean Moulin, 1995; per i rapporti
con la Crusca vedi Catalogo degli accademici dalla fondazione, a cura di S. Parodi, Firenze,
presso l’Accademia, 1983, pp. 101-102.
5 Jean Chapelain (1595-1674), letterato, erudito, critico e poeta francese, fu uno dei
primi membri dell'Académie Française e dell'Académie des Inscriptions; accademico
della Crusca dal 2 settembre 1654 (S. Parodi, Catalogo, cit., p. 102); fu in rapporti
epistolari con il principe Leopoldo de’ Medici [Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
(BNCF), Lett. Aut. II, 14-15], con il Dati (BNCF, Baldovinetti 258, III, 11), con
Francesco Marucelli (BNCF, Lett. Aut. II, 16) e con Antonio Magliabechi (BNCF, Ms.
Magl. VIII 155, cc. 85r-87); J. Chapelain, Lettere inedite a corrispondenti italiani, con
introduzione e note di P. Ciureanu, Genova, Di Stefano editore, 1964; A. Mirto, Lettere
di Jean Chapelain a Carlo Roberto Dati, «Atti e memorie dell’Accademia Toscana di Scienze
e Lettere “La Colombaria”», LXX, n. s. LVI (2005), pp. 131-151.
6 Jean Thévenot, viaggiatore e nipote di Melchisédec, nato a Parigi nel 1633, dopo
la morte del padre, avendo ereditato una cospicua fortuna, si dedicò ai viaggi. Visitò i
Paesi Bassi, la Germania e l’Italia; quando entrò in contatto con Barthélemy d’Herbelot
gli nacque la passione per l’Oriente, perciò dopo una visita a Roma nel maggio del 1655,
nel giugno, s’imbarcò da Civitavecchia alla volta della Sicilia e, dopo aver toccato Malta,
si diresse a Costantinopoli, che rappresentò la base per la visita di altre località.
Rientrato in patria nell’ottobre del 1663, non tardò a ripartire e già nel gennaio dell’anno
seguente lo troviamo a Marsiglia da dove salpa per l’Oriente, dove rimane fino al
febbraio 1667, quindi cercò di rientrare attraverso l’Armenia e l’Asia Minore in Europa,
ma i lunghi viaggi avevano minato la sua salute e il 28 novembre spirò a Miana, piccolo
villaggio non distante da Tauris. Le relazioni dei suoi viaggi furono stampati a più
riprese a partire dal 1664. Su di lui, vedi Biographie Universelle (Michaud) ancienne et moderne,
Paris, chez Madame C. Desplaces et Leipzig, Librairie de F. A. Brockhaus, s. a., 41, pp.
326-327.
314
Logos
il nome di Alessandro VII7. Tornato a Parigi si dedicò completamente
agli studi, con particolare interesse per le discipline scientifiche. La
conoscenza delle lingue moderne, sia europee sia orientali, gli consentì di
entrare in contatto con gli eruditi del tempo e di ottenere la carica di
bibliotecario del re, nel 1684, carica che gli permise di arricchire la
raccolta reale di testi rari soprattutto attinenti alla geografia ed ai viaggi.
Fu amico di Henri-Louis Habert de Montmor8, che lo volle fra i suoi
collaboratori alla nascente Accademia delle Scienze, e di altri studiosi
francesi, per i quali fu intermediario con i dotti italiani9. I rapporti
epistolari che il Thévenot ebbe con il principe Leopoldo de’ Medici e con
Vincenzio Viviani riguardano gli scambi di notizie culturali e delle novità
scientifiche fra le due accademie alle quali i tre dotti appartenevano,
quella del Cimento e l’Accademia delle Scienze di Parigi. Interessanti
sono le novità che l’erudito francese spedì a Firenze e che trattano degli
esperimenti fatti dagli accademici parigini e da quelli inglesi. Le
annotazioni, in francese, appartengono al Thévenot e il principe
Leopoldo le fece tradurre in italiano; Giovanni Targioni Tozzetti
affermava che questa raccolta dette motivo agli Accademici del Cimento
di riprovare «alcune di esse Esperienze, e di farne altre correlative, ma in
maniera migliore, e più convincente»10. Le esperienze più rilevanti furono
elencate alla fine e riguardano quelle che si sarebbero dovute fare nelle
isole Canarie tra cui quella di osservare se «si congeli alcun vapore su la
superficie esterna di un vaso di vetro pieno di neve con infusione di sale»
e quella di «osservare la figura, colore, chiarezza del Sole, o della Luna
7 Su Fabio Chigi, eletto papa nel 1655, vedi AA.VV., Alessandro VII Chigi (15991667). Il papa senese di Roma moderna, a cura di A. Angelini, M. Butzek e B. Sani, Firenze,
Maschietto & Mugolino; Siena, Protagon editori toscani, 2000.
8 Henri-Louis Habert de Montmor (morto nel 1679), maître de requête, consigliere
del re di Francia, accademico, letterato ed erudito. Si interessò di questioni fisiche e di
storia naturale; fece della sua casa il berceau della futura Académie des Sciences, che fu
fondata nel 1666. Ricevette a casa sua personaggi di grande prestigio come Descartes,
Roberval ed i fratelli Dupuy. Fu tra i fondatori dell'Académie Française e amico di
Gassendi, di cui pubblicò le opere a proprie spese. Sulla sua appartenenza all’Accademia
della Crusca, vedi Catalogo degli accademici cit., p. 118.
9 Sul Thévenot, vedi AA.VV., Biographie Universelle, cit., pp. 323-326; D. S. Lux,
Patronage and royal science in seventeenth-century France. The académie de Physique in Caen, IthacaLondon, Cornell University Press, 1989, pp. 29-56; Id.,”Colbert’s Plan” for the Grande
académie. Royal Policy toward science, 1663-1667, in «Seventeenth-century French studies»,
XII (1990), pp. 177-188.
10 G. Targioni Tozzetti, Notizie degli aggrandimenti delle scienze fisiche accaduti in Toscana
nel corso di anni LX del secolo XVII, Firenze, Bouchard, 1780, p. 458 (l’opera del Targioni
Tozzetti si trova anche con il frontespizio Atti e memorie inedite dell’Accademia del Cimento e
notizie aneddoto dei progressi delle scienze in Toscana, Firenze, 1780, si vende da Giuseppe Tofani
Stampatore e da Luigi Carlieri Librajo).
La fortuna editoriale dei Saggi di naturali esperienze nei secoli XVII-XIX
nel tramontare e nel nascere; notare le parallassi, scintillazione, figura et
apparenze dei pianeti, e delle altre stelle, particolarmente di Saturno, di
Marte e di Giove col cannocchiale, e senza»11.
Dalla corrispondenza che Alessandro Segni ebbe durante il suo
viaggio per l’Europa con il principe Leopoldo, con Carlo Roberto Dati,
con Vincenzio Viviani12 e con lo stesso Lorenzo Magalotti13, traspare
l’interesse dei francesi per i Saggi che tardavano ad essere pubblicati.
Scriveva, infatti, il Segni: «Veridici e pieni di altra dottrina e sicura
saranno i Saggi di naturali esperienze, che con tanta ansietà s’aspettano da
questi signori che io non nominerò punto per esser quei medesimi che
V.A. mi ordinò di salutare a suo nome»14. Le esperienze, com’è noto, non
furono tutte riprodotte e come affermò il Targioni Tozzetti: «Gli
Accademici [fecero] una scelta d’alcune Esperienze, relative a certi soli e
determinati Capi, nei quali si erano meglio sodisfatti, ma ne tralasciarono
alquante che appartengono a questi medesimi Capi; forse per non si
dilungar troppo, o coll’idea di sodisfarvisi meglio sopra. Moltissime altre
poi restarono indietro, ed inedite, alcune delle quali, in questo frattempo
sono state preoccupate da altri Fisici Sperimentatori»15 Giovanni
Targioni Tozzetti, quando pensò di pubblicare le esperienze inedite e
BNCF, Ms. Gal. 270, c. 154r.
Vincenzio Viviani (1622-1703), matematico, discepolo di Galilei e di Torricelli.
Si occupò anche di idrodinamica e di altri problemi di fisica. Utilizzando le poche
notizie date da Pappo Alessandrino, ricostruì il V libro delle Coniche di Apollonio di
Perga. Curò pure un'edizione degli Elementi di Euclide (1690). Su di lui vedi V. Viviani,
Vita di Galileo, a cura di L. Borsetto, Bergamo, Moretti & Vitale, 1992; I. Maglioni,
Vincenzo Viviani e l’Arno. Scienza galileiana e problemi di un fiume e del suo bacino nel XVII
secolo, in «Archivio storico italiano», I, CLIX (2001), pp. 151-170; V. Viviani, Vita di
Galileo, a cura di B. Basile, Roma, Salerno editrice, 2001; A. Mirto, Lettere di Stefano Gradi
ai Fiorentini: Viviani, Dati, Redi, Leopoldo e Cosimo III de’ Medici, in «Studi secenteschi»,
XLIX (2008), pp. 371-404; Id., Carlo Roberto Dati e Vincenzio Viviani: carteggio (16591672), cit.
13 Lorenzo Magalotti (1637-1712) nacque a Roma da famiglia fiorentina, il padre
era prefetto dei corrieri pontifici; studiò presso il Collegio dei gesuiti e poi, a Pisa, fu
allievo del Malpighi, del Borelli e del Viviani. Molto giovane fu segretario
dell’Accademia del Cimento, per la quale curò i Saggi di naturali esperienze (Firenze,
Cocchini, 1667), “uomo d’ingegno aperto, di grande cultura, d’abitudini a forte tinta
epicurea”. Autore di novelle e poesie, di una difesa del cristianesimo nelle Lettere familiari
contro l’ateismo (Venezia, Coleti, 1719); di altre lettere inserite nelle Lettere familiari di
Lorenzo Magalotti e di altri insigni uomini (Firenze, Cambiagi, 1719) e delle celebri Lettere
sulle terre odorose d’Europa e d’America dette volgarmente buccheri (1695). Per la bibliografia
aggiornata su di lui, vedi Dizionario Biografico degli Italiani (DBI), Roma, Istituto
dell’Enciclopedia Treccani, 67, 2006, pp. 300-305, voce curata da C. Preti e L. Matt.
14 Lettera a Leopoldo de’ Medici datata Parigi 2 Aprile 1666 (BNCF, Ms. Galil.
277, cc. 265r-267r).
15 G. Targioni Tozzetti, Notizie degli aggrandimenti […], cit., I, p. 413.
11
12
316
Logos
prese in mano le carte dell’Accademia, trovò difficoltà a districarsi fra le
minute dei Saggi, che a suo dire avevano «tanti rassettaticci e […] tante
scassature, chiamate, mutazioni e cartucce appiccicate coll’ostia, che
fanno pietà, e non potrebbero credersi sennon da chi li veda»16. Altri
parleranno o hanno parlato di questi aspetti dei Saggi, noi ci
soffermeremo sull’iter della loro pubblicazione, anche se dobbiamo fin
da subito rilevare che le varie edizioni, che si sono susseguite nel
Seicento e nel Settecento hanno ripresentato la stesura originaria
dell’edizione princeps: lo stesso Targioni Tozzetti, che pure si era servito
dei Diari dell’Accademia, non solo, com’è già stato rilevato, non ci
mostra i Saggi nella loro evoluzione, «ma avendo egli voluto intercalare
col testo del Libro anche parte dei Diari delle Sessioni, anche di questi ci
ha dato una narrazione frammentaria e in contrasto coll’intendimento di
un diario che è quello di seguire il più strettamente possibile un ordine
cronologico»17. Successivamente, in occasione del Congresso degli
Scienziati Italiani, tenutosi a Firenze nel settembre del 1841, fu
pubblicata la terza edizione fiorentina dei Saggi, anche in questa sede
furono utilizzati i Diari e alla fine del libro furono stampate delle
Aggiunte, che come scrisse l’estensore della lettera ai Lettori, furono
«ricavate con studiosa e diligente scelta dalle annunziate Carte
dell’Accademia»18. Per avere un’edizione più completa bisogna aspettare
quella nazionale delle opere dei discepoli di Galilei del 194219, dopo di
Ivi, I, p. 417; la riproduzione dei Saggi si trova nel tomo secondo, parte seconda,
pp. 377-599; segue un’Appendice, dove sono riportate alcune annotazioni fatte da G. A.
Borelli, da V. Viviani e da C. Rinaldini (pp. 599-613), quindi una Seconda raccolta di
memorie dell’Accademia del Cimento, che comprende le osservazioni, ed esperienze naturali, che non
ebbero luogo nei Saggi (pp. 615-715).
17 AA.VV., Le opere dei discepoli di Galileo Galilei. L’Accademia del Cimento. Parte
Prima, Firenze, Barbèra editore, 1942, p. 32.
18 Saggi di naturali esperienze, Firenze, Dai torchi della Tipografia Galileiana, 1841,
Aggiunte, p. IV.
19 Il progetto della pubblicazione di tutto il materiale relativo all’Accademia del
Cimento si può leggere nell’Avvertimento posto all’inizio Le opere dei discepoli di Galileo
Galilei. L’Accademia del Cimento. Parte Prima, cit., pp. 4-6; questo volume comprende:
i Saggi (pp. 81-270), Varianti ed osservazioni per la stampa dei Saggi suggerite dagli accademici
(pp. 273-278), Primo disteso dei Saggi sottoposto all’esame degli accademici (pp.281-322),
Correzioni, osservazioni e proposte fatte dagli accademici sul disteso del codice A (pp. 325-348),
Miscellanea di esperienze varie con le correzioni degli accademici (pp. 351-381), Varianti
all’esperienze dei Saggi proposte varie di esperienze e strumenti rivendicazioni (pp. 385-446), Suoni,
luce, strumenti, pendolo. Osservazioni elettriche e varie (pp.449-480), Esperienze sul peso assoluto
dell’aria (pp. 483-494).
16
La fortuna editoriale dei Saggi di naturali esperienze nei secoli XVII-XIX
che sui Saggi sono tornati Enrico Falqui, nel 194720, e Teresa Poggi Salani
nel 197621.
Il principe Leopoldo decise che ad occuparsi della parte editoriale
avrebbe dovuto essere il segretario dell’Accademia, Lorenzo Magalotti
che, in accordo con gli altri accademici, dovette stabilire quali esperienze
riportare. Perciò ogni accademico fu incaricato di leggere la bozza o la
minuta concernente i vari esperimenti elaborata dal Segretario,
annotando quello che credesse doversi mutare o correggere. Per la
stesura finale, il Principe pensò di far seguire il giovane estensore da
alcuni accademici considerati ricercatori più dello stesso Magalotti, che
pur avendo una cultura scientifica, era portato «per istinto a cercare […]
ciò che è “ammirabile”, “bizzarro”, “stupendo”, [e] si capisce che ciò che
davvero lo affascina, al di là del resoconto che stende e della
registrazione dei fenomeni, non è la scoperta della verità, è l’aspetto delle
cose, e in modo tutto particolare le contraddizioni che la natura sembra
presentare, sulle quali gli piace indugiare, non per scoprirne il segreto, ma
per perdersi in esse svelando la sua ammirazione venata di uno
scetticismo lieve»22. I revisori dell’opera furono perciò importanti
studiosi, a cominciare da Giovanni Alfonso Borelli23 e poi Vincenzio
Viviani, Carlo Rinaldini24 e Michelangelo Ricci25; mentre fecero
Saggi di naturali esperienze fatte nell’Accademia del Cimento sotto la protezione del
Serenissimo Principe Leopoldo di Toscana e descritte da Segretario di essa Accademia: Lorenzo
Magalotti. Ristampa integrale illustrata a cura di E. Falqui, Edizioni numerate per sé e per pochi di
Colombo, Roma, 1947 (di questo testo abbiamo una riproduzione per conto della
Sellerio, Palermo 2001).
21 Saggi di naturali esperienze di Lorenzo Magalotti, a cura di T. Poggi Salani, Milano,
Longanesi, 1976.
22 Saggi, a cura di T. Poggi Salani, cit., p. 31.
23 Sugli studi dedicati a Giovanni Alfonso Borelli ha fatto il punto, di recente, Luigi
Guerrini nel suo articolo Matematica ed erudizione. Giovanni Alfonso Borelli e l'edizione
fiorentina dei libri V, VI e VII delle Coniche di Apollonio di Perga, in «Nuncius. Annali di
storia della scienza», XIV, 2 (1999), pp. 505-568.
24 Carlo Rinaldini o Renaldini (1615-1698), professore di matematica allo Studio
pisano dal 1643 al 1663; abbandonò il Granducato nel 1666, trasferendosi a Padova,
dove insegnò anatomia e medicina. Pubblicò, tra il 1681 e il 1688 la Philosophia rationalis,
naturalis atque moralis (Patavii, Sumptibus Petri Mariae Frambotti), che fu la sua maggiore
opera. Tentò più volte di tornare ad insegnare a Pisa, ma i suoi sforzi ebbero sempre
esiti negativi, anche per le contrapposizioni teoriche con Redi e Viviani. Su di lui, vedi
A. Brigaglia, Algèbre et géométrie dans l’œuvre de Carlo Renaldini, Géométrie, atomisme et vide dans
l’école de Galilée, textes réunis par E. Festa, V. Jullien et M. Torrini, Fontenay/SaintCloud, ENS Éditions, 1999, pp. 79-96.
25 Michelangelo Ricci (1619-1682), matematico, legato agli eruditi dell’accademia
del Cimento ed in rapporto con il cardinale Leopoldo de’ Medici, che lo considerava
20
318
Logos
osservazioni di carattere linguistico e grafico Ottavio Falconieri26 e Pietro
Sforza Pallavicino27. Le prime bozze furono corrette da Francesco
Ridolfi28 e da Alessandro Segni. I Saggi, iniziati nel 1662, poterono essere
considerati ultimati nel 1664 e la voce di una loro pronta pubblicazione
dovette circolare negli ambienti della Repubblica Letteraria, tanto che
Pieter Blaeu29, figlio di quel Joan Blaeu, stampatore olandese famoso per
i suoi Atlas30, li considerava addirittura editi se, nella lettera del 22 agosto
1664, scriveva ad Antonio Magliabechi di onorarlo di uno o due
esemplari «delle Esperienze fatte nell’Accademia di quella Ser.ma
Corte»31. Pieter Blaeu conosceva personalmente, oltre al Magliabechi ed i
principi di casa Medici, molti degli eruditi che ruotavano intorno al
principe Leopoldo; infatti, egli era stato a Firenze nel 1660 ed aveva
saggio ed equilibrato, specie nelle questioni che potevano interferire con le autorità
ecclesiastiche.
26 Ottavio Falconieri (1636-1675), letterato, studioso di antichità; partecipò
all’Accademia della Crusca, nella quale fu provveditore allo stravizzo del 1660. Su di lui
vedi Dizionario Biografico degli Italiani (DBI), Roma, Istituto dell’Enciclopedia, 44, 1994,
pp. 385-388, voce curata da M. Sanfilippo; Lettere di Ottavio Falconieri a Leopoldo de’ Medici,
a cura di L. Giovannini. Presentazione di M. Gregori, Firenze, Edam, 1984; per la sua
partecipazione all’Accademia della Crusca, vedi S. Parodi, Catalogo cit., pp. 106-107.
Sulla famiglia interessanti notizie in I. Fosi, All’ombra dei Barberini. Fedeltà e servizio nella
Roma barocca, Roma, Bulzoni, 1997.
27 Pietro Sforza Pallavicino o Pallavicini (1607-1667), gesuita e cardinale, si laureò
in diritto canonico alla Sapienza (1625) e in teologia al Collegio romano (1628). Fu
amico di Giovanni Ciampoli e principe dell’Accademia degli umoristi; nel 1630 prese gli
Ordini minori e nel 1637 entrò nella Compagnia di Gesù; fu professore prima di
filosofia (1639-43), poi di teologia al Collegio romano; fu nominato cardinale da
Alessandro VII il 10 dicembre 1659, e fu membro della Congregazione. L’opera per la
quale viene maggiormente ricordato, e che la Curia romana oppose a quella di Paolo
Sarpi, è l’Istoria del Concilio di Trento (1656-57). Sull’appartenenza ai Lincei si veda G.
Gabrieli, Verbali delle adunanze e cronaca della prima Accademia dei Lincei (1603-1630), in
«Atti dei Lincei - Memorie», II, serie VI, fasc. VI (1927), p. 507; si veda, pure, M. L.
Altieri Biagi, Il “Dialogo” di Galileo e l’ “arte del dialogo” di Sforza Pallavicino, in «Lingua e
stile», I (2002), pp. 65-74.
28 Francesco Ridolfi (morto nel 1697), letterato, accademico della Crusca (Catalogo
degli accademici, cit., pp. 100-101); maestro di camera del cardinale Pignatelli, futuro papa
Innocenzo XII; membro dell'Accademia Fiorentina e dell'Accademia Reale di Cristina
di Svezia.
29 Sui Blaeu, vedi A. Mirto & H. Th. Van Veen, Pieter Blaeu: Lettere ai fiorentini
Antonio Magliabechi, Lopoldo e Cosimo III de’ Medici, e altri, 1660-1705, Firenze, Istituto
Universitario Olandese di Storia dell’Arte – Amsterdam & Maarssen, APA – Holland
University Press, 1993.
30 Geographia quae est Cosmographiae Blavianae (Atlas), Amstelodami, apud Johannem
Blaeu, 1662.
31 A. Mirto & H.Th. Van Veen, Pieter Blaeu: Lettere ai fiorentini, cit., p. 125.
La fortuna editoriale dei Saggi di naturali esperienze nei secoli XVII-XIX
stretto rapporti con Carlo Roberto Dati, Lorenzo Panciatichi32, Carlo
Rinaldini, Michele Ermini33 ed altri. Alessandro Segni durante il suo
viaggio per l’Europa, quando arrivò ad Amsterdam non mancò di visitare
Pieter Blaeu e la sua stamperia che si trovava sul Damrak34. A proposito
del Blaeu, l’11 luglio 1666, il Segni scriveva: «Nel vecchio [Joan] e nel
giovane [Pieter] Blaeu ho trovato qui in Amsterdam un’umanità infinita.
Aspetta il signor Pietro molti libri che V.S. [Leopoldo de’ Medici] gli
accenna inviarli per distribuire in diverse parti, forse saranno con quelli
che ella medesima mi dice inviarmi a Brusselles, dove sarò fra otto giorni.
Aspettano questi Signori pure ancora i disegni delle piazze del Ser.mo
Gran Duca a che han dedicato tutto intero un volume del lor Teatro
d’Italia. Lavorano di presente sopra lo Stato di Savoia e vi consumeran
molti mesi, forse al mio ritorno costà com’è informato del desiderio di
questi Signori e del modo tenuto a Venezia, e a Turino potrò servire in
cosa di tanto splendor del paese»35.
32 Lorenzo Panciatichi (1635-1676). Di nobilissima famiglia, fu uomo di
vivacissimo ingegno, di rara erudizione, poeta satirico e scrittore elegante. Canonico
della Metropolitana fiorentina, gentiluomo del principe Leopoldo e suo bibliotecario.
Ebbe missioni diplomatiche all’estero; fu membro dell’Accademia Fiorentina e fece
parte dell’Accademia della Crusca, di cui fu massaio nel 1655-56, censore nel 1658-59 e
1666-67, arciconsolo nel 1669; provveditore allo stravizzo del 1660 (S. Parodi, Catalogo
cit., p. 101; L. Passerini, Genealogia e storia della famiglia Panciatichi, cit.). Sulla sua morte il
Bisdosso scrive: «Adì 12 giugno 1676, il Sig.r canonico Panciatichi ammalato più
d’ipocondria, e d’umor malinconico che d’altro, si gettò nel pozzo della propria casa
posta in via de’ Servi; la qual cosa aveva tentato di fare più volte, che perciò un servitore
lo guardava giorno e notte; questo servitore sopraffatto dal sonno per le molte vigile
fatte si messe a traverso all’uscio, e s’addormentò di maniera, che il Canonico levatosi,
et aperto l’uscio, lo cavalcò, e si gettò nel pozzo, dove affogò senza che egli sentisse
nulla, e si credette che la continua applicazione allo studio lo rendesse delirante»
(Bisdosso o’ vero Diario del Pastoso. A Firenze, in Italia, in Europa nel Seicento, Firenze, Ente
Cassa di Risparmio, 1999, c. 145); Scritti vari di Lorenzo Panciatichi accademico della Crusca,
raccolti da C. Guasti, Firenze, Le Monnier, 1856.
33 Michele Ermini (morto verso il 1677, secondo la testimonianza del Magliabechi),
bibliofilo e grecista fiorentino, accademico della Crusca; dal 1658 fu membro della
deputazione del latino per la terza impressione del vocabolario. Di lui abbiamo alcune
opere inedite conservate nella BRF (cod. Car. 2568, 2478, 2712; cod. Ch. 1188); per la
sua appartenenza alla Crusca, vedi Catalogo degli accademici, cit., p. 104.
34 Il Blaeu, il 9 luglio 1666, così scriveva ad Antonio Magliabechi: «Il Sig. Marchese
Francesco Riccardi et il Sig. Alessandro sono stati alcuni giorni in questa città, et hanno
comprato da me molti libri, fra li quali sono alcuni per il Ser.mo Principe di Toscana»
(A. Mirto & H. TH. Van Veen, Pieter Blaeu: Lettere ai fiorentini cit., p. 151).
35 BNCF, Aut. Palat. V, 101, lettera di Alessandro Segni a Leopoldo de' Medici del
1 luglio 1666. Per le vicende della pubblicazione del volume Teatro d'Italia relativo alla
Toscana, vedi A. Mirto & H. TH. Van Veen, op. cit., passim; A. Mirto, Stampatori, editori,
librai nella seconda metà del Seicento. I grandi fornitori di Antonio Magliabechi e della corte medicea,
320
Logos
Il Segni, nel suo Diario, si soffermò lungamente sul soggiorno ad
Amsterdam: vi si può leggere la visita che fece insieme al marchese
Riccardi alla tipografia dei Blaeu, in quel momento una delle maggiori
d'Olanda e quindi del mondo. Annotava il Segni: «Di buonissima ora
andai alla bottega del Blaeu. Parlai col Signor Giovanni, e appresso col
Signor Pietro suo figliuolo e sodisfeci con tutti due gli ordini che avevo
dal Signor Principe Leopoldo di riverirgli in suo nome. Mi mostrarono i
disegni e piante avuti di Savoia per fare nel Teatro d'Italia il volume
contenenti gli Stati di Sua Altezza Reale. Comparve il Signor Marchese
Francesco e tutti insieme andammo a vedere la stamperia de’ Signori
Blaeu che è in luogo assai lontano dalla casa e bottega loro. Colà in
grandi armadi son i rami per le figure cosmografiche In una stanza allato
sono i torcoli per tirar le medesime figure in numero di nove. In altro
simil salone sono parimente nove torcoli, distinti co’ nomi delle Muse,
per istampare. Nella parte più alta della casa sono i magazzini con molti
lavori fatti, e in particolare libri di rosso e nero, come Breviari, Messali e
simili, per la valuta de’ quali passa d'Italia gran somma di denaro in
Olanda. In altre stanze ci mostrarono caratteri latini, greci, ebraici, siriaci,
persiani, arabi e tedeschi, strumenti e madri per gettare i medesimi
caratteri e grandissima quantità di strumenti Cosmografici e
Astronomici»36.
L’iter editoriale37 dei Saggi fu lungo e laborioso per molteplici motivi,
primo dei quali l’insicurezza del Magalotti circa il suo stile: dobbiamo
evidenziare che la scelta del Magalotti a redigere i Saggi suscitò qualche
perplessità nell’ambiente fiorentino, per più motivi; Magalotti era giovane
e, soprattutto, pur essendo di famiglia fiorentina, era di cultura romana.
Perciò, a molti sembrava che la sua prosa non fosse pulita come quella di
un Dati o di un Redi. Dobbiamo anche rilevare che il primo segretario
dell’Accademia era stato Alessandro Segni, forse perché segretario del
Firenze, Centro editoriale toscano, pp. 61-68, mentre quello relativo al Piemonte è
Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis Pedemontii Principis [...], Amstelodami,
apud Haeredes Joannis Blaeu, 1682.
36 Biblioteca Riccardiana di Firenze, Aut. Ricc. 2296, cc. 231-232. Di questo
avvenimento abbiamo cenni anche in una lettera di Pieter Blaeu ad Antonio
Magliabechi, nella quale si affermava che il Segni ed il Riccardi nella loro visita alla
bottega dei Blaeu avevano acquistato vari libri sia per il principe Leopoldo, sia per
Cosimo de' Medici (A. Mirto & H. TH. Van Veen, Pieter Blaeu cit. p. 151, lettera del 9
luglio 1666).
37 Il Targioni Tozzetti scrive che il principe Leopoldo «volle che [il libro dei Saggi]
si pubblicasse colla data del 1666 e colla data arretrata della dedicatoria del 14 luglio
1667, cioè cinque mesi avanti a che egli fosse creato cardinale, com’era attualmente
allora» (G. Targioni Tozzetti, Notizie degli aggrandimenti […], cit., p. 464).
La fortuna editoriale dei Saggi di naturali esperienze nei secoli XVII-XIX
principe Leopoldo, ma egli, pur essendo buon letterato, mancava di una
preparazione scientifica necessaria per comprendere il significato delle
varie esperienze. Ecco perché defilatosi i più importanti rappresentanti
dell’Accademia, il principe Leopoldo de’ Medici pensò di far cimentare il
più giovane, ma anche il più volenteroso di quelli rimasti38. Della
difficoltà di portare avanti la stesura dei Saggi, lo stesso Magalotti si fa
interprete in una lettera ad Ottavio Falconieri, dove a proposito
dell’opera scriveva: «Del libro non so che dirti: mi vergogno, ma è mia
colpa, anzi d’una avversione invincibile che ho concepita contro di esso.
Sono alcune poche settimane che ho rimesso mano alla stampa, che ha
dormito sedici mesi. A dirtela, io sono malissimo soddisfatto del mio
disteso, né è possibile ch’io ci accomodi l’animo. Pensa ch’io considero
questo libro come un mezzo che dovrà affatto screditarmi: or vedi se con
ragione ci vado di male gambe. Però ti giuro di volere adesso non
distaccar le labbra da questo calice amaro, finché ve ne rimarrà una
gocciola»39.
Tuttavia, anche quando la stampa fu ultimata, gli esemplari non
ebbero vasta circolazione prima di tutto perché non erano in vendita,
salvo qualche eccezione: delle ottocento copie stampate40, poche
probabilmente ne furono vendute; è il caso di ricordare gli esemplari che
Antonio Magliabechi41 spedì a Venezia, Amsterdam e Lione: il 10
dicembre 1667, Giovanni La Noù, olandese trapiantato nella città
lagunare ed associato a Sebastiano Combi, libraio e stampatore
veneziano42, avvertiva Antonio Magliabechi di aver ricevuto, franco di
Un elemento che poteva occuparsi della stesura dei Saggi era forse Vincenzio
Viviani, ma egli era troppo intento a concentrarsi sia sui suoi studi, sia sulla possibilità
di poter pubblicare Opera omnia del suo maestro Galileo, dopo l’edizione mutila degli
eredi Dozza di Bologna del 1656.
39 L. Magalotti, Lettere familiari, I, p. 159, lettera del 30 marzo 1666.
40 BNCF, Ms. Magl. X.68 (Scritture per l’Accademia del Cimento). Si tratta delle
spese necessarie per la stampa dei “Saggi” (Magliabechi, in alcuni appunti che dovevano
costituire il canovaccio di una lettera al principe Leopoldo, contesta la somma della
spesa presentata dall’editore).
41 Su Antonio Magliabechi, vedi A. Mirto, Lettere di Antonio Magliabechi ad Étienne
Baluze, in «Studi Secenteschi», XLVI (2005), pp. 319-342; Id., Il carteggio degli Huguetan con
Antonio Magliabechi e la corte medicea. Ascesa e declino di un’impresa editoriale nell’Europa
seisettecentesca. Presentazione di F. Lomonaco, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005; DBI,
67, 2006, pp. 422-427, voce curata da M. Albanese.
42 Su questi personaggi, vedi A. Mirto, Librai veneziani nel Seicento: i Combi-La Noù ed
il commercio con l’estero, in «La Bibliofilía», XCI (1989), III, pp. 287-305; Id., Librai veneziani
del Seicento: i Combi – La Noù ed il commercio librario con Firenze, in «La Bibliofilía», XCIV
(1992), 1, pp. 75-78. Una notizia di possibile invio dei Saggi a Padova per un baratto tra
Francesco Passerini, libraio fiorentino, e i Frambotti, stampatori e librai della città
38
322
Logos
porto, due esemplari dei Saggi e di avergli accreditato lire fiorentine 32,
Giovanni La Noù aggiungeva: «ci è stato molto a caro d’haverlo avuto
delli primi, per poterlo mostrar a un curioso cavalier», e ancora il 19
gennaio del 1669, lo stampatore olandese scriveva: «delle tre Esperienze
daremo credito a V.S.»; infine il 23 febbraio 1669, il La Noù comunicava
al Bibliotecario fiorentino di aver ricevuto altri due esemplari dei Saggi e
che gli aveva dato credito di lire 45 e 4 soldi; il 19 gennaio 1668, il libraio
Filippo Borde, uno degli Associati lionesi43, scriveva al Magliabechi: «V.S.
vederà per detta factura como in detto fardo vanno gli libri che noi à
chiesto per il montare delli sei trattati d’Experienze che à rimezzo per
nostro conto al Signore de Gastines44 de Livorno como anchora quattro
Franzius De Competentiis Iurisdictionis45 gratis per compensare quelli
altri libri che V.S. giudicarà a proposito di presentare a cotesti Signori
Principi e altri amici afficionati che gli danno commissioni di libri»; 46
altro motivo che contribuì alla mancata diffusione fu la pubblicazione dei
Saggi in lingua toscana; all’estero vennero apprezzati da un numero
ristretto di studiosi; Jean Chapelain, per esempio, in una lettera a
Leopoldo de’ Medici affermò che il «Libro pubblicato sotto la sua
protezione chiamato Saggi di Naturali Esperienze […] sarà ormai il
principale ornamento del mio Gabinetto e la delizia del mio animo».47 Il
«Journal des Savants», però, non fa alcun accenno all’edizione,
nonostante il principe Leopoldo abbia inviato più copie a Parigi e a
Lione. Probabilmente questo silenzio è da attribuire alla crisi in cui
versava, in quel momento, il periodico francese48: 11 numeri nel 1668, 4
nel 1669 e uno soltanto nel 1670 e, forse, anche per motivi di gelosia,
infatti, molte esperienze fatte nell’Accademia, trovavano riscontro anche
veneta si legge in una lettera del Magliabechi a Fabrizio Cecini, segretario personale del
cardinale Leopoldo de’ Medici (BNCF, Ms. Fondo Nazionale II.IV 545, c. 16, senza data).
43 Sui Borde-Arnaud e Associati lionesi, vedi S. Ussia, Carteggio Magliabechi. Lettere di
Borde, Arnaud e Associati lionesi ad Antonio Magliabechi (1661-1700), Firenze, Olschki, 1980;
A. Mirto, Lettere di Borde, Arnaud, Rigaud e associati lionesi a Carlo Roberto Dati, ad Antonio
Magliabechi, a Leopoldo e a Cosimo III de’ Medici, in «Culture del testo», 26 (2008), pp. 5-23.
44 Sul De Gastines, vedi R. De Magistris, Il mercante e il bibliotecario. La circolazione del
libro nelle lettere di Gilles De Gastines a Magliabechi (1661-1709), in «Biblioteche oggi», III
(1985), pp. 93-113; A. Mirto, Il carteggio degli Huguetan con Antonio Magliabechi e la corte
medicea, cit.
45 D. A. Frances De Urrutigoito, Tractatus de competentiis iurisdictionis inter Curiam
Ecclesiasticam et secularem et de Officio Canciliarii Regnorum Coronae Aragonum, Lugduni, Ph.
Borde et L. Arnaud, 1667.
46 S. Ussia, Carteggio Magliabechi. I Borde, Arnaud e Associati lionesi, cit., p. 117.
47 BNCF, Ms. Gal. 278.
48 J.-M. Gardair, Le «Giornale de’ Letterati» de Rome (1668-1681), Firenze, Olschki,
1984, p. 182.
La fortuna editoriale dei Saggi di naturali esperienze nei secoli XVII-XIX
in quelle portate avanti da scienziati francesi49. Mentre il principe
Leopoldo, ora cardinale, inviava esemplari lussuosamente rilegati
all’estero, in Italia, i Saggi tardavano ad essere conosciuti. La difficoltà
della circolazione del testo nella Penisola è senz’altro da collegare agli
argomenti galileiani, che ancora rimanevano proibiti, ma non dobbiamo
dimenticare che già qualche anno addietro il principe Leopoldo si era
fatto promotore dell’edizione bolognese delle opere di Galilei50, anche se
parziale, e che gli stessi Saggi avevano avuto l’Imprimatur necessario.
L’ambiente italiano restava restio ad accettare quest’opera probabilmente
perché era intriso di cultura controriformistica, principalmente in alcuni
ambienti ecclesiastici ed universitari, dove predominava ancora la cultura
peripatetica. È il caso di ricordare le difficoltà che incontrò Alessandro
Marchetti nel pubblicare la traduzione del De rerum natura di Lucrezio51,
tanto che dovette rassegnarsi a desistere, perché attaccato dai sostenitori
della filosofia tradizionale ed abbandonato dal cardinale Leopoldo: ma i
tempi erano ulteriormente peggiorati, dopo la morte del granduca
Ferdinando II, anche lui in qualche modo vicino alle posizioni dei
“moderni”, e l’ascesa al trono di Cosimo III, molto più vicino agli
ambienti ecclesiastici e monastici rispetto a suo padre52. D’altra parte lo
stesso «Giornale dei Letterati», stampato a Roma nel presentare i Saggi
non andava al di là di una mera descrizione retorica, nonostante che vi
fosse la mediazione di Michelangelo Ricci, che ben conosceva l’ambiente
fiorentino. Ecco cosa scriveva il «Giornale dei Letterati»: «Non solo in
riguardo dello stile che può servir di regola a gli studiosi della buona
lingua Toscana, ma per la nobiltà del soggetto ancora, trattandosi in esso
di molti esperimenti, co’ quali si può arricchire la Filosofia di ben mille
verità da chi saprà saggiamente maneggiarli, ed usarli ne’ suoi discorsi.
Non si deve né meno tralasciare di considerare la qualità de’ virtuosi che
sono concorsi a quest’opera di sublime ingegno, e di maturo giudicio, e
49
395.
G. Targioni Tozzetti, Notizie degli aggrandimenti […], cit., II, Parte seconda, p.
G. Galilei, Opere […]. In questa nuova edizione insieme raccolte, e di varij Trattati
dell’istesso Autore non più Stampati accresciute […], Bologna, per gli HH. del Dozza, 1656.
Per gli studi più recenti su Galileo, vedi Galileo e l’universo dei suoi libri, Firenze, Vallecchi,
2008; A. Righini, Galileo tra scienza, fede e politica, Bologna, Editrice Compositori, 2008; L.
Guerrini, Galileo e la polemica anticopernicana a Firenze, Firenze, Polistampa, 2009.
51 Sulle vicende della traduzione del De rerum natura, vedi A. Marchetti, Della natura
delle cose di Lucrezio, a cura di D. Aricò, Roma, Salerno editrice, 2003.
52 Fra i tanti ordini sponsorizzati da Cosimo III, vi fu quello dei padri alcantarini,
chiamati nel 1678 e sistemati nei pressi della Villa dell’Ambrogiana, dove furono eretti
un convento e una chiesa dedicata a San Pietro d’Alcantara. Su quest’aspetto, vedi N.
Nelli, Il Convento del Granduca Cosimo III all’Ambrogiana, Firenze, Giampiero Pagnini
editore, 1998.
50
324
Logos
di molta destrezza, industria, e diligenza nel far tali esperienze; e per
ultimo, che da pregio singolarissimo al tutto, quello che vi ha contribuito
il Sig. Principe Leopoldo hoggi Cardinale di Santa Chiesa con l’autorità e
la protettione, con la sua magnificenza, sommo giudicio, e profonda
intelligenza»53.
Se i Saggi, come opera complessiva, non ebbero la rilevanza meritata,
«Il Giornale de Letterati» non mancò di recensire le pubblicazioni dei
singoli membri dell’Accademia del Cimento o rilevare l’importanza delle
scoperte e degli studi che direttamente o indirettamente si collegavano
all’accademia fiorentina. Com’è già stato affermato, ben tre generazioni
di galileiani sono rappresentati nelle pagine del periodico romano: dal
Doni54 e Ciampoli,55 contemporanei del Galileo, al Borelli sino ad
Alessandro Marchetti56, Donato Rossetti57 e Geminiano Montanari58,
questi ultimi due, come rileva Vincenzio Antinori, possono considerarsi
«come corrispondenti dell’Accademia e – aggiunge - di loro dirò due
parole ponendoli insieme, di che se fossero in vita non mi saprebbero
buon grado, perché furono acerrimi disputatori, e la loro lunga ed
ostinata contesa, non per sazietà, ma per stanchezza alla fine si tacque; in
questa come in tutte le altre dispute di simil genere l’umanità vi perde
53 «Il Giornale de Letterati», Roma, per Nicolò Angelo Tinassi, 1668, p. 4 [primo
numero (28 gennaio 1668); ai Saggi sono dedicate le pp. 4, 5 e parte della 6]; J.-M.
Gardair, Le «Giornale de’ Letterati» de Rome, cit., p. 182.
54 Giovanni Battista Doni (1594-1647), letterato e scrittore musicale, dopo essere
stato a Roma al servizio di Francesco Barberini, con il quale andò in Francia ed in
Spagna, nel 1640 ritornò a Firenze, dove il granduca Ferdinando II gli offrì una cattedra
di eloquenza e un lettorato di greco allo Studio fiorentino; in questo incarico alla sua
morte gli subentrò Carlo Roberto Dati, che raccolse una buona parte delle Iscrizioni
antiche copiate dal Doni sia a Roma che a Firenze e che vennero pubblicate da Anton
Francesco Gori nel 1731. Sul Doni, vedi bibliografia in A. Mirto, Lucas Holstenius e la
corte medicea, cit., p. 390.
55 Giovanni Battista Ciampoli (1589-1643), su cui vedi DBI, 25, 1981, pp. 147-152;
F. Favino, Deux dialogues retrouvés de Giovanni Ciampoli, in AA.VV., Géométrie, atomisme et
vide dans l’école de Galilée, cit., pp. 25-42.
56 Alessandro Marchetti (1633-1714); su di lui vedi Introduzione a A. Marchetti, Della
natura delle cose di Lucrezio, cit., pp. VII-LVIII.
57 Donato Rossetti (1633-1686), allievo del Borelli e professore di filosofia a Pisa,
sostenitore dell’atomismo e amico di Francesco Redi. Su di lui, vedi S. Gómez López,
Donato Rossetti e le Cercle Pisan, in AA.VV., Géométrie, atomisme et vide dans l’école de Galilée,
cit., pp. 281-297.
58 Geminiano Montanari (1633-1687), professore di matematica a Bologna e a
Padova; su di lui vedi F. Cattelani Degani – M. U. Lugli, Cinque lettere di Geminiano
Montanari a Gian Domenico Cassini, in «Nuncius», XIX (2004), 1, pp. 205-223; M. U.
Lugli, Astronomi modenesi tra Seicento e Novecento Geminiano Montanari, Modena, Edizioni Il
Fiorino, 2004.
La fortuna editoriale dei Saggi di naturali esperienze nei secoli XVII-XIX
molto e la scienza nulla guadagna»59. Anche Francesco Redi e Carlo
Roberto Dati figurano tra gli autori recensiti nell’annata 1668 del
periodico di Francesco Nazari: il primo apre il numero del 28 dicembre
per l’opera le Esperienze intorno alla generazione degl’Insetti60, il secondo
appare nel numero di gennaio per le Vite de’ pittori antichi61.
I Saggi di naturali esperienze (cioè “di esperienze sopra le cose
naturali”), quindi, uscirono da sotto i torchi nell’ottobre 1667, dopo una
gestazione durata almeno cinque anni; l’opera, infatti, come già è stato
rilevato, era quasi pronta nel 1662 ed ebbe l’imprimatur nel 1664; quando
il libro uscì, il Magalotti non si trovava nemmeno a Firenze, ma era in
giro per l’Europa ed aveva lasciato l’incombenza del Proemio ad Ottavio
Falconieri, il quale si rivolse al priore Orazio Ricasoli Rucellai62 e a suo
figlio Luigi63, che portarono a termine l’operazione. Così si esprimeva il
Magalotti in una lettera ad Ottavio Falconieri: «Benissimo hai fatto a
intendertela con Luigi Rucellai circa il proemio, perché egli ed il Priore,
59 V. Antinori, Notizie istoriche relative all’Accademia del Cimento, in AA.VV., Saggi di
Naturali Esperienze fatte nell’Accademia del Cimento, terza edizione fiorentina, Firenze, dai
torchi della Tipografia Galileiana, 1841, p. 85; sulle opere, sugli autori citati nel
«Giornale dei Letterati», vedi J.-M. Gardair, Le «Giornale de’ Letterati» de Rome, cit., pp.
182-185.
60 F. Redi, Esperienze intorno alla generazione degl’insetti, in Firenze, all’Insegna della
Stella, 1668.
61 C. R. Dati, Vite de’ pittori antichi scritte e illustrate da Carlo Dati nell’Accademia della
Crusca lo Smarrito …, in Firenze, nella Stamperia della Stella, 1667.
62 Orazio Ricasoli Rucellai (1604-1674), figlio di Giovambattista Ricasoli e di
Virginia d’Orazio Rucellai, da cui prese il nome, priore dell’Ordine di Santo Stefano; fu
membro dell’Accademia Fiorentina, di cui fu consolo nel 1653; accademico della
Crusca, con il nome di Imperfetto dall’11 agosto 1626; ricoprì la carica di arciconsolo dal
1650 al 1651; fu membro della deputazione per il Vocabolario dal 1650, per il quale
spogliò le opere di Giovanni Della Casa. Autore di dialoghi e di cicalate, alcune delle
quali inserite nelle Prose fiorentine. Gentiluomo di Camera di Ferdinando II e di Cosimo
III; nel 1657, fu nominato soprintendente della Libreria di San Lorenzo. Su di lui, vedi
S. Parodi, Catalogo cit., p. 62; A. Mirto, Lucas Holstenius e la corte medicea cit., p. 313; S.
Caroti, Orazio Ricasoli Rucellai: un galiléen platonicien, in AA.VV., Géomètrie, atomisme et vide
dans l’école de Galilée, cit., pp. 229-250 ; G. Lazzi – I. Truci, Les papiers d’Orazio Ricasoli
Rucellai acquis par la Bibliothèque Nationale de Florence, in AA.VV., Géomètrie, atomisme et vide
dans l’école de Galilée, cit., pp. 251-256.
63 Luigi Rucellai (1639-1704), figlio di Orazio Ricasoli Rucellai, letterato di buona
fama, accademico della Crusca, dove recitò interessanti 'cicalate' e l'orazione funebre in
morte di Ferdinando II, pubblicata nel 1671; dal Diario di Agostino Nelli, apprendiamo
che fu eletto Arciconsolo dell’Accademia della Crusca nella seduta del 23 agosto 1670,
nella stessa occasione venne letta una lettera di ringraziamento del cardinale di Retz
(BNCF, Fondo Nazionale II. 15, a, c. 340). Su di lui, vedi S. Parodi, Catalogo cit., p. 109; F.
Passerini, Genealogia e storia della famiglia Ricasoli, Firenze, Coi tipi di M. Cellini e C. alla
Galileiana, 1861, pp. 91-92.
326
Logos
chiotti, chiotti, senza motivarne al Sig. Principe, aggiusteranno quel che
bisogna. Basta, io non vorrei che il Sig. Michelangelo Ricci obbligasse a
mutar pensiero, perché più tosto voglio farlo stampare in Ginevra.
Capperi, quest’uomo mi riesce stitico; o la difficoltà nasce dalla cosa in
sé, o da ignoranza, o da sottigliezza del Revisore64 [P. fra Sebastiano da
Pietrasanta zoccolante]: se nasce di qui, perché non si può rendere
capace? Or facciamo un po’ quel che e’ vogliono e la finiscano in tanta
malora»65.
Orazio Ricasoli Rucellai, il priore e suo figlio Luigi Rucellai, il
priorino, non erano direttamente coinvolti nella stesura dei Saggi, ma
appartenevano entrambi all’Accademia della Crusca ed erano in ottimi
rapporti con il Magalotti. Ancora agli inizi del 1666, il Magalotti tornava
sulle sue difficoltà a portare a termine l’opera, come si ricava da un’altra
lettera, questa volta indirizzata ad Alessandro Segni, che in quel periodo
si trovava a Parigi: «La sua lettera è stata certamente il veleno della mia
pigrizia avendomi fatto subito ripigliar la stampa intralasciata del libro
per non intralasciarla più fin al totale compimento dell'opera, la quale
non ha dubbio che per più conti sparirà all'aspettazione di codesti
letterati, ma io confido che l'esser divolgata tra essi per le sue mani le
conferirà un poco di stima e di credito e che le sue parole avranno forza
di farla parere eziandio quel ch'ella non è per se stessa. Intanto le mando
il titolo fermato e stabilito da' Signori Accademici, che intanto servirà a
corregger quello che V.S.Ill.ma mi ha scritto darsele costà: Saggi di naturali
esperienze fatte nell'Accademia del Cimento sotto la protezione del Ser.mo P.pe
Leopoldo di Toscana descritte dal Segretario di essa Accademia. A Ferdinando
Secondo Gran Duca di Toscana. Sotto a questo va la cartella con la seguente
impresa: Una caraffa di quelle che s'adoprano al cimento regio dell'oro,
con una massa d'oro nel fondo che si solve in acqua forte, il che si
riconosce da' periti dalla figura della stessa boccia e dal fumar ch'ella fa,
quantunque non abbia sotto il fuoco. Il motto preso da Dante:
“Provando e riprovando”. In piè della cartella v'è scritto: “Cimento”,
ch'è nome».
Il «volume, che usciva in una lussuosa edizione in folio – con le
illustrazioni degli strumenti ripetute con dovizia per evitare al lettore il
fastidio di dover girare troppo spesso le pagine – era da tempo atteso
negli ambienti scientifici in Italia e all’estero […]; s’intende atteso con
interesse reale da alcuni, con malevolenza da altri»66. La stampa dei Saggi,
secondo Giovanni Targioni Tozzetti, non fu eseguita con tutte le migliori
Il padre Sebastiano da Pietrasanta era stato maestro di Vincenzio Viviani.
L. Magalotti, Lettere, cit., p. 176.
66 Saggi, a cura di T. Poggi Salani, p. 23.
64
65
La fortuna editoriale dei Saggi di naturali esperienze nei secoli XVII-XIX
regole e finezze della stampa tipografica, facendo questi rilievi: «Le
Lettere Iniziali intagliate in legno, ed i fregi, e finali sono troppo grandi,
che paiono da Libri Corali, e riescono sproporzionati al testo della
pagina; ed i margini delle pagine sono mal regolati. Il carattere del disteso
è troppo grande, e mancante di corsivo, che sarebbe stato adattato per le
Rubriche; e quello delle Postille Marginali è troppo minuto; e noiosa è la
numerazione delle pagine a numeri romani, i quali neppure sono segnati
colle buone regole. Finalmente la carta è troppo fine e cenciosa, per la
sua grandezza, e fu tenuta troppo bagnata dall’imperito e trascurato
stampatore…Per ultimo, le tavole in rame sono mancanti di alcune
lettere indicate nella descrizione, ed alcune di loro sono tirate dove non
lo dovevano essere, e sono state tralasciate dove erano necessarie»67.
Nonostante il giudizio poco lusinghiero del Targioni Tozzetti, il
quale, tra l’altro, affermò che «pochi ebbero il libro e pochi l’intesero»,
non molto tempo dopo la pubblicazione dell’opera, lo stampatore
veneziano di nascita olandese Giovanni La Noù scriveva ad Antonio
Magliabechi di voler stampare nuovamente i Saggi e lo pregava di fargli
avere una copia ben corretta. Il Magliabechi dovette rispondere che la
cosa non dipendeva da lui, perché tutto era in mano del principe
Leopoldo de’ Medici; lo Stampatore veneziano accettò a malincuore la
realtà e tranquillizzò il Bibliotecario fiorentino affermando che «Dio ci
guardi d’haver ne meno pensiero di voler far ristampar dette Esperienze,
sapendo che dipende dal Rev.mo e Ser.mo Sig. Cardinale, stimiamo più
la sua buona grazia che mille ducati di utile»68.
Il fatto che appena pochi anni dopo si sia sentita la necessità di
ristampare l’opera significa che anche nella Penisola, superate le prime
perplessità, i Saggi ebbero successo e, nonostante le riserve dello stesso
Magalotti, essi furono considerati esempio di purezza linguistica,
eleganza di stile e chiara prosa, tanto che il Vocabolario della Crusca (terza
edizione, 1691), li addita come fondamentale testo di lingua, e come
segnala la Poggi Salani: «In effetti il libro accoglieva nella lingua e nello
stile l’eredità fondamentale, pienamente posseduta, dalla tradizione
toscanista, arricchita in modo particolare dall’esempio dell’esperienza
stilistica di Galileo. E in direzione galileiana, evitando in linea generale i
neologismi tecnici di origine dotta, si risolvono, sostanzialmente, i
problemi peculiari della terminologia scientifica, mentre il letterato, in
quanto tale, si permette sia il moderato accoglimento di voci e movenze
arcaizzanti, sia l’utilizzazione, qua e là, di modi usuali del parlato toscano
o della singola gustata ‘fiorentineria’ (e come si sa, entrambi questi poli
67
68
G. Targioni Tozzetti, Notizie degli aggrandimenti, I, cit., p. 418.
BNCF, Ms. Magl. VIII 640, lettera del 19 gennaio 1669.
328
Logos
appartenevano – nelle diverse modulazioni dei momenti e degli autori –
appunto a quella tradizione letteraria). I Saggi cioè, pur restando anzitutto
un libro di scienza sperimentale, scrupoloso e fedele, onesto, mostrano
non velatamente la preparazione, il gusto e le ambizioni letterarie
dell’autore»69.
Lasciando ad altri relatori la disamina della lingua e dello stile,
ritorniamo alla loro fortuna editoriale: ristampati nel 1691, i Saggi ebbero
ben sei tra edizioni e ristampe nel Settecento e due nell’Ottocento.
Mentre la prima traduzione in una lingua straniera fu nel 1684, in
inglese70. Nel 1731, venne una versione latina, arricchita dalle aggiunte di
carattere scientifico dall’olandese Pieter van Musschenbroek71 e che ebbe
anche una ristampa nel 175672; vi fu anche una versione in lingua
francese, secondo il Targioni Tozzetti, da attribuire al Lavirotte, sotto il
titolo di Essais d’expériences physiques faites dans l’Académie de Florence, avec des
notes ou additions Tirées de la Traduction Latine de van-Musschenbroek73.
Diamo, ora, uno sguardo alle edizioni italiane sei-settecentesche,
cominciando da quella fiorentina del 1691: «Questa edizione74 riporta il
ritratto di Cosimo III in luogo di quello di Ferdinando II; poi la dedica
dello Stampatore a Cosimo III; il Proemio a’ Lettori; seguono i Saggi; il
formato, in foglio, misura 38x26,50; i rami usati sono gli stessi e
Saggi, a cura di T. Poggi Salani, cit., p. 25.
1684 (Londra, versione inglese di R. Waller), di cui abbiamo un’edizione in
facsimile, con un’Introduzione di A. Rupert Hall (New York and London, Johnson
Reprint Corporation, 1964); alla fine dell’Introduzione, il curatore di questa edizione
afferma che l’edizione del Waller non è perfetta e presenta alcune lacune ed errori, che
vengono segnalati.
71 Tentamina // experimentorum naturalium // capturum in Academia del Cimento // Sub
Auspiciis // Serenissimi Principis // Leopoldi // Magni Etruriæ Ducis [sic] et ab ejus academiæ
secretario conscriptorum: // Ex Italico in Latinum Sermonem conversa. // Quibus commentarios,
nova experimenta, et // orationem de metodo instituendi // experimenta physica addidit // Petrus
van Musschenbroek, // L.A.M. Med. & Phil. D. Phil. & Mathes. Profess. // In Acad.
Ultraj.//, Lugduni Batavorum, Apud Joan. Et Herm. Verbeek, Bibliop., 1731; la
versione latina dei Saggi, compresi il Proemio e la Lettera dedicatoria a Ferdinando II,
segue una lettera dedicatoria, una prefazione ed una Orazione sul metodo sperimentale
in fisica, a firma del curatore. Formato: 24x19.
72 Tentamina experimentorum naturalium captorum in Accademia del Cimento […],
Viennae, Pragae et Tergesti, Typis et sumptibus Joannis Thomae Trattner, 1756.
73 Si trova in Collection académique, composée Des Mémoires, Actes, ou Journaux des plus
célèbres Académies & Sociétés étrangerès, des Extraits des meilleurs Ouvrages Périodiques, des Traités
particuliers, & Pièces Fugitives les plus rares […], A Dijon, chez François Desventes. A
Auxerre, chez François Fournier, 1755, tome I, pp. LXJ-LXXJ e 1-251.
74 Saggi // di naturali // esperienze // fatte nell’Accademia // del Cimento // sotto la
protezione // del Serenissimo Principe // Leopoldo di Toscana // e descritte da Segretario di essa
Accademia// Seconda edizione in Firenze, Nella Stamperia di Gio. Filippo Cecchi, 1691.
69
70
La fortuna editoriale dei Saggi di naturali esperienze nei secoli XVII-XIX
riproducono le medesime figure; i numeri delle pagine sono in romano;
sono stati corretti gli errori della prima edizione, perciò non riporta
l’Errata-corrige; la stampa è più chiara, la carta più spessa e di migliore
qualità; nell’esemplare da me controllato (IMSS, MED 2174)
l’autorizzazione all’imprimatur e l’avvertimento a’ librai per il registro, si
trovano dopo l’indice (in alcune copie esse si trovano avanti la lettera
dedicatoria)75; tra l’edizione del 1667 e quella del 1691, quindi, le
differenze sono poche, nel frontespizio, per esempio, la sola variante è
l’aggiunta: Seconda Edizione e il nome della nuova stamperia (In Firenze,
Nella Stamperia di Gio. Filippo Cecchi); i rilievi del Targioni Tozzetti,
perciò, valgono anche per questa edizione. Si tratta quindi più di una
ristampa che di un’edizione vera e propria».
Nel 1701 a Napoli, presso Giacomo Raillard, uscì la terza edizione in
foglio76, da me non controllata.
Nel 1710 (In Venezia, Per Domenico Lovisa, in 4)77, edizione
(quarta) citata da Boffito, p. 242. Ci pare improbabile che l’anno
successivo, lo stesso stampatore proponesse un’altra edizione, con la
dicitura “quarta edizione”; è verosimile che sul frontespizio di alcune
copie sia stato stampato un diverso anno per probabili motivi di “tansa”
(cioè di tassazione), poiché ogni stampatore era tassato secondo il
numero dei privilegi richiesti e in base alle copie stampate78.
Vedi Le opere dei discepoli di Galileo Galilei, cit., p. 25.
Edizione citata da Giuseppe Boffito, Bibliografia galileiana: 1896-1940 […],
supplemento alla Bibliografia Galileiana, di A. Carli e A. Favaro, Roma, Libreria dello
Stato, 1943, p. 242. Sulle edizioni napoletane ha messo l’accento A. Borrelli in Fortuna
di Francesco Redi a Napoli nel Sei-Settecento, in Galileo e Napoli, a cura di F. Lomonaco e M.
Torrini, Napoli, Guida, 1987, pp. 398-427; pp. 404-407. Delle tre edizioni napoletane
(1701, 1704, 1714), probabilmente solo la prima può essere considerata una vera e
propria edizione, mentre nella seconda e nella terza è stato sostituito solo il
frontespizio.
77 Lo stampatore è Domenico Lovisa e non Daviso come viene riportato
nell’Avvertimento de Le opere dei discepoli di Galileo Galilei. L’Accademia del Cimento, parte
prima, Firenze, Barbèra, 1942, p. 24.
78 Sulla questione dei privilegi di stampa e di tassazione a Venezia, vedi A. Mirto,
Città ed editoria: Venezia tra Cinquecento e Seicento, estratto dal volume: Le ideologie della città
europea dall’Umanesimo al Romanticismo, a cura di V. Conti, Firenze, Leo S. Olschki editore,
1993; notizie anche in M. Zorzi, La produzione e la circolazione del libro, in Storia di Venezia
dalle origini alla caduta della Serenissima, VII, La Venezia barocca, a cura di G. Benzoni e G.
Cozzi, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 921-984 e in F. Barbierato,
Giovanni Giacomo Hertz. Editoria e commercio librario a Venezia nel secondo ‘600, in «La
Bibliofilia», CVII (2005), 2, pp. 143-170.
75
76
330
Logos
Nel 1711 a Venezia79 fu pubblicata una nuova edizione dei Saggi di
formato: 24x18 (in 4); con lo stesso numero di pagine della stampa di
Firenze del 1691. I Saggi vengono dopo una lettera dedicatoria dello
Stampatore a Girolamo Frangini. La stampa inizia con il Proemio a’ lettori,
segue la licenza dell’Inquisitore, manca la Lettera dedicatoria a Ferdinando II.
È da rilevare una curiosità: che gli stampatori veneziani dei Saggi,
Domenico Lovisa nel 1711 e Giovambattista Pasquali nel 1761
appartenevano alla schiera dei medi stampatori e librai. Infatti, nel 1704,
il Lovisa era tassato per 40 lire veneziane, lontano dalla somma pagata
dalle due maggiori stamperie di Venezia: i Baglioni, che versavano 160
lire e i Pezzana, che ne versavano140; il Lovisa, però, pagava di più di un
Girolamo Albrizzi, che presto diventerà famoso principalmente per la
pubblicazione del «Mercurio Veneto» e di Antonio Pinelli, che stampava
i fogli per conto della Repubblica. Questi erano tassati rispettivamente di
28 e 20 lire veneziane. Anche il Pasquali non era tra i più i importanti
stampatori della Serenissima, come i Baglioni ed i Pezzana, ma
nemmeno come gli Hertz, che risultavano quelli che pagavano più tasse,
per buona parte del secolo80.
Ritornando al nostro discorso, segnaliamo un’edizione napoletana
del 171481: questa edizione dei Saggi è dedicata al principe don Cesare
Michel-Angelo Davalos, d’Aquino, d’Aragona; dopo la lettera
dedicatoria, segue il Proemio a Lettori; la licenza per la stampa e subito le
Esperienze, secondo l’edizione del 1691, con l’eccezione della prima figura
che è diversa; il formato è in foglio: 34x23,50.
Nell’edizione veneziana del 1761 (In Venezia, Presso Giambattista
Pasquali): formato piccolo (in 8), 18x11,50; con l’aggiunta della vita di
Lorenzo Magalotti, scritta da Domenico Maria Manni; il testo si apre con
l’Avviso dello Stampatore, dove è annunciato il piano editoriale della
ristampa delle opere del Magalotti a cominciare dai Saggi, il disegno
prevedeva anche la pubblicazione delle opere inedite, pubblicazione
affidata ad «un Soggetto ragguardevole in Firenze» (non è segnalato il
nome); nel 1772, G. B. Pasquali pubblicò Le Lettere scientifiche. La vita del
Magalotti è posta dopo il Proemio (che è stampata prima della Lettera) e la
79 Saggi // di Naturali // Esperienze // fatte nell’Accademia // del Cimento // sotto la
protezione // del Serenissimo Principe // Leopoldo di Toscana // e descritte dal Segretario di essa
Accademia // Quarta edizione. // Consacrati // All’Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor //
Girolamo Flangini // Patrizio Veneto, &c., In Venezia, Per Domenico Lovisa, 1711.
80 M. Infelise, L’editoria veneziana nel ‘700, Milano, Franco Angeli, 1989, pp. 21-23.
81 Saggi // di Naturali // Esperienze // fatte nell’Accademia // del Cimento // sotto la
protezione // del Serenissimo Principe // Leopoldo di Toscana // Dedicati // All’Altezza
Serenissima // di // D. Cesare Michel-Angelo // Davalos // D’Aquino, d’Aragona, In
Napoli, Nella Stamperia di Bernardo-Michele Raillard, 1714.
La fortuna editoriale dei Saggi di naturali esperienze nei secoli XVII-XIX
Lettera a Ferdinando II. Le tavole (28) sono riprodotte alla fine del
volume.
L’edizione del 1806 riporta il Proemio, ma non la Lettera dedicatoria a
Ferdinando II; riproduce il frontespizio, ma non il motto né l’impresa. Il
formato è piccolo (12x20); le figure sono pubblicate alla fine e raccolte in
cinque tavole (l’esemplare da me controllato è mutilo della II tavola).
La nostra analisi finisce con l’edizione del 1841, curata da Vincenzio
Antinori ed dal professor Gazzeri, il primo ha tracciato la storia delle
scienze in Toscana e la nascita dell’Accademia del Cimento, il secondo si
è interessato delle aggiunte apportate ai Saggi pubblicati nel 1667 e nel
1691. Il frontespizio porta: terza edizione fiorentina; secondo l’Antinori,
questo testo rappresenta: «Il libro che tutti i moderni Fisici venerano
come primo modello e guida nelle ricerche sperimentali, il primo corso di
Fisica, che tanta luce di sapere e di verità dette agli uomini nello studio
delle Leggi dell’Universo, che pose l’esperienza nella vera sua sede, e nel
quale l’ingegno ed il retto giudizio degli sperimentatori apparisce
manifesto a gloria della nostra Toscana, ad esempio di tutte le nazioni,
un libro in cui le nuove dottrine esposte con tanta precisione, venustà e
purezza di lingua, che insieme collo spirito del Galileo sembra anco
vedervi trasfuso quel nobile e puro stile con che ci vennero dettate le
prime verità sperimentali, e che la Patria di Dante, del Petrarca e del
Boccaccio non poteva con altri colori annunziare, non solo non giunse
mai a contentare l’illustre scrittore che noi ammiriamo, ma in più lettere
si palesa di sentire per quel lavoro, le cui molte minute sono ripiene per
ogni dove di variazioni e di postille, un’avversione invincibile, tanto è
vero che chi più vede meno si appaga; e venuto poi alla luce del
pubblico, non ebbe da primo quell’incontro che si meritava dagli uomini,
né ciò farà specie ad alcuno»82.
Questa edizione, che venne approntata in occasione del Congresso
degli scienziati italiani tenutosi a Firenze nel settembre del 1841, ebbe
risonanza internazionale, infatti, il «Journal des Savants», tra il febbraio
1843 ed giugno 1844, le dedica cinque articoli a firma di Guglielmo Libri,
nei quali analizza minuziosamente l’Introduzione dell’Antinori e sottolinea
che sarebbe stato più semplice tradurre tutta l’opera che farne un
riassunto, poiché gli argomenti trattati sono tutti importanti; nel primo
articolo, dopo aver presentato i due curatori dell’opera (Antinori e
Gazzeri), due tra i fisici più validi del tempo, Vincenzo Antinori traccia la
storia sia dell’Accademia sia dei Saggi, mentre Giuseppe Gazzeri si
82 Saggi // di Naturali Esperienze // fatte // nell’Accademia del Cimento // Terza
edizione fiorentina // Preceduta da notizie storiche dell’Accademia stessa // e // seguitata da alcune
aggiunte, Firenze, dai torchi della Tipografia Galileiana, 1841, pp. 103-104.
332
Logos
interessa a correggere il testo e a preparare le aggiunte di questa nuova
edizione, l’Autore entra nell’analisi del testo, facendo una sorta di storia
dello sviluppo scientifico legato ai Lincei e al ruolo svoltovi da Galileo.
L’Autore si rammarica del fatto che l’Antinori, mentre ha ricostruito
magistralmente la storia dell’Accademia del Cimento, non ha parlato
affatto di quella dei Lincei. Nel secondo articolo, l’Autore tratta, tenendo
presente l’Introduzione dell’Antinori, dei primi allievi del Galileo, a
cominciare da Benedetto Castelli e dei loro studi ed esperienze; nel terzo
articolo sono analizzate le figure del Cavalieri e del Torricelli, riportando
anche documenti e lettere, tra cui una del Cavalieri a Galileo, datata
Parma, 24 novembre 1624 e un’altra del 14 giugno 1634. Nel quarto
articolo sono discussi i Dialoghi di Orazio Ricasoli Rucellai83 e la
personalità di Lorenzo Magalotti. Nel quinto articolo abbiamo un sunto
generale dell’Introduzione dell’Antinori. Già sul «Giornale», (vol. 3, 1842,
pp. 188-201) era apparsa una nota a firma di Giuseppe Belli, nella quale
era tracciata una sorta di storia della genesi dell’Accademia del Cimento e
dei suoi aderenti. Lo stesso Autore nel presentare la sua relazione,
sottolineava: «Noi non parleremo della parte principale ossia dei Saggi
propriamente detti, siccome di cosa che ciascuno conosce ed apprezza, e
la cui ristampa se ha presentemente de’ distinti pregi, gli ha nella parte
sua materiale. Ci occuperemo in vece della prefazione, lavoro tutto
nuovo, facendo un cenno altresì dell’aggiunta».
Il Belli, nel recensire la pubblicazione, tralascia del tutto i motivi che
portarono a questa terza edizione fiorentina, lasciando trasparire che fu
solo la magnanimità dell’allora Granduca a volerla, né più, né meno
come accadde quasi due secoli addietro per l’edizione princeps dei Saggi. Il
Belli, infatti, comincia la sua nota parlando dei discepoli del Galileo, dei
meriti di Ferdinando II e di suo fratello Leopoldo, degli effettivi e dei
corrispondenti dell’Accademia del Cimento, di un approssimativo
calendario delle riunioni e delle esperienze, ma nessun accenno alla storia
della pubblicazione dei Saggi. Il fatto che in nemmeno tre secoli i Saggi
abbiano avuto nove, dieci secondo il Boffito, fra edizioni e ristampe nelle
lingue italiana, francese, inglese e latina, ci induce a pensare che il testo
non solo, come abbiamo sottolineato, era di notevole importanza
letteraria, ma anche di accertato valore scientifico.
83 Dialoghi filosofici, su cui vedi S. Caroti, Nel segno di Galileo: erudizione, filosofia e scienza
a Firenze nel secolo XVII. I Trattati Accademici di Vincenzio Capponi, Firenze, Edizioni
S.P.E.S., 1993, pp. 81-102.
Fernanda Gallo
Il manoscritto De Anima di Bertrando Spaventa
Nella Biblioteca Nazionale di Roma, presso il fondo RughiniGhezzi1, si trova un manoscritto (28.3) di Bertrando Spaventa dal titolo
“De Anima”. Alessandro Savorelli nel suo studio sul fondo romano2 fa
risalire il manoscritto 28.3 al 1862-63, poiché contiene gli appunti del
secondo corso napoletano di Spaventa, dedicato alla filosofia dello
spirito, che si tenne in quegli anni. Tale manoscritto risulta
particolarmente interessante in quanto è da considerarsi la prima stesura
dell’opera Studi sull’etica di Hegel (riedito da Giovanni Gentile nel 1904 col
titolo Principi di etica), data alle stampe da Spaventa stesso solo nel 1869.
Alla luce di questo nuovo elemento intendo compiere un’analisi
descrittiva, confrontando il manoscritto con il testo a stampa e
mostrando come essi si presentino praticamente identici, ad eccezione di
alcune varianti d’occasione che verranno segnalate. A partire da tale risultato
intendo inoltre riconsiderare il testo a partire dalla sua retrodatazione.
Bisogna, infatti, a questo punto, inquadrare la teoria spaventiana dello
Stato, così come è delineata nei Principi di etica, nel periodo ascendente
dell’hegelismo napoletano. Lo Spaventa dei primi anni ’60 è infatti un
pensatore di matrice liberale, che, per alcuni aspetti, si discosta dalle
posizioni più conservatrici dello Hegel dei Lineamenti di filosofia del diritto.
L’esempio più significativo è forse proprio la diversa posizione circa la
pena di morte. Infatti Spaventa, «proprio in base agli stessi schemi
1 Il lascito manoscritto di Bertrando Spaventa è sicuramente molto ricco ed è stato
ulteriormente accresciuto dal piccolo corpus donato alla Biblioteca Nazionale di Roma da
Guido Ghezzi nel settembre 1989. Esso costituisce l’insieme delle carte Spaventa che
Sebastiano Maturi lasciò in eredità alla sig.ra Giulia Rughini-Ghezzi, con cui era
imparentato, e che non entrò a far parte del Fondo Maturi dei manoscritti spaventiani,
di cui venne in possesso, dopo il 1917, Benedetto Croce, il quale lo donò alla Società
Storica Napoletana, donde giunse alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Ritengo a questo
proposito importante ricordare che un secondo gruppo di manoscritti, che era in
possesso di Silvio Spaventa, fu acquisito, alla morte di quest’ultimo, dalla Biblioteca
civica “A. Mai” di Bergamo. Sono inoltre presenti altri documenti di Bertrando
Spaventa presso la Società Napoletana di Storia Patria e presso la Fondazione Gentile.
2 Il “Fondo Rughini-Ghezzi” è stato analizzato da A. Savorelli nel suo studio
Manoscritti spaventiani nella Biblioteca Nazionale di Roma, in «Giornale Critico della Filosofia
Italiana», 7, II (2006), pp. 276-295.
Il manoscritto De Anima di Bertrando Spaventa
fondamentalmente hegeliani di deduzione del diritto di punire»3, esclude
la possibilità della pena di morte e dell’ergastolo. Anche Italo Cubeddu
sottolinea come, in Spaventa, «il diritto punitivo miri a restaurare il diritto
violato elevandolo alla intimità del volere nell’animo del delinquente,
sicché appare contraddittorio con il concetto stesso della pena il
consentire alla sua perpetuità o anche alla pena di morte»4. Questa
deduzione trova le sue ragioni nel fatto che queste due pene, in primo
luogo, presuppongono che la nascita ideale mediante la morale sia in alcuni
casi impossibile; in secondo luogo negano che la natura dello spirito sia
proprio l’essere uno e due insieme, gemello di se stesso, negano quindi
quella che Spaventa, in una lettera a Angelo Camillo de Meis (23 giugno
1868), chiama la teorica dell’ens geminum siamese. In questa teorica egli utilizza
la figura dei gemelli siamesi per esemplificare l’idea che l’essenza dello
spirito dell’uomo sia la medesimezza (Io=Io): Che senso avrebbe, senza la
mia teorica dell’ens geminum siamese, la confessione, l’assoluzione, la
remissione, dei peccati, il perdono? Che senso avrebbe la stessa pena, che
è il contrario?[…] Io penso e dico che la mia teorica mena dritto diritto a
dimostrare ingiusta e assurda la pena di morte, ed è insieme la sola via di
fondare il diritto di punire5. A questo proposito scrive invece Hegel nel §
100 delle Grundlinien:
«Beccaria hat dem Staate das Recht zur Todesstrafe bekanntlich aud
dem Grunde abgesprochen, weil nicht präsumiert werden könne, daß im
gesellschaftlichen Vertrage die Einwilligung der Individuen, sich töten zu
lassen, enthalten sei, vielmehr das Gegenteil angenommen werden müsse.
Allein der Staat ist überhaupt nicht ein Vertrag, noch ist der Schutz und die
Sicherung des Lebens und Eigentums der Individuen als einzelner so
unbedingt sein substantielles Wesen, vielmehr ist er das Höhere, welches
dieses Leben und Eigentum selbst auch in Anspruch nimmt und die
Aufopferung desselben fordert6».
G. Vacca, in B. Spaventa, Unificazione nazionale ed egemonia culturale, Bari, Laterza,
1969, p. 270, nota 2.
4 I. Cubeddu, Bertrando Spaventa, Roma, Sansoni, 1964, p. 273.
5 B. Spaventa, Dal Carteggio inedito di Angelo Camillo de Meis, Comunicati
all’Accademia Pontaniana del socio B. Croce, Napoli, F. Giannini e Figli, 1915, p. 9.
6 G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Recht (1821), Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1970, pp. 190-191. Traduzione italiana: «Come si sa, Beccaria ha negato allo
stato il diritto alla pena di morte sul fondamento che non si possa presumere che nel
contratto sociale sia contenuto il consenso degli individui a lasciarsi uccidere, anzi si
debba assumere il contrario. Ma lo stato in genere, non è un contratto, ne la sua essenza
sostanziale è la protezione e l’assicurazione della vita e proprietà degli individui come singoli
in modo così incondizionato, anzi esso è l’entità superiore, la quale anche avanza
3
336
Logos
Notiamo quindi che Spaventa, nonostante non condivida la teoria
contrattualistica dello Stato, si oppone alla pena di morte proprio a
partire dalla logica interna alla dialettica hegeliana.
Retrodatare i Principi di etica al 1862-63 significa fare i conti con
un’altra importante opera che Spaventa pubblicò nel 1862: La filosofia
italiana nelle sue relazioni colla filosofia europea. Questo testo «occupa un
posto particolare: fu il più discusso, il più innovatore, quello che ebbe
maggiore influenza sui contemporanei e che si possa in qualche misura
definire un classico della letteratura filosofica italiana dopo l’Unità»7.
Esso è il risultato del corso di lezioni tenuto da Spaventa presso
l’Università di Napoli nel 1861, dopo essere stato nominato professore di
filosofia teoretica nell’ambito di una ristrutturazione dell’Università
partenopea operata dall’allora Ministro dell’Istruzione del Regno d’Italia
Francesco De Sanctis. Fu Gentile a rendere canonica l’espressione,
utilizzata da Spaventa stesso, «circolazione del pensiero italiano»8 per
individuare la tesi complessiva dell’opera. Questa tesi fu elaborata
essenzialmente negli anni dell’esilio torinese9 ed è «inevitabile percepirla
pretesa su questa vita e proprietà ed esige il sacrificio della medesima», in Id., Lineamenti
di filosofia del diritto, trad. it. G. Marini, Bari, Laterza, 2000, p. 90.
7 A. Savorelli, Introduzione, in B. Spaventa, La filosofia italiana nelle sue relazioni con la
filosofia europea, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, p. V.
8 Questa espressione viene utilizzata da Spaventa nella Prolusione alle lezioni di
storia della filosofia presso l’Università di Bologna, letta il 30 aprile 1860 (B. Spaventa,
Carattere e sviluppo della filosofia italiana dal secolo XVI sino al nostro tempo, ora in La filosofia
del Risorgimento, a cura della Società di Studi politici, Napoli, La Scuola di Pitagora, 2005,
p. 69). Come sottolinea Giovanni Rota, fu soprattutto il Gentile a porre al primo posto
tra i concetti originali di Spaventa quello della circolazione. Il Rota infatti scrive:
«L’opera svolta da Spaventa ebbe il merito di aiutare la cultura italiana, per la prima
volta in una maniera elaborata e originale, a pensare, se non mondialmente, di sicuro
tentando di mantenere il passo del più raffinato pensiero europeo. Lo stesso Gramsci
aveva certamente qualche debito nei confronti della teoria più caratteristica di questo
filosofo, quella che Gentile aveva riassunto nella formula «circolazione del pensiero
europeo», G. Rota, La «circolazione del pensiero» secondo Bertrando Spaventa, in «Rivista di
storia della filosofia», 4 (2005), p. 1. La teoria della circolazione del pensiero italiano è
composta di due parti distinte: la prima riguarda lo studio dei nostri filosofi del
Rinascimento in quanto precorrono la filosofia moderna, in particolare Tommaso
Campanella, Giordano Bruno e Gianbattista Vico; la seconda vuole mostrare come i
filosofi contemporanei Galluppi, Rosmini e Gioberti siano, nei risultati del loro
pensiero, in consonanza col pensiero europeo, ed in particolare con i risultati raggiunti
da Kant e dall’idealismo tedesco. Essa si propone infatti come cerniera tra le due
tradizioni a cui Spaventa era maggiormente legato: il pensiero rinascimentale e la
filosofia classica tedesca.
9 Il 26 ottobre 1849 Spaventa, perseguitato dalla polizia, fu costretto all’esilio
mentre il fratello Silvio veniva imprigionato a Napoli. Passò i primi dieci mesi a Firenze
e nel settembre del 1850 si recò in quella che allora era l’unica terra libera: il Piemonte.
Il manoscritto De Anima di Bertrando Spaventa
come una tesi contrapposta all’idea del primato elaborato dal
neoguelfismo10 […] L’idea – alternativa a questa – di un rapporto meno
lineare e più “drammatico” tra pensiero nazionale ed europeo, affondava
invece le radici in un settore delle ideologie risorgimentali di cultura laica
e d’opposizione»11. Ritengo quindi che l’interesse principale del manoscritto
romano del 1862-63 derivi dalla possibilità che ci offre di comprendere
come i tratti originali,, con cui Spaventa analizza la filosofia dello spirito
hegeliana, siano intimamente connessi alla prospettiva di filosofia della
storia che egli delinea nella teoria della «circolazione del pensiero».
Sarebbe quindi interessante, in questa prospettiva, riconsiderare i Principi
di etica a partire dai «due soli» del pensiero spaventiano: la filosofia
italiana del Risorgimento12 e la filosofia tedesca:
«vedevo tutto buio in Italia, soprattutto dopo l’esodo del 1849[…]Pure,
fin da’allora io mirava, in mezzo alle tenebre, lontano lontano, due luci, e
n’era tutto innamorato, e avea il lieto presentimento che fossero un
medesimo sole; e sembravano due, perché erano lo stesso sole in due punti
diversi dell’orizzonte. Senza metafore, la filosofia italiana del Risorgimento,
e la filosofia tedesca»13.
Intendo che questa nuova analisi possa permetterci di comprendere
meglio l’”autodefinizione” data da Spaventa stesso alla sua opera sulla
filosofia dello spirito di Hegel: «questa esposizione non sarà né un
compendio, né un estratto, né una parafrasi, ma il concetto – direi quasi
l’immagine – che io mi son formato di essa, spiegato e definito nelle forme più
essenziali in cui si individua sempre più l’assolutezza del volere»14.
Si fermò a Torino per dieci anni fino al momento dell’Unità d’Italia. Per maggiori
informazioni sull’esilio torinese cfr. G. Gentile, Bertrando Spaventa, in B. Spaventa, Opere
(1908), a cura di G. Gentile, Firenze, Sansoni, 1972, pp. 26-40.
10 L’idea del primato era l’idea di una filosofia italiana stabile nei suoi concetti,
proveniente da una remota antichità autoctona e autonoma dalle “deviazioni” del
pensiero straniero.
11 A. Savorelli, Introduzione, cit., p. IX.
12 Con questo termine Spaventa si riferisce al pensiero rinascimentale.
13 B. Spaventa, Logica e Metafisica, a cura di G. Gentile, Bari, Laterza, 1911, p. 12.
Questo testo fu pubblicato per la prima volta dall’autore nel 1867 a Napoli, per lo
stabilimento tipografico Ghio, con il titolo Principii di filosofia.
14 B. Spaventa, Principi di etica (1904), Napoli, La Scuola di Pitagora, 2007, pp. 3637.
338
Logos
1. Il contesto del De Anima
In primo luogo, affinché l’analisi sia completa, bisogna collegare il
manoscritto romano 28.3 al manoscritto 7.4, presente nelle Carte Maturi
della Biblioteca Nazionale di Napoli, autografo di Spaventa15, contenente
gli appunti del corso del 1862-63 sulla filosofia della natura. Le ultime
lezioni del manoscritto napoletano (fogli 55-70) contengono infatti un
Epilogo sulla natura e le lezioni introduttive alla filosofia dello spirito e
sull’anima in generale. Inoltre, nella lezione introduttiva di questo corso,
l’autore esprime il proposito di volersi occupare dell’anima, da cui
l’ipotesi che il manoscritto romano sia per questo intitolato De Anima,
titolo da attribuire probabilmente a Maturi.
In secondo luogo, bisogna sottolineare che il manoscritto
napoletano è numerato da foglio 1 a 70, mentre quello romano da 71 a
121 e che la datazione presente nel manoscritto napoletano va dal 18
novembre 1862 al 16 aprile 1863, mentre quella del manoscritto romano
va dal 21 aprile al 27 giugno. Nonostante in quest’ultimo non troviamo
l’indicazione dell’anno, possiamo dedurre dalla regolarità dei giorni che le
lezioni presenti nel manoscritto di Roma siano la continuazione del
manoscritto napoletano del 1862-63, anche perché procedono con lo
stesso intervallo di tempo16.
Possiamo quindi ragionevolmente ipotizzare che il manoscritto 7.4,
presente nella Biblioteca Nazionale di Napoli, e il manoscritto 28.3, della
Biblioteca Nazionale di Roma, siano due parti della stessa opera.
Per quanto riguarda il manoscritto napoletano notiamo che esso è
mancante dei fogli da 57 a 61, i quali, però, sono presenti nel manoscritto
32.3 delle Carte Spaventa della Biblioteca Nazionale di Napoli. Questi
fogli corrispondono letteralmente al primo capitolo, intitolato Logo,
Natura, Spirito, dei Preliminari dell’etica, cioè del primo capitolo dei Principi
di etica. Inoltre i fogli da 62 a 70 del manoscritto napoletano 7.4
corrispondono più o meno letteralmente con il primo e secondo
paragrafo del secondo capitolo, intitolato Lo Spirito, dei Preliminari.
Vediamo infine che il manoscritto romano 28.3 comincia la sua
corrispondenza a partire dal terzo paragrafo del secondo capitolo dei
Preliminari.
15 Per un quadro completo dei manoscritti spaventiani presenti alla Biblioteca
Nazionale di Napoli vedi A. Savorelli, Le Carte Spaventa della Biblioteca Nazionale di Napoli,
Napoli, Bibliopolis, 1980.
16 Ho infatti dedotto dalla consultazione di un calendario storico del 1862 e del
1863 che i corsi si tenevano regolarmente di martedì, giovedì e sabato.
Il manoscritto De Anima di Bertrando Spaventa
Possiamo inoltre notare che nel manoscritto napoletano vi sono
delle aggiunte apportate con la data del 1868, che indicherebbero che il
testo è stato rimaneggiato, probabilmente proprio in vista della
pubblicazione del ‘69. È quindi possibile ipotizzare che la decisione di
pubblicarlo in quell’anno sia connessa a quella che Gentile definì la «felix
culpa» di Terenzio Mamiani, il quale, con la pubblicazione del suo testo
Confessioni di un metafisico17, suscitò la risposta di Spaventa. Non a caso
l’unica parte mancante, rispetto al testo a stampa, nei manoscritti che
abbiamo analizzato è proprio il Proemio, in cui l’autore difende il pensiero
di Hegel dal giudizio che Mamiani espresse sull’etica hegeliana.
Quest’ultimo infatti la definiva immorale in quanto negatrice del
principio morale assoluto, in luogo del quale sostiene l’utilità o la volontà
del maggior numero degli uomini. La posizione di Mamiani viene
sintetizzata da Spaventa così: «Il biasimo di ricercare l’assoluto e l’accusa
di non ammettere che il relativo - è il segreto del Mamiani contro
Hegel»18. Spaventa quindi si occupa, nel Proemio, sostanzialmente dei
concetti di assoluto e di relativo, nella convinzione che il problema del
pensiero di Mamiani sia la mancanza della comprensione di tali concetti.
Infatti quest’ultimo, secondo Spaventa, pur ammettendo l’assoluto, lo
ricerca nel modo sbagliato e contrario alla filosofia di Hegel, poiché lo
considera un oggetto dinanzi e sopra l’uomo, il quale lo contempla ma
non lo può apprendere realmente, bensì solo «astrattamente o
fantasticamente», in quanto «l’atto mio conoscitivo e la mia ricerca non è
insieme l’atto suo, la sua vita e dirò anche la sua ricerca»19. Vi è quindi
una «sacra chiave della filosofia moderna»20, cioè la duplice esigenza
dell’unità del finito e dell’infinto, che Mamiani non comprende e che si
esplica nel concetto hegeliano per cui «il finito non è senza l’infinito,
l’infinito non esiste senza il finito»21. Scrive infatti Spaventa ad Angelo
Camillo de Meis: «Indovina poi qual è il principio nuovo della filosofia?
Il principio di contraddizione, come principio ontologico; s’intende.
Unità di contraddittorii e unità sintetica di essi in ogni cosa»22. L’unità di
soggetto e oggetto, di infinito e finito, è la chiave che indica Spaventa per
la chiarificazione dell’assoluto hegeliano.
T. Mamiani, Confessioni di un metafisico. I: Principi di Ontologia. II: Principi di
Cosmologia, 2 voll., Firenze, Barbera, 1865.
18 B. Spaventa, Principi di etica, cit., p. 5
19 Ivi, p. 10.
20 Ivi, p. 11.
21 Ibid.
22 Id., Dal Carteggio inedito di Angelo Camillo de Meis, Comunicati all’Accademia
Pontaniana del socio B. Croce, Napoli, F. Giannini e Figli, 1915, p. 2.
17
340
Logos
2. Il testo del De Anima
Confrontando più nel dettaglio il manoscritto romano con i Principi
di etica si osserva che vi è una corrispondenza quasi letterale, e che le
minime differenze presenti sono per lo più varianti d’occasione, dovute al
fatto che il testo originario era preparato per sostenere delle lezioni ed i
destinatari erano essenzialmente studenti universitari. Vediamo inoltre
che le uniche due parti non corrispondenti, cioè la trattazione della
differenza tra i precetti giuridici e quelli morali, e quella che riguarda le
due specie di violazioni del diritto, che sono presenti nel testo a stampa e
non riscontrabili nel manoscritto 28.3, sono però presenti nel
manoscritto 28.1523, appartenente allo stesso Fondo della Biblioteca
Nazionale di Roma24.
Oltre questa unica differenza con il testo a stampa notiamo che le
varianti più diffuse sono quelle d’introduzione alla lezione, che si trovano
generalmente nelle prime righe di ogni nuova dissertazione, interessanti
in quanto rappresentano una sintesi elaborata dall’autore stesso di ciò
che ha illustrato nella lezione precedente:
1. Nella prima lezione datata 21 aprile al foglio 71 del manoscritto e
intitolata Lo Spirito Spaventa scrive:
«Lo Spirito in quanto Anima, incomincia come sentimento
indeterminato, fondamentale e si compie come identità pura ideale con se
stessa: Coscienza. In quanto Coscienza, incomincia come certezza o sapere
indeterminato, conoscibile: l’oggetto (questo) è; io ( soggetto, questo) sono;
e si compie come Coscienza razionale, Ragione, Spirito in quanto Spirito,
incomincia come intendimento o coscienza intuitiva, e si compie come
Etica (Spirito libero, Coscienza = Volere). Il cominciamento è il semplice
concetto (in sè) possibilità di quel che comincia e si compie; non è l’attualità
di esso concetto. Così Anima, Coscienza, Spirito come cominciamento
(Primo) tutto quello che sono come perfetta anima, perfetta Coscienza,
perfetto Spirito. Lo Spirito – come unità di Coscienza e autocoscienza
propriamente detta, o in generale di Anima e Coscienza (in senso
universale) – è Ragione; ma come cominciamento non è perfetta Ragione».
Il ms. 28.15 contiene anche alcuni rari documenti del corso di filosofia del
diritto tenuto da Spaventa a Modena tra il 1859 e il 1860.
24 La trattazione di queste due tematiche si trova nel ms. 28.15 rispettivamente ai
fogli da 3 v. a 5 e da 11 v. a 12 v. è stato possibile individuare questi fogli nell’altro
manoscritto per una annotazione dell’autore stesso fatta a margine del foglio 94 del ms.
28.3.
23
Il manoscritto De Anima di Bertrando Spaventa
2. Al foglio 73 del 23 aprile:
Nella lezione antecedente – epilogando la cosa detta riguardo i gradi
nello spirito pratico e la sua risoluzione (la conciliazione del teoretico e del
pratico) nello spirito libero, ho parlato d’un difetto25 nello Spirito. Come
cominciamento, ho detto, l’Anima non è perfetta anima; la Coscienza non è
perfetta coscienza; lo Spirito non è perfetto spirito (l’Intendimento non è
perfetto intendimento; il Volere non è perfetto volere).
3. Al foglio 75 del 25 aprile:
«Lo Spirito libero – etico – è lo Spirito, il quale in quanto Soggettività
(già perfetta in sé, ma semplicemente in sé, come Soggettività: Anima,
Coscienza, Intendimento o Ragione: Intendimento teoretico e pratico) si
oggettiva necessariamente, assolutamente: in modo conforme alla
universalità, che è la sua (essenza)»26.
4. Al foglio 78 del 28 aprile:
«Lo Spirito etico – ho detto – è il mondo dello Spirito. Ho ricordato il
significato del Mondo, ed opposto la differenza fra tre mondi: logico,
naturale e spirituale. Mondo è Oggettività (Concetto come Oggettività:
Unità positiva di oggetti). Logico = oggettività nell’elemento astratto del
pensiero. Naturale = oggettività nell’elemento della realtà immediata. Etico
= oggettività nell’elemento del volere (libero e universale – razionale –
Volere)».
5. Al foglio 80 del 30 aprile:
«Della mondanità27 ho detto nella penultima lez.; della necessità etica28
nell’ultima (così così per le ragioni che si sa: ***)29 [seguono appunti per
25 Il difetto cui fa riferimento Spaventa è che lo spirito nella sua immediatezza non
è il vero spirito. Tale difetto, o meglio tale imperfezione, manifesta quella che è la vera
natura dello spirito, cioè la produzione assoluta di sé stesso a partire da ciò che è
semplicemente.
26 Questo passo riguarda il capitolo che nel testo a stampa ha come titolo Lo spirito
come mondo, nel quale l’autore comincia l’analisi dello spirito oggettivo del sistema
hegeliano.
27 Con mondanità Spaventa si riferisce in questo caso al mondo dello spirito, ovvero
al mondo etico, prodotto dagli individui stessi, che è il sistema delle relazioni tra gli
spiriti: la comunità degli spiriti. Egli usa però il termine mondo anche per intendere il
sistema di oggetti ed esistenze immediati che costituisce il mondo della natura.
28 La necessità etica è per Spaventa l’unità di necessità e libertà possibile nel
momento in cui l’individuo come volere realizza il suo concetto, cioè la libertà, nella
esistenza esterna oggettiva, per cui non si ha più né una semplice e pura libertà né una
semplice e pura realtà immediata. La conciliazione di questi due opposti significa che,
342
Logos
uso proprio dell’autore] Epilogo sulla necessità etc. Mondo = Oggettività
Oggettività = Realtà, Esistenza, Esteriorità, finità, ***»
6. Al foglio 93 del 21 maggio:
«Ho detto: la Moralità è l’esistenza interna della libertà (del volere
oggettivo, della ragione del volere, di quello che è diritto, giusto, buono): la
esistenza della libertà nel volere stesso (soggettivo)».
7. Al foglio 96 del 26 maggio:
«Fin qui nello spirito etico abbiamo: Diritto (astratto: diritto
propriamente detto): proprietà, contratto e relazione del diritto e della
violazione del diritto: delitto e pena30. Moralità: nei suoi primi gradi, nella
sua immediatezza: Proposito, intenzione, benessere31».
Abbiamo anche delle varianti di stile:
1. Al foglio 82v. del 2 Maggio:
da una parte, la libertà non ha più esclusivamente un carattere interno, dall’altra, la
realtà non è più solo un qualcosa di totalmente esterno.
29 Il segno *** indica una parola illeggibile
30 La coppia delitto e pena è particolarmente interessante in quanto segna il
passaggio dal diritto astratto alla morale mediante la figura della violazione del diritto. Infatti la
negazione assoluta del diritto, cioè il delitto, è un’azione eticamente nulla, per cui bisogna
restituire il diritto a questa azione mediante la pena. La giustizia punitiva attua se stessa
superando la sua negazione, per cui il vero atto della giustizia è la realizzazione della
pena. Il diritto che si compie come giustizia penale è la morale. Infatti il diritto è
l’esistenza della libertà in una cosa esterna, ed è quindi il volere oggettivo. Affinché,
però, la libertà realizzi la sua interiorità, deve negare il diritto ed elevarsi al di sopra di
esso. Ciò può avvenire, in primo luogo, con la negazione del diritto nella sua esteriorità
mediante il delitto, il quale però è una negazione assoluta dell’esistenza della libertà; in
secondo luogo con la moralità, che nega l’esteriorità del diritto, e quindi una forma di
vita esteriore della libertà, rivendicandone la vita intima. Quindi se il volere viene posto
come delitto si dà la possibilità del volere come moralità. La libertà, lesa come esterna,
si restaura nella pena non come esterna ma in una nuova esistenza più alta, più intima:
la morale. Spaventa sostiene quindi che il passaggio dalla persona giuridica al soggetto morale
si faccia nell’atto del diritto punitivo, poiché la pena restituisce una nuova esistenza al
diritto, cioè quella della libertà nella intimità del volere.
31 Proposito, intenzione e benessere sono le tre figure della moralità. Il proposito è
ciò che caratterizza moralmente un’azione in quanto è ciò che spinge un soggetto, che è
soggetto morale in quanto sa e vuole, all’azione; l’intenzione è ciò che determina
moralmente un’azione in quanto la rende imputabile ad un soggetto, essa è più
profonda del proposito poiché ha come contenuto l’essenza della cosa e non il suo lato
empirico; il benessere consiste nell’insieme di bisogni, interessi e fini del soggetto
raccolti in un solo fine come materia dell’azione morale.
Il manoscritto De Anima di Bertrando Spaventa
«La realtà del libero volere – la libertà reale – la realtà etica – l’atto etico
– è l’unità del volere soggettivo e del volere oggettivo. Lo spirito – in
quanto quest’atto, questa unità, nella sua immediatezza (nella sua esistenza
immediata) – è individuo: è lo spirito come Questo. Immediatezza, esistenza
immediata, è indeterminazione, determinabilità pura, semplice essere.
Immediatezza, indeterminazione, determinabilità pura, essere, non vuol dire
la privazione assoluta d’ogni determinazione, ma sì la più povera, più
astratta, più comune determinazione: il puro Questo, il puro Individuale, il
puro Sensibile: il puro Singolare».
2. Al foglio 97v del 28 maggio delucida un concetto che è espresso
in una forma un po’ diversa nel testo a stampa e corrisponde al primo
paragrafo del punto 6 del capitolo La Moralità. Concettualmente vengono
espressi gli stessi contenuti ma la forma nel manoscritto si presenta in
modo diverso anche perché è una sintesi esplicativa delle lezioni
precedenti:
«Nelle due lez. precedenti ha risultati che paiono opposti:
Risoluzione dell’immediatezza del Proposito, del formalismo
dell’Intenzione, del particolarismo del Benessere è il Bene: universalità
concreta e assoluta del Volere.
Ho cominciato anche così; ho detto anzi, che, riassumendo i primi gradi
dello Spirito morale nel Benessere, il contenuto del Bene è il diritto e il
Benessere. Poi considerando quella attualità che è il Bene, ho detto:
quest’attualità non è niente d’immediato: e perciò: immediata la relazione tra
il volere soggettivo e il Bene è quella dell’ha da essere, non quella dell’È. Poi
considerando questa relazione sono riuscito a questo: il volere, il Soggetto
che sa e vuole come pura certezza, come pura determinazione di sé»
Al foglio 103 v. abbiamo un epilogo didattico, in cui l’autore, alla fine
della sezione della Moralità, opera alcuni chiarimenti per punti,
sottolineando gli aspetti più importanti che ha trattato:
«1.Chiarire la identità positiva di Volere e Bene, in quanto risulta da
quella loro nullità [annotazione a margine dell’autore: Hegel fil. di diritto]
2.Giustificazione estrinseca delle cose apparentemente più scandalose
dette qui (luoghi di Gioberti)
3.Dal diritto alla Moralità mediante !!! il delitto: Dalla Moralità al
Costume mediante !!!!! il Male.
[Nello stesso foglio l’autore aggiunge delle annotazioni didattiche per se
stesso]:
Fare così: prima il 3° punto, ma brevemente. Senza Soggettività non
Bene. Soggettività = possibilità del Male. Poi il 2° punto. Il 3° al principio
della lez. seg. Come Concetto del Costume. In questa lezione solo il 2°
punto. Gio. nel Saggio sul Male Prot. II. “L’attività del mondo è la sola
cosa, che possa spiegare l’origine del male” (Se il mondo non fosse attivo,
344
Logos
non ci sarebbe male. E se non ci fosse male, il mondo sarebbe attivo?) –
Giob. Dice poi cosa sia questo attivismo: “Mondo è finito in atto, infinito in
potenza; è con dio che incomincia etc…”. Perciò Contingente. L’esistenza
del male è richiesta 1° dalla *** dell’infinito contingente. 2° dall’*** morale
Il Male (in generale: non il solo male) è in sé (nell’Universo) nullo. A: Il
male ha un lato di Bene. Il Male è in sé nullo. B: Il Male è in sé nullo: quindi
non immanenza del Male. C: Ragione e necessità del Male. D:»
Dopo il foglio 107 troviamo inserito un foglio non numerato da
Spaventa: esso è probabilmente stato inserito in quel luogo in quanto
l’autore vi descrive la figura della famiglia. Evidentemente si era occupato
dell’assunto in un’altra opera e ha aggiunto direttamente il foglio.
Quest’ultimo corrisponde perfettamente al testo a stampa tranne che per
gli ultimi due paragrafi che sono chiaramente l’inizio di un nuovo
discorso, il quale, infatti, non trova continuazione nel manoscritto.
Questi due paragrafi hanno come argomento il diritto di successione ed e
possibile ipotizzare, per l’argomento trattato, che essi appartengano al
corso modenese sulla filosofia del diritto, tenuto nel 1859-60:
«La successione è o testamentaria o ab intestato. Domandare la ragione
del diritto di successione, è domandare nel primo caso se l’uomo abbia il
diritto di disporre della sua proprietà a favore di un altro di maniera che il
suo volere abbia effetto anche dopo la sua morte; e nel secondo caso, se i
membri della famiglia abbiano il diritto di ereditare naturalmente e senza la
manifestazione della volontà di chi muore, sia il capo della famiglia, sia un
membro di essa. Sino alla fine del passato secolo questi due diritti si sono
considerati come validi in diritto naturale. Ma poi si è detto in primo luogo,
che l’uomo non può disporre del suo»
Notiamo inoltre delle varianti incisive o esplicative, consistenti per lo più
in delle frasi che chiarificano maggiormente concetti espressi in
precedenza ma che non implicano delle variazioni concettuali:
1. Al foglio 73 del 23 aprile
«Perciò, come già sappiamo, lo Spirito è Dialettica, attività dialettica: il
Primo e l’Ultimo dialettico: Processo32».
2. Al foglio 74 del 23 aprile
«Qui comincia una nuova sfera dello Spirito: la sfera dello spirito libero,
etico. Lo Spirito ora non è più semplice Anima, Coscienza, semplice
Soggetto (che si forma come Intendimento e Volere), come Teoria e
Questa frase viene utilizzata da Spaventa per chiarire maggiormente il
fondamentale concetto dell’unità degli opposti.
32
Il manoscritto De Anima di Bertrando Spaventa
Pratica: come Soggetto appunto, come Spirito individuale), ma è Soggetto
che si oggettiva: si oggettiva assolutamente e universalmente. Questo
secondo sviluppo è l’Etica»33.
3. Al foglio 84 v. del 9 maggio
«Conchiudendo, quel giudizio che è la Proprietà, che è il primo grado
dello spirito come diritto (e quindi dello Spirito etico) si fonda sulla
giudicabilità (sussumibilità; ogni giudizio è sussunzione) della cosa (la cosa è
praticamente giudicabile qui, in quanto non è libera, è in sé senza volere, è
semplice materia) e sulla universalità del volere. (universalità = forma,
categoria). Questa è la possibilità della Proprietà, di quel giudizio che è la
Proprietà. Kant domandava nella rag. teoretica: come sono possibili i giudizi
sintetici a priori? (Sensibilità, Intelletto: sintesi a priori: unità – teoretica –
***: spirito teoretico). Si può fare (e Kant lo fa) la stessa domanda: come
sono possibili i giudizi sintetici pratici a priori? Il giudizio pratico (etico) è
anche esso – in quanto legittimo (giuridico) – a priori. Materia e Forma;
Sensibilità (appetibilità, cosa) e Volere (libero volere). Unità sintetica
originaria pratica (etica): necessità etica, Diritto, unità in sé di volere
oggettivo e soggettivo, atto del libero volere (unità de’ due opposti: libero
volere e realtà immediata: libertà necessaria e necessità libera. V. le due
lezioni antecedenti). (Lo spirito è Ragione: teoretica ed etica, e come
Ragione è sempre sintesi pura originaria). (Questo è il gran pregio del
Kantismo)»34.
4. Al foglio 89v. del 16 maggio
«La libertà si realizza direttamente nella cosa esterna mediante il volere
soggettivo»
Questo passo chiude i Preliminari ed apre al capitolo successivo che nel testo a
stampa viene intitolato Lo spirito come mondo.
34 Spaventa dedica ben due monografie ad Immanuel Kant: La filosofia di Kant e la
sua relazione con la filosofia italiana (scritta nel 1856 e pubblicata nella Nuova enciclopedia
popolare nel 1860) e Kant e l’empirismo (comparso per la prima volta nel 1881 negli «Atti
dell’Accademia delle Scienze Morali e Politiche» di Napoli). Il criticismo kantiano ha un
ruolo fondamentale nel pensiero di Spaventa ed in particolar modo nella teoria della
circolazione del pensiero, in quanto egli ritiene che il filosofo di Königsberg rappresenti la
vera negazione storica dell’intellettualismo e dell’empirismo attraverso la categoria del
giudizio sintetico a priori: «Negare l’immediatezza e arrivare all’assoluta mediazione, è
l’opera gigantesca della critica kantiana. Kant, eccitato dallo scetticismo di Hume, apparisce come negazione a un tempo del sensualismo e dell’intellettualismo, e insieme
come la loro conciliazione. […] Tale è il gran pregio di Kant: il significato del suo
problema del giudizio sintetico a priori. Il difetto di Kant è l’aver presupposto il
conoscere, il non aver compreso come sia possibile l’”atto”, cioè quella unità originaria
degli opposti scoperta da lui stesso, l’aver ridotto questa unità a una unità vuota e
astratta» [B. Spaventa, Della nazionalità della filosofia (1862), in La filosofia del Risorgimento, a
cura della Società di Studi politici, Napoli, La Scuola di Pitagora, 2005, pp. 124-125].
33
346
Logos
5. Al foglio 92 v. del 19 maggio
«Lo stesso si può dire del Logo. Tale è l’Idea. Perciò Logo, Natura e
Spirito sono l’Idea. L’Idea è appunto questa Compossibilità. Processo dei
contrari, e alla fine unità di contradittori: Spirito = Unità della
contradizione con sé»35.
6. Al foglio 97 del 26 maggio:
«Ma per giungere sino a questo, bisogna intendere bene quel che ho
accennato fin qui, spiegare la contradizione, la contradizione con se stesso,
non già col principio di contradizione, del concetto del bene, tornare un po’
indietro.
(Dove dichiaro questo punto: Il Bene è l’Universalità del volere del
soggetto: quindi Dovere. In questa immediata posizione, la particolarità è
distinta dal Bene, e cade nel volere soggettivo; quindi il Bene – immediato –
ha solo questa determinazione: essenzialità universale astratta. Ciò pare
contrario al risultato della lezione antecedente: universalità concreta e
assoluta del volere)»
7. Al foglio 101 del 16 giugno, a proposito del diritto come
amministrazione della giustizia, chiarifica il concetto in questo modo:
«Il Diritto prova se stesso. Pena = vendetta del diritto: perciò non
semplice vendetta».
Abbiamo infine, nell’ultima pagina del manoscritto un’altra variante,
che definirei retorica: è l’esortazione finale che Spaventa fa ai suoi studenti
l’ultimo giorno di lezione (27 giugno 1863), in cui incoraggia i giovani ad
amare in modo serio e rigoroso la Scienza:
«Ringraziandovi di avermi udito fin qui, questo io vi raccomando: di
essere uomini puri, di non esser pettegoli, di amare la scienza per sé, di
prenderla per una cosa seria; la cosa più seria che ci sia. E si prende per una
cosa seria, quando si studia davvero e si è persuasi che studiare non è
improvvisare, simulare, sognare,*** di ragione - alias formale che con un
finto ** ogni difficoltà - ma avere coscienza, lealtà, sincerità, unità: verso di
sé e un po’ anche verso il prossimo (vivo e morto). Se ora non è tutto così,
se il nostro cielo non è ancora del tutto sereno - se tutti coloro che guidano
Scienza non sono uomini seri -, io spero che sarà così, se non oggi, domani,
dopodomani. Ciò dipende da voi».
35 Dopo aver illustrato la dialettica della compossibilità reale di due contrari – per
cui due contrari hanno la medesima radice pur non essendo la stessa cosa – nell’ambito
del volere libero e della natura, nel manoscritto figura anche un richiamo a questa
dialettica nel Logo. Nel testo a stampa questa analisi riguarda solo la Natura e lo Spirito.
Il manoscritto De Anima di Bertrando Spaventa
Queste sono le parole con cui Spaventa chiude il corso napoletano.
Egli ha parlato ai suoi studenti della scienza come la vera serietà della
vita, la quale trova il suo interesse solo in sé stessa e non in altro. Egli
esorta i giovani ad amare la scienza in se stessa, come il nostro filosofo
stesso ha fatto durante la sua vita. Le sue lezioni erano realmente
appassionate e in grado di spingere i ragazzi all’azione, così come
descrisse l’osservatore tedesco Theodor Sträter che, in una lettera del 5
dicembre 1864 indirizzata alla rivista berlinese «Der Gedanke»36, scrive
che se la filosofia moderna potrà avere un futuro sarà solo in Italia ed in
particolare con il «professore» Spaventa, per il quale «la filosofia è
diventata veramente quello che dovrebbe essere dai tempi di Fichte –
vita, azione, carattere personale, vorrei dire religione del cuore e non una
semplice occupazione mentale fra le altre»37.
La rivista «Der Gedanke» era l’organo ufficiale della Philosophische Gesellschaft, la
quale venne fondata dal gruppo degli hegeliani tedeschi raccolti intorno a Karl Ludwig
Michelet a Berlino il 5 gennaio 1843 e, dopo alcuni anni d’interruzione seguiti alla
rivoluzione del ’48, riprese la sua attività il 28 gennaio 1854. La rivista fu pubblicata tra
il 1860 e il 1884, rispettando una cadenza d’uscita regolare solo negli anni Sessanta. I
redattori volevano segnalare un rinnovato impegno della filosofia sul terreno
dell’intervento politico guardando soprattutto alla filosofia di Hegel, la quale venne
messa in continuo confronto con gli eventi politici contemporanei, e in base a ciò
sottoposta ad un considerevole mutamento di contenuti ed intenzioni teoriche. Nel
vasto quadro di contatti internazionali della rivista, lo scambio con Napoli e i suoi
filosofi ha un particolare rilievo, testimoniato soprattutto dalla corrispondenza del
libero docente di filosofia e di estetica dell’Università di Bonn Theodor Sträter, che tra
il 1864 e il 1865 inviò diverse lettere da Napoli alla rivista berlinese. Cfr. W.
Kaltenbacher (Hrsg.), Der Gedanke, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2004, pp. 335.
37 Th. Sträter, Lettere sulla filosofia italiana, ed. it. a cura di A. Gargano, Napoli,
Bibliopolis, 1987, pp. 10-11.
36
Simona Giacometti
La guerra e le decisioni spirituali: un possibile
progetto politico
1. I termini della ripresa simmeliana di Kant
La profondità del contributo filosofico che Simmel diede all’analisi
della propria epoca è indiscutibilmente connessa alla pluralità dei modelli
teorici con i quali il filosofo berlinese seppe confrontarsi in modo tanto
più produttivo, quanto meno convergente fu l’atteggiamento assunto
rispetto alle linee guida di diverse correnti.
Alla luce di questa premessa, va interrogata la natura del rapporto
che Georg Simmel intrattenne con le voci del panorama filosofico a lui
contemporaneo, in primis con gli esponenti delle scuole neokantiane alla
cui prospettiva non è assimilabile tout court la lettura che il filosofo
berlinese diede della filosofia kantiana.
I termini in cui Simmel si inserisce nel solco della tradizione
kantiana, le ragioni di continuità e di differenza con l’impianto filosofico
di Immanuel Kant si ricavano in modo esplicito nelle pagine di Kant. 16
Vorlesungen gehalten an der Berliner Universität1, ma Kant resta un punto di
riferimento centrale in tutto il percorso filosofico simmeliano, anche nei
lavori in cui la riflessione del filosofo di Königsberg non è elevata ad
oggetto privilegiato d’indagine.
Nel testo citato del 1904, come negli altri contributi in cui la figura di
Kant è presente seppur sullo sfondo, la specificità della posizione
simmeliana rispetto al paradigma kantiano si ricava più immediatamente
riconducendo tutti gli elementi di distanza tra i rispettivi dispositivi
G. Simmel, Kant. 16 Vorlesungen gehalten an der Berliner Universität, in Id.,
Gesamtausgabe, Band 9, hrsg. von G. Oaks und K. Röttgers, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1997; Kant. Sedici lezioni berlinesi, trad. it. A. Marini, A. Vigorelli, Milano,
Unicopli, 1987. Nelle pagine dell’opera, il sistema kantiano non è l'oggetto di una
ricostruzione storico-fìlosofica, quanto piuttosto l'esposizione di un possibile paradigma
teorico; in primo piano è la specifica modalità di risoluzione delle questioni-chiave della
filosofia da parte del filosofo di Königsberg, «si tratta esclusivamente di porre
nell'inventario intemporale del patrimonio filosofico [...] le idee essenziali con cui Kant ha
fondato una nuova immagine del mondo, indipendentemente da tutte le applicazioni e
integrazioni che – pur all'interno del sistema kantiano complessivo, non sono legati a quegli
elementi essenziali secondo interni punti di vista, capaci di determinare una visione del
mondo», ivi, p.9; (trad. it. cit., p. 63).
1
La guerra e le decisioni spirituali: un possibile progetto politico
interpretativi alla diversa nozione di soggettività elaborata dai due. Si
tratta di assumere nelle sue più ampie implicazioni l'affermazione di
principio in base alla quale «i principali problemi della vita nell'età
moderna si muovono essenzialmente attorno al concetto di
individualità»2 e di elevare quest’ultimo a criterio di confronto di
paradigmi di lettura del reale che presentano significativi elementi di
contatto accanto ad altri di differenza ugualmente forti.
Questa operazione è stata condotta con una certa consuetudine sul
terreno delle questioni etiche e gnoseologiche consentendo di misurare
rispettivamente la consistenza della legge individuale simmeliana al
confronto con l’imperativo categorico kantiano e la specificità del
contributo simmeliano nella definizione dello statuto delle scienze dello
spirito; la nostra analisi si propone di verificare se e come la differente
fisionomia assunta dal concetto simmeliano di individuo possa costituire
il presupposto e la cifra di una proposta alternativa al modello kantiano
non soltanto in relazione al problema della morale e della conoscenza,
ma anche a questioni di “filosofia politica”.
Siamo convinti che le riflessioni etiche e teoretiche sviluppate da
Simmel nelle pagine di Kant rendano manifesto, con un'immediatezza
certamente maggiore rispetto ad altri ambiti di riflessione, quella distanza
tra le Weltanschauungen dei due autori che intendiamo verificare anche nel
confronto tra il loro pensiero politico.
Dalla lettura di alcuni passaggi della prefazione a Kant. 16 Vorlesungen
gehalten an der Berliner Universität emerge come il motivo dell'interesse
simmeliano per la filosofia di Kant sia nella specifica modalità in cui il
filosofo di Königsberg struttura la relazione tra Io e mondo nella sfera
dell'attività teoretica e in quella pratica; l'istituzione di un parallelo tra la
riflessione politica di Kant e gli spunti contenuti negli scritti simmeliani
sulla prima guerra mondiale consente di estendere all’ambito della
riflessione politico-giuridica il confronto tra due modalità di intendere
quella relazione tra soggetto e oggetto che ha le sue fondamenta in
contesti “spirituali” profondamente distanti tra loro.
L’obiettivo è di rilevare i punti sui quali Kant è divenuto estraneo al
modo di sentire dell'uomo moderno
non solo rispetto alle
problematiche etica e gnoseologica, ma anche in relazione al modello di
organizzazione dello spazio politico e statuale. La tesi che intendiamo
sviluppare vuole dimostrare in primo luogo come, assumendo la
prospettiva simmeliana, nell'impostazione dell’analisi politico-giuridica
kantiana siano evidentemente riconoscibili le tracce di quel
2
Ivi, p. 215; (trad. it. cit., p. 253).
350
Logos
meccanicismo che il filosofo berlinese aveva rilevato già a proposito della
filosofia teoretica e morale.
Coerentemente con le ragioni a partire dalle quali il filosofo berlinese
aveva elaborato in sede etica la legge individuale in polemica con la logica
dell’imperativo categorico e, in sede teoretica, proposto una nuova
concezione dell’a priori per superare il formalismo da cui era affetta quella
kantiana, le considerazioni simmeliane sulla prima guerra mondiale
possono essere assunte come sintomatiche della percezione della fine di
un ordine politico tanto quanto dell'inadeguatezza dei tradizionali
modelli teorici a leggere, alla luce delle consuete categorie, la nuova realtà
che si andava configurando. Tra le righe di questa denuncia è possibile
cogliere rimandi ad un modello diverso di organizzazione in cui il singolo
e la totalità statuale sono in un rapporto completamente diverso da
quello teorizzato da Kant.
Nell'avanzare questa ipotesi interpretativa, è d'obbligo usare una
particolare cautela in considerazione del fatto che, nella sua pur ricca
produzione, Simmel non elabora in modo sistematico una teoria politica;
nondimeno gli scritti di guerra - non solo quelli raccolti nell'opuscolo Der
Krieg und die geistigen Entscheidungen ma anche quelli pubblicati su quotidiani
e riviste, compresa la corrispondenza intrattenuta con i maggiori
intellettuali dell'epoca - offrono spunti rilevanti da cui dedurre la
posizione assunta da Simmel di fronte alle forme d’organizzazione
politica della propria epoca.
Fissato quest'obiettivo, la nostra analisi si articolerà in passaggi
successivi volti a chiarire in primo luogo in che senso, dalla prospettiva
simmeliana, anche la riflessione politico-giuridica di Kant soffra di quel
razionalismo meccanicistico che, a chiare lettere, Simmel aveva
rimproverato all’etica e alla gnoseologia del filosofo di Königsberg;3
quindi, come la diversa caratterizzazione dei concetti simmeliani di
individuo e libertà possa costituire la cifra della definizione di un ordine
mondiale alternativo a quello liberale; infine, la natura e la direzione di
questa alternativa.
Spunti significativi a conforto della possibilità di interpretare la filosofia politica
di Kant in questa prospettiva sono stati ricavati dalla lettura di N. Bobbio, Kant e le due
libertà, in Id., Da Hobbes a Marx, Napoli, Morano, 1965, pp. 147-163, e di N. De
Federicis, Kant 'politico'? A margine del rapporto di Kant col liberalismo, in AA. VV., La filosofia
politica di Kant, a cura di G. M. Chiodi, G. Marini, R. Gatti, Milano, F. Angeli, 2001, pp.
159-165.
3
La guerra e le decisioni spirituali: un possibile progetto politico
2. Il “fanatismo logico” dell’impianto kantiano
Assumendo l'ottica interpretativa di Simmel, in relazione al primo
punto, crediamo che il meccanicismo della prospettiva kantiana sia
ravvisabile valutando sia il livello formale – quello che attiene alla
metodologia e all'impianto concettuale adottati - sia il piano
contenutistico della riflessione politica di Kant, considerando quanto la
specifica fisionomia dei suoi concetti di individuo e libertà risponda alle
caratteristiche proprie di un particolare stadio dello sviluppo economico
e socio-culturale4.
Per concezione meccanicistica Simmel intende quella che «opera con
strutture di fattura completamente nuova, non rinvenibili nella realtà dei
processi psichici, con concetti fermamente circoscritti, idealmente fissi,
che definisce come rappresentazioni singole»5; alla luce di questa
definizione, il primo elemento cui attribuiamo valore rispetto all'oggetto
della nostra indagine è il dato per cui lo Stato secondo Kant è un'idea
della ragione: «in sede pratica il diritto e lo Stato sono per Kant concetti
trascendentali, che attingono a una realtà intelligibile, e non possono
costituirsi che a priori in fuori da qualsiasi esperienza. Solo ciò che è a
priori ha validità oggettiva, universale»6 .
Il tema in questione ha uno sviluppo sistematico e coerente nella
prima parte dell'opera del 1798 Die Metaphysik der Sitten che si struttura
come «sistema di cognizioni a priori derivato da concetti puri che ha per
oggetto la libertà della volontà»7. Nelle pagine del testo, il suo autore
conduce uno studio sulle leggi che regolano la condotta dell'uomo come
essere libero da un punto di vista meramente razionale; si tratta quindi di
un'indagine sui principi razionali riconosciuti a fondamento dell'agire
pratico, distinta dalla pragmatische Anthropologie dedicata allo studio
empirico della condotta morale che pone in rilievo le condizioni
In questa prospettiva interpretativa si collocano i lavori di P. Koslowski, Staat
und Gesellschaft bei Kant, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1985, e di R. Saage, Eigentum, Staat und
Gesellschaft bei Immanuel Kant, Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1994.
5 G. Simmel, Das individuelle Gesetz. Ein Versuch über das Prinzip der Ethik, in Georg
Simmel Gesamtausgabe, Bd. 12, I, hrsg. von R. Kramme und A. Rammstedt, Frankfurt
am Main, Suhrkamp, 2001, p. 427; La legge individuale. Un saggio sul principio dell’etica, in Id.,
La legge individuale e altri saggi, a cura di F. Andolfi, trad. it. G. Barbolini, Parma, Pratiche,
1995, p. 87.
6 G. Solari, Introduzione a I. Kant, Scritti politici e di filosofia della storia e di diritto, trad.
it. di G. Solari e G. Vidari, a cura di N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, Torino, Utet,
1995, pp. 13-48, ivi pp. 25-26.
7 Ivi, p. 17.
4
352
Logos
soggettive della natura umana, favorevoli o contrarie all'adempimento
delle leggi della metafisica.
Soffermandoci a considerare la logica di fondo sottesa all'analisi
kantiana, dalla prospettiva simmeliana, le indicazioni contenute nella
prefazione, prima tra tutte, la presentazione della dottrina del diritto nei
termini di «sistema derivato dalla ragione, che si può chiamare metafisica
del diritto»8 sono del tutto in linea con l’impostazione della problematica
morale alla quale il filosofo berlinese aveva esplicitamente mosso l’accusa
di formalismo logico.
Nella norma morale kantiana Simmel aveva riconosciuto e
denunciato l’errore tipico dei procedimenti razionalistici ispirati da un
meccanicismo di fondo per il quale ogni processo psichico è innanzitutto
un contenuto singolarizzabile, separabile attraverso distinzioni logiche
dal complesso intreccio di elementi da cui ha origine. È in questo senso
che Simmel dichiara: «sia Kant che il suo sistema sono completamente
intellettualistici [...]. È il più grande trionfo, e il più raffinato, della
mentalità logico-concettuale quello di far decidere del valore degli uomini
solo alla volontà etica, ma nello stesso tempo di determinare l'eticità del
volere in base ad una norma puramente logica»9. L’intellettualismo di cui
Simmel accusa la morale kantiana è quindi la tendenza ad estendere la
validità delle norme che regolano il pensiero a tutte le dimensioni in cui
l’uomo vive ed agisce, il che, di necessità, richiede che le istanze etiche
siano private della forma del vissuto, perché è solo a questa condizione
che una norma può valere universalmente.
Negli stessi termini Simmel denunciava l’estraneità che l’a priori
kantiano mostra nei confronti della dinamica vitale dell’individuo perché,
dal punto di vista del filosofo berlinese, “se da un lato abbiamo il
compito di cercare in ogni fenomeno esistente, al di là del suo contenuto
sensibile, le norme a priori e durature che lo formano, dall’altro lato vige il
principio che si deve ricondurre ogni singolo a priori (ma non l’a priori in
generale) alla sua origine genetica nell’esperienza”10.
Il presupposto ad ogni obiezione che Simmel avanza alla definizione
kantiana di a priori è nella differenza che lo distingue dal concetto di idea
8 I. Kant, La metafisica dei costumi, trad. it. a cura di G. Vidari, Torino, G. V. Paravia e C.,
1923, p. 1. Sulla questione si rinvia al capitolo 7 del contributo di G. Solari, Studi storici di
filosofia del diritto, Torino, Giappichelli, 1949, pp. 207-229 (Scienza e metafisica del diritto in
Kant).
9 G. Simmel, Kant. 16 Vorlesungen gehalten an der Berliner, cit., pp.15-16; (trad. it. cit.,
p. 69).
10 G. Simmel, Philosophie des Geldes, in Georg Simmel Gesamtausgabe, Bd. 6, hrsg. von
D. P. Frisby und K. Ch. Köhnke, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1989, p. 113; Filosofia
del denaro, trad. it. di A. Cavalli, R. Liebhart, L. Perrucchi, Torino, Utet, 1984, p. 172.
La guerra e le decisioni spirituali: un possibile progetto politico
innata: il fondamento dell’universalità e della necessità delle idee innate è
nel soggetto e nel patrimonio di cui, in quanto uomo, è portatore. A
giudizio di Simmel, Kant non lega la validità incondizionata dell’a priori
alla capacità conoscitiva del soggetto di determinare i caratteri
dell’oggetto di esperienza, ma caratterizza l’a priori come forza oggettiva
che vale esclusivamente come postulato. Ad esso la concretezza non
viene dalla partecipazione alla dinamica psichica del soggetto, ma dalla
sua applicazione all’esperienza che ignora la «costituzione temporocoesistenziale del soggetto in quanto esistenza storicamente positiva»11.
Posto come obiettivo della sua riflessione l’individuazione delle
condizioni interne di una conoscenza che possa dirsi oggettivamente
valida, Kant valuta determinanti gli aspetti strutturali e non quelli
temporali nell’elaborazione dell’a priori. L’obiettivo autentico della critica
simmeliana al concetto di a priori è individuato nell’ideale kantiano
dell’assoluta estraneità della struttura oggettiva della scienza rispetto alla
dinamica dello sviluppo psichico del soggetto: l’intelletto kantiano, di cui
l’a priori è forma, possiede una validità oggettiva, è presentato come un
complesso di principi e non come una facoltà psichica dell’uomo, non è
un’estrinsecazione di vita individuale, ma “coscienza in generale”, il
senso per la connessione spirituale dei contenuti mondani.
Simmel chiaramente contraddice l’assunto kantiano dell’immutabilità
delle forme a priori: nel tentativo di dare espressione a ciò che eccede la
dimensione puramente intellettiva, egli afferma la necessità di attribuire a
queste forme una dinamicità per la quale esse si sviluppano nel corso
della storia umana, non sono eterogenee all’esperienza, ma si elaborano a
partire da questa fino ad acquisire una qualificazione sociologica.
La condizione posta da Simmel alla concreta validità dell’a priori e
alla realizzazione del processo di conoscenza, in virtù del suo contributo,
è la sua partecipazione alla dinamica della vita12. Per Simmel, l’a priori non
G. Semerari, Kant interpretato da Simmel, in «Rivista internazionale di filosofia del
diritto», 31 (1954), pp. 289-296, ivi p. 296.
12 Nelle pagine di Il relativismo critico e l’intuizione filosofica della vita nel pensiero di Georg
Simmel (Introduzione a G. Simmel, I problemi fondamentali della filosofia, trad. e intr. di A.
Banfi, pref. di F. Papi, Milano, SE, 2009, pp. 11-30), Antonio Banfi mette in luce come
il processo di storicizzazione delle forme a priori sia stato condotto da Simmel al punto
da riconoscervi degli atti individuali dello spirito, una sorta di atti di coscienza. Anche
Giorgio Di Giovanni ha posto la contestazione del carattere intellettualistico delle
categorie a fondamento del relativismo di Simmel. La negazione dell’assolutezza e della
necessità che i kantiani e i neo-kantiani attribuiscono agli a priori è interpretata dal
critico come testimonianza di «un fenomeno di endosmosi in cui appaiono il
relativismo gnoseologico e il relativismo sociale», G. Di Giovanni, Teoria della conoscenza e
filosofia della vita in Georg Simmel, Roma, De Luca, 1968, p. 8.
11
354
Logos
è forma dell’intelletto, ma, innanzitutto, evento psichico, rintracciabile
nell’interiorità del soggetto e, per questo, intrecciato con il suo sentimento
della vita. La natura psicologica delle categorie del soggetto conoscente le
pone in un rapporto di correlazione con il contenuto del conoscere e
conferisce ad esse una validità ipotetica, euristica, relativa esclusivamente
allo specifico ambito di analisi nel quale trovano applicazione. Come
mutuazioni dell’esperienza, le categorie si trasformano da principi
regolatori in principi euristici o, nei termini utilizzati da Pietro Rossi,
«l’apriorità è il segno di una funzione esercitata in un particolare indirizzo
di ricerca, non è un attributo che poggia su un’origine diversa
dall’esperienza»13.
L’intellettualismo che Simmel rimprovera a Kant nelle pagine di
Kant. 16 Vorlesungen gehalten an der Berliner Universität in relazione
all’impostazione della sua proposta etica e gnoseologica può essere esteso
anche al discorso politico-giuridico, se il filosofo di Königsberg «insiste
dunque sulla necessità di superare il punto di vista empirico entro cui si
muove il giurista e di trasferire sul terreno della pura razionalità la ricerca
dell'essenza del diritto» 14, con l'obiettivo di individuare il criterio
universale cui l'uomo deve ispirare la propria condotta, perché essa sia
conforme a giustizia.
Nella denuncia del carattere intellettualistico del moralismo kantiano
Simmel aveva già rilevato quanto fosse centrale «questa riduzione dell'io
al razionale, questa messa al bando del sensibile dal regno della libertà»15.
A giudizio del filosofo berlinese, il fondamento della validità universale e
necessaria di ogni norma è posto da Kant esclusivamente nella razionalità
di cui l'uomo, come essere intelligibile, è partecipe. Il dato centrale, al
quale la lettura simmeliana conferisce rilievo assoluto, è la presupposta
equazione tra questa idea di ragione e quella di umanità per cui, secondo
Simmel, all’interno dell’impianto kantiano «la legge, nella cui forma
incontriamo il valore morale, non contiene alcuna contraddizione nei
riguardi della libertà, poiché essa - e l'obbedienza che le dobbiamo - è
l'espressione del nostro più proprio interno, non determinabile da alcun
potere fuori di noi. Agendo per dovere, obbediamo di fatto solo a noi
13
p. 212.
P. Rossi, Lo storicismo tedesco contemporaneo, Torino, Giulio Einaudi editore, 1956,
G. Lumia, La dottrina kantiana del diritto e dello stato, Milano, A. Giuffrè, 1960, p. 40.
G. Simmel, Kant. 16 Vorlesungen gehalten an der Berliner Universität, cit., p.145; (trad.
it. cit., p. 188).
14
15
La guerra e le decisioni spirituali: un possibile progetto politico
stessi, tutto ciò che non sia noi stessi viene, in base ai presupposti della
moralità, completamente escluso da essa» 16.
Nella lettura simmeliana del sistema kantiano, il contenuto del
concetto di libertà si eleva a indicatore dell'impostazione meccanicistica
della Weltanschauung del XVIII secolo di cui Kant è, a giudizio del filosofo
berlinese, l'esponente più rappresentativo.
Il concetto di libertà elaborato nel clima spirituale del ‘700 «definisce
l’insieme delle tensioni e delle rivendicazioni individuali rispetto alla
società»17: i vincoli di ceto, di corporazione e di chiesa, posti e legittimati
dalle istituzioni settecentesche, avevano generato un complesso di
disuguaglianze che costringeva le forze della personalità in vie per essa
innaturali; sulla base di questa salda convinzione sembrò allora che
l’unica condizione che potesse garantire una libera espressione del nucleo
autentico di un’individualità fosse l’eliminazione delle disuguaglianze,
attraverso quella della disuguaglianza in generale.
In questi termini Simmel definisce l’«individualismo dell’uguaglianza»
secondo il quale «l'uomo è sempre e ovunque lo stesso, perché da lui è
tolto ciò che distingue gli uomini gli uni dagli altri. II motivo di fondo è
che in ciascun uomo è contenuto un nucleo che rappresenta in lui
l'essenziale e che al tempo stesso è in tutti gli uomini il medesimo»18,
chiaramente riconoscibile nell'universale razionalità. L’affermazione della
libera volontà individuale venne in questo modo a coincidere
perfettamente con la rivendicazione di un ideale di uguaglianza19. Il suo
fondamento fu individuato dai razionalisti nella seconda possibile
16 Ivi, p.117; (trad. it. cit., p. 163). Nella stessa direzione la riflessione espressa
da Lunati che, in riferimento alla problematica della libertà in Kant, scrive: «Fra
ragione e libertà vi è un rapporto strettissimo; non può la prima sussistere senza
che la seconda non si svolga con la propria peculiare indipendenza dalla sensibilità, non
può la seconda essere peculiarmente indipendente senza una intrinseca libertà», G.
Lunati, La libertà. Saggi su Kant, Hegel e Croce, Napoli, Giannini, 1959, p. 31.
17 G. Simmel, Grundfragen der Soziologie (Individuum und Gesellschaft in Lebensanschauung
des 18. und 19. Jahrhunderts. Beispiel der philosophischen Soziologie), in Georg Simmel,
Gesamtausgabe, Bd. 16, hrsg. von G. Fitzi und O. Rammsted, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1999, p. 128; Forme e giochi della società. Problemi fondamentali della sociologia, trad.
it. di C. Tommasi, Milano, Feltrinelli, 1983, p. 100.
18 G. Simmel, Die beiden Formen des Individualismus in Georg Simmel Gesamtausgabe,
Band 7, I: Aufsätze und Abhandlungen 1901-1908, hrsg. von R. Kramme, A. und O.
Rammstedt, 1995, p. 51; Le due forme dell'individualismo, in Id., La legge individuale ed altri saggi,
Parma, Pratiche, 1995, pp. 31-39 ivi p. 33.
19 Sulla questione, cfr. H. Kress, Il pensiero dell’individualità in Schleiermacher e i suoi
riflessi sulla filosofia della vita di Simmel, in «La società degli individui», 7, III (2000/2001),
pp. 31-56. Il contributo compare nella sua prima edizione in AA. VV., Internationaler
Schleiermacher-Kongress, hrsg. von K. V. Selge Berlin 1984, Berlin-New York, 1985, pp.
1243-1266.
356
Logos
accezione assunta dal concetto di natura: oltre che «sostanza
dell’accadere storico», essa è definita «essere originario della specie e degli
individui umani»20, intendendo in tal modo l’universale razionalità di cui
ogni fenomeno – umano e non – rappresenta soltanto un caso
particolare. «Sottolineando l'identico nucleo essenziale, la comune
partecipazione di tutti gli uomini alla dimensione razionale
universalmente umana, egli [Kant] può fondare l'idea che tutti gli
individui siano da considerarsi come aventi gli uni di fronte agli altri
uguali diritti e uguale valore»21.
Determinato il contenuto proprio dell'idea kantiana di libertà,
occorre a questo punto verificare come la ragion d'essere dello Stato
consista nel dispiegare pienamente l'idea del diritto nella concordanza
delle libertà individuali sotto una legislazione universale.
3. Il modello kantiano di Stato
Se assumiamo la prospettiva simmeliana, non possiamo non
accogliere il giudizio espresso da Solari per il quale nella teoria giuridica
kantiana «lo Stato si pone come organo dell'Io comune ed è chiamato a
tradurre in atto l'esigenza razionale implicita nella norma universale»22 ;
crediamo che la genesi stessa di questo istituto del diritto pubblico possa
esserne una conferma inequivocabile. Inserendosi nella linea tracciata da
Hobbes e Locke23, Kant fa propria l'idea del passaggio da uno stato di
natura ad uno stato civile il quale, però, rispetto al primo non si
differenzia essenzialmente, cioè nella sua sostanza più propria: distinti tra
loro stato civile, stato naturale e stato giuridico, Kant precisa che «il
primo e il secondo si possono chiamare di diritto privato, il terzo ed
ultimo poi stato di diritto pubblico. Questo non contiene nulla di più o
non contiene altri doveri degli uomini fra di loro che quelli che possono
G. Simmel, Grundfragen der Soziologie (Individuum und Gesellschaft in Lebensanschauung
es 18. Und 19. Jahrhunderts. (Beispiel der Philosophischen Soziologie), cit., p.129; (trad. it. cit., p.
101).
21 H. Kress, II pensiero dell'individualità in Schleiermacher e i suoi riflessi sulla filosofia della vita
di Simmel, cit., pp. 31-56.
22 G. Solari, Introduzione, cit., p. 16.
23 In polemica con l'eudemonismo giuridico e politico di cui costoro sono
rappresentanti, Kant rifiuta categoricamente l'idea che la costituzione dello Stato sia
funzionale al conseguimento della felicità e della perfezione individuali; piuttosto la sua
genesi va ricondotta alla necessità di tutelare i principi posti dalla ragione legislatrice pura a
priori che non tende al conseguimento di singoli fini empirici, ma a garantire, attraverso
l'esercizio di un potere coattivo, gli stessi diritti riconosciuti nello stato di natura all'uomo
come essere razionale, in primis quello alla libertà.
20
La guerra e le decisioni spirituali: un possibile progetto politico
essere pensati nel primo; la materia del diritto privato è uguale in
ambedue i casi. Le leggi dell'ultimo riguardano, dunque, soltanto la forma
giuridica dell'unione degli uomini tra loro (la loro costituzione),
relativamente alla quale esse leggi devono essere pensate necessariamente
come pubbliche» 24 .
Già anni prima - quando nel 1793 Kant attese alla pubblicazione di
Über den Gemeinspruch: Das mag in Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die
Praxis -, nella seconda sezione dello scritto dedicata all'analisi del
rapporto tra teoria e prassi in relazione al diritto dello Stato, il filosofo
definisce il diritto pubblico rispetto alla nozione generale del diritto in
questi termini: «Diritto è la limitazione della libertà di ognuno alla
condizione dell'accordo di questa con la libertà di ogni altro, in quanto
ciò sia possibile secondo una legge universale; e diritto pubblico è
l'insieme delle leggi esterne che rendono possibile un tale accordo
onnicomprensivo»25.
Il passaggio appena ripreso, oltre ad individuare nell'indispensabile
presenza del potere coattivo l'elemento che distingue il diritto pubblico
dal diritto privato, pone in luce un dato essenziale alla comprensione
della modalità specifica in cui, nella prospettiva kantiana, particolare e
universale, individuo e Stato sono tra loro in relazione. Esiste, a giudizio
del filosofo di Königsberg, un «unico diritto originario spettante ad ogni
uomo in forza della sua umanità»26 che precede l'istituzione
dell'organismo statale e che è da riconoscere nella libertà.
Questo aspetto non è irrilevante ma, al contrario, consente di
verificare come nella prospettiva kantiana «l'ordine politico statale [sia] al
servizio di questa libertà: non è l'uomo libero ad essere fatto per lo Stato,
ma lo Stato che si fa per l'uomo libero»27. La costante minaccia che, in
una condizione cosiddetta “pre-giuridica”, viene dall'esistenza dell'altro,
in quanto semplice esistenza28, pone la necessità di istituire un organo
della volontà comune, per cui gli uomini commetterebbero
«un'ingiustizia in massimo grado nel voler essere e rimanere in uno stato
che non è giuridico, nel quale cioè nessuno è certo del suo contro la
24 I.
Kant, La metafisica dei costumi, cit., pp. 139-140.
Id., Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la prassi, in Id.,
Scritti di storia, politica e diritto, a cura di F. Gonelli, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 123161, ivi p. 137.
26 Id., La metafisica dei costumi, cit., p. 46.
27 A. Tosel, Kant rivoluzionario: diritto e politica, trad. it. F. Petrucciani, Roma,
Manifestolibri, 1999, p. 51.
28 I. Kant, Per la pace perpetua, in Id., Scritti di storia, politica e diritto, cit., pp. 163-207,
ivi p. 169.
25
358
Logos
prepotenza degli altri»29 ; la transizione dallo stato di natura allo stato
giuridico si configura quindi, a giudizio di Kant, come un dovere che,
però, al contrario di quello imposto dalla morale, non ha in sé il proprio
fondamento, ma nella necessità di tutelare ciò che è proprio dalla
minaccia dell'altrui appropriazione.
La costituzione dello stato giuridico è sancita dalla stipula di un
contratto originario, le cui caratteristiche dicono ancora qualcosa del
formalismo tipico del procedimento adottato da Kant30; di nuovo, a
conferma di quel «fanatismo logico» che costituisce la trama della critica
simmeliana al sistema kantiano, il contratto, lungi dall'essere «un fatto»
storicamente determinato, collocato nello spazio e nel tempo, costituisce,
piuttosto, un'idea di ragione 31, il cui soggetto è «l'uomo noumenico, che
realizza in unione con i suoi simili, mediante lo Stato, la condizione di
vita rispondente alla sua natura di essere razionale»32. «Ecco in tal modo
dedotta a priori l'esigenza del diritto il quale ha lo scopo di garantire la
libertà esterna, ossia di rimuovere gli ostacoli esteriori che impediscono
all'uomo di agire nel mondo conformemente alle leggi di ragione»33.
Quanto detto fin qui attiene al piano formale del discorso kantiano,
alla metodologia e all’impianto concettuale della sua analisi; se ne
consideriamo di seguito il contenuto, lo scarto tra le posizioni di Kant e
Simmel è evidente anche in relazione alla differente modalità in cui, nella
loro analisi, lo Stato sembra organizzarsi a tutela e garanzia della libertà
individuale.
Caratteristica della riflessione kantiana è la stretta connessione che la
nozione di libertà presenta con quella di proprietà. Prima ancora che
rispetto agli oggetti esterni, l'autonomia di cui l'individuo gode come
Staatsbürger consiste, a giudizio di Kant, nel fatto che «jeder sich selbst besitzt
und nicht vom absoluten Willen eines anderen neben oder über ihm abhängt»34; è
persona e soggetto giuridico esclusivamente chi possiede diritto di
determinazione sulla propria persona, appartiene a se stesso e a nessun
Id., La metafisica dei costumi, cit., p. 141.
In questa prospettiva si colloca l’analisi di A. Negri, Alle origini del formalismo
giuridico. Studio sul problema della forma in Kant e nei giuristi kantiani tra il 1789 e il 1802,
Padova, Cedam, 1962.
31 I. Kant, Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la prassi, cit.,
pp. 143-144.
32 G. Solari, Introduzione, cit., p. 17.
33 G. Lumia, La dottrina kantiana del diritto e dello stato, cit., p. 42.
34 I. Kant, La metafisica dei costumi, cit., pp. 149-150. Citiamo il passaggio appena
ripreso in lingua tedesca che consente, meglio di quella italiana, di porre in rilievo
l'uso del termine Besitzt e quindi la specificità della nozione di autonomia come
possesso su di sé.
29
30
La guerra e le decisioni spirituali: un possibile progetto politico
altro e indicativo della sua capacità giuridica è il riconoscimento del
diritto di voto35. Ma «la qualità che si esige a questo fine, eccetto quella
naturale (che non sia donna né bambino), è esclusivamente questa: che
egli sia suo proprio signore (sui iuris), e cioè che abbia una qualche
proprietà (in cui può includersi anche ogni arte, lavoro manuale, o arte
bella o scienza) che lo mantenga [...]»36
La centralità della possessio o del Besitz, come esperienza giuridica
fondamentale del diritto privato moderno, è confermata dalla
formulazione del postulato giuridico della ragion pratica - «il considerare
e trattare ogni oggetto del mio arbitrio come cosa che oggettivamente
può diventare mia o tua»37 -; ciò definisce lo stato di natura come sfera
del possesso, luogo di appropriazione della terra da parte di proprietari
privati, per cui esso - il giudizio è di Tosel- «nella sua generalità formale
esprime la modernità “borghese” di Kant. [...]. Per e attraverso la libertà
moderna del proprietario privato, la natura cessa di essere soltanto un
“dato” trascendente. Essa è data al nostro arbitrio onde questo qualifichi
a priori la natura come materiali da trasformare in “cose”, in oggetti
utilizzabili»38.
Che la proprietà costituisca il principio supremo del sistema
giuridico e politico kantiano è ulteriormente deducibile dall'affermazione
per cui «è possibile che io abbia come mio un oggetto esterno del mio
arbitrio; il che vuoi dire che una massima, secondo la quale (qualora esse
avesse forza di legge), un oggetto dell'arbitrio dovesse essere in sé
(oggettivamente) senza padrone (res nullius), è contraria al diritto».39
Il rapporto di proprietà preesiste allo Stato e in esso trova
semplicemente la condizione che lo rende stabile, che la trasforma da
provvisoria a perentoria; «Lo Stato pertanto sorge e si costituisce per la
difesa della proprietà individuale e solo il proprietario riveste la qualità di
cittadino, cioè di compartecipe alla sovranità. Lo Stato giuridico kantiano
realizzava uno dei postulati del liberalismo che associava in vincolo
indissolubile la libertà e la proprietà»40.
«Der Eigentumsbegriff konstituiert bei Kant den Person-Begriff», P. Koslowski, Staat und
Gesellschaft bei Kant, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1985, p. 13.
36 I. Kant, Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la prassi, cit.,
p. 142.
37 Ivi, p. 57.
38 A. Tosel, Kant rivoluzionario: diritto e politica, cit., pp. 55-56.
39 I. Kant, La metafisica dei costumi, cit., p. 56.
40 G. Solari, Introduzione, cit., pp. 29-30.
35
360
Logos
4. Gemeinschaft versus Gesellschaft
Se lo Stato kantiano è chiamato a porre in essere quelle condizioni
che garantiscano ai singoli soggetti giuridici l'esercizio della propria
universale razionalità contro la minaccia rappresentata dall'esistenza
altrui, allora l'ordine politico che esso istituisce è al servizio di una libertà
intesa come tutela del singolo dall'ingerenza dell'altro, come difesa
dell'inviolabilità e dell'autonomia dell'individuo dall'impedimento che
proviene non solo dagli altri soggetti giuridici, ma anche dallo stesso
Stato.
Di tutt'altro genere è il contenuto proprio del concetto di libertà di
cui si fa garante la Germania nello scontro ideologico prima che politico
negli anni del primo conflitto mondiale, come consente di verificare
quanto di seguito riportato: «Caratteristico del concetto tedesco di libertà
è la consapevole priorità del tutto: tutti i singoli elementi dell'impero
conservano la loro indipendente peculiarità tuttavia, ciononostante si
controllano, si lasciano inquadrare entro la totalità; allo stesso modo ogni
singolo individuo fin dalla fanciullezza domina se stesso a favore del
tutto»41.
Ribadendo quanto premesso in apertura a questo contributo, di una
teorizzazione stricto sensu del problema politico nella riflessione di Georg
Simmel sarebbe forse improprio parlare. E nostra intenzione, tuttavia,
dimostrare come dal contenuto dei saggi raccolti nell'opuscolo del 1917,
Der Krieg und die geistigen Entscheidungen, si possa ricavare la volontà
dell'autore di discutere e ridefinire il rapporto tra parte e tutto, tra
individuo e Stato, in termini alternativi rispetto a quelli tipici del
liberalismo borghese di cui Kant appare, nell'analisi fin qui condotta,
rappresentante illustre.
Una trattazione sistematica della questione del rapporto tra individuo
e totalità si ricava innanzitutto dalle prime battute di Deutschlands innere
Wandlung laddove Simmel afferma esplicitamente che il cambiamento
prodotto dall'evento bellico «era innanzitutto conness[o] ad un rapporto
sentito in modo nuovo tra il singolo e l'intera nazione»42. Il giudizio
simmeliano sulla guerra è, in queste pagine come in altre della raccolta,
strutturalmente connesso alla critica della modernità : riprendendo le
H. S. Chamberlain, Kriegsaufsätze, München, F. Bruckmann, 1915, p. 22.
G. Simmel, Deutschlands innere Wandlung, in Id., Der Krieg und die geistigen
Entscheidungen, in Id., Gesamtausgabe, Band 16, hrsg. von G. Fitzi und O. Rammsted,
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1999, p. 14; (trad. it. La trasformazione interiore della
Germania, in Id., Sulla guerra, a cura di S. Giacometti, Roma, Armando editore, 2003, pp.
50-51).
41
42
La guerra e le decisioni spirituali: un possibile progetto politico
argomentazioni già sviluppate in Philosophie des Geldes, il filosofo berlinese
si sofferma a considerare come nella società moderna il rapporto tra
singolo e totalità sia disciplinato dalle necessità poste dalla divisione del
lavoro per cui «il singolo aveva consapevolezza di essere legato al tutto in
virtù del suo contributo specifico e lo scambio di ciò, cosa che si
estendeva a tutta la vita nazionale»45.
Lo scoppio della guerra segna, innanzitutto rispetto alla problematica
in questione, una svolta: nello stato d'eccezione inaugurato dal conflitto
«non accade semplicemente che una parte circoscrivibile della propria
esistenza personale si trasformi; al contrario, si ha una sola esistenza nella
quale la componente più individuale e quella più generale si
compenetrano in ogni punto per diventare unità di vita»43.
Una valutazione comparativa della natura del rapporto che il singolo
stabilisce con la totalità, entro il pensiero politico di Kant e di Simmel,
consente di verificare quanto il modello della Kultur tedesca – difesa
strenuamente dall’intellettualità tedesca favorevole alla guerra di fronte
alla minaccia di una crescente Zivilisation - sia a fondamento di un'altra
idea di comunità, per la quale gli individui non compongono lo Stato, ma
si identificano con esso: non è, infatti, il contratto sociale o una
costruzione finalistico-razionale che crea lo Stato dagli individui, ma un
Volksgeist con cui la guerra chiama a identificarsi.
Le parole che Troeltsch pronuncia il 2 agosto del 1914 di fronte ad
una folta assemblea riunita presso l'università di Heidelberg sono, in una
certa misura, paradigmatiche perché in esse riconosciamo espressi la
natura ideologica della guerra e i compiti che ad essa l'intellettualità tutta
conferisce: «Oggi, in mezzo alla guerra e proprio attraverso la guerra si
pone il grande compito del vivere umano, unire nel loro rapporto
comunità e libertà, individuo e Stato in un modo nuovo ma nello stesso
tempo procedente dall'antico senso e Wesen del Deutschtum»44.
Se in una certa prospettiva è evidentemente riconoscibile nelle
pagine dell'opuscolo del 1917 un documento del clima di mobilitazione
spirituale in cui il testo viene alla luce, assumere questa raccolta
esclusivamente come una testimonianza della densa problematicità delle
circostanze politiche che ne costituiscono lo sfondo non renderebbe
ragione del senso più proprio del sostegno simmeliano alla causa bellica.
Ignorare i presupposti teorici a fondamento dell'appoggio che Simmel e
l'intellettualità tedesca offrirono alle ragioni della prima guerra mondiale
43 Ivi,
p.15; (trad. it. cit., p. 52).
E. Troeltsch, Das Wesen des Deutschen, in Id., Deutscher Geist und Westeuropa:
gesammelte Kulturphilosophische Aufsatze und Reden, hrsg. von H. Baron, Aalen, Scientia,
1966, ivi p. 28.
44
362
Logos
ci esporrebbe al rischio di un’interpretazione scorretta del fenomeno
come stato di acritica ed indifferenziata esaltazione del conflitto45; al
contrario, l'ipotesi che discutiamo in questa sede intende verificare come
nella guerra sia piuttosto in questione la validità di un paradigma
esistenziale, storico e politico che ha le sue radici nello spirito del XVIII
secolo46. Solo a questa condizione, la raccolta Der Krieg und die geistigen
Entscheidungen può essere inserita nel solco di un'evoluzione organica di
pensiero entro la quale crediamo che essa rappresenti il tentativo di
pensare e, sotto alcuni aspetti, di “praticare” una ridefinizione del
rapporto soggetto-oggetto, alla cui problematicità Simmel ha dedicato la
sua riflessione fin dagli esordi del proprio itinerario speculativo.
Lo scoppio della prima guerra mondiale, a giudizio di Simmel, segna
l'apice della crisi del paradigma esistenziale che nella personale immagine
del mondo elaborata da Kant aveva la sua più rappresentativa
formalizzazione. In considerazione di ciò e di quanto andremo
discutendo in seguito, risulta presumibilmente più comprensibile la
ragione del riferimento, ricorrente nella pubblicistica di guerra, al
contrasto ideologico di fondo tra le idee del 1789 e quelle del 1914: «il
1914 rappresenta senza dubbio un punto di svolta della storia europea e
45 Nella recensione a G. Simmel, Aufsätze und Abhandlungen 1909-1918 (Georg
Simmel, Gesamtausgabe, Bd. 13, II, hrsg. Klaus Latzel, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 2000),
in «Filosofia politica», XV, 3 (2001), pp. 485-488, G. Fitzi denuncia la tendenza della
storiografia tedesca sull'argomento a rimanere in sospeso tra un orientamento incline a
considerare la guerra come un evento a lungo atteso, cui gli intellettuali avrebbero
legato la speranza di un rinnovamento della cultura e, su un altro versante, quello
generalmente disposto ad interpretare l'atteggiamento dell'intellettualità tedesca
esclusivamente come una reazione irrazionale allo scoppio improvviso del conflitto.
Paradigmatici delle tendenze descritte i contributi di U. Barrelmayer, Der Krieg, die Kultur
und die Soziologie. Georg Simmel und die deutschen Soziologen im Ersten Weltkrieg, in «Sociologia
Internationalis», 34 (1994), pp. 163-190, e di H. Jonas, Die Sozialwissenschaften und der
Erste Weltkrieg: Eine vergleichende Analyse, in W. J. Mommsen, Kultur und Krieg. Die Rolle der
Intellektuellen, Künstler und Schriftsteller im Ersten Weltkrieg, München, Oldenbourg, 1996,
pp. 17-29. Se al primo va riconosciuto il merito di considerare lo sviluppo simmeliano
del tema del primo conflitto mondiale in connessione con la teoria della cultura
elaborata dal filosofo berlinese - rilevando la funzione di rinnovamento assunta dalla
guerra di fronte alla crisi della cultura -, il secondo si limita alla considerazione dei suoi
effetti sociopsicologici, senza considerare la natura filosofica o, più precisamente
metafisica, della prospettiva d'indagine di Georg Simmel.
46 In questo senso conferme vengono da quanto lo stesso Simmel afferma in nota
ad una considerazione svolta nelle pagine di Deutschlands innere Wandlung: «Anche qui la
guerra ha rivelato ciò che si può chiamare la sua portata metafisica: la guerra è il grande
movimento di separazione tra la luce e le tenebre, tra il nobile e la gente comune cui un
trascurabile periodo di pace poteva concedere limiti più incerti», G. Simmel, Deutschlands
innere Wandlung, cit., p.19; (trad. it. cit., p. 57).
La guerra e le decisioni spirituali: un possibile progetto politico
mondiale [...]. Nel 1914 crolla il mondo borghese del XVIII secolo,
finisce un'epoca storica cominciata nel 1789»47; lo scoppio della
rivoluzione francese e la diffusione dei suoi ideali avevano segnato
storicamente l'avvento del mondo borghese ottocentesco, al cui concetto
di libertà gli intellettuali tedeschi che si richiamano alle idee del 1914
oppongono quello di responsabilità, co-appartenenza, autorità espressi
nella nozione di Ordnung «primo grande ideale del 1914 che deve
distruggere quello di libertà sorto nel 1789 e trasformato in
degenerazione»48.
La percezione di essere di fronte ad un evento epocale49 è comune e
condivisa anche dal filosofo berlinese per il quale la guerra irrompe
improvvisamente nell'imperturbabilità della vita quotidiana, ne scuote i
fondamenti e la situazione estrema in cui getta l'individuo costringe a
rinunciare a tutto ciò che non è più vitale e cui consentiva la
sopravvivenza solo una dimensione ordinaria nella quale l'esistenza non
era messa in discussione. «Solo un lungo periodo senza scotimenti molto
profondi fa sorgere una visione meccanicistica, per la quale ciò che è
comune e ciò che è proprio esistono in una sorta di separazione spaziale.
Le epoche in cui crolla quella artificiosità astratta propria di ogni
separazione in presenza di sconvolgimenti dei fondamenti vitali sono
piene dell'interezza e della grandiosità della vita»50.
A chiare lettere fin dal titolo della raccolta, emerge l'opportunità di
intendere la riflessione simmeliana di questi anni in un senso più ampio
di quello che verrebbe dalla considerazione di questi scritti, se li
47 R. Rürup, Der Geist von 1914 in Deutschland, in B. Hüppauf, Ansichten vom Krieg.
Vergleichende Studien zum Ersten Weltkrieg in Literatur und Gesellschaft, Königstein/Ts.,
Forum Academicum, 1984, pp. 1-30, p. 5.
48 R. Kjellen, Die Idee von 1914. Eine weltgeschichtliche Perspektive, Leipzig, S. Hirzel
Verlag, 1915, p. 34.
49 In una lettera indirizzata a Margarete Susman il 22 agosto del 1914, Simmel
descrive lo scoppio della guerra come «un evento inaudito, il destino dell'intero
mondo della cultura sentito immediatamente come del tutto proprio, non più una
parte, ma contemporaneamente, in questo momento, assoluta indistinzione, [tra] colui
che rappresenta la totalità e ciascun individuo!», In G. Simmel, Briefe, in G. Simmel,
Gesamtausgabe, Band 23, Hrsg. von O. und A. Rammstedt, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 2008, p. 372
50 G. Simmel, Deutschlands innere Wandlung, cit., p. 14; (trad. it. cit., p. 51). Poco
più avanti ulteriore conferma a quanto appena considerato viene da questa
affermazione: «Chi non sia in grado di cooperare per la costruzione della nuova
Germania, chi - uomini e cose -, nei cui confronti la guerra si limita ad eseguire la
sentenza, è interiormente già condannato e reso improduttivo, deve stare in disparte.
Poiché le scosse della guerra agitano gli alberi fino al punto in cui cade ciò che è
troppo maturo e appariva ancora fresco solo alla più pigra indulgenza», ivi, p. 21; (trad.
it. cit., p. 61).
364
Logos
assumessimo semplicemente come documento di una generica adesione
alla pubblicistica di guerra51. La straordinarietà dell'evento chiama il
mondo tedesco ad una «decisione. spirituale» che lo investe nelle sue
fondamenta come lascia intendere anche un'esplicita dichiarazione di
Simmel per il quale «comunque si possano concludere gli eventi attuali,
vivremo il nostro futuro sul terreno e il suolo di un'altra Germania. [...].
Nessuno oserà determinare positivamente oggi il modo in cui ciò si
mostrerà in forma e contenuto; ma forse, proprio perché noi non
conosciamo il modo ma solo il fatto, questa idea per così dire
indifferenziata ci domina in modo tanto più forte e generalizzato: ne
uscirà un'altra Germania rispetto a quella che è entrata in questa
guerra»52.
A combattere questo Kulturkrieg53 sono due modi di intendere
l'individuo, la sua libertà e l'organizzazione statale entro la quale essa si
51 Lo strumento cui l'ambiente accademico ricorre sistematicamente è la
diffusione di appelli, un fenomeno di proporzioni tali da giustificare l'uso che la
storiografia ha tradizionalmente fatto della formula guerra di proclami. Una delle tappe
più significative di questa battaglia è rappresentata dalla pubblicazione sui principali
quotidiani, il 4 ottobre 1914, dell'Aufruf an die Kulturwelt, redatto da WilamowitzMoellendorf e sostenuto dalle firme di 93 dei più illustri esponenti dell'intellettualità
tedesca (il testo compare per la prima volta in H. Kellermann, Der Krieg der Geister,
Weimar, 1915, p. 3, successivamente fu incluso nella raccolta antologica di Böhme,
Aufrufe und Reden deutscher Professoren, Stuttgard, Reclam, 1975, pp. 47-49). Successiva di
pochi giorni Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches, scritta dallo stesso
Wilamowitz e successivamente sottoscritta da 3016 firme, costituisce il vero e proprio
documento programmatico a cui si ispira il ceto accademico tedesco coinvolto in
questa mobilitazione spirituale, una fonte di argomentazioni che costituiranno, di lì a
poco i topoi dell'oratoria del'14. «La formulazione delle idee del '14 è il contributo
della filosofia tedesca alla prima guerra mondiale. Queste idee sono il documento della
sua volontà di non tacere laddove parlano le armi», H. Lübbe, Politische Philosophie in
Deutschland, München, DTV, 1974, p.171. La formula con cui la storiografia definisce
tradizionalmente questa corrente è stata presumibilmente mutuata dal titolo dello
scritto di Rudolf Kjellén Die Idee von 1914, ma Canfora esprime delle riserve in merito,
considerando che già l'anno precedente una conferenza di Troeltsch alla Deutsche
Gesellschaft recava lo stesso titolo. La traduzione italiana della Dichiarazione dei
professori dell'impero tedesco è in L. Canfora, Cultura classica e crisi tedesca. Gli scritti
politici di Wilamowitz-Moellendorf, 1914-1931, Bari, De Donato, 1977, pp. 51-52.
Un'analisi dettagliata delle modalità con cui si svolse l'attività di propaganda che
impegnò il ceto accademico durante la prima guerra mondiale è offerta dall'articolo di
R. Kramme, “Aufklärung” und “Propaganda”. Einige Bemerkungen zum öffentlichen
Engagement deutscher Soziologen während des Ersten Weltkrieg, in «Simmel Newsletter», 7, 2
(1997), pp. 82-102.
52 G. Simmel, Deutschlands innere Wandlung, cit., p. 13; (trad. it. cit., pp. 49-50).
53 La connessione tra Krieg e Kultur è assunta da Mommsen per il quale «non
solo nell'impero tedesco i ceti intellettuali considerarono fin dall'inizio la prima
guerra mondiale come una guerra che avrebbe deciso della configurazione futura
La guerra e le decisioni spirituali: un possibile progetto politico
esercita, incarnati l'uno dalla Francia e dall'Inghilterra, l'altro dalla
Germania. Di questa distanza, la nozione di libertà elaborata nei diversi
contesti spirituali è indice significativo.
Riprendendo i termini utilizzati da Troeltsch, «dai tempi antichi noi
abbiamo un'altra rappresentazione del tutto con il singolo e vediamo nei
diritti prima di tutto i doveri. La libera integrazione di sé e la devozione
in subordinazione e spontaneità allo stesso tempo sono, in relazione a
ciò, il nerbo della nostra idea di libertà»54. Sulla specificità del concetto
tedesco di libertà si gioca questo scontro tra culture, perché la guerra
decide della sopravvivenza della Germania come garante della Kultur
europea contro la minaccia della progressiva Zivilisation rappresentata da
Inghilterra e Francia; l'alternativa di fronte alla quale la situazione
assoluta del conflitto pone è tra il modello empirico, atomistico e
utilitaristico dell'Occidente europeo e la Weltanschauung idealisticoromantica della Germania.
Non è casuale, quindi, che il terzo dei saggi raccolti in Der Krieg und
die geistigen Entscheidungen ponga l'accento fin dalle prime battute sulla
specificità della natura tedesca rispetto a quella francese e inglese: «La
forma in cui il tedesco costruisce il suo ideale di vita mostra un tipo che
non sembra essere rappresentato da nessun altro popolo. L'ideale del
francese è il perfetto francese, l'ideale dell'inglese è il perfetto inglese.
L'intera storia dello spirito tedesco prova invece che l'ideale del tedesco è
il perfetto tedesco e - contemporaneamente- il suo contrario, il suo altro,
il suo completamento»55. In questa descrizione del Wesen tedesco, Simmel
precisa che esso non esprime, come ogni forma di idealismo,
semplicemente un disagio verso lo stato di cose presenti e una generica
aspirazione ad un che di ulteriore; non si tratta di un dover-essere ideale
di tipo kantiano quanto, piuttosto, il dato, assolutamente reale, per cui
ogni essenza è definita come tale dal suo opposto in cui trova
compimento; a questa configurazione del carattere tedesco Simmel
riconduce la sua distintiva mancanza di forma come principium
individuationis che struttura ogni ente in modo categorico e definitivo.
Assunto come criterio di distinzione tra le diverse nature la disponibilità
di materia spirituale non ancora cristallizzata nelle forme rigide della
della cultura europea», W. J Mommsen, Die deutschen kulturellen Eliten im Ersten Weltkrieg,
in Id., Kultur und Krieg. Die Rolle der Intellektuellen, Künstler und Schriftsteller im Ersten
Weltkrieg, cit., p. 1.
54 E. Troeltsch, Der Geist der deutschen Kultur, in Id., Deutscher Geist und Westeuropa:
gesammelte Kulturphilosophische Aufsatze und Reden, cit., ivi, p. 97.
55 G. Simmel, Die Dialektik des deutschen Geistes, in Id., Der Krieg und die geistigen
Entscheidungen, cit., ivi, p. 30; La dialettica dello spirito tedesco, in Id., Sulla guerra, cit., p. 73.
366
Logos
cultura, nel confronto tra francesi e inglesi da un lato e tedeschi dall'altro,
Simmel ha modo di verificare che, in merito ai primi, non si può parlare
di una quantità di forze in tensione non ancora liberate perché essi
«sono, in un certo qual modo, già diventati ciò che potevano diventare»56.
In questi termini il filosofo motiva la necessità per cui sia la cultura
tedesca e non altre a sperimentare con lo scoppio della guerra quel clima
di mobilitazione spirituale che chiama alla trasformazione interiore: la sua
costitutiva assenza di forma garantisce «la più alta probabilità di
realizzare tutte le sue possibilità e di liberare tutte le sue potenzialità di
sviluppo»57.
Per queste ragioni, alla guerra combattuta dalla Germania Simmel
lega la possibilità di definire un nuovo paradigma esistenziale in cui sia
ricomposta la scissione tipicamente moderna tra individuo e totalità, tra
soggetto e oggetto che l'avvento dell'economia monetaria potenzia oltre
misura58.
Entro determinati limiti, questa separazione è essenziale
all'affermazione stessa della soggettività umana, risultato di un processo
attivato da una qualità distintiva dell'individuo, la sua spiritualità, posto
che «avere uno spirito non significa altro che operare questa separazione,
considerare se stessi come oggetto, essere capaci di conoscersi»59; ma se
la scissione di quell'unità indistinta di soggetto e oggetto è operata
dall'individuo in virtù di una disposizione naturale che Simmel gli
attribuisce nei termini appena ripresi, è pur vero che «l'età moderna [...]
ha da un alto portato alla forma più profonda e radicale il concetto
dell'Io, [...] dall'altro all'autonomia e alla forza del concetto di oggetto»60.
Come abbiamo avuto modo di rilevare in precedenza rispetto ad altri
passaggi dei saggi sulla guerra, il filosofo torna a porre in connessione
con il primo conflitto mondiale la sua diagnosi della società moderna, in
una modalità che – lo vedremo a breve – è per noi determinante ai fini di
una valutazione complessiva della raccolta Der Krieg und die geistigen
Entscheidungen. Il denaro - in virtù della peculiare astrattezza conferitagli
dalla «qualità molto positiva che si indica con il concetto negativo della
Ivi, p. 32; (trad. it. cit., p. 76).
Ibid.
58 È alla luce di questa premessa che, a nostro giudizio, vanno assunte le considerazioni
espresse in proposito da Lübbe che, in merito al contributo simmeliano alla propaganda
bellica, scrive: «II suo contributo pubblicistico all'evento bellico piuttosto contiene
riflessioni filosofiche sul processo di vivificazione esistenziale che si realizza in guerra.
Simmel parte dal risultato della sua critica sociologica della moderna società europea», H.
Lübbe, Politische Philosophie in Deutschland, cit., p. 217.
59 G. Simmel, Philosophie des Geldes, cit., p.119; (trad. it. cit., p. 177).
60 Ivi, pp. 30-31; (trad. it. cit., p. 100).
56
57
La guerra e le decisioni spirituali: un possibile progetto politico
mancanza di carattere»61- opera una netta distinzione tra il nucleo della
personalità individuale e la molteplicità delle funzioni che, in ambiti
diversi, essa è chiamata a svolgere. In particolare, Simmel fa risalire alla
moderna divisione del lavoro la tendenza a dissolvere «la personalità
dietro alle rispettive funzioni, perché privilegia una sola dimensione
cancellando tutte le altre che soltanto insieme formerebbero una
personalità»62; alla cooperazione tra componenti di natura personale e
immediata, il sistema economico moderno, astratto e oggettivo,
sostituisce funzioni di carattere tecnico e impersonale che fanno
dell'individuo solo il titolare di una prestazione per cui «il fornitore, il
finanziatore, l'operaio, dai quali ognuno di noi dipende, non agiscono
come personalità, poiché entrano in rapporto con noi solo in quanto
forniscono merci, prestano denaro, compiono un lavoro»63.
La perplessità con cui Simmel guardava alla società moderna - pur
nella consapevolezza dell'alto grado di emancipazione individuale
garantito dall'economia monetaria - traspare immediatamente laddove il
filosofo rileva i rischi strutturalmente connessi alla nozione di cultura e
alla configurazione specifica che essa assume in un contesto in cui a
dominare è il denaro. Intesa come «quel perfezionamento dell'anima che
essa non raggiunge direttamente a partire da se stessa [...], ma piuttosto
prendendo la via traversa che passa per le formazioni create dalla
generale tensione storico spirituale»64, la cultura è esposta al rischio che il
denaro - mezzo per eccellenza -prolunghi infinitamente la serie delle
istanze intermedie che l'anima compie per giungere a se stessa ad un più
alto stadio di realizzazione.
La più immediata conseguenza di ciò è l'assunzione della dignità di
fini da parte di semplici mezzi65, causa di «quell'inquietudine cercante,
che deve risultare dalla riflessione sull’esser preso in una rete di nudi
Ivi, p. 273; (trad. it. cit., p. 316).
Ivi, p. 394; (trad. it. cit., p. 427).
63 Ivi, p. 393; (trad. it. cit., p. 427).
64 G. Simmel, Die Krisis der Kultur in Id., Der Krieg und die geistigen Entscheidungen, cit.,
ivi p. 37; (trad. it. La crisi della cultura, in Id., Sulla guerra, cit., pp. 83-102, ivi p. 83).
65 «Qui risiede lo straordinario pericolo interno di tutte le culture molto sviluppate,
vale a dire delle epoche in cui l'intero ambito della vita è coperto da un massimo di mezzi
costruiti l'uno sull'altro. La crescita di certi mezzi in scopi ultimi può procurare a questa
situazione una sopportabilità psicologica, in realtà la rende sempre più insensata», ivi, p. 38;
(trad. it. cit., p. 84). La questione cui il passaggio appena ripreso fa riferimento è
sviluppata in numerosi luoghi della riflessione simmeliana; si rinvia in particolare ad un
confronto il capitolo III della sezione analitica della Filosofia del denaro, cit., pp. 299-409.
61
62
368
Logos
mezzi, di vie traverse, di provvisorietà»66. L'individuo - alla descrizione
della cui fisionomia Simmel dedica gran parte della sua riflessione assume la scissione come dato che lo definisce strutturalmente come
«ente indiretto e, certamente, lo è tanto più, quanto più in alto grado egli
è civilizzato»67.
La fisionomia che la nozione moderna di libertà assume in questa
fase si configura, conseguentemente alla direzione in cui è compiuta la
correzione delle serie teleologiche, come sviluppo separato e autonomo
di qualità, forze e impulsi, ciascuno secondo la propria natura: «è libero
nella sua totalità l'uomo nel quale ogni singola energia si sviluppa e si
dispiega esclusivamente in base ai propri fini e alle proprie norme»68.
Nel dispositivo kantiano crediamo di trovare un'esemplificazione
concreta di questo modo di intendere la libertà e il soggetto individuale
che ne dispone; come abbiamo avuto modo di considerare in
precedenza, Kant sostiene che l'attributo della libertà sia proprio
esclusivamente di quella volontà che agisce determinata dalla ragione e
negli impulsi sensibili va riconosciuta la radice di ciò che allontana
l'uomo dalla pratica della sua essenza costitutiva, l'universale razionalità.
Decide quindi della natura umana ciò che, a giudizio di Simmel,
costituisce solo una delle sue componenti. Tacciando di meccanicismo
ogni dottrina che definisca l'individuo a partire da un contenuto
singolarizzabile, separato dal complesso intreccio di elementi da cui egli è
costituito, Simmel riconosce piuttosto nell'individualità umana «l'uomo
intero, non il resto che rimane quando da questo si toglie ciò che
condivide con altri»69.
«La categoria tutto/parte, che vale per l'inorganico, non è applicabile
alla vita, soprattutto alla vita individuale psichica»70; su questa
convinzione si radica la critica simmeliana al soggetto morale di Kant e,
più in generale, all'impostazione concettualistica di ogni etica
razionalistica e ad essa crediamo di poter ricondurre anche il “progetto
66 Id., Schopenhauer und Nietzsche in Id., Gesamtausgabe, Band 10, hrsg. von M. Behr,
V. Krech und G. Schmidt, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1995, ivi p. 177; Id., Nietzsche
e Schopenhauer, a cura di A. Olivieri, Firenze, Ponte delle grazie, 1995, p. 18.
67 Ivi, p. 176; (trad. it. cit., p. 17).
68 Id., Philosophie des Geldes, cit., pp. 418-419; (trad. it. cit., p. 449).
69 Id., Das individuelle Gesetz. Ein Versuch über das Prinzip der Ethik, cit., p.463; (trad.
it. cit., p. 326).
70 Id., Lebensanschauung. Vier metaphysische Kapitel in Id., Gesamtausgabe, Band 16, hrsg.
von G. Fitzi und O. Rammsted, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1999, p. 399; (trad. it.
Intuizione della vita. Quattro capitoli metafisici, a cura di G. Antinolfi, Napoli, Edizioni
scientifiche italiane, 1997, p. 171).
La guerra e le decisioni spirituali: un possibile progetto politico
politico” formulato indirettamente nelle pagine dei saggi di Der Krieg und
die geistigen Entscheidungen.
Nell'interpretazione che ne dà Simmel, lo scoppio del conflitto getta
«sul terreno e il fondamento di un assoluto» in cui la vita si ripropone
nella sua «interezza e grandiosità», libera dalle restrizioni imposte dalle
categorie logiche in cui la teorizzazione e la pratica ottocentesche
l'avevano fino ad allora costretta. Per cogliere la connessione tra la critica
simmeliana alla società moderna e le riflessioni sviluppate dal filosofo
berlinese allo scoppio del primo conflitto mondiale, per rispondere
all'interrogativo circa la possibilità che alla guerra, sintomo di una cultura
malata, sia legata anche la sua guarigione, occorre verificare quale sia il
ruolo che essa svolge nella dialettica della cultura.
Contro ogni forma di distinzione meccanicistica tra soggetto e
oggetto, tra individuale e universale71 - costitutiva della nozione di cultura
e ulteriormente potenziata dall'incidenza dell'economia monetaria -, la
guerra «sembra operare in direzione di un restringimento di quella
lacerazione da due lati»72 proprio in considerazione del suo carattere,
della sua natura, della situazione assoluta che essa definisce e in cui il
filosofo riconosce il riaffermarsi del primato della vita nella sua unità
indistinta. Il conflitto segna una svolta epocale esattamente nella misura
in cui, nella situazione straordinaria del momento, la vita si emancipa
dalle forme in cui era tradizionalmente cristallizzata e si lascia esperire
come flusso ininterrotto. Nella prospettiva simmeliana, lo stato di guerra
arresta lo sviluppo della modernità nel momento in cui ristabilisce un
rapporto organico tra individuo e totalità superando la separazione
meccanica che il denaro crea tra questi due termini73.
«Sembra appartenere al ritmo vitale dell'umanità il fatto che essa sia sottoposta a
vivere tali epoche della differenziazione in cui bisogna schierarsi e da cui poi dì nuovo
passa in un più tollerante relativismo dei suoi valori, in una più costante connessione tra
i suoi poli», Id., Die Krisis der Kultur, cit., p. 57; (trad. it. cit., p. 19).
72 Ivi, p. 40 (trad. it. cit., p. 87). Flasch, nel suo commento al saggio simmeliano,
segue alla lettera il testo del filosofo berlinese: «Wohl aber, fährt Simmel fort, bewirke der
Krieg eine Verschmälerung des Risses zwischen Seele und Sachwelt», K. Flasch, Die geistige
Mobilmachung. Die deutschen Intellektuellen und der erste Weltkrieg, Berlin, Fest, 2000, p. 335.
73 Cfr. U. Barrelmayer, Der Krieg, die Kultur und die Soziologie. Georg Simmel und die
deutschen Soziologen im Ersten Weltkrieg, cit. Nella stessa direzione va considerato il
contributo di Watier, per il quale la pubblicistica di guerra di Simmel è da leggere come
analisi della crisi dell'economia di mercato e l'avvento di relazioni comuni in luogo delle
separazioni di impianto meccanicistico caratteristiche della società moderna ad
economia monetaria: «L'individuel et le général se pénètrent a chaque point de manière
a produire une unité de la vie, la vie individuel/le est remplie par la totalité, la sensation
d'une vie nouvelle et d'un tournant historique vécu scellent l'unité sociale autour décès
deux impératifs: Krieg un Siège», P. Watier, Georg Simmel et la guerre, in W. J. Mommsen,
71
370
Logos
Per Simmel, il primo a fare esperienza di questo superamento della
tensione tra la soggettività della vita e i suoi contenuti oggettivi è il
soldato che, esposto materialmente alla costante minaccia della morte, si
eleva a simbolo della riconciliazione del conflitto che caratterizza la
cultura moderna. «L'intero congegno della cultura sprofonda dietro il
soldato, non soltanto perché egli ne deve fare a meno, ma perché il senso
e l'esigenza dell'esistenza in guerra risiedono in una prestazione, la cui
coscienza di valore non prende una via traversa oltre gli oggetti»74.
Presumibilmente il soldato è il simbolo, il modello di quella nuova
umanità a cui Simmel fa esplicito riferimento e che consente di verificare
come «nell'esperienza odierna risplend[a] da questo nuovo livello, da
questo nuovo modello di responsabilità e sacrificio anche una nuova
relazione tra individuo e totalità, la cui espressione concettuale è difficile
e piena di contraddizioni e la cui più pura evidenza è il soldato in
campo»75. L'uomo nuovo che annuncia Simmel non è da identificare con
una figura storica determinata76, è piuttosto un ideale regolativo in cui
trovano espressione tutte le aspirazioni dell'epoca presente e il disagio
maturato nei confronti di un'esistenza dominata da un orientamento
meccanicistico teso a distinguere nettamente ciò che è proprio da ciò che
è comune. D'altra parte, scrive Simmel, «l'intenzione non è diretta al
raggiungimento della compiutezza di questo o di quello; piuttosto si
compie un'epoca in cui l'uomo come intera esistenza è l'ideale di un
Kultur und Krieg. Die Rolle der Intellektuellen, Künstler und Schriftsteller im Ersten Weltkrieg, cit.,
p. 37.
74 P. Watier, Georg Simmel et la guerre, in W. J. Mommsen, Kultur und Krieg. Die Rolle der
Intellektuellen, Künstler und Schriftsteller im Ersten Weltkrieg, cit., pp.48-49.
75 G. Simmel, Deutschlands innere Wandlung, cit., p.15; (trad. it. cit., p. 52). «Da
diversi anni in Germania le correnti spirituali si indirizzano, a dire il vero, da lontano,
in modo frammentario, più o meno inconsapevole, verso l'ideale di nuova umanità», ivi
pp. 26-27; (trad. it. cit., p. 68). Crediamo significativo riprendere in questa sede una
riflessione che in realtà Simmel sviluppa nelle pagine del saggio Die Dialektik des deutschen
Geistes a provare l'ancestrale dialettica del popolo tedesco; qui la sua considerazione va
assunta in una diversa prospettiva, a definire piuttosto la situazione estrema del soldato e
con lui dell'uomo moderno: «Certamente vita e morte si limitano l'un l'altra con rigida
esclusività; eppure c'è un ultimo ed assoluto significato della vita in cui essa include anche
la morte e comprende e fonda il significato relativo di quella insieme con quello della vita
stessa», in Id., Die Dialektik des deutschen Geistes, cit., pp. 34-35; (trad. it. cit., p. 38).
76 «Questo non è un uomo singolo possibile “in concreto”- qui io non parlo di un
Messia -, ma propriamente un'idea sovra singolare, come lo era “l'uomo naturale di
Rousseau, che neppure era uno che assumeva un aspetto definito o che
immediatamente realizzava un nuovo concetto bensì uno nel quale di certo con un
grado impressionante di realtà si raccolsero tutte le possibili aspirazioni e valutazioni del
XVIII secolo», ivi, p. 27; (trad. it. cit., p. 69).
La guerra e le decisioni spirituali: un possibile progetto politico
rinnovamento»77, un obiettivo questo di cui, per il filosofo berlinese, solo
la Germania si può fare carico.
Con la stessa indeterminatezza, il testo che abbiamo fin qui
esaminato non offre ulteriori indicazioni circa il concreto funzionamento
della comunità entro la quale l'uomo è organicamente inserito; da qui la
nostra perplessità a includere le riflessioni simmeliane contenute in Der
Krieg und die geistigen Entscheidungen nel solco di una sistematica
teorizzazione del problema politico. Tuttavia, a nostro parere, dalla
raccolta di saggi emergono sufficienti elementi per intendere il concetto
di comunità a cui fa riferimento il suo autore in linea con quello
teorizzato da Tönnies, in primo luogo per l’evidente opposizione al
concetto di società.
Nell’autore di Gemeischaft und Gesellschaft le due forme di aggregazione
si strutturano diversamente a partire dalla differente tipologia di volontà
che le costituiscono: la comunità è definita da una «volontà
essenzialmente comune» che la rende una totalità organica – «durevole,
intima ed esclusiva»- al cui interno i suoi membri presentano «la
medesima origine, i medesimi sentimenti, e la stessa aspirazione
fondamentale». La società, al contrario, ha piuttosto la fisionomia di uno
strumento o di una macchina a fondamento della quale c’è «una volontà
arbitraria comune» orientata razionalmente al conseguimento di un
obiettivo esterno a sé e al cui interno i suoi membri sono «non già
essenzialmente legati, bensì separati rimanendo separati nonostante tutti i
legami, mentre là [nella comunità] rimangono legati nonostante tutte le
separazioni»78.
Nella distinzione di quelle che evidentemente sono due categorie
ideali della sociologia pura, emergono le ragioni della polemica di
Tönnies nei confronti del modello di aggregazione fornito dalla società il
cui membro è un uomo astratto, «la più artificiale, regolare e raffinata di
tutte le macchine: è costruito e inventato e deve essere considerato come
uno spettro nella fredda e chiara verità del giorno»79. Assumendo questo
elemento come sintomatico di una prospettiva che nello spazio del
nostro contributo non può analiticamente essere esaminato, accogliamo
una tradizione secondo la quale «Comunità e società può essere considerata
un testo di rilievo politico. Coincide largamente, nella storia del
pensiero,con la crisi del modo di pensare liberale, […] l’opera segue ed
esprime profondamente la crisi ideologica della borghesia europea e
Ivi, pp. 27-28.; (trad. it. cit., p. 69).
F. Tönnies, Comunità e società, Milano, Edizioni di comunità, 1979, p. 83.
79 Ivi, p. 255.
77
78
372
Logos
tedesca. E per ideologia intendo qui quel tessuto categoriale, filosofico e
dottrinario elaborato da Kant»80.
La ripresa da parte della Kriegsideologie dell’opposizione tra
Gemeinschaft e Gesellschaft - così come teorizzata da Tönnies – va, dunque,
strutturalmente connessa con la critica della modernità e del modello
politico liberale rappresentato da Kant; le considerazioni simmeliane
sulla guerra rientrano a nostro giudizio in questo orizzonte all’interno del
quale la tradizione storiografica inscrive la riflessione di autori come
Ernst Jünger, Oswald Spengler, Werner Sombart, Moeller van den
Bruck.
Sono indiscutibili e men che mai azzerabili le specificità dei percorsi
di pensiero individualmente intrapresi dalle voci citate; d’altra parte
costoro furono testimoni di eventi – in primis l’esperienza della
Repubblica di Weimar – che per ragioni meramente cronologiche
Simmel non visse. Al di là delle differenze, congiunturali ed essenziali –
legate, cioè, ai diversi dispositivi interpretativi alla luce dei quali la realtà
viene letta e interpretata- l’elemento che per noi assume un rilievo
assoluto e alla luce del quale la riflessione simmeliana sulla guerra è
inscrivibile nella tradizione alla quale pure appartengono tra gli altri
Jünger, Spengler, Sombart, è la connessione da costoro stabilita tra
esaltazione della guerra e diagnosi della crisi della modernità81.
Quale modernità? Per questi autori, a cui noi associamo il nome di
Georg Simmel per la serie di argomentazioni sviluppate nello spazio di
questo contributo, la modernità coincide con il modello teorico elaborato
da Kant: modernità è il mito della sicurezza borghese, di un ordine
astratto che la situazione assoluta della guerra mette a nudo in tutta la sua
artificiosità; è ancora l’ideale kantiano della pace perpetua fondato su un
modello di organizzazione statuale che risente della stessa astrattezza che
caratterizza la nozione settecentesca di individuo; modernità è il primato
80 N. Pirillo, Comunità e società: una dicotomia del moderno, in «Annali di sociologia», 4,
II (1988), pp. 189-221, ivi pp.189-190.
81 La connessione a cui qui si fa riferimento è la trama che mette in relazione la
posizione degli autori citati, tra gli altri, nei testi di J. Herf, Il modernismo reazionario:
tecnologia, cultura e politica nella Germania di Weimar e nel terzo Reich, trad. it. e cura di M.
Cupellaro, Bologna, 1988 e D. Losurdo, La comunità, la morte, l’occidente. Heidegger e
l’ideologia della guerra, Torino, Bollati Boringhieri, 1991. In merito al primo contributo, va
rilevata la specificità della categoria storiografica di “modernismo reazionario”, coniata
da Herf a definire quel particolare orientamento di parte della destra tedesca
caratterizzato dalla tendenza a svincolare il concetto di progresso tecnologico dal suo
retroterra illuministico, per trasferirlo dal suo originario “luogo naturale”- la Zivilisation nel cuore stesso della Kultur tedesca. L’obiettivo di quella che Thomas Mann definisce la
“compenetrazione tra interiorità tedesca e moderna tecnologia” era di fare dei frutti del
progresso tecnologico strumenti al servizio dell’affermazione della Volksgemeinschaft.
La guerra e le decisioni spirituali: un possibile progetto politico
della logica del concetto sulla dinamica interna della vita, da riaffermare
in nome del fatto che «l'essere vivente non è mai sottoposto alla signoria
del concetto quanto l'essere inorganico [....]. Gli esseri organici hanno
piuttosto un'unità oggettiva immanente a loro stessi e trovano la loro
limitazione costitutiva in virtù della propria entelecheia»82 .
82 G. Simmel, Lebensanschauung. Vier metaphysische Kapitel, cit., p. 364; (trad. it. cit., p.
139). A descrivere gli orientamenti della filosofia in riferimento al clima spirituale in cui
opera anche Simmel rinviamo a Piovani: «Il concetto stesso cessa di essere l'organo della
riduzione all'essere della purificata, accidentata realtà esistenziale, ritorno del decaduto
multiforme alla pura unicità della forma logica ed ontologica onnicomprendente. Il concetto,
quando sia meglio approfondito e compreso, non è più il protagonista della filosofia. [....]. Il
concetto non è più lo strumento caratteristico della riduzione della praticità dei
fenomeni alla teoreticità dei pensieri unificati nell'unità sovrastante del logos», P. Piovani,
Princìpi di una filosofia della morale, Napoli, Morano, 1972, pp. 214-215.
374
Logos
Stefania Vacca
La teologia dialettica tra fede e esistenza nel
pensiero di Karl Barth
Nell’intero programma teologico, nonché esistenziale di Karl Barth,
“ricominciare da Dio”, significa ricostruire dialetticamente i termini della
relazione Dio-uomo. Secondo Barth, la fede e l’esistenza sono state
sinora valutate dal punto di vista dell’uomo su Dio e non di Dio
sull’uomo: l’errore non contempla l’”infinita differenza qualitativa” delle
parti, che è all’origine tanto dell’irriducibilità dell’uno all’altra, quanto
dell’orizzonte entro cui è possibile pensarla nel mondo.
L’appello linguistico alla “differenza”, evocazione di ascendenza
kierkegaardiana, nell’Epistola ai Romani1 del 1921, definisce
paradossalmente la “misura” mediante la quale l’uomo investe di
responsabilità se stesso, nel proprio tempo2, incorrendo nella “distretta”,
che la fede impone e presuppone nella scelta.
La principale preoccupazione di Barth, relativa all’umanizzazione del
divino, è di arginare l’errore sinora commesso piuttosto che riflettere
sulla possibilità dell’uomo di presumere se stesso da Dio, perché
impossibile3. La distanza qualitativa tra Dio e l’uomo è rivelata
storicamente in Cristo, ma è nell’ a-priori della Grazia che emerge il
significato del legame di Dio con l’uomo:
1 «Essere cristiani per Paolo significa essere stati crocefissi con Cristo, essere
battezzati non da un’acqua qualsiasi, ma nella sua stessa morte. Lutero, nel suo grande
commento a Romani, diceva: qui Paolo parla della morte eterna, buona e ottima, la
morte della morte, poiché soltanto morendo con la crocifissione, essendo stati
crocefissi con Cristo, lì, in quella figura, muore la morte, e quindi è morte buona e
ottima (questa espressione la “morte della morte”, negazione della negazione, sta
all’origine di tutte le dialettiche filosofiche idealiste)», M. Cacciari, Il nomos dell’amore,
in La legge sovrana, a cura di I. Dionigi, Milano, BUR, 2006, pp. 79-86, ivi p. 81.
2 Secondo Barth, è il presente a stabilire l’importanza degli eventi passati: l’attimo
in cui Cristo si rivela, come fenomeno sovra-storico, è il “qui e ora” dell’uomo, affinché
la speranza nella redenzione si ripeta nella fede e divenga “crisi” nell’esistenza.
3 «Un uomo avrebbe potuto immaginare benissimo, nella poesia di farsi uguale a
Dio o Dio uguale a se stesso, ma non immaginare che Dio si immaginasse uguale
all’uomo; perché se Dio non ne desse alcun segno, come potrebbe l’uomo immaginare
che Dio Benedetto può aver bisogno di lui?», S. Kierkegaard, Briciole filosofiche, trad. it di
a cura di S. Spera, Brescia, Queriniana, 1987, p. 91.
La teologia dialettica tra fede e esistenza nel pensiero di Karl Barth
«All’inizio, prima ancora che esistessero il tempo e lo spazio che noi
conosciamo, prima della creazione, prima che nessuna realtà differente da
Dio abbia potuto essere l’oggetto del suo amore e fungere da cornice agli
atti della sua libertà, Dio (nella forza del suo amore e della sua libertà, del
suo sapere e del suo volere) ha premeditato e fissato il fine ed il senso di
tutta al sua opera nel mondo ancora inesistente, decidendo di fare grazia
all’uomo nel figlio suo e di legarsi così alla sua creatura»4 .
L’attenzione di Barth verte sul punto di vista di Dio, affinché la
relazione5 vincoli l’uomo alle determinazioni del peccato e della colpa, lo
restituisca all’intervento della Grazia, all’Eterno che s’innesta nel tempo.
La radicale problematicità dell’uomo appartiene a Dio, in Lui risiede
l’oggettività della crisi e l’eternità della salvezza. Il SÌ e il NO sono
“ugualmente necessari” e, nell’implicazione6, divini: la stretta dipendenza
tra i due prevede che il NO muti sempre in SÌ e il SÌ in NO, se così non
fosse, si annullerebbe il significato del movimento che a-priori li concilia.
Il Dio del punto di vista umano è un non-Dio, un idolo, perché il Dio
della logica umana, del pensiero lineare, è un Dio-dato e non la
“presupposizione di tutti i dati”, di conseguenza, la linearità del nostro
pensiero su Dio, deve essere radicalmente rovesciato da Dio. Ma la
filosofia ha preteso di utilizzare un metodo di conoscenza per Colui che
è “il fondamento della conoscenza”, e la teologia liberale, di matrice
schleiermacheriana, si è avvalsa della fede come argomento di
conoscenza profonda dell’uomo e di Dio. Se la ragione volesse
dimostrare l’inesistenza di Dio, sarebbe una follia dimostrarla, perché
nessuna cosa può essere dimostrata come esistente se non nella
descrizione delle sue caratteristiche e, tra esse e l’oggetto in questione,
non v’è rapporto di reciprocità alcuna
La fede è sì il presupposto indiscutibile dell’intelligere teologico, ma
non richiede una comprensione dell’esistenza di Dio, bensì cerca l’intima
ragione dell’operare di Dio nel mondo, si occupa del come la
proposizione “Dio esiste” sia vera: «Non c’è mai conoscenza “pura “ di
4 K. Barth, Gottes Gnadenwahl, in Deus-Trinitas: il Dio possibile, in V. Vitello, E pose la
tenda in mezzo a noi…, a cura di V. Vitello, Milano, Albo Versorio, 2007, pp. 49-56, ivi p.
51.
5 In riferimento al concetto di relazione, Barth rifiuta in modo drastico
l’introduzione in ambito teologico dell’ “analogia entis”, perché «ha soprannaturalizzato
Dio fino a renderlo un ganz anderes che solo la fede attinge, essa pure detta in tout autre
dalle vicende umane, per ogni verso incommensurabile», I. Mancini, I filosofi esistenzialisti,
Urbino, Aralia, 1964, p. 84.
6 «Quel concetto fondamentale barthiano che chiamiamo implicanza, e che
consiste, nella necessaria connessione di negativo e positivo per cui fatalmente dall’uno
si passa all’altro», L. Pareyson, Studi sull’esistenzialismo, Firenze, Sansoni, 1943, p. 175.
376
Logos
Dio che non sia attraverso il negativo. L’ontico è di fatto soltanto
positivo, il noetico invece è del tutto dialettico. Dialettico qui significa:
intensamente contraddittorio, ma proprio per questo anche produttivo di
storia»7. Cristo è difatti il “luogo di rottura” tra ciò che l’uomo conosce
nel mondo e l’Altro dal mondo. Quello a noi sconosciuto è il totalmente
Altro, il positivo, l’origine, il mondo sovra-storico che non possiamo
intuire8.
La rivelazione è un evento storico solo nel suo significato sovrastorico, se così non fosse allora parleremmo di un uomo e non del Figlio
di Dio, del tempo e non dell’Eternità, ma la storicità dell’evento
restituisce alla riflessione sulla fede il dinamismo dell’esistenza, la
“tensione” della scelta.
Noi viviamo in questo mondo storico costantemente irradiato dalla
“luce dall’alto”, cioè dal non-storico che conferisce al tempo la sua utilità.
Nel “timore e nel tremore” per quel niente che si prospetta nell’esistenza
senza Dio, vi riponiamo la nostra fede, affinché Dio “faccia pace” con
noi. L’uomo che si predispone a questa pace crede nella Totale Alterità di
Dio e sussume la sua esistenza a quest’unica certezza. La fede stessa non
ha alcunché di umano, è “fedeltà di Dio”, non ha argomenti umani su cui
fondare la propria realtà, è insondabile, un “salto nel vuoto”, l’Aut-Aut di
Kierkegaard.
Di qui il ricorso al paradosso9 la cui necessità teologica perviene alla
ragione dialettica per tre motivi: a) perché le opposizioni dialettiche non
danno vita ad argomentazioni azzardate sulla differenza esistente tra Dio
e l’uomo, b) perché le opposizioni dialettiche non usano impropriamente
K. Barth, L’umanità di Dio, trad. it. di S. Merlo e cura di S. Rostagno, Torino,
Claudiana, 1997, p. 60.
8 «La suprema oggettività di Dio avvolge la soggettività pensante che lo cerca, e si
comunica nelle parole della rivelazione, che proibiscono alla creatura di pronunciarne il
nome per catturarlo o farne oggetto di giochi mentali: il Dio trascendente viene
nell’immanenza del pensiero che sia aperto e interrogante, capace di un ascolto libero
da pregiudizi e di una decisione priva di condizionamenti», B. Forte, La sfida di Dio, dove
fede e ragione si incontrano, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2001, p. 113.
9 «Anche per il Kierkegaard il Cristo è paradosso, è, anzi, l’assoluto paradosso. E’
manifestazione di Dio nell’uomo, rivelazione dell’infinito nel finito, discesa dell’eterno
nel temporale. Di questa “folle” paradossalità del Cristo l’uomo si scandalizza. Ma il suo
è lo scandalo della ragione offesa dall’irrazionalità del paradosso. Tuttavia o lo scandalo
o la fede: anche qui si presenta l’opposizione antinomia, indefinitamente reperibile nel
reale esasperatamente discontinuo. Ma vi è, in quest’alternativa, la possibilità di una
scelta? La risposta non è meno paradossale, non meno scandalosa: v’è e non v’è, perché
la fede è scelta nostra, e pure dono divino», L. Pareyson, Studi sull’esistenzialismo, cit., p.
136.
7
La teologia dialettica tra fede e esistenza nel pensiero di Karl Barth
della parola “Dio”, c) perché le opposizioni dialettiche non appiattiscono
la relazione tra Dio e l’uomo, tra cielo e terra:
«Ma questo pensare paradossale si rivela d’altra parte ragionevole, se la
ragione, fattasi umile nell’avvertimento dei suoi limiti, non pretende
commisurare a sé l’esistenza e la storia, ma commisura sé con la novità della
storia come sorpresa dell’iniziativa di Dio e con la novità dell’esistenza
come decisione della libertà»10.
La teologia dialettica non ha la pretesa idealistica11 di conquistare il
cielo, muovendo dal basso, anzi la forza vitale di questo movimento
giunge dall’alto, vuole essere una “teologia assoluta”, del “paradosso”, «la
via di Dio che mena all’uomo non è un movimento autonomo, ternario,
ma eteronomo quaternario»12, e l’a priori divino fa il gioco senza entrare
in gioco.
Se il segno “–” dinanzi all’esistenza umana fosse semplice
rassegnazione allora la contraddizione non sarebbe speranza, attesa e,
infine, gioia. Il SÌ della promessa contiene e contraddice il NO del
peccato, il SÌ è la fede dell’ uomo “nuovo”, rappresentato dalla figura di
Cristo, annienta la presunta perfettibilità dell’uomo vecchio. Per Barth, il
rovesciamento dialettico del NO nel SÌ è un’espressione algebrica: - (-a b -c -d) il segno “–” dinanzi alla parentesi, modifica i segni all’interno
positivamente, «Il meno divino dinanzi alla parentesi è appunto un
giudizio annientante su tutte le consapevolezze umane»13 .
Nell’opposizione dialettica non comprendiamo Dio (il movimento è
generato e risolto in Dio), bensì comprendiamo noi stessi partendo da
Dio. La rivelazione di Cristo, come unità di uomo e Dio, diviene per
l’uomo identità, l’esserci diviene essere-con-Dio:
10 K. Barth, Prefazione alla seconda edizione dell’Epistola ai Romani (1921), in Id., Le
origini della teologia dialettica, a cura di J. Moltmann, trad. it. di M. C. Laurenzi, Brescia,
Queriniana, 1977, p. 145.
11 «L’Iddio vivente di Hegel, egli ha visto bene e visto meglio di molti teologi come
Dio sia vivente, è l’uomo vivente, e in quanto quest’uomo vivente potrebbe ora essere
soltanto l’uomo pensante, questo astratto uomo pensante soltanto un uomo pensato e
per nulla l’uomo reale, potrebbe darsi che anche questo Dio vivente, l’Iddio vivente sia
soltanto un Iddio pensante e soltanto un iddio pensato, che l’uomo reale stia dinanzi a
lui come dinanzi a un idolo, a un idolo, a un niente che stia in ogni caso in una
sconfinata solitudine», K. Barth, Filosofia e rivelazione, trad. it. di V. Vinay, Milano, Silva,
1965, pp. 426-428).
12 I. Mancini, Un itinerario che non deve morire, in Parola di Dio e Parola umana, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 1999, p. 30
13 K. Barth, L’Epistola ai Romani, cit., pp. 463-464.
378
Logos
«Ma questo processo di autoidentificazione (con l’uomo nuovo) che è
autodifferenziazione (con l’uomo vecchio), non è possibile se non con
l’infinita predicazione “io credo”. Entriamo così nel campo della fede. E la
fede è morire con il Cristo e risorgere con lui. Quindi il senso dei legami
dialettici che costituiscono l’esistenza è il miracolo della fede, e di quello che
è il paradosso assoluto: il Cristo»14.
L’uomo che accetta il NO di Dio è l’uomo destinato al SÌ della
Grazia, perché l’Amore di Dio15 è la realtà infinita e impossibile
dell’unica esistenza possibile e finita.
La relazione che emerge dalla comunicazione16 autentica tra sé e
l’altro è suggellata, nella rivelazione, nell’esistenza, dall’Amore per il
totalmente Altro. E’ l’Amore che ha originato il mondo, la Parola rivelata
e l’azione responsabile dinanzi a Dio. L’Amore, qui menzionato, relativo
all’ultima parte dell’Epistola ai Romani, trae spunto dall’immagine
kierkegaardiana dell’amante che nell’amore trasforma “radicalmente” se
stesso, anche e soprattutto nella sofferenza che questo amore porta con
sé, nel paradosso di libertà e necessità, dell’ amore esistenziale che
riconosce tanto l’aspetto della comunicazione quanto quello della
solitudine17. L’uomo “nuovo” vuole non-essere per essere nella fede,
L. Pareyson, op. cit., p. 130.
«La moralità elimina la signoria nelle sfere di ciò che è giunto a coscienza;
l’amore elimina i confini delle sfere della moralità. Ma l’amore stesso è ancora natura
incompleta: nei momenti di amore felice non vi è spazio per l’oggettività; ma ogni
riflessione che toglie l’amore, ristabilisce l’oggettività e con questo ricomincia l’ambito
delle limitazione. L’intuizione dell’amore sembra soddisfare la richiesta di compiutezza,
ma vi è una contraddizione: intuire o rappresentare è limitare e ricevere solo ciò che è
delimitato, mentre qui l’oggetto sarebbe un infinito; l’infinito non può essere riportato
in un recipiente», G. W. F. Hegel, Lo spirito del Cristianesimo e il suo destino, trad. it. di E.
Mirri, L’Aquila, Japadre, 1970, p. 116.
16 Cristo secondo Jaspers non è il termine medio tra esserci e esistenza, perché la
rivelazione racchiude in sé due interpretazioni: la prima assume il significato di
annuncio, di salvezza, nella gratuità dell’Amore autentico, la seconda circoscrive
l’evento all’ambito dell’autorevolezza e della necessità. Alle due interpretazioni, il
filosofo ne aggiunge una terza, relativa alla comunicazione: non esistono verità assolute,
bensì la libertà dell’interpretazione, intrinseca nel significato stesso delle Scritture. Se
l’uomo riconoscesse unicamente il secondo significato allora la possibilità della salvezza
diverrebbe mero punto fermo cui aggrapparsi dinanzi all’angoscia del nulla e non la
verità rinnovata nella libertà dell’esistenza.
17 «Per Jaspers, solitudine e comunicazione sono termini correlativi. La solitudine
intende salvaguardare la disposizione all’esistenza possibile, alla libertà, non lasciandosi
coinvolgere nelle comunicazioni oggettive, dove va smarrita la singolarità dell’esistenza.
E’certamente una situazione paradossale», G. Cantillo, Introduzione a Jaspers, Roma-Bari,
Laterza, 2002, p. 75.
14
15
La teologia dialettica tra fede e esistenza nel pensiero di Karl Barth
esistere nell’impossibilità divina e nella prigionia dell’inquietudine
riconoscere la ragione della propria libertà.
Il soggetto esiste nell’amore per l’altro come aspirazione all’amore di
Dio. L’amore per Barth è il termine medio nell’incontro con l’altro, ma si
misura in termini di obbedienza e non di libertà: «Esso vede in ogni
“prossimo” soltanto la similitudine di colui che si deve amare, ma la vede
veramente, e vede in ogni prossimo colui che si deve amare, ma la vede
veramente, e vede in ogni prossimo colui che si deve amare; esso vede e
ode in ogni tu temporale il Tu eterno che gli sta di fronte, e senza il quale
non esiste alcun io».18
Chi segue la via dell’amore segue la via della possibilità della fede in
Dio, la “via inconcepibile”di chi ama l’altro, è l’unica possibile all’uomo
per sondare la sua problematicità.
La nascita della cosiddetta “teologia della crisi”, dell’esistenzialismo
teologico, conferisce dunque all’esistenza umana un significato pratico,
piuttosto che teoretico: «Il mondo come è, nel quale vogliamo volere e
operare, ci ha offerto l’occasione di riflettere a quello che è, cioè al modo
in cui viviamo in esso, a quello che dobbiamo fare in esso»19.
L’incontro con l’altro espone l’io all’esistenza e alla scoperta del
“Tu” invisibile, ricorda l’Amore di Dio compiuto in questo “tu” che ci
sta dinanzi. L’amore per il prossimo è l’amore che vive nella
“similitudine” di quell’ Altro amore che in Cristo ha spezzato l’invisibilità
e l’idealità che lo caratterizza, per la visibilità e la temporalità, dell’amore
per l’altro. Nell’amore di Dio, l’uomo fonda la propria personalità perché
è stato toccato dal Dio “sconosciuto” nella piena libertà che l’amore
istituisce in questa relazione, la sua individuazione nel mondo è lo “staredavanti-a-Dio”.
L’amore è un evento enigmatico, non è un atto del pensiero bensì
una “presupposizione psicologica”, che dall’alto effonde in noi
l’atteggiamento conforme alla realizzazione di questo sentimento. «Amar
Dio vuol dire eseguir volentieri i suoi comandamenti; amare il prossimo
vuol dire metter in pratica volentieri tutti i doveri verso di esso”; eppure,
il comandamento contiene in sé una contraddizione: può mai un dovere
essere svolto volentieri? Dunque, le leggi auree: “Ama Dio sopra ogni
cosa” e “ama il prossimo tuo come te stesso”, come tutti i precetti morali
racchiusi nel Vangelo, rappresentano l’intenzione morale nella sua intera
perfezione come un ideale di santità non raggiungibile da nessuna
18
19
K. Barth, L’Epistola ai Romani, cit., p. 476.
Ivi, p. 410.
380
Logos
creatura, e che tuttavia è l’esemplare a cui dobbiamo procurare di
avvicinarci e diventare pari in un progresso ininterrotto, ma infinito»20.
Nell’ “estremo” NO abbiamo conosciuto l’”estremo” SÌ, cioè
l’amore che vuole se stesso in Dio e l’incontro con l’altro mediante
l’Alterità. L’ “uomo nuovo” agisce nel dovere dell’amore che lo ha reso
tale, nella risurrezione alla vita di Cristo, sopprime l’in-azione del
peccato, scorgendo nel “ Tu devi!” , nel suo operato l’Eternità. «Poiché
l’amore di Dio in Gesù Cristo è l’unità dell’amore di Dio verso l’uomo e
dell’amore dell’uomo verso Dio. In esso trionfa il nostro amore»21. L’
amore spinge l’uomo verso Dio, verso il bene cui si attua l’ azione
“nuova”, che non contraddice la negazione dell’ordine esistente, bensì
desta il SÌ della fede.
Se la teologia dialettica, muovendo dal pensiero che Dio non si
esaurisce sul piano oggettivo, teoretico, allora la venuta di Cristo
stabilisce quei valori che nell’esistenza definiscono l’ordine sul piano
pratico, etico: «Il problema dell’etica ci ricorda appunto che non è l’atto
di pensiero come tale, ma il suo invisibile principio, la sua
presupposizione, che è giustificata nella sua estraneità dal mondo, per il
fatto che appunto in tal modo esso rende ragione della pienezza del
concreto»22.
E’ la “teoria della prassi” e non la “prassi accanto alla teoria”, perché
i suoi presupposti sono la grazia, la risurrezione, la fede.
L’aspetto intimistico della fede come scelta soggettiva, suggerito da
Kierkegaard, quale appropriazione di sé come esistenza e non più come
essenza, è per Barth una modalità d’interazione nella vita pratica
stimolata dalla contemporaneità del messaggio Cristo, come incontro con
l’altro per la condivisione del totalmente Altro, della Parola. L’uomo
riconosce che il problema dell’etica è la domanda necessaria per risalire
all’origine dell’unico vero oggetto dal quale essa muove: Dio. È l’evento
della rivelazione a determinare il modello eccellente per le norme etiche,
in virtù di quella corrispondenza originaria tra Dio e l’uomo, della
volontà divina incarnata in Cristo, che diviene contenuto per
antonomasia dell’agire pratico23 nell’esistenza.
20
p. 183.
I. Kant, Critica della ragion pratica, trad. it. di F. Capra, Roma-Bari, Laterza, 2006,
K. Barth, L’Epistola ai Romani, cit., p. 311.
Ivi, p. 409.
23 «Tutto il nostro atteggiamento pratico deve essere unicamente sottomesso alle
disposizioni della legge divina; soltanto Dio possiede il potere di trarre il bene dal male
e di agire, sempre nell’Amore, secondo il proprio volere: “Rebecca ebbe figli da un solo
uomo, Isacco nostro padre: quando essi ancora non erano nati e nulla avevano fatto di
bene o di male- perché rimanesse fermo il disegno divino fondato sull’elezione non in
21
22
La teologia dialettica tra fede e esistenza nel pensiero di Karl Barth
base alle opere, ma alla volontà di colui che chiama- le fu dichiarato: il maggiore sarà
sottomesso al minore” (Rm 9, 10-12).Conoscendo tutto da prima, Dio elabora come
vuole il suo Disegno di salvezza senza mai ledere la nostra libertà», C. A. Bernard, San
Paolo mistico e apostolo, Milano, Edizioni San Paolo, 2000, p. 23.
Maurizio Filippo Di Silva
Heidegger: Agostino e l’ellenizzazione della
coscienza cristiana
Obiettivo del presente saggio è delineare il senso delle indagini
heideggeriane relative al X libro delle Confessioni. Heidegger dedicò ad
esso le analisi di un corso friburghese del 1921. Al fine di cogliere
preliminarmente la direzione dell’indagine heideggeriana è essenziale
considerare il titolo del corso in questione: Agostino e il neoplatonismo.
Centro dell’analisi heideggeriana si rivela essere il nesso tra il pensiero
agostiniano e i concetti fondamentali della filosofia neoplatonica. Senso
di tale relazione è il celarsi dell’esperienza effettiva della vita sotto il
segno del theorein. E’ nell’ottica della minaccia del teoretico per la scienza
originaria che emerge il «proprio» dell’indagine in questione, è in tale
prospettiva che è posta la relazione tra grecità e cristianesimo. L’indagine
considerata viene dunque a situarsi nell’orizzonte delle direzioni
essenziali della riflessione filosofica heideggeriana degli anni di
insegnamento friburghesi 1919-1923. Essa ha in sé i segni del progetto
filosofico del periodo indicato: accedere alla vita nella sua purezza. E’
nella triplice direzione dell’analisi che ciò diviene manifesto. Il confronto
tra fenomenologia e scienza critica della storia, l’interpretazione
fenomenologica del X libro delle Confessioni e l’analisi heideggeriana
dell’ellenizzazione della coscienza cristiana trovano nel vivere il loro
orizzonte di senso. E’ alla forza dell’esistere di cui c’è traccia nelle
Confessioni che essi guardano: «Per il Suo compleanno Le invio gli auguri
più cari. Penso che le Confessioni si addicano al meglio a questo giorno, e
Le auguro di ricevere da questo grande libro un ricco e durevole profitto;
la forza dell’esistere che promana da esso è in effetti inesauribile»1. Nel
passo della lettera inviata da Heidegger a Elisabeth Blochmann il 12
aprile del 1933 c’è dunque l’indice decisivo per la presente indagine.
Sono le vestigia del sapere effettivo e del suo celarsi che l’analisi cerca, è
nel nesso tra la lotta alle tentazioni e la fruitio Dei che essa vive. Emergerà
in ciò il senso heideggeriano della grecizzazione della coscienza cristiana
della vita. Le successive indagini si articoleranno in tre momenti:
Fenomenologia e scienza critica della storia - Agostino e il
M. Heidegger – E. Blochmann, Carteggio 1918-1969 (1989), trad. it. R. Brusotti,
Genova, Il melangolo, 1991, p. 104.
1
Heidegger: Agostino e l’ellenizzazione della coscienza cristiana
neoplatonismo - Ellenizzazione della coscienza cristiana. Accederemo
così al senso dell’analisi heideggeriana immergendoci nelle sue
dimensioni essenziali.
1. Fenomenologia e scienza critica della storia.
I primi passi dell’interpretazione heideggeriana delle pagine del X
libro delle Confessioni sono dedicati alla determinazione del senso del
progetto filosofico qui considerato. Heidegger specifica la natura della
propria analisi procedendo per via negativa. E’ nel confronto con le
indagini della scienza critica della storia che ha luogo tale determinazione:
«Nel diciannovesimo secolo, con il destarsi della scienza critica della
storia, cioè con lo sviluppo sia di un’autentica storia delle Chiese e dei
dogmi, sia di una storia cristiana della filosofia e della letteratura, Agostino
ha goduto di una nuova considerazione in questo senso. Tracceremo qui un
breve profilo delle tre concezioni e valutazioni più notevoli tratte dalla
ricerca degli ultimi decenni, rispetto alle quali il percorso che noi
svilupperemo si distingue e si delimita in modo essenziale» 2.
M. Heidegger, Agostino e il neoplatonismo (semestre estivo 1921), in Fenomenologia della vita
religiosa [1995], trad. it. G. Gurisatti, Milano, Adelphi, 2003, p. 210. Sul confronto
heideggeriano con Agostino si veda: G. Di Muccio, Heidegger, Agostino, l’antropologia, in
«Annali dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici», 16 (1999), pp. 541-670; C. Esposito,
Martin Heidegger. La memoria e il tempo, in AA. VV., Agostino nella filosofia del Novecento, a
cura di L. Alici, R. Piccolomini, A. Pieretti, Roma, Città Nuova, 2000, vol. I, pp. 87-124;
Id., Quaestio mihi factus sum. Heidegger di fronte ad Agostino, in AA. VV., Ripensare Agostino:
interiorità e intenzionalità, a cura di L. Alici, R. Piccolomini, A. Pieretti, Roma, Institutum
Patristicum Augustinianum, 1993, pp. 229-259; Id., L’essere, la storia e la grazia in
Heidegger, in AA. VV., Nichilismo e redenzione, a cura di R. Bruno, F. Pellecchia, Milano,
Franco Angeli, 2003, pp. 184-207; AA. VV., Heidegger e i medievali, a cura di C. Esposito,
P. Porro, numero speciale di «Quaestio. Annuario di storia della metafisica», 1 (2001);
A. Fabris, L’«ermeneutica della fatticità» nei corsi friburghesi dal 1919 al 1923, in AA. VV.,
Guida a Heidegger, a cura di F. Volpi, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 59-111; D. Fedoryka,
Authenticity: The Dialectic of Self-Possesion. Reflections on a Theme in St. Augustine, Heidegger and
Von Hildebrand, in «Aletheia», 5 (1992), pp. 215-235; F. von Hermann, Die «Confessiones»
des Heiligen Augustinus im Denken Heideggers, in AA. VV., Heidegger e i medievali, cit., pp.
113-146; T. Kisiel, Heidegger Reads Augustine on Fear and Trembling, in «The University of
Dayton Review», 3 (1994), pp. 295-304; E. Mazzarella, Ermeneutica dell’effettività.
Prospettive ontiche dell’ontologia heideggeriana, Napoli, Guida, 1993; V. Pinto, Storicità ed
effettività dell’io ed esperienza cristiana originaria della vita: Paolo e Agostino nei corsi di Heidegger
del 1920-1921, in «Atti dell’Accademia di scienze morali e politiche», 17 (1987), pp. 165193; L. Savarino, Heidegger e il cristianesimo. 1916-1927, Napoli, Liguori, 2001; Id., Filosofia
e temporalità. Heidegger e il cristianesimo prima di Essere e tempo, in AA. VV., Heidegger e la
fenomenologia dell’esistenza, a cura di M. Gardini, Macerata, Quodlibet, 2000, pp. 39-73; R.
2
384
Logos
E’ attraverso un’attenta considerazione delle indagini di Troeltsch,
Harnack e Dilthey che emerge il «proprio» della riflessione heideggeriana
in analisi.
Heidegger considera, in primis, l’interpretazione troeltschana di
Agostino. Essa emerge nel celebre scritto Augustin, die christliche Antike
und das Mittelalter. Im Anschluß an die Schrift «De Civitate Dei». E’ in un
orizzonte di filosofia della civiltà che si situa l’analisi di Troeltsch. La
figura di Agostino è in essa considerata all’interno dell’orizzonte
temporale della storia universale. Troeltsch coglie in Agostino il grande
maestro di etica dell’antichità cristiana: «Per Troeltsch l’autentico
significato di Agostino consiste nel fatto che, con la sua etica del summum
bonum, egli è diventato il grande maestro di etica dell’antichità cristiana»3.
Di segno diverso si rivela essere l’analisi di Harnack. Agostino è in essa
considerato all’interno del percorso temporale della storia dei dogmi.
Nella stessa l’Ipponate assume un duplice rilievo. Egli, per un verso, è
colui che ha ridonato vita all’intero sistema dogmatico, per un altro, con
la dottrina del peccato e della grazia, ha rappresentato un’innovazione nel
contesto della storia dei dogmi:
«Nell’ambito della problematica della storia dei dogmi così concepita il
tratto peculiare di Agostino, secondo Harnack, non sembra essere tanto la
costruzione di un nuovo sistema dogmatico, bensì, da un lato, la
restituzione di quello antico a nuova vita in base all’esperienza e alla
devozione personali, dall’altro, in stretto rapporto con ciò, la fusione al suo
interno del nuovo pensiero fondamentale della dottrina del peccato e della
grazia»4.
Di assoluto rilievo si rivela essere l’interpretazione diltheyana di
Agostino. Essa emerge all’interno del tentativo di delineare il ruolo avuto
dal cristianesimo nella fondazione delle scienze dello spirito. Più
precisamente l’interpretazione di Dilthey mira a determinare il ruolo del
cristianesimo grecizzato in tale dinamica. In tale prospettiva Agostino
appare, inscindibilmente, momento essenziale nella nascita delle
Geisteswissenschaften ed esempio della grecizzazione della coscienza
cristiana. E’ nella fondazione agostiniana della realtà interiore che emerge
il convergere di grecità e cristianesimo:
J. Severson, Time, Death, and Eternity: Reflecting on Augustine’s «Confessions» in Light of
Heidegger’s «Being and Time», Lanham, Scarecrow Press, 1995; D. Vicari, Ontologia
dell’esserci. La riproposizione della «questione dell’uomo» nello Heidegger del primo periodo friburghese
(1916-1923), Torino, Zamorani, 1996.
3 Ivi, p. 211.
4 Ivi, p. 213.
Heidegger: Agostino e l’ellenizzazione della coscienza cristiana
«Dilthey approfondisce ulteriormente tale aspetto mostrando come
sotto l’influsso della scienza antica il cristianesimo si trasformi in dottrina e
in filosofia. Qual è l’importanza di Agostino in questo processo? In
contrasto con l’antico scetticismo egli stabilì la realtà assoluta dell’esperienza
interiore (in una forma che anticipa il “cogito, ergo sum” di Descartes).
Subito però avviene la svolta verso la metafisica: le veritates aeternae sono le
idee contenute nella coscienza assoluta di Dio» 5.
Come evidente, le tre celebri interpretazioni di Agostino offrono una
triplice immagine dell’Ipponate. Nonostante le differenze emerse, esse
sono d’altronde strettamente legate nell’impostazione metodologica,
cuore della stessa è l’atteggiamento teoretico-oggettivante. Nel theorein la
vita è rap-presentata e constatata. Essa diviene così oggetto: «Per quanto
eterogenee possano essere nelle tre interpretazioni le direzioni dell’accesso
al loro oggetto, in quanto domina sempre una diversa determinatezza
complessiva del contenuto del “che cosa” della sua “prestazione” - etica,
religiosità, fondazione gnoseologica -, il senso dell’accesso è lo stesso.
L’oggetto (Agostino) è visto sotto diversi riguardi (si guarda a esso
cogliendone differenti “lati”), eppure è colto come obietto nel contesto
obiettivo di un determinato ordine, benché il quadro di quest’ultimo – sia
esso pensato o meno come nesso evolutivo – possa avere ampiezze
differenti»6. Il tempo non è qui altro che il contesto («genere») nel quale
si situano gli eventi. L’esserci è parte di esso:
«L’esserci preoccupato è inserito in un contesto obiettivo. Ma in che
rapporto sta l’esserci preoccupato in quanto tale con lo storico che compare
nelle tre vie? L’esserci preoccupato è soltanto un “frammento di obietto”
facente parte di un intero, grande obietto (la totalità dell’accadere storico
obiettivo)»7.
La temporalità dell’esserci è qui ridotta, inautenticamente, all’essere
nel tempo dell’esserci stesso: non c’è traccia di una temporalità altra dalla
successione di istanti. In tale prospettiva la vita storica non può che
andare persa. Spetterà alla filosofia condurci all’attimo. Sarà suo compito
accedere al vivere effettivo:
«Anche l’applicazione dello storico alla realtà umana sarà una
determinazione di questo storico-obiettivo. L’uomo stesso nella sua realtà è, in
quanto obietto, nel tempo, sta nel divenire. Essere storico è appunto una
delle sue proprietà. Questa concezione dello storico si sviluppa ancora
Ivi, p. 215.
Ivi, p. 217.
7 M. Heidegger, Introduzione alla fenomenologia della religione (semestre invernale
1920/1921), in Fenomenologia della vita religiosa, cit., p. 87.
5
6
386
Logos
totalmente nella sfera del comune buon senso. Ma la filosofia non è altro
che una lotta contro il comune buon senso! Non si può liquidare il
problema dello storico in questo modo, per quanto difficile possa essere,
oggi, giungere a una concezione differente»8.
Per accedere alla vita è necessario un approccio vivente ad essa ed é
in tale ottica che va inteso il distaccarsi heideggeriano dalle
interpretazioni di Agostino considerate. Tale distacco si consuma ad un
duplice livello: senso dell’accesso e base motivazionale dell’impostazione
e dell’attuazione dell’accesso. Ciò non segna alcuna rottura con le
esigenze di una conoscenza rigorosa, ma, al contrario, è qui in atto uno
sforzo di afferrare in maniera più originaria la vita stessa. E’ solo
attraverso il ripensamento del nesso tra storia e scienza che la storicità
vivente diviene accessibile nella sua originarietà:
«Soprattutto ci si deve guardare dal costruire in modo precipitoso, e non
bisogna ritenere che l’”antitesi” dell’esperienza storico-obiettiva sia
“soggettiva”, “non scientifica” e simili, cioè che si fondi su un punto di vista
“soggettivo” e su una finalità soggettiva. Così non si ottiene assolutamente
nulla, solo la forma atrofizzata e deteriore di una considerazione storica in
sé del tutto legittima, poiché ciò che in tal caso rimane indiscusso è proprio
il senso della relazione fra storia e scienza» 9.
Il criterio di verità della scienza originaria non può dunque essere
l’obiettività. La coincidenza di verità e visione pura è infatti immersa nel
theorein. Essa è diretta espressione dell’approccio conoscitivo teoreticooggettivante:
«La distinzione di “vero” e “falso”, intesa nel senso corrente – in genere
acriticamente accettato -, non può essere semplicemente trasposta nella
storia. Altrettanto sbagliata sarebbe tuttavia un’argomentazione che si
basasse su uno scetticismo risultante da questo fatto. Lo scetticismo, nella
concezione corrente, ha senso infatti solo in quanto antitetico al concetto di
verità sopra menzionato: entrambi si trovano nel medesimo stadio di
attuazione del determinare e dell’assicurare teoretici e delle loro norme di
senso immanenti»10.
E’ pertanto l’idea di un sapere vivente il senso del ripensamento
heideggeriano del rapporto tra storia e scienza. Nel concetto di decisione
è pensata l’esperienza vissuta dell’esperienza vissuta. Solo
sprofondandosi nella vita è possibile accedere ad essa: «Se quindi
Ivi, p. 70.
M. Heidegger, Agostino e il neoplatonismo, in Fenomenologia della vita religiosa, cit., p. 221.
10 Ivi, pp. 215-216.
8
9
Heidegger: Agostino e l’ellenizzazione della coscienza cristiana
l’esperienza e la conoscenza storiche non debbono rimanere sottoposte a
criteri conoscitivi tradizionali, bisogna cercare di decidere – nel senso
positivo dell’esperire e del determinare storici – e tale decisione, a sua
volta, non può che essere storica»11. Tale approccio vivente alla storia
guarda al senso dell’attuazione come direzione della propria indagine.
Esso è il cuore della totalità fenomenale: «Il raggiungimento di una simile
decisione e la sua genuina appropriazione dominano le considerazioni
seguenti, che sono tuttavia pensate solo come lavori preliminari. Nel loro
concreto svolgimento esse sono forse in grado di avviare nel modo più
semplice una comprensione sia del senso dell’attuazione dell’esperienza
storica ivi operante, sia del carattere peculiare dei problemi che vi
emergono»12 . Tenendosi in tale orizzonte l’indagine arriverà a scorgere
nella riflessione agostiniana il primo passo della teoretizzazione del
sapere effettivo. La filosofia è oggigiorno pienamente immersa
nell’elemento greco:
«Il neoplatonismo e Agostino non diventano un prodotto qualunque del
caso, giacché nel corso dell’analisi la loro storicità deve piuttosto
intensificarsi fino alla sua forma autentica, come qualcosa nella cui peculiare
dimensione di influenza noi stessi oggi ci troviamo. La storia ci colpisce, e
noi siamo la storia stessa»13 .
Alla luce di quanto fin qui considerato è ora possibile determinare lo
specifico dell’analisi heideggeriana. Ambito d’indagine della stessa è il
nesso tra Agostino e il neoplatonismo, suo obiettivo è evidenziare la
compresenza dell’elemento cristiano (originario) e dell’elemento greco
(teoretico) nel pensiero dell’Ipponate. Ciò permetterà di indicare
preliminarmente gli esiti di tale incontro sotto il segno
dell’interpretazione heideggeriana della grecizzazione della coscienza
cristiana. Primo passo della ricerca sarà così mostrare le tracce di un
esperire vivente la vita effettiva rinvenibili nelle pagine delle Confessioni.
2. Agostino e il neoplatonismo.
Luogo chiave del misurarsi heideggeriano con le analisi agostiniane
sono i capitoli 28 e 29 del X libro delle Confessioni. E’ il motivo delle
deformità della vita umana, vale a dire della sua distanza da sé, a muovere
le riflessioni di Heidegger:
Ivi, p. 216.
Ivi, pp. 216-217.
13 Ivi, p. 224.
11
12
388
Logos
«“Et in ista formosa quae fecisti, deformis irruebam”, in verità mi gettavo
sul mondo e sulle cose formosa (dalle belle forme), che suscitano impressione
e annunciano qualcosa di significativo, sicché tutto ciò mi catturava, e il mio
voler conoscere si estenuava con esso; però deformis irruebam: io stesso non
ero in quella forma, non avevo quell’essere che è l’essere genuino di un sé.
“Tetigisti me, et exarsi in pacem tuam”»14.
La radice della perdita di sé è il defluire nell’ente: «un orientato
essere attratti dalla e nella delectatio: la vita mondana nella sua molteplicità
di significatività - è così che va inteso il “multum” - alletta»15. In esso vive
la rovina del sé: il disperder-si. Dio esige dall’uomo la reazione alla
dispersione. La sola possibilità per l’esserci di essere il proprio sé è la
continenza: «Infatti, “in multa defluximus”, ci dissolviamo in molteplici
cose e siamo completamente assorbiti nella distrazione. Tu esigi la
reazione contro la dispersione, contro il cadere in pezzi della vita. “Per
continentiam quippe colligimur et redigimur in unum [necessarium –
Deum ?]”»16. Il senso della continentia agostiniana è, per Heidegger, il
recupero del nostro essere più proprio: il Signore ordina al servo di
essere ciò che è. E’ nello scontro con le tentazioni che vive tale sforzo:
«“Tolerari iubes”: “molestias et difficultates”; le molestie e le difficoltà
non vanno soltanto sopportate, ma affrontate come tali, il che tuttavia non
significa amarle - in fondo trasformando le difficoltà in un piacere,
sacrificandosi a esso -, bensì porsi nei loro confronti in maniera tale che il
tolerare stesso rimanga l’elemento decisivo. “Nemo quod tolerat amat, etsi
tolerare amat”. Il tolerare circoscrive un contesto peculiare di attuazione, che
non è posto in opera isolatamente, bensì cresce da e si muove in una
direzione caratteristica fondamentale della vita effettiva, nella quale anche la
tentatio trova al tempo stesso il suo senso e la sua motivazione» 17.
E’ nuovamente il motivo paolino dell’esserci come lotta per il sé che
traspare al fondo delle riflessioni agostiniane: è nella cura autentica che
va afferrato il senso della lotta alle tentazioni. In essa è rinvenibile quel
decider-si che è l’essere in relazione con Dio. Nella decisione emerge
quella temporalità altra dall’istante in cui ha luogo l’articolarsi di passato e
futuro. Essa è l’attimo: «Non ho mai la possibilità di richiamarmi a un
momento per così dire “fissato” in cui io possa sostenere di avere
penetrato me stesso. Già l’attimo successivo può smentirmi, rivelandomi
come del tutto diverso»18. Agostino coglie, per Heidegger, come
Ivi, p. 264.
Ivi, p. 266.
16 Ivi, p. 265.
17 Ivi, p. 266.
18 Ivi, p. 279.
14
15
Heidegger: Agostino e l’ellenizzazione della coscienza cristiana
l’esistenza umana sia esposta al rischio della perdita di sé, anzi, più
propriamente, che la perdita di sé sia quel rischio costitutivo che è
l’esistenza umana. Nessuno può ritenersi sicuro. La possibilità della
caduta è intrascendibile: «Perciò l’ “avere me stesso” - nella misura in cui
è attuabile - si dà sempre solo nel corso e nella direzione di questa vita,
un avanti e indietro. “ ‘Et nemo securus esse debet in ista vita, quae tota
tentatio nominatur’ (Gb, 7, 1), utrum qui fieri potuit ex deteriore melior,
non fiat etiam ex meliore deterior”»19. L’esserci è di volta in volta
richiamato a una scelta in cui ne va di se stesso:
«L’attuazione dell’esperienza è di per sé sempre nell’insicurezza. Nel
contesto dell’esperienza non c’è in nessun caso un medius locus in cui non
siano presenti al tempo stesso le possibilità contrarie, al punto che Agostino
deve dire: “ex qua parte stet victoria nescio” (dove in definitiva vada a finire
la propria vita). Si scopre così una diabolica lacerazione nell’esperire come
tale. “Ecce vulnera mea non abscondo”, vedi, non nascondo le mie
“piaghe”»20.
Vivere in tale chiarezza è gravarsi del peso angosciante del proprio
sè. Per l’uomo è d’altronde impossibile con le sue sole forze obbedire al
volere divino. E’ solo il soccorso della grazia che può dare l’uomo a se
stesso. E’ solo alla speranza nella misericordia del Signore che il nostro
sé disperato può aggrapparsi: «La vita è tale che il senso
(costitutivamente esistenziale) dell’attuazione dell’attendente, aprente
“mantenersi aperti per” può essere solo “tota spes [...] non nisi in magna
valde misericordia [Dei]” (speranza per disperazione!)»21. E’ dunque la
vita come sempre aperta possibilità di realizzarsi o perdersi che è pensata
nel nesso agostiniano di continentia e defluxus. Nel defluire l’uomo si
disperde tra gli enti dimentico di sé. In esso vive la cura inautentica. Lo
sforzo sempre rinnovantesi di essere continenti è invece la lotta per il sé:
la cura autentica. Viene così a delinearsi l’orizzonte problematico
fondamentale dell’indagine heideggeriana. Sarà la determinazione del
coincidere agostiniano di vita e tentazione la direzione fondamentale
della ricerca:
«Voi che siete autenticamente continens, “cogitet quid sibi desit, non quid
adsit”. E ci sarà sempre qualcosa quid desit, poiché la vita non è
propriamente nient’altro che una costante tentazione. “Numquid non
tentatio est vita humana super terram sine ullo interstitio?”. Bisogna
intendere in modo più preciso questo carattere fondamentale in cui
Ibidem.
Ivi, p. 269.
21 Ivi, p. 265.
19
20
390
Logos
Agostino esperisce la vita effettiva – la tentatio - per poi, in base a ciò,
comprendere in che senso colui che vive in una tale chiarezza e a un tale
stadio di attuazione sia necessariamente un peso per se stesso» 22.
E’ a partire da tali rilievi che Heidegger considera le pagine
agostiniane dedicate alle tre forme di concupiscenza: concupiscentia carnis,
concupiscentia oculorum, ambitio saeculi. Il senso di tali riflessioni va pensato
alla luce del bivio tra autenticità e inautenticità: esse non sono riducibili a
mere considerazioni di carattere morale. Le analisi in questione saranno
comprese autenticamente solo da quanti sono impegnati nella
permanente lotta per il proprio sé. Heidegger segue lo svilupparsi delle
riflessioni agostiniane relative alle tentazioni conformemente
all’andamento del X libro. In tal senso le considerazioni heideggeriane
sono in primis indirizzate alla trattazione agostiniana della concupiscentia
carnis. Particolare attenzione è dedicata da Heidegger, in tale contesto,
alle analisi agostiniane relative alla voluptas oculorum: «E qui, nella voluptas
istorum oculorum, l’accento cade sullo “amant oculi”, su ciò che gli occhi
cercano in quel momento: “pulchras formas et varias, nitidos et amoenos
colores” - lux»23. Quanti cercano i piaceri della vista si riversano sulle
creature abbandonando il loro creatore. Essi defluiscono nel mondo
disperdendo-si nella dimenticanza di Dio.
Il secondo passo della riflessione heideggeriana tocca la trattazione
agostiniana della concupiscentia oculorum. Essa è la curiosità: il desiderio di
conoscere fine a se stesso. Soggiacendo ad essa l’uomo si disperde
nell’ente: «Haec concupiscentia est “in appetitu noscendi”, dell’esperire che
prende conoscenza, che conosce, del guardar-si intorno (non del darsi da
fare) negli ambiti e nei campi più diversi, “che cosa vi accade”. Curiositas,
“avidità del nuovo”, “cupiditas, nomine cognitionis et scientiae palliata”
(“pallium”, riferimento molto probabile: dotto e filosofo greco);
indossare il mantello della profondità di pensiero e dell’assoluta necessità
culturale di prestazioni speciali»24. Nella sua irrequietezza il curioso
vedere cerca la distrazione da sè. Saranno le analisi di Essere e tempo a
evidenziare ciò:
«La curiosità, ormai predominante, non si prende cura di vedere per
comprendere ciò che vede, per «essere-per» esso, ma si prende cura solamente
di vedere. Essa cerca il nuovo esclusivamente come trampolino verso un
altro nuovo. Ciò che preme a questo tipo di visione non è la comprensione
o il rapporto genuino con la verità, ma unicamente le possibilità derivanti
Ivi, pp. 265-266.
Ivi, p. 281.
24 Ivi, p. 286.
22
23
Heidegger: Agostino e l’ellenizzazione della coscienza cristiana
dall’abbandono al mondo. La curiosità è perciò caratterizzata da una tipica
incapacità di soffermarsi su ciò che si presenta. Essa rifugge dalla
contemplazione serena, dominata com’è dall’irrequietezza e dall’eccitazione
che la spingono verso la novità e il cambiamento. In questa agitazione
permanente la curiosità cerca di continuo la propria distrazione»25.
Senso della curiosa dispersione è il distrar-si. In esso giace l’uomo:
«Curiosum genus ad cognoscendam vitam alienam, desidiosum ad
corrigendam suam»26. Abbandonarsi alla curiosità è essere nella piena
dimenticanza del proprio sé.
Anche nella considerazione del terzo genere di tentazione, l’ambitio
saeculi, emergono elementi rilevanti per l’iter filosofico heideggeriano del
’27. Più specificamente va sottolineato come il filosofo tedesco individui
nelle analisi del terzo genere di tentazione tracce utili per afferrare la
caduta dell’esserci nell’incontro con gli altri. Heidegger si sofferma sulle
due direzioni dell’analisi agostiniana dell’ambitio saeculi: il desiderio di
essere temuti e amati dagli uomini e la superbia. Nel primo caso
Heidegger coglie nell’affaccendarsi dell’esserci rivolto ad ottenere il
consenso umano la cura inautentica dimentica di sé: «il curare di questo
esperire si dà da fare per conquistare all’esperiente una determinata
M. Heidegger, Essere e tempo (1927), trad. it. P. Chiodi, Milano, Longanesi, 1976, p.
217. Elemento di continuità tra le interpretazioni fenomenologiche heideggeriane del X
libro delle Confessioni e le analisi di Essere e tempo è l’interesse heideggeriano per il motivo
agostiniano del primato della vista tra i sensi impegnati nel conoscere. Esso evidenzia,
per Heidegger, il coincidere nelle riflessioni agostiniane di visione e conoscenza:
«Perché questa concupiscentia è intesa e definita come concupiscentia oculorum? “Oculi autem
sunt ad cognoscendum in sensibus principes […]. Ad oculos enim proprie videre
pertinet”. (Poiché il senso dell’operazione della sensibilità è il prendere conoscenza, fra
le sue varie modalità il primo posto va assegnato al vedere). “Utimur autem hoc verbo
etiam in caeteris sensibus, cum eos ad cognoscendum intendimus”, se diamo alla
sensibilità quella piena direzione e funzione di senso del conoscere che essa, come tale,
non ha già comunque, sempre e in primo luogo» (M. Heidegger, Agostino e il
neoplatonismo, in Fenomenologia della vita religiosa, cit., p. 288). Tali rilievi emergeranno
nuovamente nelle analisi heideggeriane di Essere e tempo dedicate alla genesi esistenziale
della scienza. Nelle stesse Heidegger evidenzierà la presenza nel pensiero agostiniano
del paradigma conoscitivo del vedere intuitivo puro: «L’essere è ciò che si manifesta alla
visione intuitiva pura: solo questo vedere scopre l’essere. La verità originaria e genuina
consiste nella intuizione pura. Questa tesi resterà alla base della filosofia occidentale. In
essa trova il suo motivo anche la dialettica hegeliana, che è possibile solo sul
fondamento. Lo straordinario primato del “vedere” fu notato soprattutto da Agostino
nell’interpretazione della concupiscentia. “Ad oculos enim videre proprie pertinet”. Il
vedere è proprio degli occhi. […] A causa di ciò l’esperienza dei sensi in generale è detta
“concupiscenza”, come si dice degli occhi, perché anche gli altri sensi, quando si tratta
di conoscere qualcosa, usurpano, per analogia, la funzione del vedere, funzione nella
quale gli occhi hanno il primato» (M. Heidegger, Essere e tempo, cit., p. 216).
26 Agostino, Confessioni, X, 3, 3, trad. it. C. Carena, Roma, NBA 1, 1991.
25
392
Logos
posizione in rapporto al mondo degli altri. Si tratta di un velle: volere,
desiderare, mettere coscientemente in opera la vita in modo da essere
temuti o amati dagli altri»27. Nel secondo caso Heidegger individua tracce
del massimo pericolo per il sé: l’autocompiacimento. Esso vive nel pieno
oblio della radicale dipendenza dell’uomo da Dio:
«In questa forma di tentazione c’è una possibilità di decadimento, tale
che in esso il sé e, quindi, l’esserci del singolo diventano frivoli,
volatilizzandosi nel vuoto e nel nulla. Sibi placens, farsi valere di fronte a se
stessi, compiacersi di fronte a se stessi, attribuire a se stessi un bonum; il
gaudium (delectatio) si dirige verso il mondo del sé, e nel darsi da fare per la
beata vita è il mondo del sé a essere preso sul serio» 28.
Le tre vie agostiniane del deflusso si rivelano essere, per Heidegger,
la radice della sempre possibile perdita o conquista di sé. Il loro senso
diviene manifesto alla luce della cura autentica. Esse sono le pericolose
occasioni dell’aver-si:
«Molestia: un “come” dell’esperire, una molestia e una minaccia dell’avere
se stessi - nella piena fatticità -, “avere se stessi” che, in quanto effettivo, è
tale da attuare da sé questa minaccia ed esserne fiero. Nell’attuazione
concretamente genuina dell’esperienza si dà la possibilità del decadimento,
però nella cura più propria e radicale di se stessi si dà nel contempo
l’”occasione” piena, concreta ed effettiva di pervenire all’essere della vita più
propria. Decisivo è dunque l’effettivo avere se stessi nel dare-forma alla
possibilità e nell’essere fieri di essa in quanto “occasione” del sussistere della
tentatio, […] e dell’attuazione […], dell’afferrare l’autentica direzione della
cura del proprio esserci effettivo. La molestia si determina quindi secondo il
“come” dell’avere se stessi nel “come” dell’attuazione effettiva
dell’esperienza»29.
Nella lotta per il sé emerge con chiarezza il significato della
coincidenza di vita e tentazione. In essa vive, per Heidegger,
l’intrascendibile rischio di sé: «“Vita” - un “come” dell’essere, che
consiste precisamente nell’esperire le tentationes. E’ una tentatio, costituisce
la possibilità del perdersi e del conquistarsi»30.
Dopo aver delineato le tracce dell’esperire vivente la vita effettiva
rinvenibili nelle Confessioni agostiniane, è ora necessario chiarire il senso
del distacco dalla vita del cristianesimo delle origini. Ciò significherà
M. Heidegger, Agostino e il neoplatonismo, in Fenomenologia della vita religiosa, cit., p. 293.
Ivi, pp. 303-304.
29 Ivi, p. 311.
30 Ivi, p. 313.
27
28
Heidegger: Agostino e l’ellenizzazione della coscienza cristiana
misurarsi con l’interpretazione heideggeriana della grecizzazione della
coscienza cristiana.
3. Ellenizzazione del cristianesimo.
L’analisi heideggeriana del senso della presenza dell’ontologia greca
nel pensiero agostiniano è l’altro aspetto essenziale delle interpretazioni
fenomenologiche del X libro delle Confessioni. In essa giunge a
espressione l’interpretazione heideggeriana della grecizzazione della
coscienza cristiana della vita. Tracciare il senso di tale analisi è il compito
specifico del presente momento della ricerca. Ciò permetterà inoltre di
cogliere la natura del mutamento del giudizio di Heidegger sul
cristianesimo delle origini.
E’ fin da subito necessario precisare la posizione heideggeriana
relativa al tema indicato. La specificazione del senso proprio della stessa
emerge nelle considerazioni introduttive del corso del 1921 dedicato ad
Agostino. L’analisi di Heidegger si caratterizza per la sua essenziale
differenza dalle più celebri interpretazioni della grecizzazione della
coscienza cristiana dell’epoca. E’ particolarmente nel confronto con
Dilthey che emerge la specificità dell’indagine heideggeriana:
«La delimitazione negativa può essere colta in modo ancora più preciso.
Il titolo dell’indagine è: “Agostino e il neoplatonismo”. Dal punto di vista
storico-obiettivo si tratta della questione riguardante il peso e la modalità
dell’influsso della filosofia neoplatonica sul lavoro filosofico-teologicodogmatico di Agostino. Oggi, nell’ambito dei recenti studi agostiniani, non
si fa che parlare di questo. Harnack, ad esempio, proprio con l’intento di
indagare - sotto l’influsso teologico di Ritschl - la genesi e l’evoluzione dei
dogmi ecclesiastici, punta lo sguardo sul processo di ellenizzazione del
cristianesimo. Analogamente Dilthey - sotto l’evidente influsso di
Schleiermacher e Ritschl - ha parlato di una penetrazione della metafisica e
della cosmologia greche nell’esperienza interiore. Tuttavia, Dilthey non ha
fornito una prova realmente concreta, né quelle di cui disponiamo sono
qualcosa di più che mere constatazioni di genere storico-letterario,
accertamenti riportati di assunzioni di concetti e termini» 31.
Ivi, pp. 221-222. Sull’interpretazione diltheyana di Agostino confronta: W. Dilthey,
Introduzione alle scienze dello spirito (1883), trad. it. G. A. De Toni, Varese, Bompiani, 2007,
pp. 505-529. Quanto alle analisi che von Harnack dedica all’Ipponate si veda A. von
Harnack, Manuale della storia dei dogmi (1885-89), Mendrisio, Casa editrice Cultura
moderna, 1912-1914. Per una introduzione al problema della grecizzazione della
coscienza cristiana, M. C. Bartolomei, Ellenizzazione del cristianesimo, L’Aquila, Japadre,
1984. Sul problema della trattazione heideggeriana dell’ellenizzazione della coscienza
31
394
Logos
E’ l’impostazione stessa dell’analisi diltheyana a suscitare le critiche
heideggeriane. Essa manca infatti lo specifico orizzonte del problema e
ne cela il senso originario: non è nel nesso tra metafisica ed esperienza
vissuta che va colto il senso dell’ellenizzazione del cristianesimo. La
traccia autentica della grecizzazione della coscienza cristiana va cercata,
per Heidegger, nell’imporsi del teoretico nell’esperire vivente la vita
effettiva del cristianesimo delle origini:
«Se nella forma obiettiva della metafisica e della cosmologia greche è
contenuto il problema del senso della scienza reale teoretico-obiettiva, e se
la domanda sull’esperienza interna e sull’essenza del contesto effettivo cela
un fenomeno assai più radicale - ci limitiamo qui a enunciarlo con il titolo
“vita effettiva” - , a maggior ragione la relazione fra l’uno e l’altro è qualcosa
di diverso da una penetrazione reciproca, ovvero, in termini positivi, dalla
fondazione (costituzione) gnoseologica del primo sul secondo e in base al
secondo»32.
Heidegger non prende dunque posizione contro l’idea della
grecizzazione della coscienza cristiana, bensì contro gli approcci che ne
mancano la specificità. Le critiche mosse a Dilthey vanno dunque colte
nello sforzo di pensare in maniera radicale l’ellenizzazione del
cristianesimo. E’ in tale orizzonte concettuale che si situano le analisi
heideggeriane delle Confessioni.
Determinante per la comprensione del senso della teoretizzazione
dell’esperienza cristiana della vita è l’analisi della natura della presenza
dell’assiologia greca nelle riflessioni agostiniane. Elemento essenziale
della stessa è l’equazione Essere=Bene: «Assiologizzazione indirizzata in
modo preciso (incommutabile e summum bonum; e da qui l’intero ordine)»33.
La rilevanza dell’assiologia neoplatonica si rivela essere determinante alla
luce del peso che essa ha nella metafisica di Agostino. La comprensione
agostiniana dell’ente poggia infatti su di essa: «Questa gerarchia è
largamente dominante in Agostino, benché in verità non sia concepita in
forma così separata come si fa oggi (ad esempio in Scheler); essa fa
tutt’uno con la sua concreta metafisica, e la comprensione della realtà
(res) è improntata su di essa»34. La presenza dell’ontologia neoplatonica
nel cuore dell’indagine metafisica di Agostino è all’origine del concetto di
Dio come ente sommo: assoluta stabilità e piena perfezione. Dio è il
cristiana, confronta: A. Fabris, L’«ermeneutica della fatticità» nei corsi friburghesi dal 1919 al
1923, cit., pp. 88-89; D. Vicari, Ontologia dell’esserci. La riproposizione della «questione
dell’uomo» nello Heidegger del primo periodo friburghese (1916-1923), cit., pp. 104-107.
32 Ivi, p. 223.
33 Ivi, p. 333.
34 Ivi, p. 354.
Heidegger: Agostino e l’ellenizzazione della coscienza cristiana
sommo Bene: ciò che deve essere goduto per se stesso. L’atteggiamento
corretto nei confronti degli altri enti è invece l’uso strumentale di essi. Il
fine in sé è unicamente Dio: «Nel godere dobbiamo avere le cose eterne
e immutabili. Il giusto comportamento nei confronti delle altre cose è
l’uti, dato che proprio per loro tramite giungiamo al frui di ciò che è
genuino»35. Emerge in ciò il plesso teoretico dei concetti di uti e frui: esso
è il cuore della lotta agostiniana alle tentazioni. E’ qui evidente
l’inscindibile nesso tra l’elemento cristiano e l’elemento greco del
pensiero agostiniano: lottare per il sé è amare il più prezioso. La cura
autentica coincide dunque con l’amore ordinato: «Ama in modo
autentico colui che è integer aestimator rerum e che ha la ordinata dilectio, in
virtù della quale né ama ciò che non deve essere amato, né ama di più ciò
che non deve essere amato di più, eccetera»36. L’uomo stesso non può
essere amato per se stesso. La sua mutevolezza lo rende inadatto a ciò:
«Anche per se stesso l’uomo non può essere oggetto del frui, se vedi con
chiarezza. “Si autem se propter se diligit”, non si riferisce a Dio. Se è
rivolto a se stesso non è rivolto a nulla di immutabile. E poiché ciò che
dice di amare in se stesso è afflitto da un difetto (defectus, la caducità), è
preferibile che, senza difetti, si leghi all’incommutabile, piuttosto che “ad
seipsum relaxatur”»37. E’ unicamente Dio ciò di cui dobbiamo godere. La
fruitio Dei è la sua contemplazione:
«Senso estetico fondamentale del frui; fruendum est trinitate, rei intelligibilis
pulchritudo [?] (vvvv√ohto;√ kavlloı) [?]; incommutabilis et ineffabilis
pulchritudo = Dio. Il frui è quindi la caratteristica fondamentale
dell’atteggiamento di fondo di Agostino nei confronti della vita stessa. Il suo
correlato è la pulchritudo. Vi è dunque contenuto un momento estetico. E lo
stesso vale per il summum bonum»38.
Si è se stessi nella quiete del theorein, si è in una lotta angosciante solo
per essere liberi da ogni angoscia. E’ qui che diviene visibile, per
Heidegger, la grecizzazione della coscienza cristiana. In ciò diviene
manifesto il venir meno dell’afferramento originario della vita e della cura
autentica:
Ivi, p. 347.
Ivi, p. 357.
37 Ivi, p. 355.
38 Ivi, p. 347.
35
36
396
Logos
«La fruitio Dei si pone in ultima analisi in antitesi con l’avere il sé; le due
cose non nascono dalla medesima radice, bensì sono cresciute insieme
dall’esterno»39.
Il tradimento del contenuto originario del primo cristianesimo
emerge già nel pensare Dio all’interno delle categorie dell’ontologia
neoplatonica. Nel Dio concepito come pura presenza e summum Bonum
non c’è traccia del Signore nel cui aiuto il cuore dell’uomo confida in
questa vita che è radicalmente prova: Dio è qui ridotto a oggetto di
conoscenza. L’essere in relazione con Dio si riduce alla contemplazione
dell’ente sommo. Chi è nella luce riconosce l’Anticristo: «Il theologus
gloriae, che si delizia esteticamente delle meraviglie del mondo, nomina il
sensibile in Dio. Il teologo della croce dice come sono le cose»40. Lutero
colse il rischio insito nella teologia della gloria: «Quando Dio è concepito
primariamente come oggetto di speculazione si ha un decadimento dal
comprendere autentico. Lo si capisce soltanto quando si attua
l’esplicazione dei nessi concettuali. Questo però non lo si è mai tentato,
poiché la filosofia greca è penetrata nel cristianesimo. Soltanto Lutero ha
fatto un tentativo in questa direzione, e ciò spiega il suo odio per
Aristotele»41. Nel rapporto con Dio non c’è più traccia dell’inquietudine
per il sé. E’ l’ingresso della quiete greca che cela l’angustia per
l’imminenza della parousiva: «A ciò è connesso il fatto che per
Agostino lo scopo della vita è la quies. Vita praesens: “In re laboris, sed in
spe quietis; in carne vetustatis, sed in fide novitatis”»42. E’ l’incedere della
metafisica nell’ambito della vita.
Emerge ora con chiarezza l’inscindibilità del nesso tra Agostino e la
tradizione neoplatonica tale da rendere impossibile ogni sforzo di
distinzione tra ciò che è propriamente cristiano e ciò che risulta invece
essere greco nel pensiero dell’Ipponate: «Non ci si può dunque limitare a
eliminare l’elemento platonico presente in Agostino, ed è sbagliato
credere di poter ottenere l’elemento autenticamente cristiano facendo
riferimento alla sua opera»43. La teoretizzazione del pensiero agostiniano
è il primo passo della grecizzazione della coscienza cristiana della vita.
Esito di tale processo è il sempre più pieno celarsi del sapere effettivo.
L’odierna filosofia è puro theorein: «Nel complesso, tuttavia, l’esplicazione
dell’esperienza di Dio in Agostino è specificamente “greca” (nello stesso
Ivi, p. 348.
Ivi, p. 359.
41 M. Heidegger, Introduzione alla fenomenologia della religione, in Fenomenologia della vita
religiosa, cit., p. 137.
42 M. Heidegger, Agostino e il neoplatonismo, in Fenomenologia della vita religiosa, cit., p. 348.
43 Ivi, p. 358.
39
40
Heidegger: Agostino e l’ellenizzazione della coscienza cristiana
senso in cui anche tutta la nostra filosofia è ancora “greca”). Non si
giunge a una problematica e a una considerazione dell’origine
radicalmente critiche (distruzione)»44.
I rilievi svolti risultano determinanti alla luce degli sviluppi
immediati del pensiero heideggeriano. In esso si verrà delineando
l’abbandono dell’ottica con la quale si erano aperte le ricerche relative al
protocristianesimo: anche quest’ultimo viene infatti ricondotto
all’orizzonte greco del theorein. La stessa prospettiva della grecizzazione
della coscienza cristiana verrà abbandonata. Già nel primo dei corsi
dedicati ad Aristotele tale novità si fa evidente. In esso infatti emerge
come la distinzione tra cristianesimo delle origini e scolastica venga
progressivamente meno: «La coscienza cristiana della vita propria della
prima scolastica nonché di quella dell’alto Medio Evo - in cui si è attuata
la vera e propria ricezione di Aristotele e, con essa, una sua ben precisa
interpretazione - era già passata attraverso una “grecizzazione”. Già le
stesse condizioni di vita del cristianesimo originario erano maturate in un
ambiente la cui vita tendeva ad esprimersi in una direzione determinata
non da ultimo dall’interpretazione dell’esistenza e dalla concettualità
(terminologia) dei Greci»45. La distanza rimarcata tra filosofia e fede
andrà sempre più accentuandosi negli anni successivi. Più volte nel corso
di essi Heidegger traccerà le linee di confine tra l’ambito e le vie
d’accesso filosofiche e le problematiche e i metodi della teologia.
L’incessante e inquieto domandare filosofico non si arresterà di fronte
alla sicurezza della fede.
Ivi, pp. 371-372.
M. Heidegger, Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele. Introduzione alla ricerca
fenomenologica (semestre invernale 1921/1922) [1985], trad. it. M. De Carolis, Napoli,
Guida, 1990, p. 44.
44
45
Maria Giungati
Comprensione e perdono in Hannah Arendt
“Esercizi di pensiero”
Abbiamo varcato da circa un decennio ormai il terzo millennio ed
ancora oggi, nonostante il decantato valore “esemplare” della memoria
degli errori e degli orrori passati, siamo paurosamente messi di fronte al
rinnovato incalzare di fenomeni che hanno già segnato i momenti più bui
della nostra tradizione recente. La «mancanza di patria», lo
«sradicamento», la «disintegrazione dei corpi politici e sociali», di cui
parlava Hannah Arendt intorno al 19501, tornano a riproporsi con
sgomentante attualità e con tutte le conseguenti manifestazioni nella
realtà umana odierna, caratterizzata da conflitti atroci e violenze
innumerevoli. Le sollecitazioni alla comprensione e al perdono delle
colpe del passato, che pur si levano da più parti, sembrano perdersi nel
nulla: la comprensione si tramuta in totale incomprensione dei diritti più
elementari dell’altro ed il perdono in facile ed inutile “perdonismo”.
Hannah Arendt, ebrea tedesca che ha attraversato con la sua
esistenza «i tempi più oscuri» del secolo scorso, è una “voce” con un
timbro originale che, traendo spunto da quel «fenomeno unico» che fu il
totalitarismo, fu impegnata in un incessante sforzo di comprendere e di
portare alla parola «l’inaudito», l’incomprensibile che si era consumato
nelle «fabbriche della morte» di Auschwitz.
Il totalitarismo non fu da lei assimilato – come è noto – alle altre
forme di dispotismo o di dittatura che pur si sono susseguite nella storia
umana, ma le apparve in tutta la sua «novità», anche se in un certo senso
rappresentava la «cristallizzazione» di «elementi» presenti nella tradizione
H. Arendt, The Eggs Speak Up, in Id., Essays in Understanding 1930-1954, ed. J.
Kohn, New York, Harcourt Brace & Company, 1994, p. 271; trad. it. in Archivio Arendt
2. 1950-1954, a cura di S. Forti, Milano, Feltrinelli, 2003, p. 45. Qui la Arendt, coerente
con i suoi intendimenti circa il concetto di «origini» del totalitarismo, individua nello
«spaesamento», nello «sradicamento» e nella «disintegrazione dei corpi politici e delle
classi sociali» quei fenomeni che, se pure «non sono le cause dirette del totalitarismo,
sono quantomeno all’origine di quasi tutti gli elementi che alla fine confluiscono nella
sua formazione».
1
Comprensione e perdono in Hannah Arendt
storico-politica occidentale2. Il totalitarismo è il «senza precedenti» che
ha fatto irruzione nella storia, è l’«orrore puro», impunibile e
imperdonabile che ha polverizzato tutte le nostre categorie di pensiero e i
nostri criteri di giudizio morale. Ma se è vero che il regime totalitario ci
pone di fronte ad un «abisso» incolmabile, a ciò che la Arendt chiama
«l’immagine dell’inferno», l’importante, a suo avviso, è ricordare senza
giustificare, è tentare una comprensione che non miri a dissolvere
«l’inaudito» nelle griglie neutralizzanti della speculazione, ma che affronti
«spregiudicatamente» la realtà, renda conto del male accaduto, riscatti tale
passato evocandolo come tale e sottraendolo così alla comoda visione
della Storia intesa come continuum necessario e necessitato.
Ben consapevole che «la storia umana non ha mai conosciuto una
storia così difficile da raccontare»3, Hannah Arendt, con appassionata
tenacia ed anche con una certa distanza nei confronti di una storiografia
che si vorrebbe puramente “obbiettiva”, ricostruisce faticosamente i
fenomeni che, nella loro contingenza storica, hanno offerto terreno
fertile alla “fabbricazione” della realtà totalitaria e all’esplosione del «male
radicale», riflette sul fenomeno totalitario e sulla sua natura non solo
«nelle sue implicazioni storiche e politiche» ma, come è stato giustamente
sottolineato, «da una prospettiva di senso»4. «Che cosa succedeva? Perché
succedeva? Come era potuto succedere?» sono interrogativi che, posti
con lucida profondità nella Prefazione del 1966 a Le origini del totalitarismo,
illuminano un percorso. E’ il percorso di una pensatrice che procede «dal
dato al significato», in «un’attività senza fine» che si amplia, lungo l’arco
2 La metafora della «cristallizzazione» e il rifiuto della categoria della «causalità»,
propria del tradizionale approccio storiografico, trovano una loro esplicitazione in
quanto la Arendt affermò in una serie di lezioni tenute nel 1954 alla New School for
Social Research. «Gli elementi del totalitarismo costituiscono le sue origini, purché per
“origini” non si intenda “cause”. La causalità, cioé il fattore di determinazione di un
processo di eventi in cui un evento sempre ne causa un altro e da esso può essere
spiegato, è probabilmente una categoria totalmente estranea e aberrante nel regno delle
scienze storiche e politiche. Probabilmente gli elementi in se stessi non causano mai
alcunché. Essi divengono l’origine di un evento se e quando si cristallizzano in forme
fisse e definite. Allora, e solo allora, sarà possibile seguire all’indietro la loro storia.
L’evento illumina il suo stesso passato, ma non può mai essere dedotto da esso» (cit. in
E. Young-Bruhel, Hannah Arendt. For Love of the World, New Haven-London, Yale
University Press, 1982; Hannah Arendt 1906-1975. Per amore del mondo, trad. it. di D.
Mezzacapa, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, p. 241). Ora anche in H. Arendt,
Understanding and Politics (The Difficulties of Understanding), in Id., Essays in Understanding,
cit., p. 325, nota 12; trad. it. in Archivio Arendt 2.1950-1954, cit., p. 92, nota 14.
3 H. Arendt, The Image of Hell (1946), in Id., Essays in Understanding, cit., trad. it. in
Archivio Arendt 1. 1930-1948, a cura di S. Forti, Milano, Feltrinelli, 2001, p. 232.
4 S. Forti, Hannah Arendt: filosofia e politica, in AA.VV., Hannah Arendt, a cura di S.
Forti, Milano, Bruno Mondadori, 1999, p. XIII.
400
Logos
della sua vita, attraverso un dialogo continuo, che la conduce a misurarsi
con il rapporto politica-filosofia e politica-morale. La «malinconia
ontologica e storica»5, la decostruzione critica della filosofia e della
filosofia politica occidentali, nonché della morale naufragata
nell’esperienza totalitaria, sono motivi che sicuramente ci conducono al
cuore del pensiero di Hannah Arendt; ma a questa opera di
decostruzione segue un lascito propositivo privo di aporie?
Come ormai concorda la maggior parte dei critici, i suoi «esercizi di
pensiero» non ci consentono di incapsulare le sue riflessioni in un
sistema razionalistico esaustivo e conciliante; ci suggeriscono piuttosto di
rispettarne la problematicità, di coglierne la sottesa provocazione, e
anche in fondo di percepire la pur sommessa speranza che in essi
traspare. E’ questa problematicità e questa capacità di provocare che
vorrei mettere in moto con il prendere in considerazione il rapporto fra
la comprensione e il perdono nel pensiero di Hannah Arendt, non
guidata da un intento puramente espositivo, ma con il proposito di
interrogarla, di camminare con lei e, perché no, di esplorare qualche
possibilità di procedere oltre le sue riflessioni.
1. Il «dovere» di comprendere
Il «bisogno» di comprendere fu sollecitato precocemente in Hannah
Arendt dalla lettura di libri attinti dalla biblioteca di famiglia, come lei
stessa confidò a Gaus nell’intervista televisiva del 28 ottobre 19646.
Questo bisogno, successivamente alimentato dagli studi di filosofia da lei
seguiti a Marburg, a Freiburg e a Heidelberg con Heidegger, Husserl,
Bultmann e Jaspers, si trasformò dagli anni Quaranta in poi nel «dovere»
di comprendere gli eventi terribili del suo secolo.
Tra il «bisogno» di comprendere e il «dovere»7 di comprendere
intercorre l’adesione ad un imperativo, ad una «chiamata»8 che implicava
5
Cfr. J.-F. Lyotard, Sopravvissuto, in AA.VV., Hannah Arendt, a cura di S. Forti, cit.,
p. 74.
6 H. Arendt, Was bleibt? Es bleibt die Muttersprache, in Gespräche mit Hannah Arendt, a
cura di A. Reif, München, Piper, 1976; Che cosa resta? Resta la lingua materna, in «AutAut», set.-dic. (1990), p. 18; ora anche in Archivio Arendt 1, cit., p. 43.
7 Assumo e sviluppo liberamente le espressioni usate dalla stessa Arendt
nell’intervista citata, ove in verità non è sottolineato in maniera esplicita il passaggio dal
«bisogno» al «dovere» di comprendere.
8 Cfr. L. Ritter Santini, La passione di capire. Hannah Arendt e il pensare letteratura.
Introduzione a H. Arendt, Il futuro alle spalle, a cura di L. Ritter Santini, Bologna, Il Mulino,
1981, p. 52. Qui si legge: «Hannah non credeva nelle gregarie idee di un “dovere”
personale (forse per questo la parte del suo libro sulla volontà le aveva posto tanti
Comprensione e perdono in Hannah Arendt
il prendere in carico la storicità, e significava l’assunzione di una
responsabilità etico-politica di fronte alla catastrofe che si stava
consumando in Germania con il regime nazista. L’incendio del Reichstag
del 27 febbraio 1933 con la cosiddetta custodia preventiva che ne seguì e
la Gleichschaltung (uniformazione) degli amici intellettuali ma, soprattutto,
il «vero trauma» del 1943 – «il giorno in cui venimmo a sapere di
Auschwitz»9 – costituirono esperienze tali da imporsi nella vita della
Arendt e da segnare indelebilmente la sua riflessione.
Quella che avrebbe potuto essere una esistenza dedita alla «storia
delle idee», al cui rinnovamento era stata iniziata da due grandi filosofi
come Heidegger e Jaspers, ricevette agli inizi degli anni Trenta una nuova
direzione. «Uno stato d’animo antiaccademico»10 si impossessò di lei e di
pari passo il suo pensiero diventò più politico e più storico.
Se la sua ebraicità aveva sempre costituito e sempre costituì uno di
quei dati di fatto indiscutibili» nella sua vita che non aveva mai
«desiderato cambiare o ripudiare»11, gli eventi del 1933 fecero sì che
questo «dato di fatto» diventasse un vero e proprio «problema politico».
«Se si è aggrediti in quanto ebrei, bisogna difendersi da ebrei»12: così la
Arendt sottolinea, a distanza di un trentennio dai fatti, quello che fu
l’aspetto positivo della sua reazione alla presa del potere hitleriano. La
decisione di essere se stessa come ebrea la portò dapprima ad attivarsi
praticamente per gli ebrei in Francia, ove si era rifugiata nel ’33,
affiancandosi al movimento sionista ma con autonomia di pensiero13 –
“da libero pariah” – e a proporre poi, da New York dove era emigrata
problemi) ma rispondeva piuttosto al senso di una chiamata, di una vocazione,
compresa quella del cittadino a servire la vita pubblica». Ritengo per parte mia che la
“chiamata” apra una visione del “dovere” che non si identifica con l’obbligo esteriore.
9 H. Arendt, Che cosa resta? Resta la lingua materna, in Archivio Arendt 1, cit, p. 48.
10 E. Young-Bruhel, Hannah Arendt. Per amore del mondo, cit, p. 147.
11 H. Arendt, lettera a Gershom Scholem del 24 luglio 1963, in Id., Ebraismo e
modernità, Milano, Ed. Unicopli, 1986, p. 222.
12 Id., Che cosa resta? Resta la lingua materna, in Archivio Arendt 1, cit., p. 46.
13 Se il Selbstdenken, il “pensare da sé” di Lessing è presentato da Hannah Arendt
come la cifra del suo pensiero in momenti cruciali della sua vita (cfr. la lettera a G.
Scholem del 24/7/1963 in H. Arendt, Ebraismo e modernità, cit., p. 226), la metafora del
«pensare senza balaustrata» (Denken ohne Geländer), da lei stessa rivelata dopo aver scritto
le sue opere più importanti, si muove nella stessa direzione, anzi «supera l’autonomia
del Selbstdenken» (cfr. L. Ritter Santini, La passione di capire, cit., p. 49). Punto di
riferimento determinante è il discorso tenuto dalla Arendt il 28 sett. 1959 ad Amburgo
per il conferimento del premio Lessing, pubblicato con il titolo On Humanity in Dark
Times. Thoughts about Lessing, in H. Arendt, Men in Dark Times, New York, Harcourt
Brace & World, 1968, tr. it. L’umanità nei tempi oscuri. Riflessioni su Lessing, a cura di L.
Boella, in «La società degli individui», n. 7 (2000/1), pp. 5-30.
402
Logos
nel 1941, «un fondamento teorico e un indirizzo pratico definiti a una
politica ebraica»14.
Il rapporto di Hannah Arendt con l’ebraismo e con la politica
sionista15 non è un capitolo facile da riassumere, soprattutto se si pensa
alle controversie che seguirono la pubblicazione del libro su Eichmann.
Qui vorrei solo sottolineare la portata del “sionismo critico” della Arendt
che affonda in quel suo bisogno-dovere di pensare e di comprendere il
problema ebraico non già come «un’antisionista ma [come]
un’internazionalista»16, come cittadina del mondo che, nell’accettazione
della propria appartenenza alla tradizione ebraica, fa dell’ebraismo e
dell’antisemitismo il simbolo della universale ribellione nei confronti
dell’oppressione, senza cedere ad alcuna ideologia di parte. Se è vero,
infatti, che ella apprezzò l’autentico movimento di emancipazione
provocato dal sionismo, è pur vero che non si assimilò mai all’ideologia
sionista nei suoi aspetti più nazionalistici, né, soprattutto, alla teoria
dell’«eterno antisemitismo»17 che, a suo parere, rifiutava gli insegnamenti
dell’esperienza e induceva all’alterazione della verità dei fatti.
Ed è proprio la necessità di «affrontare spregiudicatamente,
attentamente la realtà, qualunque essa sia», la molla propulsiva
dell’analisi arendtiana del totalitarismo, analisi che - come è noto - la
Arendt conduce nell’opera che vide la luce nel 1951, dopo anni di
intenso lavoro. La Prefazione alla I edizione offre passaggi di rilevante
interesse per un primo accostamento alla problematica della
comprensione. Qui Hannah Arendt, sottolineando la vanità degli sforzi
compiuti «per evadere dall’atmosfera sinistra del presente nella nostalgia
per un passato ancora intatto, o nell’oblio anticipato di un migliore
futuro»,
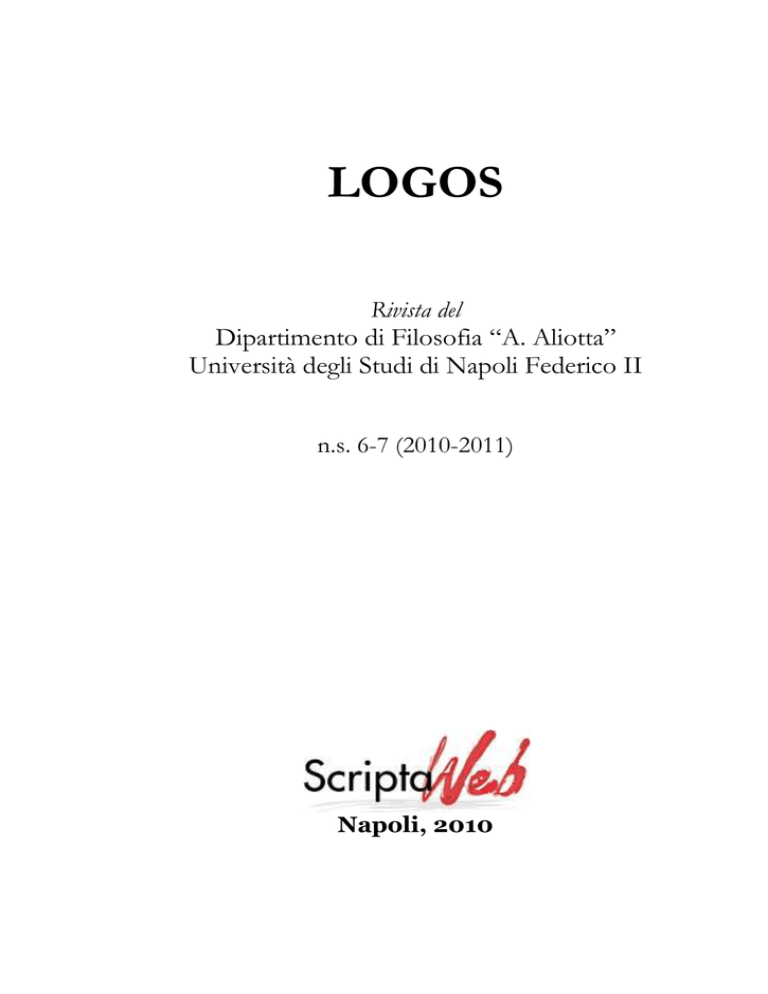


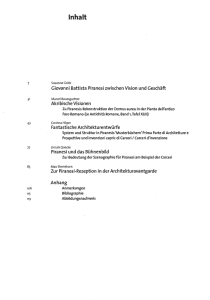
![Ricerca nr. 1 [MS WORD 395 KB]](http://s1.studylibit.com/store/data/000076742_1-2ede245e00e21c823e517529e1c3be46-300x300.png)