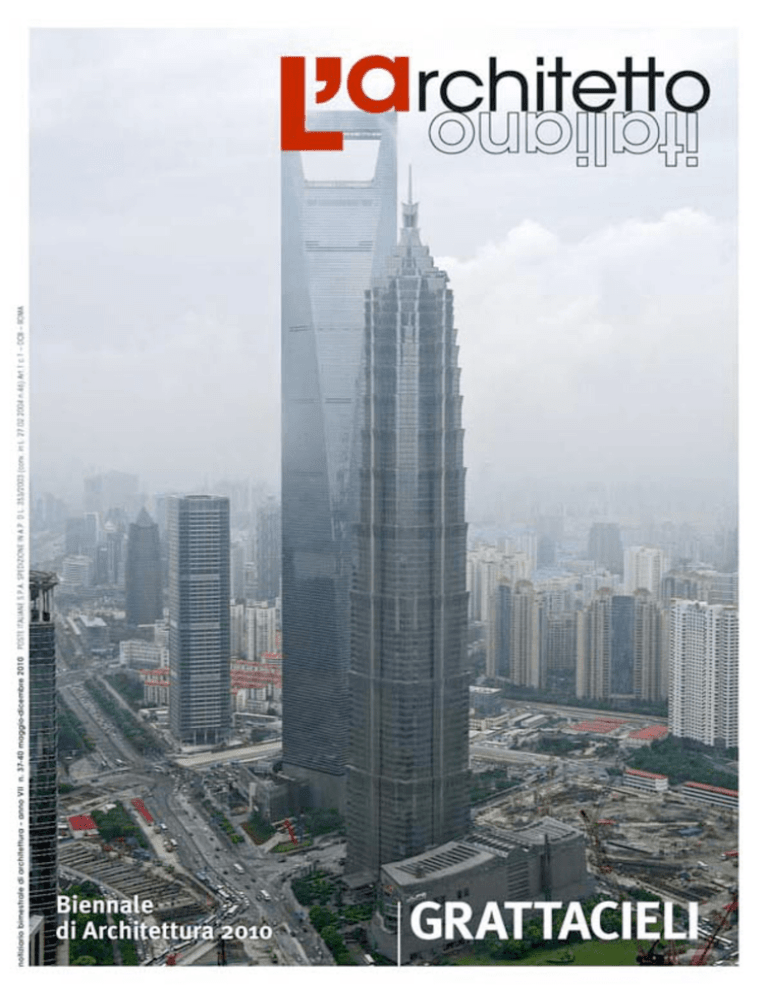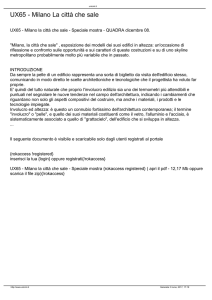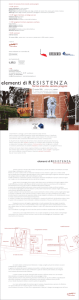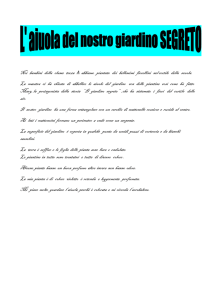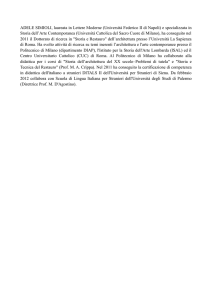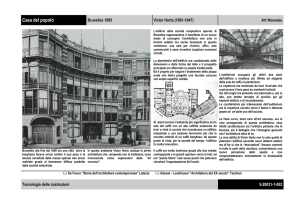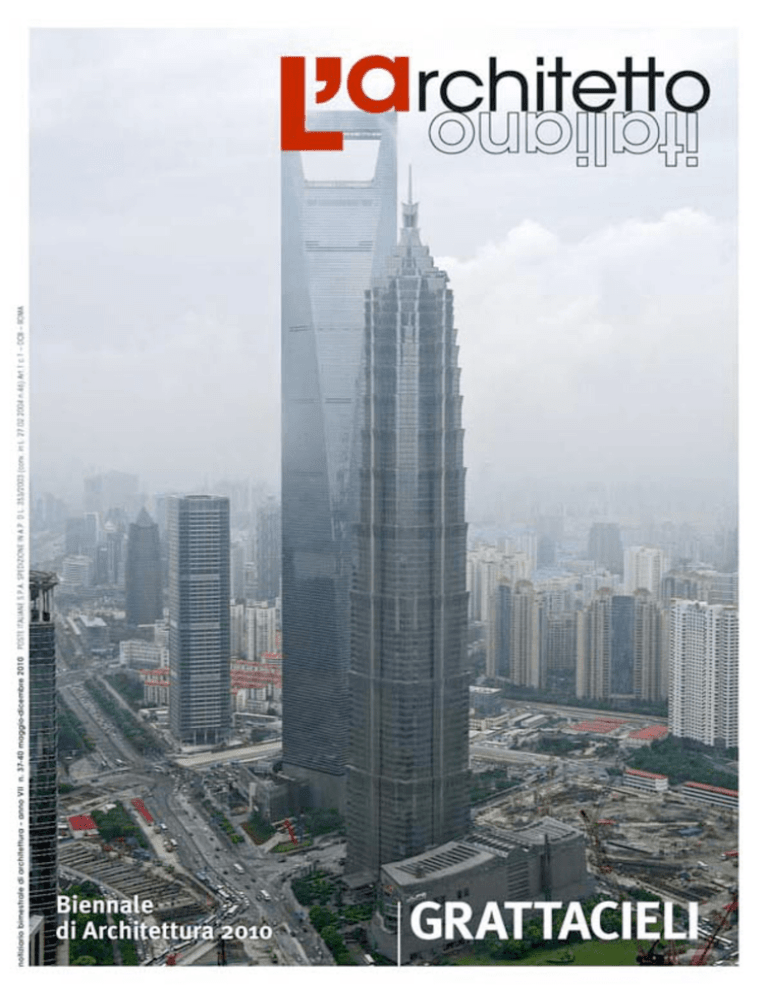
n.37-40
maggio-dicembre 2010
notiziario bimestrale di architettura
in questo numero
L’OPINIONE
BENI CULTURALI
APPROFONDIMENTI
inserto ARCHITETTURE
Biennale 2010.
People meet
in architecture
Roma, ovvero
monumenti e potere
Pensando a Magritte.
Z5 il Giardino
degli Occhi
a cura di
francesco cellini, mario
panizza, carlo mancosu
di renato nicolini
4
Un giardino poetico
alla Biennale:
conversazione
con Piet Oudolf
di luca d’eusebio
8
di michele campisi
12
RESTAURO
Il restauro
in Colombia.
Un caso recente:
il recupero
del Panóptico d’Ibagué
di alessandro pergoli
campanelli
16
di franco zagari
24
PERCORSI
LECORBUSIERIANI
Interferenze
di valerio casali
Grattacieli
33
28
30
SOCIETÀ
E/È COSTUME
Sfida antica,
marketing
contemporaneo
di renato nicolini
numero 37-40, anno VII,
maggio-dicembre 2010
redazione
00136 Roma, via Alfredo Fusco 71/a
tel. 06 35192249-59 fax 06 35192260
e-mail
[email protected]
website: www.mancosueditore.eu
PAOLO VINCENZO GENOVESE (P.V.C.)
architetto, docente presso la School
of Architecture, Università di Tianjin, Cina
MARIA GIULIA PICCHIONE (M.G.P.)
architetto, Ministero per i Beni
e le Attività Culturali
STEFANO GRASSI (S.G.)
avvocato, docente presso la Facoltà
di Giurisprudenza, Università degli Studi
di Firenze
FULCO PRATESI (F.P.)
architetto, presidente onorario
WWF Italia
direttore scientifico: CARLO MANCOSU
vice direttore: ENRICO MILONE
direttore responsabile: FABIO MASSI
MASSIMO LOCCI (M.L.)
architetto, docente presso la Facoltà
di Architettura “Valle Giulia”, Università
“La Sapienza” di Roma
responsabile di redazione: PAOLA SALVATORE
redazione: VALENTINA COLAVOLPE
CARLO MANCOSU (C.M.)
editore
comitato di redazione
FABIO MASSI (F.M.)
giornalista
GIAN LUCA BRUNETTI (G.L.B.)
architetto
GIOVANNI CARBONARA (G.C.)
architetto, direttore della Scuola
di Specializzazione in Restauro
dei Monumenti, Università “La Sapienza”
di Roma
VALERIO CASALI (V.C.)
architetto
LUIGI MAURO CATENACCI (L.M.C.)
architetto
FRANCESCO CELLINI (F.Ce.)
architetto, preside della Facoltà
di Architettura, Università Roma Tre
EUGENIO MELE (E.Me.)
avvocato, consigliere di Stato
ENRICO MILONE (E.M.)
architetto, presidente Centro Studi
Ordine degli Architetti PPC (Cesarch)
Roma
RENATO NICOLINI (R.N.)
architetto, docente presso la Facoltà
di Architettura, Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria
MAURIZIO ODDO (M.O.)
architetto
pubblicità
M.E. Architectural Book and Review S.r.l.
00136 Roma, via Alfredo Fusco 71/a
tel. 06 35192283 fax 06 35192260
e-mail
[email protected]
FRANCESCO RANOCCHI (F.R.)
architetto
abbonamento: 6 numeri – € 60,00
tel. 06 35192256 fax 06 35192264
ANTONINO SAGGIO (A.S.)
architetto, docente presso la Facoltà
di Architettura “L. Quaroni”,
Università “La Sapienza” di Roma
stampa
Tipografia Grafica Artigiana – Roma
PAOLA SALVATORE (P.S.)
architetto
collaboratori
SILVIA CIOLI, architetto
FRANCO ZAGARI, architetto
MICHELE CAMPISI, architetto
LAURA GUGLIELMI, architetto
FRANCESCO MARIA MANCINI, architetto
ARNALDO MARINO, architetto
FRANCESCA ROMANA FIERI, architetto
impaginazione e grafica
LUCIANO CORTESI, ROBERTO DI IULIO,
FABIO ZENOBI
FURIO COLOMBO (F.C.)
giornalista e scrittore
MARIO PANIZZA (M.P.)
architetto, docente presso la Facoltà
di Architettura, Università Roma Tre
LUCA D’EUSEBIO (L.D.E.)
architetto (ambiente)
ALESSANDRO PERGOLI CAMPANELLI (A.P.C.)
architetto
editore
M.E. Architectural Book and Review S.r.l.
00136 Roma, via Alfredo Fusco 71/a
tel. 06 35192255 fax 06 35192260
e-mail
[email protected]
website: www.mancosueditore.eu
IDA FOSSA (I.F.)
architetto
PLINIO PERILLI (P.P.)
scrittore e critico
responsabile trattamento dati
CARLO MANCOSU
in copertina
KOHN PEDERSEN FOX, Shanghai World
Financial Center, Shanghai, Cina
Autorizzazione del tribunale di Roma
n. 235 del 27.05.2004
ISSN 1824-0526
Gli articoli firmati esprimono solo
l’opinione dell’autore e non impegnano
la redazione, la quale è disponibile
a riconoscere eventuali diritti d’autore
per le immagini pubblicate, non avendone
avuto la possibilità in precedenza.
I manoscritti, anche se non pubblicati,
non si restituiscono.
La rivista è consultabile anche sul sito:
www.mancosueditore.eu
Le copie sono distribuite a tutti gli iscritti
agli ordini degli architetti d’Italia, agli
ingegneri edili, enti e istituzioni varie
Questo periodico è associato
all’Unione Stampa Periodica
Italiana
Biennale 2010
People meet in architecture
C
l’opinione
he l’architettura potesse definirsi come “la più noiosa
delle arti” lo affermava nel Settecento
un teorico come Francesco Milizia.
A trasformare la Biennale in spettacolo, sull’onda lunga delle fortune mediatiche del Guggenheim Bilbao di Frank
O. Gehry, era riuscito Massimiliano
Fuksas (analogo successo avevano avuto vent’anni prima la “strada novissima”
e il Teatro del Mondo di Aldo Rossi,
nella Biennale Architettura di Paolo
Portoghesi…).
Con Fuksas lungo le pareti dell’Arsenale
scorrevano in continuità le immagini di
una grande multi visione delle città del
mondo realizzata da Studio Azzurro.
Da allora, il sistema dell’architettura si
è sempre più caratterizzato come il firmamento delle archistar; e, nelle Biennali, da Sudjic ad Aaron Betsky, i progetti rappresentati tradizionalmente con
pianta, sezioni e prospetti sono stati
progressivamente sostituiti dalle instal
Kazuyo Sejima, lazioni e dalle performance artistiche.
direttore della
12. Mostra
Internazionale
di Architettura
(foto: Giorgio
Zucchiatti;
courtesy:
La Biennale
di Venezia)
Kazuyo Sejima
& Associates,
“Inujima Art House
Project”
(operated by:
Naoshima
Fukutake Art
Museum
n.37-40
Foundation;
2010
© Kazuyo Sejima
& Associates)
4
La Biennale appena inaugurata, visitabile fino all’11 novembre, firmata da
Kazuyo Sejima, sembra invitare in un’altra direzione, a giudicare dai saggi che
aprono il voluminoso catalogo. Maurizio Lazzarato (Capitalismo e produzione
di soggettività) cita Felix Guattari, l’“economia del possibile” – vale a dire
l’“economia del desiderio”. «Poiché l’architetto non avrebbe più come obiettivo l’essere artista di forme costruite,
ma si proporrebbe di essere anche il
rivelatore dei desideri virtuali di spazio, di luoghi, di percorso e di territorio, dovrà (…) diventare un artista e
un artigiano del vissuto sensibile e
relazionale».Yuko Hasegawa spiega il
titolo della Biennale (People meet in
architecture) in riferimento a un pensatore un po’ dimenticato negli ultimi
tempi della società dello spettacolo –
di cui è stato acuto critico precorrendo
Guy Debord – come Henri Lefebvre,
e alla sua fondamentale Critica della vita
quotidiana. «Lo spazio dell’utente è “vissuto”, non rappresentato (o concepito).
Rispetto allo spazio astratto degli
esperti (architetti, urbanisti, pianificatori), lo spazio degli atti quotidiani
degli utenti è uno spazio concreto».
Hasegawa ci invita a riflettere sul modo
in cui Lefebvre si riferisce al corpo,
«in termini di recupero dello spazio
sensoriale-sensuale», auspicando «il ripristino di uno spazio per il “non visivo” in forma di “discorso” della voce,
dell’olfatto e dell’udito».
Percorrendo gli spazi dell’Arsenale e
del Palazzo delle Esposizioni (ex Padiglione Italia) ai Giardini, si ha però una
duplice, contraddittoria impressione.
Da un lato proposte in sintonia con le
premesse teoriche appena esposte.
Kazuyo Sejima e il suo gruppo SANAA
sono effettivamente espressione di
una tendenza “non visiva” dell’architettura, fino a un’ambiguità che rasenta la
dissoluzione, confondendo e sospendendo il giudizio dell’osservatore, mantenendo il significato costantemente fluido e mobile. Il grande plastico
dell’isola di Inujima, dove Sejima e
SANAA sono impegnati in un progetto
d’intervento artistico, costruendo padiglioni trasparenti in materiali sperimentali in mezzo alle case spesso abbandonate dei pescatori, con l’intenzione
di frenare l’esodo della popolazione e
di dare all’isola una nuova prospettiva
anche economica, è forse l’installazione che più rimane nella memoria dalla
visita alla Biennale.
Tadao Ando, maestro giapponese della
generazione appena precedente, aveva fatto qualcosa di simile nell’isola di
Naoshima, realizzando un museo d’arte
contemporanea che era anche un albergo in cui il visitatore poteva dormire,
anche in stanze firmate da artisti come
Richard Long. Sejima e SANAA si fermano un gradino prima, senza arrivare
al museo, evitando una proposta troppo definita d’uso, pensando piuttosto
agli abitanti di Inujima che ai suoi visitatori, lasciando fluida la relazione tra
paesaggio tradizionale e turismo culturale. La meraviglia generata dai nuovi
padiglioni cerca di entrare in relazione
con la vita quotidiana dell’isola; come
dimostra il doppio video di Fiona Tan
– in una sala dell’ex Padiglione Italia,
oggi Palazzo delle Esposizioni ai Giardini
(girato il primo dall’alto dell’elicottero
alla scala del paesaggio di Inujima, il secondo invece a terra cercando i volti e
i gesti della popolazione, fino al bruco
che percorre lentamente una foglia).
Un altro video, di Wim Wenders (Se gli
edifici potessero parlare), percorre lentamente – lungo l’arco della giornata,
dall’apertura alla chiusura – gli spazi di
un altro edificio di SANAA, il Rolex
Learning Center dell’Ecole Polytechnique Federale di Losanna, con l’intenzione di dimostrare che «gli edifici, come la gente, sono soggetti al tempo»,
e che alcuni edifici sono «particolarmente gentili e amichevoli, fatti per imparare, leggere e comunicare». La personalità che – assieme a Kazujo Seijima
– emerge con maggiore forza da questa Biennale è però quella di un architetto che appartiene alla storia piuttosto che alla contemporaneità, Lina Bo
Bardi, cui è dedicata una bellissima sala
nel Palazzo delle Esposizioni. La progettista del Museo d’Arte Moderna di
San Paolo del Brasile, e del centro
d’arte SESC Pompeia, morta nel 1992,
ne emerge come la principale precorritrice del modo “gentile” e partecipato di approccio all’architettura. Negli
anni ’50 e ’60 la Bardi innova rispetto
alla tradizione, cui peraltro si riferirà
sempre, del funzionalismo di Le Corbusier, correggendola con le ispirazioni che le vengono dal «popolo brasiliano, che ha libertà di movimento, la
libertà di fare a meno delle istituzioni».
Kazuyo Sejima
& Associates,
“Inujima Art House
Project”
(operated by:
Naoshima
Fukutake Art
Museum
Foundation;
© Kazuyo Sejima
& Associates)
Sotto:
Wim Wenders,
“If Buildings Could
Talk…”, 2010.
Video installazione
3D girato
nell’edificio
del Rolex
Learning Center
of the Ecole
Polytechnique
Fédérale
de Lausanne
(produced by:
Neue Road
Movies, Berlin;
post-produced by:
Cinepostproduction,
München;
with the support
of Rolex;
© Neue Road
Movies 2010)
Lina Bo Bardi,
“Museu de Arte
de São Paulo MASP”,
1957-1968.
Concerto
al Belvedere, 1992
(foto: Divulgation
Itamar Miranda;
Instituto Lina Bo
e P.M. Bardi,
San Paolo, Brasile)
Il principio della libertà corregge il formalismo modernista.«Nelle civiltà orientali come quella del Giappone e della
Cina – scrive Lina Bo Bardi – si osserva una coesistenza tra una posizione culturale del corpo (il corpo come spirito)
e l’atto fisico. Questa coesistenza si ritrova anche in Brasile». Tra le installazioni contemporanee, appare coerente a questo spirito la sala dello Studio
Mumbai Architects, che ha trasportato
il proprio laboratorio a Mumbai, così
come si trovava, carico di lavori in corso
e di artigianalità del legno, nell’Arsenale
di Venezia. «L’ambiente in cui viviamo
è uno spazio che creiamo e abitiamo
in modo inconscio…».
Purtroppo, non tutta la Biennale procede con questa coerenza. Si ha l’impressione che, invitati a fare un passo di fianco, se non indietro, a proporre il lavoro
dell’architetto come maieutica del senso
della possibilità e della trasformazione,
uscendo dalla trincea estetica com’era
uscito negli anni Sessanta dalla trincea
funzionalista, la maggior parte degli invitati faccia al contrario un passo avanti
Sopra:
Studio Mumbai
Architects, “Studio
Installation”, 2010
(© the authors)
A destra:
Transsolar
& Tetsuo Kondo
Architects,
“Cloudscapes”, 2010
(foto: Frank Ockert)
n.37-40
2010
6
Centro pagina:
Olafur Eliasson,
“Your split second
house”, 2010
(© Olafur Eliasson)
nella direzione ormai consueta della
performance para-artistica. In qualche
caso con forza ed efficacia (il Balancing
Act di Anton Garcia-Abril & Ensamble
Studio che interrompe, con una colossale doppia trave incrociata retta a un
estremo da una molla, il percorso dell’Arsenale; o i tubi flessibili che spargono
acqua, con effetto di gocce d’argento
nel buio, di Olafur Eliasson…). In altri
casi con risultati più che discutibili,
come nell’ambiziosa istallazione di
Transsolar & Tetsuo Kondo Architects,
che vorrebbe farci passeggiare sopra
una nuvola sottoponendoci a una sauna
poco gradita col caldo della fine d’agosto veneziana. Mentre ci si trova a divagare con la testa e i piedi tra le nuvole,
è difficile non domandarsi chi si occupi
concretamente di architettura, dei problemi di tipologia, di urbanistica, di sostenibilità ambientale, che stanno riemergendo un po’ dovunque tra scoppi
delle bolle immobiliari, crisi dell’illusione di ricchezza facile, carenza drammatica di case a basso costo soprattutto
per i giovani e gli immigrati…
Un’analoga duplicità caratterizza i padiglioni nazionali, che rispondono ciascuno a proprio modo al tema dell’incontro
della gente mediato dall’architettura.
Dominique Perrault usa il padiglione
francese per forti immagini metropolitane; gli svizzeri riflettono sui ponti alpini,
sulla mediazione tra tecnologie e paesaggio; l’Inghilterra, sotto il titolo emblematico di Villa Frankenstein, ci spinge a
riflettere su Venezia, riprendendo Ruskin;
il Giappone riflette sul “metabolismo
delle città”, cioè sulla durata media di
una costruzione e sulle conseguenze
che ne derivano; il Bahrein (padiglione
Reclaim di Noura Al Sayeh e Fuad Al
Ansari, premiato con il Leone d’Oro)
ha trasportato a Venezia, affidando la
documentazione del paesaggio costiero in cui si inseriscono alle fotografie di
Camille Zakharia, due baracche in legno
di pescatori, dalle assi sconnesse, per
farci riflettere sul ruolo che ancora oggi
hanno le “architetture senza architetti”
care a Giuseppe Pagano e Mario Ridolfi… Il padiglione Italia, curato da Luca
Molinari, urta contro un limite non facilmente prevedibile. La voglia di dire
tutto, per documentare quanto è accaduto negli ultimi vent’anni, approda al
risultato di apparire pieno come un
uovo, se non un po’ agnostico. È una
Biennale nella Biennale, che però fa
parte per se stessa sottraendosi alla
A sinistra e sotto:
Noura Al Sayeh
e Fuad Al Ansari,
Kingdom of Bahrain
(foto: Camille
Zakharia; © Ministry
of Culture – Kingdom
of Bahrain)
Si ringrazia
per la collaborazione
La Biennale
di Venezia - Archivio
Storico delle Arti
Contemporanee
domanda People meet in architecture.
Peccato, perché in Italia (penso soltanto alla discutibile concezione di nuovo
spazio pubblico proposta di fatto dalla
ricostruzione dell’Aquila, con la gente
costretta a incontrarsi nei centri commerciali…) gli spunti per una discussione non sarebbero mancati. Il Padiglione
Italia non è comunque senza elementi
d’interesse, come la parte dedicata ai
“beni sequestrati alla mafia”, e in particolare la nuova sede degli uffici comunali a
Castelvetrano (2005-07) di Santo Giunta,
Orazio La Monaca, Leonardo Tilotta e
Simone Tilone (che, per i principi architettonici che la ispirano,è anche un affettuoso omaggio alla memoria di Pasquale
Culotta, che ci ha lasciato da poco…).
R.N.
n.37-40
2010
7
Piet Oudolf,
il Giardino
delle Vergini,
Venezia, 2010.
L’immagine mostra
la griglia e le aree
disegnate sul terreno
per collocare
i gruppi di piante
Tutte le immagini
contenute in questo
articolo mostrano
il Giardino delle
Vergini realizzato
per la Biennale
di Venezia
(© Piet Oudolf)
Un ggiardino p
poetico alla Biennale:
conversazione con Piet Oudolf
P
l’opinione
iet Oudolf è l’autore del Giardino delle Vergini realizzato
all’Arsenale di Venezia in occasione
della dodicesima Biennale di Architettura. La giuria della Biennale ha conferito una menzione d’onore al giardino,
«delicato e impressionistico nella sua
accurata orchestrazione», collocato fra
n.37-40
2010
8
gli edifici industriali dei cantieri navali e dei magazzini marittimi. Un sito
fino ad oggi abbandonato di per sé di
grande fascino, che il giardino completa magnificamente.
Direttamente coinvolto da Kazuyo Sejima, il curatore della Biennale di Architettura, che conosce e apprezza il suo
lavoro, Oudolf ha realizzato per la prima
volta nella storia della Biennale un giardino. Questo è stato di grande stimolo per lui, benché vi fossero dei tempi
molto ristretti e un budget assai limitato: «Fare un giardino in quattro mesi è
stata una bella scommessa. Un progetto di corsa e una realizzazione di corsa».
Piet Oudolf, sempre molto attento al
contesto naturale che ospita i suoi giardini, utilizza prevalentemente le erbacee perenni di tarda fioritura disegnando geometrie di forme e colori accostando foglie, fiori e steli in grande
varietà nel desiderio di lavorare anche
con la natura esistente. Infatti, anche in
questo caso, ha lasciato intatta parte
della folta vegetazione selvatica già presente sul sito. Quindi chi attraversa il
piccolo giardino con i rovi di more sullo sfondo e le variegatissime bordure
fra le alberature centenarie non ne percepisce esattamente i limiti. Oudolf,
mascherando un po’ la sua scelta poetica, racconta che una delle prime operazioni per la preparazione del sito per
ospitare il nuovo giardino è stata quella di liberarlo dai rovi. Questa operazione sembra abbia costituito un capitolo
di spesa oneroso sul ridotto bilancio
a disposizione: «Avevamo un piccolo
budget e dovevamo liberarci dai rovi.
Allora abbiamo cercato di far funzionare le due cose». La successiva operazione per la realizzazione del giardino
ha visto l’utilizzo del metodo della rappresentazione a terra del progetto sul
sito. In base al disegno di progetto viene
realizzata una griglia di 2 × 2 m come
riferimento per apportare direttamente sul suolo il disegno della sistemazione delle piante. Molti sono i disegni di
dettaglio per la piantumazione di un singolo gruppo di piante che arriva alla
definizione del numero preciso di piante da collocare. Molto soddisfatto dell’esito del giardino, Piet Oudolf intende
seguirne le evoluzioni durante i prossimi mesi venendo di persona a Venezia.
Per il momento si nota che nel giardino sono assenti le sedute. Alla richiesta di come mai non vi fossero, risponde che «in verità mi avevano promesso
delle sedute, forse arriveranno. Credo
ci saranno degli sponsor interessati.
Altrimenti non avrei fatto un sentiero
così largo. La preparazione del terreno
e la realizzazione del sentiero hanno
costituito una parte importante della
spesa. Per caso mi sono incontrato con
Robert Hammond e quindi il giardino ha avuto la fortuna di ospitare un
Chance Encounter». Si tratta di un happening ideato da Lisa Bielawa e Robert
Hammond, entrambi borsisti 2010 dell’Accademia Americana di Roma, che
hanno organizzato un esperimento urbano teso alla rivitalizzazione artistica
e urbanistica del Lungotevere di Roma.
Piet Oudolf
Piet Oudolf, uno dei più noti paesaggisti a livello
internazionale, è nato a Haarlem in Olanda nel 1944.
Ha lavorato come barista, pescivendolo, metalmeccanico e cameriere prima di essere assunto in un vivaio a 26 anni. Segue corsi di progettazione e gestione
dei giardini aprendo il suo studio di progettazione di
giardini nel 1976. Nel 1982 si trasferisce con la moglie
Anija in una fattoria a Hummelo, dove ancora vive e
lavora, in modo da poter dedicare più tempo a sperimentare con le piante e aprendo un vivaio. I suoi lavori hanno ispirato la nascita negli anni Novanta del movimento New Wave Planting, noto anche
come New Perennial. Egli stesso ha aderito a questo movimento che cerca l’abolizione dei dogmi
nella progettazione dei giardini usando masse di piante graminacee perenni disposte naturalmente a gruppi e masse di colori, e ne è uno delle firme più rappresentative.
La ricerca sperimentale di Piet e Anija si è concentrata prevalentemente sulle piante perenni, con
attenzione alla loro forma, dando nome a oltre 70 nuove piante. Da questa esperienza è nata
recentemente Future Plants una società specializzata sulla selezione, coltivazione, allevamento,
protezione e vendita delle piante che sono utili e hanno tutte le qualità necessarie per l’abbellimento e il verde pubblico.
Tra le sue pubblicazioni si ricordano: Planting Design: Gardens in Time and Space (2005) in collaborazione con Noel Kingsbury, Planting the Natural Garden (2003) in collaborazione con Henk
Gerritsen, Dreamplants for the Natural Garden (2000) e More Dreamplants in collaborazione con
Henk Gerritsen, Designing With Plants (1999) in collaborazione con Noel Kingsbury, Designing
with Grasses (1998) in collaborazione con Michael King.
Piet Oudolf è stato pregiato della medaglia d’oro al Chelsea Flower Show di Londra nel 2000, della
medaglia d’oro Veitch Memorial dal Royal Horticultural Society nel 2002, dell’Award for Excellence
in progettazione dalla commissione d’arte della città di New York, del Dalecarlica Award 2009
dalla commissione Swedish Park, il premio dell’Association of Professional Landscape Designers
nel 2010 per il contributo alla progettazione dei giardini e, infine, della menzione speciale 2010
della dodicesima Biennale di Venezia per il Giardino delle Vergini all’Arsenale.
Tra i suoi progetti principali vi sono giardini per spazi pubblici, ma anche per abitazioni private
e uffici in Olanda, Gran Bretagna, Germania, Svezia e Stati Uniti: l’ingresso del giardino botanico
De Uihof a Utrecht, il giardino del centro Reuma Verpleeghuis a Rotterdam, la riserva naturale
Pensthorpe nel Norfolk e la RHS Wisley nel Surrey, alcuni giardini al Millennium Park a Chicago
e il Battery Park e la High Line a New York, il Lurie Garden a Chicago collaborando con Frank
Gehry e Gustafson Guthrie Nichol.
n.37-40
2010
9
Cento sedie rosse pieghevoli sono state lasciate sulla banchina del fiume per
studiare le reazioni e l’uso che lo spettatore ne fa mentre assiste alla pièce
musicale a sorpresa di 30 minuti di Lisa
Bielawa. Chance Encounter è stato replicato negli spazi antistanti il MAXXI in
occasione dell’inaugurazione e appunto
alla Biennale di Venezia.
A proposito del suo recente giardino
realizzato sulla High Line a Manhattan
– giardino fondato e fortemente voluto da Robert Hammond e Joshua
David – Oudolf ha più volte detto che
si è trattato della cosa più audace che
avesse mai fatto, «praticamente ho avuto a che fare con un ambiente con una
limitata ecologia del suolo proprio al
centro di uno dei contesti urbani più
“duri”, vissuto da persone che con
molta probabilità non usciranno mai
da New York City. Ma la High Line è
anche fortemente concettuale: riconnette con qualcosa di perduto nel tentativo di avvicinare le persone a un tipo
di bellezza che forse non hanno mai
sperimentato prima».
Lista delle essenze utilizzate per il Giardino delle Vergini
n.37-40
2010
10
PERENNI
Achillea “Walter Funcke”
Aconitum wilsonii
Agastache “Blue Fortune”
Anemone “Pamina”
Anemone robustissima
Aster ageratoides “Asran”
Aster amelius “Sonora”
Aster “Little Carlow”
Aster novae-angliae “Alma Potschke”
Aster “Oktoberlicht”
Cimicifuga ramosa “Atropurpurea”
Echinacea “Fatal Attraction”
Echinacea purpurea mix
Echinops bannalicus “Taplow Blue”
Eupatorium rugosum “Chocolate”
Eupatorium maculatum
“Atropurpureum”
Genziana trifola “Royal Blue”
Helenium “Rubinzwerg”
Heuchera micrantha “Palace Purple”
Kirengeshoma palmata
Lobelia vedraiensis
Persicaria amplexicaulis “Alba”
Persicaria “Orange Field”
Scabiosa columbaria “Butterfly Blue”
Scutellaria incana
Sedum “Matrona”
Stachys officinalis “Hummelo”
Tricyrtis formosana “Purple Beauty”
ANNUALI
Ammi visnage “Green mist”
Dahlia coccigea
Dahlia “North Star”
Nicotiana sylvestris
Nicotiana “Tinkerbell”
A ogni gruppo di piante è attribuito un numero
che identifica un’essenza specifica
ERBACEE
Molinia caerulea “Edith Dudzus”
Molinia caerulea “Heidebraut”
Molinia caerulea “Moorhexe”
Molinia caerulea “Transparent”
Panicum virgalum “Rehbraum”
Panicum virgalum “Heavy Metal”
Pennisetum alopecuriodes “Virdiscens”
Sesleria autumnalis
Piet Oudolf, che non ha fatto studi particolari e lavora con l’istinto, è riconosciuto come uno dei più geniali e
innovativi paesaggisti contemporanei.
È definito “un naturalista” per la propensione all’utilizzo di piante erbacee
selvatiche quasi a voler nascondere la
razionalità del progetto del giardino.
Le piante che usa sembrano essere selvatiche, mentre i giardini che fa non lo
sono affatto. Il suo approccio genera
progetti di giardini molto “naturali” che
non partono mai da affermazioni aprioristiche bensì rispondono ai materiali
presenti nel paesaggio in cui si inseriscono: il suo clima, la sensibilità del
cliente e la complessità delle richieste.
Di fronte alla domanda: che effetto fa
al fondatore del movimento New Perennial fare un giardino in Italia, patria
della tradizione formale nell’arte dei
giardini, Oudolf ha tenuto a precisare
innanzitutto di non esserne il fondatore
ma di aver solo aderito al movimento.
Secondo Oudolf «nel fare giardini vi
sono tanti dogmi, quello che mi interessa è proprio eliminare i dogmi, allontanarmene, essere libero. Se una cosa
non piace è giusto non fare quello che
non ti piace». Il movimento New Perennial è spesso associato al paesaggista irlandese William Robinson (18381935), pioniere del giardino selvatico in cui dominano le piante perenni
insieme a quelle autoctone di un sito
al fine di creare paesaggi in linea con
la tradizione architettonica del movimento inglese degli Arts and Crafts.
Potremmo dire che Oudolf ne sia l’erede contemporaneo.
Hai lavorato molto nell’Europa del
nord, nel Canada e Stati Uniti. È stata
la prima esperienza in Italia? «Sì. I miei
giardini sono adesso più noti in Italia.
In Italia però ho visto che non sono abituati, in termini di manutenzione, al mio
tipo di giardinaggio. Venezia è al limite
tra il Mediterraneo e l’Europa quindi ho
usato piante che conosco adatte a climi
continentali. Le persone dei climi continentali sono motivate verso questo tipo
di giardino, mentre in Italia vi è più consuetudine per i giardini formali».
Oudolf e la moglie hanno un vivaio dove
fare le sperimentazioni con le piante.
A Venezia non hanno utilizzato le piante del loro vivaio che è pensato soprattutto per sperimentare, ma hanno fatto
riferimento a dei vivai olandesi per
poter avere un controllare diretto.
Il loro vivaio apre al pubblico durante
i Grass Days di fine estate e ai primi di
autunno. È il periodo in cui sono particolarmente interessanti i suoi giardini.
Come dice lui stesso «morire in maniera interessante è altrettanto importante quanto vivere». I Grass Days sono
eventi di grande interesse perché il
vivaio vanta circa 70 nuove specie e
offre la possibilità di vedere non solo
le piante in vaso ma anche la loro resa
sul terreno, in un’apposita zona della
loro proprietà.
Pensi che nel fare giardini oggi sia necessario un approccio più sostenibile?
«Penso che sia bello vedere il lento
cambiamento che hanno le piante.
Lo trovo molto istruttivo». In effetti
Oudolf ha nei confronti del giardinaggio un atteggiamento profondamente
filosofico se non addirittura religioso:
«Mi piace mettere le persone in contatto con i processi della loro vita.
Quello che richiede una vita intera,
una pianta lo sperimenta in tempi più
brevi. In questo senso il giardinaggio è
un microcosmo del ciclo vitale». Nel
caso del Giardino delle Vergini si può dire
che rappresenti anche una perfetta
trasposizione del tema della Biennale,
People meet in architecture, dall’architettura al paesaggio attraverso una piacevole pausa tra padiglioni e architetture nel poetico scenario dell’Arsenale.
Silvia Cioli e Luca D’Eusebio
n.37-40
2010
11
Crollo di parte
della volta
della Domus Aurea,
avvenuto
il 30 marzo 2010
Sotto: l’interno
della Domus Aurea
Roma, ovvero monumenti e potere
beni
culturali a cura di Maria Giulia Picchione
Il
n.37-40
2010
12
30 marzo di quest’anno, come
forse ci si poteva attendere da
qualche parte di questa antica città, crollava una porzione di una vecchia volta
adiacente i leggendari anfratti della
Domus Aurea neroniana. Questa, sia pur
piccola cosa, era parte delle strutture,
tutt’oggi esistenti del terrazzamento
voluto da Traiano ai primi anni del II secolo d.C., costruito lì per potervi poggiare la sontuosa architettura delle sue
terme; forse anch’esse nate dalle idee
di Apollodoro damasceno. A distanza
di un po’ di tempo, sopiti i clamori e le
inevitabili indignate costernazioni, insieme ai residui sembrano oggi già sotterrate anche le più caritatevoli e insolite
attenzioni dei giornali. Del resto, nel
contemporaneo, tutto sembra essere
mosso dalla “notizia” e com’è noto dal
più consueto paradosso mediatico, se
una cosa non la trovi su quelle pagine
vuol dire che non è mai accaduta. Nel
nostro caso vuol dire che è accaduta
per i tre giorni che hanno accolto gli
immancabili commenti e i solonici responsi sulle taumaturgie indispensabili
a questa città che… ahimè non è più
la stessa!
Tra la polvere dei pavimenti di Colle
Oppio, lì accanto all’ingresso misterioso della Domus neroniana, rimane molto
più di quanto faccia credere l’informe
mucchio di residui; resta, piaccia o no,
una strana idea della Roma contemporanea, l’inconsolato destino della città.
Al sommo della questione esiste una
evidente conflittualità tra “passato” e
contemporaneo.Checché ne voglia pensare un certo modernismo destrorso
che vuole ancora porre, al di fuori del
tempo, la figura di un umanesimo nostalgico fatto di concezioni in sé conflit-
tuali come spiritualità dei valori umani
e materiale sopravvivenza. Una destra
dirigistica che trova nella relazione essenziale tra indirizzo del vertice istituzionale e politica per la base civica l’unica opposizione etico-politica al “parlamentarismo culturale”: uno spettro che
si aggira(va) quanto meno nel sottosuolo di Roma. In verità, tanti si vorrebbero illudere della sua reale capacità rigeneratrice a fronte di una imbarazzante
empasse davanti cui parcheggia l’idea di
“sinistra”. Una supremazia che in quarant’anni di solide istituzioni culturali e
relate uniformi sociali resiste nell’idea
nostalgica e nella memoria epifenomenica di sia pur gloriose generazioni.
Dov’è quella bella città; ma dov’è il
Bello in questa città? Dove le sue sempre più arcaiche sofferenze postbelliche
da cui fumavano, tra i ruderi macabri del
grande errore, speranze nascoste di civiltà. Forse già in quegli stessi momenti,
covava, impercettibile e nascosta, una
ben altra rovina. È il paradosso dell’Italia
moderna a partire dagli anni Cinquanta: viva nelle ruderi sembianze di interi
quartieri storici; San Lorenzo, mortale
nelle variopinte e policrome accelerazioni dei sobborghi agricoli occupati.
Tanto che pare assai difficile parlare
della città storica prescindendo dalla sua
esistenza metropolitana che la include
come un nucleo inquieto, che la muta
e la modifica in una fibra inattiva secca
e legnosa, intorno alla quale ruotano
vortici di sostanze sempre più estranee.
La “moltitudine” ha definito questo processo. Ha costruito in questo suolo la
dinamica corruttrice del consenso.
La città nella sua storia ha sempre vissuto, con contiguità e sentimento di appartenenza, la sua esistenziale condizione monumentale. La società, in qualche
modo, ne era parte organica anche a
dispetto del potere che ne ha sempre
subìto un’attrazione ferale, evocandola
nel proprio immaginario come la propria massimizzabile rappresentazione;
non ultima la città napoleonica, né quella umbertina. Ai segni di un potere strettamente legato alla sostanza tangibile dei
luoghi si è in seguito sostituito un meccanismo di controllo più etereo e rarefatto che si sostanziava nell’Immagine
quale mezzo del contatto sublime.
Oggi l’evoluzione del rapporto tra potere e monumento si è quasi annullato
abbandonando quest’ultimo a un autonomo destino di inutile contenitore, di
incoerente presenza nel tessuto degli
scambi sociali della città. La condizione
di romantica suggestione, anacronistica
e per certi versi surreale, rimane affidata a un precario e residuale apparato
giuridico del vecchio Stato che a suo
tempo, con cognizione democratica ne
aveva definito la categoria sostanziale
nello status di “bene”; una identità che
in questi giorni è difficile collocare esattamente nella sua originaria vestizione.
Prova ne è il lento abbandono del Ministero creato negli anni Settanta dal-
l’intervento di una generazione intellettuale che mostrava ancora di credere
alla idea salvifica di “tutela” come avamposto della civiltà.
Oggi si parla sempre più astrattamente
del patrimonio come luogo di un ennesimo veicolo da immettere nella fluidità delle relazioni produttive. Il lessico
con cui si vuole sostanziare l’innovazione del settore rappresenta sempre
più evidentemente la distanza che corre
tra il sistema dei valori dell’età classica
e il contemporaneo. Qual è lo spazio
oggi possibile della grande tradizione
che, dall’Umanesimo all’Illuminismo, ci
ha definito nella coscienza più importante della nostra cultura e della sua
espressività linguistica?
Determinato dalla grande recessione
economica, seconda solo a quella del
’29, il destino dei monumenti si è posto
sempre più in coincidenza con l’obbligo di una loro autonoma capacità di sopravvivenza e di idoneità produttiva.
Quello che era stato l’assunto etico
sancito dall’articolo 9 della Costituzione,
l’obbligo di fatto da parte della Repubblica alle provvidenze indispensabili per
la salvaguardia dell’identità materiale:
paesaggio, patrimonio storico e artistico è sempre più disatteso. Come per
gli altri articoli “fondamentali” è sottoposto alle bordate di insofferenza dei
“manovratori” al comando negli ultimi
due decenni. Pesa qui non solo il fatto
che su di essi non sia più stata licenziata una efficace politica della risorsa;
né sul primario, né sullo straordinario, quanto piuttosto l’assunzione di un
ruolo negativo. Un recente rapporto
(«Giornale dell’Arte», n. 298, maggio
2010, p. 10) chiarisce il peso dell’inefficacia gestionale del denaro disponibile in considerazione dei 1.843 miliardi
di euro di residuo passivo per il 2009.
La situazione è per altro comune a tutti
i ministeri, il più compromesso dei quali,
per paradosso è quello dello Sviluppo
Economico dove i residui passivi arrivano quasi al 60% degli stanziamenti di
bilancio. Nel corso degli ultimi esperimenti dei nuovi ordinamenti e assetto
ministeriale, i tentativi sono culminati
con la formazione di società finanziarie parzialmente esterne all’amministrazione pubblica che avessero tali capacità di spesa.Anche in questo caso, a parte
di qualche strategico impiego, per insondabili motivi, la giacenza paralitica delle
attività è stata quasi pari al silenzioso
lavorio che vi si svolge ai consueti margini. Rimangono in piedi alcune certezze: il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, svuotato del suo personale
non più sostituito nel corso del tempo,
è stato di fatto deposto da qualsiasi capacità ed efficacia; ridotto ad affrontare
la sempre maggiore aggressività delle
L’interno
del Colosseo
Sotto:
il Portico d’Ottavia
componenti territoriali. La strategia in
atto almeno da poco più di un decennio
ha una data topica nel 1997. Con la
“legge Bassanini” si erano infatti determinati, con l’ultima concordia generale
del Parlamento, condizioni ideali per innovare seriamente il settore. Anche
questo esperimento, che comunque
avrebbe mostrato forte carattere propositivo, ancora oggi non pare aver avuto esito di completezza. Varie istanze
hanno spinto al mantenimento di uno
status quo da cui non appaiono esimersi le colpe dello stesso mondo professionale e intellettuale dentro l’istituzione: un patrimonio umano ridotto
troppo spesso a gerarchiche carriere
d’apparato.
Il mondo dei beni, intanto, una volta
decaduto nell’inutile, poteva non più
rappresentare intralcio, come poi diventato, all’esercizio dello sviluppo,
dell’occupazione e rigenerazione fondiaria del territorio. L’età post-liberale ha di fatto sovra passato l’idea del
patrimonio come struttura della sfera
pubblica a beneficio dell’azione speculativa in funzione del consolidamento
finanziario. Il ruolo del presente apparato bancario, quanto più lontano ed
estraneo all’etica sociale che in qualche
modo vi sopravviveva ancora negli anni
Sessanta, ha determinato anche per i
settori a sé ignoti e lontani alla pratica finanziaria, vincoli di redditività.
Comuni, ministeri, Regioni, enti appositi, fondazioni, si sono fatti in quattro
per dimostrare la assai stupida idea dei
“giacimenti culturali”. Come se di fatto
non avessero, i monumenti di Roma,
nessun ruolo nella mobilità turistica.
Si è poi scoperto che nessuna istituzione è stata in grado di attribuirsi conti
economici in parità.
n.37-40
2010
13
Il MACRO
(Museo d’Arte
Contemporanea
di Roma)
Sotto:
il MAXXI
(Museo Nazionale
delle Arti
del XXI secolo)
n.37-40
2010
14
L’estemporaneità con cui il potere politico ha assunto la disciplina adesso
rimbalza da un esperimento all’altro:
oggi potrà andare alla grande un bravo
manager; poi una società finanziaria,
poi ancora – perché non vendere tutto? Ma a chi, e cosa? Non possono aversi dubbi sul fatto che il monastero di
Pizzighettone, luogo caro al paradosso politico, soprattutto se mancante
da svariati decenni di manutenzione,
non rischi minimamente la sua incerta
e ruderale sopravvivenza marginale.
Certamente più attraente una spiaggia,
una galleria già restaurata dove portare invitati e convegnisti: un destino
ancor più risibile dello sfortunato monastero.Quanto dovremo ancora aspettare? Quanti esperimenti?
Il settore, quindi, per tale scarsa capacità competitiva sarà ben al riparo dai
sostegni allo sviluppo, lasciando molta parte del suo costrutto alla speranza di una coscienza civica sempre più
analfabeta.
Da tutto questo non può che sopravvivere l’idea di città turistica. Quali
altri destini si è in grado di immaginare infatti? Roma ne assume il portato
più esemplare. Quel tessuto di quartieri, ricco degli strati più multiformi
e degli eventi singolari, finisce in mano
ai torpedoni: gli unici che hanno oggi
il diritto di circolazione libera e indefinita tra le strade della vecchia città.
Le trasformazioni si misurano su queste intenzioni. Spazi che si possono ora
recludere con provvidenziali cancellate che ne evitino attività di mantenimento. Vi si passa sotto, a distanza per
tragitti studiati al massimo del risultato col minimo degli sforzi. Il Colosseo
finché tiene così com’è, Veiovis: questo sconosciuto; le pozze del Portico
di Ottavia, i semi ponteggi della Torre
dei Conti. Le notti che ormai calano
pericolosamente nel buio; forse ci salverà l’involontaria comicità di un “suono e luci”. I Fori sono colti da un meritato sonno. Sono scenari questi che
non partecipano all’immaginario turistico. Non risiedono né permangono
nel trascorso dell’esperienza di viaggio; non più di un piatto di pajata o di
un’asfittica carbonara.
Roma intanto trova la sua nuova vocazione modernista! La liberazione da
quel passato, la cancellazione di quel
“parlamentarismo culturale” porta distintamente la cifra neo-futurista della
nuova epoca: multietnica, multiformale, eccentrica, a volte americana e informale, questa volta però fuori dagli
studi artistici del Prenestino. Si compiono i processi di lungo cammino
con l’arte per la riverente moltitudine che a frotte occuperà le sale impercorribili dei nuovi musei d’arte moderna; involucri luciformi e turpidi ben
riparati dal corrosivo materialismo:
il Macro-Mattatoio, il MAXXI. La suggestione al potere è un’efficiente macchina organizzativa pronta a monetizzare l’evento. È chiaro che a partire da
qui non può vedersi conflittualità tra il
passato e il contemporaneo. Tutti gli
spazi vanno bene – al contemporaneo.
È il passato che mostra sempre più i
segni di un logoro rapporto con la città,
che si dimostra sempre più abbandonato all’estemporanea iniziativa di istituzioni passatiste. L’idea dello Stato,
l’anglosassone modello delle “comunità” resistito alla dinamica della comunicazione appartengono di fatto a un’archeologia socialogica in cui ha sempre
meno terra l’individuo.
Vale a questo punto la crudele rassegnazione poetica di Pier Paolo Pasolini:
(…) questo cielo
di bave sopra gli attici giallini
che in semicerchi immensi fanno velo
alle curve del Tevere, ai turchini
monti del Lazio… Spande una mortale
pace, disamorata come i nostri destini,
tra le vecchie muraglie l’autunnale
maggio. In esso c’è il grigiore del mondo,
la fine del decennio in cui ci appare
tra le macerie finito il profondo
e ingenuo sforzo di rifare la vita;
il silenzio, fradicio e infecondo…
Michele Campisi
restauro a cura di Giovanni Carbonara e Alessandro Pergoli Campanelli
(San Bonifacio de)
Ibagué (del Valle
de las Lanzas),
il “Panóptico”:
vista del cortile
interno dopo
i recenti lavori
n.37-40
2010
16
Il restauro in Colombia. Un caso recente:
il recupero del Panóptico d’Ibagué
L
a disciplina del restauro architettonico non è
certo sconosciuta in Colombia. Lo dimostrano
i tanti interventi degli ultimi anni, specialmente quelli realizzati nei siti turistici più noti, laddove il risalto provocato
dai numerosi riconoscimenti internazionali (quali, ad
esempio, i prestigiosi inserimenti nella lista del patrimonio
mondiale dell’UNESCO, come è avvenuto per il porto, la
fortezza e i monumenti storici di Cartagena) ha attivato
ingenti risorse economiche.Tuttavia, come spesso accade,
l’aumento degli investimenti non ha automaticamente
generato risultati altrettanto positivi per la conservazione
e il restauro dei principali monumenti. Questo perché la
direzione – oculata o meno – di ogni intervento è rimasta, nella maggior parte dei casi, affidata all’iniziativa e alla
capacità dei singoli progettisti, non sempre versati nel
campo conservativo.
Attualmente in Colombia non esistono, infatti, specifiche
normative sui beni culturali né tantomeno strutture di tutela paragonabili a quelle attive in Italia da oltre un secolo.
Vi è, però, sia a livello teorico che professionale, un sempre
maggior interesse per le tematiche della conservazione e
del restauro. Fra gli architetti colombiani che si occupano di restauro, uno dei progettisti più attivi e attenti alle
preesistenze storiche è Alberto Samudio Trallero, direttore del corso di specializzazione in Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico dell’Università di Bogotá
“Jorge Tadeo Lozano”.
I suoi lavori – seppur sempre d’alta qualità – sono esemplificativi d’un procedere altalenante che, in assenza d’un
sistema pubblico di controllo e indirizzo, di volta in volta
si conforma sulle diverse esigenze d’una committenza,
ora istituzionale ora privata. È un approccio strettamente
dipendente dalle capacità e dalle sensibilità personali piuttosto che dall’applicazione d’una metodologia rigorosa e
condivisa. Alcuni lavori sono, infatti, improntati al rispetto
dell’autenticità del bene sul quale s’è intervenuti, con inserzioni delicatamente riconoscibili, come nel restauro del
seicentesco bastione di Santa Catalina, realizzato nel 2004.
Altri suoi lavori, invece, sono tesi maggiormente alla valorizzazione d’importanti monumenti attraverso l’introduzione
di nuove funzioni d’uso (è il caso del restauro del settecentesco Palazzo dell’Inquisizione trasformato, fra il 1996 e il
2003, nel nuovo Museo Storico di Cartagena, o di quello
della cattedrale e del chiostro di San Domenico, attuale sede
del Centro per la Formazione e la Cooperazione Spagnola).
Vi sono poi altri interventi che, pur eseguiti su preesistenze
storicamente connotate, col restauro hanno poco a che
vedere e che, anzi, rischiano di trasformare, lentamente ma
inesorabilmente, il tessuto minore dei centri storici.
Lo stesso rischio, ugualmente, si potrebbe verificare anche
in Italia se i progettisti fossero lasciati in balia di se stessi
e della sola committenza, senza l’ausilio di alcun controllo
pubblico (questi sono solo alcuni fra i tanti pregi di un sistema di tutela come quello italiano, spesso criticato ma che,
Cartagena, il “Palacio
de la Inquisicìon”
(fine del XVIII sec.)
sede dell’attuale
Museo Storico
dopo i restauri
proprio nel confronto con altre realtà straniere, mostra
tutto il proprio valore).
Uno dei più interessanti restauri attualmente in corso di
esecuzione in Colombia riguarda l’area dell’ex penitenziario d’Ibagué. Il processo che ha portato alla realizzazione dell’intero intervento, su progetto dell’architetto Luis
Humberto Duque Gómez, è stato assai lungo: vale tuttavia la pena ripercorrerlo per comprendere le molte difficoltà che incontrano simili operazioni in Colombia.
Tutto ha inizio nel lontano 1987, quando il complesso venne
inserito fra i pochi immobili riconosciuti quali patrimonio
histórico y cultural del Paese (risoluzione n. 10 del Consiglio
Nazionale dei Monumenti). Dovranno poi passare altri dieci
anni perché il Panóptico venga dichiarato, nel 1997, monumento nazionale e, un anno dopo (risoluzione n. 752 del
1998), bien de interés cultural de carácter nacional.
È però solo nel 2001 che il penitenziario viene definitivamente chiuso e iniziano, di fatto, 14 anni dopo il riconoscimento del valore storico-architettonico dell’intero complesso, le procedure operative per la sua conversione in museo.
Da sinistra:
facciata principale
e dettaglio
del portale barocco
Sotto:
vista del cortile
interno e del portico
del secondo piano
L’episodio, anche dal punto di vista sociale, fu certamente
rilevante. Non a caso proprio nel 2004 Ibagué viene eletta
capitale andina dei diritti umani e della pace. Si giunge così
al 2005 quando, finalmente, si apre il cantiere del Panóptico i
cui lavori, ad oggi, sono conclusi per il solo nucleo centrale.
Basta però leggere già l’intestazione del cantiere, Restauración integral obra nueva paisajismo museografia y proyectos
técnicos del panoptico de Ibagué, per cogliere la complessità
dell’intervento e la coesistenza di diverse istanze, non tutte
necessariamente riconducibili al restauro.
n.37-40
2010
17
Cartagena,
cattedrale
di Santo Domingo,
facciata principale
prima e dopo
i lavori di restauro
Sotto:
Studio Samudio,
progetto di restauro,
prospetto principale
e pianta del primo
e del secondo piano
L’edifico principale dell’ex complesso penitenziario, dalla particolare pianta cruciforme, è meglio noto come
Panóptico. Il nome deriva da un’opera letteraria del 1791,
Panopticon or the inspection-house: containing the idea of a
new principle of construction applicable to any sort of establishment, in which persons of any description are to be kept
under inspection, del giurista inglese Jeremy Bentham (per
l’edizione italiana v. Bentham, Jeremy, Panopticon, ovvero
la casa d’ispezione, a cura di Foucault, Michel e Perrot,
Michelle, Venezia, Marsilio, 1983). Egli riteneva che attraverso l’architettura fosse possibile indurre le persone a
determinati comportamenti “disciplinati” grazie a «un
nuovo modo per ottenere potere sulla mente, in una
quantità finora mai vista».
Si trattava, in sostanza, di una
moderna e raffinata strategia del terrore applicata
n.37-40
2010
18
all’architettura attraverso l’invenzione di una nuova tipologia costruttiva (in questa circostanza una casa di detenzione
ma lo stesso modello poteva adattarsi, secondo Bentham,
anche a scuole, fabbriche e ospedali, in particolare quelli per
i malati di mente). Grazie ad alcuni accorgimenti basati sulle
regole dell’ottica, sarebbe stato infatti possibile, anche con
un solo guardiano, sorvegliare senza essere visti tutte le
persone presenti (detenuti, operai, malati o, magari, alunni),
incutendo un senso di onnipresente vigilanza.
Quello della soggezione indotta dalla consapevolezza d’una
“presenza invisibile” è un principio associato più volte
all’architettura: basti pensare, ad esempio, al medievale
Corridore del Cassero di Prato, utilizzato dalle truppe fiorentine per entrare e uscire di nascosto dalla città senza
esser visti. La novità dell’idea di Bentham fu rappresentata dall’averla associato a uno specifico tipo edilizio, il
panottico, appunto.
Si tratta d’una tipologia che Bentham riteneva adattabile,
secondo le circostanze a edifici diversi ma che, com’era
facilmente prevedibile, riscontrò maggior successo proprio come prototipo di una moderna struttura carceraria
piuttosto che in altre applicazioni civili.
Nel Lazio si ha un pregevole esempio nell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano; da notare che la struttura di questo panottico italiano – assai più vicina all’originaria idea del giurista inglese che non la sua tarda derivazione colombiana – è stata realizzata a partire dal 1794,
ovvero solo tre anni dopo la pubblicazione dell’opera di
Bentham. I lavori del Panóptico di Ibagué iniziarono invece
nel 1892 (la struttura fu ultimata nel 1902) sotto la direzione del generale Manuel Casabianca.
Questi ripropose il progetto utilizzato per il panottico di
Bogotà (oggi trasformato in museo nazionale), dell’architetto danese Thomas (o Tomàs) Reed che, giunto da Caracas
nel 1847 per insegnare architettura nell’università statale,
successivamente si trasferì a Quito, in Ecuador, dove nel
1855 progettò un analogo edificio penitenziario (cfr. Saldarriaga Roa, Alberto et al., En busca de Thomas Reed,
arquitectura y polìtica en el siglo XIX,
Bogotà, Secretaria general Alcadia
Mayor, 2005).
Ad oggi sono ancora esistenti in America Latina solo pochi dei molti edifici carcerari realizzati sul modello di
Bentham: oltre i due colombiani e il panottico di Quito (ancora utilizzato come casa di detenzione)
vi sono, infatti, il Palazzo di Lecumberri a Città del Messico
(oggi sede dell’archivio generale) e il panottico di La Paz, in
Bolivia (anch’esso in corso di conversione).
Dal punto di vista delle scelte progettuali il restauro del
panottico di Ibagué è stato pensato e realizzato secondo le
modalità di una “manutenzione spinta” ovvero con evidenti tendenze al ripristino di un aspetto pulito e decoroso
della struttura monumentale.
Vi sono, poi, insieme agli interventi più strettamente di restauro, anche altre opere di nuova architettura, di arredo
esterno e di musealizzazione. In particolare, l’aggiunta di
nuovi edifici all’interno dell’area dell’ex penitenziario è propedeutica alla riconversione in spazio museale, mentre la
progettazione degli spazi verdi ha assunto precise valenze
simboliche. Al posto di garitte e mura di guardia (alte oltre
6 metri) che confinavano il vecchio penitenziario e delle quali,
ancora per poco, sono visibili alcuni tratti (destinati come
gli altri ad essere completamente abbattuti) vi saranno, infatti, moderne recinzioni tese quasi a scomparire. L’intenzione
è che una maggior permeabilità restituisca il panottico alla
In alto da sinistra:
Cartagena,
Teatro Heredia,
prospetto principale
dopo i recenti
interventi di restauro
Cattedrale
di San Pedro Claver,
una fase dei
delicati inter venti
di restauro
delle murature
in pietra corallina
della facciata
Sotto:
Ibagué, la facciata
principale
del “Panóptico”,
prima e dopo
i restauri
n.37-40
2010
19
Nelle intenzioni di Duque Gómez i riflessi del penitenziario sull’acqua rappresenteranno così lo «specchio di un
passato restaurato».
Si tratta quindi, nell’insieme, non d’un intervento di restauro conservativo ma certamente di un meno rigoroso e più
articolato «conjunto de proyectos, obras de restauración,
obra nueva y tratamiento de paisajismo que sustenten la articulación de lo histórico con las nuevas necesidades y usos»,
come dichiarato dal progettista stesso (Duque Gómez in
Saravia Ríos, Elizabeth, Museo panóptico, «Arcadia», 23,
agosto 2007, p. 32).
La volontà alla base dell’intervento è manifesta: riconvertire un pregevole edifico di fine Ottocento a un uso più consono, celando o, meglio, cercando di cancellare, per quanto
possibile, il ricordo delle tante sofferenze in precedenza
associate a quel luogo, senza però rinunciare a evocarne, in
maniera garbata, la memoria.
La stessa conservazione dell’edifico principale del carcere,
con gli spazi angusti delle celle sarà a tal proposito, secondo Duque Gómez, sufficiente: «El edificio como pieza principal del museo, por sus dimensiones y características, resultará por sí mismo impactante para las personas que no
han entrado a una cárcel, e imaginen en el recorrido la vida
en confinamiento» (ibidem).
È un complesso, quindi, quello del panottico di Ibagué che
con la sua storia evoca ricordi positivi e, insieme, anche assai
negativi. Il progetto, attraverso una precisa lettura critica, ne
ha riproposti alcuni scegliendo, al contempo, di mitigarne altri.
L’edifico è stato così riproposto nel suo “stile originario”,
attraverso il rifacimento di alcune parti con materiali e tecniche costruttive ormai appartenenti alla storia passata.
La struttura del Panóptico è stata, infatti, riportata, per quanto riguarda le coperture e i prospetti esterni alle sue forme
iniziali di fine Ottocento, eliminando tutte quelle superfetazioni giudicate deturpanti e conservando, fra le tante
aggiunte e decorazioni “spontanee”, solo quelle ritenute,
città, rimuovendo una separazione ormai funzionalmente
inutile e simbolicamente carica di valenze negative.
Precise operazioni di architettura del paesaggio trasformeranno quindi gli spazi esterni, avvalendosi d’un tema
definito dagli stessi progettisti «tipico dell’architettura
islamica»: la circolazione dell’acqua. Questa scorrerà in
Ibagué, piccoli canali lungo tutti gli spazi esterni per poi colmail “Panóptico” re cinque stagni artificiali. A tale scopo si riutilizzeranno anche le strutture di una piscina risalente al lontano
In alto: 1915, da tempo non più in uso.
i resti, da demolire,
delle recinzioni
dell’ex casa
di detenzione
A destra:
particolare
della copertura
in “guadua”
della torre centrale
dopo il ripristino
della configurazione
originaria del tetto;
uno dei bracci interni
dopo il restauro.
L’armonia irreale
e il tono caldo
dei colori utilizzati
è in evidente
contrasto con
la severità
n.37-40
dei luoghi e con
2010
la loro funzione
originaria
20
Ibagué,
il “Panóptico”
Sopra: nella
reinterpretazione
del restauro
le colorazioni
delle finestre,
una volta utilizzate
dai detenuti
per identificare
la propria cella,
sono diventate,
un elemento
decorativo
della facciata
A fianco:
planimetria
e “master plan”
dell’intero progetto
di recupero
dell’ex complesso
carcerario
A sinistra:
alcuni dei “murales”
interni conser vati
nel progetto
di restauro
attraverso un condivisibile giudizio critico, le più meritevoli
di perpetuazione.
Sono così rimaste, delle molte pitture interne, probabilmente eseguite dagli stessi detenuti per rendere la loro prigionia meno pesante, solo le più consone al nuovo decoro
della struttura, ovvero quelle in grado di restituire una testimonianza della solitudine carceraria, ma non dello squallore
e del degrado.
Il valore che si è voluto evidenziare è stato quello di un
documento architettonico, ritenuto rilevante più per le sue
qualità formali che non per particolari motivazioni storiche
legate al vissuto dei detenuti. Ecco perché il progetto di
restauro del Panóptico ha scelto di privilegiare l’istanza estetica, portatrice di valori di speranza, su quella storica tout
court nel conservare – seppur trasformandolo e “colorandolo” eccessivamente in più parti – un documento importante della storia cittadina di Ibagué.
A.P.C.
n.37-40
2010
21
Pensando a Magritte
Z5 il Giardino degli
Z5
approfondimenti
è un grande crescent residenziale di sei piani, con
una unica corte a giardino di forma ellittica, spazio che è allo stesso tempo
l’ingresso alle unità abitative, in sei punti
sul suo perimetro, ai garage e ai servizi
nel sottosuolo, e l’affaccio della maggior
parte degli appartamenti. Il giardino è
quindi un luogo di rappresentanza, non
tanto dove stare, ma da attraversare e
da vedere dall’alto, un ambito molto
presente nella vita quotidiana degli abitanti, che segna fortemente l’identità
del complesso. Il progetto ha cercato di
lavorare con due obiettivi: stabilire dei
caratteri che assolvessero quest’attesa
di identità e rendere lo spazio il più possibile dinamico per contrastare la staticità della forma ellittica.
n.37-40
2010
24
Occhi
Il suolo, interamente artificiale, è articolato su tre livelli a gradoni a prato, con
washingtonie, ciliegi giapponesi, magnolie soulengiane, arbusti di varia natura,
ficus repens, grandi pergole in acciaio
ricoperte di glicine. Gli alberi e le palme
sono disposti su collinette coniche in
modo di avere un maggiore spessore
di zolla dove serve e si è avuto cura di
disporre le piante più pesanti sulla testa dei pilastri sottostanti. Con dolore
si è dovuto rinunciare a piantare dei boschetti di bambù, che invece si sarebbero voluti in quantità, per la temuta invasione da parte di queste piante dei
canali di deiezione. Come pure si è dovuto rinunciare a piantare banani, pur
essendo il giardino molto protetto dal
vento, avendo scoperto che fra il cen-
tro di Roma – dove queste piante prosperano – e il quartiere, d’inverno, si
può misurare una differenza che sarebbe fatale di dieci gradi. Come si vede
per la vegetazione si è scelto un repertorio piuttosto originale, che sarebbe
stato anche più spinto, per rispondere
meglio al tema, un roof garden incluso
in un ambiente densamente costruito,
seppure con infinite attenzioni verso
una ricerca di trasparenza e leggerezza.
Non ultima l’importanza dei tutori,
vistosi e multicolori, per compensare
il periodo di adolescenza di ciliegi e
magnolie.
Si distinguono due diversi percorsi principali: un anello a ellisse perimetrale lastricato in gres a campi paralleli bianchi
intervallati da righe sottili nere, e al
centro un sistema complementare coloratissimo in resina che invece attraversa il giardino e porta a due ascensori verso i garage. Per dare maggiore
continuità fra i diversi piani un sistema
di grandi pergole in acciaio, fra loro
parallele, scavalcano i gradoni, dipinte in varie tonalità di azzurro e destinate a essere inghiottite dal glicine.
Poste a filari sono composte da elementi piatti perpendicolari ai salti di
quota con un profilo molto particolare,
che li fa sembrare come delle gambe in
movimento, che nell’insieme, se l’imma-
gine può essere accettata, possono far
pensare a uno spettacolare corpo di
ballo. Chi percorre il giardino ha così
il massimo della trasparenza quando è
di fronte e di copertura man mano che
si sposta sui lati. Ancora in acciaio due
grandi balaustre continue, questa volta
bianche, accompagnano le scale che sulle due esedre dell’ellisse collegano i tre
livelli. Qui sarà il ficus repens a inghiottire strutture e sovrastrutture creando
nel punto più delicato dell’ellisse una
ibridazione fra architettura, percorsi
e giardino.
SCHEDA TECNICA
NOME DEL PROGETTO: Z5, il Giardino degli Occhi
LUOGO: Roma, Quartiere Talenti
Complesso abitativo Impreme
PROGETTO: Franco Zagari con Barbara Salerno,
Maura Teiner e Domenico Avati
COLLABORATORI: foto e video di Maria Rosa Russo
CRONOLOGIA: 2007-2010
DATI DIMENSIONALI: 3.000 mq
IMPRESE OPERE A VERDE: Valverde
MATERIALI:
Resina Artigrup e Gres Marazzi (pavimentazioni)
Targetti (illuminazione)
Valverde (impianto irrigazione e materiali vegetali)
Maestri del ferro (pergole)
Al centro
del giardino
una fontana
radente con getti
intermittenti
di acqua e aria.
Il pavimento
è dipinto in resina
di colore bianco
con un disegno
solarizzato
di due occhi che
immediatamente
si riconoscono
come quelli di
Audrey Hepburn,
un carattere
molto forte
n.37-40
che sottrae
2010
il giardino alla sua
staticità geometrica
25
Un altro elemento
caratteristico sono
delle pergole
in acciaio
che mediano i due
salti di quota e
carenano le bocche
d’aria dei garage.
Vagamente
antropomorfe,
destinate a essere
inghiottite dal
glicine, le pergole
sono sistemi
di piatti fra loro
allineati e paralleli
di disegno sinuoso,
che ricordano
un corpo di ballo
n.37-40
2010
26
Al centro del giardino vi è il tema dominante, una piccola piazza con getti di vapore intermittenti, caratterizzata dal disegno di due grandi occhi,
immediatamente riconoscibili: sono
quelli enigmatici e indimenticabili di
Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, dipinti sul suolo, fortemente solarizzati in modo che avvicinandosi il
disegno diventa del tutto astratto. È un
carattere forte quanto affidato alla interpretazione personale di chi lo vive,
un disegno che in qualche modo in fase
di progetto si è affermato da sé, cercavamo un deus ex machina, un evento inatteso che spiazzasse il peso e
la simmetria e quando questa immagine da noi molto amata si è presentata non ne abbiamo più potuto fare
a meno, non senza sorpresa trovando poi l’appoggio degli abitanti. Chi
osserva il giardino improvvisamente
si rende conto di esserne osservato
a sua volta, come accade visitando uno
stupa nepalese, i grandi occhi conferiscono al giardino una sua misteriosa personalità, aperta alle più diverse
interpretazioni.
Franco Zagari
Interferenze
T
percorsi
lecorbusieriani a cura di Valerio Casali
ra le sue tante pubblicazioni Le Corbusier aveva
concepito una serie particolare, da lui personalmente curata («edité, dirigé, mise en page par Le Corbusier»),
caratterizzata da un contenuto di carattere quasi, direi, confidenziale; la collana è battezzata Gli album della ricerca paziente (Les carnets de la recherche patiente) e si distingue per una
numerazione molto evidente, scritta a mano dall’autore, in
numeri arabi, in copertina.
La serie di pubblicazioni – ognuna dedicata a un’opera del
maestro – che prevedeva numerosi titoli, si è poi esaurita in
soli tre numeri,1 di cui il secondo è dedicato alla Cappella
di Ronchamp.2
Il libro, di formato pressoché quadrato – 18,80 × 20 cm – è
diviso in tre parti e alla p. 87, quale illustrazione introduttiva alla terza parte, figura una strana immagine: una sorta
di composizione geometrica astratta, realizzata con campiture puntinate e rigate.
Questa immagine è assai inquietante, perché non si riesce a
percepirne immediatamente il significato e altrettanto difficile risulta metterla in relazione con il soggetto del libro.
Peraltro nessuna didascalia aiuta il lettore.
Conoscendo il rigore proprio di Le Corbusier e sapendo
come ogni minimo elemento nelle sue opere – in qualunque
campo – svolga un ruolo preciso e mai sia casuale, né introdotto con leggerezza, non si può saltare la pagina a piè pari
per passare oltre…
Ma, come trovare un’interpretazione?
In effetti l’immagine è ermetica ed è impossibile risalire al suo
significato se non si conosce una puntuale spiegazione, fornita dallo stesso Le Corbusier alcuni anni prima, nel Modulor 2,
ove, alla p. 157 (fig. 58), figura – tale e quale – l’illustrazione
in parola; questa volta l’immagine è accompagnata da altre
due similari – p. 156 (fig. 57) e p. 158 (fig. 59) – e da un breve
testo (pp. 155 e 159) che riporto integralmente:
«Interferenze
Osservate! Ecco dei cliché che mostrano le trame di tre
diversi tipi di retini sovrapposti che danno origine a disegni simili ad onde, di natura senza dubbio matematica.
Né geometra, né matematico, non sono designato a fornire la spiegazione: mi contento di osservare il fenomeno.
n.37-40
2010
28
Le Corbusier,
“Modulor 2”,
p. 156
Le Corbusier,
“Modulor 2”,
p. 157
Il “retino” è un prodotto messo recentemente a disposizione degli ateliers di disegno, dei fotoincisori e dei grafici.
Sono dei fogli di cellofan trasparente con trame diverse
stampate in nero. Qui la prima trama è un puntinato regolare (fig. 57); la seconda un rigato regolare (fig. 58) e la
terza, una combinazione di puntinato e di rigato (fig. 59).
Per realizzare il giuoco (imprevisto) che vi propongo, basta
prendere il primo frammento di “retino” che vi viene sottomano, e posarlo su uno uguale, girando impercettibilmente da sinistra verso destra o viceversa, ci si accorgerà
allora che si sono determinati, in un tempo inferiore ad
un quarto di rotazione, sette diversi disegni di esagono.
Questo si svolge sotto i vostri occhi: in un secondo, avete
visto nascere e svilupparsi un fenomeno geometrico affascinante. Ma se, nella vostra rotazione, non vi siete arrestati alle tappe giuste, non ci sarà geometria; resterete
davanti alla porta, nell’inconsistente!
Questo fenomeno d’interferenza dimostra sia l’incontro
ed anche la perfezione.Tutto questo dipende da voi o
dalle circostanze della vostra lettura o dalla vostra disattenzione o dal minimo spostamento di un oggetto. La ricchezza del mondo è proprio in queste sfumature che la
maggioranza dimentica di vedere perché immagina una
ricchezza spettacolare, rumorosa, torrenziale, etc…. che
vive solo in terreni privilegiati inaccessibili ai modesti…
È stato sufficiente osservare!…».
Scopriamo dunque che il significato dell’immagine è estremamente importante: Le Corbusier afferma che la bellezza è conseguenza della perfezione; una perfezione di ordine
matematico, che diviene reale solo in istanti precisissimi,
quando si verifica una totale concordanza di elementi, misure, proporzioni. Come gli stupefacenti esagoni scaturiscono
d’un tratto dalle trame puntinate, l’opera “indicibile” sorge
improvvisamente nell’istante in cui la concordanza, la precisione, la perfezione si verificano.
E come gli esagoni non esistono che per certe determinate
posizioni dei puntinati, per certi – e solo per certi – rapporti tra le trame sovrapposte, così lo “spazio indicibile”3 non si
determina che in presenza di uno stato di perfezione.
Le Corbusier,
“Modulor 2”, p. 158
Sotto:
Le Corbusier,
“Modulor 2”, p. 158,
particolare
A sinistra dall’alto:
illustrazione,
“Modulor 2”, p. 156,
particolare
Le Corbusier,
“Modulor 2”, p. 157,
particolare
Non a caso una tale riflessione – o meglio l’illustrazione che
tale riflessione sottintende – è posta in un libro sulla
Cappella di Ronchamp; Le Corbusier giudicava che questo
edificio fosse «frutto dei numeri», affermazione un po’ provocatoria, giacché la cappella si presenta come un’architettura piuttosto libera – particolarmente libera in confronto
ad altre opere del maestro – e le sue qualità più appariscenti sembrano non essere in alcun rapporto con i numeri; l’architetto, al contrario, ha sempre sostenuto che proporzione e precisione sono all’origine della bellezza della cappella
ed è per questo che l’immagine in questione viene ad assumere carattere di esplicazione del “miracolo Ronchamp”.
Essa ammonisce che l’architettura non scaturisce da un gesto
creatore spontaneo e geniale; semmai questo può essere
esistito in qualche momento del processo, ma quello che
finalmente determina la qualità di un’opera è la perfezione,
frutto della “ricerca paziente”, lavoro assiduo e puntiglioso,
chiave del processo creativo lecorbusieriano: in assenza della
perfetta rotazione comportante l’unica posizione rivelatrice, non ci sono esagoni, ma solo retini puntinati e rigati;
così come a Ronchamp, al di fuori della concorde perfezione di tutti gli elementi, non ci sarebbe una grande opera,
ma solo muri, tetti e finestre…
V. C .
NOTE
1
1 - “Une petite maison” (“Una piccola casa”); 2 - “Ronchamp”; 3 - “Les
maternelles vous parlent” (“Le scuole materne vi parlano”)
2
Le Corbusier, “Ronchamp”, Les Editions Girsberger, Zurigo, 1957
3
Al proposito vedere: Valerio Casali, “L’espace indicible”, «L’architetto
italiano» n. 17, dicembre 2006/gennaio 2007, pp. 38-41
n.37-40
2010
29
La celebre scena
del film “King Kong”
e il “Burj Khalifa”
di Dubai
Sfida antica,
marketing contemporaneo
società e/è costume a cura di Renato Nicolini
L
n.37-40
2010
30
e due cose che mi hanno più
emozionato, in questo 2010,
sono state il nuovo grattacielo di Dubai
e il nuovo film – dieci anni dopo Titanic
– di James Cameron. Mi sono domandato che cosa potesse tenerle insieme,
e ne è uscito quest’articolo.
Il 4 gennaio del 2010 è stato aperto al
pubblico il nuovo grattacielo campione
d’altezza del mondo, il Burj Khalifa di
Dubai, 828 m di altezza all’antenna.
La costruzione, che era iniziata il 21 settembre del 2004, è frutto di una joint
venture tra un’impresa sudcoreana, la
Samsung C & T (che aveva già realizzato i grattacieli – a suo tempo anch’essi
primatisti – Taipei 101 a Taipei e Petronas Towers a Kuala Lampur), una belga, la Besix, e una degli Emirati Arabi,
l’ArabTec. Il prezzo di vendita degli spazi
destinati a uffici è di 43.000 dollari al mq,
degli Armani Residences di 37.000 dollari al mq. La Burj Khalifa (Torre del
Califfo) sorge nel centro di Dubai, vicino alle isole artificiali più famose del
mondo, le Palm Islands e le World
Islands, al più grande centro commerciale del mondo, il Dubai Mall, e al Dubai
Waterfront. Solo qualche mese fa era
sembrato che l’economia del Dubai
stesse per esplodere in una bolla speculativa, ma l’Emiro (di Abu Dhabi) ha
messo mano al proprio portafoglio personale e ripianato i conti.
Nel Dubai tutto è travestimento, sotto
la novità si celano altri nomi, storie
e miti antichi del mondo. Gli Emirati
Arabi Uniti – così si chiama lo Stato che
riunisce, assieme al Dubai, sette emirati – erano noti come la Costa dei Pirati.
Il lupo perde il pelo ma…? Gli Emirati
oggi sono una federazione di sette monarchie ereditarie assolute. Il Consiglio
Supremo dei Sovrani, formato dai sette
emiri, ognuno dei quali signore assoluto in casa propria, elegge nel suo seno
il presidente (tradizionalmente l’emiro di Abu Dhabi) e il primo ministro
(l’emiro del Dubai). Non esistono partiti politici.
La stessa ibridazione tra passato e futuro si mostra passando dalla geografia
all’architettura. I progettisti del grattacielo sono niente meno che i SOM di
Chicago, la griffe Skidmore, Owings e
Merrill ben lontana nel tempo dagli
Skidmore, Owings e Merrill originari.
Un nome che è di per sé garanzia di
continuità, piuttosto che di innovazioni… Ma il gioco dei rimandi non si ferma
alla firma. La forma del Burj Khalifa –
è stato quasi immediatamente osservato – ricorda quella del grattacielo alto
un miglio disegnato ma mai costruito
da Frank Lloyd Wright per l’Illinois.
Più nella snellezza della costruzione,
che non nei particolari (c’è una evidente differenza dal futuro immaginato da
Wright, che prevedeva una pista d’atterraggio per oltre 50 elicotteri sul tetto
del suo grattacielo). Forse come omaggio all’architettura “organica” wrightiana, circola su Wikipedia il fiore a cui
i SOM si sarebbero ispirati per la Burj
Khalifa, l’Hymenacallis, della famiglia cui
appartengono le Amarillidi. Anche se
Wikipedia non lo sa, a me viene in mente il Regno di Ofioch della Principessa
Brambilla di ETA Hoffmann e la favola
dell’Amarillide. Il futuro del deserto
arabo si congiunge così col romanticismo tedesco e col suo vagheggiamento delle origini, dello stato originario
del mondo.
Se lo scoppio della bolla speculativa non
ha fermato la Burj Khalifa, ha assicurato però alla torre un lungo periodo
di dominio incontrastato come edificio
più alto del mondo. Sono stati infatti
rinviati a tempo indeterminato i progetti per la Nakheel Tower (1.000 m),
sempre nel Dubai; per la Hurjan Tower
(Torre del Corallo, 1.022 m) a Manama
nel Bahrein. Mentre ci vorranno almeno 25 anni per la Mubarak al Kabir
Tower (1.001 m) nel Kuwait. Fermato
ai nastri di partenza il progetto di
Libeskind per Ground Zero, previsto
per un’altezza uguale all’anno dell’indipendenza americana, 1.776 m.
Il grattacielo, lo skyscraper, è uno dei
simboli per eccellenza della modernità.
New York si afferma come capitale del
XX secolo (come Parigi lo era stata
del XIX) all’ombra dell’Empire State
Building. Quest’immagine di New York
si diffonde in tutto il mondo, attraverso
la fotografia e la nuova arte, il cinema.
L’Empire State Building si trasforma in
icona della nuova civiltà industriale, programmaticamente opposta alla natura.
Tensione che si rivela drammaticamente quando sul grattacielo si arrampica
la Grande Scimmia, riemersa dalla preistoria, King Kong. La grande città si rivela però piuttosto simile alla foresta
selvaggia da cui King Kong proviene,
luogo di desideri e conflitti altrettanto
primitivi. L’Empire State Building non
un’invenzione da set cinematografico,
come Metropolis di Fritz Lang e Thea
von Harbou. E come luogo reale ricompare in tutta una serie di film ambientati a New York, di cui voglio almeno
citare Un giorno a New York. Tre militari, in licenza nella Grande Mela per un
giorno, come prima cosa salgono sulla terrazza dell’Empire State Building;
“Il grattacielo
alto un miglio”
in un disegno di
Frank Lloyd Wright
e il progetto
di Libeskind
per Ground Zero
ed è sulla stessa terrazza che, 24 ore
dopo, la loro avventura si conclude.
Luogo dunque di sospensione temporale, capace di generare un altro senso
del tempo, nel passaggio di testimone con la Tour Eiffel di Paris qui dort di
René Clair, ancora sotto il segno del
cinema muto.
Il grattacielo non si pacificherà mai, nell’immaginario nostro contemporaneo.
Gli peserà sempre l’ombra della Grande Scimmia (o forse addirittura la memoria del divieto biblico all’uomo di
spingersi nell’alto dei cieli con le sue
costruzioni, la Torre di Babele cui Peter
Brueghel ha dato forma “moderna”
nel Cinquecento). Non resterà legato
a New York, ritornerà alla Chicago delle sue origini, invaderà il dominio della
“città dell’automobile” per eccellenza,
Los Angeles (To live and to die in L.A. di
William Friedkin).
L’attentato dell’11 settembre del 2001
alle Torri Gemelle di New York ha fatto esplodere anche i territori dell’immaginario e del simbolico. Le reazioni
sono state molto diverse tra di loro.
I nuovi Paesi asiatici, dalla Malaysia a
Taiwan, da Singapore a Hong Kong, da
Shangai a Dubai, si sono sentiti spinti a
spezzare l’equivalenza grattacielo-USA.
n.37-40
2010
31
Il “Grattacielo
Pirelli” di Gio Ponti
e la “Torre Velasca”
dei BBPR
Sotto:
il gigantesco
“albero-casa”
del film Avatar
Mentre in Occidente, nonostante Libeskind, è come riemerso – penso soprattutto a certe dichiarazioni di Renzo
Piano sull’“inopportunità” dei grattacieli (espresse sia a proposito di Ground
Zero e della nuova sede del «New York
Times» sia – con qualche caduta di stile
– per delegittimare le Torri di Cesare
Ligini all’EUR) – il tabù biblico contro
la Torre di Babele. Accompagnato dal
diffondersi di immagini manieriste, in
cui il grattacielo si piega su se stesso,
come nei cartoon della moglie di Rem
Koolhaas, e sembra quasi volersi negare
“facendosi strano” (come nei progetti,
che forse non vedremo mai realizzati,
per l’ex Fiera di Milano). Difficile non
pensare – per contrasto – alla Torre
Velasca dei BBPR, al Grattacielo Pirelli
di Gio Ponti, alle case a Corso d’Italia
a Milano di Luigi Moretti. Esisteva, anche rispetto alla tipologia americana per
eccellenza, una tradizione “italiana” che
faceva della nostra esperienza – anche
formale – della città, patrimonio comune. Altrettanto difficile non pensare che, sostanzialmente, gli sono state
voltate le spalle. Anche in questo sra-
dicamento dalla maniera italiana a proposito delle costruzioni alte ha pesato
il trauma dell’11 settembre.
Mi è sembrato invece operare per un
superamento dello choc l’ultimo, straordinario film di James Cameron, Avatar.
Nel film non c’è il grattacielo, ma il suo
equivalente nel mondo naturale, un gigantesco “albero-casa”, alto centinaia
di metri, forse un chilometro forse di
più… Non è il terrorismo islamico, ma
il terrorismo endogeno del mondo
capitalistico, a distruggerlo, sparandogli contro raffiche di missili che ricordano i due aerei che hanno perforato
le due torri del World Trade Center
abbattendole. Sarà l’azione degli altri
uomini, giganti azzurri alti tre metri,
connessi alla natura in un’unica rete, a
ricostruire quanto la violenza occidentale ha distrutto. Nel mondo dell’immaginario, dei desideri, è noto che ogni
cosa “all’incontrario va”. E nella direzione opposta al senso comune, così
come su Pandora l’“albero casa” si ricostruisce da sé, anche sulla Terra seguitiamo a spingerci – nelle ibride forme
della Burj Khalifa (è un progetto americano, data la firma dei progettisti?
Arabo-cinese-sudcoreano, date le nazionalità dell’impresa? È un sogno estremo postmoderno nel mondo favolistico di Dubai? Dubai è una città o la
nuova invenzione del marketing urbano
dopo Las Vegas?) – nell’assalto al cielo.
Nel Giobbe del Rapisardi, poema ormai
dimenticato dell’Italia carducciano-crispina, l’assalto riusciva e l’umanità spodestava “l’eterno”…
R.N.
architettureidee
Il grattacielo ha avuto per più di un secolo il suo baricentro
geografico e culturale negli Stati Uniti; è poi migrato in
Oriente e questo passaggio ha coinciso, schematicamente,
con l’inizio della sperimentazione decostruttivista. Le aree di
maggiore influenza sono diventate la penisola arabica, la
Malesia, Hong Kong e Shanghai, oltre ad alcune città
europee, prime fra tutte Londra e Francoforte.
Dopo il lungo impero del prisma di cristallo miesiano e l’orgia
del Post Modern, entrambi radicati nel tessuto delle città, il
grattacielo è diventato il simbolo dell’isolamento e della
straniazione dal tessuto compatto. Conseguentemente, la sua
figura si è trasformata in un elemento morfologico a sé
stante, destinato a rapportarsi con un territorio molto vasto,
ben al di là delle aree limitrofe. È quello che accade nelle
città d’Oriente che, prive quasi sempre di un tessuto urbano,
composto di edifici alti, si ritrovano improvvisamente
sbilanciate dalla presenza di torri fuori scala, inconfrontabili
con l’edilizia circostante. Questa condizione di landmark
MARIO PANIZZA
CityLife, Milano
Area di progetto: 255.000 mq circa (area di proprietà
di CityLife); 111.000 mq circa (area comunale al contorno);
65.000 mq circa (area di cessione da parte di Fiera di Milano
al Comune)
Superficie edificabile: 288.879 mq – 51% (residenziale),
49% (terziario)
Parco e aree pubbliche: 160.000 mq
Servizi e aree a valore aggiunto: cinema, ristoranti, bar,
locali, shopping di qualità, sedi di associazioni, poste,
banche, servizi alle imprese
Parcheggi: 7.000 circa – 800 circa (parcheggi pubblici),
4.500 circa (parcheggi per residenti), 1.500 circa (parcheggi
per uffici e commercio)
Infrastrutture e trasporti pubblici previsti: Tunnel Gattamelata;
Metropolitana 5 (stazione Tre Torri)
Cronologia: 2007 (inizio lavori) – 2014 (fine lavori)
Costo: 523 mln di euro circa
isolato sta promuovendo una ricerca espressiva molto libera,
tesa a inseguire i caratteri della grandezza assoluta e
autoreferente, attraverso la convulsa ricerca verso il desiderio
di combinare regionalismo e high-tech. In qualche modo il
grattacielo orientale fonde i due linguaggi precedenti –
l’astrattismo razionale e la riconoscibilità dei motivi figurativi
– attraverso modelli che aggiungono al rigore della
CityLife: il dritto,
lo storto, il curvo
idee
DI
Zaha Hadid, Arata Isozaki, Daniel Libeskind
I tre grattacieli nello skyline di Milano
architetture
35
idee
architetture
36
costruzione essenziale il decoro, a grande scala, di alcuni
temi figurativi. Anche in questa nuova accezione orientale il
grattacielo non perde tuttavia il carattere primario di
paradosso costruttivo che, utilizzando l’architettura dagli
effetti speciali, cattura e trasforma in profitto la curiosità dei
passanti.
La coincidenza temporale con il Decostruttivismo non ha però
avuto un concreto riscontro nella definizione dell’immagine;
solo in Europa l’audacia di alcune intemperanze costruttive ha
avuto un certo rilievo, concentrandosi soprattutto in quei
grattacieli che, più bassi – circa la metà degli edifici dei record
–, potevano sopportare la sperimentazione di forme, talvolta
solo apparentemente, squilibrate.
L’impegnativo progetto presentato da CityLife, la cordata che
si è aggiudicata la gara per la riqualificazione dell’area della
Fiera Campionaria di Milano, affida all’immagine di tre
grattacieli il compito di definire il carattere dell’intervento.
Quale architettura, se non quella legata alla forma del
grattacielo, avrebbe infatti potuto rappresentare meglio la
carica simbolica che, insieme al contenimento dei costi di
gestione e alla rapidità di esercizio, erano alla base delle
richieste del concorso?
In realtà l’insediamento non si limita ai tre grattacieli;
comprende un parco di 160.000 mq e si articola su un
territorio molto esteso dove sono previste attività
commerciali, residenziali e ricreative. Entro il 2014 sorgeranno
anche un museo di arte contemporanea (Daniel Libeskind),
Il progetto presentato da CityLife si articola su un territorio molto esteso
e prevede molteplici attività, commerciali, residenziali e ricreative ma è sui tre
grattacieli che si concentra il maggiore interesse: ribattezzati “il dritto,
lo storto e il curvo” esprimono scelte figurative che impongono la loro
personalità
tre lotti di edilizia residenziale (Arata Isozaki, Zaha Hadid e
Daniel Libeskind), due torri residenziali (Pier Paolo Maggiora)
e un vasto complesso direzionale e commerciale. Sia gli
alloggi che gli uffici occuperanno 150.000 mq.
È però sui tre grattacieli che si concentra il maggiore
interesse; dell’intero intervento rappresentano la componente
più visibile e appariscente: ribattezzati “il dritto, lo storto e il
curvo”, esprimono scelte figurative determinate che, anche
attraverso la loro semplificazione terminologica, impongono
la loro personalità.
Quello di Isozaki – il dritto – sviluppa un profilo impostato
sulla ripetizione di un modulo di sei piani sagomato da linee
curve che riecheggiano il tema formale delle torri di Brancusi.
L’impianto tipologico è regolato da un sistema strutturale
modulare, con le scale e gli ascensori confinati alle estremità
dei lati corti per lasciare agli ambienti per gli uffici il massimo
di affaccio sull’esterno.
Lo storto, il grattacielo di Zaha Hadid, delinea una sagoma
che sfida i principi della verticalità, proponendo un volume
che, attraverso la rotazione della pianta, provoca uno
sbilanciamento molto pronunciato. L’effetto è curioso e si
affida alla combinazione accorta delle geometrie che
governano il disegno della pianta: il nucleo rigido centrale –
perfettamente in verticale – ha una forma irregolare,
calibrata sulle distanze che può tollerare la gabbia strutturale
esterna man mano che i singoli pilastri si allontanano dalla
giacitura iniziale.
idee
In alto: il grattacielo di Isozaki, “il dritto”, sviluppa un profilo impostato sulla
ripetizione di un modulo di sei piani sagomato da linee curve che
riecheggiano il tema formale delle torri di Brancusi
In basso: il grattacielo di Zaha Hadid, “lo storto”, presenta un volume che,
attraverso la rotazione della pianta, provoca uno sbilanciamento molto
pronunciato
architetture
37
idee
Anche il grattacielo di Libeskind – il curvo – mira a
impressionare per la precarietà dell’equilibrio. In questo caso
a sfidare la verticalità non è il volume inclinato, bensì una
porzione di guscio irregolare che si piega salendo verso l’alto.
L’uso accorto della geometria accompagna, anche in questo
caso, le esasperazioni strutturali: solo una breve porzione, la
più alta e meno voluminosa, sporge rispetto alla sagoma di
appoggio e il nucleo rigido dei collegamenti verticali è posto
nell’angolo opposto dello sbilanciamento, proprio per
riequilibrare e compensare l’insieme.
Il progetto di Libeskind è quello che ha provocato il maggior
numero di critiche: viene contestato soprattutto per la sua
foma bizzarra, poco riguardosa verso i principi
dell’architettura e la sobrietà del contesto urbano milanese. Si
è giunti perfino a rimproverargli un’immagine poco “virile”,
quella che, secondo alcuni, dovrebbe rappresentare il
carattere distintivo del grattacielo.
Tutte le volte che si intraprendono campagne di stampa in
difesa della tradizione e dello stile, quasi sempre si finisce per
osteggiare il Moderno e confinarne la ricerca formale
all’interno di pochi canoni consolidati. A sostegno di queste
tesi si muovono valori dove la retorica domina sull’autonomia
e l’originalità del pensiero. Sarebbe al contrario più
opportuno, quando il contesto non impone particolari
condizioni di rispetto legate al carattere delle preesistenze,
che il progetto venisse valutato attraverso i parametri concreti
che misurano un edificio, cercando di porre in secondo piano
le categorie universali dell’ideologia.
Ciò ovviamente non significa che, lontano da un centro antico,
tutto sia lecito e il giudizio estetico sia affidato alla pura
soggettività. L’opera architettonica può essere valutata però con
maggiore autonomia e le sue qualità rintracciate soprattutto
architetture
38
In questa pagina: il grattacielo di Libeskind, “il curvo”, sfida la verticalità
piegando una porzione del guscio esterno verso l’alto mentre, nell’angolo
opposto allo sbilanciamento, propone un nucleo rigido di appoggio che
riequilibra l’insieme
Alcune immagini del complesso progetto per la riqualificazione dell’area
della Fiera Campionaria di Milano. All’immagine dei tre grattacieli è affidato
il compito di valorizzare pubblicitariamente l’impegno dell’impresa
idee
39
architetture
nelle premesse espressive del progetto. Il grattacielo di
Libeskind, così come quello di Zaha Hadid, e per certi versi
anche come quello di Isozaki con il suo esplicito riferimento
alle sculture di Brancusi, hanno motivi di esagerata esibizione
provocatoria; ma non veniva chiesto loro proprio di esibire un
forte carattere simbolico di richiamo, per promuovere
l’interesse sull’intero insediamento? D’altronde la scelta del
grattacielo quasi mai corrisponde a una esclusiva esigenza
tipologica: quasi sempre esprime l’intenzione di esibire un
carattere esuberante e di affidare all’edificio il compito di
valorizzare pubblicitariamente l’impegno dell’impresa.
Anche le perplessità sull’incoerenza tra grattacielo e tessuto
urbano hanno poca consistenza. Milano ha infatti voluto in
passato nel suo centro cittadino due importanti grattacieli,
modelli copiati e di grande rilievo nella storia dell’architettura
moderna: la Torre Velasca (BBPR, 1958) e il Grattacielo Pirelli
(Gio Ponti, 1961).
Le motivazioni storicistiche e ambientali non giustificano
pertanto le critiche ai tre grattacieli di CityLife; ciò tuttavia
non ne riconosce implicitamente le qualità architettoniche
che, per altri versi, sollevano non pochi dubbi che riguardano
soprattutto il rapporto non ben giustificabile tra la loro esibita
muscolarità strutturale e la poco razionale utilizzazione degli
spazi. Ma a questo punto si rientra in una valutazione critica
che riguarda gran parte dell’architettura contemporanea,
soprattutto in Italia, dove l’originalità dell’immagine è
inseguita molto più della correttezza funzionale. La
riconoscibilità di una firma affermata esprime un valore che
spesso azzera la qualità dell’opera. Questo peraltro è anche
favorito dal ciclo ormai diffuso che vede l’idea architettonica
concludersi con il progetto e, solo raramente, misurarsi con le
verifiche della realizzazione. n
architettureopere
opere
Burj Dubai,
il grattacielo dei record
architetture
40
L’edificio in fase di costruzione e l’area del distretto
finanziario principale di Dubai
La costa di Dubai caratterizzata da avveniristici
grattacieli e arcipelaghi artificiali
SOM – Skidmore, Owings and Merrill LLP
opere
Burj Khalifa (Burj Dubai), Dubai, Emirati Arabi Uniti
Cronologia: 2004-2009 (costruzione); 2010 (inaugurazione)
Altezza antenna: 828 m
Numero piani: 160 (esterni), 2 (sotterranei)
Area di progetto: 454.249 mq
Costruttore: Emaar Properties
Costo: 1,5 mld di dollari
MARIO PANIZZA
L’edificio terminato si presenta come una svettante stalagmite in crescita
progressiva
41
architetture
DI
opere
architetture
42
Il Burj Dubai è il grattacielo dei record: numero di
appartamenti, uffici, posti macchina, spazi pubblici, giardini e,
soprattutto, il primato dell’altezza.
La sua storia non può essere disgiunta dalle vicende
dell’emirato che, nel volgere di pochi anni, a partire dal 2003
(inizio della costruzione dell’edificio) è passato da una
grande espansione a una crisi economica molto profonda. Il
modificarsi così repentino della condizione finanziaria del
Paese sembra corrispondere alle esagerazioni delle scelte
architettoniche già compiute in questa nazione: il Burj Al
Arab, l’hotel a sette stelle dove si può anche sciare, e le isole
artificiali a forma di palme che raccolgono lussuose ville in
mezzo al mare.
Anche il Burj Dubai, in pianta, ha la forma di un fiore.
Risponde in tal modo a precise esigenze distributive e
strutturali, e rimane nella tradizione grafica della cultura
araba. Il modello organico viene poi interpretato e governato
da precise regole geometriche, al fine di fissare tutte le
misure all’interno di opportune gerarchie scalari e, stabilendo
una novità assoluta per un progetto di architettura, lasciare
che l’opera tolleri il principio, presente nella concezione
iniziale, che l’esito finale possa mutare nel corso della
realizzazione. Questo ha accresciuto la curiosità sull’edificio,
mantenendo incerto fino alla fine il numero dei moduli che
sarebbero stati agganciati al nucleo centrale e, soprattutto,
lasciando indefinita l’altezza che sarebbe stata raggiunta a
conclusione dell’opera. L’immagine, anche adesso che
l’edificio è terminato, rende bene questa idea di crescita
progressiva: una stalagmite che sale da terra e non si sa
quale quota raggiungerà, quale delle numerose opzioni del
progetto seguirà.
L’assunzione di una pianta a petali non è del tutto nuova.
Oltre alle sagome a ninfea proposte in più occasioni da Alvar
Aalto, a Chicago Schipporeit e Heinrich costruiscono nel 1968
il Lake Point Tower, un grattacielo a tre lobi, proprio come il
Burj Dubai, che a sua volta ricorda i modelli, mai realizzati,
progettati da Mies van der Rohe all’inizio degli anni Venti.
Proiettare da un nucleo centrale tre corpi separati permette di
ottenere il maggior numero di affacci liberi e assicura una
vista molto ampia sull’intero Golfo Persico. All’interno di
questo profilo trilobato della pianta si sviluppano ulteriori
temi di modellazione formale, legati alle specifiche varianti
della grafia araba, che permettono di isolare le singole cellule
residenziali. La moltiplicazione degli elementi che vanno a
comporre il profilo del perimetro rende pertanto molto ricca
la gamma delle offerte funzionali e garantisce a tutti i
lussuosi alloggi che svettano a grande altezza viste
assolutamente privilegiate.
Il Burj Dubai è l’edificio dei record anche per la grande
estensione degli spazi all’aperto, veri e propri parchi verdi,
alimentati dall’acqua raccolta grazie alla condensa che viene
dal contatto tra il caldo umido esterno all’edificio e il
raffrescamento degli ambienti interni.
Il profilo pulito della silhouette mette in evidenza la moltiplicazione degli
elementi e la modellazione formale
La pianta dell’edificio a forma di fiore risponde a precise esigenze distributive
e strutturali oltre a rimanere nella tradizione grafica della cultura araba
opere
Due profili che, a scala diversa, rendono evidente
il contesto in cui il grattacielo si inserisce
architetture
43
opere
Il progetto di un grattacielo impone sempre la ricerca di
soluzioni economicamente ben misurate, proprio perché
l’investimento è tale che non può permettersi di trascurare
fattori che per altri edifici sarebbero secondari. Tra questi, il
tempo privo di profitti, talvolta anche lungo, necessario alla
costruzione, e la spendibilità pubblicitaria dell’opera che deve
proporre un’architettura ben riuscita e ricca di optionals. Per la
architetture
44
Alcune immagini del Burj Dubai realizzato e in fase di costruzione
Il grattacielo illuminato nello skyline di Dubai
opere
prodotto architettonico. Insomma, la coerenza vitruviana tra
forma, funzione e struttura per un grattacielo dei record è
assolutamente imprescindibile: Adrian Smith dello Studio
SOM, con la pulizia della silhouette del Burj Dubai, indica una
strada precisa, che ricerca nelle forme “copiate” dalla natura
non un’immagine di moda, ma la semplicità costruttiva e, per
quanto è possibile, il contenimento dei costi energetici. n
45
architetture
costruzione dell’Empire State Building le travi in acciaio della
struttura venivano fuse 72 ore prima del loro montaggio,
giusto il tempo per il trasporto in cantiere e mettere in opera
senza occupare uno spazio prezioso tra le strade di Manhattan;
nell’AT&T, sempre a New York, Philip Johnson giunge, tra le
altre scelte, a “inventare” il lampadario che, aumentando le
altezze interne degli ambienti, rende ancora più prestigioso il
DI
FRANCESCO MARIA MANCINI
Renzo Piano Building Workshop
The New York Times Building, New York, NY
Progetto: 2001
Costruzione: 2004-2007
Consulenti USA: FXFOWLE Architects
Consulenti per l’interior design: Gensler Architecture
Strutture: Thornton Tomasetti
Impianti: Flack + Kurtz
Superficie complessiva: 150.000 mq
Area di intervento: 7.800 mq
Altezza dell’edificio all’antenna: 319 m
Altezza dell’edificio: 227,5 m
Costo: 1 mld di dollari
opere
Il New York Times Building di Renzo Piano non si pone come
rivale dei giganti d’Oriente che, a partire dalle Petronas
Towers di Cesar Pelli a Kuala Lumpur (1998), hanno dato
nuovo slancio alla corsa per il primato in altezza.
Inaugurato il 17 settembre 2007, per le sue dimensioni
medio-alte (52 piani, 319 m all’antenna) il Times è
attualmente terzo tra i grattacieli di New York, puntando più
sul rapporto con il tessuto urbano che sulla forma
eccezionale, secondo quella linea “cittadina” di grattacieli
che disegnano il profilo, sempre mutevole, delle metropoli.
Tranne rari casi, infatti, il grattacielo americano si inserisce in
un tessuto ordinato, costituito da edifici, più o meno alti, che
architetture
46
Una leggerezza
sostenibile
Il NY Times Building visto dall’8a strada
L’ingresso principale alla sede del giornale da cui si percepisce la hall in tutta
la sua lunghezza
nello skyline pronunciano la loro singolarità individuale, ma
alla quota stradale disegnano la compattezza del blocco
urbano denso, utilizzato in tutta la sua estensione. Come
sappiamo l’innovazione più originale di questo schema
compare a Manhattan nel 1958 grazie a Mies van der Rohe,
che arretrando il Seagram Building rispetto al filo stradale,
determina su Park Avenue uno spazio-piazza aperto alla
L’edificio in relazione alla scala urbana circostante
opere
modellando la composizione tra l’edificio alto e quello basso
sul più significativo dei simboli urbani: la piazza con la
“chiesa” e il “campanile”.
Renzo Piano adotta questo schema per il New York Times
preferendo alla caratterizzazione figurativa il tema
compositivo della torre e della sala bassa, aperta alla città e
arricchita da un arioso giardino interno. «La maggior parte
dei grattacieli a New York scende fino a terra, prendendo
possesso in modo piuttosto aggressivo del territorio», spiega
Piano, mentre in questo caso il piano terra di fatto unisce la
40a Strada alla 41a: «L’edificio e la città si leggono a vicenda
e dialogano (…) una buona metafora del concetto di
redazione e di giornale, una struttura che si alimenta della
città».1
La trasparenza come metafora per l’edificio è un’idea
perseguita sin dalle prime fasi del progetto, nonostante
l’attentato dell’11 settembre 2001. Questo atto di negazione
della città avrebbe potuto indurre ad accentuare il tema
della sicurezza, ma non l’architetto genovese, che riafferma
l’importanza della fruibilità dello spazio urbano anche dentro
i grandi edifici.
La lobby del Times Building si apre al pubblico per più di
100 m oltre i nuclei ascensori. Dall’ingresso su strada si
notano le attività all’interno, dal trambusto dell’atrio fino alla
quiete del giardino, una corte di 400 mq circondati da 2.400
mq di spazi commerciali ad essa complementari, dalla
newsroom del Times e dagli uffici soprastanti.
Un auditorio di 380 posti prospiciente il patio completa
l’offerta di servizi, potendo ospitare videoconferenze,
commedie teatrali, notiziari live e recital musicali. Questa
piastra riccamente articolata si traduce in un optional
invitante e, nel contempo, permette alla città di estendere la
riqualificazione di un’area fino a poco prima tra le più
degradate e insicure. Su di essa si sovrappone la torre
quadrata degli uffici che offre a ogni piano 3.000 mq di
superficie utile illuminata da luce naturale.
Le soluzioni distributive più utilizzate sono due: l’open space
modulato su un passo di 1,5 m, con workstations schermate
da bassi pannelli, che si alternano a spazi di incontro e
collaborazione, o il perimeter plan con gli uffici disposti su
un anello esterno e i servizi raggruppati nell’area centrale.
Il progetto, oltre a un’attenta ricerca edilizia sul piano
tipologico, mostra grande attenzione alla sostenibilità,
realizzando un vero e proprio tecno-tipo che integra la
matrice distributiva del grattacielo con le sue prestazioni
strutturali e tecnologiche.
Anzi tutto Renzo Piano sceglie di mostrare le travi all’esterno
e all’interno dell’edificio. 25.000 tonnellate di acciaio, per il
95% riciclato, vengono accuratamente sagomate e
assemblate in un telaio a vista integrato nell’involucro,
mentre un nucleo centrale in cemento armato resiste alle
sollecitazioni orizzontali, bilanciando la leggerezza del
reticolo esterno. Il nucleo nella parte alta si riduce,
47
architetture
città. Una soluzione ripresa da molti altri progetti, sebbene
con l’ulteriore variante, più redditizia sul piano commerciale,
di porre la piazza all’interno dell’edificio.
I grandi atri risultano infatti gli accorgimenti più efficaci per
richiamare il pubblico dei visitatori e, quindi, dei potenziali
clienti. Sono spazi che coincidono per lo più con la lobby del
grattacielo, generalmente di grande altezza e di forte
impatto, ben visibile dalla strada. Gli esempi non sono pochi
e riguardano sia i grattacieli del periodo déco che quelli post
modern, entrambi contraddistinti da decori esuberanti.
Parallelamente a queste soluzioni, con gli ambienti pubblici
che occupano la parte basamentale dell’edificio, se ne
sviluppano altre, dove al foyer è destinato uno spazio,
sempre interno al lotto, ma adiacente all’edificio principale.
Anche in questo caso vi sono prototipi molto seguiti, come il
Republic Bank Center, realizzato a Houston nel 1984 da
Philip Johnson, che risolve il rapporto con la città
1
1
4
Legenda:
7
5
2
3
6
opere
7
1
1
1. spazi commerciali
2. atrio
3. auditorium
4. foyer
5. patio
6. area carico/scarico
7. ascensori
1
architetture
48
Sezione longitudinale. La Times Company utilizza dal piano terra fino al 27°,
per un totale di 80.000 mq. A partire dal piano tecnico altri 21 livelli, per
complessivi 67.000 mq, sono gestiti dalla Forest City Ratner Companies
Pianta del piano terra. Intorno alla corte interna si articolano la main hall
del giornale, gli ambienti commerciali (MUJI, Dean & DeLuca Cafè, Inakaya) e
un piccolo auditorio
Lo spazio interno beneficia di splendide viste grazie alle vetrate a tutta altezza
protette da curtain wall di ceramica
6
6
2
3
6
5
6
2
4
4
6
5
4
5
8
6
5
7
7
4
4
9
1
3
2
8
4
1
3
5
8
6
9
3
6
3
2
a
b
6
6
Legenda:
Legenda:
6
1. atrio/attesa
2. postazioni di lavoro
open space
3. riunioni
4. fotocopie/caffè
5. spazi comuni
6. uffici
7. spazi tecnici
8. ascensori
9. wc
6
2
6
4
3
6
6
2
8
1
6
3
3
8
1
9
9
4
5
4
7
4
3
4
7
6
5
3
5
c
2
d
6
In alto: piante dal 2° al 27° livello. Soluzioni open space (a) e perimeter plan (b)
In basso: piante dal 29° al 52° piano. Soluzioni open space (c) e perimeter
plan (d). Ai piani alti affittati ad altre compagnie, la superficie commerciale
aumenta grazie alla riduzione del nucleo ascensori
6
6
49
architetture
6
opere
6
2
opere
eliminando un blocco ascensori in favore di una più ampia
superficie commerciale.
Questo modello strutturale è capace di rispondere a ben 24
combinazioni di spinte del vento e azione sismica
sopportando, nella sua snellezza, i notevoli allungamenti e
contrazioni dovuti agli shock termici che in estate
raggiungono anche i 24°.
Un secondo aspetto è il tema dell’efficienza energetica. Il
grattacielo è supportato da un impianto di cogenerazione a
gas in grado di produrre 1,4 MW di energia elettrica, mentre
un circuito secondario integrato ne recupera il calore
dissipato sfruttandolo per riscaldare gli ambienti. Il Times è
così in grado di produrre fino al 40% di energia necessaria al
raffrescamento estivo e al riscaldamento invernale.
Un’efficiente ventilazione forzata permette di condizionare
l’aria esterna fino a 6° più calda della norma e immetterla
architetture
50
In alto:
Al centro e in basso:
La struttura in acciaio a vista costituisce parte integrante dell’immagine
dell’edificio
La lobby, lungo i due blocchi degli ascensori ad alta velocità, è caratterizzata
da 560 display che offrono un dinamico ritratto del Times, alternando titoli
estratti dai 156 anni dei suoi archivi agli strilli delle ultime notizie
La caffetteria su due livelli al 14° piano: un luogo piacevole per una pausa,
equipaggiato, come tutto l’edifico, con rete wi-fi e voip system
La corte all’interno dell’ariosa lobby si pone in contrasto con i ritmi intensi
della città, costituendo il cuore pubblico dell’edificio
Lo spazio di lavoro, di classe A, è progettato per essere flessibile secondo
le necessità della Times Company, che affianca alle news attività di business
e corporate
Vista notturna dello skyline della città
opere
luce naturale, in totale assenza di fenomeni di
abbagliamento. Il curtain wall di frangisole ceramici, le
ampie vetrate e la struttura caratterizzano sul piano
espressivo l’involucro, mostrando un’immagine vibrante che
amplifica la trasparenza dell’edificio man mano che la
sagoma procede verso l’alto.
Il confine con il cielo si perde quando la frangia del bordo
superiore si smaterializza e i segni sottili della struttura
dell’involucro non hanno più nessun volume da proteggere. n
1
Renzo Piano, intervista al «Corriere della Sera» del 16 novembre 2007
51
architetture
lentamente dall’elegante pavimento in rovere, invece di
pomparla ad alta velocità dal soffitto. Grazie al calore dalle
persone e dei computer l’aria viene post-riscaldata senza
sprechi, salendo per poi defluire dalle riprese a soffitto.
L’azione di sensori di anidride carbonica assicura un notevole
comfort, favorito anche dalla ventilazione naturale.
Un sistema di illuminazione ad alta efficienza gestisce
18.000 lampade con alimentatori a chip programmabili in
funzione dell’apporto di luce solare. A questo si affianca un
dispositivo di ombreggiamento dinamico, costituito da uno
schermo di aste in ceramica capace di un risparmio
energetico annuo del 30%.
La riduzione del 50% del flusso di energia solare
proveniente dall’esterno ha permesso di installare vetrate da
cielo a terra in tutti i piani del grattacielo. Lo spazio interno
guadagna così una splendida vista e un maggior apporto di
C.Y. Lee & Partners Architects/Planners
Taipei 101, Taipei, Taiwan
Cronologia: 2004 (realizzazione)
Altezza antenna: 508 m
Peso: 705.130 t
Acciaio: 107.000 t
Calcestruzzo: 242.852 mc
Ascensori: 63 (velocità: 16,83 m/s)
Costo: 1,5 mld di euro
DI
FRANCESCA ROMANA FIERI
opere
Taipei 101,
fra tradizione
e innovazione
architetture
52
Alcune immagini dell’edificio che domina Taipei.
Il motivo formale della rastremazione ha un
preciso scopo strutturale e funzionale
opere
Ora che il grattacielo più alto del mondo è il Burj Dubai, il
Taipei 101 è un po’ passato in secondo piano, anche se
rimane leader nell’inglobare tecnologia costruttiva e cultura
del luogo, attraverso un’attenta cura dei dettagli.
La sua struttura a gradoni, che si distacca dalla consueta
forma filante, richiamando un gambo di bambù, antico
simbolo di crescita, è formata da 8 moduli rastremati a base
quadrata, ognuno di 8 piani, che si innalzano uno sopra
l’altro da un basamento piramidale. Proprio intorno al
numero 8, che nella cultura cinese rappresenta abbondanza,
prosperità e buon auspicio, si ordina l’insieme degli elementi
costruttivi; non mancano tuttavia altri simboli: quattro grandi
dischi, che raffigurano monete, sono montati sulle quattro
facciate, a marcare il passaggio dei due diversi motivi
geometrici della parte in elevazione; alcuni draghi d’acciaio
sono posti a guardia degli spigoli; le cifre ruyi, antico simbolo
associato alle nuvole del cielo, dichiarano guarigione e
protezione. Anche l’altezza di 101 piani commemora il
rinnovo del tempo (100+1) e tutti i nuovi anni (1-01). A
rafforzare l’effetto scenografico dell’edificio contribuisce
l’illuminazione, che ogni sera propone uno dei sette colori
Quattro grandi dischi che raffigurano monete sono montati sulle quattro
facciate
Pianta piano tipo e schema sintetico delle destinazioni d’uso dei vari piani
architetture
53
opere
architetture
54
Sul piano del risparmio energetico, le facciate continue in vetro verde offrono
protezione dalla radiazione solare bloccando il 50% del calore esterno
Ai suoi 101 piani, serviti da 63 ascensori, si aggiungono 5 piani interrati
dedicati al commercio
opere
dello spettro che corrispondono ai giorni della settimana.
Ma oltre a richiamare così fortemente la cultura religiosa
cinese, il Taipei 101 è anche un insieme di alta tecnologia.
La sua solidità strutturale inizia con le fondazioni, ancorate a
una massa rocciosa che si trova a 60 m al di sotto del piano
di campagna, prosegue dal 1° al 62° piano con 8 colonne
d’acciaio riempite di cemento – due in ogni angolo – e si
conclude in sommità con una sfera d’acciaio di oltre 5 m di
diametro che, sostenuta da pompe idrauliche, scorre da 1 a
150 cm, riequilibrando le sollecitazioni orizzontali provocate
dal vento o dai terremoti. Questo accorgimento tecnico, già
sperimentato in altri edifici a partire dal Citicorp Center di
Hugh Stubbins a New York (1977), è risultato uno dei più
sicuri ed efficaci nell’alleggerimento delle strutture in acciaio.
Nei grattacieli infatti, se si riescono a neutralizzare, almeno in
parte, le spinte orizzontali, è possibile giungere a una
riduzione fino al 20% del peso della struttura.
Anche il motivo formale della rastremazione di 7° ogni 8
piani ha un preciso scopo strutturale e funzionale: ogni
segmento è completato da travi che si collegano al nucleo
centrale e l’aggetto esterno è utilizzato come spazio calmo in
caso di incendio. Sugli angoli gli spigoli sagomati a “W”
hanno il compito di irrigidire l’involucro e rompere, per
forma, la spinta del vento.
Sul piano del risparmio energetico, le facciate continue in
vetro verde offrono protezione dalla radiazione solare
bloccando il 50% del calore esterno e il sistema di gestione
delle acque grigie soddisfa il 30% del bisogno totale. È
previsto un investimento di quasi 2 milioni di dollari, che
dovrebbero essere recuperati in soli tre anni, per ottenere
entro un anno la certificazione LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design). Il Taipei 101 diventerebbe in tal
modo l’edificio sostenibile più alto del mondo. n
In sommità è posta una sfera
d’acciaio di oltre 5 m di
diametro che, sostenuta da
pompe idrauliche, scorre da 1 a
150 cm, riequilibrando le
sollecitazioni orizzontali
provocate dal vento o dai
terremoti
In alto a sinistra:
La struttura dell’edificio è ancorata a una massa rocciosa che si trova a 60 m
al di sotto del piano di campagna
In basso a destra:
L’effetto scenografico dell’edificio è affidato all’illuminazione che ogni sera
propone uno dei colori dello spettro
architetture
55
ARNALDO MARINO
opere
DI
architetture
56
Il territorio di Pudong infittito di grattacieli in continua
competizione per il primato d’altezza e originalità
Il drago cinese
alla guerra dei simboli
Kohn Pedersen Fox
La facciata dell’edificio su cui si specchia la Jin Mao Tower di SOM
57
architetture
Chi, all’inizio degli anni ‘90, visitando Shanghai avesse gettato
lo sguardo dalla riva occidentale dello Huangpu dove il fiume
realizza un’ampia ansa, avrebbe osservato sull’altra sponda
una vasta estensione di territorio coltivato a risaia e un
agglomerato di case di pescatori costituente il distretto di
Lujiazui. Oggi la vista si trova invece a
fronteggiare un esteso, più di
Manhattan, e moderno quartiere per
affari con uno skyline decisamente
avveniristico.
Shanghai, insieme a Hong Kong, ha
rappresentato da sempre la porta
d’accesso alla modernità per la nazione
cinese che usciva dalla sua condizione
di gigante dormiente. La rincorsa a un
progresso che fosse anche ostentazione
di primati ha rappresentato quindi per
la dirigenza cinese una politica da
perseguire con metodo e persistenza (si
pensi alle faraoniche e costosissime
Olimpiadi di Pechino). In vent’anni
dunque il territorio di Pudong si è
infittito di grattacieli in continua
competizione per il primato d’altezza e
l’originalità.
Nell’area solo fino a tre anni fa la scena
era dominata dalla Jin Mao Tower di
SOM, che ostentava il suo dominio
sull’intorno dall’alto dei suoi 420 m,
oltreché in virtù del suo stile
orientaleggiante che ammiccava allo
spirito locale. Ma il suo primato non ha
fatto in tempo a consolidarsi che al suo
cospetto, beffardamente a distanza di
pochi metri, è sorto il nuovo emblema
della modernità cittadina.
La realizzazione dello Shanghai World
Financial Center (SWFC) ha richiesto 11
anni, comprensivi anche di una battuta
d’arresto di circa quattro, coincidente
con una delle più rovinose crisi
finanziarie asiatiche. Il progetto di Kohn Pedersen Fox
interpreta il programma finanziario di un consorzio di
investitori giapponesi guidato dalla Mori Corporation, un
gigante economico con una sua visione della modernità
urbana fatta di densificazione e vertical cities garden.
Il programma iniziale, per un edificio di 97 piani, prevedeva
di superare le mitiche Petronas Towers in Malaysia, ma il
fermo del cantiere e il protrarsi nel tempo della
realizzazione ha richiesto, alla ripresa nel 2003 per
conservare il primato, un’addizione per raggiungere, con i
suoi attuali 101 piani, i 492 m. Seguendo uno schema, sia
statico che funzionale, che trova nel J. Hancock Center di
opere
Shanghai World Financial Center (SWFC), Shanghai, Cina
Cronologia: 1997-2008 (realizzazione)
Altezza antenna: 492 m
Piani: 101
Ascensori: 91
Foto: Maurizio Gargano
opere
SOM a Chicago del 1968 il capostipite di questo genere, il
progetto prevede che intorno a un nocciolo centrale,
fortemente inerziale costituito dal sistema delle connessioni
verticali (scale, ascensori e tecnologico), si sviluppi
anularmente lo spazio servito per un totale di 358.000 mq.
Realizzando in termini funzionali un mix che garantisce la
compresenza di attività commerciali, lavorative e residenziali
e dunque rifugge dai limiti e dalla scarsa attrattiva degli
edifici monofunzionali.
Sulla base di canoni ormai classici l’edificio modula il suo
volume in tre segmenti (basamento-fusto-coronamento)
corrispondenti funzionalmente alle differenti attività insediate.
Solidamente incardinato su un “podio” compatto e massivo
che lo radica fortemente al suolo, il volume affonda per tre
piani sotto il livello di terra a realizzare un capace parcheggio,
ed emerge per cinque con un vasto e sontuoso centro per il
commercio. Su questa sorta di piedistallo si erge poi,
affusolato e lucente con la sua pelle vitrea priva di asperità, il
fusto del corpus principale costituito per 70 piani (7-77) da
spazi per ufficio e per altri 15 (79-93)
dall’ennesimo lussuoso ed esclusivo
hotel. Con un ultimo guizzo, infine, a
coronare il suo bisogno di
primato, la stele si conclude
con un maestoso, e forse
retorico se non inutile,
portale che
L’edificio affusolato e lucente, simbolo della modernità cittadina, svetta a pochi
metri di distanza dalla Jin Mao Tower
Il volume principale disegnato sull’intersezione di due archi permette di
ridurre la resistenza alle forze orizzontali
architetture
59
opere
architetture
60
assicura però ai visitatori paganti della galleria belvedere
un’esperienza visiva unica e incomparabile.
Nell’allegoria dei segni, che poggia nella tradizione cinese, il
prisma basale allude alla terra mentre i due archi, dalla cui
intersezione si genera il volume principale, rappresentano il
cielo. E dunque l’edificio si pone come elemento di legame
La galleria belvedere offre ai visitatori un punto di vista unico sulla città
di Shanghai
tra i due. Ma l’argomento sembra debole se è vero come è
vero che il grattacielo in quanto tale, per sua natura, è nato
per scalare il cielo. Rimane il dato ingegneristico, quello sì
ineludibile, di alleggerire e rastremare il volume per ridurre la
resistenza alle forze orizzontali e, a parità d’altezza, il peso
complessivo del gigante.
Alcune immagini della grande vetrata panoramica
61
architetture
Infine, se è vero che il veleno sta nella coda, la risoluzione
formale del coronamento ha avuto implicazioni e
connotazioni politiche che hanno sollecitato antiche e mai
sopite idiosincrasie se non ostilità. L’establishment cinese,
che in una visione molto pragmatica si è sempre dimostrato
pronto a recepire e fare proprio qualunque elemento
esterno che significasse modernità e promozione sul piano
internazionale, difficilmente poteva accettare l’idea che un
consorzio d’impresa giapponese realizzasse l’edificio
emblema di Shanghai collocando in sommità un segno (un
tondo) che palesemente richiama il “Sol levante”.
E così, senza tanti rimpianti ma con molto realismo, il sole è
diventato un portale e l’impresa è andata a buon fine. n
opere
D’altronde che la questione sia staticamente rilevante è
confermato dalla necessità di “smorzare” l’oscillazione
apicale dell’edificio – fino a 1 m – in presenza di vento,
adottando un espediente già sperimentato nel 1977 da
Hugh Stubbins nel suo Citicorp Bldg a New York. La
dislocazione infatti al 90° piano di un bilanciere inerziale di
150 tonnellate, monitorato e azionato da computer,
consente di assorbire l’energia trasmessa dal vento, e di
mitigare lo spostamento laterale che genererebbe
condizione di malessere oltreché insicurezza.
opere
architetture
62
Il grattacielo culmina con una grande apertura trapezoidale
opere
L’edificio trova posto in un moderno quartiere per affari con uno skyline
avveniristico
architetture
63