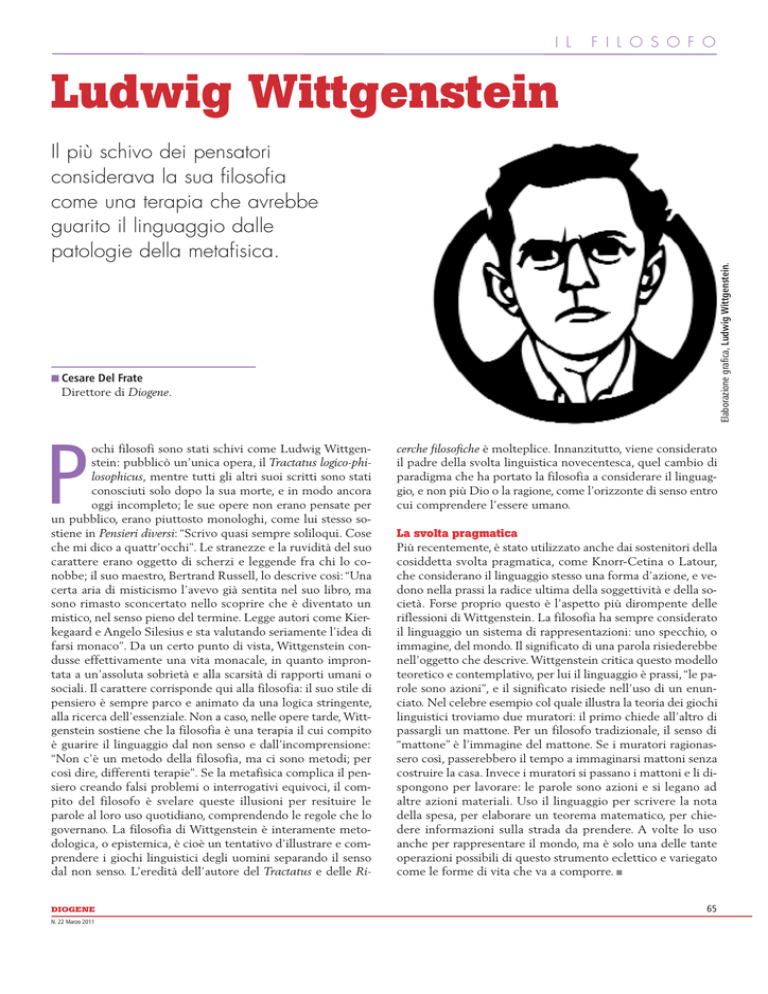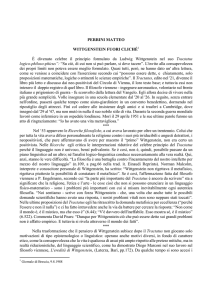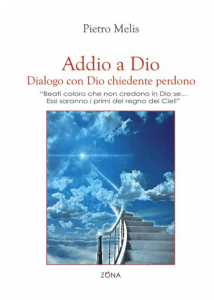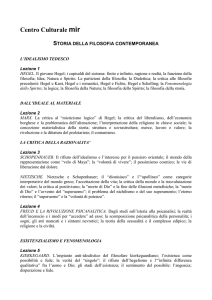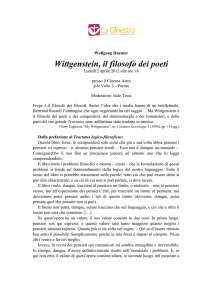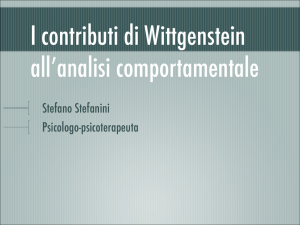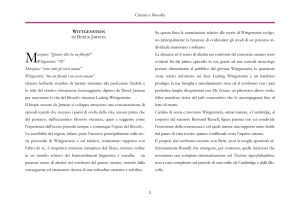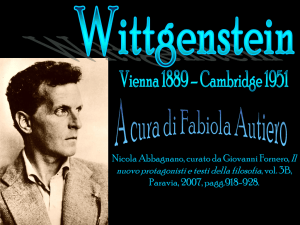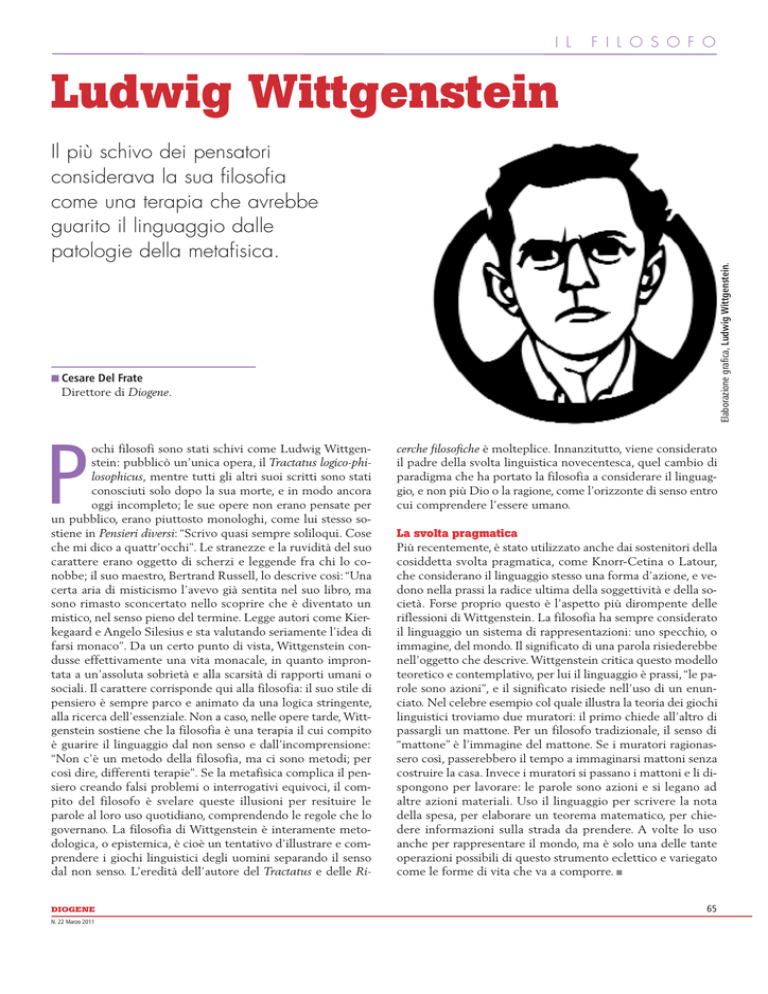
I L
F I L O S O F O
Ludwig Wittgenstein
Elaborazione grafica, Ludwig Wittgenstein.
Il più schivo dei pensatori
considerava la sua filosofia
come una terapia che avrebbe
guarito il linguaggio dalle
patologie della metafisica.
K Cesare Del Frate
Direttore di Diogene.
P
ochi filosofi sono stati schivi come Ludwig Wittgenstein: pubblicò un’unica opera, il Tractatus logico-philosophicus, mentre tutti gli altri suoi scritti sono stati
conosciuti solo dopo la sua morte, e in modo ancora
oggi incompleto; le sue opere non erano pensate per
un pubblico, erano piuttosto monologhi, come lui stesso sostiene in Pensieri diversi: “Scrivo quasi sempre soliloqui. Cose
che mi dico a quattr’occhi”. Le stranezze e la ruvidità del suo
carattere erano oggetto di scherzi e leggende fra chi lo conobbe; il suo maestro, Bertrand Russell, lo descrive così: “Una
certa aria di misticismo l’avevo già sentita nel suo libro, ma
sono rimasto sconcertato nello scoprire che è diventato un
mistico, nel senso pieno del termine. Legge autori come Kierkegaard e Angelo Silesius e sta valutando seriamente l’idea di
farsi monaco”. Da un certo punto di vista, Wittgenstein condusse effettivamente una vita monacale, in quanto improntata a un’assoluta sobrietà e alla scarsità di rapporti umani o
sociali. Il carattere corrisponde qui alla filosofia: il suo stile di
pensiero è sempre parco e animato da una logica stringente,
alla ricerca dell’essenziale. Non a caso, nelle opere tarde, Wittgenstein sostiene che la filosofia è una terapia il cui compito
è guarire il linguaggio dal non senso e dall’incomprensione:
“Non c’è un metodo della filosofia, ma ci sono metodi; per
così dire, differenti terapie”. Se la metafisica complica il pensiero creando falsi problemi o interrogativi equivoci, il compito del filosofo è svelare queste illusioni per resituire le
parole al loro uso quotidiano, comprendendo le regole che lo
governano. La filosofia di Wittgenstein è interamente metodologica, o epistemica, è cioè un tentativo d’illustrare e comprendere i giochi linguistici degli uomini separando il senso
dal non senso. L’eredità dell’autore del Tractatus e delle Ri-
DIOGENE
N. 22 Marzo 2011
cerche filosofiche è molteplice. Innanzitutto, viene considerato
il padre della svolta linguistica novecentesca, quel cambio di
paradigma che ha portato la filosofia a considerare il linguaggio, e non più Dio o la ragione, come l’orizzonte di senso entro
cui comprendere l’essere umano.
La svolta pragmatica
Più recentemente, è stato utilizzato anche dai sostenitori della
cosiddetta svolta pragmatica, come Knorr-Cetina o Latour,
che considerano il linguaggio stesso una forma d’azione, e vedono nella prassi la radice ultima della soggettività e della società. Forse proprio questo è l’aspetto più dirompente delle
riflessioni di Wittgenstein. La filosofia ha sempre considerato
il linguaggio un sistema di rappresentazioni: uno specchio, o
immagine, del mondo. Il significato di una parola risiederebbe
nell’oggetto che descrive. Wittgenstein critica questo modello
teoretico e contemplativo, per lui il linguaggio è prassi, “le parole sono azioni”, e il significato risiede nell’uso di un enunciato. Nel celebre esempio col quale illustra la teoria dei giochi
linguistici troviamo due muratori: il primo chiede all’altro di
passargli un mattone. Per un filosofo tradizionale, il senso di
“mattone” è l’immagine del mattone. Se i muratori ragionassero così, passerebbero il tempo a immaginarsi mattoni senza
costruire la casa. Invece i muratori si passano i mattoni e li dispongono per lavorare: le parole sono azioni e si legano ad
altre azioni materiali. Uso il linguaggio per scrivere la nota
della spesa, per elaborare un teorema matematico, per chiedere informazioni sulla strada da prendere. A volte lo uso
anche per rappresentare il mondo, ma è solo una delle tante
operazioni possibili di questo strumento eclettico e variegato
come le forme di vita che va a comporre. K
65
I L
F I L O S O F O
Nel Tractatus logicophilosophicus,
l’unico saggio
pubblicato mentre
era in vita,
Wittgenstein propone
una riforma
in senso logico
del tradizionale
linguaggio filosofico.
Prospettiva assurda, cortesia flickr.com.
Logica e verità
K David Pears
Filosofo inglese, è stato uno dei maggiori studiosi di Wittgenstein.
66
Nel Tractatus logico-philosophicus di
Wittgenstein, leggiamo che il metodo
corretto della filosofia dovrebbe essere
quello di dire solo proposizioni della
scienza naturale e, quindi, “qualcosa
che con la filosofia nulla ha da fare”.
Qual è il significato di questa relazione
tra scienza e filosofia? Qual era inoltre
l’atteggiamento di Wittgenstein verso il
ruolo della scienza nella società contemporanea?
La relazione che Wittgenstein stabilisce
fra la sua filosofia e la scienza è, in un
certo senso, il tratto più importante del
suo pensiero. Egli percepiva che la filo-
sofia contemporanea - quella del Diciannovesimo e del Ventesimo secolo era dominata dal modello della scienza,
cosicché i filosofi producevano teorie filosofiche della medesima forma di
quelle scientifiche e a questo egli si opponeva profondamente. Pertanto, si potrebbe considerare il suo primo libro, il
Tractatus, come un lavoro simile a
quello di Kant, che limita la scienza alla
sfera che le è propria, mentre lascia la
filosofia libera di svilupparsi indipendentemente da quella.
La relazione tra scienza e filosofia è senz’altro, dal mio punto di vista, una
DIOGENE
N. 22 Marzo 2011
I L
buona chiave per avvicinarsi alla filosofia di Wittgenstein. Ci sono molti altri
modi per accostarvisi, ma la questione
del rapporto tra scienza e filosofia è un
filo rosso che attraversa tutto lo sviluppo del pensiero di Wittgenstein.
Sino alla fine, infatti, egli si oppose all’assimilazione della filosofia alla
scienza, all’idea che la filosofia dovesse
produrre teorie metafisiche modellate
sulle teorie scientifiche, per quanto
prive, naturalmente, della verifica sperimentale che si ha nella scienza. Per
quanto riguarda l’atteggiamento di
Wittgenstein nei riguardi della scienza
si tratta di un argomento assai difficile.
Ciò che Wittgenstein pensava della
scienza è che la tecnologia che essa produce ha avuto, nel complesso, un effetto
molto negativo sulla vita umana.
Egli riteneva che la gente fosse ormai
ossessionata dal possesso, dalle macchine, e che avesse perso semplicemente contatto con la propria esistenza
umana: alludo alle automobili, alla televisione e alla radio. Egli pensava che,
nell’insieme, tutto ciò avesse un effetto
negativo: la sua vita fu estremamente
austera e semplice. Quando era a Cambridge, la sua stanza era arredata con
molto poco, appena due sedie a sdraio,
di quelle da spiaggia, e nessun quadro
alle pareti. I muri erano assolutamente
bianchi come quelli di una stanza
d’ospedale. Viveva in una assoluta semplicità, cosa che ovviamente era una
reazione verso il lusso nel quale era cresciuto da bambino a Vienna.
Ma aveva anche un altro sentimento
verso la scienza e la tecnologia, e cioè
sentiva che la gente era alienata dall’ambiente circostante. A parte l’essere
un filosofo, Wittgenstein progettò una
casa davvero splendida a Vienna, ed era
anche un buono scultore. Egli sentiva
che l’esistenza umana si era andata deteriorando a partire dalla metà del Diciannovesimo secolo. Tuttavia questo
suo atteggiamento è qualcosa di diverso
dalla sua posizione teorica: sono due
cose differenti. Da una parte, infatti, sul
piano teorico, egli si oppose al predominio della scienza nella filosofia, dall’altra, dal punto di vista della vita
quotidiana, egli semplificò la propria
esistenza.
Una trattazione a parte merita il rap-
DIOGENE
N. 22 Marzo 2011
porto tra Wittgenstein e Freud; Wittgenstein è affascinato da Freud, il quale
proviene dal medesimo ambiente viennese. Un paziente sotto terapia, secondo Wittgenstein, è persuaso
dall’analista, dal terapeuta, a considerare la propria vita e i propri sentimenti
in una nuova luce. Secondo Wittgenstein, anche se personalmente non condivido una simile veduta, il mito
implicito nella teoria freudiana consiste
nell’affermazione che vi sono degli
eventi risalenti ai primi anni di vita, racchiusi nell’inconscio del paziente, che
vengono rivelati solo in analisi e che
questi non sono solo eventi inconsci,
ma anche eventi connessi causalmente.
Questa impostazione produce una specie di versione psicologica della fisica,
una psicologia costruita analogamente
alla fisica, che certamente era ciò che
Freud intendeva realizzare e che era, secondo Wittgenstein, un mito. In realtà,
secondo lui, è possibile solo che un
abile analista riesca a persuadere il paziente a considerare la sua vita passata
sotto una nuova luce, a vederne nuovi
aspetti e nuove relazioni, ma non a scoprire eventi che hanno avuto luogo nel
suo inconscio.
Nel Tractatus Wittgenstein cerca di
scoprire l’essenza della proposizione.
Perché la nozione di proposizione è
così importante?
Wittgenstein era un autentico filosofo
dei filosofi. Cioè, egli scriveva filosofia
per i filosofi, avendo altri filosofi in
mente quali suoi interlocutori. Aveva
l’idea, non del tutto originale, che il
modo migliore di esaminare il pensiero
umano fosse di prendere il linguaggio e
di analizzarlo scomponendolo nei suoi
elementi più semplici. L’analogia è con
l’atomismo della fisica antica, vale a
dire con l’idea che, se si vuole comprendere la struttura delle diverse sostanze, le si deve analizzare riconducendole alla loro struttura atomica.
Ebbene, Wittgenstein condivideva questa idea a proposito del pensiero e delle
proposizioni che esprimono i pensieri:
era necessario scomporli nei loro elementi più semplici sino a mostrare esattamente quale fosse l’essenza del
pensiero umano. Wittgenstein non voleva riformare il linguaggio, poiché nel
F I L O S O F O
Tractatus egli stesso afferma che il linguaggio quotidiano è perfettamente in
ordine così come esso è. La sua idea era,
invece, che dietro al linguaggio di tutti
i giorni ci fosse un altro linguaggio
molto più accurato e molto più perfettamente strutturato, nel quale il linguaggio ordinario poteva essere
tradotto. Quando scrisse il Tractatus,
egli pensava di produrre uno schema
per la traduzione del linguaggio ordinario in questo linguaggio molto tecnico
basilare. La ragione era che egli voleva
mostrare ciò che ha senso e ciò che è
privo di senso. Credeva che una larga
parte della filosofia fosse non senso e
che, quindi, l’unico modo di correggere
questa situazione fosse quello di produrre un’analisi esaustiva di ogni cosa
che potesse essere legittimamente
detta, analizzandola sino ai suoi elementi fondamentali. In questo modo, si
sarebbe ottenuta una specie di mappa
di ogni possibile linguaggio e, quindi, di
ogni possibile insieme di proposizioni.
In quest’ottica, ogniqualvolta ci si trova
di fronte ad affermazioni filosofiche imbarazzanti, le si può osservare, interrogandoci se l’affermazione o le
affermazioni in questione possono trovare posto nella mappa. Se la risposta è
affermativa, la proposizione può essere
accettata, altrimenti, ci troviamo di
fronte a un’incomprensione, vale a dire
a un uso improprio del linguaggio, che
non ha senso. Questo era lo scopo del
lavoro di Wittgenstein sviluppato nel
Tractatus.
In quale misura le idee di Wittgenstein
sono debitrici dei lavori di logica e di
filosofia della matematica di Frege e di
Russell? Inoltre quanto hanno influito
Kant e la tradizione kantiana sul Wittgenstein del Tractatus?
Frege e Russell furono coloro che ebbero la maggiore influenza su questa
parte del lavoro di Wittgenstein. E la
cosa principale che egli trasse da loro,
da entrambi, fu l’idea di una perfetta
analisi del linguaggio. Wittgenstein ereditò questa concezione da Frege e fece
uso della logica di quest’ultimo, e naturalmente di quella di Russell, per costruire lo schema di un linguaggio
perfetto. Da Russell trasse non solamente questo, ma anche l’idea che la
67
I L
F I L O S O F O
struttura apparente di una proposizione
può differire molto dalla sua struttura
reale, profonda. Se si prende una frase
ordinaria, che sembra dica una certa
cosa, e la si analizza, può risultare che
essa sia sorprendentemente diversa.
Queste furono le due principali influenze sul Tractatus.
Come Wittgenstein stesso affermò nella
prefazione, il suo debito principale fu
verso Frege e Russell. Occorre anche ricordare l’importanza rivestita dalla filosofia kantiana. Penso che la cosa più
semplice da dire sia che il sistema di
Wittgenstein nel Tractatus è una specie
di versione linguistica di Kant, della filosofia kantiana. Ovviamente, una simile affermazione è assai imprecisa.
Non dobbiamo dimenticare che Kant
ha tentato di mostrare la validità delle
categorie scientifiche e del modo in cui
noi costruiamo il mondo usando le nozioni di causa ed effetto, di spazio e
tempo. E contemporaneamente ha cercato di porre a tutto questo dei limiti,
di tracciare un confine netto, affermando che al di là di questo confine ci
sono l’etica e l’estetica. Questo era in
realtà anche il programma di Wittgenstein nel Tractatus. Ovviamente egli
fece uso di metodi molto diversi da
quelli di Kant, perché la sua indagine è
per intero linguistica o logica, mentre
quella di Kant è una ricerca concettuale. Ma lo scopo è lo stesso e gli esiti
non sono poi così dissimili. Il risultato
infatti è dare alla conoscenza scientifica
e fattuale una base assolutamente sicura
e solida, innanzitutto, e quindi, di limitarne l’ambito, in modo tale che al di
fuori si trovino altre sfere del pensiero
come l’etica e l’estetica. Rimane naturalmente il problema della metafisica:
certamente il modo in cui Wittgenstein
ne diede conto fu diverso da quello di
Kant. Questo è l’autentico rapporto esistente fra la filosofia di Kant e quella di
Wittgenstein.
Wittgenstein sostiene che mostrare
l’essenza di una proposizione significa,
allo stesso tempo, mostrare l’essenza di
ogni possibile descrizione, e quindi del
mondo. Cosa significa?
Nel Tractatus, egli combatte l’idea che
la filosofia debba produrre teorie analoghe alle teorie scientifiche, per quanto
68
prive di verifica. D’altro lato, chiaramente, il sistema del Tractatus è esso
stesso una teoria sulla natura del
mondo. Wittgenstein credeva, infatti,
che, una volta arrivati al livello fondamentale in cui il linguaggio è completamente analizzato, le proposizioni
corrispondano esattamente ai fatti del
mondo. E osservando questo linguaggio,
attraverso di esso, si vede la struttura essenziale del mondo, alla quale le proposizioni corrispondono. Solo se si è
capaci di chiarire perfettamente il proprio linguaggio e i propri pensieri, si è
in grado di vedere, attraverso questi, la
reale natura del mondo. Questa è la
concezione del Tractatus. In questo
senso, si potrebbe dire che il libro
adotta una metafisica realistica. In seguito, però, Wittgenstein abbandonò
questa concezione e abbracciò l’idea,
del tutto diversa, che la credenza che il
linguaggio corrisponda al mondo sia
semplicemente una conseguenza del
nostro limitato punto di vista. Si vede
il mondo attraverso il linguaggio, e si
pensa che ciò sia una corrispondenza
perfetta, ma la ragione per cui essi sembrano corrispondere è che si portano
questi occhiali da cui si guarda il
mondo. Dopo il Tractatus, quindi, egli
abbandonò l’idea di un linguaggio atomico corrispondente perfettamente alla
realtà. Naturalmente molti altri, oltre
Wittgenstein, hanno avuto questa idea
del linguaggio come raffigurazione del
mondo. Mi torna in mente, a tal proposito, un racconto di uno scrittore inglese, William Golding, intitolato The
Inheritors, che narra di persone che vissero prima dell’uomo di Neandertal e
che comunicavano l’un l’altra per
mezzo d’immagini: invece di pronunciare frasi, esse si inviavano telepaticamente immagini. È solamente un
esempio dell’idea del tutto naturale che
una frase sia un’immagine. Se si spiega
la grammatica ai bambini, un modo per
farlo è quello d’illustrare il parallelismo
fra le parole in una frase e i particolari
di un disegno. Credo perciò che sia
un’idea alquanto naturale e non una sofisticata invenzione dei filosofi. Come
si presenta in Wittgenstein tale concezione? Egli riteneva che la natura ultima della realtà del mondo, questa è la
sua teoria metafisica, consistesse di og-
getti che, combinati in certi determinati
modi, rendono vere le proposizioni basilari. E la natura essenziale del mondo,
secondo questa concezione, era che una
qualsiasi combinazione o esiste o non
esiste, senza che si dia una terza possibilità. Pertanto, una proposizione del
linguaggio fondamentale è o vera o
falsa, senza una terza alternativa. Per capire perché la proposizione è come
un’immagine o un quadro può essere
utile il seguente esempio: se si disegna
una pianta di Roma e il Vaticano viene
posto a Nord di un determinato edificio
in cui ci si trova, dobbiamo dire che il
Vaticano, rispetto all’edificio preso
come punto di riferimento, è a Nord
oppure non lo è. In realtà, è vero che
questo non è un esempio completamente soddisfacente, perché entrambi,
sia il Vaticano che l’edificio di riferimento, potrebbero trovarsi esattamente
alla stessa latitudine, tuttavia, esso serve
a rendere più chiara l’idea della teoria
della proposizione-immagine.
Una proposizione è, infatti, un’immagine della realtà perché mostra l’organizzazione e le relazioni reciproche
degli oggetti nel mondo. E tali relazioni
o sono come la proposizione ce le presenta oppure no. La proposizione o è
vera o è falsa, senza altre alternative. Si
tratta di una logica bivalente.
Wittgenstein sostiene che le dimostrazioni logiche sono senza senso. Ma
d’altra parte afferma che una proposizione dotata di senso è una raffigurazione di un fatto in virtù della sua
struttura logica. Qual è il ruolo della logica nel Tractatus?
Sembra paradossale sostenere che una
verità logica sia senza senso, perché “se
P allora Q” è una verità logica che sembra avere perfettamente senso. Ebbene,
per comprendere, è necessario fare una
distinzione: una cosa è una proposizione priva di senso, che è totalmente
inservibile e da buttare via, altra cosa,
invece, è una proposizione che non
esprime una possibilità che sia o vera o
falsa.
Ora, una proposizione logica appartiene a quest’ultima classe. Non è qualcosa che possa essere vero o falso. Se
qualcuno sottoponesse a prova sperimentale la proposizione citata prima,
DIOGENE
N. 22 Marzo 2011
I L
DIOGENE
N. 22 Marzo 2011
L’illusione ottica del vaso e dei due profili.
Giochi di parole e di immagini
I filosofi del passato avevano la presunzione di spiegare l’essenza delle cose
usando, come strumenti, le parole. Ma queste, obietta Wittgenstein, non hanno
senso in sé, non esprimono un significato univoco ma lo assumono in relazione
all’uso che ne facciamo, soprattuto nella dimensione ordinaria, originaria e quotidiana del linguaggio. Le parole, quindi, formano “giochi linguistici” che è inutile spiegare, dato che possono essere capiti solo giocando lo stesso gioco, ossia
partecipando in prima persona ai fenomeni di cui si tratta.
Lo stesso discorso vale per l’immagine: quella qui sopra rappresenta un vaso centrale o due profili di teste contrapposte? Sia l’una che l’altra riposta sono vere e
possibili, ma, si noti, non possono coesistere. Si vede il vaso oppure le due teste,
alternativamente, e la scelta è sempre il frutto di una nostra libera decisione, in
un certo senso dall’uso che vogliamo fare dell’immagine.
Come esempio di immagine paradossale Wittgenstein propose la celebre illussione ottica dell’anatra-coniglio, qui sotto, già studiata dallo psicologo statunitense Joseph Jastrov, ma esistono innumerevoli immagini, architetture e persino
oggetti tridimensionali egualmente paradossali,
di cui le immagini in questa sezione
offrono un esempio.
L’illusione ottica dell’anatra e del coniglio.
direi che questi ha semplicemente
frainteso questa proposizione.
Ho provato questa esperienza durante
la guerra. Ero topografo nell’esercito
per un reggimento d’artiglieria. Facevamo delle mappe di siti in campo
aperto per mezzo di triangolazioni, di
metodi trigonometrici. Era un lavoro
molto faticoso; si doveva camminare attorno a questi immensi triangoli per registrare le osservazioni. Un giorno,
durante l’inverno, il mio assistente e io
ripetemmo più volte l’operazione e il
triangolo risultava sempre avere 190
gradi, cioè più di due angoli retti. Allora
gli dissi: “Come possiamo essere certi
che non si tratti semplicemente di un
triangolo eccezionale, un triangolo con
190 gradi? Insomma abbiamo solo
avuto sfortuna”.
Chiaramente si tratta della mancata
comprensione di una verità matematica; allo stesso modo, quando si tenta
di mettere alla prova sperimentalmente
una proposizione logica, vuol dire che
non la si è compresa. Egli pensava che
la logica ci dia la struttura ultima del
linguaggio, il linguaggio basilare e perciò il mondo, questa era la sua idea. Egli
credeva che, partendo dal livello fondamentale con quella che egli chiamava la
proposizione elementare, che può essere o vera o falsa senza altre possibilità, si potessero combinare queste
proposizioni elementari in molti modi
usando le connessioni logiche, così costruendo proposizioni sempre più complesse. In questa maniera tutto ciò che
può essere detto risulterebbe da una
combinazione di proposizioni elementari: tutto ciò che può essere detto e
che abbia un senso, vale a dire che possa
essere vero o falso. E la logica, pensava
Wittgenstein, esibisce davvero la struttura di questo sistema linguistico. Egli
riteneva che la logica, nella sua interezza, fosse realmente basata sui valori
di verità, vale a dire pensava che la verità di ogni formula logica dipendesse
interamente dalla verità delle proposizioni di base, le proposizioni elementari, e che queste mostrassero la
struttura del mondo.
La sua visione della logica era quindi in
realtà assai differente da quella di Frege
e di Russell, in quanto egli credeva che
ciò che la logica tratta non siano le di-
F I L O S O F O
69
I L
F I L O S O F O
“
Ogni affermazione vera in geometria
per essere ritenuta valida deve essere
evidente per mezzo dell’intuizione spaziale.
Wittgenstein fece propria questa idea
e la applicò alla logica.
mostrazioni o i teoremi, ma semplicemente il fatto che certe determinate
combinazioni, per la loro propria natura, siano verità logiche, certe altre
contraddizioni, e tutto ciò che sta nel
mezzo, siano proposizioni contingenti,
vale a dire vere o false. Per Wittgenstein,
quindi, la logica fornisce effettivamente
la struttura del mondo. Ma le proposizioni della logica non sono proposizioni
allo stesso modo delle proposizioni ordinarie, tutt’altro.
Questa idea viene in effetti da Schopenhauer. Se si legge Il mondo come volontà e rappresentazione c’è un capitolo
sulla geometria, che Wittgenstein ha
letto, nel quale Schopenhauer dice che
Euclide sbaglia nell’istituire la geometria come insieme di assiomi e teoremi,
in quanto ogni affermazione vera in
geometria per essere ritenuta valida
deve essere evidente per mezzo dell’intuizione spaziale, e non richiede una dimostrazione. Wittgenstein fece propria
questa idea e la applicò alla logica.
Nel Tractatus incontriamo la nozione
di “mistico”, che Wittgenstein definisce
nel seguente modo: “Mistico è ciò che
non può essere detto, ma che si mostra
da sé”. Questa non è una formulazione
usuale di mistico. Che cosa intende
Wittgenstein con la sua definizione?
Suppongo che ordinariamente il termine mistico si riferisca a colui che è direttamente in contatto con il mondo
spirituale, o qualcosa del genere. Wittgenstein usa l’idea, la parola mistico in
modo molto diverso. Per lui il mistico
include tutto ciò che non può essere
espresso nel linguaggio scientifico e fattuale. Quindi, e questo è un tratto pa70
radossale del Tractatus, le cose che si
possono dire, affermare, si limitano alle
affermazioni fattuali del tipo: questo tavolo è fatto di legno o di qualunque
altra cosa; o alle affermazioni scientifiche, alle teorie e questo è tutto ciò che
può realmente essere detto, tutto ciò
che ha un senso letterale.
Tutto il resto si divide in due categorie.
Innanzitutto affermazioni senza senso
prive di qualsiasi significato; e dall’altro
il mistico, che include l’insieme del sistema filosofico del Tractatus, qualcosa
che dunque, strettamente parlando, può
solamente essere mostrato e che non
può essere espresso in un linguaggio
fattuale.
Esso comprende anche l’etica, l’estetica
e la religione: tutte queste cose appartengono alla medesima categoria del
mistico. Il mistico è perciò quella parte
di un indice che chiameremmo miscellanea: tutto ciò che non può essere classificato come scientifico o fattuale
diviene parte del mistico, a condizione
ovviamente che non sia privo di senso.
Pertanto, il concetto di mistico in definitiva si potrebbe definire un concetto
negativo: ciò che tutte queste cose
hanno in comune è una caratteristica
negativa, il non poter essere espresse
nel linguaggio fattuale. Ma ovviamente
le differenze fra le varie cose raccolte
sotto l’etichetta di mistico sono enormi.
Wittgenstein visse fra due mondi, la
Vienna di Kraus e la Cambridge di
Russell. A quale di questi mondi appartenne di più?
Appartenne sempre a entrambi. Il
tratto più significativo, almeno nei suoi
saggi, che si può far risalire a Vienna, è
l’ironia, il carattere epigrammatico dei
suoi scritti, il distacco e la serietà sottostanti. Wittgenstein fu profondamente
influenzato da Karl Kraus, ma anche da
molti altri scrittori viennesi. La cosa
però che più colpisce della sua eredità
viennese è il disinteresse nell’afferrare
pensieri precisi ed esprimere i pensieri
individuali in modo convenzionale in
un libro ordinario. Egli sentì sempre che
i pensieri hanno una vita propria e affermò, molte volte, l’impossibilità di
poterli esprimere attraverso un libro
con un inizio e una fine.
L’unica espressione veramente accurata
dei suoi pensieri è un breve epigramma
perfettamente escogitato e racchiuso in
un paragrafo. Credeva, infatti, che essi
avessero una specie di esistenza autonoma, che sarebbe stata stravolta se si
fosse tentato di forzarli entro un capitolo di un libro. Questa è certamente
l’eredità più cospicua che gli derivò dall’ambiente viennese. Per quanto riguarda l’Inghilterra, credo che
l’influenza della filosofia sviluppatasi a
Cambridge e quella di Russell fosse
molto forte nel 1912, quando lavorò
con lui per la prima volta. Non fu lui
che lo avvicinò alla filosofia, allora
aveva già letto Schopenhauer e altri autori. Wittgenstein però, sebbene non
per lungo tempo, fu profondamente influenzato dall’atomismo della filosofia
di Russell, molto simile a quello della
sua prima filosofia.
Ma fu proprio questo atomismo logico,
caratteristico del periodo del Tractatus,
a scomparire più decisamente nel suo
pensiero più tardo. Ciò che conservò,
invece, della filosofia inglese fu l’idea
che si dovesse essere assolutamente accurati nell’analisi di una frase, accuratezza che, nell’ultima fase della sua
filosofia, impiegò nella descrizione di
un gioco linguistico. In questo senso, la
Cambridge del filosofo e logico Moore
ebbe su di lui un’influenza decisiva.
Non perché la sua filosofia fosse simile
a quella di Moore, ma nel senso che
questa specie di totale onestà intellettuale, a mio parere, gli derivò dal suo lavoro in Inghilterra. K
Tratto da: D. Pears, Linguaggio e mondo
nel Tractatus di Wittgenstein, EMS Rai,
1989.
DIOGENE
N. 22 Marzo 2011
I L
F I L O S O F O
Illusione ottica in architetura, cortesia panoramio.com.
Regole e paradossi
Le regole sono comprensibili solo a partire dalla loro stessa applicazione,
non in base a misteriosi processi mentali o a interpretazioni intellettualistiche.
C
he cosa significa, in cosa consiste, seguire correttamente
una regola? “Ma come può
una regola insegnarmi che
cosa devo fare a questo
punto?”, si chiede Wittgenstein nelle
Ricerche filosofiche. Egli ritiene che due
siano i tipi di risposta che i filosofi
hanno per lo più dato a questo interrogativo: secondo alcuni dobbiamo rispondere alla domanda riconoscendo
che le conseguenze di una regola “esistono già, in un senso ideale di esistere,
prima di essere tratte”, che le conseguenze sono contenute in una regola
“come una collana di perle in una scatoletta, dobbiamo soltanto tirarla fuori”.
Secondo questa prospettiva è come se
la regola tracciasse “la linea della sua
propria osservanza attraverso l’intero
spazio”. Quando comprendi la regola,
“la tua mente vola, per così dire, in
avanti e compie tutti i passaggi prima
che tu pervenga fisicamente a questo o
quel punto”. Ora, Wittgenstein ritiene
che queste siano solamente delle immagini che si travestono da spiegazioni
e che non fanno che riproporre e moltiplicare, secondo quello che è il destino
di ogni platonismo, la domanda a cui si
illudevano di rispondere: chi, o che
cosa, ci assicura che il punto a cui siamo
fisicamente giunti sia proprio il punto
a cui la regola è già da sempre idealmente giunta? Infatti, “l’assunzione di
DIOGENE
N. 22 Marzo 2011
una prefigurazione del passaggio non ci
porta avanti, poiché non colma lo iato
tra la prefigurazione e il passaggio
reale”.
È di fronte alle difficoltà appena evocate che nasce il secondo tipo di risposta. Una volta riconosciuto che la regola
non anticipa né predetermina “in un
modo singolarissimo” le sue applicazioni, si è infatti spinti ad affermare che
tra essa e ciascuna delle sue applicazioni deve intervenire qualcosa o qualcuno. Eppure, ci sono conseguenze
paradossali a cui conduce la supposizione che tra la regola e la sua applicazione debba sempre intervenire
qualcosa come un’interpretazione.
Se la regola deve essere sempre e comunque interpretata, se tra la regola e
ogni sua applicazione c’è uno iato da
colmare, allora è difficile evitare la conclusione che “qualunque cosa io faccia,
può sempre essere resa compatibile con
la regola mediante una qualche interpretazione”. Ma se qualunque cosa io
faccia può essere messa d’accordo, mediante un’interpretazione, con la regola,
essa potrà anche essere messa, tramite
una diversa ma equivalente interpretazione, in contraddizione con la medesima regola: “A questo punto, però, non
esistono più né concordanza né contraddizione”.
Se il platonismo reifica e mitizza le regole, chi sostiene il ruolo dell’interpre-
tazione le dissolve. Rispetto a questi
due esiti, la mossa di Wittgenstein consiste nel sottolineare che è nell’uso che
una regola è tale. Ciò significa, in primo
luogo, che è seguendo una regola che ne
impariamo il significato, e che capiamo
una regola imparando a distinguere tra
ciò che concorda con essa e ciò che la
contraddice.
Le conseguenze di questa mossa sono
molte e di grande peso. Intanto, non si
danno regole prima e al di fuori delle
varie e differenti pratiche che chiamiamo “seguire una regola”, le quali, a
loro volta, si intrecciano e connettono
nel tessuto complesso e variopinto di
una forma di vita. Inoltre, non è la regola che spiega e fonda una prassi, ma è
nella prassi che la regola vale come tale:
“Per stabilire una prassi non sono sufficienti le regole, ma abbiamo anche bisogno di esempi. Le nostre regole
lasciano aperte certe scappatoie, e la
prassi deve parlare per se stessa”. A un
certo punto, la regola “è la cosa spiegata,
non la cosa che spiega”. K
Tratto da: L. Perissinotto, Le vie dell’interpretazione nella filosofia contemporanea, Laterza, Roma-Bari, 2002.
K Luigi Perissinotto
Insegna Filosofia all’Università
Ca’ Foscari di Venezia.
71
I L
F I L O S O F O
La vita come sfondo
Prospettiva assurda, cortesia flickr.com.
Alle radici di un dialogo possibile tra le culture: certezza, forme di vita,
multuculturalismo a partire da Wittgenstein.
E
K Anna Boncompagni
????
72
cco una delle affermazioni più
significative eppure più difficili
da decifrare di Wittgenstein:
“Ciò che dobbiamo accettare, il
dato, sono – potremmo dire –
forme di vita”. La citazione viene dalla
seconda parte delle Ricerche filosofiche,
scritto, più volte rimaneggiato, corretto
e pubblicato postumo nel 1953. L’indagine wittgensteiniana arriva alla forma
di vita partendo dal linguaggio, tentando di dar conto del modo in cui le
parole assumono significato e contribuiscono a dare forma al nostro vivere.
Nel momento in cui per spiegare il linguaggio perde importanza la prospet-
DIOGENE
N. 22 Marzo 2011
I L
tiva corrispondentista della verità, per
la quale a ogni parola corrisponde un
oggetto e la frase rispecchia una situazione del mondo reale, assume rilievo
l’idea che il senso delle parole venga
non tanto dagli oggetti ai quali corrispondono, quanto dall’uso che di tali
parole facciamo nel parlare quotidiano.
Così, il significato della mia espressione
non lo andrò più a cercare nel mondo
là fuori, ma all’interno del contesto comunicativo nel quale essa è inserita.
Un contesto che non è fatto solo di
altre parole, ma di un insieme di persone, azioni, movimenti, suoni, espressioni facciali, riferimenti culturali,
ambienti, immagini, abitudini, credenze, attese. È a tutto questo che si riferisce l’espressione forma di vita, ed è
tutto questo che (ci dice Wittgenstein)
dobbiamo “accettare” come “dato”.
Se tentiamo di analizzare il linguaggio,
troviamo comportamenti sensati intrecciati tra loro, che contribuiscono
essi stessi a costruire il significato dei
termini, in modo tale che non potremmo mai progettare un’analisi nel
senso tradizionale del termine, cioè una
disamina dell’oggetto per scomposizione in elementi semplici.
Ciò che è sensato
Il dato del quale andiamo in cerca non
può essere un elemento semplice, perché la scomposizione distrugge proprio
il nostro oggetto d’indagine, ce lo toglie
da sotto gli occhi. Ciò che è sensato non
si può analizzare nei termini di elementi non sensati. Il nostro dato è costitutivamente articolato, complesso.
Il dato quindi non è un piccolo mattoncino che, assemblato con tanti altri
piccoli mattoncini, dà luogo a un edificio, l’edificio della conoscenza. Il dato
non è un fondamento. Se troviamo
quello che ci sembra il muro maestro
della casa – ebbene, questo stesso muro
maestro “si potrebbe quasi dire che è
sorretto dall’intera casa”, scrive Wittgenstein in Della certezza.
C’è uno slittamento semantico essenziale che va colto a questo punto: se è
di un dato che andiamo in cerca, non lo
troveremo, miticamente, in un fondamento, ma piuttosto, prosaicamente, in
uno sfondo, nello sfondo che costituisce “l’intero brulichio delle azioni
DIOGENE
N. 22 Marzo 2011
F I L O S O F O
“
Ogni espressione dipende normalmente
da una serie di assunzioni di sfondo,
delle quali non ci rendiamo nemmeno conto.
umane”, per citare sempre Wittgenstein, contro il quale assumono significato le azioni, i concetti, i giudizi, le
reazioni. Ogni espressione infatti, anche
quella il cui significato sembra assolutamente letterale – un’affermazione
come “il gatto è sul tappeto”, per fare
un esempio utilizzato dal filosofo John
Searle – dipende normalmente da una
serie di assunzioni di sfondo, delle quali
non ci rendiamo nemmeno conto, tanto
sono profondamente installate nel nostro modo di vivere.
Che fine farebbero infatti il gatto e il
tappeto, se non tenessimo conto del
fatto che diamo per scontato che ci sia
la forza di gravità? In assenza di gravità,
che significato potrebbero mai avere
“sopra” e “sotto”? Il significato non è
mai indipendente dallo sfondo, e ogni
assunzione di sfondo dipende da innumerevoli altre, in un circuito che però
non rimane sterilmente chiuso in se
stesso: il circolo ermeneutico non è un
mero esercizio d’interpretazione molteplice che si esaurisce nel linguaggio,
perché il linguaggio stesso non è che
uno strumento del nostro vivere, e in
quanto strumento è nel vivere che trova
gli appigli del suo funzionamento.
Il linguaggio è essenzialmente deittico,
si rivolge a qualche cosa che indichiamo, e questa sua natura deittica è
comprensibile solo a partire dal contesto pragmatico-comunicativo nel quale
la frase viene enunciata. Lo sfondo infatti non ha a che fare solamente con il
know that, con il “come stanno le cose”,
ma anche, in un modo difficilmente districabile dal primo significato, con il
know how, con il saper fare le cose e con
il conoscere come si eseguono, coerentemente con un dato contesto e date
caratteristiche naturali e culturali, certe
azioni. È sempre Searle a fornirci qualche indicazione ulteriore sullo sfondo,
che definisce (in una delle tante formulazioni, solo in parte sovrapponibili,
che si trovano nel suo lavoro) “un insieme di capacità mentali non rappresentazionali, che rendono possibile ogni
rappresentazione”.
Certezze e verità
Lo sfondo, il background, afferma, consiste di due componenti: il background
profondo, ovvero le capacità comuni a
tutti gli esseri umani, come il camminare, il percepire e “l’atteggiamento
preintenzionale che tiene conto della
solidità delle cose e dell’esistenza indipendente degli oggetti e delle altre persone” (si noti la complessità filosofica
nascosta dietro queste parole); e un
background locale, corrispondente a
pratiche culturali, come ad esempio il
saper aprire porte o bere dalle bottiglie,
non necessariamente proprie di ogni individuo in ogni tempo e luogo.
È interessante notare che questa distinzione si ritrova, anche se il collegamento non è mai esplicito, nella
letteratura secondaria sul tema della
forma di vita di Wittgenstein. Uno degli
assi del dibattito riguarda infatti proprio
la natura singolare o plurale della forma
di vita; ci si chiede, in altre parole, se
Wittgenstein parlando di forma di vita
intenda riferirsi alle caratteristiche che
accomunano tutti gli esseri umani
(background profondo), oppure alle caratteristiche delle singole culture (background locale).
Un secondo asse del dibattito è se la
forma di vita abbia natura empirica oppure trascendentale, se cioè le caratteristiche del nostro modo di vivere siano
osservabili e descrivibili attraverso un
73
I L
F I L O S O F O
linguaggio, per così dire, neutro rispetto
a esse, o se piuttosto non costituiscano
esse stesse le categorie interpretative attraverso le quali ogni sguardo sul
mondo e sulla nostra stessa natura deve
passare. Se noi proviamo a far lavorare
insieme questi due assi del dibattito –
la natura singolare o plurale della forma
di vita, e la sua natura empirica o trascendentale – troviamo una griglia di
quattro possibili situazioni, che possiamo guardare un po’ più da vicino.
La forma di vita è una e trascendentale:
l’uomo in quanto tale ha determinate
caratteristiche, che costituiscono la
lente attraverso la quale si rapporta al
mondo, a se stesso e agli altri.
Il linguaggio stesso ne è parte integrante. Non è possibile dar conto della
forma di vita, in quanto per poterlo fare
ci si dovrebbe situare fuori da essa, il
che non ha senso.
La forma di vita è plurale e trascendentale: ogni cultura è a se stante. Ognuna
ha il proprio metro di giudizio e non è
possibile alcun dialogo neutrale tra di
esse, perché ogni cultura è in grado di
vedere le altre solo a partire dal proprio
linguaggio. Questo significa, a un
estremo, relativismo più assoluto (perché io riconosco che non potrò mai giudicarti, e nemmeno percepirti per
quello che sei) e all’altro estremo antirelativismo assolutista (proprio perché
comunque non potrò mai rapportarmi
a te in modo neutrale, sono legittimato
a ritenere che soltanto io, nel mio quadro di riferimento, ho ragione).
La forma di vita è una ed empirica: tutti
gli esseri umani condividono alcune caratteristiche di fondo, in parte probabilmente innate in parte acquisite;
appartenendo alla medesima specie,
hanno fondamentalmente lo stesso tipo
di percezioni, si muovono e utilizzano il
corpo in una data maniera, sono dotati
di linguaggio, vivono in forma associata,
tendono a rispondere a determinati stimoli nello stesso modo; la cultura stessa
fa parte della natura umana.
Nel mondo esistono poi forme di vita
animali ma non umane, con le quali
l’uomo si confronta pur non condividendone la natura. La forma di vita è
plurale ed empirica: su molteplici scale,
ogni aggregato umano, dal piccolo
gruppo alla cultura di un popolo o di
74
un’area del globo, costituisce una forma
di vita caratterizzata dalla presenza di
prassi e conoscenze condivise, che
vanno dalle semplici abitudini comportamentali (il modo in cui si dice sì con
il corpo, per esempio) alle forme culturali più alte e complesse. Ogni cultura è
passibile di descrizione empirica attraverso l’osservazione antropologica. Naturalmente questo è solo uno schema e
in quanto tale ha il difetto della… schematicità. Le diverse concezioni della
forma di vita non necessariamente si
escludono a vicenda.
Forme di vita
Negli scritti di Wittgenstein, fra l’altro,
per quanto l’espressione “forma di vita”
compaia solo poche volte, non ne troviamo una caratterizzazione precisa;
piuttosto, prendendo in esame non solo
le Ricerche filosofiche ma anche gli scritti
precedenti e successivi, dalle Note sul
Ramo d’oro di Frazer a Della certezza, si
può identificare un progressivo spostamento da una caratterizzazione di tipo
empirico e plurale a una riflessione che
si avvicina di più, negli ultimi anni, a
certe forme di trascendentalismo che ricordano il Tractatus logico-philosoficus,la
prima opera del filosofo.
A prescindere da ogni intento filologico
o esegetico, quello che sembra interessante sottolineare è che il privilegio che
Wittgenstein stesso accorda a un metodo di tipo osservativo ci può legittimare ad assumere un atteggiamento
antropologico verso la forma di vita.
Un atteggiamento nel quale diverse culture, riconoscendo di essere tutte, per
l’appunto, cultura, siano in grado di
confrontarsi, dialogare e migliorarsi nell’ottica di un interesse superiore.
Naturalmente la possibilità effettiva di
un simile dialogo non va data per scontata, e in questa chiave l’indice migliore
per capire se una cultura è in grado di
confrontarsi veramente con un’altra è
dato dalla capacità di quella stessa cultura di giudicare, criticare e correggere
se stessa. Perché ciò sia possibile, ci suggerisce la filosofa Naomi Scheman, che
prende in considerazione la società occidentale odierna, è essenziale che all’interno della forma di vita esistano e
siano legittimate a parlare alcune posizioni di “marginalità privilegiata” che,
collocandosi al limite della forma di
vita, ne facciano parte ma allo stesso
tempo non si sentano completamente
“a casa”. Proprio il disagio, la critica, l’allargamento di prospettiva che le marginalità privilegiate (la comunità gay, la
comunità nera, la cultura ebraica, i rom
e così via) consentono, danno l’indice
dello stato di salute e della capacità di
dialogo di una cultura.
In questo senso, oltretutto, la filosofia
stessa può ritrovare una propria dimensione nella ricerca di tipo critico, anche
orientata storicamente, volta a delineare
i caratteri propri del modo di vivere di
determinate epoche e culture, e il
modo in cui le prassi vitali hanno dato
luogo, nel tempo, a linguaggi, ideologie,
sovrastrutture. Con l’intento di riuscire
a vedere quel dato di sfondo che, per ritornare alla citazione iniziale di Wittgenstein, è ciò che dobbiamo
“accettare”; dove l’idea dell’accettazione non ha a che fare con una forma
di assenso a prescindere, ma col rispetto, la critica e il confronto. K
A P P R O F O N D I R E
K
F. Cimatti, Il senso della mente. Per
una critica del cognitivismo, Bollati
Boringhieri, Torino, 2004.
K
G. Frongia, Wittgenstein e la diversità degli animali, in R. Egidi (a cura
di), Wittgenstein e il Novecento,
Donzelli, Roma, 1996.
K
A. Gargani, Il sapere senza fondamenti, Einaudi, Torino, 1975.
K
N. Garver, This complicated form of
life. Essays on Wittgenstein, Open
Court, Londra, 1994.
K
N. Scheman, Forms of life: Mapping
the rough ground, in H. Sluga e D.
G. Stern (a cura di), The Camdridge
companion to Wittgenstein, Cambridge University Press, Cambridge,
1996.
K
J. Searle, Intentionality, Cambridge
University Press, Cambridge, 1983.
K
L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche,
Einaudi, Torino, 1999.
K
L. Wittgenstein, Della certezza, Einaudi, Torino, 1999.
DIOGENE
N. 22 Marzo 2011
Prospettiva assurda, cortesia flickr.com.
Oltre la comprensione
La filosofia è forse una raffinata risposta a quella particolare forma di
autismo di cui sembrano soffrire i filosofi, spesso come estraniati dal mondo?
A
K Andy Martin
Insegna Filosofia alla
Cambridge University.
DIOGENE
N. 22 Marzo 2011
vrei dovuto pensarci due
volte prima di pranzare con
uno psicologo: “Sei decisamente autistico”, mi ha
detto, “Cosa?!”, “Proprio
così, lo si capisce anche dal tuo stupore,
come volevasi dimostrare”. La sua provocazione ironica consisteva nel fatto
che se non avessi accettato la sua descrizione, allora avrei manifestato tendenze autistiche.
Una particolare conversazione intercorse fra Ludwig Wittgenstein, durante
un suo esame, e i filosofi Bertrand Rus-
sel e G. E. Moore, a Cambridge nel
1929. Wittgenstein stava presentando il
suo Tractatus Logico-Philosophicus, saggio già famoso scritto nel 1921 come
tesi di dottorato. Russel e Moore stavano obiettando che non comprendevano un passo del libro quando vennero
bruscamente interrotti da un Wittgenstein decisamente irritabile: “Non mi
aspetto che lo capiate!”.
Ho sempre pensato che la risposta del
filosofo fosse altezzosa, che mostrasse
troppa sicumera e mancanza di rispetto.
Ma, se l’autismo può essere definito
75
I L
F I L O S O F O
come incapacità di comprendere gli
altri, è allora plausibile che Wittgenstein stia qui facendo un’affermazione
filosofica, piuttosto che stigmatizzare i
limiti dei suoi interlocutori. Si potrebbe
parafrasare quanto da lui enunciato in
questo modo: “Grazie, signori, per aver
sollevato il problema della comprensione. Il fatto è che, in generale, non mi
aspetto che le persone capiscano
quanto ho scritto. E non perché abbia
scritto qualcosa di criptico, o ellittico, o
di difficile interpretazione, ma perché
non ci è mai dato, come soggetti, di capire pienamente quanto altri dicono o
scrivono. E questa è la ragione per cui
non mi aspetto che comprendiate il
problema dell’incomprensione”.
Il problema dell’incomprensione
Se Wittgenstein stava facendo una simile affermazione, allora ciò offrirebbe
una prospettiva illuminante da cui leggere il Tractatus, dove andrebbe ripensata l’insistenza sulla “proposizioni che
non dicono nulla”, solitamente interpretata come la questione del “mistico”:
“Ma v’è dell’ineffabile. Esso mostra sé, è
il Mistico”. Piuttosto che segnare una
cesura netta fra due tipi di proposizione, da una parte quelle ben formate
e intelligibili (la scienza), dall’altra
quelle vaghe, dubbie e mistiche (etica
ed estetica), dovremmo ammettere che,
dato il modo in cui gli uomini interagiscono, c’è sempre, almeno potenzialmente, un mistero celato fin nelle
proposizioni più elementari. È difficile
immaginare di poter riuscire a eliminare completamente ogni residuo di
oscurità, la possibilità dell’incomprensione che si annida sempre in ogni affermazione.
A volte Wittgenstein ritiene di aver risolto il problema, altre no, “la risoluzione del problema della vita si scorge
allo sparire di esso”, scrive nel Tractatus.
E come dovremmo interpretare le
dense, elegiache e forse incomprensibili
ultime righe di questo testo, “su ciò di
cui non si può parlare, si deve tacere”?
Forse Wittgenstein sta qui suggerendo:
“Sono autistico” o, per dirla in altri termini, l’autismo non è un’anomalia esotica ma una costante dell’essere umano.
Probabilmente sto fraintendendo il
testo: se l’ho compreso correttamente,
devo necessariamente fraintenderlo.
Comunque, Wittgenstein è stato frequentemente definito autistico. La psichiatra Sula Wolff, ad esempio, in
Loners, the life path of unusual children,
analizza il filosofo come un caso da manuale della sindrome di Asperger, una
variante dell’autismo, una delle sue
forme meno gravi ed evidenti ma che
ciò nonostante comporta l’inabilità nel
gestire le relazioni sociali.
Wittgenstein ammette di avere difficoltà nel comprendere il significato
delle altrui espressioni o azioni; in un
appunto scrive: “Tendiamo a percepire
la lingua cinese come un gorgoglio inarticolato. Chi conosce il cinese invece riconosce in quei suoni il linguaggio.
Nello stesso modo, spesso non riesco a
riconoscere l’umanità di un altro essere
umano”. Il che potrebbe anche spiegare
il passo delle Ricerche filosofiche in cui
sostiene che, se anche un leone potesse
parlare, noi non lo capiremmo.
Filosofi autistici
Wittgenstein non è il solo, anche un
altro filosofo, Russell, è stato definito
autistico. È ipotizzabile che Wittgenstein, quando gli dice di non aspettarsi
che questi lo comprenda, intendesse
dire: “Sei autistico!”. O, se avesse avuto
una macchina del tempo, avrebbe potuto dire: “Se devo credere a quanto sostengono Wolff e altri psichiatri, noi
due siamo autistici. Forse lo sono tutti i
Prospettiva assurda, cortesia flickr.com.
76
DIOGENE
N. 22 Marzo 2011
I L
filosofi; è la ragione per cui finiamo a
studiare filosofia”.
Non intendo affermare che tutti i filosofi siano autistici nel senso clinico del
termine. Ma prendiamo una famosa
sentenza di Sartre: “L’inferno sono gli
altri”. L’autismo, con la sua intrinseca
povertà di contatti affettivi, non potrebbe spiegare queste parole? La paura
dei volti e dello “sguardo dell’altro” analizzati da Sartre ne sono sintomi classici. Sartre riconosce questo fenomeno
in se stesso e in altri: definisce esplicitamente Flaubert come “autistico” nel suo
grandioso studio sullo scrittore, L’idiota
di famiglia, e afferma pure “Flaubert
sono io”. La tesi di Sartre, secondo cui
Flaubert cresce autistico e tutto ciò che
scrive, cercando ad esempio di immedesimarsi nella personalità di Madame
Bovary, sia una forma di compensazione, potrebbe essere facilmente applicata al filosofo stesso.
Un’implicazione degli studi sull’autismo potrebbe suonare pressappoco
così: tu, filosofo, sei incline alla filosofia
proprio perché non afferri ciò che gli
altri ti dicono. Tu, come Wittgenstein,
sei abituato ad ascoltare o leggere proposizioni, ma le percepisci come prive
di significato, o come se fossero pronunciate o scritte in cinese. In altre parole, la filosofia sarebbe la tendenza a
interpretare le altrui proposizioni come
fossero puzzle di difficile comprensione.
Un buon meccanico
Forse è in questo senso che Wittgenstein sostiene che per essere un buon filosofo dovresti diventare un buon
meccanico d’auto (mansione che egli
effettivamente svolse durante la Prima
guerra mondiale). La riparazione delle
macchine funge qui da metafora del linguaggio: sappiamo d’altronde che Wittgenstein elaborò la sua prima teoria a
riguardo mentre si trovava a Parigi studiando i referti giudiziari di un incidente automobilistico.
Le radici della teoria della rappresentazione (i modelli usati in tribunale per
raffigurare l’evento) e della definizione
ostensiva (tutte quelle frecce ed etichette) sono già tutte qui. Ma al centro
dell’episodio c’erano due macchine e
una collisione. Forse il linguaggio po-
DIOGENE
N. 22 Marzo 2011
trebbe essere visto come un’automobile, realizzata per condurti da A a B,
portando un certo carico di informazioni, ma passibile di rimanere bloccata,
o di incepparsi, o di subire un incidente,
dovendo di conseguenza essere riparata.
Una simile concezione meccanica del
linguaggio è affine alla logica autistica,
che capisce i sistemi molto meglio delle
persone. Gli autistici non sono empatici, sono invece estremamente sensibili
all’ordine e alle categorizzazioni sistemiche, come la matematica.
Il punto a cui voglio arrivare è che la
maggioranza dei meccanici è composta
da uomini piuttosto che donne. Solitamente gli autistici sono maschi: il rapporto rispetto alle femmine è di 4 a 1
(di 10 a 1 nella sindrome di Asperger).
Lo psichiatra che diede il nome a quest’ultima sindrome scrisse che la mente
autistica è “una variante estrema dell’intelligenza maschile”.
Comprendere non è tutto
In maggioranza i filosofi sono maschi:
persino sul blog filosofico del “New
York Times” sul quale scrivo il rapporto
è di 4 a 1. Uno psicologo potrebbe dire:
“la filosofia riguarda la creazione di sistemi di pensiero tramite una logica
dura e fredda, mentre l’empatia cerca
paradisi più umani e meno meccanici”.
Prendiamo la questione da un altro
verso: Platone, in La repubblica, scrive
che le donne sono portate alla filosofia
esattamente come gli uomini, e ciò le
qualifica a divenire le governanti della
città ideale.
Pare che fra i protofilosofi presocratici
ci fossero donne, ma si esprimevano per
lo più con stile oracolare e per enigmi.
La filosofia, da Aristotele in poi, si è
prefissata di abolire gli enigmi anche se
questi, oggi come oggi, sembra stiano
tornando di moda.
Davvero devo mirare a una comprensione totale e completamente trasparente? Il rivendicare di capirmi così
bene ed esaustivamente non è forse una
forma di egemonia, di rapporto di potere asimmetrico? Simone de Beauvoir,
quando scrisse “donna non si nasce, si
diventa”, stava esercitando il suo diritto
a una certa dose di autismo: l’essere
femminile non è completamente conoscibile né, quindi, dominabile. Signifi-
F I L O S O F O
cativamente, l’epigrafe del suo primo
romanzo riporta una citazione di
Hegel: “Ogni coscienza cerca la morte
dell’altra”. Quando la filosofa femminista Luce Irigaray intitola un saggio Questo sesso che non è un sesso, ci sta
chiedendo di non dare per scontata la
nostra comprensione della differenza
sessuale.
Lo studio della psicopatologia, con i
mezzi della neurologia cognitivista, ci
suggerisce una storia ipotetica: perché
abbiamo sviluppato il linguaggio? Questo è nato in risposta al fraintendimento. Il linguaggio corporeo, i gesti, gli
ammiccamenti non sono abbastanza:
non siamo telepati e non ci capiamo.
Abbiamo bisogno di suoni e segni
scritti, di atti locutori, della parola e del
linguaggio. Se mi dici ciò che vuoi, farò
lo stesso con te.
Il linguaggio è un sistema nato per compensare un deficit di empatia. Ma con o
senza il linguaggio, posso pur sempre
mostrare tratti autistici, ad esempio
fraintendendo i segni. Forse sarebbe più
corretto dire che l’autismo può essere
identificato solamente se c’è l’aspettativa di comprendersi. Ma se l’autismo è
un problema, da un certo punto di vista
è anche una soluzione, in quanto è l’affermazione che la comprensione stessa
è spesso sopravvalutata. Si tratta di un
problema illustrato da Wittgenstein
nell’introduzione al Tractatus, dove
scrive: “La verità dei pensieri qui comunicati mi sembra intangibile e irreversibile. Io ritengo, dunque, di aver
definitivamente risolto nell’essenziale i
problemi. E, se qui non erro, il valore di
quest’opera consiste allora nel mostrare
a quanto poco valga l’essere questi problemi risolti”.
Il che spiega anche perché, alla fine del
libro, suggerisca che chiunque sia salito
sulla sua scala filosofica dovrebbe, subito dopo, gettarla via.
Tratto da: A. Martin, Beyond understanding, in “New York Times”, 21 Novembre 2010.
Traduzione di Cesare Del Frate.
77
Prospettiva assurda, cortesia ytmnd.com.
Guarire il linguaggio
Se la metafisica complica il pensiero con falsi problemi e concetti ambigui,
allora la terapia filosofica dovrà riportare la chiarezza.
I
K G.H. von Wright
Filosofo finlandese,
è stato allievo di Wittgenstein.
78
n un clima sociale di bigottismo e
ipocrisia, anche la lingua tende a
corrompersi. Vi si infiltrano eufemismi. Le cose non vengono più chiamate direttamente e semplicemente
con i loro nomi, ma sono mascherate da
evasive circonlocuzioni, e a esse ci si riferisce con un’artificiosa terminologia
tecnica. Lo stile diventa oscuro, il significato si fa sfuggente. Nella società moderna questa distorsione del linguaggio
ha assunto proporzioni grottesche con
il gergo della pubblica amministrazione
e dei media. Fu forse nell’Austria degli
ultimi Asburgo che iniziò a dilagare
questa malattia dei tempi, oggi universale. Combatterla fu il compito che si
assunse la generazione dei cosiddetti
purificatori, alla quale Wittgenstein appartiene. Secondo Wittgenstein, i problemi filosofici sono dovuti a confusioni
linguistiche, a ciò che egli chiamò l’incantamento del nostro pensiero a opera
del linguaggio.
Queste difficoltà non sono domande in
cerca di risposta, ma “bernoccoli che
l’intelletto si è fatto cozzando contro i
limiti del nostro linguaggio”, come af-
DIOGENE
N. 22 Marzo 2011
I L
ferma in Ricerche filosofiche. Una delle
cause principali di questi bernoccoli è
che “non vediamo chiaramente l’uso
delle nostre parole”. Non riusciamo
cioè a cogliere la “rappresentazione perspicua” che ci rivela l’uso non distorto
del linguaggio, riportando le parole indietro, da ciò che Wittgenstein chiama
“il loro impiego metafisico” al “loro impiego quotidiano”. La chiarezza data
dalla rappresentazione perspicua è assoluta, fa sparire completamente i problemi filosofici.
La filosofia che si attiene a tale criterio
è strettamente descrittiva. Essa non
spiega nulla, per esempio come sia possibile che i segni significhino, né risponde a domande sull’essenza, per
esempio su cosa siano il pensiero, la verità o la necessità logica. Essa mette da
parte gli interrogativi del tipo “Come è
possibile?” e “Cos’è?” per dirigere la nostra attenzione sul ruolo che le parole
problematiche hanno nella comunicazione reale. In questo senso, si può dire
che “il lavoro del filosofo consiste nel
mettere insieme ricordi, per uno scopo
determinato”.
Nessuna risposta
Una filosofia che non cerca risposte a
domande, non spiega le questioni che
richiamano l’interesse del filosofo (né
teorizza su di esse) e non tenta di fornire fondamenti alle nostre credenze
non è una filosofia per la quale il pensiero scientifico possa fornire un modello. Al contrario, essa lotta contro le
infiltrazioni di tale pensiero e lo ritiene
responsabile delle confusioni di cui il filosofo tenta di liberarsi.
Non è ostile, non è necessario lo sia, alla
scienza in quanto tale. Piuttosto, assume un atteggiamento critico, persino
ostile, per quanto riguarda l’influenza
della scienza al di fuori del suo dominio, in particolare sul pensiero filosofico. In questo, essa si oppone a una
delle correnti intellettuali maggioritarie
della modernità.
Il discorso di Wittgenstein sulla filosofia
mi fa venire in mente questa immagine:
nel grande giardino del linguaggio, vi
sono appezzamenti di terreno curati,
frequentati da esseri umani che giocano
giochi linguistici non corrotti. Ma questo giardino è anche parzialmente rico-
DIOGENE
N. 22 Marzo 2011
F I L O S O F O
“
La metafisica contro la quale
Wittgenstein lotta non è
radicata nella teologia,
ma nella scienza.
perto da erbacce metafisiche che nascondono alla vista gli appezzamenti,
rendendo indistinti i loro confini, e
dunque confondono coloro che giocano
con il linguaggio. Il bravo filosofo sarebbe un giardiniere che, estirpando le
erbacce, riporta alla luce nella loro purezza gli appezzamenti di terreno linguistico e fa dunque in modo che la
comunicazione non venga impedita
dalle confusioni metafisiche.
Per i positivisti le questioni sono metafisiche quando non possono essere risolte con gli strumenti della scienza o
con una deduzione logica che si fondi
su premesse accettabili scientificamente. Com’è ampiamente testimoniato dai documenti del periodo del
massimo splendore positivistico, i campioni della “nuova filosofia” consideravano la metafisica come risultato e
residuo delle credenze religiose di una
società premoderna, come mascheramento razionalizzante di atteggiamenti
fortemente irrazionali. La filosofia era
la forza che aveva aiutato le forze reazionarie a bloccare e ritardare il progresso dell’uomo emancipato, razionale
e secolarizzato.
I limiti della scienza
La lotta di Wittgenstein contro la metafisica fu qualcosa di molto diverso. Per
uso metafisico del linguaggio egli intendeva quell’“andare a ruota libera”
che si verifica quando le parole vengono distaccate dal loro uso corrente e
sono usate per costruire, nell’isolamento linguistico della mente del filosofo, dei “castelli di carte”. Nei secoli
passati della storia europea la riflessione
dei metafisici era in larga misura alimentata dai rituali linguistici di una
cultura religiosa. Si trattava di una cultura in cui i giochi linguistici con parole
come Dio, peccato, grazia, giudizio universale e redenzione avevano un uso
quotidiano stabilito. In modo analogo, il
pensiero che Wittgenstein chiama metafisico è caratterizzato dai modelli linguistici e dagli abiti mentali di una
società prevalentemente scientifica.
La metafisica contro la quale Wittgenstein lotta non è dunque radicata nella
teologia, ma nella scienza. Egli combatte l’influsso ottenebrante che sul
pensiero hanno non i relitti di una cultura morta, ma gli abiti di una viva. Di
ciò Wittgenstein diede un chiaro avvertimento nel Libro blu, dove scriveva: “I
filosofi hanno sempre davanti agli occhi
il metodo della scienza, e hanno l’irresistibile tentazione di rispondere alle
domande nello stesso modo in cui fa la
scienza. Questa tendenza è la reale
fonte della metafisica, e porta il filosofo
nell’oscurità completa”.
E subito dopo forniva degli esempi: la
bramosia di teorie generali, di contro a
ciò che Wittgenstein definisce “l’atteggiamento di disprezzo per il caso particolare”, la tendenza a spiegare il
concetto di numero, a ridurre l’infinito
al finito, la matematica alla logica, il
comportamento intenzionale al meccanismo corporeo.
Gli esempi più volgari di questa tendenza mi pare siano dati dall’attuale filosofia della mente, per esempio nella
forma dell’“identificazione” dei cosiddetti stati mentali con i processi cerebrali da parte dei fisicalisti o nel rifiuto
da parte dei materialisti dei concetti
psicologici del senso comune, il tutto a
favore di una futura neuroscienza compiuta. Come vide Wittgenstein, è diffi79
I L
F I L O S O F O
cile che la filosofia possa perdersi inoltrandosi nella jungla della metafisica
più di quanto non accada con le attuali
manifestazioni di una cultura filosofica
fattasi in verità scientista.
Il filosofo viennese era anche acutamente consapevole che non stava continuando una tradizione. Ciò che egli
faceva era tanto diverso da ciò che avevano fatto Leibniz o Spinoza quanto la
vita nella nostra epoca differisce da
quella dei loro tempi. Tuttavia vi sono
ancora affinità tali, come scrisse lui
stesso, da rendere la sua filosofia una legittima erede delle attività intellettuali
del passato, che tradizionalmente sono
conosciute con il nome di filosofia.
Spero di aver chiarito in che senso i tentativi filosofici di Wittgenstein fossero
una lotta contro l’atmosfera intellettuale predominante del nostro secolo,
che chiamerei “modernità”. In origine A
essa si affiancava un’euforica fiducia nel
progresso ottenuto con l’impiego di
procedure razionali nella gestione delle
società democratiche industrializzate. I
lutti delle due guerre mondiali e il fardello che l’uomo ha imposto alla natura, minacciando di distruggere la
biosfera, hanno di molto affievolito
questo ottimismo.
Ma anche se l’umanità è sgomenta, in
preda a una disposizione cupa, persino
apocalittica, questo progresso distruttore continua. “È possibile che scienza e
industria”, scrisse Wittgenstein poco
prima di morire, finiscano per rivelarsi
“le cose più durature” del mondo moderno. Ma aggiunse anche che non vi è
nulla di assurdo nel credere che “l’era
scientifica e tecnica sia l’inizio della fine
dell’umanità” e che il genere umano, nel
tentativo di guidare il proprio cammino
verso il futuro affidandosi alla razionalità scientifica, “cada in una trappola”. K
Tratto da: G. H. von Wright, Wittgenstein e il Novecento, in R. Egidi (a cura
di), Wittgenstein e il Novecento, Donzelli, Roma, 1996.
Prospettiva assurda, cortesia flickr.com.
80
DIOGENE
N. 22 Marzo 2011