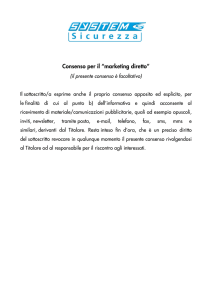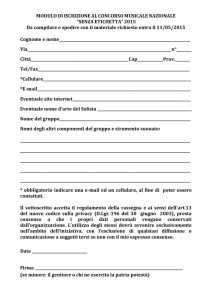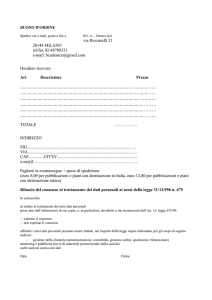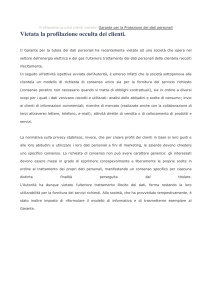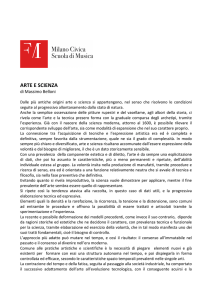CONSENSO ALLA PRESTAZIONE OSTETRICA:
“EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA E RISVOLTI OPERATIVI”
Ost. Giulia Bertolli, Prof. Riccardo Zoja, Ost. Daniela Calistri
Introduzione
Sin dagli inizi del secolo scorso, si è sottolineato come l’atto ostetrico comporti una serie
d’intrusioni nella sfera personale della donna che, sotto il profilo del diritto, potrebbero ledere o
mettere in una condizione di pericolo vari diritti della persona, configurando in astratto vere e
proprie figure di reato. I giuristi, dunque, si sono lungamente soffermati sulla ricerca di un’unica
causa di giustificazione che potesse legittimare tale attività.
Dopo aver constatato che il principale criterio sul quale fondare la liceità dell’attività sanitaria
potesse essere l’acquisizione del consenso dell’avente diritto (art. 50 del Codice Penale), mi è
sembrato interessante analizzare in quale misura il consenso fosse effettivamente da considerarsi
come il cardine centrale dell’attuale inquadramento della liceità dell’atto sanitario.
Il ruolo del consenso della donna, dal momento in cui è testimone dell’espressione del diritto di
libertà individuale costituzionalmente garantito, dovrebbe rivestire una posizione centrale ed
imprescindibile.
Ha avuto inizio, così, la ricerca, stimolata dall’attenta e scrupolosa osservazione dell’operato
altrui, durante le ore di tirocinio svolte presso le strutture ospedaliere. Fin dagli arbori è emerso
che l’essenza del consenso talvolta perdeva la sua intima natura, risultando un adempimento
formale e burocratico, dotato di senso solo perché ritenuto una forma di difesa legale. A seguire,
sono rimbalzate tutte le possibili viziature del consenso, come la formalizzazione dello stesso a
posteriori della prestazione, la mancanza dell’informazione, ecc.
In altre situazioni estreme il consenso non era stato proprio dato.
L’apice della contraddizione, però, a mio avviso, era raggiunto laddove la donna aveva dato il
consenso per la prestazione ad un operatore che, fornendole scarne e frettolose informazioni a
riguardo, svolgeva delle manovre e/o trattamenti non strettamente indicati clinicamente a quella
data situazione. Risultava, quindi, che l’atto ostetrico era legittimato perché corredato dal relativo
consenso, ma che nella realtà fosse totalmente superfluo. La firma o il si della donna, in un qual
modo, erano spostati a piacimento come pedine da parte dell’operatore, che pilotava il consenso
con le sue informazioni.
La tesi è nata, quindi, nel frangente in cui mi sono posta il seguente quesito: “Può il solo consenso
rendere lecito l’atto ostetrico? Cosa serve per far sì che sia realmente lecito?”.
Dapprima, ho ritenuto necessario analizzare le ultime vicende legali, dalla quale sono emerse delle
controversie nel Diritto in merito alla legittimazione dell’atto sanitario, che hanno dettato un
percorso segnato da tappe di grande rilievo, espressive di un autentico travaglio giurisprudenziale.
Tali controversie hanno evidenziato l’esigenza della Medicina di ricevere delle certezze sul suo
campo d’azione da parte del Diritto.
Infatti, come il Diritto da sempre chiede alla Medicina degli elementi precisi di descrizione allo
scopo di fornire risposte legali sicure, secondo l’assioma “Da mihi factum, dabo tibi ius”, così la
Medicina vorrebbe per contro certezze giuridiche che consentano agli operatori sanitari di
esprimere al meglio le proprie capacità nell’interesse dell’individuo.
Il Diritto, dunque, rispondendo alla richiesta della Medicina, convoca a Sezioni Unite i Giudici di
Piazza Cavour, con la sentenza del 18 dicembre 2008 – 21 gennaio 2009, n. 2437.
Essendo tale sentenza l’ultima tappa del percorso giurisprudenziale, ho ricercato al suo interno le
risposte al mio quesito.
La tesi si sofferma sulla mia personale elaborazione delle singolari decisioni emerse e sui
cambiamenti salienti che la sentenza ha apportato alla pratica ostetrica in merito alla
legittimazione dell’atto sanitario e all’acquisizione del relativo consenso.
“Chi è, allora, l’ostetrica legittimata? E in quale misura il consenso rende ancora l’atto lecito?”…
1.
Le nuove tendenze della giurisprudenza penale sul fronte dell’informazione finalizzata
alla realizzazione del consenso
Premessa
Complice il progresso scientifico e tecnico raggiunto nelle discipline mediche e l’allargamento del
ventaglio degli strumenti diagnostici e terapeutici disponibili, sono aumentate le possibilità
d’intervento e, quindi, anche i rischi di errore o di fallimento connessi a ogni pratica, con un continuo
incremento dei contenziosi medico - legali. Il quadro si completa richiamando all’attenzione anche
altri fattori di carattere sociale, culturale ed economico che con maggiore peso giustificano la
tendenza da parte dell’utenza a considerare sempre più spesso l’intervento medico inadeguato,
insufficiente o addirittura dannoso.
Tale temperie evolutiva ha evidenziato le lacune presenti nella giurisprudenza, soprattutto sul
versante della legittimazione dell’atto medico, facendo avvertire un senso d’insicurezza, un bisogno
di acquietanti e condivisi indirizzi su molti essenziali aspetti, momenti, fasi dell’attività medico chirurgica e, consequenzialmente, la necessità di ripristinare una sorta di ordine.
Con questo scopo, quindi, sono stati ancora chiamati a pronunciarsi i Giudici di Piazza Cavour,
chiamati a Sezioni Unite nella sentenza del 18 dicembre 2008 – 21 gennaio 2009, n. 2437.
Il compito principale affidato alle Sezioni Unite è quello di superare il contrastante orientamento
della dottrina e della giurisprudenza in relazione alla responsabilità medica sulle eventuali ipotesi
delittuose integrate dalla condotta del sanitario che, in difetto del consenso opportunamente
informato del paziente, lo abbia sottoposto ad un determinato trattamento sanitario nel rispetto delle
“regole dell’arte” e con esito fausto.
Si tratta di un’ostica problematica secolare senza precisa chiarezza quella per la quale sono state
interpellate le Sezioni Unite, poiché coinvolge differenti questioni irrisolte, quali: il fondamento
giuridico dell’attività medico-chirurgica, il concetto di malattia, che in relazione all’attività medico chirurgica viene in rilievo, e il valore che ha il consenso del paziente, considerando le posizioni che
la Costituzione, la legislazione e il Codice Deontologico hanno preso a riguardo dell’argomento,
avendo come principio fondamentale il presupposto che la salute sia un diritto della persona.
L’evento culminante che ha reso necessario tale sentenza, è da identificare in un processo milanese
nel quale una donna, operata per un sospetto tumore maligno alla mammella, che poi si scoprirà
essere un nodulo sentinella, e sottoposta alla terapia con tamoxifene, querela il medico per non averla
informata anticipatamente sui disturbi che tale farmaco poteva arrecarle. Dopo una perizia legale del
Professore dell’Università degli Studi di Milano, Riccardo Zoja, richiesta dal Dott. Spera, il C.T.U.,
la sentenza si conclude con la decisione che l’imputato non può essere accusato del reato di lesioni
personali, cui l’art. 582 c.p., poiché il suo comportamento era incontestabile e eseguito leges artis;
poteva, invece, essere accusato di violenza privata, cui l’art. 610 c.p. dal momento in cui aveva
privato la donna di nozioni importanti tali per cui la stessa potesse decidere sul percorso terapeutico
da perseguire.
Il consenso alla prestazione sanitaria: dalla posizione della giurisprudenza all’innovativa
decisione delle Sezioni Unite
Il ruolo del consenso del paziente, nell’ambito dell’attività medica a scopo diagnostico e terapeutico,
riveste una posizione centrale ed imprescindibile, in quanto espressione del diritto di libertà
individuale costituzionalmente garantito all’individuo di scegliere se curarsi o meno, se privilegiare o
no il suo stato di salute, o se, addirittura, rifiutare le cure.
La giurisprudenza penale, prima della sentenza delle Sezioni Unite, prevedeva che qualsiasi
intervento medico - chirurgico, eseguito dal sanitario con la consapevolezza dell’inesistenza del
consenso o della sua invalidità ed in mancanza di cause di giustificazione codificate, risultava idoneo
a violare la libertà del singolo di autodeterminazione e, ricorrendone gli estremi materiale e
soggettivo, poteva configurare i reati di: violenza privata, cui all’art. 610 c.p., stato di incapacità
procurato mediante violenza, cui all’art. 613 c.p., sequestro di persona, art. 605 c.p. e reato punito a
titolo colposo in caso di esito infausto previsto dall’art. 586 c.p. Oltretutto, ogni attività medico terapeutica prestata in assenza del consenso informato, anche quella che avesse avuto esito
favorevole, era da considerarsi illecita, salvo la presenza di valide cause di giustificazione codificate,
vale a dire lo stato di necessità (art. 54 c.p.).
Tali posizioni sono divenute sempre più labili, soprattutto in seguito alla lettura non originale, ma
incisiva, che è stata assegnata al consenso dalle Sezioni Unite.
Tale sentenza ha permesso di pronunciare singolari conclusioni, affermando che “ove il medico
sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato
prestato il consenso informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges
artis, si sia concluso con esito fausto, nel senso che dall'intervento stesso è derivato un apprezzabile
miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento, anche alle eventuali alternative ipotizzabili,
e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di
rilevanza penale, tanto sotto il profilo della fattispecie di cui all'art. 582 c.p., che sotto quello del
reato di violenza privata, di cui all'art .610 c.p.”.
Dalla ricerca della causa di giustificazione all’autolegittimazione dell’attività medica
Nell’ultimo secolo la giurisprudenza si è lungamente soffermata sulla ricerca di una causa di
giustificazione dell’attività medica e chirurgica, escogitando differenti soluzioni al problema della
liceità dell’atto medico.
Tale esigenza nasce nel momento in cui si percepisce che è necessario, a fronte di una analisi del
Codice Penale, considerare il trattamento sanitario come un’intrusione nella sfera personale
dell’individuo e, quindi, consequenzialmente, si configura una condotta penalmente rilevante. A
questo riguardo, perciò, la dottrina medica si è ampiamente pronunciata nella ricerca di un unico
criterio su cui fondare la liceità di tale attività, enunciando differenti teorie meritevoli di analisi.
•
Teoria dell’azione socialmente adeguata (Cattaneo – Fiore – Bettiol).
•
Teoria della mancanza dell’elemento soggettivo (Carrara – Altavilla).
•
Teoria dell’assenza del fatto tipico (Grispigni – Antolisei).
•
Teoria della causa di giustificazione non codificata (Vassalli).
•
Teoria fondata sullo scopo riconosciuto dallo Stato (Liszt).
•
Teoria fondata sull’attività autorizzata dall’ordinamento (Mantovani).
Molti autori condividono quest’ultima teoria in cui si ricerca la liceità del trattamento medico
all’interno di differenti ordinamenti e delineando, in questo modo, delle cause di non punibilità del
reato.
All’interno del Codice Penale sono state identificate due cause di non punibilità: in primis il
consenso dell’avente diritto, disciplinato dall’art. 50 c.p., secondo cui “Non è punibile chi lede o
pone in pericolo un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne”. Si evince
che il consenso ha, così, acquisito una posizione centrale modificando il tradizionale rapporto medico
- paziente, fondato da sempre su una profonda asimmetria, soprattutto sul fronte decisionale. Il
consenso ha permesso di rimandare ad una sfera di decisione autonoma del paziente.
L’altra causa di non punibilità emersa prende in considerazione l’esimente dello stato di necessità
prevista dall’art. 54 c.p., secondo cui “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona,
pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia
proporzionato al pericolo”. Questa causa di non punibilità ricorrerebbe, però, solo per interventi
pericolosi in situazioni di urgenza, rendendo l’opera del medico non punibile perché necessaria alla
salvezza del malato.
Nel caso di assenza di rischio, quindi, tale esimente non opererebbe e dovrebbe essere ricercata nel
consenso del paziente.
È in questo quadro che si inserisce l’innovativa decisione sul fronte penale della Suprema Corte a
riguardo della legittimazione dell’attività sanitaria. Riprendendo la tesi civilistica, afferma che vi è
una “autolegittimazione della attività medica, la quale rinverrebbe il proprio fondamento, non tanto
nella scriminante tipizzata del consenso dell'avente diritto, come definita dall'art. 50 c.p., quanto
nella stessa finalità, che le è propria, di tutela della salute, come bene costituzionalmente garantito.
È, dunque, la finalità dell’atto terapeutico alla tutela della salute, come bene costituzionalmente
garantito dall’art. 32, a rendere lo stesso legittimo.
Nel testo della sentenza si legge, infatti, che “l’attività sanitaria, pertanto, proprio perché destinata a
realizzare in concreto il diritto fondamentale di ciascuno alla salute (…) ha base di legittimazione
(fino a potersene invocare il carattere di attività, la cui previsione legislativa, deve intendersi come
“costituzionalmente imposta”), direttamente dalle norme costituzionali, che, appunto, tratteggiano il
bene della salute come diritto fondamentale dell’individuo”, con la conseguenza che ai giudici di
legittimità sembra “davvero incoerente l’ipotesi che una professione ritenuta, in sé, di “pubblica
necessità” (art. 359 c.p.), abbisogni per legittimarsi, di una scriminante tipizzata, che escluda
l’antigiuridicità di condotte strumentali al trattamento medico, ancorché attuate secondo le regole
dell’arte e con esito favorevole per il paziente”.
Ne segue, come ovvia conseguenza, che “il presupposto indefettibile che giustifica il trattamento
sanitario va rinvenuto nella scelta, libera e consapevole - salvo i casi di necessità e di incapacità di
manifestare il proprio volere - della persona che a quel trattamento si sottopone”, il quale principio
del consenso si configura come diritto della persona espresso nell’artt. 2, 13 e 32 della Costituzione.
L’art. 2 tutela e promuove i diritti fondamentali, l’art. 13 stabilisce l’inviolabilità della libertà
personale e, infine, l’art. 32 afferma che nessun individuo può essere obbligato a sottoporsi ad alcun
trattamento sanitario, se non quelli obbligatori per disposizione di legge.
In conclusione, è deducibile trarre che il consenso trova il suo fondamento nei suddetti articoli
costituzionali, volti a tutelare i basilari diritti della persona dell’autodeterminazione e della salute e,
singolare innovativa decisione, non più nell’art. 50 c.p.
Nell’affermare l’autolegittimazione dell’attività terapeutica, le Sezioni Unite sottolineano anche
come si possano trovare altri fondamenti anche al di fuori della Costituzione, quali la Convenzione
sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina (Oviedo, 1997), il Codice Deontologico, approvato il 16
dicembre 2006 dal Consiglio Nazionale della federazione Italiana degli Ordini dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri, nonché la Convenzione sui diritti del fanciullo (1989) e la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea (2000).
Una sintesi dello stato attuale e i cambiamenti salienti apportati dalla Suprema Corte
In definitiva, sono state proposte dalla Cassazione varie ipotesi:
•
in presenza di consenso informato l'atto medico è "perfetto" se compiuto e se eseguito secondo
le leges artis, estraneo, quindi, ad ogni ipotesi delittuosa e non abbisognevole di alcuna causa di
giustificazione penalmente prevista; se l'esito è infausto per negligenza, imperizia, imprudenza
comportamentale, solo allora può profilarsi una responsabilità per colpa ove sussistano gli estremi di
cui agli artt. 585 e 590 c.p.;
•
in assenza o in difetto di consenso informato l'atto medico è viziato dalla carenza o dalla
insufficienza di consapevole volontà del paziente, ma non integra alcun reato se l’esito è fausto,
mentre se l’esito è infausto potrebbero ravvisarsi gli estremi dei reati contro la persona a titolo di
colpa, ma solo nel quadro di una illiceità molto nebulosa, non solo per il profano;
•
in caso di dissenso, se l'esito è fausto, il comportamento è comunque privo di qualsiasi
copertura costituzionale; se l'esito è infausto, la violenza è implicita con le aggravanti dell’eventuale
ricorrenza della morte o della lesione personale, con buona pace di quanto appena escluso in ordine
alla esclusione dell'atto anche chirurgico dalla sfera delle rispettive ipotesi penalistiche.
In particolare, come già detto, per le Sezioni Unite non sembra sussistere alcun motivo di addebito
nei confronti del medico che sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico non chiaramente
consecutivo o diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso debitamente
informato se tale intervento, sia stato eseguito nel rispetto delle leges artis e si sia concluso con esito
fausto e, quindi, un apprezzabile miglioramento per il paziente.
Sugli altri casi, quali il difetto del consenso e l’intervento seguito da esito infausto, il discorso resta
aperto.
Prima di addentrarsi nell’analisi dei risvolti operativi che la sentenza del 18 dicembre 2008 – 21
gennaio 2009, n. 2437, ha apportato, è doveroso porre l’accento su quali siano state le
modificazioni, chiaramente riconoscibili, che i Giudici di Piazza Cavour hanno elaborato.
Risulta rilevante esplicare quali siano stati i cambiamenti salienti, per rendere più immediato un
confronto tra la situazione che c’era e quella che si ritrova oggi giorno all’interno della
giurisprudenza penale.
Le chiavi di volta delle decisioni della sentenza risultano essere le seguenti:
•
l’attività medica e chirurgica non necessita più di una causa di giustificazione per rientrare nei
limiti della liceità, bensì è autolegittimata nella stessa finalità di tutela della salute, come bene
costituzionalmente garantito. Infatti, tale teoria trova la sua diretta garanzia all’interno della
Costituzione e, nella fattispecie, nell’art. 32, comma 1, Cost.
•
Il consenso informato depone il suo fondamento non più nel Codice Penale, ma anch’esso
direttamente all’interno della Costituzione e, più precisamente, negli artt. 2, 13, e 32 della Carta.
Rappresenta ora la sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e
quello alla salute.
•
Il consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.), che prima legittimava l’atto medico, ora è definito
come inapplicabile, non necessario e addirittura eccentrico, poiché estraneo a un’attività che trae la
sua precisa legittimazione in sé stessa e nel dettato costituzionale. Dunque, non rappresenta più il
presupposto indefettibile che giustifica il trattamento sanitario, poiché ora va rinvenuto nella scelta,
libera e consapevole, della persona che a quel trattamento si sottopone.
•
L’indisponibilità dell’integrità corporea (art. 5 c.c.) risulta superata dal dettato costituzionale
e va interpretata nel senso che il “negato” potere di disporre non esclude la libertà di disporre del
proprio corpo e, quindi, di decidere e di autodeterminarsi in ordine e comportamenti che
coinvolgono e interessano il proprio corpo.
•
L’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) perde il suo valore, poiché è la volontà dell’individuo a
sottoporsi o meno alle prestazioni medico – chirurgiche a prendere il sopravvento sul sanitario, al
quale non è più riconosciuto un generale diritto di curare. L’individuo non si trova più,
giuridicamente parlando, in una posizione di soggezione in cui il sanitario stesso potrebbe
intervenire con il solo limite della propria coscienza, forte di una posizione di garanzia, ma diventa
l’assoluto protagonista delle sue decisioni.
•
Estremizzando la sensibile innovazione interpretativa della concezione di “malattia”, la quale
afferma che per essere definita tale deve esservi il requisito essenziale di una riduzione apprezzabile
della funzionalità, è definitivamente stabilito che le alterazioni anatomiche determinate da una
necessità di salute non costituiscono più una malattia. Di conseguenza, non possono integrare il
reato di lesioni personali volontarie delineato all’art. 582 c.p. Ciò, per esempio, nel caso di una pur
necessaria e corretta soluzione di continuo chirurgica, di per sé non curativa, ma diretta ad aprire la
via per superare un pregiudizio funzionale.
•
L’atto terapeutico non è più da intendersi come un atto fine a sé stesso, bensì come una
porzione della condotta terapeutica. Ne segue che, seppur sia stato compiuto, deve essere preso in
esamina solo e soltanto in vista degli esiti conclusivi che sono scaturiti sul piano della salute
complessiva dell’individuo.
•
Laddove è stato prestato un trattamento sanitario in mancanza del consenso opportunamente
informato, non potrà più configurarsi il delitto di lesioni personali, cui l’art. 582 c.p., né quello di
violenze privata, cui l’art. 610 c.p., nel momento in cui sia stata rigorosamente rispettata la leges
artis e tale intervento abbia avuto esito fausto.
Questi sono tutti dei punti cruciali che devono essere veramente chiari agli attori che lavorano nel
contesto sanitario, come l’ostetrica, al fine di poterne interiorizzare i concetti e contestualizzarli in
relazione al proprio operato.
2.
L’applicazione della sentenza delle Sezioni Unite nella pratica ostetrica
Le ripercussioni operative in campo ostetrico
Dopo aver percorso un arduo cammino, ad oggi, l’ostetrica è una professionista sanitaria che svolge
attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute della donna con
responsabilità e autonomia professionali. Tali caratteri sono documentati l’uno dalla legge n. 42 del
26 febbraio 1999, che delimita l’ambito di competenza e di responsabilità ostetrica, l’altro dalla
legge n. 251 del 10 agosto 2000, che ne definisce l’autonomia operativa e decisionale.
L’ostetrica, dunque, ha la possibilità d’essere chiamata a rispondere del proprio operato in sede
giudiziaria, qualora occorrano fatti previsti dalla legge come reato, oppure circostanze ritenute
dannose da chi ha fruito di una prestazione.
È estremamente necessario, allora, il continuo aggiornamento circa l’evoluzione della
giurisprudenza e i risvolti operativi che possono emergere riguardo alla proclamazione delle
sentenze, a maggior ragione nelle situazioni nelle quali è stato chiamato ad emettere la sua
pronuncia il collegio a Sezioni Unite.
L’ostetrica svolge il suo lavoro in piena autonomia e con la massima responsabilità professionale
laddove regna la fisiologia.
Competono a lei situazioni nelle quali la donna con la quale si relaziona non è in una condizione
patologica, bensì ha bisogno di essere aiutata ad affrontare un evento naturale. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità (O.M.S.), infatti, nel 1985 ha definito processi fisiologici – naturali: il
menarca, la contraccezione, il concepimento, la gravidanza, il travaglio, l’espletamento del parto, il
puerperio e l’allattamento, il climaterio e la menopausa.
Seppur sia basilare il concetto, non si cade nella banalità esplicitandolo perché rappresenta il fulcro
sul quale fanno leva i risvolti operativi in campo ostetrico delle decisioni delle Sezioni Unite.
L’ostetrica e il percorso nascita
L’obiettivo dell’assistenza ostetrica alla gravidanza e al parto fisiologico deve essere quello di
rapportarsi alla madre e al feto/neonato in buona salute con il più basso livello d’intervento
compatibile con la sicurezza, al fine di preservare lo stato preesistente di benessere.
Come deciso nella sentenza delle Sezioni Unite, l’intervento medico – chirurgico e, nella
fattispecie, quello ostetrico, è autolegittimato nel momento in cui s’interviene per salvaguardare la
salute della donna e non più bisognevole del consenso per essere definito lecito. Così il consenso
alla prestazione non rappresenta più la giustificazione all’atto, ma diviene lo strumento unico che
testimonia la garanzia dell’espressione della donna assistita. Alla base, però, vi sono due
presupposti indefettibili: la priorità dell’indicazione clinica e le procedure all’informazione.
Infatti, prendendo in considerazione il presupposto poc’anzi evidenziato, l’intervento ostetrico,
affinché sia ritenuto lecito, deve essere mosso da valide ragioni, tali per cui, seppur interferendo con
il processo fisiologico, arrecano un reale beneficio per la donna e/o per il nascituro.
Risulta evidente che, sostenendo la causa dell’autolegittimazione dell’atto sanitario, il Collegio
Supremo non abbia voluto dar maggior libertà all’azione, ma piuttosto abbia voluto caricare
maggiormente di responsabilità all’azione il sanitario che si accinge a prestare il suo operato.
La “ostetrica legittimata”, dunque, è quell’ostetrica che, dopo aver analizzato dettagliatamente una
data situazione, grazie alla conoscenza scrupolosa della letteratura, ad un’attenta focalizzazione
delle linee guida e dei protocolli a sua disposizione, sulle basi delle raccomandazioni dell’O.M.S.,
applica minuziosamente il trattamento più indicato clinicamente al caso preso in esamina.
Questo vuol dire che non sono in nessun modo autolegittimati quegli atti terapeutici applicati non
ad hoc, dove non è fortemente riconoscibile un’indicazione clinica tale per cui possa far presagire
un reale beneficio per la salute della donna.
L’indicazione clinica diventa, quindi, essenziale perché un atto sanitario sia autolegittimato.
A scopo esemplificativo, è utile analizzare la motivazione che può indurre a ritenere necessario
avere a disposizione un catetere venoso periferico e, in primis, nell’assistenza ad un travaglio, e
durante la fase espulsiva. L’utilità di tale manovra è di praticare delle infusioni d’idrosoluzioni, di
permettere un’alimentazione parenterale a breve durata, oppure di somministrare per via
endovenosa dei farmaci.
Tali necessità nell’assistenza ad un travaglio fisiologico non sussistono, dal momento in cui la
donna può alimentarsi e idratarsi autonomamente e non risiede il bisogno di somministrarle alcun
tipo di farmaco. Di conseguenza non è giustificata l’ostetrica che indistintamente attua tale pratica.
Laddove, al contrario, discostandosi dalla pura fisiologia, una donna sia in possesso di un esito del
tampone vagino – rettale positivo allo streptococco – beta - emolitico e, quindi, vi sia l’indicazione
ad una profilassi antibiotica, allora l’atto terapeutico è appieno autolegittimato dal momento in cui
ha inizio il travaglio attivo, ma non prima.
Anche durante la fase espulsiva idealmente non sussiste il bisogno di somministrare dei farmaci per
via parenterale endovenosa. Tuttavia è utile fare una distinzione per quelle partorienti definite
particolarmente a rischio di emorragia del post - partum, quali possono essere le multipare e le
donne che presentano un’anamnesi passata positiva per un’atonia uterina. In suddetti casi la
Cochrane Library suggerisce un protocollo che prevede, oltre alla somministrazione di uterotonici
per via intramuscolo, anche l’uso di 20 Unità Internazionali (U.I.) di ossitocina diluite in 500
milligrammi (ml) di soluzione fisiologica per via endovenosa.
Un altro esempio calzante è rappresentato dall’utilizzo del supporto cardiotocografico (C.T.G.)
durante l’evoluzione del travaglio. Nella letteratura ostetrica e nelle linee guida italiane si può
leggere che il corretto atteggiamento è l’auscoltazione del battito cardiaco fetale ad intermittenza
con intervalli di venti minuti e che, per contro, una registrazione continua non migliora l’outcome
neonatale, anzi lo peggiora per certi versi. Infatti, il monitoraggio in continuo, utilizzato
metodicamente e indistintamente, aumenta i falsi positivi di tracciati C.T.G. non rassicuranti, di
conseguenza si ricorre, talvolta inutilmente, a un taglio cesareo, privando il neonato dei benefici del
travaglio e precludendo alla donna la possibilità di espletare il parto per vie naturali.
Appare, allora, ingiustificata e, quindi, mancante di un’indicazione clinica l’ostetrica che utilizzi per
tutta la durata del travaglio il tracciato C.T.G.
Tale atteggiamento non può definirsi autolegittimato, poiché non comporta alcun beneficio né per la
partoriente, né per il nascituro.
Le procedure all’informazione risultano aver acquisito un’esponenziale importanza rispetto a prima
perché permettono di dimostrare la totale indicazione clinica della prestazione e di identificare nel
consenso il portavoce dell’autodeterminazione della donna e della libertà di disporre del suo corpo.
Infatti, venendo meno l’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) non sussiste più il diritto di curare e
diviene di primaria importanza l’informazione che l’ostetrica fornisce alla donna, la stessa che
servirà come strumento alla donna per decidere quale percorso intraprendere.
L’ostetrica e l’attività sul territorio: la prevenzione
L’ostetrica, secondo il suo profilo professionale definito con il D.M. 740/94, può ricoprire
l’importante mansione dell’educatrice sessuale e partecipare a campagne di prevenzione in
ginecologia.
Può svolgere un ampio lavoro sia nell’ambito della prevenzione primaria, volta allo stimolo di un
cambiamento dello stile di vita, come per esempio la promozione dell’utilizzo del preservativo per
diminuire il rischio del contagio delle Malattie a Trasmissione Sessuale (M.S.T.), che nell’ambito
della prevenzione secondaria, all’interno di programmi specifici di screening, come può essere
l’esecuzione del Pap – test, o nell’accompagnamento della donna durante il suo iter diagnostico.
Tali attività sono offerte principalmente sul territorio, sia svolgendo il suo operato all’interno dei
consultori famigliari integrati, sia attraverso incontri mirati nei diversi ordini di scuola (infanzia –
primaria - secondaria inferiore e superiore).
All’origine, tuttavia, secondo la nuova chiave di lettura apportata dalle Sezioni Unite, è necessario
un intervento di educazione della donna ad una “cultura della prevenzione” che la sensibilizzi e le
permetta di assimilare il concetto di prevenzione come un intervento volto a modificare il proprio
stile di vita in funzione della stessa. Infatti, la mancanza di motivazione da parte della donna,
vanificherebbe anche il migliore programma di prevenzione e il lavoro di educatori fortemente
motivati.
Tale intervento deve essere mirato a permettere una maggior presa di coscienza da parte della donna
ed un aumento della consapevolezza su quale sia il miglior percorso da seguire; è fondamentale per
potenziare la sua autodeterminazione.
Tutto ciò è attuabile solo attraverso una profonda informazione.
L’informazione non rappresenta più un elemento accessorio, ma l’asse portante che può stimolare la
donna alla ricerca della “cultura della prevenzione” che le permetta un mantenimento del suo
benessere psico – fisico.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno voluto annientare quel legame intimo indissolubile che regnava tra
l’informazione e la validità al consenso, in cui la prima forniva consapevolezza e la seconda
legittimava l’atto.
Con la sentenza n. 2437 l’informazione acquisisce una rilevanza autonoma in quanto accentua la
valorizzazione della donna e dell’individuo, come essere capace di autodeterminarsi. Attraverso
l’informazione, la donna non solo acconsente, ma si rende partecipe e diviene titolare di una sua
propria e riconosciuta libertà di autodeterminazione, identificata quale valore fondamentale
dell’individuo a livello costituzionale nell’art. 32 della Carta.
L’informazione va fornita a priori della prestazione e diviene la garanzia di aver svolto in modo
inopinabile il proprio lavoro e questo per due motivazioni: dapprima perché fornendo l’esatta
spiegazione, indirettamente è fornita anche l’indicazione clinica; in secondo luogo perché non è in
alcun modo violata l’autodeterminazione della donna.
Per esempio, è interessante analizzare la fase esplicativa che può condurre un’ostetrica per la
prevenzione al cancro della cervice uterina. Dopo aver fatto un’educazione sessuale in merito e aver
sottolineato quali possano essere i comportamenti e i fattori di rischio, è importante riportare quali
siano le evidenze scientifiche in merito all’esecuzione del Pap – test.
E’ di primaria importanza mettere in evidenza quale sia la fascia d’età, che è quella tra i 25 anni e i
65, e, soprattutto, gli intervalli di tempo che devono intercorrere tra un esame citologico e il
successivo, che devono essere di tre anni per le donne a basso rischio, oppure con scadenze
personalizzate laddove se ne riscontri il bisogno. Il concetto che la donna deve recepire è che, nel
caso in cui faccia parte di quella fascia a basso rischio, non deve cedere ai continui inviti annuali da
parte di personale che vuole speculare sulla salute, facendo leva sulle sue paure. Quindi, l’obiettivo
è di fornirle le dovute informazioni per metterla nelle condizioni di poter veramente
autodeterminarsi e di non farsi soggiogare.
Sul versante pratico – operativo, tuttavia, non pare esservi un sostanziale sconvolgimento delle
abituali mansioni dell’ostetrica all’educazione sessuale e alla prevenzione dei tumori della sfera
genitale, ma tale visione funge da molla per far scattare il concetto della libertà individuale,
fortemente ricercato dai Giudici di Piazza Cavour.
3.
Conclusioni
In un’era nella quale i contenziosi medico – legali sembrano essere in ostetricia all’ordine del
giorno e l’attività ostetrica è controllata dagli accecanti riflettori dei mass media, l’obiettivo ultimo
delle Sezioni Unite da interiorizzare non solo per un’ostetrica, ma per tutto il personale sanitario,
alla sottoscritta risulta essere il concetto di seguito riportato.
Non è solo possibile, ma doveroso identificare un comportamento ad hoc nell’affrontare ogni
circostanza, al fine di evitare l’utilizzo di schemi diagnostico – terapeutici ormai superati e che non
apportano dei reali benefici, ma che, al contrario, appaiono dannosi perché, talvolta, mossi da
un’intrinseca azione interpretativa soggettiva.
La ricerca, invece, all’indicazione clinica assoluta permette di raggiungere una posizione unanime,
ritrovandosi concordi sulla scelta di un percorso, dal momento in cui lo si riconosce indistintamente
come il più efficace nel contenere i rischi e nell’esaltare i benefici.
Optando per tal scelta, l’atto sanitario non può che dar luogo al miglior esito, minimizzando le
conseguenze negative e le azioni penali.
Tale obiettivo è da perseguirsi attraverso una capillare e continua professionalizzazione di tutti gli
operatori della nascita; ciascuno di essi deve avvertire l’imperativo etico della propria evoluzione in
termini culturali e di competenze.
Ognuno deve poi, soprattutto, imparare a metabolizzare l’idea che la donna assistita opera le sue
scelte secondo il diritto riconosciutole dal Supremo Collegio, che è quello dell’autodeterminazione,
vivendo serenamente questa condizione nella consapevolezza di rispettare i desideri espressi,
quando possibile, e di averle fornito con correttezza, attraverso il dialogo e l’informazione, tutti gli
elementi per decidere autonomamente.
Solo così facendo, l’ostetrica potrà sentirsi realmente legittimata nel suo operato.