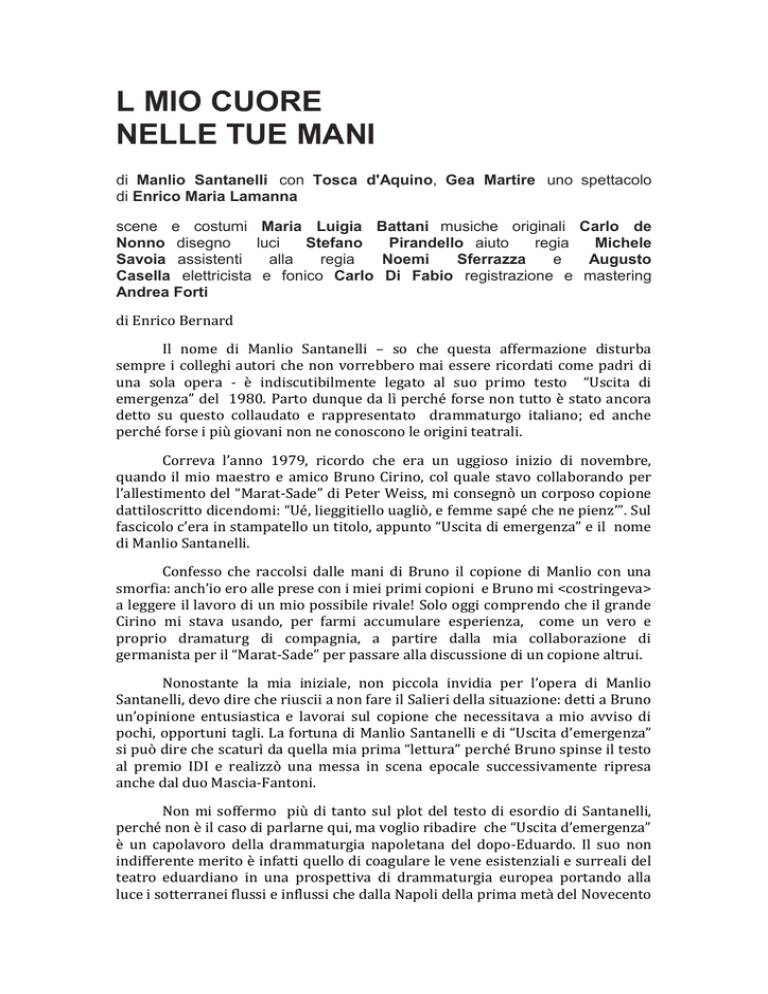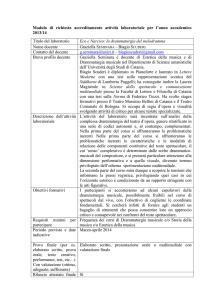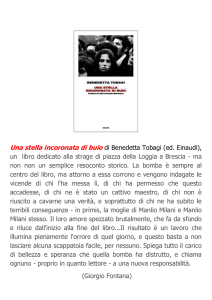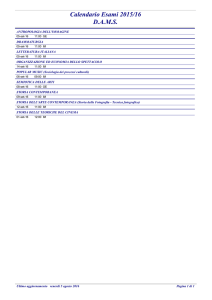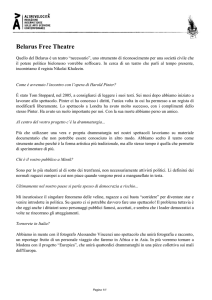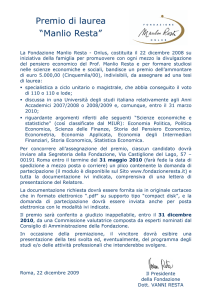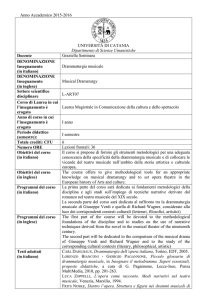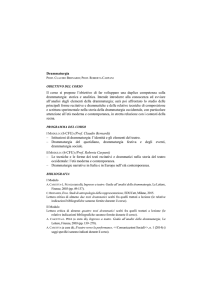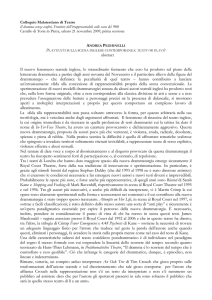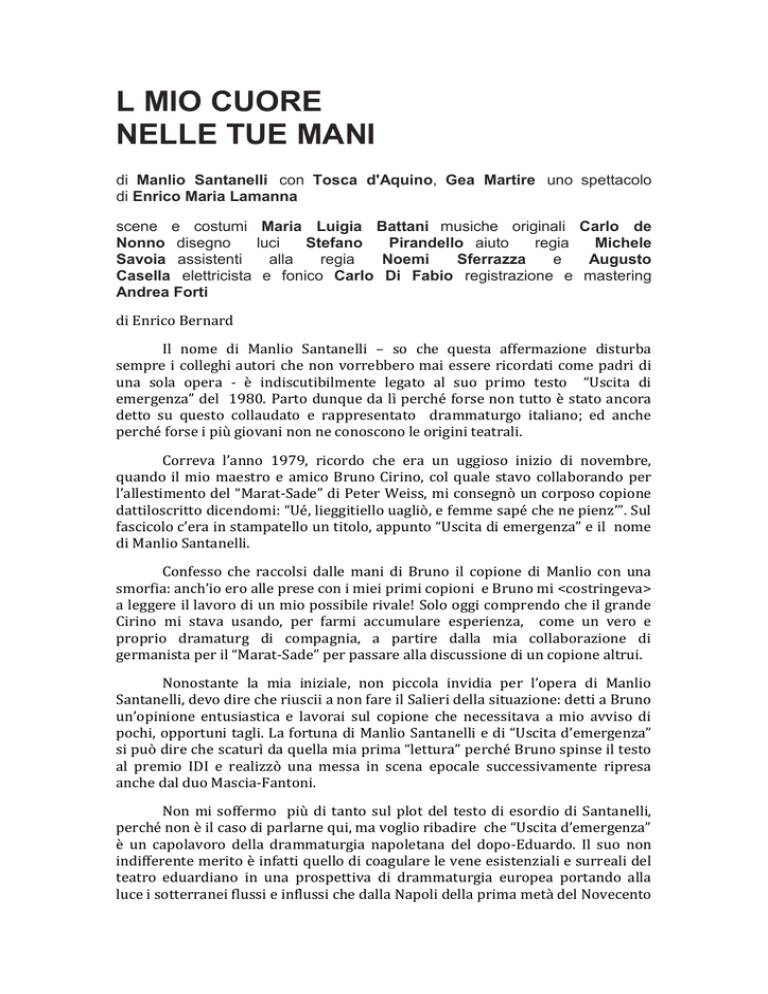
L MIO CUORE
NELLE TUE MANI
di Manlio Santanelli
con Tosca d'Aquino, Gea Martire
uno spettacolo
di Enrico Maria Lamanna
scene e costumi Maria Luigia Battani
musiche originali Carlo de
Nonno
disegno
luci
Stefano
Pirandello
aiuto
regia
Michele
Savoia
assistenti
alla
regia
Noemi
Sferrazza
e
Augusto
Casella
elettricista e fonico Carlo Di Fabio
registrazione e mastering
Andrea Forti
di Enrico Bernard
Il nome di Manlio Santanelli – so che questa affermazione disturba
sempre i colleghi autori che non vorrebbero mai essere ricordati come padri di
una sola opera - è indiscutibilmente legato al suo primo testo “Uscita di
emergenza” del 1980. Parto dunque da lì perché forse non tutto è stato ancora
detto su questo collaudato e rappresentato drammaturgo italiano; ed anche
perché forse i più giovani non ne conoscono le origini teatrali.
Correva l’anno 1979, ricordo che era un uggioso inizio di novembre,
quando il mio maestro e amico Bruno Cirino, col quale stavo collaborando per
l’allestimento del “Marat-Sade” di Peter Weiss, mi consegnò un corposo copione
dattiloscritto dicendomi: “Ué, lieggitiello uagliò, e femme sapé che ne pienz’”. Sul
fascicolo c’era in stampatello un titolo, appunto “Uscita di emergenza” e il nome
di Manlio Santanelli.
Confesso che raccolsi dalle mani di Bruno il copione di Manlio con una
smorfia: anch’io ero alle prese con i miei primi copioni e Bruno mi <costringeva>
a leggere il lavoro di un mio possibile rivale! Solo oggi comprendo che il grande
Cirino mi stava usando, per farmi accumulare esperienza, come un vero e
proprio dramaturg di compagnia, a partire dalla mia collaborazione di
germanista per il “Marat-Sade” per passare alla discussione di un copione altrui.
Nonostante la mia iniziale, non piccola invidia per l’opera di Manlio
Santanelli, devo dire che riuscii a non fare il Salieri della situazione: detti a Bruno
un’opinione entusiastica e lavorai sul copione che necessitava a mio avviso di
pochi, opportuni tagli. La fortuna di Manlio Santanelli e di “Uscita d’emergenza”
si può dire che scaturì da quella mia prima “lettura” perché Bruno spinse il testo
al premio IDI e realizzò una messa in scena epocale successivamente ripresa
anche dal duo Mascia-Fantoni.
Non mi soffermo più di tanto sul plot del testo di esordio di Santanelli,
perché non è il caso di parlarne qui, ma voglio ribadire che “Uscita d’emergenza”
è un capolavoro della drammaturgia napoletana del dopo-Eduardo. Il suo non
indifferente merito è infatti quello di coagulare le vene esistenziali e surreali del
teatro eduardiano in una prospettiva di drammaturgia europea portando alla
luce i sotterranei flussi e influssi che dalla Napoli della prima metà del Novecento
partivano per le capitali della drammaturgia: Parigi (Beckett) e naturalmente
Londra (Pinter). E dico questo aggiungendo una verità-provocazione: Santanelli
resie evidente la formazione eduardiana dello stesso Harold Pinter, che, lo dico
tra parentesi, si dà al teatro nel 1957 quando già De Filippo è internazionalmente
conosciuto e acclamato.
Penso che, al di là del valore delle singole opere, l’importanza di un
autore sia relativa al suo “ruolo” nella drammaturgia nazionale: Santanelli
insomma rappresenta il punto di incontro e di osmosi fra le grandi
drammaturgie europee e l’immensa tradizione teatrale napoletana, una
tradizione che addirittura anticipa (e in qualche caso <spiazza>) i grandi maestri
d’Oltralpe. Ho così continuato a seguire Santanelli nel corso di oltre trent’anni
con lo stesso spirito del mio primo incontro da apprendista stregone della
drammaturgia con la sua opera prima e principale. E dico <principale> senza
dimenticare che i lavori successivi del drammaturgo napoletano, da “Regina
Madre” a “Disturbi di memoria”, sono opere di tutto rispetto. Ma, questo è il
punto, se un posto da protagonista nella grande drammaturgia nazionale spetta
a Santanelli, ciò è proprio per “Uscita d’emergenza”: come dicevo, per aver
dimostrato che è Pinter ad essere eduardiano e non la drammaturgia italiana
contemporanea a vivere di luce (riflessa) pinteriana.
“Il mio cuore nelle tue mani” messo in scena da Enrico Maria Lamanna al
Santa Chiara (vedi recensione su Saltinaria di Serena Lena) la scorsa stagione e
che ora viene ripreso al Teatro della Cometa parte da uno spunto non originale
che Santanelli stesso spiega così in una nota introduttiva:
“Che cosa dovrebbe fare un povero santo, nel caso specifico San Gennaro, se
nello stesso istante due devote gli chiedessero un intervento che porta a due punti
di arrivo diametralmente opposti?”
Mi sembra strano che sia passato inosservato un celebre sketch della
Smorfia, cioè del trio Massimo Troisi, Lello Arena, Enzo DeCaro, che negli anni
magici del sodalizio, il 1978 e il 1979 si cimentava con San Gennaro. Cito dalla
introduzione dell’edizione Einaudi del brano:
“La povertà, la mancanza di lavoro e San Gennaro, dove Troisi e Arena si
contendono i favori del santo, in un crescendo amarissimo e difficile da sostenere –
sono temi di sempre…”
Quando Troisi spiega le origini drammaturgiche del brano “San Gennaro”
eccolo riallacciarsi a quella grande tradizione napoletana di cui parlavo a
proposito degli esordi di Santanelli:
“Lello e io ci conosciamo fin da quando eravamo ragazzini. E, insieme,
abbiamo cominciato a fare del teatro, qualche anno fa. Teatro sperimentale,
mescolando Eduardo e Fo, Viviani e gli autori d’avanguardia.”
Anche nel testo di Santanelli tuttavia il folklore sembra sfociare
nell’ossessione e possessione religiosa, il grottesco che rasenta l’inverosimile
(grande Gea Martire nel racconto al limite del vero, più ai confini della realtà che
surreale, della famiglia che uccide i figli per ricevere la solidarietà e l’affetto dei
vicini) si trascina nella tragedia del quotidiano dove le madri invocano il santo
per finalità diametralmente opposte.
Ma ecco ancora Troisi che chiosa il suo “San Gennaro”, una illustrazione
che si potrebbe allungare fino al testo di Santanelli:
“Quando c’è di mezzo Napoli, spesso o si fa del folklore o si frana nella
tragedia. Insomma, o Piedigrotta o il colera, o le mandolinate o i guappi, o pizza e
spaghetti o la fame nera, la disoccupazione. E tutto questo, nel bene e nel male,
viene sempre presentato con fatalismo, con rassegnazione. Noi della Smorfia,
invece, parliamo di Napoli facendo della satira, ma tenendo sempre i piedi per
terra. Punzecchiamo la realtà insomma”.
Dico tutto questo senza nulla detrarre al lavoro di Santanelli che si dipana
in questo contesto drammaturgico con solide basi nella tradizione e
nell’avanguardia teatrale napoletana. Ne è cosciente la regia di Lamanna che
trasforma con rapidi stacchi il sacro delle preghiere monologanti delle due
donne nel loro quotidiano, il <vissuto>: la cucina e la macchina per cucire che
ribaltano i panconi della chiesa come scatole cinesi contenti il profano. Sembra
così di assistere ad un comico skeccettone magistralmente interpretato da Gea
Martire e Tosca d’Aquino, ma la tragedia è in agguato. Le due donne invocano il
santo per una doppia protezione impossibile: il figlio di una è di scorta ad un
magistrato anticamorra che Gennaro, figlio della seconda, deve andare ad
uccidere. Le due donne si sfioreranno appena all’uscita dalla chiesa, in chiusura
come nel <pezzo> della Smorfia, lasciando in sospeso l’enigma: chi riceverà la
grazia del Santo? Troisi o Lello Arena, la madre del giovane carabiniere o quelle
del guappo camorrista? Che siano i numeri del lotto o le vite di due giovani è
pressoché indifferente in una città in cui il destino risponde sempre con una
smorfia che non si sa se di dolore o di gioia. Una smorfia con cui la statua del
santo, come la Sfinge, in un buio angolo della chiesa di freddo marmo non può
umanizzarsi.