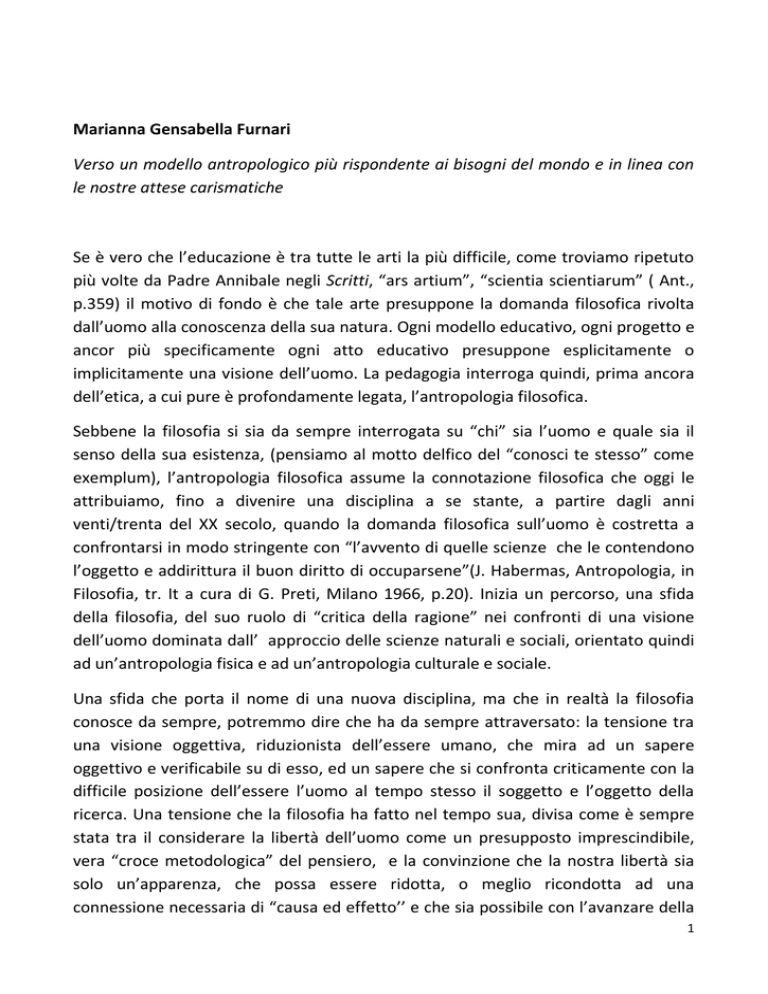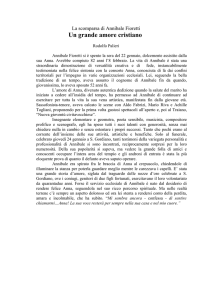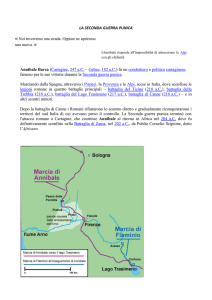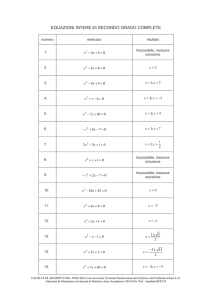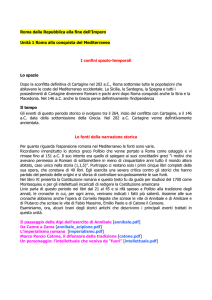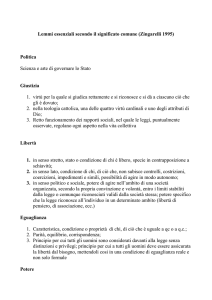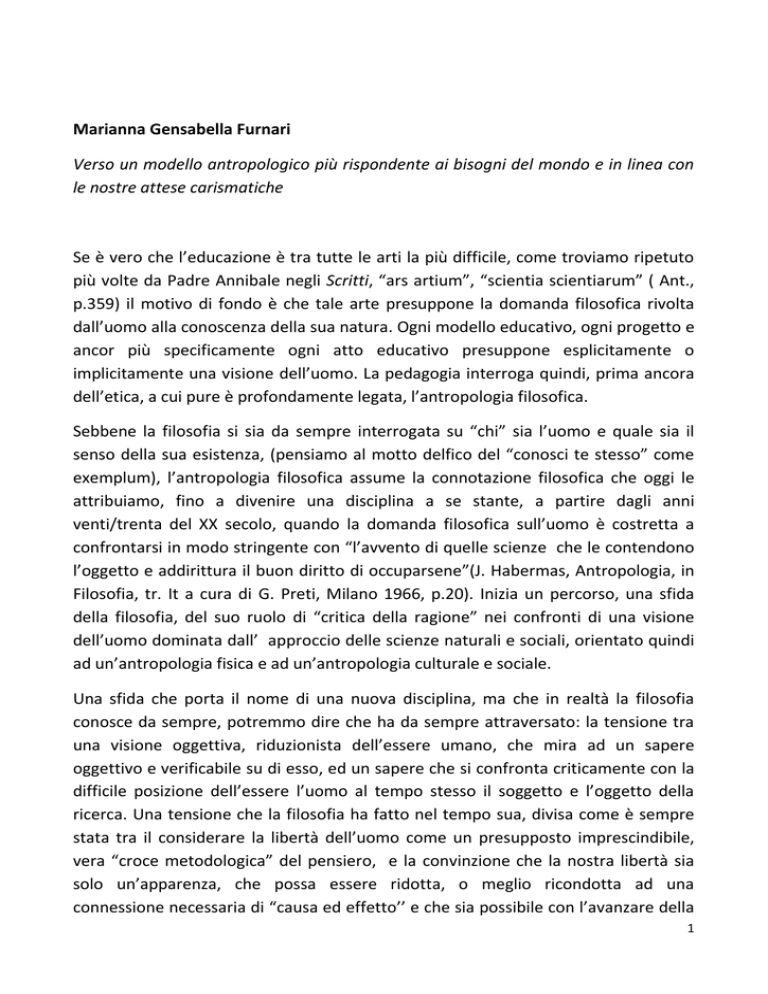
Marianna Gensabella Furnari
Verso un modello antropologico più rispondente ai bisogni del mondo e in linea con
le nostre attese carismatiche
Se è vero che l’educazione è tra tutte le arti la più difficile, come troviamo ripetuto
più volte da Padre Annibale negli Scritti, “ars artium”, “scientia scientiarum” ( Ant.,
p.359) il motivo di fondo è che tale arte presuppone la domanda filosofica rivolta
dall’uomo alla conoscenza della sua natura. Ogni modello educativo, ogni progetto e
ancor più specificamente ogni atto educativo presuppone esplicitamente o
implicitamente una visione dell’uomo. La pedagogia interroga quindi, prima ancora
dell’etica, a cui pure è profondamente legata, l’antropologia filosofica.
Sebbene la filosofia si sia da sempre interrogata su “chi” sia l’uomo e quale sia il
senso della sua esistenza, (pensiamo al motto delfico del “conosci te stesso” come
exemplum), l’antropologia filosofica assume la connotazione filosofica che oggi le
attribuiamo, fino a divenire una disciplina a se stante, a partire dagli anni
venti/trenta del XX secolo, quando la domanda filosofica sull’uomo è costretta a
confrontarsi in modo stringente con “l’avvento di quelle scienze che le contendono
l’oggetto e addirittura il buon diritto di occuparsene”(J. Habermas, Antropologia, in
Filosofia, tr. It a cura di G. Preti, Milano 1966, p.20). Inizia un percorso, una sfida
della filosofia, del suo ruolo di “critica della ragione” nei confronti di una visione
dell’uomo dominata dall’ approccio delle scienze naturali e sociali, orientato quindi
ad un’antropologia fisica e ad un’antropologia culturale e sociale.
Una sfida che porta il nome di una nuova disciplina, ma che in realtà la filosofia
conosce da sempre, potremmo dire che ha da sempre attraversato: la tensione tra
una visione oggettiva, riduzionista dell’essere umano, che mira ad un sapere
oggettivo e verificabile su di esso, ed un sapere che si confronta criticamente con la
difficile posizione dell’essere l’uomo al tempo stesso il soggetto e l’oggetto della
ricerca. Una tensione che la filosofia ha fatto nel tempo sua, divisa come è sempre
stata tra il considerare la libertà dell’uomo come un presupposto imprescindibile,
vera “croce metodologica” del pensiero, e la convinzione che la nostra libertà sia
solo un’apparenza, che possa essere ridotta, o meglio ricondotta ad una
connessione necessaria di “causa ed effetto’’ e che sia possibile con l’avanzare della
1
conoscenza scientifica leggere i meccanismi che ci determinano ad agire in un modo
o nell’altro. Sotto forme diverse, portando avanti l’ipotesi di meccanismi fisici, o
psichici, o riconducibili a cause economiche, ambientali o sociali, il determinismo si è
da sempre contrapposto ad una visione dell’uomo come essere libero e
responsabile, tentando di ri/solvere, dis/solvere il mistero di quella libertà,
inconoscibile e tuttavia idea forte della ragione di cui parla Kant. Una “mise en
question” radicale della libertà che trova oggi, per il progredire delle scienze, in
particolare le neuroscienze e la genetica, nuova forza.
Le ricadute sull’etica e sulla pedagogia delle due visioni dell’uomo, libero nelle sue
azioni o determinato da meccanismi, siano essi insiti nella sua stessa natura, o
derivanti dall’ambiente, sono significative e vanno in senso chiaramente diverso. Se
l’etica non può prescindere dalla libertà, a meno di ridursi ad una mera
fenomenologia dei costumi o ad un’analisi del linguaggio morale, l’educazione che
non presupponga la libertà vede il suo compito ridotto ad una conoscenza dei
meccanismi del comportamento umano e delle possibilità di condizionarlo.
Parlare di un modello antropologico, significa, inoltre, dal punto di vista della
filosofia, confrontarsi con diversi nodi teorici. Ne indichiamo alcuni. Il primo: se si
possa in effetti parlare di una “natura umana” o se l’essere stesso dell’uomo, il suo
tendere sempre al di là di sé, il suo essere come sostiene Heidegger un “progetto
gettato”, e d’altra parte l’essere tale progetto sempre in bilico tra natura e cultura,
tra ciò che definisce l’uomo alla nascita e ciò che egli diviene facendo, costruendo i
suoi artefatti e con essi se stesso, non porti piuttosto a parlare più correttamente di
“condizione umana” ( A. Heller). Se accettiamo tale concezione, il modello
antropologico dovrà fondarsi su questo continuo “progettarsi”, cercando di
ritrovarne le linee fondamentali e il senso, distinguendo, come invano cerca di fare
l’esistenzialismo satriano, tra un progettarsi autentico ed uno inautentico.
Secondo punto: come possiamo pensare oggi, superato il dualismo cartesiano, il
rapporto tra corpo e psiche, visto nella sua ultima declinazione come rapporto tra
cervello e mente? E all’interno della psiche, come pensiamo il rapporto da sempre
problematico tra la nostra razionalità e la sfera emotiva-sentimentale? Come
vediamo il riflettersi di tale tensione nella nostra vita etica e nell’impegno educativo,
nella tensione che da sempre anima l’una e l’altro, tra passioni e virtù?
Terzo punto: come consideriamo il “soggetto” uomo in rapporto agli altri? Un
individuo, distinto dagli altri, che tende a conquistare la propria autonomia, sulla
2
base della propria ragione, secondo lo schema del contrattualismo che da Hobbes a
Rawls ha segnato il nostro modo di pensare all’insegna del patto e della giustizia i
nostri rapporti sociali? O lo vediamo come un individuo sociale, secondo la visione
aristotelica, un essere di bisogno, vulnerabile e quindi in un perenne rapporto di
mutua dipendenza dagli altri, come nel pensiero che filosofi e soprattutto filosofe
portano avanti, centrandolo su una visione dell’uomo strettamente ancorata alla
“Cura”, nel senso doppio della preoccupazione per i propri bisogni e della
sollecitudine per quelli degli altri?
Quarto e ultimo ( forse primo per importanza): l’individuo umano è forse diverso,
per “dignità” da tutti gli altri individui animali o no? Vi è qualcosa nel suo essere che
possiamo individuare come “persona”, qualcosa che lo distingue per un singolare
rapporto ontologico con l’Essere da cui viene e a cui torna? E se è così, questo
“quid” lo distingue dal primo accendersi della vita, ancora nel grembo materno, fino
al suo spegnersi, a prescindere dal darsi delle sue funzioni, come sostiene il
personalismo ontologico? O dovremo consegnarci a una visione dell’uomo che lo
riconduca ad “animale umano”, per un verso innalzando e liberando da ogni
specismo gli animali non umani, come vuole Peter Singer, per l’altro discriminando
gli esseri umani a seconda della presenza o meno di funzioni razionali? Ad essere in
gioco è qui il rispetto che dobbiamo alla vita umana nascente, alla vita delle tante
persone con disabilità mentale, alla vita umana dei pazienti in stato vegetativo…Ad
essere in gioco è, con questo rispetto anche il modello con cui educheremo i nostri
giovani…
Se questi sono, per grandi linee, alcuni dei nodi problematici che intravedo
nell’antropologia filosofica, quale paradigma antropologico possiamo trarre dagli
Scritti di Annibale Maria di Francia? La grande mole degli scritti è un’opera
nell’Opera, testimonianza viva dell’impegno educativo del Padre Fondatore. Dietro
quest’impegno vi è certo un modello antropologico, che tuttavia rimane implicito.
Non appartiene a Padre Annibale l’amore per la “nebulosa filosofia” (T. Tusino,
Padre Annibale Maria di Francia, Rogate, Roma 1995, p.227): il rimpianto per il
mancato approfondimento degli studi (..”se i poveri bambini non mi avessero
oppresso”), riguarda piuttosto lo studio delle Scritture ( vii, p.176). E’ da lì, come
testimoniano i tanti rinvii degli Scritti, che deriva il modello antropologico su cui la
sua pedagogia si fonda: dalle Scritture e in particolare dal Nuovo Testamento, P.
Annibale deriva la concezione di un uomo visto nella sua fragilità di creatura,
segnato dal peccato originale, ma anche redento dal sacrifico di Cristo e, da questo e
3
per questo, predisposto alla salvezza. Il modello antropologico che ritroviamo
implicito negli scritti è quindi segnato da una profonda tensione, chiaramente
ispirata a S. Paolo tra “l’uomo secondo Adamo” e “l’uomo interiore” che deve
“formarsi” sulle rovine del primo (Regolamento per la congregazione religiosa).
L’uomo perde se stesso se si racchiude in sé, nel suo egoismo, diremmo nel suo
essere individuo e trova se stesso nell’”unione amorosa dell’anima con Dio”,
un’unione che nella santità, giunge al nascondimento dell’anima in Dio, fino
nascondersi a se stessa:
E’ la profonda, pressante aspirazione alla santità che guida la pedagogia di Annibale
Maria di Francia. Una santità che, al di là delle visioni definite “superficiali” che la
rappresentano circondata da un gande apparato di austere penitenze…di portenti e
di miracoli”, è definita dalla perfetta adesione alla volontà del Padre: “Vera santità è
la perfetta unione, sia pure attiva, della nostra volontà con quella dell’Altissimo, per
puro amore di Dio, e col solo retto fine di piacere a sua divina Maestà. Quando
l’anima è giunta a questo felicissimo stato, null’altro brama che restare nascosta col
suo Diletto, il Quale spesso fa che quest’anima sia anche nascosta a se stessa”…. Si
avverte qui l’eco di S. Paolo, citato più avanti:: “Vita mea abscondita est cum
Christo” ( Col.3,3) (Discors, 5. Novembre 1907). Troviamo qui il tono alto del mistico,
e del resto Padre Annibale non è stato solo uomo dalla straordinaria carità, ma
anche “uomo dotato di capacità contemplative e mistiche che nelle lunghe ore di
orazione lo hanno avvicinato alle misteriose soglie delle profondità divine” (
Annibale Maria Di Francia, Le virtù eroiche, redazione di Padre Valentino Macca,
p.23). In Lui era viva l’esigenza, avvertita fortemente anche da Madre Teresa di
Calcutta, altra luminosa testimone della carità, di coniugare l’operosità con la
meditazione e la preghiera, anzi di far precedere queste alle opere, trovando in
queste e per queste le ragioni e la forza dello stesso operare.
E’ attraverso questa via difficile, nell’intreccio indissolubile della preghiera e della
carità operosa che P. Annibale ci consegna, come un messaggio implicito, la sua
visione dell’uomo: più che una visione, una testimonianza, che trova riscontro, forse
un pallido, sbiadito riscontro nella nostra possibilità di ricondurla a teoria, se
l’accostiamo al cuore del personalismo ontologico di un filosofo cristiano, Luigi
Pareyson, là dove l’essere umano si connota come persona, ossia come rapporto
all’Essere ( Esistenza e persona, 1950).
4
Ancora, quel nesso tra meditazione e carità, ci conduce ad una visione dell’uomo
che dal suo essere, diremmo meglio dalla sua continua tensione interiore ad essere,
in relazione con Dio deriva la sua apertura agli altri. Così scrive, quasi a voler
distinguere la sua opera da altre a carattere genericamente umanitario, a Tommaso
Cannizzaro, poeta e letterato messinese che si dichiarava ateo: «Tutto questo le
dico, Professore carissimo, non per farmene un vanto, perché nulla io sono, ma per
dimostrarle
che
l’amore del prossimo fino al sacrificio non può sussistere senza l’amore
verso Gesù Cristo Dio. (...)
Ritenga, Professore carissimo, che se io non amassi Gesù Cristo Dio, mi annoierei ben presto a stare immezzo ai poveri più abbietti, e spogliarmi del mio, e perdere il sonno e la propria quiete
pei poveri e pei bambini » ( Scritti, vol. 56, p.122, vedi anche Lettere del Padre, vol.
2,pp.62-63)1.
La visione dell’essere dell’uomo come “essere con gli altri” e “per gli altri” su cui
si travaglia, tentando di trovarne un fondamento, il pensiero filosofico
contemporaneo, in particolare l’esistenzialismo, appare un’eco sbiadita di questa
forte vissuta affermazione di una fondazione della carità nella fede, dell’essere “per
gli altri” nell’ “essere per e con Dio”.
Il modello antropologico che emerge dagli Scritti è quindi attraversato dalla
profonda tensione tra ciò che l’uomo è e ciò che tende ad essere riconducendosi al
Padre. Una tensione che si declina attraverso le virtù della vita interiore e che è
sostenuta dalla “retta intenzione” del non cercare che Dio solo ( Regole della Pia
Congregazione dei Rogazionisti). Tale tensione è sostenuta dalla preghiera, indicata
da Padre Annibale come “il respiro dell’anima” (Spirito Figlie del Divino Zelo, Ant.,
p.194) e dalla meditazione, che fa scorgere il proprio nulla e accende l’anima di
santi desideri (Ivi, p.199). Senza di esse, senza la tensione della vita interiore
nessun’opera veramente buona può prodursi, nessuna parola veramente redentrice
può espugnare i cuori, nessuna beneficenza veramente proficua e duratura può
stabilirsi; e qualunque affaticarsi non si riduce ad altro se non quel detto
dell’Apostolo: Son divenuto ( se in me manca lo Spirito del Signore) quasi uno
strumento il cui suono fa un po’ fragore che presto svanisce!” ( Discorsi, 17 aprile
1915, Ant., p.93).
1
APR 55, 3994; TUSINO, LP, II, pp. 61-3.
5
Ma cosa muove nell’uomo questa tensione: l’intelletto o la volontà? Il problema
antropologico che da sempre i filosofi si sono posti e che oggi alla luce delle
neuroscienze riveste una particolare attualità, non è estraneo alle pagine degli
Scritti: “La volontà non si muove, come insegnano i filosofi e l’esperienza, senza che
l’intelletto apprenda il bene che le è conveniente. In altri termini se tu, o anima, non
apprendi bene quanto è desiderabile e profittevole la virtù, tu non ti muoverai a
domandarla a Dio e a sforzarti per raggiungerla con la tua cooperazione”. Sembra
quindi che tutto parta dall’intelletto e dalla cognizione. Ma di che tipo di cognizione
si tratta? Di seguito leggiamo: “se la cognizione dell’intelletto è debole e soltanto
speculativa e superficiale, e per nulla acquisita col dono dell’intelletto, la volontà si
muoverà pure debolmente…Se invece il lume e la cognizione dell’intelletto …sono
pieni, per un concorso ed illustrazione di fede e di Spirito Santo, allora la volontà si
muoverà tutt’intera ed attiva sia a pregare sia a cooperare per ottenere e
conseguire la virtù e la grazia desiderata”( Spirito Figlie del Divino Zelo, Ant., p.160).
Qui l’espressione chiave è col dono dell’intelletto: l’ intelletto precede sì, ma a patto
che non sia “solo” speculazione dell’uomo ( più avanti si parla di “semplice
intelligenza naturale specultaiva”), ma sia ”pieno”, come solo può essere un
intelletto illuminato dal dono dello Spirito, invocato e accettato nella preghiera. Al di
là di ogni dualismo intelletto e volontà si sostengono l’un l’altra nella tensione
interiore dell’anima che cerca di giungere al suo Sommo Bene, Dio, attraverso il
bene della virtù, ma nel loro sostenersi hanno a loro volta bisogno di essere
sostenuti dalla meditazione e dalla preghiera. Nell’ordine spirituale indicato da
Padre Annibale il movimento parte quindi dall’Alto, dalla grazia, ma non può
avvenire senza il concorso della libertà/ volontà dell’uomo e della sua intelligenza:
“La grazia previene la volontà buona che si muove d’accordo con la grazia, la
meditazione rende sempre più attivo il movimento della volontà per mezzo del
lume dell’intelletto; la volontà così mossa si spinge ad ottenere gli obiettivi spirituali
con tutte le sue forze, usando il gran mezzo della preghiera e unendovi l’opera per
ottenere ciò che con la preghiera si domanda” ( Spirito Figlie del Divino Zelo, Ant.,
p.162).
(Su intelletto, volontà, sentimento vedi anche, Ant., pp.644/645).
In quest’ordine spirituale non poca rilevanza viene data al “desiderio”: “il desiderio
dà le ali alla volontà; la volontà che ferventemente desidera non corre ma vola verso
ciò che desidera” (ivi, p.200). Parole che trovano riscontro profondo nella nostra
esperienza, ma anche nel pensiero filosofico, dagli antichi ai contemporanei, così
6
come nelle ipotesi della psicoanalisi. Ma di “quale” desiderio parla Annibale Maria Di
Francia? Il problema che attraversa l’etica e la pedagogia dell’ordine e
dell’educazione dei desideri, è presente nelle pagine degli Scritti, là dove si distingue
tra “desideri imperfetti” che come dicono le Scritture “occidunt pigrum” (Prov., 21,
25) e “ardenti”, “santi” desideri, che sono tesi al raggiungimento di “beni grandi ed
eterni” (Ivi, p.200). il discernimento tra gli uni e gli altri non può che avvenire
attraverso la meditazione, la preghiera e la cooperazione della buona volontà ( cfr.
su quest’ultima , ivi, p.198).
Se questa è la tensione della vita interiore quali sono le virtù attraverso cui tale
tensione si esplica, si rafforza?
Padre Annibale attribuiva, a ragione, grande importanza all’esercizio delle virtù: ne
sono prova le “gare delle virtù” intese come strumento pedagogico. Luogo dell’etica,
l’’esercizio delle virtù, può essere considerato il ponte prezioso tra antropologia e
pedagogia: vero fil rouge degli Scritti lasciati dal Padre Fondatore ai suoi Figli e ai
laici che si accostano al suo insegnamento. Un ponte anche con il pensiero etico
contemporaneo, attraversato dall’esigenza di un “ritorno alle virtù” ( A. Mac Intyre)
per ricomporre i frammenti di un ethos sempre più frammentato.
Ma torniamo alla nostra domanda su quali siano per Padre Annibale le virtù più
importanti per la vita interiore.
Parlerò solo di alcune.
La prima è l’umiltà, considerata “base di ogni virtù” ( Ant., 89) “La definizione di
questa grande virtù è semplice: l’umiltà è l’opposto della superbia (…) La superbia
gonfia il cuore dell’uomo e ci fa credere tanto alti, tanto forniti d’intelletto e di doti
morali e naturali, da non aver bisogno alcuno di Dio E tanto meno che ci ammaestri.
L’umiltà invece, nel suo vero significato spirituale, è quella virtù per la quale
riconosciamo che Dio è l’Essere supremo, al Quale dobbiamo stare soggetti, e che
se dote spirituale è in noi, tutto è dono di Dio…il grande Apostolo S. Paolo scrive: “O
uomo, quale dono hai tu che non lo ricevesti da Dio? E se lo hai ricevuto perché te
ne glori? (I Cor, 4,7)…L’umiltà fu la grande virtù della quale Gesù Cristo ci diede
l’insegnamento…”Imparate da me che sono mansueto ed umile di cuore” ( Matt, 11,
29) ( Ant., 96-97)…Umiliamoci tutti con amorosa umiltà …perché alla fine Gesù
Cristo è nostro padre e noi gli siamo figli, è padrone amorosissimo, indulgente e
benigno con quelli che lo amano e gli stanno soggetti come figli al padre” (ivi, p.98).
7
Virtù praticata in modo eroico in prima persona ( vedi Le virtù erocihe)t, l’umiltà
considerata più volte a fondamento di ogni altra è anche la prima richiesta ai
Rogazionisti e alle Figlie del divino zelo.
Strettamente connessa all’umiltà, perché fondata sullo stesso principio dello
sradicamento dal sé, è l’obbedienza: “La santa obbedienza è virtù di perfetta
santificazione e di perfetta unione con Dio, perché obbedendo al Superiore e alle
Regole si fa perfettamente la volontà dell’Altissimo” ( quaranta dichiarazioni e
promesse, n.7).
E ancora, in connessione con l’umiltà, la povertà: “ La Santa Povertà è miniera di
molte altre virtù: dell’umiltà, della pazienza, della temperanza, del santo distacco:
essa è il vero tesoro nascosto agli occhi dei mondani, per il cui acquisto dobbiamo
dare ogni gloria mondana” ( Scritti, vol. 61, p.191). Come è stato notato la povertà
considerata prima solo come privazione di beni, diviene con Gesù e per Gesù, per il
suo esempio, virtù. Gesù, come ricorda Padre Annibale non aveva dove posare il
capo…Anche noi per amor suo spogliamoci di tutto” ( Testimonianze, p.321, PSV,
vol.2). Appartenendo ad una famiglia benestante, Annibale sceglie la povertà,
diremmo che è provocato dalla figura divenuta emblematica di Zancone, a scegliere
l’amore per i poveri, condividendone la povertà. Curandoli ed amandoli, da vero
eccezionale apostolo della carità, ne difende la dignità rispetto ai signori, ai potenti
del tempo, riconoscendoli come “Signori” e “Principi”.
La Chiesa che ha nel cuore Annibale Maria di Francia è una Chiesa “per i poveri”, ma
al tempo stesso povera. E’ la stessa che ascoltiamo oggi dalla voce e dall’esempio di
un grande Papa che ha voluto prendere il nome di Francesco.
A queste virtù e ad altre, come la temperanza, la fortezza, la castità, la giustizia, la
prudenza, tutte praticate in modo eroico e quindi testimoniate da Padre Annibale,
come risulta chiaro dalla Positio, ma anche indicate negli Scritti, danno sostegno e
respiro le virtù teologali: la Fede, la Speranza e la Carità.
Poiché la Carità è Padre Annibale, la sua vita, la sua Opera, mi soffermo un
momento sulla Speranza e sulla Fede che sono presenti in Lui in modo altrettanto
sorprendente ed alimentano la Carità.
Il legame tra speranza e carità, dà ragione della sua incredibile capacità di operare
per i poveri, dando oltre ogni misura, fino ad affrontare le critiche di molti: “ A Dio
benedetto nulla è impossibile, quindi non ci resta che abbandonarci in Dio”( Scritti,
8
vol. 39, p.56) e ancora: “il dare l’ho riguardato come segreto infallibile di continua,
divina Provvidenza. E la mia speranza in Dio non è mai stata delusa” ((Scritti, vol. 29,
pp. 46-47). Fede e speranza si intersecano nei tre voti della fiducia, di cui uno
riguardava l’anima ( “ Signore, fossero i miei peccati più numerosi e più gravi di
quelli di Giuda, io confiderò sempre nella vostra misericordia” e il secondo e il terzo,
la vita dell’Istituto ( Signore, fosse tutto distrutto dal maligno, io sempre confido in
Voi, che ricostruirete tutto, se ciò è conforme alla Vostra Gloria” ( vedi Le virtù
eroiche, p.113, PSV, vol. 2).
Uomo di fede profonda, Annibale Maria di Francia fa della sua vita una
testimonianza della verità di quanto predica come sacerdote: “ l’uomo che vive
secondo la fede si solleva con lo spirito al di sopra di tutte le cose terrene. Dei suoi
stessi sensi egli si vale per innalzarsi a Dio (…) L’uomo che vive di fede, nulla reputa
tutte le cose della terra: non ama le ricchezze…non chiede onori….non è avido di
piaceri. In tal modo la carne resta soggetta allo spirito, le passioni vengono
dominate dalla ragione, l’uomo vive una vita pura, semplice, spirituale: la vita della
fede” ( discorso tenuto a Castanea delle Furie, Messina il mese di maggio del 1880,
in DI, pp. 311-312).
La vita praticata secondo la virtù della fede indica quindi il modello di uomo che
Annibale Maria di Francia ha in mente nel suo personale itinerario spirituale, ma
anche in quello di pastore, di educatore, di padre fondatore. Un modello segnato
dalla tensione tra uomo vecchio ed uomo nuovo, secondo la predicazione di S.
Paolo, più volte citata negli Scritti, che rischia di suonare forse troppo severo a chi
vive nel secolo, in particolare se si tratta del nostro tempo.
Un modello che trova però una profonda risonanza nella nostra esperienza
esistenziale, se proviamo a rileggerlo comprendendolo secondo due paradigmi. Il
primo è quello del figlio: colui che ha bisogno di tutto e che si rivolge con fiducia
piena al Padre, sicuro che sarà Lui a provvedere; le virtù della fede e della speranza
convergono qui in quella “fiducia” che segna le nostre relazioni umane, importante,
preziosa e pure poco evidente come l’aria che respiriamo, come scrive Annette
Baier, fiducia che segna in particolare la relazione del figlio, piccolo, vulnerabile,
verso il genitore, da cui dipende per ogni cosa. Padre Annibale con il suo particolare
amore per gli orfani, coloro che non sono più figli, che non hanno più in chi avere
fiducia, in chi sperare indica l’importanza di questo paradigma che ha al suo fondo
per un verso l’esperienza, comune a tutti, ma più evidente nell’infanzia, della
9
vulnerabilità, per l’altra quella della fiducia in qualcuno che possa prendersi cura di
noi. Ma ancora, Padre Annibale, forse non è un caso che io continui, come tanti a
chiamarlo così, vedendo nella sua Paternità spirituale verso tanti la sua stessa
santità, si avverte lui stesso Figlio di quel Padre in cui crede e spera. Troviamo qui
nel paradigma del figlio, una singolare convergenza con un modello antropologico
portato avanti da alcune filosofe che contrapponendosi al modello dell’homo
oeconomicus, individuo, razionale, indipendente, portano avati un modello di uomo
centrato sulla vulnerabilità, la cura reciproca, la reciproca interdipendenza.
La differenza certo c’è, ed è molta, di prospettiva di fede, di mancanza nelle filosofe
che possiamo racchiudere nella corrente dai confini ancora imprecisati di etica della
cura, di un pensiero della trascendenza. Se siamo tutti figli di Cura, ossia tutti
vulnerabili, tutti soggetti e oggetti di Cura, questo certo ci impegna in un patto di
fratellanza che scavalca le frontiere della giustizia del neocontrattualismo, per aprire
a frotniere nuove nei confronti anche di chi non può contrinbuire al reciproco
vantaggio. Ma fino a che punto andremo avanti? La fede di Padre Annibale portava
non “misurare” mai la carità, sicuro com’era che Qualcuno, la Provvidenza in cui
credeva, sarebbe venuto in soccorso, avrebbe risposto alle sue preghiere. Il patto tra
i figli della Cura non ha uguali con il legame tra i figli di Dio che non hanno bisogno
nemmeno di stringere un patto perché vedono l’uno nell’altro il Volto dell’unico
Padre.
E tuttavia alcune cose passano dall’uno all’altro paradigma, se non altro,
l’indicazione di quella vulnerabilità che segna la figura del figlio, ma anche quel
superamento nella fratellanza, che anche l’etica della cura indica delle differenze,
dell’estraneità dell’altro. E andiamo qui al secondo paradigma con cui possiamo
ripensare oggi, nel nostro tempo, così lontano, per costumi, per senso etico, il
modello antropologico di Padre Annibale: il paradigma del povero. Chi è il povero?
Colui che manca di tutto, ma anche colui che per questo mancare sembra abbia
perso la sua dignità di essere umano: è sporco, lacero, maleodorante, a volte la sua
povertà si traduce anche in povertà morale, a volte delinque, in ogni caso è “fuori”,
o vogliamo che sia “fuori” dalla comunità degli uomini.
La lettera ai Direttori dei giornali messinesi con al sua veemenza è tutta una difesa
dei poveri dalla minaccia che grava su di essi di essere rinchiusi in carcere se sorpresi
a mendicare. In quella minaccia possiamo vedere un atto estremo di difesa sociale
dai poveri visti come “altri”. Padre Annibale reagisce, in modo vibrante, vuole
10
lasciare ai poveri la loro libertà, di più vuole ridare e di fatto ridà costantemente con
sua opera a loro la dignità che non viene più loro riconosciuta. Di più “si fa povero”,
riconoscendo nella povertà non solo una dimensione di profonda umanità, ma
anche una condizione che aiuta a superare tutto ciò di cui l’uomo deve liberarsi nel
suo itinerario verso Dio.
Anche qui possiamo ritrovare delle profonde risonanze con il pensiero dell’etica
della cura quando dilatando le frontiere della giustizia si fa carico di quel dolore
della differenza che segna le antiche e nuove povertà. Differenti i poveri del
quartiere di Avignone, in cui i cittadini di Messina non volevano entrare, differenti
come gli immigrati che sbarcano nella mia Sicilia, come le persone con disabilità a
cui non riusciamo a garantire condizioni di vita buone. Ripensare quella differenza,
come fa l’etica della cura per cercare di assumerla come aspetto della comune
condizione umana significa già, forse, essere sia pure in una dimensione orizzontale,
ancora di immanenza, sulle vie di Padre Annibale.
Vie che vi percorrete, dedicando la vostra vita, dando costante testimonianza del
vostro carisma di quello “zelo” che germina dalla carità come suo ardore e che
dedicate alla gloria di Dio e alla salvezza delle anime.
Cosa può dirvi chi rimane china sui libri a studiare “la nebulosa filsofia” sulla
possibilità di rispondere meglio col vostro carisma alle attese dei tempi? Poco o
nulla. Forse qualche parola su quanto sia importante oggi quel messaggio di
“fiducia” così vivo nel vostro padre fondatore e di cui il nostro tempo ha smarrito le
ragioni. Bisogno di fiducia dei giovani, delle persone mature, degli anziani: bisogno
di fiducia in noi stessi, nelle nostre capacità di amare non in un tempo spezzato, con
emozioni passeggeri, manella continuità faticosa e lieta di legami densi di affetti. E’
possibile in un tempo segnato dalla liquidità di cui parla il sociologo Zigmunt
Bauman, parlare ancora di matrimonio, di famiglia, di promesse che durano nel
tempo? Il ritorno alle virtù di cui Alasdair Mac Intyre vede l’esigenza per tenere
insieme l’ethos frantumato in cui viviamo è possibile? Io credo di sì, continuerò a
crederlo, facendo voto di fiducia, fino a quando ci saranno testimoni delle virtù
come voi, come il Santo fondatore a cui vi ispirate. E per questo Vi prego di
continuare nella vostra opera e di costruire il più possibile ponti con il pensiero
laico, cercando ciò che di buono vi è, quei semi di verità che per quanto impazziti,
come scriveva Maritain, o quanto meno caduti lontano dall’Albero maestro,
possono, se raccolti insieme, dare frutto.
11