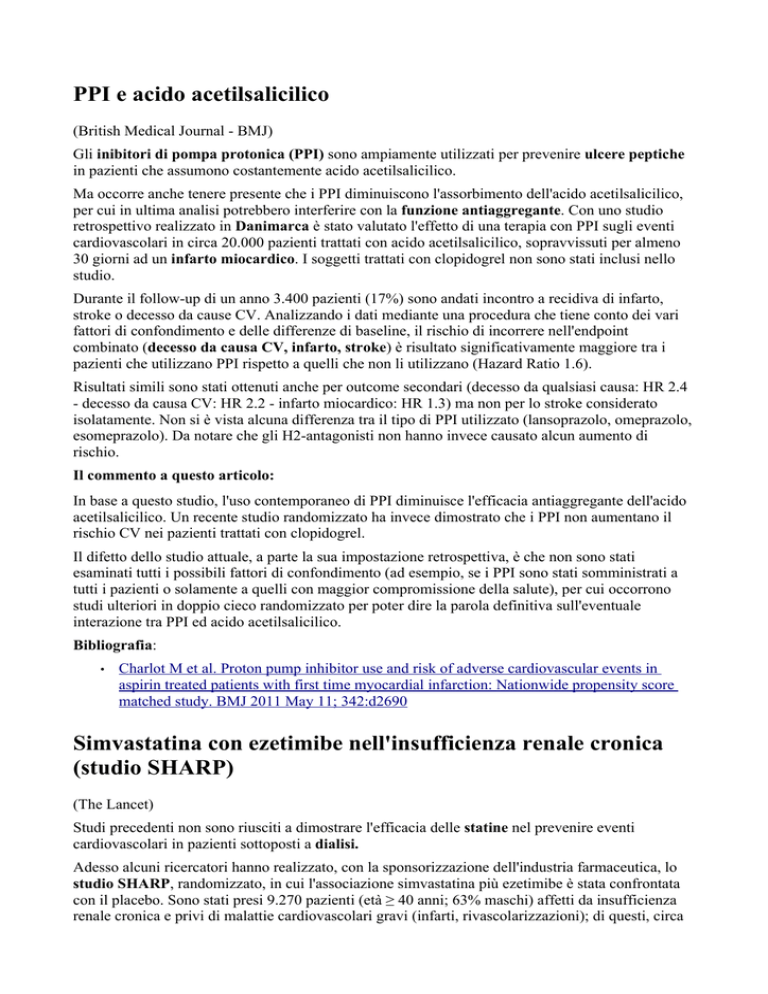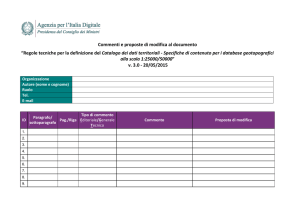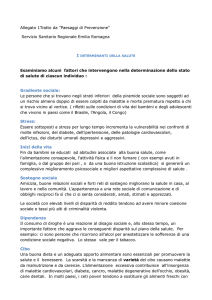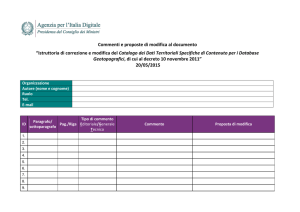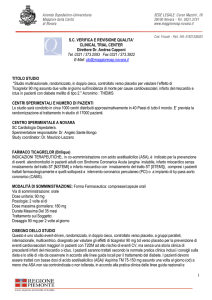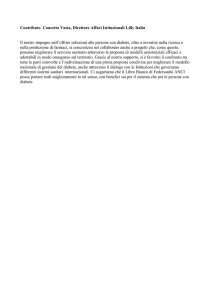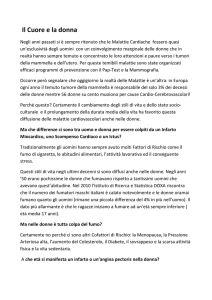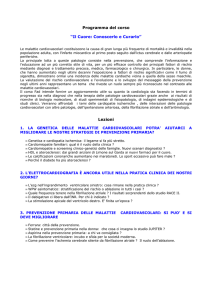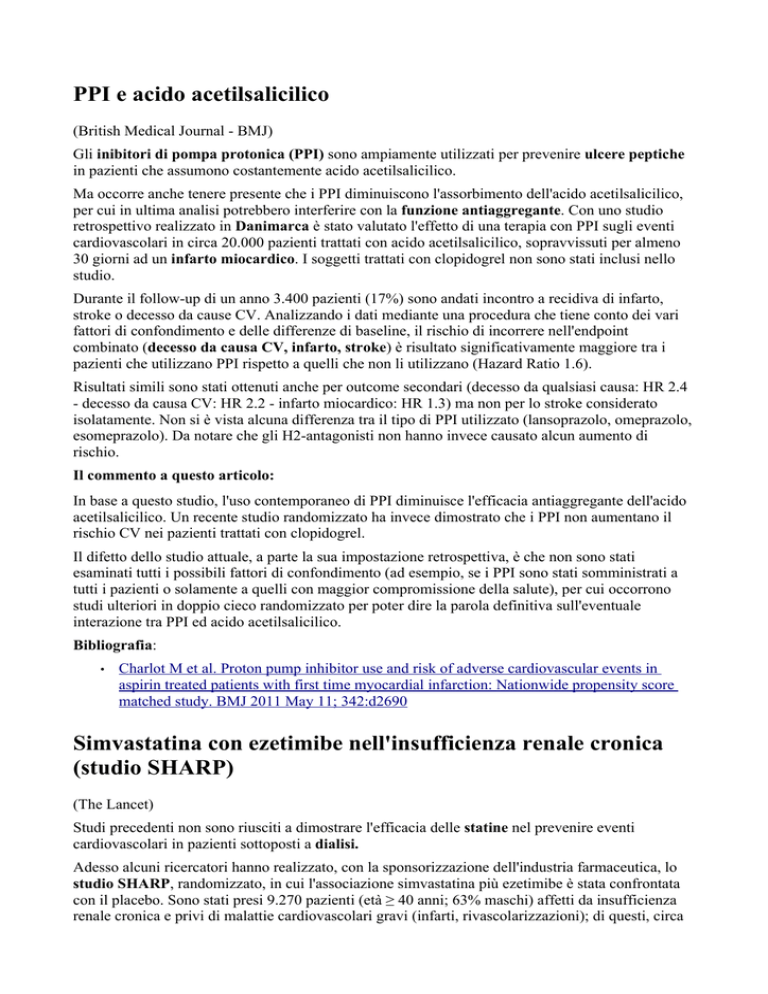
PPI e acido acetilsalicilico
(British Medical Journal - BMJ)
Gli inibitori di pompa protonica (PPI) sono ampiamente utilizzati per prevenire ulcere peptiche
in pazienti che assumono costantemente acido acetilsalicilico.
Ma occorre anche tenere presente che i PPI diminuiscono l'assorbimento dell'acido acetilsalicilico,
per cui in ultima analisi potrebbero interferire con la funzione antiaggregante. Con uno studio
retrospettivo realizzato in Danimarca è stato valutato l'effetto di una terapia con PPI sugli eventi
cardiovascolari in circa 20.000 pazienti trattati con acido acetilsalicilico, sopravvissuti per almeno
30 giorni ad un infarto miocardico. I soggetti trattati con clopidogrel non sono stati inclusi nello
studio.
Durante il follow-up di un anno 3.400 pazienti (17%) sono andati incontro a recidiva di infarto,
stroke o decesso da cause CV. Analizzando i dati mediante una procedura che tiene conto dei vari
fattori di confondimento e delle differenze di baseline, il rischio di incorrere nell'endpoint
combinato (decesso da causa CV, infarto, stroke) è risultato significativamente maggiore tra i
pazienti che utilizzano PPI rispetto a quelli che non li utilizzano (Hazard Ratio 1.6).
Risultati simili sono stati ottenuti anche per outcome secondari (decesso da qualsiasi causa: HR 2.4
- decesso da causa CV: HR 2.2 - infarto miocardico: HR 1.3) ma non per lo stroke considerato
isolatamente. Non si è vista alcuna differenza tra il tipo di PPI utilizzato (lansoprazolo, omeprazolo,
esomeprazolo). Da notare che gli H2-antagonisti non hanno invece causato alcun aumento di
rischio.
Il commento a questo articolo:
In base a questo studio, l'uso contemporaneo di PPI diminuisce l'efficacia antiaggregante dell'acido
acetilsalicilico. Un recente studio randomizzato ha invece dimostrato che i PPI non aumentano il
rischio CV nei pazienti trattati con clopidogrel.
Il difetto dello studio attuale, a parte la sua impostazione retrospettiva, è che non sono stati
esaminati tutti i possibili fattori di confondimento (ad esempio, se i PPI sono stati somministrati a
tutti i pazienti o solamente a quelli con maggior compromissione della salute), per cui occorrono
studi ulteriori in doppio cieco randomizzato per poter dire la parola definitiva sull'eventuale
interazione tra PPI ed acido acetilsalicilico.
Bibliografia:
•
Charlot M et al. Proton pump inhibitor use and risk of adverse cardiovascular events in
aspirin treated patients with first time myocardial infarction: Nationwide propensity score
matched study. BMJ 2011 May 11; 342:d2690
Simvastatina con ezetimibe nell'insufficienza renale cronica
(studio SHARP)
(The Lancet)
Studi precedenti non sono riusciti a dimostrare l'efficacia delle statine nel prevenire eventi
cardiovascolari in pazienti sottoposti a dialisi.
Adesso alcuni ricercatori hanno realizzato, con la sponsorizzazione dell'industria farmaceutica, lo
studio SHARP, randomizzato, in cui l'associazione simvastatina più ezetimibe è stata confrontata
con il placebo. Sono stati presi 9.270 pazienti (età ≥ 40 anni; 63% maschi) affetti da insufficienza
renale cronica e privi di malattie cardiovascolari gravi (infarti, rivascolarizzazioni); di questi, circa
1/3 era sottoposto a dialisi.
I livelli di creatinina partivano da 1.7 mg/dl nei maschi e da 1.5 mg/dl nelle femmine. L'endpoint
primario è stato stabilito in qualsiasi evento aterosclerotico maggiore, escludendo dallo studio i
soggetti che dopo 6 settimane non avevano aderito al protocollo terapeutico. Al baseline, il livello
medio di colesterolo totale era di 189 mg/dl e quello medio di colesterolo LDL di 108 mg/dl. A
metà dello studio, il colesterolo LDL era diminuito maggiormente (mediamente di 33 mg/dl) nel
gruppo trattato attivamente.
Il follow-up è durato 4.9 anni e in tale periodo l'endpoint primario è occorso nell'11.3% dei soggetti
trattati con gli ipolipemizzanti e nel 13.4% di quelli trattati con placebo (RR 0.83; 95% IC 0.740.94; P=0.002). Sebbene la frequenza di infarto non mortale o di decessi da cause coronariche non
sia stata differente in modo statisticamente significativo, l'incidenza di stroke ischemici e di
procedure di rivascolarizzazione (coronarica, carotidea, agli arti inferiori) è stata significativamente
minore nel gruppo della statina, mentre la mortalità da qualsiasi causa è risultata invece superiore
(24.6% contro 24.1% del placebo). Per quanto riguarda la dialisi, la frequenza dell'endpoint
primario è stata del 15.2% nei pazienti trattati e del 15.9% in quelli che hanno assunto placebo.
Il commento a questo articolo:
I risultati di questo studio, sponsorizzato dall'industria farmaceutica, non dicono granché: non
sappiamo che esiti avrebbe avuto l'utilizzo della sola statina, per cui l'aggiunta dell'ezetimibe, se
produce un beneficio, non è quantificabile; i risultati più significativi si sono avuti su endpoint
secondari, quali la rivascolarizzazione; la mortalità globale è stata superiore con l'associazione dei
farmaci; non sono stati registrati vantaggi eclatanti nemmeno nei pazienti dializzati. In conclusione,
lo studio SHARP non modifica l'approccio attuale a questi pazienti.
Bibliografia:
•
•
Baigent C et al. The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in
patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): A randomised
placebo-controlled trial. Lancet 2011 Jun 12
Stevens KK and Jardine AG. SHARP: A stab in the right direction in chronic kidney
disease. Lancet 2011 Jun 12
Omalizumab nell’asma grave
(Annals of Internal Medicine)
L’omalizumab è un anticorpo monoclonale ricombinante che inattiva le IgE, ed è approvato dalla
FDA per la terapia dell’asma moderato-grave in pazienti di oltre 11 anni che non siano
adeguatamente controllati dai corticosteroidi inalatori.
Con uno studio realizzato in USA, randomizzato, in doppio cieco, placebo-controllo, è stata valutata
l’efficacia e la sicurezza dell’omalizumab su 850 soggetti asmatici (età 12-75 anni) non
adeguatamente controllati mediante alte dosi di cortisonici inalatori e di β2-agonisti long acting
(LABA).
L’anticorpo è stato somministrato per via sottocutanea ogni 2-4 settimane, a dose dipendente dal
peso del soggetto e dai livelli di IgE. Tutti i pazienti erano positivi ai test allergici per allergeni
respiratori perenni. Dopo 48 settimane le riacerbazioni gravi dell’asma si sono verificate nel 22%
dei soggetti trattati con omalizumab e nel 25% dei soggetti trattati con placebo. Almeno due episodi
di riacerbazioni si sono verificati nel 7% dei pazienti trattati attivamente e nell’8% di quelli trattati
con placebo.
Il commento a questo articolo:
Innanzitutto occorre notare che lo studio è stato sponsorizzato dalla ditta produttrice
dell’omalizumab. In secondo luogo, il miglioramento ottenuto è estremamente modesto. In ultimo,
il costo dell’aggiunta terapeutica è molto elevato: da 700 a 4.000 dollari al mese, in base alla dose
utilizzata. Da notare che le linee guida del NIH raccomandano la prescrizione dell’omalizumab
solamente da parte di specialisti pneumologi o allergologi.
Bibliografia:
•
Hanania NA et al. Omalizumab in severe allergic asthma inadequately controlled with
standard therapy: A randomized trial. Annals of Internal Medicine 2011 May 3; 154:573
Vampate menopausali
(Obstetrics and Gynecology)
Una domanda che spesso pongono le pazienti riguarda la durata delle vampate in menopausa. La
risposta varia da 6 mesi ad oltre 5 anni, mediamente, e sono segnalati casi di vampate anche dopo
10 anni dalla cessazione del ciclo mestruale.
Per comprendere meglio il decorso naturale di questo sintomo particolarmente fastidioso, alcuni
ricercatori hanno realizzato uno studio prospettico basato su un'ampia coorte di pazienti (il Penn
Ovarian Aging Study), in cui 259 donne di 35-47 anni al momento dell'arruolamento, non facenti
uso di terapie ormonali, sono state seguite per 13 anni, durante tutto il loro periodo menopausale,
suddiviso in 5 fasi: premenopausa - premenopausa terminale - transizione precoce - transizione
terminale - postmenopausa.
La durata media delle vampate moderate e gravi è stata di 10.2 anni. Le donne che hanno iniziato a
presentare vampate nel periodo di transizione sono quelle in cui il disturbo è durato più a lungo
(11.2 anni), rispetto alle donne che hanno iniziato a soffrire di vampate nella tarda transizione o in
postmenopausa. In queste ultime, la durata media è stata di 3.8 anni.
Analisi aggiustate hanno dimostrato una durata maggiore nelle donne nere e in quelle non obese,
anche se quest'ultima osservazione contrasta con quanto rilevato in altri studi precedenti.
L'abitudine al fumo non ha invece influenzato né la durata né l'intensità delle vampate.
Il commento a questo articolo:
Tanto più precoci sono le vampate, tanto più durano. A parte questa conclusione, l'unica vera
terapia in grado di alleviare il fastidio delle vampate resta quella ormonale, che può essere adottata
nelle donne in cui il disturbo è particolarmente invalidante, per periodi di tempo non lunghi. Il
ricorso a terapie alternative, per lo più basate su derivati vegetali, ha dato risultati inconcludenti.
Bibliografia:
•
Freeman EW et al. Duration of menopausal hot flushes and associated risk factors.
Obstetrics & Gynecology 2011 May; 117:1095
Fibrillazione atriale e infarto
(Circulation)
Non è chiaro se e come la prognosi di un infarto venga modificata dall’insorgenza di fibrillazione
atriale, per cui è stato realizzato uno studio di coorte nel Minnesota, reclutando 3.220 pazienti
ricoverati in seguito ad infarto (primo episodio) e suddivisi in queste categorie:
1. assenza di fibrillazione atriale;
2. presenza di FA prima dell’infarto:
3. insorgenza di FA dopo l’infarto (in quest’ultimo caso con una sottodivisione in base al
tempo tra l’infarto e la FA: 2 giorni, da 2 a 30 giorni, oltre 30 giorni).
In 304 pazienti, la FA ha preceduto l’infarto; in 729 pazienti è insorta durante o dopo l’infarto
(generalmente oltre i 30 giorni). In questo ultimo caso, i fattori predisponenti sono stati l’età
avanzata, la presenza di ipertensione, il sesso femminile, la presenza di diabete e la presenza di
insufficienza renale, mentre le caratteristiche cliniche più comuni sono state la sede anteriore, una
frazione di eiezione minore e una classe Killip più elevata.
La FA dopo l’infarto si è associata ad un rischio più elevato di decesso (Hazard Ratio 3.8) durante il
follow-up di oltre 6 anni. In base al tempo di insorgenza della FA si è avuto, per quanto riguarda la
mortalità, un Hazard Ratio di 1.5 per chi presentava FA prima dell’infarto e di 2.6 per chi è andato
incontro a FA almeno un mese dopo l’infarto.
Il commento a questo articolo:
Una FA che insorga dopo un infarto, soprattutto oltre il mese successivo, si associa ad una elevata
mortalità, anche se il rapporto causa-effetto non è dimostrato: l’insorgenza dell’aritmia potrebbe
essere semplicemente un segno di rischio cardiovascolare elevato, per cui si impone il suo
trattamento con la stessa intensità con cui si interviene sulle coronarie.
Bibliografia:
•
•
Jabre P et al. Atrial fibrillation and death after myocardial infarction: A community study.
Circulation 2011 May 17; 123:2094
Lubitz SA et al. Atrial fibrillation and death after myocardial infarction: Risk marker or
causal mediator? Circulation 2011 May 17; 123:2063
Beta-bloccanti nella BPCO
(British Medical Journal - BMJ)
Molti β-bloccanti hanno in scheda tecnica la controindicazione al loro uso nelle broncopatie
ostruttive, per cui anche nella BPCO vengono raramente utilizzati con la paura che possano
scatenare o peggiorare un broncospasmo.
Con questo studio retrospettivo sono stati valutati gli effetti dei β-bloccanti sulle riacerbazioni di
malattia, ricoveri ospedalieri e mortalità in 6.000 pazienti scozzesi affetti da BPCO. Nel
complesso, 819 soggetti utilizzavano β-bloccanti.
Dopo un follow-up medio di 4.4 anni (in tale periodo sono deceduti circa un terzo dei pazienti) l'uso
di β-bloccanti si è associato ad una diminuzione del 22% della mortalità globale, e tale dato è
risultato indipendente dal tipo di terapia inalatoria cui i pazienti hanno fatto ricorso (steroidi,
LABA, anticolinergici, associazioni varie). Da rimarcare che l'uso dei β-bloccanti non ha avuto
alcuna interferenza con la funzionalità respiratoria.
Il commento a questo articolo:
Anche uno studio del 2010 era arrivato alle stesse conclusioni, che non sono poi così stupefacenti: il
90% dei β-bloccanti utilizzati é di tipo cardioselettivo (atenololo, metoprololo), e molti soggetti
erano anche cardiopatici, con indicazioni quindi all'uso di tale tipo di farmaci.
Bibliografia:
•
Short PM et al. Effect of β blockers in treatment of chronic obstructive pulmonary disease:
A retrospective cohort study. BMJ 2011 May 10; 342:d2549
Screening del cancro ovarico (studio PLCO)
(JAMA - Journal of the American Medical Association)
Il cancro dell’ovaio è uno dei tumori peggiori, dal momento che la sintomatologia iniziale è assai
sfumata e spesso la diagnosi viene posta quando lo stadio è già avanzato, con conseguente elevata
mortalità.
Il desiderio di poter effettuare uno screening che riveli tumori in stadio iniziale è pertanto
ampiamente giustificato, ed è stato verificato su 78.216 donne partecipanti ad un ampio studio
iniziato nel 1993: lo studio PLCO (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening
Trial).
Le donne, la cui età variava da 55 a 74 anni, sono state sottoposte in modo randomizzato ad uno
screening annuale basato sul dosaggio del CA 125 associato ad ecografia transvaginale. Lo
screening veniva considerato positivo quando si riscontravano valori di CA 125 ≥ 35 U/ml oppure
quando si accertavano anomalie mediante ecografia.
Nel 2009 i risultati hanno dimostrato che lo screening possedeva un basso valore predittivo
positivo. Adesso i ricercatori hanno riferito gli effetti dello screening sulla mortalità specifica da
cancro ovarico. La proporzione di cancri in stadio avanzato scoperti mediante screening è stata solo
leggermente inferiore a quelli diagnosticati secondo le procedure abituali (69% e 78%,
rispettivamente).
I decessi da cancro ovarico sono stati 118 nel gruppo sottoposto a screening e 100 nel gruppo di
controllo (rispettivamente 3.1 e 2.6 morti ogni 10.000 donne/anno). Tra le 3.285 donne che hanno
presentato falsi positivi allo screening, 1.080 sono state sottoposte ad intervento chirurgico, con un
tasso di complicazioni gravi del 15%.
Il commento a questo articolo:
Il cancro dell’ovaio è purtroppo rapidamente aggressivo, per cui lo screening annuale risulta del
tutto inefficace. Se teniamo conto dei falsi positivi e delle complicanze anche gravi dei loro
trattamenti, dobbiamo dire fermamente “no” ad eventuali proposte di screening di popolazione.
Bibliografia:
•
Buys SS et al. Effect of screening on ovarian cancer mortality: The Prostate, Lung,
Colorectal and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Randomized Controlled Trial. JAMA
2011 Jun 8; 305:2295
Selenio e quadro lipidico
(Annals of Internal Medicine)
E' stato ipotizzato che il selenio sia in grado di inibire l’ossidazione dei lipidi e ridurre
l’aggregazione piastrinica e l’infiammazione. Però i risultati di studi in cui è stata valutata la
relazione tra selenio e lipidi hanno dato risultati controversi, per cui alcuni ricercatori inglesi
hanno randomizzato circa 500 soggetti di età compresa tra 60 e 74 anni a ricevere giornalmente un
placebo o dosi differenti di selenio (100, 200, 300 μg).
Dopo 6 mesi i soggetti che avevano assunto selenio alla dose di 100 o 200 μg presentavano una
modesta riduzione dei livelli di colesterolo totale (rispettivamente una diminuzione di 8.5 mg/dl e
9.7 mg/dl), mentre non si è osservata alcuna variazione in quelli che avevano assunto 300 μg al
giorno. Per quanto riguarda il colesterolo HDL non si è verificata alcuna variazione con i due
dosaggi inferiori di selenio, mentre con 300 μg al giorno si è avuto un aumento di 2.3 mg/dl.
Il commento a questo articolo:
Le variazioni della colesterolemia totale e dei livelli di colesterolo HDL indotte da dosi differenti
di selenio non hanno alcuna rilevanza clinica, per cui la supplementazione con questo non-metallo è
del tutto inutile, ai fini lipidici.
Bibliografia:
•
Rayman MP et al. Effect of supplementation with high-selenium yeast on plasma lipids: A
randomized trial. Annals of Internal Medicine 2011 May 17; 154:656
Fibrillazione atriale e mortalità nelle donne
(JAMA - Journal of the American Medical Association)
Dopo lo studio Framingham, che aveva denunciato un aumento della mortalità a lungo termine soprattutto femminile - nei soggetti in cui insorge una fibrillazione atriale, altri studi successivi
non hanno confermato questo rischio, per cui alcuni ricercatori hanno realizzato uno studio
prospettico basato sulle partecipanti al Women's Health Study per valutare la mortalità in circa
35.000 donne non affette da problemi cardiaci al momento del reclutamento.
La fibrillazione atriale (FA) è insorta in donne che all’inizio dello studio erano di età più avanzata
(59 anni contro la media di 53) ed avevano una maggior prevalenza di ipertensione e di
ipercolesterolemia. Durante i 15 anni del follow-up è insorta FA in 1.011 donne, e 63 di queste
sono decedute. Dopo analisi aggiustate il rischio di mortalità nelle donne con FA è stato di 2.1 (per
motivi cardiovascolari è stato di 4.2 mentre per motivi non cardiovascolari è stato di 1.7).
Quando questo rischio è stato aggiustato per l’occorrenza di eventi cardiovascolari non fatali, ne è
risultato che la mortalità si è attenuata, pur restando ancora elevata (mortalità globale 1.7;
cardiovascolare 2.6; non cardiovascolare 1.4). Per quanto riguarda il tipo di FA, la mortalità non è
risultata maggiore nelle donne con FA parossistica ma solamente in quelle con FA cronica e
persistente. Nelle 74 donne con una FA isolata (senza alcuna altra patologia) non si sono verificati
decessi durante 7 anni di follow-up.
Il commento a questo articolo:
Ha senso attribuire l’eccesso di mortalità alla FA quando il 40% delle donne partecipanti allo studio
non erano affatto “sane”? La presenza di ipertensione e/o dislipidemia potrebbe giustificare da sé
l’aumento dei decessi, per cui il messaggio è semplice: occorre tenere attentamente sotto controllo
tutti i fattori di rischio e le condizioni patologiche che possono portare ad una mortalità
cardiovascolare aumentata.
Bibliografia:
•
•
Conen D et al. Risk of death and cardiovascular events in initially healthy women with newonset atrial fibrillation. JAMA 2011 May 25; 305:2080
Miyasaka Y and Tsang TS. Mortality risk among middle-aged women with first atrial
fibrillation. JAMA 2011 May 25; 305:2116
Tiotropio nell’asma grave
(Journal of Allergy and Clinical Immunology)
Con uno studio recente (NEJM 2010 Sep 19) si è visto che negli asmatici gravi non controllati
mediante cortisonici inalatori l’aggiunta di tiotropio ha ottenuto migliori risultati rispetto
all’aumento della dose degli steroidi, raggiungendo outcome simili a quelli ottenuti dall’aggiunta di
β2-agonisti a lunga durata d’azione (LABA).
Adesso è stata esaminata l’efficacia di una tripla terapia: tiotropio, LABA e steroidi inalatori. Con
uno studio crossover in doppio cieco, basato su periodi di trattamento di 8 settimane, 107 adulti con
asma grave non controllato da steroidi e LABA sono stati trattati con due dosi di tiotropio o placebo
in modo casuale. Le dosi di 5 μg e 10 μg di tiotropio si sono dimostrate ugualmente efficaci e
superiori al placebo nel migliorare il FEV1 (mediamente, un aumento di 139 ml con la dose minore
e di 170 ml con quella più elevata). Non sono state notate differenze nel punteggio sintomatologico
dell’asma durante i trattamenti.
Il commento a questo articolo:
In base alle linee guida, quando ci si trova davanti un paziente con asma non controllato da steroidi
e β2-agonisti, si aggiunge alla terapia la teofillina o gli anti-leucotrieni oppure ancora un anticorpo
quale l’omalizumab.
In base a questo studio si potrebbero ottenere dei buoni risultati anche con il tiotropio, ma lo studio
è troppo piccolo per poter stabilire una regola di comportamento, senza contare che il
miglioramento ottenuto è stato solamente su un parametro spirometrico e non clinico. Se ulteriori
dati, più corposi, confermeranno questi, il ricorso al tiotropio negli asmatici gravi potrà divenire una
componente abituale della terapia dell’asma grave.
Bibliografia:
•
Kerstjens HAM et al. Tiotropium improves lung function in patients with severe
uncontrolled asthma: A randomized controlled trial. Journal of Allergy and Clinical
Immunology 2011 Jun 2
FANS e rischio ischemico
(Circulation)
Dopo la pubblicazione nel 2007 di linee guida che hanno posto l’accento sui rischi della terapia
con FANS nei cardiopatici, sappiamo che l’uso protratto di questi farmaci aumenta ulteriormente
il rischio di eventi ischemici nei soggetti con cardiopatie o con rischio ischemico elevato.
Ma poco si sa riguardo un uso limitato nel tempo (ad es. meno di una settimana) dei FANS, per cui
sono da alcuni ricercatori stati utilizzati i dati del Danish National Patient Registry per valutare
l’uso di FANS in oltre 80.000 pazienti (età media 68 anni; 63% maschi) dopo un primo episodio di
infarto.
E' risultato che oltre il 42% dei soggetti aveva assunto FANS di vario tipo (in ordine di frequenza:
ibuprofene 23%, diclofenac 13%, rofecoxib 5%, celecoxib 5%, naprossene 2%). Durante il
follow-up (dal 1997 al 2006) l’outcome primario composto (decesso o recidiva di infarto) è
avvenuto nel 42% dei soggetti che avevano assunto FANS.
Rispetto alla popolazione generale si è visto che il rischio di un evento ischemico è stato
significativamente maggiore nella prima settimana di trattamento con FANS (Hazard Ratio 1.45) e
tale aumento di rischio si è mantenuto significativo anche con il passare dei giorni, con un Hazard
Ratio di 1.55 a 90 giorni.
Con analisi individuali si è visto che tutti i FANS, eccettuato il naprossene, si sono associati ad
aumento di rischio ischemico; il maggior aumento di rischio è stato ottenuto dal diclofenac, con un
hazard ratio di 3.26 nella prima settimana di trattamento, superiore anche a quello del rofecoxib, che
è stato ritirato dal commercio USA nel 2004 proprio per questi effetti collaterali.
Il commento a questo articolo:
Lo studio è ampio e purtroppo dimostra un aumento del rischio ischemico di circa il 45% nella
prima settimana di trattamento in pazienti con recente infarto.
Dal momento che tale rischio addirittura aumenta con il prolungamento della somministrazione
(arrivando al 55% dopo 3 mesi), appare evidente che occorre estrema cautela nel prescrivere FANS
a pazienti con problemi di cardiopatia ischemica. Se la somministrazione è assolutamente
necessaria, si utilizzi perlomeno un FANS a rischio ischemico minore, quale il naprossene.
Bibliografia:
•
Schjerning Olsen A-M et al. Duration of treatment with nonsteroidal anti-inflammatory
drugs and impact on risk of death and recurrent myocardial infarction in patients with prior
myocardial infarction: A nationwide cohort study. Circulation 2011 May 24; 123:2226
Cause di stroke ischemico
(Neurology)
Lo stroke ischemico riconosce le stesse cause nel giovane adulto e nell’adulto di età più avanzata?
Per rispondere a questa domanda è stata effettuata in Francia un’analisi retrospettiva sulle cause di
stroke acuto ischemico in 318 pazienti di età compresa tra 16 e 54 anni: quasi tutti sono stati
sottoposti ad angio-TC o angio-RM, e se queste indagini non chiarivano la causa dello stroke il
soggetto veniva sottoposto ad ecocardiografia transesofagea.
Una causa accertata di stroke è stata riscontrata nella metà dei pazienti: 15% per aterotrombosi, 8%
per malattia dei piccoli vasi, 8% per cardioembolismo (in genere da fibrillazione atriale) e 14% da
altre cause definite (compresi 30 pazienti con dissezione arteriosa cerebrale o cervicale).
Per 59 soggetti (19%) si sono riscontrate cause probabili ma non certe, in massima parte pervietà
del forame ovale e aneurisma del setto interatriale (43 casi). Sono anche state analizzate le cause
suddividendo i pazienti in due gruppi di età: 16-44 anni e 45-54 anni. La differenza è stata che nel
gruppo di età più giovane è stato più difficile risalire alle cause dello stroke (35% contro 53% di
identificazione), anche se in questo gruppo è stata molto più frequente la dissezione arteriosa (15%
contro 6%).
Il commento a questo articolo:
Purtroppo in una buona metà dei pazienti che vanno incontro a stroke ischemico non si riesce a
definirne la causa, soprattutto se l’età è giovane. Probabilmente entrano in gioco fattori genetici,
per cui sarebbe necessario effettuare uno studio accurato della situazione trombofilica ed un
monitoraggio prolungato della funzionalità cardiaca.
Bibliografia:
•
Larrue V et al. Etiologic investigation of ischemic stroke in young adults. Neurology 2011
Jun 7; 76:1983
Trigliceridi e malattie cardiovascolari
(Circulation)
Se da una parte si sta ancora discutendo sull’eventuale ruolo dei trigliceridi nella genesi delle
malattie cardiovascolari, dall’altra il livello di questi grassi continua ad aumentare con il
benessere sociale, parallelamente all’aumento dell’obesità e del diabete.
I livelli dei trigliceridi sono legati direttamente al metabolismo delle lipoproteine ad alta e bassa
densità, e l’aumento dei trigliceridi può essere di tipo genetico o acquisito (ad es. in caso di
ipotiroidismo, diabete, malattie renali). Sulla base di queste considerazioni, alcuni ricercatori
dell’AHA (American Heart Association) hanno proposto un algoritmo per la misurazione dei
trigliceridi non a digiuno: se il loro livello plasmatico è inferiore a 200 mg/dl, il soggetto non
presenta necessità di cambiamenti nell’alimentazione e nello stile di vita.
Con livelli superiori a 200 mg/dl si raccomanda il dosaggio delle lipoproteine ed un controllo
dell’alimentazione e dell’attività fisica, con aumento di quest’ultima e introduzione nella dieta di
acidi grassi ω-3. Nei pazienti con livelli molto elevati o con sintomi cardiovascolari possono essere
introdotti farmaci per abbassare il rischio, ad esempio, di pancreatite, che insorge facilmente con
livelli > 500 mg/dl.
Il commento a questo articolo:
Nonostante queste indicazioni (che non tutti condividono) continuiamo a non avere le idee chiare
sul rapporto tra trigliceridi e malattie cardiovascolari e nemmeno se convenga utilizzare farmaci
per diminuirne i livelli plasmatici.
Una soluzione di buon senso potrebbe essere quella di 'sfruttare' l’aumento dei trigliceridi per
cercare di convincere il soggetto a modificare il proprio stile di vita, aumentando l’attività fisica e
diminuendo l’introduzione di grassi. Indipendentemente dal rischio cardiovascolare, la sua salute ne
trarrà sicuramente giovamento.
Bibliografia:
•
Miller M et al. Triglycerides and cardiovascular disease: A scientific statement from the
American Heart Association. Circulation 2011 May 24
Valutazione, trattamento e prevenzione del deficit di vitamina
D
(Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism)
La Endocrine Society ha pubblicato delle nuove linee guida sul deficit di vitamina D, i cui punti
fondamentali sono i seguenti: non è raccomandato lo screening generalizzato in quanto manca
l’evidenza sulla sua utilità, ma si invita a sottoporre a screening gli adulti che siano ad alto rischio
di deficit vitaminico, compresi coloro che sono affetti da osteoporosi, obesità o che presentino una
storia di cadute.
Il deficit vitaminico è presente quando i livelli serici di 25[OH]D sono < 20 ng/ml (50 nmol/l).
L’assunzione giornaliera raccomandata per un soggetto adulto è di almeno 600 UI, aumentate ad
800 UI per chi ha oltre 70 anni, anche se alcuni soggetti a rischio possono necessitare di
un’introduzione ≥ 1500 UI.
Il problema è che pochi cibi contengono quantità sufficienti di vitamina e pochi soggetti si
espongono all’azione dei raggi solari, per cui il trattamento integrativo diventa necessario
soprattutto in presenza di patologie che riguardino l’apparato osseo. Non sussiste invece evidenza
che il trattamento vitaminico abbia effetti preventivi sulle malattie cardiovascolari o sulla
mortalità globale o, in genere, sulla qualità di vita.
Dalle linee guida non emerge comunque l’indicazione ad eseguire lo screening routinariamente e
nemmeno quali sono i casi in cui l’integrazione giornaliera sia necessaria. Per quanto riguarda l’età
pediatrica, le linee guida sono ancora più scarne: il rischio di deficit risulta aumentato nei lattanti
alimentati al seno che non ricevano integrazione vitaminica, nei soggetti di cute nera, nei figli di
madri con deficit vitaminico.
In pediatria, il livello plasmatico di rischio è, come per l’adulto, di 20 ng/ml, mentre l’apporto
giornaliero consigliato è di 400 UI fino all’anno di età e di 600 UI dopo i 12 mesi di vita.
L’integrazione per i bambini che ne hanno bisogno deve essere di 2.000 UI al giorno oppure di
50.000 UI una volta alla settimana.
Il commento a questo articolo:
Sulla necessità dell’integrazione con vitamina D si è scritto molto, ma le idee non sono ancora
chiare. L’unica certezza pare sia l’aumento del fabbisogno da 400 a 600 UI dopo l’anno di vita, ma
se sottoporre a screening, chi sottoporre a screening, quando effettuare l’integrazione vitaminica
rimangono punti ancora da chiarire.
Bibliografia:
•
Holick MF et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: An
Endocrine Society clinical practice guideline. The Journal of Clinical Endocrinology &
Metabolism 2011 Jun 6
Cortisonici nella polmonite
(The Lancet)
Quando si verifica un episodio di polmonite, oltre al focolaio infettivo localizzato si instaurano
fenomeni di flogosi generalizzata a tutto l’organismo, ed è in seguito a questa diffusione del
processo patologico che possono nascere situazioni anche gravi con pericolo di vita del paziente.
Sembrerebbe pertanto logico utilizzare dei farmaci con azione antiflogistica per cercare di prevenire
il danno sistemico. In Olanda sono stati randomizzati 304 pazienti non immunodepressi e affetti da
polmonite ad essere trattati con 5 mg al giorno di desametasone per via endovenosa oppure
placebo; dopo 4 giorni la via di somministrazione è stata passata da endovenosa ad orale.
Il trattamento antibiotico è stato quello abituale. L’endpoint primario è stato stabilito nel momento
della dimissione dall’ospedale, prendendo questo avvenimento come indice di morbilità globale
risolta. I pazienti ricoverati in unità intensive o quelli che necessitavano di cortisonici per altri
motivi (ad es. BPCO) sono stati esclusi dall’analisi.
La durata media del ricovero è stata significativamente più breve nel gruppo trattato con il
desametasone (6.5 giorni contro 7.5), mentre non si sono trovate differenze alcune nella percentuale
di pazienti inviati in unità intensive, nella mortalità globale, nelle complicanze pleuriche,
nell’insorgenza di empiema e nell’eventuale nuovo ricovero nei 30 giorni successivi alla
dimissione.
Nei primi 4 giorni di terapia la diminuzione dei valori di PCR e di interleuchina-6 è stata
ovviamente maggiore nei soggetti trattati con il cortisonico, ma in questo gruppo è stata più
frequente l’iperglicemia ed un paziente ha presentato una perforazione gastrica. Nel complesso, gli
eventi collaterali sono stati modesti e distribuiti in entrambi i gruppi.
Il commento a questo articolo:
Il beneficio del cortisonico è stato modesto (un giorno di ricovero in meno), mentre gli effetti
collaterali, anche se non gravi, non sono stati nulli. L’aggiunta del cortisonico alla terapia
antibiotica abituale della polmonite deve pertanto essere valutata caso per caso e non può essere
consigliata per tutti i pazienti.
Bibliografia:
•
•
Meijvis SCA et al. Dexamethasone and length of hospital stay in patients with communityacquired pneumonia: A randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2011 Jun
11; 377:2023
Confalonieri M and Meduri GU. Glucocorticoid treatment in community-acquired
pneumonia. Lancet 2011 Jun 11; 377:1982
ARB ed eventi cardiovascolari
(British Medical Journal - BMJ)
In un editoriale del 2004 di Verma e Strauss era stata evidenziata la possibilità che l’uso dei
bloccanti recettoriali dell’angiotensina II portasse ad un aumentato rischio di infarto del miocardio.
Per queste ragioni recentemente sono stati pubblicati i risultati di una metanalisi in cui è stato
valutato il rischio di eventi cardiovascolari associati all'uso di ARB. Sono stati considerati 37 trial
clinici randomizzati di confronto tra placebo o altri trattamenti antiipertensivi e ARB; questi trial
comprendevano un campione enorme di 147.020 pazienti, di cui il 49,8% trattato con un ARB, e
con un follow-up medio di 3.3 anni.
Rispetto al placebo e agli altri trattamenti, l'uso di ARB non è risultato associato nè ad un
aumentato rischio di infarto miocardico (RR 0.90; 95% IC 0.92-1.07) nè ad un aumento di mortalità
da qualsiasi causa, mortalità da cause cardiovascolari o angina (RR 1.0).
In aggiunta gli ARB si sono dimostrati in grado di diminuire significativamente il rischio di stroke
(riduzione relativa del 10% vs placebo), di scompenso cardiaco (13%) e di diabete di nuova
insorgenza (15%). I risultati di questa metanalisi consentono di rifiutare l’ipotesi secondo la quale la
terapia con un ARB aumenti il rischio di infarto del miocardio.
Il commento a questo articolo:
L'uso di ARB non solo non si associa ad eventi CV negativi, ma riduce il rischio di stroke, di
insorgenza di diabete e di scompenso cardiaco. Il risultato è inequivocabile: gli ARB costituiscono
un valido strumento terapeutico contro l'ipertensione, associato ad un buon profilo di tollerabilità.
Bibliografia:
•
Bangalore S et al. Angiotensin receptor blockers and risk of myocardial infarction: Metaanalyses and trial sequential analyses of 147020 patients from randomised trials. BMJ 2011
Apr 26; 342:d2234
Valsartan e incidenza di diabete mellito
(New England Journal of Medicine)
I pazienti affetti da alterata intolleranza al glucosio presentano un aumentato rischio di diabete
mellito di tipo 2 e di patologie cardiovascolari. Un approccio farmacologico per la riduzione di
queste patologie è rappresentato dall’inibizione del sistema renina angiotensina.
Lo studio NAVIGATOR (Nateglinide and Valsartan in Impaired Glucose Tolerance Outcomes
Research) è stato condotto per valutare se nateglinide, ipoglicemizzante della classe delle
meteglinidi, o valsartan, riducevano il rischio di diabete e di patologie cardiovascolari in pazienti
intolleranti al glucosio. Lo studio ha dimostrato che i pazienti che assumevano valsartan (in una
singola dose giornaliera fino a 160 mg) avevano una riduzione del rischio di diabete del 14%,
rispetto ai soggetti che assumevano placebo.
L’effetto di valsartan è risultato superiore a quello osservato con un ACE inibitore nell’unico studio
precedente che aveva come outcome primario definito prospetticamente lo sviluppo di diabete o la
morte. Nello studio DREAM è stata riscontrata una tendenza non significativa a una riduzione
dell’incidenza di diabete nel gruppo ramipril rispetto ai pazienti del gruppo placebo.
Una nota importante riguarda l’impatto delle modificazioni dello stile di vita in termini di riduzione
di incidenza di diabete di nuova insorgenza e nel lungo periodo degli eventi cardiovascolari in
genere. Sia nello studio NAVIGATOR che nello studio DREAM si è dimostrata l’importanza di un
corretto stile di alimentazione ed esercizio fisico. Quindi in aggiunta a un intervento sullo stile di
vita, valsartan alla dose di 160 mg al giorno ha ridotto il rischio di diabete in pazienti con alterata
tolleranza al glucosio. In conclusione, anche se le modifiche dello stile di vita dovrebbero rimanere
l’intervento principale per ridurre il rischio di diabete nella popolazione generale, i risultati dello
studio NAVIGATOR possono avere implicazioni anche per il trattamento dell’ipertensione, in
quanto sia l’uso di diuretici tiazidici sia di beta bloccanti è stato associato a un aumento del rischio
di diabete.
Il commento a questo articolo:
Il valsartan possiede una buona attività anti-ipertensiva e comporta una riduzione dell'incidenza di
diabete mellito, statisticamente significativa. Inoltre, nei soggetti diabetici, consente un risparmio
farmacologico per il controllo glicemico e comporta una riduzione dei valori glicemici rispetto al
placebo, dimostrandosi un valido strumento terapeutico non solamente nel campo cardiovascolare
ma anche in quello metabolico.
Bibliografia:
•
The NAVIGATOR Study Group. Effect of valsartan on the incidence of diabetes and
cardiovascular events. NEJM 2010 Mar 14
Confronto tra Valsartan ed altri ARB
(International Journal of Psychiatry in Clinical Practice)
Per effettuare un confronto tra i vari antagonisti dei recettori dell’angiotensina (ARB) disponibili in
commercio è stata realizzata una ricerca sistematica dei lavori comparsi in letteratura tra il 1997 e il
2008, prendendo in considerazione studi di breve durata, in doppio cieco randomizzato (RCT)
riguardanti l’ipertensione lieve-moderata (definita come valori compresi tra 90 e 115 mmHg).
Per ogni soggetto è stata valutata sia la pressione sistolica che quella diastolica ed i cambiamenti
ottenuti, valutando il tipo di ARB utilizzato e la dose impiegata. Nel complesso, sono stati inclusi
31 RCT per un campione complessivo di 13.110 pazienti. Di questi, 6 erano stati condotti con
candesartan, 6 con irbesartan, 13 con losartan, 2 con olmesartan, 5 con telmisartan e 12 con
valsartan.
La riduzione media della pressione sistolica e diastolica con valsartan 160 mg è stata di 15.32
mmHg e 11.30 mmHg, rispettivamente, mentre con il dosaggio di 320 mg la riduzione è stata
rispettivamente di 15.85 mmHg e di 11.97 mmHg. L’entità di queste riduzioni è statisticamente
significativa se paragonata a quanto ottenuto con losartan 100 mg (12.01 mmHg e 9.37 mmHg), e
si è anche constatato che la terapia con valsartan 160 mg riduce la pressione sistolica e diastolica
maggiormente che non irbesartan 150 mg e candesartan 16 mg. Le altre differenze riscontrate tra i
vari ARB non hanno raggiunto la significatività statistica.
Questa metanalisi ha dimostrato che valsartan 160 e 320 mg è più efficace in termini di riduzione
pressoria rispetto a losartan 100 mg.
Il commento a questo articolo:
Tra tutti gli ARB, il valsartan a dosaggio medio (160 mg/die) o elevato (320 mg/die) mostra una
maggiore efficacia antiipertensiva associata ad un buon profilo di tollerabilità; queste caratteristiche
dovrebbero essere tenute in debito conto nella scelta di questa classe di farmaci.
Bibliografia:
•
Nixon RM, Müller E, Lowy A, Falvey H. Valsartan vs. other angiotensin II receptor
blockers in the treatment of hypertension: a meta-analytical approach. Int J Clin Pract. 2009
May;63(5):766-75.
Rischio di fratture nel diabete di tipo 2
(JAMA - Journal of the American Medical Association)
Se da un lato il diabete di tipo 2 si associa ad una elevata densità ossea, paradossalmente in questa
malattia è presente un rischio maggiore di fratture, che non è facilmente quantificabile con i mezzi
a disposizione (ad esempio applicando il punteggio FRAX o calcolando il valore della densità ossea
mediante DEXA).
Sono pertanto stati esaminati i dati di tre studi nazionali, unificati per valutare il rischio di frattura
in 9.449 donne anziane, seguite mediamente per 12.6 anni, e in 7.436 maschi anziani, seguiti
mediamente per 7.5 anni. Tra le 770 donne diabetiche si sono verificati 262 casi di frattura non
vertebrale, mentre tra i 1.199 maschi diabetici le fratture non vertebrali sono state 133. Circa un
quarto di tutte le fratture sono state di femore.
Il calcolo della BMD (densità minerale ossea) aggiustato per età e sesso ha fornito valori predittivi
di frattura indipendenti dalla presenza o meno del diabete, anche se, per ogni valore della BMD i
pazienti diabetici hanno presentato un rischio maggiore di quelli non diabetici: ad es. le donne
diabetiche con T-score migliore di 0.59 punti hanno presentato la stessa incidenza di fratture
rispetto alle donne non diabetiche con un T-score peggiore. Per i maschi la differenza del T-score è
stata di 0.38 punti. La stessa cosa si è vista con il punteggio FRAX.
Il commento a questo articolo:
Da questa analisi sappiamo che sia il calcolo della BMD sia l'applicazione del punteggio FRAX
fornisce una attendibile previsione sulla fragilità ossea, e sappiamo pure che, a parità di punteggio,
i soggetti con diabete di tipo 2 presentano un lieve aumento del rischio di fratture rispetto ai non
diabetici.
Bibliografia:
•
Schwartz AV et al. Association of BMD and FRAX score with risk of fracture in older
adults with type 2 diabetes. JAMA 2011 Jun 1; 305:2184
Fumo e rischio di arteriopatie periferiche nelle donne
(Annals of Internal Medicine)
Le statistiche dicono che negli USA il 18% delle donne sono fumatrici, e questa abitudine si
ripercuote sicuramente sul rischio di arteriopatie periferiche, anche se in modo forse differente dai
maschi.
Per studiare meglio questo aspetto del problema sono stati utilizzati i dati relativi a 40.000 donne
non cardiopatiche partecipanti al Women's Health Study, valutando l'associazione tra arteriopatie
periferiche (sia come malattia sia come intervento di rivascolarizzazione) ed abitudine al fumo
(sia come fumo attuale sia come cessazione).
Durante un follow-up medio di 13 anni si sono verificati 178 eventi vasculopatici, con un'incidenza
variabile da 0.12 eventi ogni 1000 donne/anno per le non fumatrici fino a 1.63 eventi/1000
donne/anno per quelle che fumavano ≥ 15 sigarette al giorno al momento dell'ingresso nello studio.
L'aggiustamento in base ai soliti fattori di rischio e l'eventuale uso di terapie ormonali non hanno
modificato questi risultati.
Le donne ex-fumatrici, confrontate con le fumatrici attuali, hanno presentato un rischio minore,
con una diminuzione del rischio direttamente proporzionale al periodo di tempo trascorso dopo la
cessazione del fumo: l'uguaglianza con le non fumatrici è stata raggiunta dopo 20 anni di cessazione
dal fumo.
Il commento a questo articolo:
Lo studio conferma quanto si ipotizzava già e cioè che il fumo aumenta il rischio di arteriopatia
periferiche anche nelle donne, con due dati di fatto da tenere presenti e da ricordare alle donne
fumatrici: primo, l'associazione tra fumo e arteriopatie è indipendente da altri fattori di rischio;
secondo, la cessazione dal fumo abbassa gradatamente tale rischio.
Bibliografia:
•
Conen D et al. Smoking, smoking cessation, and risk for symptomatic peripheral artery
disease in women: A cohort study. Annals of Internal Medicine 2011 Jun 7; 154:719
Annusare il cancro
(GUT)
Sono stati pubblicati lavori in cui si è dimostrato che i cani sono in grado di scoprire tumori della
pelle, della vescica, dei polmoni, della mammella e dell’utero mediante l’olfatto. Adesso alcuni
ricercatori appartenenti al St. Sugar Cancer Sniffing Dog Training Center in Chiba (Giappone)
hanno utilizzato una femmina labrador di 8 anni per verificarne la capacità di percepire cancri del
colonretto.
L’allenamento del cane è iniziato nel 2005, facendole annusare alcune centinaia di pazienti affetti
da cancro del colonretto e circa 500 volontari sani. Ogni sessione di allenamento veniva
considerata terminata quando il cane poteva distinguere tra campioni del paziente e campioni di 4
controlli fatti annusare consecutivamente, il tutto ripetuto per diverse volte. Lo studio ha
comportato l’utilizzo di due tipi diversi di campioni: aria espirata da 33 pazienti e da 132 controlli
sani e feci lavate in acqua emesse da 37 pazienti e da 148 controlli.
Tutti i soggetti, sia quelli affetti da cancro sia quelli sani, sono stati preventivamente sottoposti a
colonscopia, riscontrando la presenza di polipi del colonretto in circa la metà di loro. Facendo un
confronto con i risultati di una tradizionale colonscopia, il cane ha raggiunto una sensibilità del
91% e una specificità del 99% con i campioni di aria espirata; i due valori sono stati del 97% e del
99% con i campioni di feci lavate in acqua. Questi risultati sono stati indipendenti dallo stadio del
tumore.
Il commento a questo articolo:
Se teniamo presente il costo dell’allevamento, addestramento e mantenimento di un cane dedicato a
questa ricerca, è chiaro che una soluzione del genere è improponibile come screening. Lo studio è
importante semplicemente perché dimostra la presenza di sostanze volatili specifiche del cancro,
emesse con il respiro e con le feci, che se potessero venire identificate con metodi chimici
aprirebbero una nuova strada agli screening.
Bibliografia:
•
Sonoda H et al. Colorectal cancer screening with odour material by canine scent detection.
Gut 2011 Jun; 60:814
Exemestane in prevenzione del cancro mammario
(New England Journal of Medicine )
Il tamoxifene ed il raloxifene diminuiscono il rischio di cancro nelle donne a rischio elevato.
Adesso un terzo farmaco, appartenente alla categoria degli inibitori dell’aromatasi, è stato messo a
disposizione: l’exemestane.
Con uno studio in parte finanziato dall’industria farmaceutica sono state arruolate 4.560 donne in
postmenopausa che possedevano almeno uno dei seguenti criteri di inclusione:
•
età ≥ 60;
•
•
rischio di cancro mammario a 5 anni > 1.66%;
pregressa neoplasia intraepiteliale.
Le donne sono state randomizzate a ricevere exemestane per 5 anni, con controlli clinici e
mammografia annuali. Durante il follow-up medio di 3 anni sono stati diagnosticati cancri invasivi
in 11 donne trattate con exemestane e in 32 donne che avevano assunto placebo (incidenza annuale
0.19% contro 0.55%).
Vampate e dolori articolari sono stati leggermente più frequenti con il farmaco che con il placebo,
mentre l’incidenza di fratture e di eventi cardiovascolari è risultata simile nei due gruppi. Circa un
terzo delle donne in entrambi i gruppi ha abbandonato lo studio, con una maggioranza di abbandoni
per effetti tossici nel gruppo dell’exemestane (15.4% contro 10.8%).
Il commento a questo articolo:
Anche se tamoxifene e raloxifene sono approvati per l’uso preventivo, a questo scopo vengono
comunque poco usati, per vari motivi (resistenza dei medici a proporre questo tipo di intervento?
Paura di effetti collaterali? NNT troppo elevato?).
In questo studio anche l’exemestane si dimostra in grado di diminuire l’incidenza del cancro
mammario, con un NNT di circa 100 in tre anni. Vedremo nel futuro come verrà affrontato il tema
della prevenzione farmacologica.
Bibliografia:
•
Goss PE et al. Exemestane for breast-cancer prevention in postmenopausal women. NEJM
2011 Jun 23; 364:2381