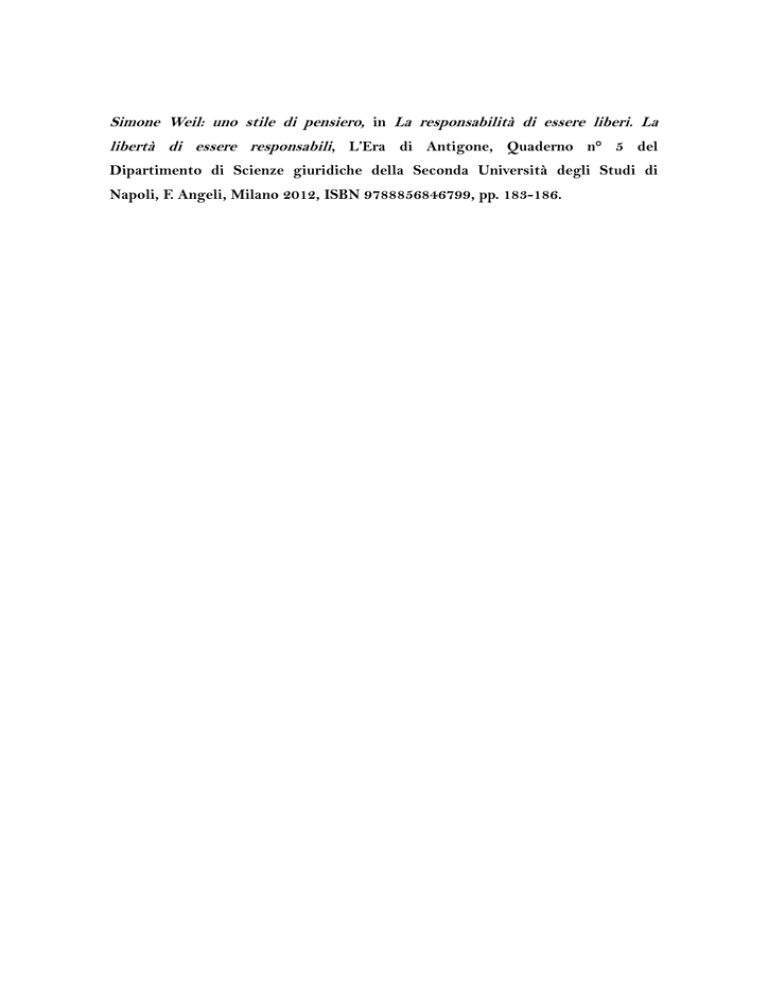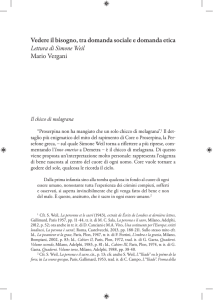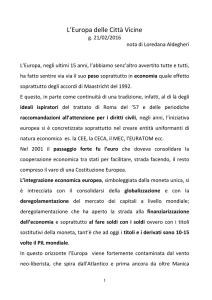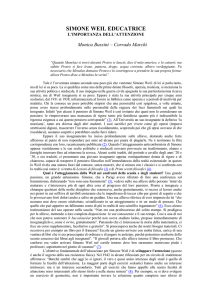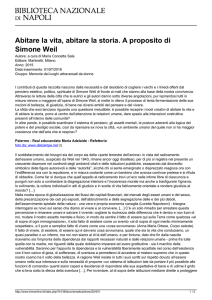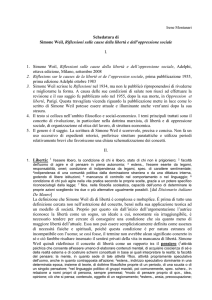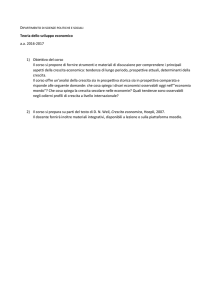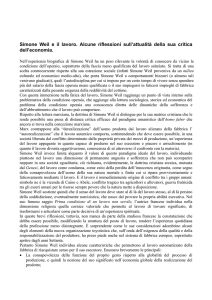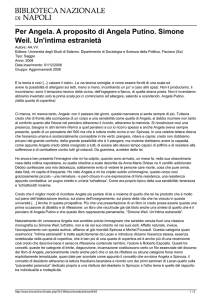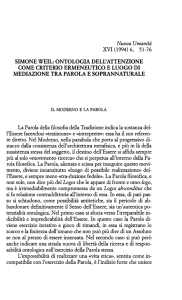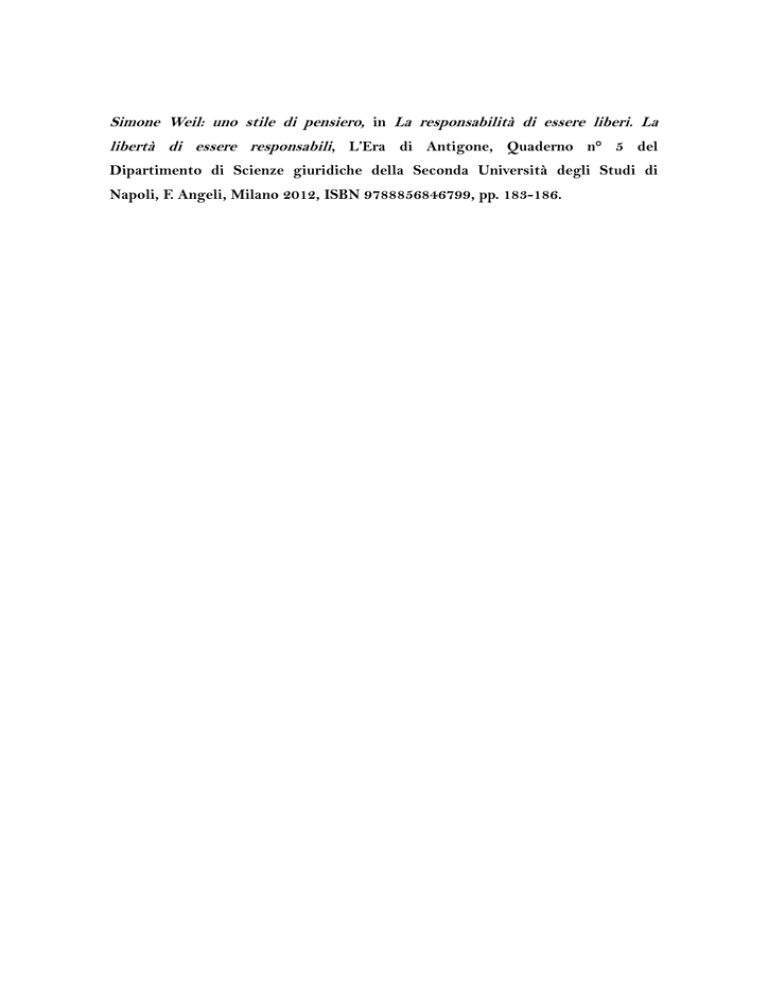
Simone Weil: uno stile di pensiero, in La responsabilità di essere liberi. La
libertà di essere responsabili, L’Era di Antigone, Quaderno n° 5 del
Dipartimento di Scienze giuridiche della Seconda Università degli Studi di
Napoli, F. Angeli, Milano 2012, ISBN 9788856846799, pp. 183-186.
Simone Weil: uno stile di pensiero
di Giuseppe Limone
Simone Weil nasce a Parigi nel 1909 e muore a Ashford nel 1943, ad appena 34 anni.
La sua breve vita, collocata fra i due conflitti mondiali del Novecento, presenta
simbolicamente in se stessa i tratti degli eventi di cui fu testimone non passiva: la crisi
del ‘29, l’avvento dei totalitarismi, la critica rivoluzionaria dei sistemi sociali, i
movimenti operai, la guerra di Spagna, la seconda guerra mondiale. Di tutto ciò il suo
pensiero porta le stimmate, ma in un modo del tutto originale.
Crediamo che, per inquadrare correttamente il pensiero di Simone Weil, sia
necessario individuare la sua postura speculativa. Un pensiero infatti può essere
compreso non solo indagandone il contenuto, ma a partire dalla prospettiva radicale da
cui muove, ossia da quella che noi chiamiamo la sua postura teoretica. Crediamo, in
questo senso, che il pensiero di Simone Weil possa capirsi solo a partire dallo stile
tragico della catastrofe. Ci sono due modi diversi di pensare l'etica e due modelli di
pensatori: c'è un modo che pensa l'etica riferendosi agli eventi difficili della vita come a
possibili contingenze incontrate nel proprio cammino e c'è un altro modo, che pensa
invece l'etica proprio a partire dagli eventi più difficili, gli eventi-limite, quelli a partire
dai quali è possibile vedere in un orizzonte di verità. Esiste cioè uno stile etico del
pensare eticamente e uno stile tragico del pensare eticamente. Crediamo, in questo
senso, che la Weil sia una pensatrice tragica che pensa a partire dalla catastrofe: la
catastrofe intesa come la situazione vera da cui è possibile guardare la realtà. Già nella
prima fase della sua ricerca intellettuale c'è un forte indizio di questa sensibilità
teoretica, consistente nel fatto che il suo pensiero muove per vocazione sua propria non
da un mero intreccio di ragionamenti, ma direttamente dal vissuto. Simone Weil non
semplicemente pensa al proprio vissuto, ma a partire dal proprio vissuto. Un tale
indirizzo speculativo non indica solo una preferenza metodologica, ma lo statuto di una
postura teoretica. Soltanto a partire dal vissuto si possono dire cose vere. La scelta
spaesante della Weil di vivere, lei borghese, direttamente la condizione operaia nel
1934 ne è un'indicazione forte. La Weil decide non di pensare la condizione operaia, ma
di pensare a partire dalla condizione operaia.
Questo avvio di vita teoretica conosce una più esplicita svolta con lo scoppio della
seconda guerra mondiale, quando la pensatrice francese sceglie più drasticamente di
vivere la condizione dei vinti. Essa cioè pensa a partire dalla catastrofe. Ciò per una
scelta che, ancora una volta, non è semplicemente di contenuto, ma di impostazione.
Solo a partire dalla catastrofe infatti si guarda la realtà dalla condizione degli ultimi,
degli sventurati. La condizione della sventura è il luogo necessario dal quale può
vedersi la verità. Qualsiasi altro luogo non sarebbe né rivelativo né radicale. La
condizione della catastrofe ha una sua tragica “oggettività”, che non dipende dalla
scelta di questa o di quella confessione religiosa. In ogni catastrofe il vinto, lo
sventurato guarda con gli stessi occhi con cui ogni altro vinto guarda,
indipendentemente dalla fede abbracciata. Crediamo che sia in questo preciso senso che
la Weil esprima la sua cristologia spaesante, per la quale si parte da Cristo e dalla sua
croce in un orizzonte che paradossalmente prescinde dalla stessa adesione al
cattolicesimo o al cristianesimo. Pensare a partire dalla catastrofe infatti significa
collocarsi nella condizione più radicale per pensare a partire dalla verità. E, d'altra
parte, pensare a partire dalla verità significa pensare a partire dalla comunità: quella
comunità con cui si pensa, a cui si pensa, per cui si pensa, a partire da cui si pensa.
Se si guarda alla stessa tragedia greca e al ruolo che in essa ha il coro, può capirsi
bene come la posizione del coro sia quella dello spettatore partecipante, dello
spettatore comunitario partecipante, che guardando da una condizione di catastrofe,
vede la verità della condizione umana dall’interno di un coinvolgimento emozionale. Si
consideri ciò che Walter Benjamin dice dell'eroe greco nei confronti del Fato. Egli
sottolinea che l'eroe, caduto sotto i colpi di una Forza anonima che non ha volto, si
sente moralmente superiore a essa: è solo nella condizione della catastrofe che a lui
appare questa straordinaria verità.
La sventura quindi, per Simone Weil, è la condizione a partire dalla quale possiamo
veramente capire. Ciò vale sia per chi ne è colpito sia per chi decide di condividerla con
lui. Si tratta di una condizione che può subirsi direttamente o può condividersi per
compassione: per una compassione da intendere come scelta di compartecipazione. La
compassione infatti è il luogo specifico all'interno del quale la sventura, condivisa per
generosità, può far balenare la sua ultimativa verità. La sventura, in quanto espressione
della catastrofe, non è solo oppressiva, ma rivelativa. C'è da osservare però che Simone
Weil, che tanta meditazione filosofica ha sviluppato a partire dalla riflessione sulla
condizione di sventura, ha forse disatteso o mal compreso, nel suo opporre
l'impersonale al personale in nome dell'impersonale, il problema della persona. Che
cosa è infatti l'impersonale per la Weil? È l'affermarsi di un universale che non è
disincarnato, non è astratto non è attivistico e non è partigiano. Un tale “impersonale”,
affermato in nome della carnalità ineludibile, rappresenta quella condizione universale
che rifiuta la mera particolarità e rifiuta di essere ridotta all'astrazione, mentre
contemporaneamente rifiuta di essere ricondotta a un giacimento attivistico che si
esaurisce in una volontà e in un fare. La condizione dell'impersonale a cui guarda la
Weil è una condizione “passiva” non nel senso della sua inerzia, ma nel senso del suo
costituire il grado zero del sé. Ora, un tale “impersonale” non è affatto contrapposto
alla persona, se si guarda alla persona nella sua configurazione radicale. La persona
infatti non può essere pensata come disincarnata, né può essere guardata astrattamente,
né può essere vista nella sua mera soggettività attivistica, particolare e partigiana. È
dentro la “persona” appunto che vive l'“impersonale” di cui parla la Weil. La persona
non è la pura soggettività attivista e cosciente, ma è il grado zero del sé, assunto nella
sua unicità e nella sua valenza universale. Questa “persona” non è il puro soggetto, né
la mera coscienza, né la semplice singolarità che ha perso il legame con l'universale.
Essa è, se ci si sa elevare a un tipo logico superiore, l'universalità della propria unicità.
Nella persona, concreta singolarità di ognuno, vive appunto quel quid che Simone Weil
chiama impersonale e che è invece il vero nocciolo universale del personale. Dentro la
persona abita non solo la soggettività, ma quella “passività intelligente” in cui si
realizza quel nucleo universale che in un lampo improvviso di luce la catastrofe rivela.
L'“impersonale” della Weil e l'idea della persona ben configurata hanno gli stessi
bersagli dialettici: possono ben essere quindi, da questo punto di vista, semanticamente
convergenti. La vera radice della filosofia è il vissuto. La filosofia deve avere la capacità
e la forza di uscire dai salotti delle pure argomentazioni per entrare nella dura terra
della realtà carnale, anzi deve avere l'umiltà e il coraggio di ripensare daccapo a partire
da essa. In una tale condizione, stando nel luogo del vissuto, essa può esprimere quel
pensiero che è attenzione e attesa, là dove l'attenzione rifiuta l'inerzia e l'attesa rifiuta la
superbia, la ybris, di chi crede di potersi salvare da sé e da solo. Non a caso sia l'attesa
(«l'attente») sia l'attenzione («l'attention») hanno in comune la tensione (la «tension»),
ossia quell'atteggiamento non inerte che mira contemporaneamente all'altro e all'alto
della possibile grazia.
Simone Weil mette al centro della sua meditazione il malheur, la sventura, nella quale
è decapitato ogni futuro. La sventura è quella condizione di atterrata inermità a partire
dalla quale la realtà si rivela nella sua ultima, intima e celata verità. In essa appare in
filigrana la realtà della condizione umana. Una tale condizione può essere subìta
direttamente nella propria carne o condivisa per compassione: ma sia nell'uno che
nell'altro caso tale condizione accade in nome del significato universale dell'umano in
cui la catastrofe rivela il nascosto. La catastrofe identifica in un lampo i punti-crisi che
disegnano i contorni di un’identità, dell’identità della situazione umana: sia in quanto
singolarmente vissuta, sia in quanto radicata in una comunità, sia in quanto generata
dalle sociali responsabilità. Nella sventura pesano insieme la sorte e le volontà
oppressive, che stringono gli assoggettati in un viluppo di necessità nel quale l'unica
risorsa, incancellabile risorsa, è l’istanza del bene che nell'attenzione e nell'attesa può
trovare aperto un varco condiviso verso la possibile grazia. In questo senso, la sventura
è condizione politica e ontologica, in cui si mostra ciò che l'umano può fare e ciò che
l'umano non può fare. Nella situazione di catastrofe che la sottende lampeggiano
insieme l'universalità segreta di ogni condizione, la necessaria responsabilità e la
possibile grazia.