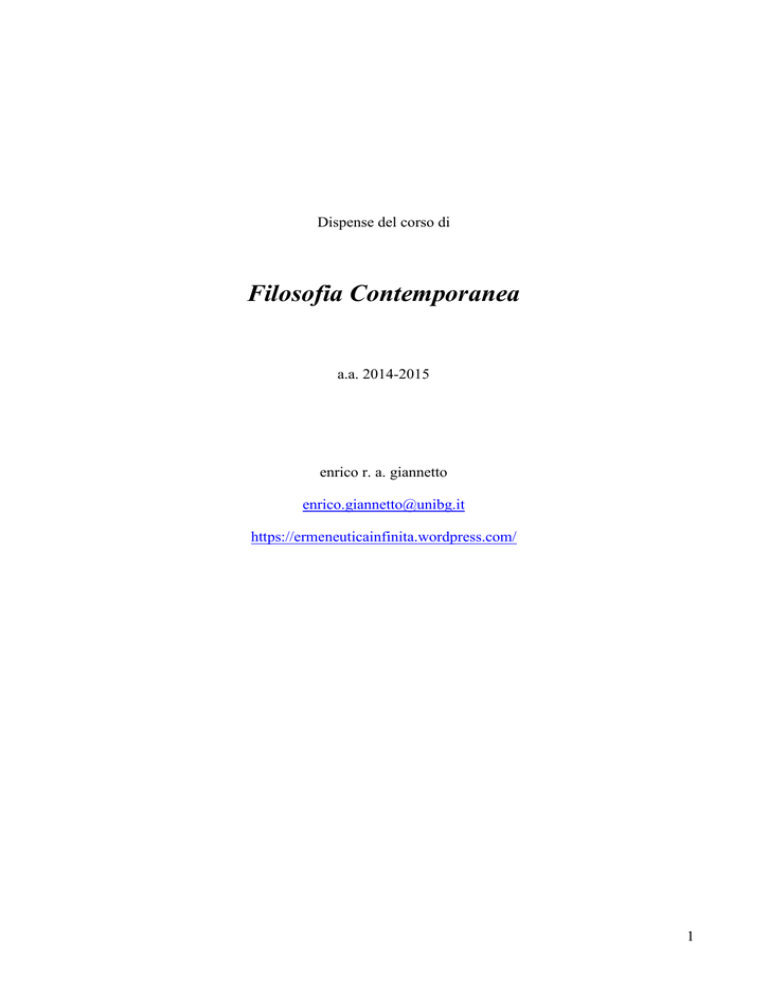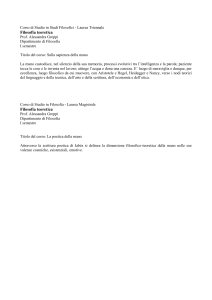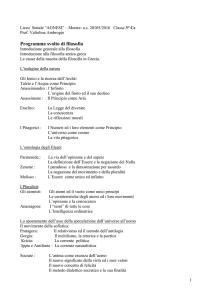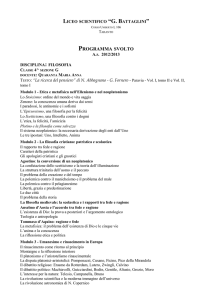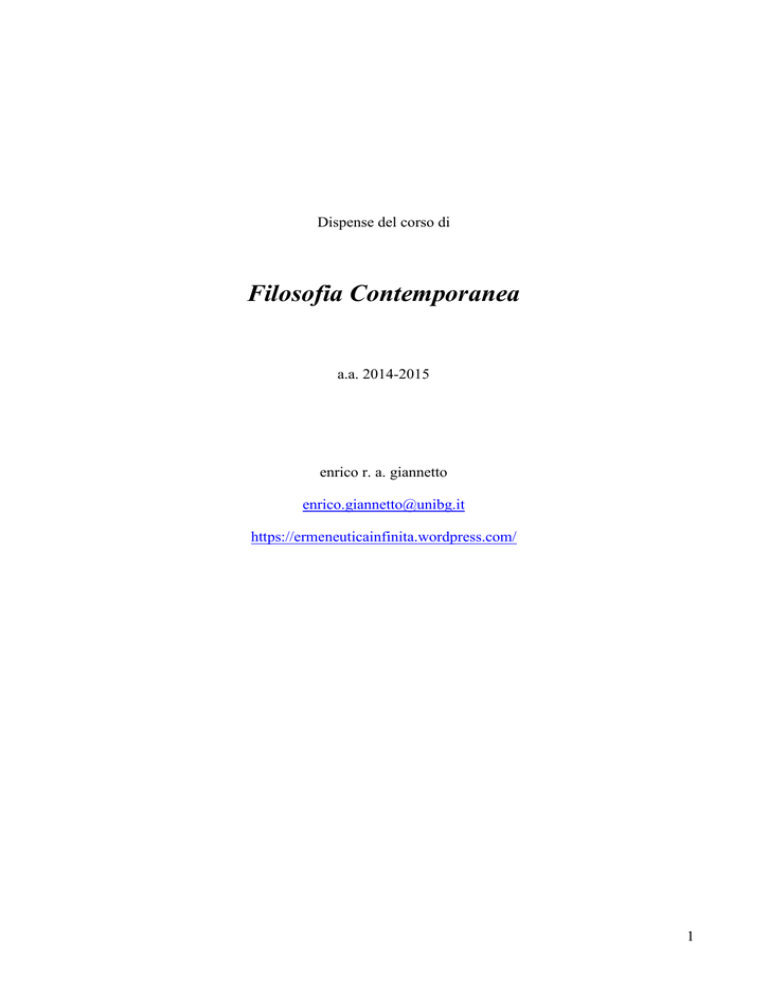
Dispense del corso di
Filosofia Contemporanea
a.a. 2014-2015
enrico r. a. giannetto
[email protected]
https://ermeneuticainfinita.wordpress.com/
1
1. Introduzione storica
Delineare un quadro della “filosofia contemporanea”, sia che si faccia riferimento in senso stretto
all’attualità, sia che si indichi, più tradizionalmente, il periodo che va da fine Ottocento a oggi, è
praticamente impossibile. Il ricorso a manuali, più o meno completi,1 non è sufficiente: si tratta di
ricostruzioni artificiali che selezionano, da prospettive parziali, di correnti maggioritarie o di moda,
se non del tutto ideologiche o addirittura determinate da teologie o filosofie della storia, autori, temi
o tendenze più o meno presunte. La molteplicità e la complessità delle varie prospettive filosofiche
è del tutto irriducibile.
Ma c’è di più: la storiografia filosofica, al contrario della storiografia scientifica, è rimasta
essenzialmente, a tutt’oggi, una “storiografia interna”, chiusa sugli sviluppi puramente interni alle
discipline filosofiche, astratta dalla più vasta storia umana, dalla storia delle culture, dalla storia
delle altre discipline, delle scienze naturali e umane, pure ad essa connesse. Questo atteggiamento
storiografico è la conseguenza di un atteggiamento filosofico teoretico che considera la storia del
tutto inessenziale alla presunta eternità dei problemi filosofici che si potrebbero trattare ogni volta
secondo una prospettiva puramente teoretica, in un circolo auto-fondativo. Nel tentativo di ritagliare
alla filosofia teoretica un ambito chiuso, un universo del discorso puramente filosofico, astorico,
trascendentale nel senso di al di là dell’esperienza e in particolare dell’esperienza storica.
Si tratta di quella prospettiva, ben nota al dibattito epistemologico sulla scienza moderna, per cui si
possa prescindere del tutto dal cosiddetto contesto della scoperta sperimentale o della genesi dei
concetti scientifici per limitarsi al contesto assiomatico della legittimazione puramente teoretica. La
storiografia scientifica ha dovuto riconoscere che la scienza è la sua stessa storia, il suo farsi storico,
la storia delle sue pratiche; che comprendere la scienza si può solo, con Giambattista Vico (16681744), comprendendone la genesi e il farsi. La storiografia filosofica hegeliana, prima ad avere
1
Si vedano, per esempio: G. FORNERO & S. TASSINARI (a cura di), Le filosofie del Novecento, I-II, Bruno Mondadori,
Milano 2002, pp. 1-1588; G. CAMBIANO & M. MORI, Storia della filosofia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2014,
pp. 1-530.
2
inteso la filosofia come la sua storia, l’ha concepita deterministicamente, determinata ferreamente
da una super-logica dialettica e riducendo altresì la stessa storia a mera storia della filosofia, con
una trasformazione di una più antica teologia della storia in una filosofia deterministica della storia.
D’altra parte, il capovolgimento marxista della dialettica hegeliana ha ridotto la storia della filosofia
a storia economico-materiale dell’umanità inquadrandola in una altrettanto deterministica filosofia o
scienza economica della storia.
Così, si può comprendere effettivamente la connotazione “contemporanea” della filosofia solo
attraverso una comprensione radicalmente storica della filosofia. Gli sviluppi contemporanei
potranno essere compresi solo attraverso una prospettiva storica che li leghi in qualche modo a
quelli moderni e a partire dalla filosofia medioevale e antica. Comprendere l’esistenza e la
consistenza di tutte le prospettive contemporanee è possibile solo attraverso l’indagine delle loro
genesi storiche nel complesso dell’intera storia umana, cosa praticamente quasi impossibile.
Tuttavia, una chiave di lettura molto generale permette di delineare alcune tendenze: si tratta di
comprendere la storia della filosofia occidentale soprattutto in termini dell’incontro-scontro fra
intellettualismo greco e volontarismo cristiano, fra filosofia teoretica greca e pratica etica e di fede
cristiana. Si tratta di due prospettive, in realtà, opposte: la filosofia teoretica greca è legata all’ideale
di una vita contemplativa, intellettualmente distaccata e volta alla realizzazione di una felicità
individuale; la pratica etica e di fede cristiana è invece correlata all’ideale di una vita activa, volta
all’amore e alla felicità altrui. Nella filosofia greca, i problemi etici sono trattati all’interno della
filosofia pratica, che è sempre (a parte qualche eccezione) gerarchicamente subordinata e
secondaria rispetto alla filosofia teoretica.
Ancora oggi è prevalente questo atteggiamento per cui nei manuali di storia della filosofia spazio
maggiore è dedicato alla filosofia teoretica. Le importanti esperienze storiche del Cristianesimo, nei
manuali non sono quasi mai trattate direttamente, ma solo indirettamente nei loro riflessi all’interno
degli autori cristiani della tarda antichità e del medioevo. Per trovare discusse, in maniera rilevante,
le relazioni storiche fra filosofia e fede cristiana, è necessario rivolgere la propria attenzione a testi
3
che sembrano occuparsi di particolari branche della filosofia, ovvero di filosofia della storia, o a
testi storici che riguardano il problema della modernità e della secolarizzazione2. Non solo: a questo
riguardo, è fondamentale, indipendentemente dalle soluzioni proposte, un testo che unico affronta il
problema in tutta la vastità della sua portata, un testo dello storico delle idee Hans Blumenberg
(1920-1996), La legittimità dell’età moderna.3
Blumenberg vuole contestare la prospettiva di Karl Lӧwith (1897-1973) e molti altri, secondo la
quale il pensiero moderno e la modernità possano comprendersi solo in termini di un processo di
“secolarizzazione” del pensiero e delle forme di vita cristiani, un processo di trasformazione cioè
che mantiene la modernità dipendente comunque dal Cristianesimo, pur se esplicitamente se ne
vorrebbe staccare.
La tesi sostenuta da Blumenberg ribalta quella proposta da Eric Voegelin (1901-1985) sull’età
moderna come “nuova gnosi”: si tratterebbe invece di considerare l’età moderna come secondo
superamento della gnosi, laddove il primo superamento della gnosi all’inizio del medioevo non
sarebbe riuscito4.
Blumenberg generalizza la tesi di Adolf Harnack (1851-1930)5 per cui il cattolicesimo si è costituito
dogmaticamente contro la gnosi di Marcione (85-160), alla tesi che anche la teologia medioevale è
una risposta a Marcione, a partire dalla polemica di Agostino (354-430) contro i manichei fino alla
Scolastica, per superare la concezione negativa del mondo dominato dal male, che deve essere
2
Si vedano, per esempio: K. LӦWITH, Meaning in History, The University of Chicago Press, Chicago 1949;
Weltgeschichte und Heilsgeschehen, Kohlhammer, Stuttgart 1953; tr. it. dal ted. di F. Tedeschi Negri, pref. di Pietro
Rossi, Significato e fine della storia. I presupposti teologici della filosofia della storia, Edizioni di Comunità, Milano
1963 e poi il Saggiatore, Milano 1989, 1991; K. LӦWITH, Skepsis und Glaube (1951), Wissen und Glaube (1954),
Schӧpfung und Existenz (1955), Kierkegaards in den Glauben (1956), Sinn der Geschichte (1956), Das Vorhӓngnis des
Fortschritts (1963), tr. it. in, Storia e fede, Laterza, Roma-Bari 1985; C. TAYLOR, A Secular Age, Harvard University
Press, Cambridge (Mass.) 2007; tr. it. a cura di P. Costa, L’età secolare, Feltrinelli, Milano 2009.
3
H. BLUMENBERG, Die Legitimität der Neuzeit, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1966, 1974 2, tr. it. di C. Marelli,
La legittimità dell’età moderna, Marietti, Genova 1992.
4
H. BLUMENBERG, La legittimità dell’età moderna, op. cit., p. 132; E. VOEGELIN, in Philosophische Rundschau I
(1953/54), p. 43.
5
A. VON HARNACK, Lehrbuch der Dogmengeschichte, J. C. B. Mohr, Tübingen 1886-1890, 1909, 1914, 1991; tr. it.,
Manuale di storia del dogma, Casa editrice Cultura Moderna, Mendrisio 1912 e poi rist. anast. presso Paideia, Brescia
2012, vol. I; A. VON HARNACK, Marcion: das Evangelium vom fremden Gott. Eine Monographie
zur Geschichte der Grundlegung der katholischen Kirche, Hinrichs, Leipzig 1921, 1924, Wiss. Buchges. Darmstadt
1985; tr. it a cura di F. Dal Bo rivista da G. Dal Dosso, Marcione. Il Vangelo del Dio straniero. Una monografia sulla
storia dei fondamenti della Chiesa cattolica, Marietti 1820, Genova 2007.
4
distrutto escatologicamente per la salvezza, nel recuperare positività al mondo come creazione che
poteva assicurare l’esistenza umana, sovrapponendogli l’idea di cosmo greco. Con la dissoluzione
del mondo aristotelico da parte della rivoluzione francescana-nominalista (e si potrebbe aggiungere
con la successiva nuova negativizzazione luterana del mondo, in qualche modo radicale quanto
quella “gnostica”), sorgerebbe, secondo Blumenberg, la nuova “soluzione” moderna che non è più
teologica (si arriva alla negazione di Dio), ma porta all’autoaffermazione dell’essere umano che si
impegna nelle opere mondane.
La questione, invero, è ancora più complessa di quanto delineata da Blumenberg: la gnosi cristiana
del II secolo aveva già assorbito degli elementi greci nel trasformare la dualità cristiana fra mondo
presente dominato dal male e mondo futuro come Regno di Dio nella dualità platonico-aristotelica
fra mondo terrestre e mondo celeste, e questa gnosi marcionita si era pure innestata, attraverso il
Vangelo di Giovanni,6 nella cattolicità. D’altra parte, si deve tener conto che la diffusione del
Cristianesimo in occidente si risolse più in un’ellenizzazione del Cristianesimo che non in una
effettiva cristianizzazione dell’occidente, e il venir meno della fede attiva nella prossima Parousia
del Cristo e nel prossimo instaurarsi del nuovo mondo del Regno di Dio7 spostò l’enfasi dalla
trasformazione etica attiva del mondo alla conoscenza contemplativa e intellettuale.
Già in un testo del Nuovo Testamento accettato dalla Chiesa, la Parola (in lingua aramaica, Meltha
o Memra) del Prologo del Vangelo di Giovanni, nella sua traduzione in greco era stata letteralmente
ellenizzata in un Logos che ne trasformava il senso. Il senso di parola vivente del dialogo, che
costituisce Dio stesso in una perfezione che non può essere mai egoistica e solitaria
autocontemplazione divina ma che è eterna e originaria apertura all’alterità, e di parola vivente della
continua relazione di dialogo fra Dio e il mondo e l’umanità che si compiva in Gesù, viene
6
R. EISLER, Das Rätsel des vierten Evangeliums, in Eranos Jahrbuch 1935, a cura di O. Fröbe-Kapteyn, Rhein, Zürich
1936, pp. 323-511; R. EISLER, The Enigma of the Fourth Gospel, its author and its writer, Methuen, London 1938.
7
A. SCHWEITZER, Von Reimarus zu Wrede: Eine Geschichte der Leben-Jesu-Forschung , J. C. B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen, 1906, 1913, 1950; tr. it. a cura di F. COPPELLOTTI, Storia della ricerca sulla vita di Gesù, Paideia, Brescia
1986; A. SCHWEITZER, Die Mystik des Apostels Paulus, Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1930; tr. it. di A. Rizzi, La
mistica dell’apostolo Paolo, Ariele, Milano 2011; M. WERNER, Die Entstehung des christlichen Dogmas Problemgeschichtlich Dargestellt, Paul Haupt, Bern & Katzmann, Tübingen 1941, 1954; edizione ridotta di quest’opera
è stata pubblicata con lo stesso titolo presso Kohlhammer, Stuttgart 1959; tr. it., dall’edizione ridotta, di F. E. SCIUTO e
A. PUSKÀS VON DITRÒ, Le origini del dogma cristiano, voll. I-II, Rubbettino, Soveria Mannelli 1997.
5
trasformato in un significato intellettualizzato quale Logos-Intelletto come parte di Dio che
presiedeva ad una creazione razionale del mondo e che quindi richiamava subito il logos della
filosofia greca e in particolare della cosmologia stoica, e permetteva l’accettazione cristiana di un
cosmo greco razionalmente costituito e conoscibile.
Da un punto di vista di psicoanalisi della storia, si potrebbe guardare all’irrompere del
Cristianesimo in occidente, e non solo della gnosi, come un evento che provocava il riemergere alla
coscienza collettiva il problema del male radicale del mondo e il correlato problema del posto
dell’essere umano nel mondo8 e che faceva saltare le precedenti rimozioni veicolate dalle
razionalizzazioni della filosofia teoretica greca che aveva già costituito un “superamento” del
pensiero mitologico e tragico greco. Il Cristianesimo originario opponeva al problema del male una
pratica etica attiva trasformatrice del mondo, e la gnosi, in positivo e in negativo, contribuì ad una
nuova razionalizzazione filosofico-teoretica basata su una metafisica teologica a cui si tentò di
ridurre la fede cristiana.
Si trattò di una duplice esigenza, una interna al Cristianesimo che si allontanava dalla sua fede
originaria e una interna al pensiero filosofico occidentale. Dall’altra parte, infatti, la conclusione
della filosofia teoretica greca, da Carneade a Sesto Empirico, aveva portato ad esiti scettici ed
esigeva un nuovo fondamento, che poté trovare nella metafisica teologica in cui si trasformò la fede
cristiana nel pensiero tardo antico e nel medioevo.
La dissoluzione di questa nuova razionalizzazione filosofico-teoretica in cui il Cristianesimo
cattolico si era unito alla filosofia greca fu determinata dalla rivoluzione operata da Francesco
d’Assisi (1182-1226), che riproponeva un ritorno alle origini del Cristianesimo come pratica etica di
vita, con l’abolizione di tutte le gerarchie nella creazione, di cui il “cantico delle creature” è traccia
sublime.
8
N. O. BROWN, Life against Death. The Psychoanalytic Meaning of History, Wesleyan University, Middleton CT 1959;
tr. it. di S. BESANA GIACOMONI, La vita contro la morte. Il significato psicoanalitico della storia, Adelphi, Milano
1964, 1978.
6
La prospettiva francescana in filosofia e in teologia ebbe il suo culmine nel pensiero di John Duns
Scotus (1265-1308) e William of Ockham (1287-1347): la valorizzazione della materia, come parte
della creazione, si opponeva alla considerazione platonica di essa come principio autonomo da cui
derivava ogni imperfezione e male, e implicava anche la distruzione della gerarchia non solo fra
materia e forma, ma anche fra mondo terrestre e mondo celeste. Richiamandosi all’originaria
caratterizzazione cristiana di Dio in termini di Amore come libera volontà, la prospettiva
francescana si oppose alla concezione della divinità greca, come quella aristotelica, chiusa nella sua
perfezione intellettuale di una autocontemplazione del pensiero e distrusse la connessione
medioevale del Cristianesimo con la teologia, la filosofia, la cosmologia e la fisica greche. La libera
volontà di Dio come Amore risultava inconoscibile, impredicibile, e non poteva più garantire non
solo la Grazia della salvezza ma neanche la razionale comprensibilità della Creazione o
dell’Incarnazione in termini di finalità umane: le argomentazioni de potentia Dei absoluta, che cioè
non si limitavano alla considerazione di ciò che Dio di fatto aveva compiuto (potentia Dei
ordinata), portavano alla conclusione che Dio, nella Sua libera volontà, avrebbe potuto non creare,
avrebbe potuto creare diversamente, avrebbe potuto non creare l’essere umano o non incarnarsi in
un essere umano. Questa conclusione riapriva l’abisso aperto dalla gnosi sul mondo, destituendo di
significato umano la creazione, svincolabile, come l’incarnazione, dalla questione della salvezza
umana dal male: distruggeva le basi teologiche di qualsiasi antropocentrismo, e invero la possibilità
di una qualsiasi fondazione teologica dell’antropocentrismo aprendo la via a soluzioni non
teologiche nella modernità all’auto-affermazione dell’umanità. Il mondo naturale non poteva essere
più considerato oggettivisticamente, secondo la prospettiva intellettualistica greca, ma, derivando
dall’azione e dalla volontà della soggettività divina, presentava connotazioni soggettive
impredicibili. E ciò distruggeva anche la possibilità di una filosofia teoretica della Natura che non
poteva che basarsi su una metafisica teologica.
7
Questa divergenza non ricomponibile fra ragione e fede, e quindi fra filosofia teoretica e fede, trovò
il suo culmine nella prospettiva di Martin Luther (1483-1546), su cui pure poco si ferma l’analisi di
Blumenberg, più strettamente legata a una storia delle idee.
Luther rompe con la tradizione filosofica greca, contestandone anche l’obiettivo, la conoscenza
intellettuale del mondo, e contrapponendole la cura attiva etica, sensibile a ogni sofferenza degli
esseri viventi, per trasformare il mondo presente dominato dal male: la concezione del mondo
completamente corrotto dal peccato e sottomesso a satana aveva la stessa radicalità gnostica e
riapriva effettivamente quell’abisso contro cui i francescani solo non potevano fornire più certezze
ma che certamente non avevano aperto. La corruzione insuperabile della Natura e in particolare
della natura umana e della sua ragione, sottomessa a una volontà schiava del peccato, non
permettevano alcuna via d’uscita naturale o razionale all’essere umano, incapace di operare il bene
se non attraverso la Grazia. Il tema della volontà altruistica cristiana si legò così solo alla Grazia,
mentre alla Natura si legò solo una volontà egoistica che diventò poi la cifra di una nuova
metafisica atea.
La fede non può coincidere più con l’adesione a certe proposizioni dogmatiche, comprensibili
razionalmente in termini di una teologia e di una metafisica basate sull’aristotelismo, come in San
Tommaso, la cui “summa teologica” brucerà in un rogo pubblico nel 1520. Le opere (rituali) non
salvano, non salva la Chiesa, solo la Grazia salva; ma solo nelle opere, nell’operare individuale nel
mondo in un’attività d’amore si manifesta la fede: è esclusa qualsiasi chiusura monacale in una vita
meramente contemplativa, che, come la concezione della futura vita paradisiaca come una mera
contemplazione di Dio, si era innestata nel Cristianesimo attraverso influenze greche. La
consapevolezza cristiana, il pensiero della fede cristiana si acquisisce e si verifica, non
contemplativamente o teoreticamente, ma solo nella prassi etica.
La transitoria congiunzione medioevale di filosofia greca e fede cristiana si era dissolta al
riemergere dei tratti rivoluzionari, anti-teoretici, della prospettiva cristiana. La modernità e il
pensiero moderno sorgono così in un’ambivalenza costitutiva: da una parte, l’età moderna è l’epoca
8
in cui si manifesta la cristianità non più ingabbiata nelle reti dell’intellettualismo filosofico e
teologico greco; dall’altra parte, la frammentazione delle chiese e delle confessioni cristiane, la
critica dell’autorità e della funzione mediatrice della Chiesa cattolica, la non traducibilità della fede
cristiana in una filosofia teoretica metafisico-teologica ma in un’attività trasformatrice umana in cui
unicamente la Grazia divina si rende immanente alla coscienza individuale, portarono alla
possibilità di una pluralità di costruzioni filosofico-teoretiche individuali indipendenti dalla Chiesa
e anche atee e di un’auto-rappresentazione filosofica dell’umanità narcisistica e antropocentrica non
più legittimata teologicamente, ma sull’auto-affermazione umana nella dimensione pratico-tecnicopolitica di un operare-lavorare intra-mondano che si stacca dalla fede.
La filosofia della Natura, avendo perso il suo fondamento teoretico nella metafisica teologica, trovò
un nuovo fondamento in una prassi sperimentale in cui la tecnica perdeva la sua connotazione
puramente strumentale per assumerne una conoscitiva: nella prassi sperimentale, il pensiero si
concretizzava, si faceva azione potendosi così misurare effettivamente con il mondo. La rivoluzione
copernicana, che pure era stata possibile assumendo una prospettiva soggettiva naturale ma non
umana, e non terrestre ma solare, si poté compiere effettivamente solo quando, con le osservazioni
telescopiche di Thomas Harriot (1560-1621), Galileo Galilei (1564-1642) e altri, anche
l’astronomia, in cui il cielo sembrava essere oggetto assoluto solo di una contemplazione,
paradigma dell’attività puramente contemplativa della filosofia teoretica greca antica come pure di
una perfezione etica e di una felicità egoistica, si trasformò in un sapere operativo-pratico, che
porta quasi a poter toccare anche il cielo, indipendente da una metafisica teologica, e non più
meramente contemplativo-teoretico.
Si rese necessaria una nuova fisica, alternativa a quella aristotelica, su cui si potesse costituire la
nuova cosmologia copernicana, come anche una nuova conciliazione fra ragione e fede dopo
Luther; e Giordano Bruno (1548-1600) propose una nuova versione dell’atomismo epicureo: questa
nuova fisica e questa nuova cosmologia non solo erano compatibili con le argomentazioni della
infinita potenza assoluta di Dio, ma realizzavano in positivo gli esiti negativi della decostruzione
9
francescana, relativizzando la posizione dell’essere umano nel mondo, ma relativizzando lo stesso
mondo in quanto solo uno fra infiniti mondi. La cosmologia neo-epicurea era l’unica cosmologia
positiva che disimpegnasse Dio dalla necessità di aver creato un mondo ordinato secondo un senso
e una finalità umani, che era solo un sottoprodotto di un’opera molto più vasta, infinita. Questa
caratteristica fornì le basi di una nuova risposta razionale alla gnosi, a Luther, nella sua
relativizzazione del male; e si poté poi facilmente adattare a una più tarda visione atea del mondo,
come esito casuale di un ordine contrastante con infiniti altri mondi disordinati.
Più in generale, la modernità e il pensiero moderno si svilupparono in forme molteplici e diverse a
seconda dei particolari contesti e dell’effettiva ricezione della Riforma.
Tutti i dubbi storici posti dagli sconvolgimenti, che, dal francescanesimo all’umanesimo, al
Rinascimento e alla Riforma, dalla rivoluzione astronomica copernicana alla nuova fisica, si
manifestarono storicamente non solo sul piano della vita ma anche sul piano della fede e della
filosofia, furono sussunti dal cattolico René Descartes (1596-1650) in una dimensione puramente
teoretica attingibile da una coscienza individuale astorica di fronte a un dubbio che è presentato
come costitutivo metodico del pensiero stesso, nel tentativo di un’auto-fondazione astorica e
autonoma della filosofia teoretica. Nel medioevo, la filosofia era dipendente dalla fede ed ancella
della teologia: da almeno Giordano Bruno in poi, la filosofia reclamava una sua autonomia. Con
Cartesio, dopo la luterana soggettivizzazione individuale della fede, si ha una soggettivizzazione
individuale della metafisica filosofica che non può più fondarsi sull’oggettivizzazione comunitariaecclesiastica della fede: la certezza stessa di Dio si fonda sulla certezza interna dell’io. Se non si
può assumere una fede condivisa come fondamento della filosofia, anche perché non è possibile
accedere a una teoria che rispecchi la visione che Dio ha del mondo, non è possibile neanche una
fondazione oggettiva della conoscenza filosofica teoretica a partire dalla certezza del mondo
(Cartesio ribalta la prova cosmologica: è dall’esistenza di Dio che solo si può provare l’esistenza
del mondo): si deve ammettere la radicale soggettività umana della conoscenza. Cartesio recepì solo
in parte l’esito della storia che si è tratteggiata: la fede non può tramutarsi in un fondamento
10
teologico
della
filosofia;
ovvero,
la
filosofia,
come
la
fede,
è
dipendente
dalla soggettività individuale che conosce, ma la metafisica è comunque possibile, in quanto
l’esistenza di Dio è a sua volta un’evidenza interna al pensiero. Pure il potenziale dirompente del
riconoscimento dell’assolutezza della volontà divina viene neutralizzato da Cartesio, in termini
dell’argomentazione di un Dio non-ingannevole e di una legittimazione di un sapere umano che
proceda per ipotesi nella spiegazione dell’ordine del mondo e in funzione di obiettivi pratici.9
Ma diverse soluzioni erano possibili: Blaise Pascal (1623-1662), giansenista più vicino
all’opposizione luterana fra ragione e fede, propose uno scetticismo filosofico, superabile e superato
solo da un pensiero basato sulla fede non tradotta in metafisica e che riusciva a percepire ancora per
l’essere umano l’abisso irrazionale dell’universo infinito. L’illuminismo francese si muoverà poi fra
deismo e ateismo.
Gottfried Willhem Leibnitz (1646-1716) fu il primo a proporre una concezione veramente moderna
della Natura. La concezione della Natura come un essere vivente e animato del pensiero arcaico e
antico era stata pure subordinata dalla filosofia teoretica alla considerazione della Natura come
espressione di una necessità logica oggettiva intellettualmente conoscibile; la filosofia francescana
aveva fatto saltare questa certezza e aveva caratterizzato la Natura come impredicibile espressione
della libera volontà di Dio. Cartesio aveva ripristinato la conoscibilità razionale della Natura e
l’antropocentrismo anche all’interno di un universo infinito, equiparando gli esseri viventi a delle
macchine e riducendo così tutta la Natura a macchina, a res extensa mero oggetto della
rappresentazione umana, espressione della solo umana (oltre che divina) res cogitans. Leibnitz
concepì Dio in termini di una volontà amorevole e non arbitraria come per Cartesio: secondo
Luther, la libertà non è arbitrio, tantomeno per Dio; l’arbitrio è servo del peccato e può essere
considerato solo per l’essere umano. La non arbitrarietà era conciliabile per Leibnitz con una
razionalità divina, anche se mai completamente attingibile dall’essere umano. Seppure la potenza di
Dio è infinita e si è espressa nella creazione di un mondo infinito, tale infinito non si identifica con
9
H. BLUMENBERG, La legittimità dell’età moderna, op. cit., pp. 188-224.
11
l’infinità dei mondi possibili dell’universo dell’atomismo epicureo: la razionalità divina della
creazione si identifica nella scelta libera del migliore dei mondi possibili, e cioè in una scelta
d’amore; la ragione divina non è altro rispetto all’amore divino nella sua libertà, mai necessitata. La
relativizzazione del male implicata in un mondo infinito e alla base della sua teodicea non coincide
mai quindi con una spiegazione casualistica dell’ordine del mondo come nell’epicureismo degli
infiniti possibili mondi e in Cartesio (che lo fa derivare naturalmente e casualmente da un caos
originario), ma è la conseguenza della ridefinizione della razionalità divina come libera volontà
d’amore e non come necessarietà logica in sé conclusa e perfetta: la razionalità divina infinita,
seppure rappresentabile simbolicamente con un calcolo integrale ma infinito, non sarà mai
direttamente attingibile dalla finita ragione umana. Dalla relatività generale del moto, che
ritematizza a partire da Bruno, Galileo e Cartesio per comprendere la rivoluzione copernicana,
Leibnitz, non ne deduce una nuova certezza cosmologica del sistema copernicano-kepleriano del
mondo, che seppure rispondente al vero è conoscibile solo da Dio e mai attingibile da una ragione
finita, umana o angelica: se il mondo è infinito, non c’è mai un punto di vista esterno da cui poter
dirimere la questione (Leibnitz non considera un universo infinito fatto da un’infinità di mondi
finiti, per cui si potrebbe uscire fuori dal nostro mondo finito, ma considera il nostro mondo
infinito). La sua monadologia, a partire dall’influenza di Bruno, va considerata come strettamente
radicata nella tematizzazione della relatività generale del moto, come hanno ben compreso Edward
Arthur Milne (almeno implicitamente nella sua cosmologia) e Herbert Wildon Carr10. La relatività
del moto e la problematica copernicana fanno comprendere come la struttura del mondo non possa
mai essere colta dall’insieme delle prospettive umane che sono tutte legate ad una prospettiva
terrestre: ne consegue che non si possa mai ridurre il mondo a una mia rappresentazione soggettiva
individuale, o a una rappresentazione soggettiva umana, in quanto neppure può essere oggetto di
10
H. WILDON CARR, The general principle of relativity in its philosophical and historical aspect, MacMillan and Co.
Limited, London 1920; H. WILDON CARR, A Theory of monads: outlines of the philosophy of the principle of relativity,
MacMillan and Co. Limited, London 1922; H. WILDON CARR, Leibniz, Dover Publications, New York 1929, 1960; G.
W. LEIBNIZ, The Monadology of Leibniz, with. an intr., comm. by H. WILDON CARR, Favil, London 1930; J. MERLEAUPONTY, Cosmologie du XX siècle, Gallimard, Paris 1965; tr. it. di S. CHIAPPORI, Cosmologia del secolo XX, il
Saggiatore, Milano 1974, pp. 126-198.
12
una rappresentazione da una prospettiva umana. Implicito nella relatività è che ogni parte del
mondo è soggetto di una prospettiva e di una corrispondente rappresentazione del mondo, e quindi
il mondo infinito è costituito da una pluralità infinita di soggetti naturali di una prospettiva e di una
rappresentazione, ciascuna diversa dalle altre in virtù della sua attività interna (forza) che ne
caratterizza il moto e il mutamento. Si tratta di soggettività come quella umana, caratterizzata da
una attività interna che soggiace alle volizioni, alle percezioni e alle intellezioni, da cui i movimenti,
le prospettive e le rappresentazioni differiscono solo in grado. Nessuna di queste soggettività
monadiche finite può vantare una prospettiva privilegiata e una rappresentazione completa del
mondo né è possibile un’auto-rappresentazione a partire dalla propria prospettiva: la Natura quindi
non si può auto-rappresentare, auto-spiegare o auto-comprendere perché la sua comprensione
implica la chiusura in una totalità finita di un’infinità di prospettive e di rappresentazioni. La
comprensione della Natura è attuabile solo dalla prospettiva infinita di Dio che può comporre
insieme l’infinità delle prospettive e delle rappresentazioni. Così, la soggettività della conoscenza,
emersa dal crollo dell’oggettivismo naturalistico-razionalistico greco, non porta per Leibnitz a un
soggettivismo umanistico antropocentrico né a un relativismo soggettivistico umanistico, ma al
riconoscimento della soggettività irriducibile della Natura in tutte le sue parti, che aprono una
pluralità infinita, intrinsecamente correlata, di prospettive sul mondo che assumono così una
valenza strutturale-ontologica e non meramente gnoseologica. La conoscenza deriva solo dalla
considerazione e dalla composizione di questa infinità di prospettive, per cui per l’essere umano
non potrà mai essere assoluta e completa, ma relativa, comparativa e incompleta e può crescere
attraverso il confronto-dialogo fra sempre più soggettività.
La critica della ragione teoretica operata da Immanuel Kant (1724-1804), che si muoveva nel clima
protestante tedesco, è funzionale a lasciare uno spazio libero alla fede, non ricopribile dalla ragione
filosofica, ma risolta all’interno della ragione pratica. La critica della ragione teoretica è la critica
della ragione teoretica che vuole andare oltre l’esperienza, e in particolare oltre l’esperienza della
fede (secondo Luther, l’essere umano, corrotto dal peccato originale che rende schiava la volontà e
13
l’azione, non può da solo, con la sola ragione arrivare a Dio, senza l’esperienza della fede e quindi
senza la Grazia, né attraverso questa si potrà edificare una conoscenza teoretica) tramutandola in
metafisica teologica razionale. La priorità della fede sulla ragione si tramuterà così in Kant nella
priorità della ragione pratica sulla ragione teoretica nella sua possibilità di accesso alla realtà, e
quindi nella priorità della filosofia pratica sulla filosofia teoretica, determinando una rivoluzione
interna alla gerarchia delle discipline filosofiche.
La soggettivizzazione della conoscenza in Kant abbandona le pretese del pensiero puro cartesiano e
post-cartesiano, e lega sempre il pensiero all’esperienza tranne che per le forme apriori e per le
categorie per cui ricade in una metafisica del soggetto oggettivizzandolo come trascendentale che
elimina le differenze fra i soggetti effettivi per superare un relativismo soggettivo. Solo
nell’impostazione del problema della legge morale, Kant si confronta, almeno formalmente, con
una pluralità effettiva dei soggetti umani e con una loro inoggettivabilità in termini di una ragione
teoretica. La moralità implicante la libertà non potrà mai essere condizionata dalla naturalità perché
questa non è mai libera (come in Luther, ma in un senso parzialmente diverso).
Con Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), invece, la contraddizione fra fede e ragione, fra
religione e filosofia fu risolta nella dialettica storica in una presunta sintesi superiore del pensiero
che riassorbiva in sé ogni prassi e il mondo stesso nella filosofia teoretica, dipanata in una storia
dello spirito quale secolarizzazione della rivelazione storica cristiana di Dio. Quello di Hegel è un
idealismo platonico, perché le idee sono reali e la soggettività dello spirito assoluto è solo l’esito di
un processo evolutivo anche naturalistico. Secondo Hegel, la questione del conoscere non può
essere posta nei termini di ciò che conosce un soggetto individuale pur nei suoi aspetti universali
che permettono la definizione di un “soggetto trascendentale” astratto, atemporale e isolato11. Per il
fatto stesso che il soggetto umano è parte di un processo storico più ampio, universale, il conoscere
è un processo storico in cui intervengono storicamente più soggetti, un processo in cui i limiti
11
G. W. F. HEGEL, System der Wissenschaft. Erster Teil: die Phänomenologie des Geistes, J. A Goebbardt, Bamberg
und Würzburg 1807; tr. it. con testo tedesco a fronte e cura di V. Cicero, Fenomenologia dello spir
ito, Rusconi, Milano 1997.
14
individuali del conoscere sono transitori e sono stati assolutizzati da Kant astrattamente: il sapere è
possibile solo perché è un processo potenzialmente infinito, in una immanentizzazione storica del
divino. La logica della storia e della conoscenza non può essere quella della coerenza di un soggetto
individuale, ma è una logica della contraddizione, del contraddittorio proprio di un dialogo in cui è
coinvolta una molteplicità di soggetti, è una “dialettica” della storia e di un divenire para-eracliteo
del mondo. Si tratta di una “dialettica trascendentale” della storia, con i suoi trascendentali
oggettivi, che si contrappone all’analitica trascendentale kantiana dell’individuo. La verità si
costituisce quindi su un piano ontologico, sul piano dell’essere-divenire nel quale i soggetti umani
sono immersi e del quale partecipano. La filosofia è la storia della filosofia, a cui si riduce la stessa
storia del mondo, e ha anch’essa una dimensione ontologica, non nel senso disciplinare. Come in
Eraclito, c’è un logos della physis,12 uno spirito del mondo del quale gli esseri umani eventualmente
e sempre parzialmente partecipano. Nella sua immanentizzazione del divino, Hegel ricade però in
tutti i problemi di una teologia positiva umanizzata, di una fondazione della filosofia come sapere
assoluto e della storia come il suo dispiegamento positivo e come tale auto-legittimantesi sia da un
punto di vista di un certo progresso sintetico dialettico sia da un punto di vista etico.
L'idealismo di Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) è invece un idealismo soggettivistico in cui tutto
è ricondotto a un soggetto pensante come io-trascendentale post-kantiano che pone completamente
il suo oggetto e che solo attraverso la fede della volontà-noumeno incontra gli altri soggettinoumeni ma come un'alterità ridotta all'io-trascendentale, correggendo la ragione pratica kantiana in
un idealismo etico: l'oggetto del pensiero è fenomeno per un soggetto che è noumeno, e la fede è
secolarizzata nell'etica.
12
E. GIANNETTO, Herakleitos, un fisico delle origini, in Eraclito: la luce dell’oscuro, a cura di G. Fornari, Olschki,
Firenze 2012, pp. 127-142.
15
2. Karl Marx e la filosofia della prassi rivoluzionaria
Ludwig Feuerbach (1804-1872) aveva già cercato di delineare una nuova antropologia
materialistica, criticando la filosofia hegeliana come teologia secolarizzata e ricomprendendo tutta
una serie di considerazioni teologiche in caratterizzazioni dell’essere umano. Dalla sua prospettiva,
almeno da un certo stadio dell’evoluzione storica delle religioni, Dio non è altro che la proiezione di
una serie di desideri e di aspirazioni dell’essere umano che non sono soddisfatti in un essere ideale
fuori dal tempo e dalla storia: l’essere umano si deve quindi riappropriare di quanto è suo e di
quanto ha estrovertito su Dio; per esempio, il desiderio di un amore eterno, infinito e assoluto è
secondo Feuerbach all’origine della concezione cristiana di Dio come Amore. Si devono invertire
soggetto e predicato e all’affermazione “Dio è Amore”, bisogna sostituire “l’Amore è Dio”. Così,
bisogna capovolgere la dialettica hegeliana, che deduce il finito dall’infinito, e ricomprendere
l’infinito dal finito, come sua aspirazione: come nella teologia, secondo Feuerbach, l’identità umana
si aliena in Dio, così nella filosofia hegeliana, si aliena nello Spirito Assoluto. Così, bisogna
ripartire dal soggetto finito umano, materiale, di cui il pensiero-spirito è solo un predicato: non è la
Natura, come in Hegel, una forma alienata dello spirito, ma lo spirito è una forma alienata della
Natura. Noi sentiamo col nostro corpo che esiste qualcosa al di là di esso, con i nostri sentimenti di
passione, fame, amore, da cui dipende la nostra stessa esistenza da sola insufficiente e manchevole:
così, non è l’io il principio della nostra vita e del pensiero; partendo dal nostro corpo,
comprendiamo che la nostra identità umana non è individuale ma si dà nell’io e nel tu, nella
relazione d’amore con un’alterità che è il tu. L’amore ci fa comprendere l’esistenza del tu e il fatto
che la nostra esistenza non si possa definire se non in questa relazione; e così, per il pensiero il
principio non è l’io: la vera dialettica non è un monologo del pensiero di un individuo con sé stesso
o del pensiero con sé stesso, ma è un dialogo fra l’io e il tu, l’amore io-tu che ci fa uscire da una
dimensione puramente di pensiero e ci fa accedere alla realtà.
Fu Karl Marx (1818-1883), riprendendo e modificando alcuni temi di Feuerbach, e capovolgendo
sotto un altro aspetto la dialettica hegeliana, a ristabilire il primato della prassi sulla teoria e di
16
conseguenza della filosofia pratica sulla filosofia teoretica. Nelle Tesi su Feuerbach del 1845 di
Marx, pubblicate da Friedrich Engels (1820-1895) solo nel 1888 come appendice nel suo testo
Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. Mit Anhang: Karl
Marx über Feuerbach v. J. 1845,
alla undicesima è scritto: “I filosofi hanno [finora] solo
interpretato diversamente il mondo; ma si tratta di trasformarlo”.
Qui, riecheggia l’originario spirito rivoluzionario cristiano, volto all’azione contro il male del
mondo presente, anche se Marx considera la religione come “oppio dei popoli”, cioè come
“ideologia” che legittima il male nel mondo, cioè l’ingiustizia legata alla diseguaglianza economica:
infatti, il cristianesimo storicamente, dopo le origini, si è trasformato in una forza conservatrice,
collusa col potere politico che mantiene l’ingiustizia considerandola come un ordine voluto da Dio,
e consolatoria trasformando il Regno di Dio da realizzare sulla terra in un al di là ultraterreno in cui
sarà Dio a fare giustizia.
Nella prima tesi aveva scritto: “Il difetto principale di ogni materialismo fino ad oggi, compreso
quello di Feuerbach, è che l'oggetto (Gegenstand, ciò che sta di fronte), il reale, il sensibile è
concepito solo sotto la forma dell'obietto (Objekt, ciò che è proiettato fuori dal soggetto) o
dell’intuizione; ma non come attività umana sensibile, come prassi, non soggettivamente. È
accaduto quindi che il lato attivo è stato sviluppato, in modo astratto e in contrasto col materialismo,
dall’idealismo, che naturalmente ignora l'attività reale, sensibile come tale. Feuerbach vuole oggetti
sensibili realmente distinti dagli oggetti del pensiero; ma non concepisce l’attività umana stessa
come attività oggettiva”. E nella seconda aveva chiarito: “La questione se al pensiero umano
appartenga una verità oggettiva non è una questione teoretica, ma pratica. È nella prassi che l'uomo
deve dimostrare la verità, cioè la realtà e il potere, il carattere immanente del suo pensiero. La
17
disputa sulla realtà o non - realtà di un pensiero isolato dalla prassi è una questione puramente
scolastica”.
Si ha qui una critica radicale della filosofia teoretica pura e della sua teoria corrispondentistica della
verità come corrispondenza del pensiero alla realtà: il pensiero non può mai cogliere la realtà
restandole esterno e considerandola astrattamente come una cosa in sé; ma non può neanche
coglierla, come nella prospettiva idealistica, facendo la realtà interna al pensiero considerandola
come un prodotto dell’attività ideale del pensiero. Ci può essere comprensione della realtà se e solo
se il pensiero si immerge nella realtà, divenendole interno nel suo farsi azione materiale,
trasformatrice del mondo. Marx non resta idealista, come pure recentemente si dice con grande
fraintendimento della sua posizione.
Oltre la prospettiva della scienza nuova della storia di Vico basata sull’identità del verum e del
factum (si conosce solo quello che si fa), per Marx ci sono ideologie che costituiscono una
legittimazione di pratiche economiche non etiche, di dominio e sfruttamento dell’essere umano
sull’essere umano, e come tali sono false; la verità sta solo nella prassi etica rivoluzionaria volta alla
liberazione degli esseri soggetti al dominio. Qui, la filosofia della storia umana fa il passo che la
filosofia della Natura aveva effettuato nella cosiddetta “rivoluzione scientifica” trasformandosi in
“scienza moderna”, cioè in una filosofia pratica (sperimentale) della Natura. Non si tratta di
contemplare o conoscere intellettualmente o comprendere teoreticamente la storia, si tratta invece di
farla. Dopo che l’intellettualismo greco era stato espulso dalla filosofia della Natura, ora lo era
anche dalla filosofia della storia, sostituito dal volontarismo attivistico cristiano (di volontà
individuali organizzate in azioni politiche sistematiche), privato della sua medioevale
teologizzazione greca. Il problema della prospettiva marxiana fu che il fine della liberazione
giustificò il mezzo della violenza, facendo perdere la connotazione etica che era stata caratteristica
della rivoluzione non violenta di Gesù (non a caso, invece, Engels diede del cristianesimo originario
un’interpretazione quale movimento rivoluzionario che usava la lotta armata).
18
Secondo Marx, “la storia è la vera storia naturale dell’uomo”, cioè il mondo naturale dell’uomo non
è il mondo della natura ma il mondo della storia, in quanto prodotto del lavoro dell’uomo, l’autoproduzione del mondo storico attraverso il lavoro umano che trasforma il mondo: da qui l’autoctisi
nella deriva idealistica della prassi nell’interpretazione di Marx data da Giovanni Gentile.
L’elemento materiale non è la natura, ma l’appropriazione della natura da parte dell’uomo, dei
mezzi di produzione, che hanno fatto sì che l’uomo producesse il suo nutrimento, la sua vita
materiale stessa, distinguendosi dagli altri animali; “ciò che sono - gli uomini – coincide con quello
che producono e con come lo producono”.
Marx comprende che ciò che distingue gli esseri umani da altri animali non può essere rintracciato
su un piano metafisico di un’essenza idealmente definita, come quella del pensiero puro, ma va
compreso su un piano storico effettivo, che rivela il tratto distintivo dell’essere umano, nella sua
storicità, nell’attività materiale dell’essere umano (non come individuo ma come essere sociale) che
si è esplicata nel lavoro della terra con la rivoluzione neolitica, cioè in un’attività tecnica sistematica
di dominio della Natura, in cui la Natura, a sua volta, si ridefinisce in termini di materia come ciò
che resiste al lavoro dell’umanità.
Come filosofia della storia attiva, Marx definisce un nuovo tipo di “materialismo”, il “materialismo
storico”, che si vuole distinguere dal materialismo come metafisica ontologica materialistica e
meccanicista della Natura, basandosi su una nuova antropologia dell’essere umano come essere
storico e sociale materialmente attivo. La ricaduta, però, in una metafisica materialista è implicita
nell’Anti-Duhring (1878) di Engels a cui anche Marx partecipò con un capitolo (seppure dedicato a
problemi di storia dell’economia) e nella Dialettica della Natura di Engels, pubblicato postumo nel
1925: bisogna quindi distinguere nettamente la posizione di Marx da quella di Engels. Qui, la
volontà di definire il materialismo come ateismo porta Engels ad accettare al suo interno l’idea di
un universo infinito ed eternamente ciclico e anche la teoria evoluzionistica di Darwin che
riconduce la lotta di classe alla lotta per la vita, e cioè un materialismo naturalistico.
19
D’altra parte, seppure Marx rivela l’essere storico-sociale dell’essere umano nella sua effettività che
lo distingue da altri animali, è portato a legittimarlo, a legittimare la sua attività di dominio tecnico
nei confronti della Natura e degli altri viventi. Tale legittimazione si traduce in una concezione
economica della realtà: ogni cosa è considerata come valore economico, per il suo valore d’uso per
l’essere umano. Nella sua opera del 1859, Per la critica dell’economia politica, Marx inizia a
delineare quanto poi confluirà ne Il Capitale del 1867, primo libro a cui ne seguiranno altri due,
pubblicati postumi da Engels nel 1885 e nel 1894: la critica dell’economia politica da parte di Marx
si concentra, in effetti, sul valore di scambio attribuito alle cose considerate come merci, in quanto è
proprio sulla valutazione del valore di scambio che si producono le ingiustizie economiche fra gli
esseri umani.
Marx sposa così il punto di vista antropocentrico della filosofia e dell’economia classica, non
comprendendo ciò che poteva risultare chiaro dal darsi storico del dominio dell’essere umano su un
altro essere umano: questo dominio nasce, nella rivoluzione neolitica, con il dominio della Natura e
degli altri viventi da parte dell’umanità, perché la terra e gli animali costituiscono la prima forma di
proprietà privata e di equivalente monetario negli scambi economici basati sul baratto. Marx non
critica così il fondamento antropologico e antropocentrico dell’economia: accetta la sua riduzione
dell’essere umano ad homo oeconomicus, che agisce solo per interesse economico e non conosce
altre modalità di rapportarsi alle cose se non in termini del loro valore d’uso e del loro valore di
scambio; una cosa è solo in funzione della sua utilità diretta o indiretta in uno scambio con un’altra
cosa.
Secondo Marx, la struttura della società, che determina l’essere umano come essere sociale e
storico, è economica ed è storicamente determinata dal modo di produzione dominante. La struttura
economica della società determina a sua volta le istituzioni politiche e lo stato, ma anche le
produzioni culturali materiali e intellettuali: da questo punto di vista, la cultura in tutte le sue forme
(religione, filosofia, letteratura, arti) è sovrastruttura. Nella posizione di Marx, al contrario che in
Engels, sono escluse retroazioni delle sovrastrutture culturali sulla struttura economica della società:
20
queste sono molto sottovalutate (come ha mostrato l’analisi dei rapporti fra cultura protestante e
capitalismo, effettuata da Max Weber (1864-1920)): anche le critiche della struttura gerarchica delle
classi sociali, come quella presentata nel Manifesto del Partito Comunista del 1848, scritto con
Engels, sono ricondotte a meri specchi passivi delle opposizioni reali emerse nella lotta di classe da
parte del proletariato contro la gerarchia della struttura economica, che si specchiava in una
ideologia della classe dominante: generata come legittimante il dominio economico, solo come suo
specchio passivo e mai considerata come produttrice attiva di dominio economico in nuove forme.
Le idee non si cambiano con la critica da parte di altre idee, ma solo con la rivoluzione della
struttura economica della società. L’indipendenza delle idee dalle strutture economiche delle società
è solo il frutto di un’illusione provocata dalla divisione fra lavoro manuale e lavoro intellettuale,
dalla divisione fra lavoro effettivamente produttivo e lavoro improduttivo. Le determinazioni
effettuate dai modi di produzione implicano differenti tipi di proprietà e una differente divisione del
lavoro. La proprietà privata rompe il legame sociale e il lavoro diviso non è più fondante una
società: essi producono divisioni sociali ed economiche, diseguaglianze, ma anche, quindi,
alienazione dell’essere umano dalla sua identità che è sociale.
Marx si interessa soprattutto all’analisi economica dei rapporti di lavoro che si erano instaurati con i
nuovi mezzi di produzione resi possibili dalla rivoluzione industriale del XVIII secolo e che
avevano generato una nuova classe economica, quella operaia, ovvero del proletariato: cioè dello
sfruttamento degli operai da parte di padroni della classe borghese che tende ad accumulare denaro
in un capitale, che caratterizza la fase storica dell’economia in termini di capitalismo moderno nella
quale anche il lavoro diviene mero mezzo di sussistenza individuale e quindi una merce acquisibile
sul mercato.
La prospettiva economica, che però anche Marx abbraccia, non può considerarsi puramente
scientifica, ma si rivela quindi come una metafisica antropocentrica della realtà come valore
economico. Marx, però, presenta la sua nuova economia come una scienza e per fare questo prende
a modello la fisica. Fondamentale si può considerare il principio di conservazione generalizzata
21
dell’energia, da poco teorizzato come primo primo principio della termodinamica soprattutto
nell’opera di James Joule e William Thomson poi Lord Kelvin. Che Marx ed Engels fossero a
conoscenza di questo principio è evidente da almeno due lettere di Engels a Marx, una del 14
Luglio del 1858 e un’altra del 21 Marzo 1869 in cui si fa riferimento anche al secondo principio
della termodinamica come formulata da Rudolph Clausius13.
L’energia (chiamata forza nell’ottocento), come intesa nel meccanicismo, è il concetto che consente
una correlazione fra i diversi tipi di fenomeni per mezzo di un’astratta equivalenza matematica, e di
un’omogeneizzazione dei rapporti metrici fra differenti variabili fisiche incommensurabili: se
quest’astratta equivalenza numerica, incarnata prima nel concetto di materia/massa e poi nella
declinazione meccanicistica dell’idea d’energia, ha il suo presupposto pratico in una forma di vita,
come quella della società capitalistica moderna, in cui il denaro svolge questo ruolo d’equivalenza
di ogni cosa14, il concetto di lavoro in economia politica è stato derivato dal concetto di lavoro
meccanico
e
dagli
sviluppi
energetici
della
termodinamica
ottocentesca
interpretata
meccanicisticamente. Infatti, la quantità di forza-lavoro (misurata in termini di tempo di lavoro
necessario per produrre una determinata cosa-merce) serve a Marx come misura equivalente e
univoca per misurare il valore di scambio delle cose-merci considerate come del tutto
interscambiabili: data questa equivalenza, Marx può spiegare come il profitto, come aumento del
denaro finalizzato alla sua pura accumulazione in un capitale piuttosto che usato per l’acquisto di
altre merci, si realizzi come plus-valore ottenuto da un industriale-padrone che paga-compra la
merce della forza lavoro di altri esseri umani meno del valore di scambio del prodotto della forzalavoro imponendo un plus-lavoro. Se un dato prodotto valutato, per esempio, 8 sterline in base alla
quantità di lavoro media necessaria a produrlo (pari per esempio a 8 ore), si basa sulla valutazione
di 1 ora di forza-lavoro come pari a 1 sterlina; se però la paga di quel tempo di forza lavoro è pari,
in questo esempio, a 4 sterline in relazione al tempo di lavoro necessario per produrre il suo
13
H. S. KRAGH, Entropic Creation – Religious Contexts of Thermodynamics and Cosmology,Ashgate, Aldershot (UK)
2008, pp. 132-139.
14
A. SOHN-RETHEL, Das Geld, die bare Münze des Apriori, Wagenbach, Berlin 1990; tr. it. di F. COPPELLOTTI, Il
denaro, l’a priori in contanti, Editori Riuniti, Roma 1991.
22
fabbisogno nutritivo giornaliero, il padrone realizza un profitto netto alla metà del valore del
prodotto: un plus-lavoro di 4 ore non pagato porta a un plus-valore di 4 sterline guadagnato dal
padrone. Dove è l’errore? La forza-lavoro non può /non deve essere valutata come merce prodotta o
in termini del valore della merce necessaria per la sua sussistenza (cioè del costo della vita), ma
deve essere valore a sé stessa: questa considerazione, però, non può essere presentata come una
mera verità scientifica, ma costituisce una esigenza etica di Marx15. Un’esigenza etica che Marx
nega perché vuole presentare il comunismo stesso non come l’esito di un’etica, ma come una verità
scientifica, determinata dalle leggi della storia.
L’operaio era sempre più alienato dalla propria attività lavorativa, depauperato del frutto del proprio
lavoro, privato del suo tempo ridotto a denaro. Non era succube soltanto nei suoi giorni, ma privato
anche dei suoi sonni e dei suoi sogni. Così, Carlo Cafiero (1846-1892), nel suo Compendio del
Capitale16, descrive, con toni massimamente inquietanti, la situazione del lavoratore: “Allora i tuoi
sonni non saranno più così tranquilli. Tu vedrai nelle tue notti il capitale, come un incubo, che ti
preme e minaccia di schiacciarti. Con occhio spaventato lo vedrai ingrossarsi, come un mostro dalle
cento proboscidi, che avidamente ricercano i pori del tuo corpo per succhiarne il sangue. E
finalmente lo vedrai assumere proporzioni smisuratamente gigantesche, nero e terribile nell'aspetto,
con occhi e bocca di fuoco, trasmutare le sue proboscidi in larghissime trombe aspiranti, entro le
quali vedrai scomparire migliaia di esseri umani: uomini, donne, fanciulli. Dalla tua fronte colerà
allora il sudore della morte, perché la volta tua, della tua moglie e dei tuoi figli starà per arrivare. Ed
il tuo ultimo gemito sarà coperto dallo sghignazzare allegro del mostro, felice del suo stato, tanto
più prospero, tanto più inumano”.
La produzione capitalistica ha come obiettivo la produzione di plus-valore, in diversi modi che
cambiano storicamente. Più entrano in gioco macchine, più il lavoratore non è in grado di effettuare
15
G. CALOGERO, Intorno al materialismo storico, Vallerini, Pisa 1941, poi come Il metodo dell’economia e il
marxismo. Invito alla lettura di Marx, Laterza, Roma-Bari 1967, pp. 39-71.
16
Il Capitale di Carlo Marx, brevemente compendiato da Carlo Cafiero, Biblioteca Socialista, n. 5, Bignami e c.
editori, Milano 1879. Si tratta di un incubo reale, che avevo quasi tutte le notti da bambino; solo verso i sedici anni,
trovai nella cantina di mio nonno questo libro di Cafiero e restai stupefatto alla lettura.
23
un lavoro compiuto da solo e più è costretto a vendere la sua forza-lavoro, fino all’organizzazione
del lavoro tramite catena di montaggio in cui l’essere umano è subordinato alla tecnica delle
macchine. Non solo, quindi, la mercificazione delle cose implica la mercificazione dell’essere
umano, ma anche il dominio tecnico esercitato sulla Natura e sugli altri viventi implica il dominio
tecnico sull’essere umano. L’essere umano perde la sua identità di soggetto di lavoro, produttore di
merci e utilizzatore di macchine, si aliena dalla sua forza produttrice che viene espropriata da altri e
dal prodotto del suo lavoro, e così si aliena e diventa oggetto-merce e strumento di macchine.
Tuttavia, l’essere umano sfruttato può uscire dalla propria alienazione, riappropriarsi di sé stesso, e,
nel “movimento messianico secolarizzato” della classe operaia – in quanto classe “universale” che
ha perduto totalmente la sua identità umana . ristabilire la giustizia, riappianare le diseguaglianze
economiche e realizzare “escatologicamente”, attraverso la dittatura del proletariato, una società
comunista senza il male e alla fine senza più bisogno di stato. Marx, però, pensa che questo possa
avvenire non attraverso la costituzione di una nuova identità non tecnica e non economica
dell’essere umano, ma semplicemente attraverso la presa di possesso e la proprietà, da parte del
proletariato, dei mezzi di produzione tecnica: si tratta di un errore fondamentale che sarà solo
parzialmente corretto nella successiva storia del marxismo occidentale, in particolare dalla Scuola
di Francoforte.
Marx prevedeva la polarizzazione della società in due classi antagoniste e quindi opposte, formatesi
con lo sviluppo del capitalismo in un contrasto sempre crescente che avrebbe contrapposto una
classe sempre più esigua di ricchissimi capitalisti e una classe sempre più povera di proletari. Era
questa contrapposizione la contraddizione reale socio-economica che avrebbe dovuto risolversi
storicamente in una nuova sintesi sociale, attraverso una dialettica materiale che doveva sostituire la
dialettica hegeliana delle idee. Marx, che aveva fondato una nuova scienza economica
deterministica come la fisica della sua epoca, pensava che si potesse determinare in maniera certa e
univoca la soluzione dell’evoluzione dinamica dei sistemi socio-economici, quale data da una
società comunista futura non più aspettata come un’utopia, ma come realizzazione di una previsione
24
scientifica e di un’azione politica rivoluzionaria. Vi erano quindi leggi deterministiche della storia e
questa erano esprimibili nei termini di una ferrea logica dialettica materiale e non ideale come
quella di Hegel: il materialismo storico si faceva dialettico (in russo, invalse l’abbreviazione
diamat). Rispetto alle astratte e universali ferree leggi della storia, gli individui e la loro sorte non
avevano più importanza: la violenza rivoluzionaria non solo era permessa, ma rappresentava in
qualche modo, come opposizione dialettica reale e materiale, la stessa legge della storia come della
vita per Darwin.
Tuttavia, Marx non si rese conto che il progredire del capitalismo in un paese industrialmente
avanzato non aveva come unico possibile esito l’impoverimento della classe operaia, nel momento
in cui il mercato andava assumendo sempre più proporzioni mondiali sostenute da politiche
colonialiste e imperialiste e il progresso tecnico permetteva un sempre più alto sfruttamento di
risorse naturali: si dava invece, in un paese avanzato, la costituzione di una classe media sempre più
ampia che livellava le possibilità economiche su uno standard di vita sempre più alto. Si sarebbe
invece prodotta una differenza economica sempre più enorme fra paesi industrialmente avanzati e
paesi non-europei subalterni. Da qui, la deriva fascista e nazionalsocialista, deriva fatale e nefasta
con la sostituzione dell’internazionalismo socialista con un socialismo nazionalista, propugnata
dall’idea mussoliniana di estendere la lotta di classe a guerra mondiale fra le nazioni “proletarie”
come l’Italia contro le nazioni plutocratiche imperialiste come l’Inghilterra e gli Sati Uniti
d’America, per il dominio economico del mondo intero. Dopo la fine della seconda guerra
mondiale, dopo la caduta dell’illusoria possibilità di un socialismo realizzato solo nella cosiddetta
Unione Sovietica, che in realtà aveva portato ad un impoverimento di tutta la popolazione per
fronteggiare il progresso tecnico-militare dei paesi capitalisti, dopo il crollo degli obiettivi dei partiti
comunisti occidentali pronti ad affermare l’imprescindibilità del capitalismo per la democrazia, è la
nuova e fortissima divaricazione economica fra paesi ricchi e paesi poveri del terzo mondo che fa
della situazione mondiale una situazione esplosiva che non porterà realisticamente a una nuova
sintesi sociale di libertà e di giustizia ma purtroppo a una violenza sempre più diffusa e dominante e
25
al sacrificio di sempre più vite umane e alla distruzione sempre maggiore delle forme di vita non
umana e, in generale, del sistema ecologico terrestre e di tutte le specie della biosfera.
26
3. Schopenhauer e l’inizio della crisi del paradigma dominante della modernità
La costruzione razionale di Kant, in qualche modo culmine dello spirito illuministico, e, insieme a
quella di Hegel, culmine della moderna metafisica soggettivistica, viene a crollare sotto la critica di
Arthur Schopenhauer (1788-1860). Le sue idee sono esposte in massima parte nella sua opera
intitolata Il mondo come volontà e rappresentazione, l’edizione del primo volume della quale fu già
nel 1818; il secondo fu aggiunto nel 1844, mentre la terza edizione fu del 185917. Si tratta di una
nuova metafisica senza dubbio, ma distruttrice delle precedenti certezze. Una metafisica che si basa
sul tema cristiano della volontà, ma ormai declinata nei termini della luterana volontà naturale,
schiava del peccato senza la grazia. Questa metafisica interpreta la volontà noumenica di Kant in
termini della volontà naturale di Luther, e della volontà di vita, come istinto di conservazione e
sforzo evolutivo, della nuova biologia evoluzionistica di Lamarck, della Philosophie zoologique del
1809, e infine della volontà come brama di vivere del buddhismo: si tratta ormai di una volontà
egoistica, in gran parte inconsapevole, istintuale, cieca, e quindi irrazionale e non più legata alla
ragione pratica kantiana.
La noumenicità della volontà non è più deducibile da un principio morale come in Kant, in
relazione alla libertà del volere, ma è invece dedotta dall’esperienza corporea che precede ogni
pensiero: il corpo è esperito primariamente come espressione di questa volontà di vivere istintuale.
Se questa conclusione è presentata in termini puramente teoretici e filosofici generali, in effetti non
può che derivare dalla nuova lamarckiana filosofia naturale evolutiva della vita e dalla “filosofia
pratica” soteriologica di Siddharta Gautama Shakyamuni Buddha del VI sec. a.C.
Questa caratterizzazione della volontà di vivere fa sì che non abbia una connotazione
immediatamente soggettivistica come la volontà nel cristianesimo e in Kant, ma piuttosto sia
considerata in termini biologici impersonali di una forza universale di vita, comune a tutti gli esseri
viventi, che può dare un fondamento nuovo alla conclusione delle Upanishad induiste, secondo la
17
A. SCHOPENHAUER, Die Welt as Wille und Vorstellung, Brockhaus, Leipzig 1859; tr. it. parziale (senza i Supplementi)
di P. Savj-Lopez & G. Di Lorenzo, intr. di C. Vasoli, Il mondo come volontà e rappresentazione, Laterza, Roma-Bari
1914/1916, 1928/1930, 1968, 1972; tr. it. di N. Palanga, A. Vigliani e G. Riconda, intr. di G. Vattimo, a cura di A.
Vigliani, Il mondo come volontà e rappresentazione, Mondadori, Milano 1989.
27
quale, alla base delle distinte individualità esistenti, vi è un’unica realtà per cui tutto è uno: il
Brahman, come universale anima del tutto, è interpretata come universale e infinita volontà di vita.
Se i fenomeni kantiani non sono le cose in sé, allora non possono essere che mere parvenze di una
realtà che è altra: i fenomeni non sono che manifestazioni di quel velo di Maya di cui parla
l’induismo. Il fenomeno non è allora espressione di una conoscenza che ha caratteristiche di
universalità e di necessità, che le derivano dalla struttura trascendentale, comune a tutti i soggetti
umani e che costituisce così un soggetto universale e atemporale, ma piuttosto è esito di una mera
costruzione razionale, anche se necessaria, ovvero di una mera rappresentazione cui appartengono
soggetti e oggetti: soggetti e oggetti, il mondo stesso, sono fenomeni illusori, rappresentazioni
razionali illusorie dell’unica infinita volontà di vita. Spazio, tempo e causalità non sono più
kantianamente considerate come forme a priori della sensibilità o dell’intelletto di un soggetto che
costituisce gli oggetti della conoscenza come fenomeni, ma sono forme a priori della
rappresentazione in cui si costituiscono i soggetti individuali di contro agli oggetti individuali:
spazio e tempo sono le forme a priori del principium individuationis, mentre la causalità è
espressione della volontà universale, che si esplica in volontà individuali che a loro volta si
esplicano in un’attività che si manifesta come un’azione causale reciproca.
Si ha così una decostruzione del soggetto come soggetto costitutivo della rappresentazione: il
soggetto è ora “oggetto” della rappresentazione, soggetto solo al suo interno. Crolla qui la
possibilità di una metafisica soggettivistica, tipica del pensiero moderno.
Le rappresentazioni razionali, pur nella loro necessità costruttiva, non sono altro che
razionalizzazioni di una volontà irrazionale, legittimazioni delle volontà egoistiche che ne sono alla
base.
Presa consapevolezza dell’illusorietà delle rappresentazioni razionali e delle azioni delle nostre vite,
la nuova filosofia evoluzionista di Lamarck lo porta a considerare la vita come un assassinio
continuo, reciproco e universale, e quindi a constatare la quadruplice verità già enunciata dal
28
Buddha nel Discorso della messa in moto della ruota della Dottrina (Dharmaçakrapravartana
Sūtra, sans., Dhammacakkappavattana Sutta, pāli)18:
1) “E questa, o monaci, è la santa verità circa il dolore: la nascita è dolore, la vecchiaia è dolore, la
malattia è dolore, la morte è dolore: l’unione con quel che dispiace è dolore, la separazione da ciò
che piace è dolore, il non ottenere ciò che si desidera è dolore, dolore in una parola sono i cinque
elementi dell’esistenza individuale”: tutto è dolore.
2) “Questa, o monaci, è la santa verità circa l’origine del dolore: essa è quella brama che è causa di
rinascita, che è congiunta con la gioia e con il desiderio, che trova godimento ora qua ora là; brama
di piacere, brama di continuare a vivere, brama di non invecchiare”: l’origine del dolore è la volontà
di vivere.
3) “Questa, o monaci, è la santa verità circa la soppressione del dolore: è la soppressione di questa
brama, annientando completamente il desiderio, è il bandirla, il reprimerla, il liberarsi da essa, il
distaccarsi”: la cessazione del dolore sta nell’estinzione della volontà di vivere.
4) “Questa, o monaci, è la santa verità circa la via che conduce alla soppressione del dolore: è il
nobile ottuplice sentiero, e cioè: retta visione, retta decisione, retta parola, retta azione, retta vita,
retto sforzo, retta meditazione, retta concentrazione”: è l’ottuplice sentiero che permette la
realizzazione del Nirvana, che letteralmente indica l’estinzione di una fiamma mediante un soffio,
l’estinzione dell’io nella vita (Buddha sviluppa la teoria dell’anatman, cioè di un’anima non
sostanziale, ma dinamica come una fiamma, per cui la metempsicosi non implica la rinascita di una
stessa anima individuale in un altro corpo, ma piuttosto l’accensione di un’altra fiamma).
La filosofia, per Schopenhauer, non nasce dalla meraviglia aristotelica (dall’esperienza del
thaumazein), ma piuttosto dal senso della sofferenza e del male del mondo.
Con il riconoscimento delle quattro nobili verità del Buddha, a cui viene affiancata una quinta, se
possibile, in cui si afferma che l’origine del dolore è in quella volontà di vivere attiva, in
quell’egoismo attivo che si fa violenza e assassinio della vita altrui, Schopenhauer riapre la visione
18
Nel Canone pāli all'interno del Saṃyutta Nikāya (nel Dhammacakkappavattana Sutta): La rivelazione del Buddha III, a cura di R. Gnoli, Mondadori, Milano 2001, vol. I, pp.5-12.
29
dell’abisso del male nel mondo all’origine della sofferenza di tutti gli esseri viventi, che era propria
del cristianesimo originario e della gnosi, ma senza neppure la fede in un Dio di salvezza:
Schopenhauer abbraccia la soteriologia atea del Buddha e del buddhismo originario detto Hinayana
(Piccolo veicolo).
L’estinzione della volontà di vivere, però, per Schopenhauer si ottiene in parte in maniera diversa
dal Buddha: nella via al Nirvana e nell’interpretazione stessa del Nirvana introduce degli elementi
cristiani e occidentali. L’arte, o più specificamente la musica al contrario delle arti figurative,
costituisce una forma di conoscenza immediata della realtà noumenica, al di là delle
rappresentazioni razionali illusorie: la musica permette di accedere all’esperienza della volontà e del
dolore al di là del rapporto soggetto-oggetto e al di là delle individuazioni spazio-temporali e
causali, e così mette nelle condizioni di superare la prospettiva della propria individuale volontà di
vivere. Questa conoscenza diventa, infatti, non più motivo determinante le azioni indotte dalla
volontà di vivere, ma quietivo delle azioni della relativa volontà di vita, e quindi di un’etica che
liberi da essa. L’etica di Schopenhauer non è però puramente negativa, cioè non implica soltanto
l’evitare le azioni egoistiche della volontà egoistica, come in gran parte l’etica del Buddha che porta
a una vita contemplativa in cui raggiungere l’illuminazione nella meditazione e il Nirvana: nella
prospettiva buddhista la karuna, la compassione, è solo compassione distaccata dello sguardo, non è
partecipazione al dolore altrui; l’amore effettivo è escluso perché comporta dolore. L’etica di
Schopenhauer è positiva e si basa invece sull’amore attivo cristiano: non si tratta solo di un’ascesi
di rinunzia dei piaceri. L’amore del prossimo, secondo Schopenhauer, si deve estendere a tutti gli
esseri viventi e comporta, per prima cosa, la non accettazione della nutrizione umana di altri
animali; non ci si può fermare a un’etica dell’intenzione che porta la maggioranza dei buddhisti ad
accettare di mangiare carne se, per esempio, offerta da altri. Gli esempi etici di Schopenhauer sono
presi soprattutto dai santi cristiani e in particolare dai catari, che arrivavano, nei casi più ‘alti’, a
praticare l’enduro, cioè a lasciarsi morire di fame per non danneggiare alcun essere vivente.
30
Il Nirvana non è inteso come uno stato positivo dell’essere, diverso da quello ordinario, e legato alla
contemplazione meditativa, ma semplicemente, come annichilimento della realtà della volontà,
come nulla: nell’annichilimento della volontà si dissolve il mondo come volontà e rappresentazione;
invero, per Schopenhauer è il mondo che è nulla di fronte a chi ha vinto il mondo. La più radicale
negazione del mondo dovuta al buddhismo si è così innestata, con accenti ancora più forti, nel
pensiero occidentale, in una prospettiva di pessimismo cosmico che accoppia paradossalmente
un’etica cristianizzante dell’infinito amore attivo della vita a un nichilismo teoretico. L’abisso della
sofferenza e del male si spalanca ancora di più di fronte a una ragione che non può comprenderlo.
31
4. Friedrich Nietzsche: la volontà di potenza come risposta all’abisso di Schopenhauer
Friedrich Nietzsche (1844-1900) ha espresso la sua filosofia perlopiù in forma di aforismi, spesso
anche in forma poetica: qui sta gran parte del suo fascino che continuamente attrae. Ha scritto cose
sublimi e altre obbrobriose, spesso all’interno dello stesso testo. Messo da parte in quanto
riferimento privilegiato del pensiero politico nazista e di destra, è stato rivalutato ma quasi sempre
senza un’adeguata messa in chiaro dei capisaldi problematici del suo pensiero. La sua filosofia si
articola soprattutto in una pars destruens delle precedenti prospettive, ma in effetti si riproponeva
una costruzione di una nuova maniera di filosofare.
Nietzsche si trova davanti all’abisso aperto dal pensiero di Schopenhauer e tutta la sua filosofia (La
nascita della tragedia, 1872; Considerazioni inattuali 1873-1876; Umano, troppo umano 18781879; Aurora, 1881; Gaia scienza, 1882; Così parlò Zarathustra, 1883-1884; Al di là del bene e del
male, 1886; Genealogia della morale, 1887; Il crepuscolo degli idoli, 1888; Ecce Homo, 1888;
L’Anticristo, 1888; opere postume: La filosofia nell’epoca tragica dei greci, I filosofi pre-platonici,
Introduzione ai dialoghi platonici) può intendersi come una risposta a Schopenhauer. Nietzsche si
confronta ormai anche con la filosofia naturale, evoluzionistica, della vita di Darwin, che ingloba
nella sua prospettiva e pure critica. Il punto di partenza è anche per lui la volontà di cui si ha
primaria esperienza nella nostra corporeità, ma questa volontà non è tanto una volontà di vita nel
senso della conservazione della vita stessa a livello individuale o di specie, quanto piuttosto
“volontà di potenza”, una volontà che altro non è che esplicazione della potenza infinita della
Natura, che incessantemente e inarrestabilmente nel suo esplicarsi e dispiegarsi illimitato crea e
distrugge senza cura e senza preoccupazione morale, senza finalità di alcun tipo. Questa volontà di
potenza nel suo espandersi vitale può incontrare anche la morte, non ha come suo fine la
sopravvivenza, e ciò comporta che nell’evoluzione non prevalga quasi mai il più forte, il più dotato,
il più ‘adatto’, ma piuttosto, al contrario di quanto pensava Darwin, sopravviva il più debole, il
32
meno dotato, il potenzialmente meno adatto. Questo tratto della sua concezione della Natura lo
portò a una critica radicale della scienza moderna in cui dominava il paradigma meccanicista19.
Secondo Nietzsche, bisogna accettare questa realtà della Natura e della vita in tutte le sue
conseguenze: per accoglierne le gioie, bisogna accettarne il dolore, gli aspetti distruttivi oltre quelli
creativi. Bisogna accettarne il dolore non con rassegnazione, ma piuttosto con l’entusiasmo
travolgente di chi si senta parte di questo fiume inarrestabile di potenza che è la la Natura, che è la
vita.
Schopenhauer, seguendo la morale buddhista non ha accettato il dolore della vita e ha negato la vita
e il mondo; all’opposto, Nietzsche ritiene che si debba dire sì alla vita in tutti i suoi aspetti e senza
porsi problemi morali. La morale nasce per diversi fattori secondo Nietzsche: innanzitutto, c’è
l’illusione della libertà del volere che renderebbe gli esseri umani responsabili delle loro azioni,
basandosi su una conoscenza, ma le azioni non sono mai del tutto libere e consapevoli e sono
piuttosto determinate da fattori istintivi vitali. Le azioni sono compiute dall’agente solo per il
proprio piacere e non per fare male agli altri: possono essere giudicate ‘cattive’ solo se si prescinde
dalla prospettiva di chi le compie e le si considera dall’esterno per le conseguenze che hanno sugli
altri. Questo punto di vista è diventato prevalente quando gli interessi della società hanno messo in
secondo piano il piacere e l’utile individuali; la morale si è quindi sviluppata non valorizzando
maggiormente moventi delle azioni superiori all’utilità, ma piuttosto sostituendo come valore
l’utilità sociale al di sopra dell’utilità individuale. L’utilità sociale ha stabilito però sempre una
gerarchia di valori a partire dalla valutazione data dai potenti nella gerarchia sociale. La morale
sociale ha determinato così una separazione netta fra Natura e cultura, portando a una repressione
della natura individuale a favore della vita sociale e politica: la civiltà ha così allevato gli esseri
umani in una situazione di costrizione sociale che ha “addomesticato” la natura selvaggia e istintiva
dell’essere umano, “la belva bionda, avida di preda e di vittoria”.
19
G. DELEUZE, Nietzsche et la philosophie, P.U.F., Paris 1962; tr. it. di S. TASSINARI, Nietzsche e la filosofia,
Colportage, Firenze 1978; e poi nuova traduzione a cura di F. POLIDORI, intr. di M. FERRARIS, Feltrinelli, Milano 1992 e
ulteriore nuova ed. italiana con appendice a cura di F. POLIDORI, tr. it. di F. POLIDORI & D. TARIZZO, Nietzsche e la
filosofia e altri testi, Einaudi, Torino 2002.
33
Seguendo l’interpretazione data da Schopenhauer del cristianesimo come sostanzialmente affine al
buddhismo nella negazione della vita e del mondo e seguendo anche la prospettiva aperta dal suo
amico “gemello” e collega teologo dell’università di Basilea, Franz Overbeck (1837-1905), secondo
il quale l’essenza del cristianesimo originario sia stata caratterizzata dall’ascetismo e dalla
negazione del mondo20, Nietzsche considerò il cristianesimo come una forma di “platonismo per il
popolo” responsabile di una svolta negativa nella morale occidentale.
Il cristianesimo aveva ereditato, secondo Nietzsche, dagli ebrei una morale tipica della rivolta degli
schiavi: gli ebrei, che erano stati sempre storicamente sottomessi, impotenti ad autoregolamentare la
loro vita sociale e politica, hanno così sviluppato odio nei confronti dei potenti e del mondo e come
popolo sacerdotale e religioso si sono consolati nell’idea di una vendetta immaginaria divina. Si
forma così una morale del risentimento, puramente reattiva contro gli altri, che trionferà con il
cristianesimo. Il risentimento si trasforma da una parte in spirito di vendetta che si esplicherebbe
nell’al di là, e dall’altra si introverte, insieme all’aggressività e alla violenza, indirizzandosi contro
sé stessi in un senso di colpa per un peccato commesso originariamente contro Dio che
spiegherebbe la sofferenza subita nel mondo: nel cristianesimo l’autosacrificio di Dio renderebbe
infinito il debito umano nei suoi confronti, moltiplicando infinitamente il senso di colpa. Questa
“cattiva coscienza” implicata dal cristianesimo diventa la più grave malattia dell’umanità
occidentale che impone sofferenza e rinunzia alla vita, mascherando nella malafede il risentimento
come amore altruistico: il cristianesimo si presenta così a Nietzsche come mero nichilismo dei
deboli e degli schiavi contro la vita e il mondo.
Gli ebrei sono considerati da Nietzsche come gli artefici della più radicale trasvalutazione di tutti i
valori nella morale, come mostruosa e funesta iniziativa contro la vita: in questo caso, la critica
della religione si risolve nella critica di un’intera etnia identificata con essa. Agli ebrei risalirebbero
anche le radici delle moderne tendenze egualitarie democratiche e socialiste. Questo di Nietzsche,
seppure diverso da quello più rozzo e più violento poi affermatosi in Germania anche sulla base di
20
F. OVERBECK, Über die Christlichkeit unserer heutigen Theologie, Fritzsch, Leipzig, 1873, e Naumann, Leipzig
1903; tr. it. a cura di A. Pellegrino, Sulla cristianità della teologia dei nostri tempi, ETS, Pisa 2000.
34
una nefasta interpretazione delle idee, è puro antisemitismo: l’anticristianesimo si fonda anche
sull’antisemitismo. Nietzsche era profondamente antisemita, senza bisogno di alcuna posteriore
falsificazione dei suoi scritti da parte della sorella, e nonostante le fasulle rivalutazioni di questo
aspetto del suo pensiero.
L’atteggiamento antiteoretico e antifilosofico deriva a Nietzsche certamente da Schopenhauer, e
quindi indirettamente dal cristianesimo e dal buddhismo; ma la sua critica a queste religioni e alla
morale che incarnano non gli permette di prenderle come modello, per cui si rivolge alla cultura
greca pre-filosofica.
Anche per l’arte, Nietzsche segue Schopenhauer: Nietzsche stesso pensava che sarebbe diventato
famoso come musicista (famoso è rimasto il suo Inno alla vita quale esempio di una sua creazione
che stimava più di altre). L’arte che per Nietzsche dà un immediato accesso alla realtà della
straripante potenza della Natura e della vita è la tragedia greca, esprimente il dionisiaco come
impulso all’ebbrezza della vita, senza freni e rappresentazioni razionali, attraverso la musica, il
canto e la danza in cui i confini della propria individualità sono superati. Dapprima crede che
Richard Wagner, con la sua opera totale e con la sua musica, possa rappresentare una rinascita dello
spirito della tragedia, ma poi se ne distacca, valutando la musica di Wagner e gran parte della storia
della musica occidentale come malata: quella di Wagner rappresenterebbe solo il culmine di
un’estenuazione di un atteggiamento che consiste nel crogiolarsi nella sofferenza nell’illusione della
catarsi, e a questa tradizione contrappone la musica gioiosa ed esaltante la vita come la Carmen di
Bizet. Secondo Nietzsche, originariamente la tragedia era costituita solo dal coro, mentre il drama,
cioè l’azione compiuta, intervenne dopo e il dialogo fu ampliato da Euripide che operò quindi una
razionalizzazione. Al pessimismo della tragedia originaria, dopo i primi pensatori pre-socratici,
nella filosofia greca si sostituì l’illusione ottimistica di poter comprendere la vita e il mondo in
termini di una conoscenza teoretica razionale che fosse di base all’etica, da raggiungere
socraticamente attraverso la dialettica e da articolarsi nell’analisi di relazioni causali necessarie. Ma
queste rappresentazioni razionali, come per Schopenhauer, non possono cogliere la realtà della
35
volontà di potenza della Natura, e sono soltanto strumentali a mascherare la tragicità della vita, per
sopravvivere; a differenza di Schopenhauer, però, queste rappresentazioni razionali non sono
uniche, necessarie e universali, ma storiche, sociali, individuali e quindi costituiscono una
molteplicità. Come per Schopenhauer, l’io non è il soggetto della rappresentazione: in questa
prospettiva, il cartesiano cogito ergo sum non può fornire la certezza dell’io, ma solo del pensiero
come rappresentazione cui l’io è interno. La filosofia e la scienza non sono espressione di una
conoscenza, ma strumenti della vita. Le loro supposte verità proprio in quanto presunte tali sono
errori: errore è credere erroneamente che esista la verità e voler sostituire gli errori con un’altra
presunta nuova verità. Come bisogna liberarsi dagli errori della morale che generano le costruzioni
metafisiche per ripristinare una presunta giustizia e un presunto bene, come bisogna andare al di là
del bene e del male, così bisogna andare al di là della verità e dell’errore, che sono tali solo
strumentalmente alla volontà di potenza e alla vita. La Natura e la vita sono un continuo divenire: la
verità cerca di fissare una realtà che non può essere fissata, perché in continua trasformazione, la
verità è quindi un errore perché nessuna affermazione fissa può corrispondere alla realtà del
divenire della Natura. Cade la teoria della verità come corrispondenza alla realtà, cade la possibilità
della conoscenza della realtà: Nietzsche distrugge la metafisica, la gnoseologia e la logica con una
estremizzazione della decostruzione francescana degli universali e dei concetti, e le reinterpreta
come funzionali alla vita o alla sua repressione.
Non si tratta quindi di fornire una dimostrazione dell’inesistenza di Dio, ma la liberazione dagli
errori della morale non può che condurre all’eliminazione del concetto di Dio, come
rappresentazione contraria al libero esprimersi della vita. Nietzsche si presenta così in qualche
modo come lo stesso autore dell’assassinio di Dio da parte dell’uomo più brutto che non sopporta
più lo sguardo di Dio, da parte della vita nella sua potenza distruttrice, da parte di chi torna a essere
fedele alla terra e alla vita senza sostituire il mondo sensibile con un mondo intellegibile “più vero”.
L’ateismo assoluto non è così espressione di una nuova filosofia teoretica, ma della morte di Dio
ucciso dalla violenza stessa della vita che riemerge da una repressione precedente durata millenni. I
36
valori superiori e trascendenti non si sono rivelati in grado di svolgere la loro funzione: la morte di
Dio si delinea attraverso l’esito nichilistico che è la stessa morte dell’essere umano. Necessaria
diventa una nuova trasvalutazione di tutti i valori, necessario il superamento di ciò che fino adesso è
stato l’essere umano: si profila la necessità di un “super-uomo” che realizzi pienamente la volontà
di potenza della vita, con il ritorno a Dioniso, un dio che canta e danza.
La critica di Nietzsche alla storia si rivolge alla duplicità dei significati del termine italiano: l’essere
umano soffre secondo Nietzsche di una “malattia storica”, cioè di una concezione storica lineare e
progressiva degli eventi umani, che deriva effettivamente da una secolarizzazione della concezione
escatologica cristiana della storia: questa concezione fa sopravvalutare la modernità rispetto alle
altre epoche, mentre non è che un processo di decadenza in cui incalza un egualitarismo livellatore
delle differenze e le considerazioni quantitative, di massa, prevalgono sulla qualità. D’altra parte, la
storiografia, nelle sue varie forme, danneggia la vita: la storia monumentale, che si confronta solo
con i grandi o con i grandi personaggi, per trovare nel passato un modello, falsifica l’immagine del
passato concentrandosi solo su alcuni aspetti e rischia di arrestare il flusso della vita per rifugiarsi
nel modello di una presunta grandezza che fu; la storia antiquaria, che invece si sofferma sui più
minuti dettagli, rischia di diventare mera erudizione di un sapere in nessun rapporto con la vita, in
cui tutti gli eventi diventano oggetto di una sorta di attività collezionistica per la valorizzazione del
passato in quanto passato senza alcun discernimento; la storia critica, che vuole solo distruggere il
passato in quanto passato per liberarcene per il nuovo, opera anch’essa senza discernimento e non ci
permette di comprendere i nostri legami con il passato, quello che si può mantenere e quello che si
deve superare. Ma è la storiografia, nell’interezza di questi vari atteggiamenti, che si vuole
presentare come disinteressata e oggettiva, che perde ogni contatto con la vita e la riduce a suo
oggetto sacrificandola.
A questa storiografia, Nietzsche contrapporrà una nuova indagine che prenderà il nome di
genealogia: si tratterà di comprendere quali atteggiamenti vitali, nel duplice senso di favorevoli alla
vita o suoi repressori, stanno dietro agli eventi della storia materiale e spirituale dell’umanità e del
37
suo pensiero. Solo questo tipo di storia come genealogia può costituire una storia al servizio della
vita.
Nietzsche aveva definito la sua filosofia come una forma di prospettivismo, che derivava da
Leibnitz attraverso Ruggero Boscovich (1711-1787), ma, eliminando la prospettiva infinita divina
che poteva ricomporre tutte le prospettive, anche quelle non umane, in un unico mondo, arrivò alla
conclusione che non esiste un mondo vero e unico, quanto piuttosto un’infinità di prospettive di
mondi da parte di differenti centri di forza e di vita, di volontà di potenza: questo è il senso della
famosa espressione “non ci sono fatti, ma solo interpretazioni”, che non è una negazione della realtà
che è questa infinità di centri di forza e di vita, ma una negazione della possibilità del pensiero di
attestare un’unica verità. Non si tratta quindi di un relativismo soggettivistico umano nel senso
idealistico della riduzione della realtà al pensiero, ma, anzi, il contrario, cioè l’affermazione
dell’impossibilità di ridurre la realtà della Natura e della vita ad unica rappresentazione razionale e
quindi al pensiero in senso soggettivistico umano: è il pensiero che è parte della Natura e della vita
infinite, al loro servizio.
4.1 Heidegger e Nietzsche: Chi è lo Zarathustra di Nietzsche? La sentenza di Nietzsche “Dio è
morto”. L’oltrepassamento della metafisica.
Già dagli anni trenta il pensiero di Friedrich Nietzsche21 fu il riferimento principale delle riflessioni
di Heidegger, che culmineranno nei due volumi dedicatigli e contenenti scritti elaborati fra il 1936 e
il 194622. Nietzsche aveva già valorizzato il pensiero tragico greco, aveva già distrutto la storia della
metafisica, la storia della filosofia; aveva già distrutto la storia del Cristianesimo come dottrina,
come teologia filosofica e metafisica, quale “platonismo per il popolo”, e determinato la necessità di
21
F. NIETZSCHE, Sämtliche Werke, a cura di G. COLLI & M. MONTINARI, Deutscher Taschenbuch Verlag/de Gruyter,
München/Berlin-New York 1967-1980; tr. it. a cura di G. COLLI & M. MONTINARI, Opere complete, Adelphi, Milano
1968, 2008.
22
M. HEIDEGGER (1936-1946), Nietzsche, Neske, Pfullingen 1961; tr. it. a cura di F. VOLPI, Nietzsche, Adelphi, Milano
1994. M. HEIDEGGER (1951-1952), Wer ist Nietzsches Zarathustra?, in Was heisst Denken?, Niemeyer, Tübingen 1954;
tr. it. di U. UGAZIO a cura di G. VATTIMO, Chi è lo Zarathustra di Nietzsche, in Che cosa significa pensare?, Sugarco,
Milano 1988; M. HEIDEGGER (1953), Wer ist Nietzsches Zarathustra?, in Vorträge und Aufsätze, Neske, Pfullingen
1954; tr. it. di G. VATTIMO, Chi è lo Zarathustra di Nietzsche?, in Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1976, pp. 66-82
38
una filosofia atea, basata sulla consapevolezza della “morte di Dio” o quantomeno di Dio come
concetto dei filosofi. Nietzsche aveva già smascherato l’antropocentrismo e l’umanismo sottostanti
la tradizione filosofica e scientifica; aveva già smascherato le rappresentazioni umane, come
determinate dalla sua volontà di potenza, di affermarsi in tutta la sua potenza; aveva già delineato la
necessità di un nuovo pensiero aurorale, che superasse il vecchio uomo e tutto ciò che era “umano,
troppo umano”. Heidegger però non condivide la parte costruttiva del pensiero di Nietzsche e si
dedica ad una sottilissima distruzione del suo pensiero positivo come compimento della metafisica,
nonostante i suoi propositi. Certo, Heidegger sa che Nietzsche è stato un filosofo anomalo, non
sistematico, che ha espresso il suo pensiero in aforismi o poeticamente, ma questo non elude il fatto
che anche “poeticamente”, in maniera affascinante e suadente come mai è la prosa filosofica, si
possano formulare concetti metafisici, snaturando invero la poesia nella metafisica.
Chi è lo Zarathustra di Nietzsche? Non è certamente lo Zarathustra storico, il profeta religioso
iraniano che ha influenzato la prospettiva escatologica del giudeo-cristianesimo, perché al contrario
annuncia una dottrina ciclica del tempo implicita nella concezione dell’eterno ritorno. Il Così parlò
Zarathustra è un confronto continuo implicito con il Cristianesimo e un tentativo di un suo
superamento con toni profetici, da “buona novella” anti-cristiana che paradossalmente annuncia la
morte di Dio e una nuova era, nuove “beatitudini” e nuove “maledizioni” (“guai a…”), una nuova
prospettiva di redenzione. Zarathustra è colui che proclama un “uomo nuovo”, che deve avere tratti
completamente diversi dal vecchio, e che per questo chiama Übermensch, che dovrebbe essere
meglio tradotto come “oltre-uomo”. Bisogna proclamare un “oltre-uomo” per difendere la vita, la
sofferenza: Zarathustra è l’“avvocato” della vita e della sofferenza, ovvero si potrebbe tradurrecomprendere il “Paracleto”, diversamente annunciato da Gesù stesso. La necessità di difendere la
vita con tutta la sua sofferenza nasce dal fatto che il platonismo e il Cristianesimo come dottrina
hanno mortificato e sacrificato la vita rimandando a un al di là, ad un mondo sovrannaturale.
Nietzsche non distingue come Heidegger fra un Cristianesimo originario, come esperienza autentica
di fede nell’auto-comprensione della radicale finitezza dell’esistenza che rifiuta qualsiasi fuga
39
metafisica, e il Cristianesimo come dottrina metafisica: Nietzsche, anche attraverso l’interpretazione
di Tolstoj del Cristianesimo, pensa che l’unico cristiano autentico sia stato solo Gesù stesso e che
già i suoi apostoli e Paolo lo abbiano completamente tradito.
Nietzsche vuole superare il solito ateismo, segnare definitivamente la morte di Dio una volta per
tutte e fornire non solo una critica filosofica atea del Cristianesimo, ma anche una nuova mitopoiesi
atea che risponda all’esigenza “religiosa” dell’essere umano: questa nuova mitopoiesi, alternativa al
Cristianesimo, non può che risolversi nella ripresa dell’antico mito pagano di un mondo ciclico,
basato anche su nuove speculazioni che derivano dalla portata cosmologica di alcune possibili
riduzioni del significato della seconda legge della termodinamica23. Ma, proprio per questo motivo,
questa nuova mitopoiesi si traduce, secondo Heidegger, in una nuova metafisica filosofica.
Nietzsche effettua una genealogia della metafisica platonico-cristiana e ne trova le radici in uno
spirito di risentimento e di vendetta: superare la metafisica platonico-cristiana implicherà quindi la
redenzione da questo spirito di risentimento e di vendetta. Lo spirito di vendetta è sicuramente
all’opera, secondo Nietzsche, nella concezione dell’inferno come luogo di punizione eterna degli
ingiusti: la concezione dell’inferno è in contraddizione con la prospettiva di perdòno infinito di
Gesù.
Anche la concezione platonica della reincarnazione degli ingiusti in forme di vita inferiore deriva da
uno spirito di vendetta mai sedato. Per Kant, Dio risultava necessario per la ragione pratica come
garante di una remunerazione equa di ricompense e di punizioni nei confronti dei giusti e degli
ingiusti. In definitiva, quindi, per Nietzsche era un falso sentimento morale animato da un effettivo
spirito di vendetta a richiedere l’esistenza di Dio e di un mondo sovrannaturale, sovra-sensibile, in
cui le sofferenze e le presunte ingiustizie della vita sarebbero state compensate. Spiega Nietzsche,
quindi, generalizzandone il senso, che lo spirito di vendetta non è altro che l’avversione della
23
G. DELEUZE, Nietzsche et la philosophie, P.U.F., Paris 1962; tr. it. di S. TASSINARI, Nietzsche e la filosofia,
Colportage, Firenze 1978; e poi nuova traduzione a cura di F. POLIDORI, intr. di M. FERRARIS, Feltrinelli, Milano 1992 e
ulteriore nuova ed. italiana con appendice a cura di F. POLIDORI, tr. it. di F. POLIDORI & D. TARIZZO, Nietzsche e la
filosofia e altri testi, Einaudi, Torino 2002; H. S. KRAGH, Entropic Creation – Religious Contexts of Thermodynamics
and Cosmology,Ashgate, Aldershot (UK) 2008.
40
volontà contro il tempo e il suo ‘così fu’: si tratta cioè di un avversione contro la temporalità della
vita che ne segna la transitorietà, il suo passare immodificabile e quindi intrinsecamente
incompensabile nelle sue sofferenze e nelle sue presunte ingiustizie. Si tratta cioè di una debolezza
della volontà, di un volere contro la volontà che sorge dentro spiriti deboli o indeboliti dalla
sofferenza, che non sanno accettare la vita che è esplicazione di una naturale volontà di potenza
creatrice e distruttrice delle sue forme finite al di là del bene e del male; si tratta anche di quella
nolontà che caratterizza l’ascesi buddhista e la prospettiva di Schopenhauer. L’oltre-uomo,
espressione suprema della volontà di potenza, accetta invece la vita in tutte le sue esplicazioni, in
tutta la sua finitezza e incompensabilità. L’accetta così tanto da volere la vita, da dirle sì non una
sola volta, ma infinite volte: sarebbe pronta a ripeterla, pure in tutte le sue sofferenze, infinite volte,
eternamente. La suprema volontà di potenza vuole l’eterno ritorno del tempo: “imprimere al
divenire il carattere dell’essere – questa è la suprema volontà di potenza”.
Nell’idea dell’eterno ritorno, Heidegger, però, scorge una ricaduta nella metafisica: si tratta
comunque, seppure paradossalmente, di eternizzare il tempo, di non accettare la radicale finitezza
dell’esistenza temporale. Heidegger, al contrario, ha impresso all’essere il carattere del divenire, il
carattere di un’intrinseca finitezza temporale: è questa, per Heidegger, l’unica soluzione antimetafisica.
Nietzsche vuole eternizzare il tempo e trovava, ancora prima della teorizzazione dell’eterno ritorno,
nell’attimo-istante, che comporta l’arresto del tempo, questa possibilità di eternizzazione della
dimensione temporale: per Heidegger, Nietzsche non si è ancora liberato dalla metafisica
dell’eternità e non riconosce la vera dimensione temporale che l’istante-ora non può cogliere (da
questa prospettiva Nietzsche, nonostante il suo stile diverso, è più vicino ad Aristotele che a
Kierkegaard).
La prospettiva nietzschiana dell’eterno ritorno è quindi metafisica in un mero ribaltamento dei
valori associati da Platone al mondo ideale e al mondo sensibile: per Nietzsche è il mondo sensibile
ad essere superiore ed eterno. Fra l’altro, il rifiuto del platonismo si sviluppa in Nietzsche con una
41
ricaduta in prospettive biologistiche e materialistiche, seppure non meccaniciste. Ma anche la
prospettiva nietzschiana della volontà di potenza è per Heidegger metafisica: si tratta di una
metafisica soggettivistica in cui l’essere è concepito umanisticamente nei termini di una volontà di
potenza illimitata, tipica solo degli enti umani. Nel medioevo cristiano la teologia francescana della
volontà si era opposta ad una teologia aristotelica dell’intelletto, e questa teologia, attraverso il
concetto di impetus poi ripreso da Bruno (e invero anche da Galileo) e Leibniz, aveva inaugurato
una nuova filosofia della Natura, distante dall’intellettualismo logico-ontologico greco. Questa
prospettiva era stata poi deformata dall’idea meccanicistica dell’inerzia e dalla biologia
evoluzionistica che aveva ricondotto la volontà a un istinto vitale egoistico, che influenzò sia
Schopenhauer che Nietzsche seppure con valutazioni opposte di questo istinto. Il tutto si legò in
Nietzsche a una secolarizzazione di una teologia protestante, fissata dall’interpretazione della
Bibbia a una visione essenzialmente ancora vetero-testamentaria e pre-gesuana della volontà, che
concepiva Dio al di là della connotazione umana del bene e del male e considerava bene tutto –
anche sofferenza, morte, violenza, assassinio – se e in quanto voluto da Dio.
Al contrario, per Heidegger, conformemente alla rivoluzione gesuana che identifica Dio con
l’Amore (I Giov. 4.8), essere-nel-mondo non può essere autenticamente che cura dell’alterità e del
mondo; mentre la volontà di potenza illimitata dell’essere umano non può che esserne un’assoluta
distorsione che considera l’essere e gli altri enti strumentalmente come oggetti disponibili al suo
arbitrio, da sfruttare, da fagocitare e da dominare tecnicamente a vantaggio della propria vita,
propria di chi non vuole accettare la propria finitezza temporale e si illude di poterla superare
nell’illimitatezza dell’estensione del suo dominio.
Non solo: la prospettiva nietzschiana si mostra metafisica ad Heidegger in quanto le
rappresentazioni del pensiero filosofico e scientifico, seppure smascherate come determinate
strumentalmente da una volontà di potenza, sono valutate positivamente da Nietzsche se non legate
ad una sua repressione ma invece ad una sua esaltazione. La verità è strumentale alla realizzazione
della massima volontà di potenza del soggetto umano, ed è un errore in quanto fissa ciò che diviene
42
e quando legata a rappresentazioni che non la realizzano: la verità non è propria dell’essere, ma è
relativa alle varie prospettive dei vari soggetti, è soggettiva ed è determinata dalla massima efficacia
delle rappresentazioni a vantaggio della volontà di potenza del soggetto24. Questa prospettiva
nietzschiana non è per Heidegger meramente metafisica, ma è il compimento assoluto della
metafisica occidentale moderna e del suo soggettivismo: non c’è più un mondo vero, un essere, una
verità; nella prospettiva nietzschiana assurge apertamente a verità quanto è strumentale al dominio
dell’illimitata volontà di potenza della soggettività umana; l’efficacia strumentale per il dominio
viene epistemologizzata a criterio di verità strumentale. Si conclude così quel processo che con la
rivoluzione scientifica aveva portato all’epistemologizzazione della tecnica. In Nietzsche,
indipendentemente dalla tecnica, viene legittimata apertamente anche quella che può essere
considerata la sua motivazione, una volontà di potenza oltre-umana (invero, “umana, troppo
umana”), illimitata e al di là del bene e del male. L’esito è che la metafisica di Nietzsche, pur
essendone sganciata, può costituire il fondamento del dominio tecnico umano che riduce tutto a
fondo di risorse di energia, nella devastazione assoluta della terra da parte dell’umanità.
24
Karl Lӧwith, che, come altri allievi ebrei, si sentì profondamente tradito da Heidegger (aveva corretto con lui anche le
bozze di Essere e tempo) per la sua adesione al nazismo, deve arrampicarsi sugli specchi per contestare il suo maestro
ormai inviso sul piano filosofico: presenta il caso di Nietzsche come esempio del fallimento dell’ermeneutica
heideggeriana, che comporterebbe quindi la falsità dell’analitica esistenziale su cui si basa. Non comprendendo
l’intreccio complesso e inevitabile fra interpretazione in senso stretto, valutazione critica e sviluppo delle problematiche
poste da un autore al di là delle soluzioni proposte, giudica l’ermeneutica heideggeriana “solipsistica”, autocentrata e
non rivolta ad un’effettiva comprensione dell’altro. Lӧwith deve affermare che se Nietzsche non avesse scritto perlopiù
per aforismi, ma piuttosto sistematicamente come Aristotele, se Nietzsche non si fosse “talora” espresso come si è
espresso, se non si leggessero gli aforismi del Wille zur Macht, allora si sarebbe compreso non come Heidegger
pretenderebbe. Siccome Lӧwith non riesce a smontare la veridicità dell’interpretazione di Nietzsche data da Heidegger,
allora attacca direttamente l’analitica esistenziale, l’essere heideggeriano che non sarebbe altro che un retro-mondo
sovrasensibile metafisico (quando è chiaro che non esiste mai né dietro né fuori dagli enti), poi cerca di spiegare
storicamente e sociologicamente il pensiero di Heidegger come di un’epoca di crisi, in cui ci sono ancora teologhi atei,
come lui, che non hanno accettato la morte di Dio evidenziata da Nietzsche (mentre è chiaramente Nietzsche che ha
dovuto colmare questa morte divinizzando la volontà di potenza dell’oltre-uomo): K. LÖWITH, Heidegger. Denker in
dürftiger Zeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1960; tr. it. di C. CASES & A MAZZONE, Saggi su Heidegger (I.
L’esistenza che si accetta e l’essere che si dà; II. Evenienzialità, storia, ventura dell’essere; III. L’interpretazione di ciò
che rimane taciuto nel detto di Nietzsche “Dio è morto”; IV. Per una valutazione critica dell’influenza di Heidegger),
Einaudi, Torino 1966, 1974, pp. 83-123, in particolare pp. 117 e 123, e inoltre pp. 130-131. Di Lӧwith si veda anche: K.
LÖWITH, Zu Heideggers Seinsfrage: Die Natur des Menschen und die Welt der Natur, in Die Frage Martin Heideggers.
Beitrӓge zu einem Kolloquium mit Heidegger aus Anlass seines 80., Winter, Heidelberg 1969, pp. 36-49; tr. it. di N.
Curcio, intr. di F. Volpi, K. LÖWITH, La questione heideggeriana dell’essere: la natura dell’uomo e il mondo della
natura, in G. ANDERS, H. ARENDT, H. JONAS, K. LӦWITH, L. STRAUSS, Su Heidegger. Cinque voci ebraiche, Donzelli,
Roma 1998, pp. 75-88; K. LÖWITH, Husserl il pazzo e Heidegger il gesuita, da Fiala. Die Geschichte einer Versuchung
(Fiala. La storia di una tentazione) in Internazionale Zeitschrift für Philosophie, n. 1 (1997), pp. 136-167, pres. di O.
Franceschelli, in Micromega, pp. 297-306; K. LÖWITH, Mein Lebenin Deutschland vor und nach 1933, Metzler,
Stuttgart 1986, pp. 42-45; tr. it. di E. Grillo, La mia vita in Germania prima e dopo il 1933, il Saggiatore, Milano 1988,
pp. 69-72.
43
Il detto di Nietzsche “Dio è morto” per Heidegger ha due aspetti25: da una parte, va compreso
positivamente nel senso della morte della metafisica del mondo sovrasensibile platonico-cristiano,
del cristianesimo come dottrina metafisica, e mai nel senso del Dio della fede dell’esperienza
autentica del Cristianesimo originario. Dal punto di vista specifico, invece, dell’assenza e del
rifiuto della fede autentica in Dio, espressa da Nietzsche nell’uccisione vendicativa e consapevole di
Dio da parte dell’“uomo più laido” (per non avere testimoni della propria abiezione), ha un aspetto
negativo ma non esprime una novità; è piuttosto il culmine del processo di oblio dell’essere, che,
nella modernità, ha i tratti della de-divinizzazione già discussa e a cui ha contribuito anche il
cristianesimo dottrinario e religioso moderno che ha ridotto, con la filosofia moderna,
soggettivisticamente il mondo a immagine, perdendo il senso divino della Physis. In questa
prospettiva heideggeriana, Nietzsche non supera il nichilismo dei valori che segue, secondo
Nietzsche, la “morte di Dio”, perché la trasmutazione nietzschiana di tutti i valori a favore della
“valorizzazione” di una volontà di potenza senza valori è parte di questo nichilismo che deriva
invece, per Heidegger, dall’oblio dell’essere e dalla de-divinizzazione che è prima di tutto perdita
del senso della Physis, per cui neanche l’assenza di Dio può essere più percepita come tale.
L’oltrepassamento della metafisica, per Heidegger, non è soltanto una svolta all’interno della
disciplina della filosofia, ma piuttosto richiede una nuova maniera di esistere autenticamente in una
nuova pre-comprensione dell’essere; è un evento nella storia dell’essere, in cui dopo l’abbandono e
l’oblio totale dell’essere che costituiscono l’attuale nichilismo, che annichila l’essere nella
devastazione della Physis, torna a rivelarsi l’essere.
Tuttavia, seppure l’eterno ritorno e la volontà di potenza di Nietzsche rientrano nella metafisica e
nell’ideologia della violenza, l’essere di Heidegger – seppure completamente temporalizzato - ,
riconducendo le cose stesse nella prospettiva dell’antica ontologia seppure modificata, è meno
indicato del divenire nietzscheano per cogliere la temporalità costitutiva delle cose; e la rivelazione
25
M. HEIDEGGER (1936-1943), Nietzsches Wort “Gott ist tot, in Holzwege, Klostermann, Frankfurt am Main 1950; tr.
it. di P. CHIODI, La sentenza di Nietzsche: “Dio è morto”, in Sentieri interrotti, La Nuova Italia, Firenze 1968, 1984, pp.
191-246.
44
della Physis oltre la metafisica è vanificata dall’ontologizzazione trascendentale e metafisica della
Physis nell’essere compiuta da Heidegger. Se si tolgono alla volontà di Nietzsche la sua
connotazione di potenza e di dominio e quindi la sua connotazione di violenza amorale egoistica, si
può accettare pienamente il suo sì alla vita e farne come in Albert Schweitzer 26 il fondamento
volontaristico di una morale del rispetto della vita in tutte le sue forme, evitando le critiche di
Heidegger di un sottostante soggettivismo umanistico.
26
A. SCHWEITZER, Aus meinem Leben und Denken, F. Meiner, Leipzig 1931; tr. it. di A. GUADAGNIN, La mia vita e il
mio pensiero, Comunità, Milano 1965; A. SCHWEITZER, Die Weltanschauung der indischen Denker. Mystik und Ethik,
Beck, München 1934; tr. it., I grandi pensatori dell’India, Astrolabio-Ubaldini, Roma 1962, e, a cura di S. Marchignoli,
Donzelli, Roma 1997; A. SCHWEITZER, Die Ehrfurcht vor dem Leben – Grundtexte aus fünf Jahrzehnten, a cura di H.
W. Bӓhr, Beck, München 1991; A. SCHWEITZER, Gesammelte Werke in fünf Bänden. Hrsg. von Rudolf Grabs. Beck,
München 1974.
45
5. Søren Kierkegaard e la filosofia dell’esistenza
Søren Kierkegaard (1813-1855) diede origine a un nuovo tipo di filosofia: la sua filosofia
dell’esistenza si oppone a tutte le precedenti filosofie delle essenze, che avevano avuto il loro
culmine in quella di Hegel. Si presenta come una nuova forma di filosofia cristiana che si
contrappone alla trasformazione del cristianesimo in una metafisica teologica: le sue radici
affondano nella critica degli universali effettuata dalla rivoluzione francescana e dal rifiuto luterano
della intellettualistica filosofia teoretica greca delle essenze. Si tratta di una filosofia, del tutto
soggettiva, dell’esistenza nella sua concretezza e singolarità, dove anche la fede non si costituisce
come suo fondamento razionale ma come particolare esperienza esistenziale concreta. Kierkegaard
in Enten – Eller (Aut-aut, 1843) (con lo pseudonimo di Victor Eremita che avrebbe trovato i fogli
pubblicati in due volumi: il primo, Enten, scritto da A l’esteta, mentre ‘il diario del seduttore è
scritto da Johannes; il secondo, Eller, scritto dal giudice in pensione Wilhelm parla dello stadio
etico); e in Stadi sul cammino della vita (1845), (in danese Stadier paa Livets Vei. Studier af
Forskjellige sammenbragte, befordrede til Trykken og udgivne af Hilarius Bogbinder, la vita
religiosa è descritta solo nella terza sezione), delinea un’analitica e una dialettica dell’esistenza,
senza che queste possano però costituire un sistema filosofico dell’esistenza: la filosofia è intesa
come tutt’uno con l’esistenza, come consapevolezza esistenziale e progetto d’esistenza, e mai come
compendiabile in un sistema di una ragione teoretica. Qui, Kierkegaard descrive e distingue tre
tipologie di esistenza, che possono costituire anche tre stadi successivi: questa analitica prende le
mosse dalle proprie esperienze esistenziali individuali e non dal ragionamento astratto legato
all’universalità impersonale di un io trascendentale. La prima tipologia d’esistenza è quella di una
vita estetica, o meglio di un modo di vivere da esteta (di cui il Don Giovanni è esempio
paradigmatico), che si realizza nel godere il piacere momentaneo dell’attimo fuggente, in una
ricerca continua ma disciplinata di qualcosa di non-banale, di sofisticato e intenso che possa
ravvivare un ebbrezza che perduri. Questa tipologia d’esistenza è destinata, per la sua natura, ad
avere come esito la noia o eventualmente la disperazione. Quando la disperazione diventa
46
prevalente, allora si prospetta una nuova possibilità, un’esistenza alternativa: la disperazione è
quindi non meramente negativa, ma ambivalente perché permette anche di uscire fuori dalla sfera
estetica. Si apre allora la strada ad una seconda tipologia d’esistenza, quella di una vita etica. Il
passaggio però non è facile perché non si tratta di un percorso continuo, senza fratture: vi è un
abisso da superare ed un salto da effettuare per questa trasformazione segnata da una discontinuità
radicale. La scelta di una vita etica comporta il raggiungimento di una nuova stabilità ed una nuova
continuità, di livello superiore a quello della vita estetica che aveva bisogno sempre di novità
esteriori per mantenersi nella sua intensità: questa nuova stabilità ha corso nella scelta di sé stessi,
di un sé stesso che si ritrova proprio nel suo scegliere in una continuità temporale che fonda la
propria identità nella sua storia, e in accordo a una legge universale che lo lega all’intera umanità.
L’esito della vita etica è il riconoscimento della propria colpa, e anche delle colpe ereditate come
membro della specie umana, che ne mostra l’insufficienza. Il sentimento di colpa genera angoscia,
e, questa angoscia presenta ancora un’ambivalenza, perché non è solo negativa ma può condurre a
uscire da questa sfera d’esistenza. Si apre allora la possibilità del pentimento, della metànoia e della
conversione alla vita religiosa. Anche fra vita etica e vita religiosa c’è un abisso, ancora più
incolmabile del precedente, e richiede il salto della fede che non è attuabile dal solo essere umano,
ma coinvolge Dio: la fede è dono della Grazia. Kierkegaard distingue nettamente la vita religiosa
dalla vita etica richiamandosi alla figura antico-testamentaria di Abramo, e sarà seguito in questo,
successivamente dal teologo Karl Barth: vede in Abramo il paradigma della fede che può portarlo
anche all’uccisione del figlio, cioè alla sospensione dell’etica e delle sue leggi. Kierkegaard crede
sia questa la radicalità della fede cristiana, ma in effetti il Dio di Kierkegaard resta così ancora
quello vetero-testamentario che è molto diverso dall’etico Dio-Amore di Gesù e del Nuovo
Testamento (I Giov. 4.8).
La fede, allora, per Kierkegaard non può che qualificarsi a sua volta, in questa sospensione
dell’etica, che un’incertezza angosciosa, dove certa resta solo l’angoscia. La fede è così paradosso e
scandalo, contraddizione ineliminabile. Il paradosso massimo è quello del Cristo dalla doppia
47
natura, umana e divina. Ma questo paradosso si ripresenta in ogni esperienza esistenziale della fede
in cui Dio è presente nella vita dell’essere umano: da un lato, è l’essere umano che deve scegliere la
vita religiosa, dall’altro è Dio che sceglie/elegge l’essere umano nella Grazia della fede. Se questa è
l’esperienza esistenziale umana che riproduce il paradosso proprio del Cristo, allora il cristianesimo
rivela la struttura stessa dell’esistenza: contraddizione, paradosso, scandalo, dubbio, angoscia sono
le caratteristiche dell’esistenza e del cristianesimo, non solo della vita religiosa ma anche della vita
estetica e della vita etica.
L’esperienza esistenziale è esperienza di una contingenza radicale, contingenza della propria
esistenziale e contingenza delle cose. L’esperienza non solo non è sufficiente per delineare alcunché
di necessario, ma è tale da dover escludere la necessità: tutto accade in quanto possibilità.
A sua volta, anche la storia è il regno della possibilità, in quanto propria del divenire: il divenire è
sempre un annientamento parziale delle possibilità soppiantate dalla realtà: il passato non è
necessario neanche dopo essere accaduto, altrimenti necessario sarebbe anche il futuro; il
necessario, proprio dell'essere immutabile, non include il possibile del divenire, come erroneamente
pensava Aristotele, ma ne è l’opposto. Il passato resta sempre possibile e quindi la sua stessa realtà
è la realtà di una possibilità (per questo Dio può cambiare anche il passato, come per la teologia di
Pier Damiani). Il passato non è che un futuro che è accaduto: la dimensione fondamentale del
tempo, come sarà ripreso da Heidegger, è così il futuro.
Come regno del possibile, il divenire non ammette causalità: Kierkegaard segue e va oltre Hume. Il
divenuto è conoscibile nel suo darsi immediato alla percezione, ma il divenire non è conoscibile: il
cambiamento non è conoscibile. Non c’è una scienza del divenire della Natura: nessuna logica
dialettica hegeliana può stabilirsi, ma neanche una scienza della Natura basabile sulla continuità e
sulla causalità che non sono tracciabili. Questa prospettiva sarà alla radice della filosofia quantistica
della Natura di Niels Bohr (1885-1962) di fronte alle evidenze di impossibilità sperimentali del
mondo atomico e microfisico: è possibile descrivere l’elettrone solo negli stati stazionari
dell’atomo, e mai nelle transizioni da uno stato all’altro, che non sono descrivibili tramite funzioni
48
matematiche continue o connessioni causali prevedibili e si configurano come i salti di Kierkegaard
fra i vari stati d’esistenza; l’elettrone verrà poi pensato da Bohr, secondo il principio di
complementarità del 1928, come avente una doppia natura di corpuscolo e di onda come la doppia
natura del Cristo in cui la contraddizione è pensata in termini appunto di complementarità.
Anche la storia come divenire non può essere quindi oggetto di scienza, in quanto niente del nonessere o distruzione delle possibilità che si sono realizzate, passaggio dal niente a una possibilità
multipla. La storia non è quindi oggetto di scienza.
La struttura dell’esistenza è quindi la possibilità, che sottostà alle varie possibili scelte alternative di
vita: l’angoscia che caratterizza l’esistenza è legata all'indeterminazione e all’infinità delle
possibilità che si concretizzano nell'avvenire, a ciò che non è ma può essere nel futuro, al nulla che
è possibile o alla possibilità nullificante, a cui si collega la morte. Il passato non può angosciare: ha
potuto angosciare nel suo essere possibile futuro che stava accadendo o può angosciare nel suo
possibile ripetersi futuro. L'angoscia è, come la disperazione, una categoria esistenziale che ci fa
comprendere, come per Luther, che nella vita può accadere di tutto e che la perdizione e
l'annientamento sono in ogni momento possibili per la struttura stessa dell'esistenza. L'angoscia è
relativa alla condizione di possibilità esistenziale dell'essere umano in relazione al mondo, la
disperazione è invece correlata alla condizione di possibilità esistenziale interna a sé stesso: la
disperazione è la malattia mortale non perché comporti la morte effettiva, ma perché è la possibilità
impossibile di affermare o negare sé stesso rispettivamente nella propria autosufficienza
o
insufficienza che comporterebbe essere altro da sé e autosufficienza; si tratta di "vivere la morte
dell'io come autosufficienza". Solo la fede permette di superare la disperazione in quanto fede in un
Dio a cui tutto è possibile. Ma la fede sconfina al di là della ragione ed è sempre paradosso e
contraddizione: così, costituisce un capovolgimento dell’esistenza per cui al possibile come fonte di
radicale instabilità si sostituisce la stabilità del possibile dipendente da Dio che può tutto.
Fede e dubbio non sono due categorie gnoseologiche ma passioni contrarie, ma la fede è anche
decisione che esclude il dubbio che non si risolve razionalmente.
49
Il rapporto fra Dio ed essere umano non si verifica nella storia o nel divenire ma nell'istante in cui
l'eternità incontra il tempo, la verità di Dio si impone sulla non-verità umana che è propria del
peccato, per cui non si può raggiungere la verità attraverso una maieutica socratica che presuppone
la presenza della verità come interna all'essere umano, ma solo attraverso la redenzione operata dal
Cristo. Dio non è dimostrabile razionalmente dall’essere umano perché caratterizzato come non
verità: le dimostrazioni presunte presuppongono già Dio e sono quindi sviluppi idealistici e non
prove. Dio è follia impensabile, differenza assoluta rispetto all'essere umano.
Con la fede, possiamo accedere alla doppia natura del Cristo, uomo e Dio, che resta per noi
paradossale e non risolvibile teoreticamente, ed il Cristo è il paradigma dell’incontro esistenziale
dell’essere umano e di Dio, dell’incontro fra Natura e Grazia nell’esistenza umana. L’esistenza
umana, così, secondo Kierkegaard, si può comprendere attraverso l’esempio del paradosso e della
contraddizione che la persona di Gesù vive in sé e che il cristiano ripercorre: anche Gesù, secondo i
Vangeli, ha vissuto pienamente l’esperienza dell’angoscia. Secondo Kierkegaard, è così il
cristianesimo che svela la struttura dell’esistenza umana: questo tema verrà ripreso da Heidegger
che costituirà la struttura trascendentale dell’esistenza sulla base della fenomenologia della vita
religiosa che rappresenta la forma di esistenza autentica.
50
6. La fenomenologia di Edmund Husserl
La fenomenologia di Edmund Husserl (1859-1938) va situata storicamente per essere compresa
pienamente: si tratta di una reazione alla crisi del pensiero moderno, scientifico e filosofico. In
fisica, dopo la costruzione della termodinamica e dell’elettromagnetismo a partire da metà
Ottocento, si delineò la crisi del meccanicismo: la concezione meccanicistica della Natura non
poteva più costituire il fondamento del pensiero fisico. D’altra parte, la costruzione delle geometrie
non-euclidee, delle algebre non-commutative, di nuove teorie dei numeri, già nella prima metà
dell’Ottocento, determinò una crisi dei fondamenti della matematica e quindi dell’intera scienza
moderna: logicismo, formalismo, intuizionismo-costruttivismo si fronteggiarono proponendo
soluzioni che non si rivelarono positive. La fondazione della filosofia teoretica era invece crollata
sotto le critiche di Arthur Schopenhauer, Karl Marx, Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche.
Il dubbio teoretico con cui Husserl si confrontava era quindi prima di tutto un dubbio storico: il
legame con Cartesio, ancora prima che teoretico, è storico: si era riaperto l’abisso di un mondo non
razionale e non razionalizzabile. Husserl tenta una rifondazione della filosofia teoretica nello spirito
greco, ma in termini della moderna metafisica soggettivistica.
A partire dalle Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, il cui primo
volume fu pubblicato nel 1913 (altri due, postumi, appariranno nel 1952)27, Edmund Husserl così
aveva proposto il metodo della cosiddetta “riduzione fenomenologica” (la sospensione del giudizio
dello scetticismo antico, l’epoché) per accedere a una dimensione in cui i fenomeni si mostrano
come tali a una coscienza pura: secondo Husserl, si devono “mettere fra parentesi” i pre-giudizi e i
giudizi del senso comune e anche delle teorie scientifiche che presuppongono già un mondo di cui
l’essere umano è parte. Unico modo per accedere al mondo vero è ricostituirlo a partire dagli atti
intenzionali della coscienza pura che lo costituiscono come tale (il mondo si coglie solo come il
correlato oggettivo di una coscienza pura che s’intenziona verso di esso e che si presenta come
27
E. HUSSERL, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und Phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine
Einführung in die reine Phänomenologie, in Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, Niemeyer,
Halle 1913; tr. it. a cura di E. Filippini, Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, Einaudi,
Torino 1965.
51
un’intersoggettività originaria): Husserl vuole partire da una correlazione originaria soggettomondo, sperando così di superare l’astratto realismo delle cose in sé e l’astratto idealismo di una
coscienza in sé a cui il mondo è interno, ma comunque il mondo si costituisce solo attraverso il
soggetto come fenomeno per una coscienza pura.
Secondo Husserl, il mondo vero non è quello descritto dall’esterno dalla scienza moderna, ma
quello “vissuto” dall’interno, dalla coscienza interiore dell’essere umano. Questa prospettiva di
Husserl vuole superare con l’idealismo post-kantiano la metafisica distinzione (kantiana) fra
fenomeno e noumeno, e si ripropone, in un contesto storico mutato, una rifondazione filosofica
della conoscenza scientifica da un punto di vista che resta soggettivistico e che certamente non tiene
conto che indirettamente della problematica humiana ormai lontana. Husserl segue il dubbio
metodico cartesiano e si arresta allo stesso modo all’indubitabile certezza dell’io, seppure
trascendentalizzato alla Kant.
C’è, poi, secondo Husserl, oltre l’intuizione sensibile kantiana,
un’intuizione categoriale (non dell’intelletto kantiano) che permette di accedere, oltre l’intuizione
empirica, alle universali e a priori modalità d’essere “oggettive” in cui si struttura l’esperienza,
cosicché si ha una riduzione eidetica dei singoli dati empirici alle “essenze oggettive” (dei
“trascendentali oggettivi”, ontologici) delle cose per come si danno allo sguardo teoretico
disinteressato. Solo questa intuizione eidetica permette di fondare una scienza rigorosa, che non è
possibile fondare a partire dall’esperienza come vorrebbero le scienze naturali. Che fosse possibile
fondare una scienza rigorosa era per Kant una fiducia assoluta nella scienza newtoniana, ma per
Husserl, che non ritiene fondate le scienze naturali, resta una mera petizione di principio, come
anche il fatto che ci sia un’essenza ideale delle cose coglibile da un’intuizione eidetica e che lo
porta a un realismo delle idee, ovvero a una sorta d’idealismo platonico senza iperuranio, un
idealismo trascendentale che ha un risvolto ontologico. Questo aprirà la strada all’ontologizzazione
del trascendentale kantiano da parte di Heidegger.
52
Ne La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale,
28
Husserl terrà conto
dell’analitica esistenziale di Heidegger, che, nel 1927, con Essere e tempo, si era distaccato dalla
sua filosofia, tematizzando il “mondo della vita” (Lebenswelt) per tenere conto dell’origine della
scienza moderna: riconosce il fatto che dietro le teorie scientifiche ci sia l’esperienza pratica e
tecnica del mondo come suo presupposto, cioè l’essere-nel-mondo-della-vita costituisce l’apriori
storico e pratico-tecnico della scienza moderna. Tuttavia, Husserl rifiuta la prospettiva
heideggeriana per cui è questo il fenomeno del mondo: bisogna effettuare un’epoché anche del
mondo della vita, per costituire il fenomeno del mondo nella coscienza pura.
Il confronto con le scienze fa emergere degli altri aspetti del suo pensiero: per Husserl la
fenomenologia resta, per esempio, pre-copernicana, perché la base su cui si costituisce poi la
conoscenza scientifica è quella dei vissuti di coscienza dell’essere umano che è radicato nella Terra
come punto d’osservazione29: questo chiarimento mostra, come già detto, perché fosse fuorviante
l’analogia posta da Kant tra la sua prospettiva e la “rivoluzione copernicana”. Si ha così il
paradosso per cui per l’essere umano il fenomeno del tramonto è reale seppure apparenza 30, e il
moto rotatorio della Terra intorno al suo asse, che sta dietro quel fenomeno, non ha realtà effettiva
ma astratta perché non riferita al senso che ha per l’essere umano conoscente. Così, tutta la
prospettiva delle teorie fisiche della relatività, sia di Bruno e Galileo sia di Poincaré ed Einstein, è
28
E. HUSSERL (1936), Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, in
Husserliana, Gesammelte Werke, Bd. VI, Nijhoff, Den Haag 1954, 1959; tr. it. di E. FILIPPINI, La crisi delle scienze
europee e la fenomenologia trascendentale, il Saggiatore, Milano 1961.
29
E. HUSSERL (1934), Umsturz der koperkanischen Lehre in der gewöhnlichen weltanschaulichen Interpretation,
pubblicato postumo con il titolo Grundlegende Untersuchungen zum phänomenologischen Ursprung der Raumlichkeit
der Natur, in Philosophical Essays in Memory of Edmund Husserl, ed. M. Farber, Cambridge Harvard University Press,
Cambridge (Mass.) 1940, pp. 307-325; Rovesciamento della dottrina copernicana nell'interpretazione della corrente
visione del mondo, tr. it. a cura di G. D. Neri, in aut-aut 245 (1991), pp. 1-18; il titolo completo dato da Husserl
suonava: Rovesciamento [Umsturz] della dottrina copernicana nell'interpretazione della corrente visione dei mondo.
L'Arca originaria Terra non si muove. Ricerche fondamentali circa l'origine fenomenologica della corporeità, della
spazialità, della natura nel senso primario delle scienze naturali.
30
Si veda la corrispondente discussione, sul tempo del mondo, da parte di Heidegger nel § 80 di Essere e Tempo, che fa
pensare ad una prospettiva di pensiero a cui quanto meno non interessa nulla del copernicanesimo: M. HEIDEGGER, Sein
und Zeit, Niemeyer, Tübingen 1927, 2001; a cura di F.-W VON HERMANN, in Gesamtausgabe, vol. II, Klostermann,
Frankfurt am Main 1977 (la prima con le glosse a margine dell’Hüttenexemplar - esemplare della baita - di Heidegger);
tr. it. di P. CHIODI, Essere e tempo, Longanesi, Milano 1970; con aggiornamento bio-bibliografico di A. MARINI 1976;
nuova edizione italiana a cura di F. VOLPI sulla versione di P. CHIODI con le glosse a margine dell’Hüttenexemplar di
Heidegger, Longanesi, Milano 2005; tr. it., con testo tedesco a fronte, a cura di A. MARINI, Essere e tempo, Mondadori,
Milano 2006.
53
considerata astratta e non restituente la realtà e il senso effettivi delle cose. Il fenomeno tematizzato
dalla fenomenologia non è più il fenomeno oggettivo del senso ordinario o della scienza e neppure
quello kantiano, ma è un fenomeno completamente soggettivistico. La fenomenologia era nata per
comprendere i fenomeni psicologici o logici interni alla coscienza (gli atti intenzionali della
coscienza erano già stati introdotti per quelli da Franz Brentano che però li considerava immanenti
alla coscienza e non correlativi ad essa come Husserl), ma applicata ai fenomeni naturali si è
rivelata riduttiva e antropocentrica.
54
7. Il tentativo di ripristinare una metafisica ontologica: Martin Heidegger
Martin Heidegger (1889-1976) inizia in qualche modo come teologo e come fenomenologo della
vita religiosa. Era stato questo il tema di Heidegger nei suoi primi corsi a Freiburg, 31 in cui aveva
delineato i limiti e le “deviazioni”, l’autocomprensione falsata della vita propria di quelle pratiche
teoretiche che astraggono dalla vita, paradigmatiche, a partire dal pensiero antico greco, di tutta la
filosofia occidentale come della scienza, caratterizzanti la conoscenza come separata dalla vita
fattizia e operanti, di converso, un processo di de-vitalizzazione e di de-naturalizzazione della stessa
vita. A tali pratiche teoretiche separate dalla vita, Heidegger contrapponeva l’autocomprensione
(storica) autentica della vita fattizia storica nel mondo nell’esperienza del cristianesimo originario,
che identificava con quello “paolino”, derivandolo da un'interpretazione dei più antichi testi delle
lettere di Paolo (la lettera ai Galati e le due lettere ai Tessalonicesi). Già qualche anno dopo,
Heidegger tradirà in effetti tale proposito radicale di comprensione inevitabilmente storica,
ontologizzerà il suo pensiero nel tentativo di una fondazione puramente filosofica di una teoria
generale, universalmente valida, di una “analitica” dell’esistenza e dell’essere, staccata
dall’esperienza storica e dalla vita fattizia: i corsi di Freiburg, pubblicati solo da qualche anno e
ancora poco studiati, sono fra l’altro perlopiù interpretati in continuità, come meri antecedenti
storici di Sein und Zeit , senza che se ne comprenda l’irriducibile rivoluzionarietà perduta negli
sviluppi successivi.32 In tale prospettiva iniziale, Agostino era interpretato come caso complesso di
autocomprensione della vita fattizia cristiana, già in gran parte però minata da elementi neoplatonici
in un quadro teoretico onto-teologico in cui lo stesso Cristianesimo occidentale, ellenizzato e
latinizzato, post-niceano si configurerà dissolvendo la stessa esperienza originaria della vita
protocristiana.
31
M. Heidegger (1995), Phänomenologie des religiösen Lebens. 1.Einleitung in die Phänomenologie der Religion (WS
1920/21), a cura di M. Jung e T. Regehly. 2. Augustinus und der Neuplatonismus (SS 1921). 3. Die philosophischen
Grundlagen der mittelalterlichen Mystik (1918/19) a cura di C. Strube, in Gesamtausgabe LX , Klostermann, Frankfurt
am Mein, tr. it. di G. Gurisatti, a cura di F. Volpi, Fenomenologia della vita religiosa, Adelphi, Milano 2003.
32
M. Heidegger (1927), Sein und Zeit, Niemeyer, Tübingen, tr. it. di P. Chiodi, Essere e tempo, Longanesi, Milano 1976.
M. Heidegger (1975), Die Grundprobleme der Phänomenologie, Klostermann, Frankfurt am Main, tr. it. di A. Fabris, I
problemi fondamentali della fenomenologia, il melangolo, Genova 1988, pp. 218-327. Si veda anche: G. Gregorio,
Hans-Georg Gadamer e la declinazione ermeneutica della fenomenologia , Alfieri & Ranieri, Palermo 1997.
55
In Sein und Zeit, Heidegger, di fronte alla crisi del pensiero moderno, ha ritenuto che fosse
necessario abbandonare la metafisica soggettivistica e ritornare ad un’antica metafisica ontologica:
la crisi della modernità viene affrontata con una critica assoluta della modernità.
Heidegger tenta così di mettere insieme trascendentalismo kantiano e poi hegeliano, fenomenologia
husserliana, l’ermeneutica di Wilhelm Dilthey (1833-1911), ed esistenzialismo kierkegaardiano
all’interno di una prospettiva metafisico-ontologica.
Dalla modernità Heidegger ha ripreso a suo modo il tema di una pre-comprensione del mondo di
tipo pratico: tuttavia, connotò questo rapporto pratico in senso puramente strumentale legato all’uso
del mondo da parte dell’essere umano, ontologizzandolo trascendentalmente33. Heidegger, in Essere
e tempo, sostituisce alla correlazione coscienza-mondo di Husserl, la correlazione essere umano –
mondo, che si costituisce nell’essere-nel-mondo che è il Da-sein: il soggetto si correla al mondo nel
suo esistere. L’analitica dell’esistenza di Kierkegaard è ripresa e riformulata: la concreta esperienza
esistenziale di Kierkegaard è sostituita in Heidegger da un’analitica trascendentale della struttura
ontologica dell’esserci (non gnoseologica come in Kant), che prescinda dall’esperienza. Al di fuori
della concreta dinamica esistenziale considerata da Kierkegaard nei suoi salti da una vita estetica ad
una etica e a una religiosa, l’angoscia e la morte stessa vengono trascendentalizzate in uno struttura
ontologica dell’essere-per-la-morte che in qualche modo le neutralizza.
L’epoché del mondo operata da Husserl è quindi rifiutata, perché la costituzione del mondo come
fenomeno non è operata dalla coscienza, ma sul piano stesso dell’esistere nel mondo stesso. Il logos
che può operare questa costituzione, così, per Heidegger, non è quello della tradizione razionalistica
che culmina nel paradigma esplicativo-causale delle scienze naturali quali scienze nomotetiche che
riconducono il fenomeno a una legge che lo sussume, ma quello proprio a una comprensione dei
fenomeni nella loro irriducibile singolarità come nelle scienze dello spirito, nelle scienze storiche
33
M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Niemeyer, Tübingen 1927, 2001; a cura di F.-W VON HERMANN, in Gesamtausgabe,
vol. II, Klostermann, Frankfurt am Main 1977 (la prima con le glosse a margine dell’Hüttenexemplar - esemplare della
baita - di Heidegger); tr. it. di P. CHIODI, Essere e tempo, Longanesi, Milano 1970; con aggiornamento bio-bibliografico
di A. MARINI 1976, § 7 pp. 46-47, § 7 C, p. 55; nuova edizione italiana a cura di F. VOLPI sulla versione di P. CHIODI
con le glosse a margine dell’Hüttenexemplar di Heidegger, Longanesi, Milano 2005; tr. it., con testo tedesco a fronte, a
cura di A. MARINI, Essere e tempo, Mondadori, Milano 2006, in particolare §§ 14-22.
56
come scienze idiografiche, e quindi ermeneutico: si tratta di una comprensione dei fenomeni in
termini del loro senso per l’esistenza, perché anche il mondo si costituisce come fenomeno in
termini del suo senso esistenziale per l’essere umano che si dà all’interno di un pensiero poetante,
ovvero del linguaggio poetico (in una sorta di trasformazione linguistico-ermeneutica del kantismo).
Tuttavia, anche l’ermeneutica fenomenologica di Heidegger, pur superando l’intellettualismo
coscienzialistico di Edmund Husserl, presenta, come si è accennato, problemi analoghi per
raggiungere le “cose stesse”: se la costituzione del mondo come fenomeno è un fatto dell’esserci
umano, allora si comprende come Heidegger possa giudicare “poveri di mondo” gli altri esseri
animali, restando in una prospettiva antropocentrica; anche il linguaggio poetico, analizzato
soprattutto dall’ultimo Heidegger, non lo apre a superare l’orizzonte antropocentrico, perché è solo
l’essere umano che ‘poeticamente abita’ fra terra e cielo, nell’incontro con gli dèi che è dei soli
veramente mortali, per Heidegger gli esseri umani.
Nel § 43 di Essere e Tempo, Heidegger si confronta sia con il realismo sia con l’idealismo: da una
parte, Heidegger concorda con il principio realistico per cui il mondo esiste anche se la sua
esistenza non va dimostrata ma piuttosto è costitutiva dell’esserci come essere-nel-mondo; dall’altra
parte, Heidegger condivide il principio idealistico per cui l’essere è “nella coscienza”, cioè si dà
solo nella comprensione dell’esserci. Solo all’interno della comprensione dell’esserci si danno per
Heidegger le cose stesse, le cose in sé, che altrimenti resterebbero indeterminabili e indeterminate.
Nel § 44c, Heidegger afferma altresì che “ogni verità è relativa all’essere dell’esserci”, che prima e
dopo l’esserci non c’è verità, che è apertura o scoprimento del mondo nell’esserci: come esempio,
Heidegger dice che le leggi di Newton, il principio di non contraddizione non erano veri prima che
fossero scoperti. L’ermeneutica fenomenologica di Heidegger ha quindi una connotazione
idealistica trascendentale che comunque resta soggettivistica e umanistica, seppure il legame al
soggetto umano non si situi su un piano gnoseologico ma piuttosto di una (pre-)comprensione
ontologica. Heidegger è consapevole che il mondo si incontra prima nella prassi che nel pensiero,
ma nel passare dalla pre-comprensione della prassi alla comprensione ontologica dell’essere,
57
ontologizzando la prassi, Heidegger subordina ancora la prassi alla teoria (ontologica) e riconduce il
mondo stesso alla comprensione ontologica che ne ha l’esserci. Heidegger effettua un doppio
movimento: segue la prospettiva gnoseologica che aveva ricondotto l’ontologia alla gnoseologia,
ma poi ontologizza la gnoseologia. Così, Heidegger crede di poter superare l’aporia che oppone
idealismo e realismo, ma invero, in quanto l’ontologizzazione è comunque teoretica, Heidegger non
riesce a superare il paradigma teoretico greco e resta imprigionato in un soggettivismo
gnoseologico: la sua ontologia resta nascostamente gnoseologia, è gnoseologia travestita;
ontologizzare il soggetto gnoseologico non implica soltanto una contraddizione nel ridurlo a
oggetto, ma anche un ridurre le cose alle forme conoscitive del soggetto umano; anziché evitare i
due errori del realismo e dell’idealismo, Heidegger li compie entrambi34.
La questione dell’essere, riproposta da Heidegger, è, se non la più antica, la questione storicamente
più importante della filosofia occidentale. Da dove ha origine? Essere è un verbo, una parte
fondamentale di un linguaggio umano legato a una scrittura alfabetico-fonetico-lineare, un concettorelazione fra altre parole-concetti, il concetto più generale che è incluso nella definizione di tutti gli
altri concetti che esprimono invenzioni fantastiche, enti puramente linguistici o pensati, o cose reali.
Questo concetto ha assunto un significato filosofico per l’interpretazione della Physis/Natura, a
partire dalla teorizzazione del divenire e del mutamento da parte di Eraclito in termini di essere e di
non essere, e poi dell’immutabilità da parte di Parmenide in termini di essere. Martin Heidegger,
seguendo la scia di Søren Kierkegaard, ha cercato di ridare concretezza all’essere, in
un’interpretazione ontologica dell’esistenza: non si tratterebbe più di un concetto teoretico, ma ciò
che solo è irriducibile a concetto, che resta quando sospendiamo tutti i concetti e tutte le teorie.
Questa concretezza però può sussistere solo intendendo l’essere come “essere qualcosa o
qualcuno”, in una sua determinazione singolare, individuale. Tuttavia, nel momento stesso in cui
34
G. CALOGERO, Leggendo Heidegger, in Rivista di filosofia XLI, n.2 (1950), pp. 136-149; poi ristampato nella
seconda edizione de La scuola dell’uomo, in Scritti di Guido Calogero I, Sansoni, Firenze 1956, pp. 231-249.
58
Heidegger pone come fondamentale, invero già in Sein und Zeit,35 la differenza ontologica tra
essere ed ente, astrae l’essere dall’ente, considera l’essere come indeterminato e quindi lo riduce a
concetto, a universale seppure non esistente platonicamente in sé, ma sempre connesso a un
individuo: non basta dire che l’essere è sempre l’essere di un ente, perché nel dire questo non si
specifica mai l’essere nella singolarità dell’ente cui si riferisce, tanto da poterlo pensare come essere
(generale, universale) degli enti.
Essere un particolare essere umano è diverso dall’essere un altro essere umano, come essere un
essere umano è diverso dall’essere una farfalla: perché l’essere sia concreto non può essere neanche
un universale di specie, deve essere considerato sempre e comunque nella sua singolarità
individuale. Nella originaria comunanza-partecipazione dell’essere a tutti gli enti, Heidegger
sperava di dare un fondamento ontologico-trascendentale all’etica, implicata nell’originario conessere sicuramente degli esseri umani; eventualmente estendibile illimitatamente, anche oltre
Heidegger, a un con-essere di tutti gli enti: un fondamento ancora più profondo, trascendentale,
precedente alla, e indipendente dall’osservazione empirica, fatta propria dalla teoria evoluzionistica
dell’origine delle specie, di una comune e unica origine di tutti gli esseri viventi.
Purtroppo, questa fondazione trascendentale ontologica escogitata da Heidegger per l’etica si è
rivelata illusoria. L’essere di Heidegger si è dimostrato un concetto etno-linguisticamente e
storicamente determinato all’interno degli sviluppi di un’etno-filosofia greca.
Guido Calogero aveva già fatto notare che quella di Heidegger era una metafisica neo-parmenidea,
e che quelle di Eraclito e Parmenide erano delle proto-logiche ontologizzate, delle onto-logiche
sorte da un’ipostatizzazione della più comune funzione verbale.36 Se l’essere è questa
35
M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Niemeyer, Tübingen 1927, 2001; a cura di F.-W VON HERMANN, in Gesamtausgabe,
vol. II, Klostermann, Frankfurt am Main 1977 (la prima con le glosse a margine dell’Hüttenexemplar di Heidegger); tr.
it. di P. CHIODI, Essere e tempo, Longanesi, Milano 1970, con aggiornamento bio-bibliografico di A. MARINI 1976;
nuova edizione italiana a cura di F. VOLPI sulla versione di P. CHIODI con le glosse a margine dell’Hüttenexemplar
(esemplare della baita) di Heidegger, Longanesi, Milano 2005; tr. it., con testo tedesco a fronte, di A. MARINI, Essere e
tempo, Mondadori, Milano 2006; E. GIANNETTO, Un fisico delle origini. Heidegger, la scienza e la Natura, Donzelli,
Roma 2010.
36
G. CALOGERO, Studi sull'eleatismo, Tipografia del Senato, Roma 1932, seconda edizione, La Nuova Italia, Firenze
1977; G. CALOGERO, Parmenide e la genesi della logica classica, in Annali della Regia Scuola Normale Superiore di
Pisa, serie II, v. 5 (1936), pp. 143-185; G. CALOGERO, Storia della logica antica, Laterza, Roma-Bari 1967.
59
ipostatizzazione indebita, allora la filosofia non è rivelazione dell’essere, pensiero dell’essere, e il
linguaggio non è la dimora dell’essere né una sua rivelazione: il logos greco, presocratico, della
physis, era solo un discorso umano, un logo umano proiettato sulla Natura; solo il logos cristiano
era carne, era vita, era amore, era rivelazione e non può essere ricompreso insieme a quello greco.
Lo stesso pensiero dell’essere di Heidegger si è manifestato quale un mero ferro ligneo, che aveva
tentato di mettere insieme intellettualismo greco e prassi etica d’amore del Cristianesimo: la
rivelazione di Dio nella Natura non si può pensare in termini della physis greca ridotta
intellualisticamente a un logos ontologico.
Se l’essere è questa ipostatizzazione indebita, allora la storia degli enti e dell’esserci umano o
dell’umanità non è riconducibile storia dell’essere, come fa Heidegger dopo la svolta degli anni
trenta, traducendo nel suo linguaggio ontologico la ‘storia dello spirito’ di Hegel; né la storia
concreta dell’esistere umano può essere compresa in termini di una sua fondazione trascendentale
nella storia dell’essere che ne determinerebbe così le condizioni di possibilità: con la conseguente
de-responsabilizzazione dell’individuo umano dalle sue scelte esistenziali, perché condizionate
dallo stesso essere che determina la storia mondiale dell’umanità. Questa prospettiva filosofica della
storia trascendentale dell’essere permette di capire perché Heidegger non si sia mai scusato del
proprio errore dell’adesione al nazismo: non solo la verità, secondo Heidegger, appartiene
all’essere, ma anche l’errore ha un suo fondamento ontologico; è l’essere stesso che nell’umanità
erra e si oblia, come massimamente nell’età moderna della tecnica distruttrice di cui il nazismo
sarebbe solo un epifenomeno.
60
8. Fra Heidegger e Marx
Fra gli allievi di Heidegger, alcuni hanno tentato di mettere insieme marxismo e filosofia di
Heidegger. Il nucleo più importante della filosofia di Heidegger fu identificato nella critica della
scienza moderna e della tecnica come dominio della Natura e degli altri esseri viventi. Si trattava di
superare il presupposto tecnico-economico che caratterizzava la concezione dell’essere umano
proposta da Marx, strettamente legato al lavoro, come attività tecnica di trasformazione della Natura
che riduceva la Natura a valore d’uso dell’umanità. Una qualche critica della scienza e della tecnica
era stata in qualche modo già proposta da Gyӧrgy Lukacs (1885-1971) in Storia e coscienza di
classe (1923), all’origine del marxismo occidentale. La critica della razionalità scientifico-tecnica,
strumentale, fu sviluppata però soprattutto dagli allievi ebrei di Heidegger della cosiddetta Scuola di
Francoforte. Herbert Marcuse (1898-1979) fin dagli anni trenta aveva cercato di sviluppare un
Heidegger Marxismus, che poi rielaborò ancora senza però più citare Heidegger in maniera
rilevante: troppo forte era stato il “tradimento” di Heidegger con la sua adesione al nazismo e con il
non riconoscere pubblicamente il proprio errore. In Marcuse si tenta anche di mettere insieme
freudismo e marxismo: in Eros e Civiltà (1955) vi è la reinterpretazione della liberazione marxiana
del lavoro in termini di liberazione dal lavoro (tecnico); contrariamente a quanto affermato da
Freud, è possibile una civiltà che non reprima l’eros, la pulsione vitale da Freud individuata quale
caratteristica fondamentale della psiche. L’uomo a una dimensione. L'ideologia della società
industriale avanzata (1964) ebbe grande importanza anche per il movimento di rivolta del 19661968: Marcuse caratterizzava il movimento studentesco come nuova “classe rivoluzionaria”. La
storia dell’essere heideggeriana veniva tolta dal suo piedistallo trascendentale e concretizzata in
termini della storia economica occidentale: si passava dalla struttura ontologica trascendentale
dell’esistenza umana alla struttura economica concreta che determina la struttura delle società
umane. L’oblio dell’essere che caratterizza l’età moderna della tecnica è legato allo sviluppo del
capitalismo moderno, che costituisce un apriori storico tecnico-economico come “trascendentale
materiale”, che fa sì che dominio tecnico della Natura e dominio dell’uomo sull’uomo siano
61
strettamente connessi: inautenticità dell’esserci heideggeriano e alienazione marxiana vengono
identificate; l’essere umano viene ridotto a una sola dimensione consumistica, anche nel pensiero
che ne è ideologia (la filosofia analitica soprattutto che si limita a un’analisi conservatrice del
linguaggio che è espressione di potere e di dominio). Marcuse delinea anche un processo
rivoluzionario di liberazione che implica una rivoluzione del linguaggio del pensiero (Saggio sulla
liberazione, 1969).
Max Horkheimer (1895-1973) e Theodor Wiesegrund Adorno (1903-1969) sviluppano la loro
critica della tecnica e della razionalità scientifica illuministica soprattutto in Dialettica
dell’illuminismo (1947). Horkheimer e Adorno sono estremamente critici nei confronti di
Heidegger, ma in effetti ne riprendono la visione critica della scienza e della tecnica in una maniera
molto simile e parallela a quella di Marcuse. Adorno non tiene conto che la prospettiva di
Hediegger si basa tutta sulla distruzione dei concetti della tradizione filosofica e teologica, e lancia
l’accusa che Heidegger rinuncerebbe all’analisi dei concetti e del pensiero critico; tuttavia, la
negativizzazione della dialettica operata da Adorno, che elimina da quella il momento sintetico,
sembra dipendere dalla distruzione dei concetti operata da Heidegger e dalla sua reinterpretazione
della storia hegeliana da rivelazione positiva a rivelazione negativa (oblio) dell’essere. 37
C’è una critica generica e aprioristica, da parte di Adorno, della metafisica ontologica dell’essere di
Heidegger: il banale fatto che viola la filosofia di Kant viene presentato come un errore di
Heidegger, ma l’ontologizzazione del trascendentalismo kantiano operata da Heidegger è un’altra
prospettiva; che nell’esserci di Heidegger si effettui anche una trascendentalizzazione
dell’esperienza non lo distingue da Kant; che Heidegger non segua il metodo dialettico non può
essere in sé un’obiezione e non se ne può dedurre che si tratti di un “pensiero dell’identità”; la
37
TH. W. ADORNO, Negative Dialektik, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1966; tr. it. di C. A. DONOLO, Dialettica
negativa, Einaudi, Torino 1970. Si vedano anche: TH. W. ADORNO, Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie,
Surkhamp, Frankfurt am Main 1964; tr. it. di P. Lauro, intr. di R. Bodei, Il gergo dell’autenticità. Sull’ideologia
tedesca, Bollati Boringhieri, Torino 1989; TH. W. ADORNO, Philosophische Terminologie, I-II, Surkhamp, Frankfurt am
Main 1973; tr. it. di A. Solmi, Terminologia filosofica, I-II, Einaudi, Torino 1975; M. HORKHEIMER & TH. W. ADORNO
(1944, 1947), Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1969; tr. it. di
R. SOLMI, introduzione di C. GALLI, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino 1966, 1997.
62
critica ideologica marxista di idealismo vale altrettanto poco. Si tratta di critiche che cercano di
mostrare delle inconsistenze nel pensiero di Heidegger, ma non dall’interno: vengono effettuate
dalla presupposizione di un’altra filosofia.
La critica dell’essere come ipostatizzazione della forma grammaticale della copula non è originale
ed è sicuramente desunta dagli studi critici parmenidei.38
Tuttavia, la critica di Adorno ad Heidegger è pure in gran parte aggressiva, disordinatamente
insistente, ripetitiva, eccessiva, ideologica, pretestuosa e falsa. Adorno diverte le argomentazioni
razionali critiche nell’identificazione sarcastica di un presunto gergo dell’autenticità di Heidegger
che nasconderebbe pure romanticismo agrario (anche attraverso una banalizzazione di poesie di
Heidegger), idealismo borghese, banalità, tautologie, violenza, conservatorismo e nazismo. Adorno
straparla
sì
in
un
gergo
pseudoconcettuale
e
pseudofilosofico,
pseudosociologico
e
pseudopsicologico, che dà aura intellettuale a un mero spirito di risentimento e di vendetta dettato
da odio ideologico: effettua connessioni deliranti, mascherandole di razionalità, per il puro gusto di
annientare Heidegger, presentato come nichilista che effettua una pseudo-teodicea della morte, solo
perché fa della morte la cifra della finitezza costitutiva dell’esserci.
Questo significa non volersi confrontare effettivamente con Heidegger per nascondere forse il fatto
che tutta la critica della razionalità illuministica moderna, della razionalità strumentale e tecnica e
del conseguente dominio sulla Natura, condotta da Adorno insieme ad Horkheimer, è copiata,
trasposta-incollata in ambito marxista, e rielaborata a partire da Heidegger: Adorno ed Horkheimer
hanno capito bene che tutta la critica della modernità effettuata da Heidegger poteva essere
presentata senza bisogno di ontologizzazioni, senza bisogno di introdurre il concetto di essere,
formulando il tutto nei termini della critica del dominio della Natura. In fondo, pur se non lo
38
Questa critica a Parmenide è svolta nella sua forma più piena negli studi di Guido Calogero (che poi la ripresentò
brevemente in un saggio su Heidegger del 1950: G. CALOGERO, Leggendo Heidegger, in Rivista di filosofia XLI, n.2
(1950), pp. 136-149; poi ristampato nella seconda edizione de La scuola dell’uomo, in Scritti di Guido Calogero I,
Sansoni, Firenze 1956, pp. 231-249), che ebbero risonanza internazionale e che già nel 1938 furono presentati in
Germania da una recensione di Kurt von Fritz, ristampata nell’edizione tedesca del 1970 e poi nella seconda italiana del
1977: G. CALOGERO, Studi sull'eleatismo, Tipografia del Senato, Roma 1932, seconda edizione La Nuova Italia, Firenze
1977; tr. ted. di W. Raible, Studien über den Eleatismus, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1970 & Olms,
Hildescheim-New York 1970.
63
avrebbero mai ammesso, la dialettica negativa (legata a Kierkegaard e Heidegger; non è un caso che
tutta la prima parte è dedicata alla critica dell’ontologizzazione della filosofia operata da Heidegger)
e la dialettica dell’illuminismo non sono altro che forme di Heidegger-Marxismus, come quella di
Marcuse, e non potrebbero essersi originate (non basta l’opera di Gyorgy Lukacs per comprenderle)
e non potrebbero essere comprese se non nei termini di una variante eretica heideggeriana del
marxismo ortodosso.
La sintesi operata da Jean-Paul Sartre (1905-1980) fra marxismo e heideggerismo si articola
soprattutto intorno alle radici esistenzialistiche del pensiero di Heidegger, svolte in termini
puramente ateistiche a partire dall’occultamento operato da Heidegger nei confronti della matrice
cristiana kierkegaardiana. Sartre riuscì a diffondere l’esistenzialismo al di là dell’ambito filosofico
non solo per la sua coniugazione con l’impegno politico marxista, ma anche per la sua traduzione in
opere letterarie e teatrali di grande suggestione, di cui il romanzo La nausea (1938) (traduzione
dell’angoscia e della noia esistenziali di Heidegger) rappresenta il momento più espressivo (vinse il
premio Nobel per la letteratura nel 1964, che con atto politico rifiutò).
64
9. La filosofia matematica
La nascita delle geometrie non-euclidee nella prima parte dell’Ottocento fu all’origine della crisi dei
fondamenti della matematica. Karl Friedrich Gauss (1777-1855) diede i primi decisivi contributi:
dal 1813 sviluppò una geometria coerente con la proprietà che la somma degli angoli interni di un
triangolo sia < 180° e che chiamerà prima “anti-euclidea”, poi “astrale”, infine
“non-euclidea”;
caratterizzata da curvatura negativa, descrive uno spazio “aperto”, applicabile ad una superficie a
sella; la differenza rispetto ai 180° è proporzionale all’area del triangolo; nel
1827, misurò la
somma degli angoli del triangolo formato da tre vette montuose (Brocken, Hohehagen, Inselberg),
ma gli errori di misura e la
relativa piccolezza del triangolo impedirono una
determinazione
sperimentale della geometria dello spazio fisico. Nel 1825, Nikolaj Ivanovic Lobacevskij (17391856) fu il primo a pubblicare un’opera su una geometria non euclidea: per un punto esterno a una
retta data non passa una e una sola retta parallela, ma due parallele, la somma degli angoli interni di
un triangolo è < 180°, e si tratta di una geometria “iperbolica”.
Se P è un punto ad una distanza a da una retta r, PD = a,
esiste un angolo &, tale che tutte le rette
che formano con PD un angolo minore di & intersecano r, tutte le rette che formano un angolo
maggiore o uguale ad & non intersecano r. Di queste ultime, le due rette p e q che formano un
angolo & sono dette parallele, le altre non intersecanti, anche se nella geometria euclidea queste
sarebbero chiamate parallele (e da questo punto di vista si potrebbe dire che esistono infinite
parallele passanti per P); & è chiamato angolo di parallelismo. Per & = 90°, si ha l’assioma di
Euclide, ovvero la geometria euclidea è un caso particolare della geometria iperbolica, per raggio di
curvatura infinito (curvatura zero). La fondazione della
geometria è, per Lobacevskij, fisica, a
partire dalle relazioni fra corpi solidi che si toccano in un punto, una linea o una superficie. Le due
geometrie coincidono a meno di infinitesimi di ordine superiore al secondo, il che significa che nel
‘piccolo’, all’interno degli errori di misura si può ancora
considerare valida la geometria euclidea,
mentre, per Lobacevskij, a livello astronomico vale quella iperbolica; e
facile modificare la
nel 1829 ipotizza che sia
meccanica sulla base della nuova geometria. Insieme a Lobacevskij, pubblica
65
sulla geometria iperbolica, nel 1825 e poi nel 1832-33, Jànos Bolyai (1802-1860), ma con
un’impostazione astratta e non fisica. Un’altra geometria fu costruita da Georg Bernhard Riemann
(1826-1866), nel 1854 in una dissertazione, presentata poi nel 1868: si tratta di una geometria
ellittica, a curvatura positiva, che descrive uno spazio “chiuso”,
applicabile ad una superficie
sferica in cui le “rette” sono le circonferenze massime, illimitate ma tutte della stessa lunghezza
finita e si incontrano in due punti; tutte le perpendicolari ad una retta data s’incontrano in un punto;
non esistono rette parallele e la somma degli angoli interni di un triangolo è > 180°.
La nascita delle geometrie non-euclidee implicava una pluralità di geometrie, tutte rigorosamente
fondate. La non-univocità della geometria comportava un’incertezza nei fondamenti della
geometria, ma anche della scienza moderna: la matematizzazione della fisica all’alba della scienza
moderna si era basata sulla geometria euclidea.
Si pensò che i fondamenti della matematica restassero inviolati al livello dell’aritmetica e
dell’algebra, se non della geometria. Tuttavia, William R. Hamilton nel 1843 aveva creato l’algebra
non-commutativa dei quaternioni, e poi Arthur Cayley quella delle matrici: si trattava della
costruzione di “numeri generalizzati”, sui quali si costituivano nuove aritmetiche e nuove algebre.
Si dava così una pluralità di aritmetiche e di algebre possibili, che comportavano un’incertezza
ancora più profonda nei fondamenti della matematica e di tutta la scienza moderna basata
sull’aritmetica e sull’algebra. Hermann von Helmholtz (1821-1894), nel 1868,
fondazione della geometria euclidea sulla
tentò una nuova
meccanica newtoniana dei corpi solidi rigidi e, nel
1887, affermò che anche le verità degli assiomi dell’aritmetica non sono a priori, ma dipendono
dall’esperienza.
A partire dalle formulazioni della teoria degli insiemi finiti e infiniti-transfiniti di Georg Cantor
(1845-1918), si tentò di fondare tutta la matematica sulla teoria degli insiemi. La teoria degli
insiemi si presentava non solo come la base di una teoria dei numeri e della geometria, ma anche
come una matematica teoria delle idee, o dei concetti: come il numero 2, per esempio, poteva essere
definito come l’insieme che contiene tutte le tipologie dell’essere 2 (due mele, due pere, due cani,
66
due gatti, due uomini,...), definibile intensivamente come ciò che è comune agli elementi
dell’insieme, così anche il concetto di cane può essere definito come l’insieme di tutti i tipi di cane,
o ciò che è comune a tutti gli elementi dell’insieme (bassotto, barboncino, bull-dog, alano,...).
Tuttavia, a partire dall’assiomatizzazione di Ernst Zermelo (1871-1953) fino alla più recente
dimostrazione del 1966 di Paul Cohen (1934-2007), anche della teoria degli insiemi si stabilì la
possibilità di costruirne una pluralità, che non permetteva di identificare un fondamento univoco.
Ancora più recentemente, Abraham Robinson (1918-1974) costruì nel 1963 anche un’analisi nonstandard, basata sull’accettazione dei differenziali di Leibnitz. La non univocità diventa una
caratteristica di tutta la matematica.
Già nel 1854, intanto, in The Laws of Thought, George Boole (1815-1864) era riuscito a dare forma
algebrica alla logica realizzando in qualche modo il progetto della mathesis universalis di Descartes
o della characteristica universalis di Leibnitz. La logica si trasformava da logica filosofica a logica
matematica, riportando in qualche modo la logica alla sua origine matematica.
Tuttavia, questa costruzione portò alla convinzione di poter risolvere il problema dei fondamenti
della matematica risalendo alla logica come fondamento univoco e certo. La prospettiva che ne
conseguì fu chiamata logicismo ed ebbe la sua massima espressione nei Principia Mathematica
(1910-1913) di Bertrand Russell (1872-1970) e Alfred North Whitehead (1861-1947).
Al logicismo si opposero il formalismo di David Hilbert (1862-1943), che considerava la
matematica come un mero gioco formale di simboli senza significato in una prospettiva finitista che
rifiutava la nozione di infinito, e l’intuizionismo di Luitzen Brouwer (1881-1966), che fondava la
matematica su un’intuizione del pensiero che ne precedeva ed eccedeva la formalizzazione. La
formalizzazione dell’intuizionismo fu compiuta definitivamente da Arend Heyting (1898-1980):
questa portò alla realizzazione di una logica matematica costruttiva e di una matematica costruttiva,
alternative a quelle standard, in cui non vale più il principio del terzo escluso e non sono ammesse
le dimostrazioni per assurdo, o ancora non è più definibile lo zero o un infinito in atto diverso da
quello potenziale.
67
Ciò nonostante, Russell non accettava di lasciare il “paradiso” dei transfiniti creati da Cantor e
aveva fornito un’interessante interpretazione nominalistica della teoria degli insiemi, e quindi dei
numeri e dei concetti ridotti all’insieme degli individui singoli che ne costituiscono gli elementi,
senza riferimento all’astratta proprietà comune. Il logicismo, però, fallì già nel momento in cui,
indipendentemente dalla logica intuizionistica, si scoprì che era possibile costruire logiche diverse
da quella aristotelica-crisippea: si dava una pluralità di logiche e quindi un’incertezza nei
fondamenti della logica e quindi di tutta la scienza moderna.
Ciò nonostante, la matematizzazione della logica ebbe come conseguenza il tentativo di costruire
una filosofia matematica, basata su un’analisi logico-matematica del linguaggio. Russell in
Introduzione alla filosofia matematica (1919) ne delineò le caratteristiche fondamentali.
Sembrava possibile così trasferire il rigore della matematica a tutto il pensiero filosofico. Di questa
prospettiva, l’opera più rappresentativa è il Tractatus-logico-philosophicus (1921) di Ludwig
Wittgenstein (1889-1951). Per Wittgenstein, si tratta di riconoscere i limiti di esprimibilità del
pensiero, che sono dati dai limiti del linguaggio, rigorosamente analizzato in termini logicomatematici. Gli enunciati della logica e della matematica sono considerati “analitici”, cioè veri
apriori: per essere tali non possono che essere delle tautologie, ovvero non fanno altro che
esplicitare quanto è implicito nei loro termini. Gli altri enunciati devono concernere il mondo come
totalità dei fatti attingibili dall’esperienza, come tutto ciò che accade, come la totalità degli stati di
cose sussistenti: essi raffigurano il mondo, non in termini iconici, ma in termini logici, con
immagini logiche, cioè è possibile istituire fra essi e il mondo dei fatti una corrispondenza
biunivoca, matematicamente definita. Questa corrispondenza è possibile se la forma logica degli
enunciati coincide con la forma della realtà. Gli enunciati sono veri o falsi a seconda che lo stato di
cose affermato sussista nel mondo o no. Nessi causali fra i fatti non sono fatti, sono quindi residui
metafisici che vanno eliminati dalle scienze naturali. Tutto ciò che si afferma oltre i fatti è
metafisica, ed è insensato. La filosofia non è altro che il chiarimento di ciò che può essere detto
all’interno di un linguaggio rigorosamente costruito in termini logico-matematici: si tratta di una
68
cura che elimini le “malattie” del linguaggio, mostrando l’insensatezza degli enunciati della
metafisica.
Gli enunciati del linguaggio esprimono come il mondo è, ma “che il mondo è” non è oggetto di
possibile riflessione filosofica è il mistico, resta cioè qualcosa di ineffabile. La filosofia si deve
quindi arrestare di fronte ai limiti del linguaggio e riconoscere che c’è qualcosa di indicibile: su ciò
di cui non si può parlare si deve tacere. La filosofia si arresta quindi di fronte a tutti i problemi che
costituiscono il senso dell’esistenza umana, che è razionalmente inattingibile. Anche l’attribuzione
di valori alle cose è affermare qualcosa che va oltre i fatti, ma non è insensato allo stesso modo
della metafisica: l’etica non può essere una disciplina filosofica, ma solo una prassi di vita. Così,
svolto il suo compito di chiarificazione, la filosofia si può autodissolvere, come si può togliere via
una scala, dopo che si è saliti nel luogo in cui si voleva arrivare. E così lo stesso Wittgenstein si
allontanò dalla filosofia, facendo vari lavori.
Tornò alla riflessione filosofica solamente quando si rese conto che era necessaria una nuova
impostazione del problema filosofico, cosa che portò da ultimo alla stesura delle Ricerche
filosofiche, pubblicate postume (1953). Wittgenstein si rese conto che la pluralità delle logiche
matematiche non consentiva la costruzione di un pensiero filosofico, fondato sull’univocità della
logica matematica. Si presentava ormai una pluralità di “giochi linguistici”, che non potevano
contare su un fondamento razionale univoco che ne privilegiasse uno sugli altri. Non esistendo un
fondamento razionale univoco, l’esistenza di una pluralità di giochi linguistici può essere compresa
solo in termini di radici storiche e antropologiche: non c’è più una sola forma logica che
corrisponde alla forma della realtà, ma la pluralità delle forme linguistiche corrispondono alla
pluralità delle forme di vita umana che le generano. La pluralità delle forme linguistiche si dà
quindi in corrispondenza alla varietà storica e antropologica delle forme di vita umana. La filosofia
occidentale stessa non è altro quindi che un prodotto etnico-culturale, una etno-filosofia. La scienza
è un’etno-scienza, la matematica un’etno-matematica, che varia da cultura a cultura, da una forma
di vita a un’altra.
69
L’esito della filosofia matematica è in Wittgenstein alla fine lo stesso crollo della metafisica
occidentale, già accertato, con diversi strumenti, dall’esito della filosofia in Nietzsche o in
Kierkegaard.
Contemporaneamente all’opera di Wittgenstein, e in parte anche da questa influenzata, si sviluppò
la filosofia del cosiddetto “neo-positivismo logico” o “neo-empirismo logico”, soprattutto nei due
centri di Wien e di Berlin, dove si crearono dei veri circoli filosofici. Del circolo di Vienna, fra altri,
si può ricordare Rudolf Carnap (1891-1970) che, nel 1928, pubblicò Der logische Aufbau der Welt
(La costruzione logica del mondo). Più originale il contributo di Hans Reichenbach (1891-1953),
del circolo di Berlino, perché più a dentro nelle rivoluzioni della fisica di quegli anni. Già nel 1920,
con Relativitätstheorie und Erkenntnis apriori (Teoria della relatività e conoscenza a priori),
gettava le basi della critica del trascendentalismo kantiano a partire dalla determinazione
aposteriori, dall’esperienza-esperimento della geometria del mondo come una cronogeometria noneuclidea a quattro dimensioni. In Philosophie der Raum-Zeit-Lehre (Filosofia dello spazio e del
tempo), nel 1928, Reichenbach poteva affermare la relatività della stessa geometria, e, nel 1944,
con I fondamenti filosofici della meccanica quantistica, affermare la determinazione aposteriori,
dall’esperienza-esperimento, della stessa logica del mondo che si rivela una nuova logica
quantistica con un terzo valore di verità indeterminato, oltre il vero e il falso. La sua prospettiva fu
poi sintetizzata in La nascita della filosofia scientifica (1951).
Nel frattempo, il cosiddetto teorema di Leopold Lӧwenheim (1878-1957) e Thoralf Skolem (18871963) aveva stabilito la non-adeguatezza espressiva, la non-caratterizzabilità e non-unicità dei
modelli (esistono anche modelli non-isomorfi) per teorie formali con finanche un numero infinito
numerabile di assiomi (pari cioè al numero infinito dei numeri naturali): l’ambiguità semantica non
è solo del linguaggio naturale, ma anche della matematica.
Tuttavia, l’esito finale della filosofia matematica è però dato soprattutto dai due teoremi
rivoluzionari di Kurt Gӧdel (1906-1978), formulati nel 1930 e nel 1931. Si tratta di due teoremi
che si applicano a una qualunque teoria formale che parta finanche da un numero infinito
70
numerabile di assiomi. Gӧdel dimostra un primo teorema per cui una tale teoria è sempre
incompleta, cioè al suo interno si presentano sempre degli enunciati indecidibili, di cui non si può
dimostrare né la verità né la falsità. E un secondo teorema per cui all’interno di una tale teoria non
si può mai dimostrare l’enunciato che attesta la sua non-contraddittorietà.
Questi teoremi mostrano che all’interno della stessa logica matematica si può sviluppare una
riflessione formale (meta-matematica) sui limiti della matematica stessa (non solo dell’approccio
formalista hilbertiano). Come il teorema d’indeterminazione di Werner Heisenberg (1901-1976),
formulato nel 1927, costituiva una riflessione formale sui limiti della fisica stessa, della misurabilità
sperimentale e della calcolabilità matematica delle grandezze fisiche a livello microscopico.
I teoremi di Gӧdel dimostrano però i limiti di una qualunque teoria scientifica: la scienza non può
costituire un sapere assoluto, completo e certo della propria non-contraddittorietà. Anche la scienza
moderna non ha quindi comunque un fondamento certo. Questa non è solo una debolezza della
scienza moderna, ma anche la sua forza, perché dimostra la possibilità di mettere in discussione
criticamente i propri fondamenti.
D’altra parte, i limiti della razionalità scientifica, quale forma più rigorosa di razionalità, sono i
limiti della stessa razionalità filosofica: neanche una teoria filosofica può basarsi su un numero di
principi-assiomi maggiore dell’infinito numerabile, data la finitezza di ogni possibile costruzione
razionale umana. I teoremi di Gӧdel rappresentano così la più rigorosa dimostrazione del crollo
della metafisica occidentale.
La filosofia analitica contemporanea, che si rifà all’ideale della filosofia matematica di un’analisi
rigorosa del linguaggio su una base logico-matematica, non ha mai tenuto conto dell’impossibilità
di un fondamento univoco di un sapere assoluto, completo e certo della propria noncontraddittorietà.
71
10. La condizione post-moderna
Le reazioni di Husserl ed Heidegger alla crisi del pensiero filosofico moderno, pur nella loro
parziale originalità, non costituivano che la riproposizione di precedenti metafisiche e non hanno
potuto arginarla che momentaneamente. Nel frattempo, la crisi delle scienze è esplosa, nella prima
metà del Novecento, in una serie di rivoluzioni fra cui spiccano quelle della fisica, quali le teorie
della relatività, la fisica dei quanti.
D’altra parte, gli eventi storici della seconda guerra mondiale con la soluzione finale dello sterminio
di milioni di ebrei, il cui simbolo è Auschwitz, hanno decretato nei fatti il crollo del paradigma
dominante della modernità quale auto-affermazione dell’umanità occidentale nel dominio tecnico
della Natura con la falsificazione dei suoi miti di progresso e di emancipazione politica. A questi
eventi ne sono poi seguiti altri che hanno ulteriormente aggravato la situazione: primi fra tutti, la
falsificazione del marxismo nell’esito sovietico e la crisi ecologica. L’abisso del male del mondo si
è riaperto in una forma ancora più sconvolgente.
Questo crollo del paradigma dominante della modernità può essere interpretato o nel senso
dell’apertura di una nuova fase della modernità, una tardomodernità in cui possono acquisire nuova
rilevanza paradigmi prima minoritari, o nel senso dell’apertura di una nuova età post-moderna. Le
due locuzioni alternative enfatizzano rispettivamente maggiori elementi di continuità o di
discontinuità rispetto alla modernità, ma corrispondono comunque a una stessa situazione storica.
10.1 Jean-François Lyotard e la fine delle grandi narrazioni
Jean-François Lyotard (1924-1998) ha caratterizzato questa situazione come la “condizione postmoderna” (La condizione post-moderna. Rapporto sul sapere, 1979): si tratterebbe, dal punto di
vista filosofico, della fine delle “grandi narrazioni” o dei “metaracconti”, ovvero delle “ideologie”,
cioè di quei sistemi di pensiero religiosi, filosofici, scientifici, psicoanalitici, tecnico-economici o
politici, che, presentandosi come fondati su principi assoluti, cercavano di legittimare la prassi di
vita umana. Si tratterebbe cioè della fine non solo della fede religiosa come sistema di pensiero,
come all’origine della modernità, ma anche di tutti quei sistemi di pensiero laici che ne avevano
72
preso il posto e che si rivelano quali altrettante forme di fede laica senza fondamento teoretico.
Questi sistemi sono caduti sotto il peso di una critica teorica interna dei fondamenti e di una critica
esterna che li ha falsificati nella prassi sullo scenario della storia stessa.
Quello che ne risulta è non solo la frammentazione dei saperi che non possono essere più
onnicomprensivi, la loro pluralità irriducibile, ma anche la loro temporalizzazione e la
localizzazione, la loro etnicizzazione, la loro relativizzazione in termini di pratiche discorsive o non
discorsive legate a forme di vita e a contesti etnico-culturali senza fondamento teoretico. La
trasformazione delle nostre società in società multiculturali e multietniche, a partire dalla seconda
metà del Novecento, ha portato alla relativizzazione non solo della religione, ma anche della
filosofia e delle scienze.
10.2 Roland Barthes e la semiologia contro l’impero dei segni
Roland Barthes (1915-1980) elabora una semiologia come studio generale della cultura (Elementi di
semiologia, 1964) all’interno del linguaggio in cui è possibile comprendere le diverse forme di
segni: una scienza dei segni, una semiologia è possibile solo a partire dalla linguistica, perché vi
sono immagini e altri tipi di simboli che sono asemantici e acquistano un significato solo quando
ricondotti al linguaggio verbale; si tratta di un ribaltamento della prospettiva desaussuriana. Già a
partire da questa riflessione si può notare come al massimo la prospettiva di Barthes si possa
definire come post-strutturalista, e non strutturalista.
La cultura umana, come insieme di saperi teoretici e saperi pratici che sono legati a un saper fare e
hanno aspetti di “materialità”, può essere considerata come una gerarchia di sistemi semiotici. La
cultura umana non è un semplice riflesso sovrastrutturale di una certa forma di vita con le sue
strutture economiche ma nella sua “materialità” tecnica svolge essa stessa un ruolo strutturale
primario nell’organizzazione della vita umana. Non solo: tutta la vita sociale ed economica si
costituisce nel linguaggio come un sistema di segni; tutto allora è struttura e sovrastruttura. La
gerarchia interna in cui si articola è legata al fatto che alcuni sistemi semiotici, corrispondenti a certi
73
saperi disciplinari, svolgono un ruolo di fondamento e di legittimazione degli altri e della
complessiva forma in cui si organizza la vita umana.
Per lungo tempo nella storia dell’occidente, ma non solo, la religione, come pratica cultuale e come
sapere teoretico quale teologia, ha costituito il sistema semiotico di fondamento di tutti gli altri e di
riferimento per l’organizzazione della vita umana dei segni; dopo questo ruolo è stato svolto anche
dalla politica e dalla scienza moderna. Si è passati così mitologie e ideologie religiose “verticali”
che hanno costituito delle metafisiche pansemiotiche religiose, a delle mitologie e ideologie socioeconomico-politiche “orizzontali” che hanno costituito nuove metafisiche pansemiotiche sociali
(Mythologies, 1957), in cui tutto rimanda non più a Dio secondo la prospettiva della signatura
rerum, ma direttamente a un ordine socio-economico-politico, che non ha più bisogno di una
legittimazione divina.
La semiologia diventa così semioclastia, in una prospettiva di riforma del marxismo,
smascheramento dei meccanismi di significazione dell’ideologia che manipola le coscienze e le vite
e che legittima i poteri, le violenze, le ingiustizie: la mitologia e l’ideologia si presentano come
significazioni comuni, innocenti nella finzione di relazioni naturali e non arbitrarie fra significante e
significato, spaziano dagli articoli giornalistici alle pubblicità, dalle immagini di copertina alla
moda vestiaria, dai cibi ai costumi, dal cinema o dalla letteratura commerciale ai saggi divulgativi o
conservatori, tutte cose che legittimano le convenzioni delle società borghesi. La mitologia e
l’ideologia
sono
sistemi
semiologici
secondari
che
si
strutturano
su
altri
pre-esi
stenti, veicolano significazioni parassite di altre che si innestano nel linguaggio e che riducono ad
altri significati superiori a partire da una presunta (ma invero arbitraria) iconicità asemantica che
rimanda a un ordine di poteri, instaurando, materialmente e idealmente, un impero dei segni
(L’impero dei segni, 1970).
Il linguaggio stesso è “fascista” (Lezione, 1977), impone un certo tipo di dire che riflette una
gerarchia di poteri diffusi. Se l’oriente giapponese, attraverso l’influenza del buddhismo zen, induce
a nientificare il potere dei segni nel vuoto, tendendo a una de-semiotizzazione della realtà, anche
74
questa de-semiotizzazione può essere giocata a sostegno dei poteri. Oltre lo smascheramento della
semiologia, è la letteratura, la scrittura poetica che contrasta la microfisica del potere che è attiva
nel linguaggio, smascherandola e decostruendola. Seppure la riflessione di Barthes sulla scrittura è
stata riassorbita nel decostruzionismo di Derrida e la prospettiva di Derrida non sarebbe
comprensibile senza l’analisi di Barthes, la prospettiva è molto diversa. La morte dell’autore (1968)
teorizzata da Barthes è molto diversa da quella strutturalista, foucaultiana e derridiana: quello che è
eliminato è l’autore esterno al testo, a favore di un autore che è rintracciato all’interno della scrittura
stessa, nelle varie funzioni discorsive come quella dell’io narrante o altre corrispondenti meno
dirette. La morte dell’autore è un atto volontario dell’autore che nella vera scrittura letteraria
trascende sé stesso e consegna la propria vita agli altri, decide di vivere nel senso che gli daranno
gli altri in una polifonia.
La scrittura di Barthes diventerà negli ultimi anni, anche a causa del lutto della madre nel 1977 che
sarà per lui devastante, sempre più personale, non più teoretica-descrittiva, ma costituita da testi in
cui la sua riflessione è direttamente connessa alla sua vita (Frammenti di un discorso amoroso,
1977; La camera chiara, 1980). Qui è Barthes, che, da innamorato, da persona coinvolta, contro i
discorsi ideologici e di potere, che parla d’amore, imbastisce frammenti di un discorso amoroso in
una società che non gli dà più valore, e opera una transvalutazione dei valori borghesi per cui la
sentimentalità dell’amore è equiparata a oscenità; è Barthes che direttamente, da persona in lutto,
parla della morte in una società che la esorcizza e la rimuove considerandola oscena come l’amore,
e opera una semiotropia, una trasformazione dei segni che, come le fotografie singolari, come la
foto del giardino d’inverno della madre,fanno risorgere i morti a una vita nuova.
10.3 Gilles Deleuze e Felix Guattari
Gilles Deleuze (1925-1995), filosofo, e Felix Guattari (1930-1992), psicoterapeuta anomalo,
tentarono invece di costruire una filosofia che mette insieme differenti istanze provenienti dalla
scienza moderna, dall’arte, dalla psicoanalisi esistenziale, dal marxismo e dalla filosofia di
75
Nietzsche. Deleuze (Nietzsche e la filosofia, 1962; Differenza e ripetizione, 1968) si era posto il
problema di salvare l’alterità senza ridurla all’identità, di rispettare la differenza senza ridurla
all’uguaglianza. La dialettica hegeliana o marxista non era riuscita a salvare l’alterità negando il
principio logico della non-contraddizione: aveva ridotto l’alterità al negativo, in qualche modo
subordinandola ancora all’identità positiva, e poi la sintesi l’annullava ad una nuova identità
positiva che l’aveva fagocitata. L’alterità e la differenza vanno mantenute in quanto tali e non sono
mai riducibili ad unità. L’alterità e la differenza sono alla base di una molteplicità che costituisce il
reale come temporalità di un divenire radicale mai riducibile all’essere statico: si può così
riformulare l’esito della filosofia di Nietzsche senza più legarla alla volontà di potenza, ma partendo
piuttosto da una differenza di potenziale energetico; si tratta di un concetto ripreso dalla fisica, non
compromesso con eventuali soggettivistiche volontà di dominio, ma che piuttosto rimanda alla
potenza creatrice della Natura di cui l’essere umano è solo un caso. L’interpretazione della volontà
di potenza di Nietzsche in termini di una volontà creatrice artistica più che di dominio, non è l’esito
di un lavoro filologicamente fedele alla lettera nietzschiana, quanto piuttosto di una trasformazione
della stessa filosofia di Nietzsche in una nuova filosofia che non presenti più come fondamentale la
concezione della vita in termini di un dominio violento del singolo sugli altri, ma piuttosto di una
differenza motrice e creatrice nel rispetto dell’alterità. L’identità stessa è ripensata in termini di una
differenza che la precede: l’identico è solo il ripetersi del differente, statico è solo il ripetersi del
mutamento, eterno non è l’essere ma solo il divenire, cui va ricondotta la stessa idea nietzschiana
dell’eterno ritorno che non va pensato come un ciclo identico che si ripete, ma una differenza che si
ripete non riproducendo mai lo stesso stato precedente. Deleuze e Guattari (L’Anti-Edipo.
Capitalismo e schizofrenia I, 1972) sviluppano insieme questa filosofia della differenza di Deleuze,
innestandole degli elementi derivati dalla psicoanalisi. Le differenze di potenziale energetico si
qualificano così in termini di flusso di desiderio: la tematizzazione della realtà umana, non più in
termini di volontà di potenza nietzschiana, avviene ora in termini di un desiderio inconscio, che non
deve più essere represso come nella psicoanalisi freudiana per la costituzione della società, perché
76
non ha più una connotazione puramente individuale e meramente sessuale, ma piuttosto preindividuale, pre-personale e presoggettiva, che attraversa e costituisce i corpi e le identità. Il flusso
di desiderio è quindi intrinsecamente e originariamente relazionale e sociale, ed è
l’individualizzazione di esso che costituisce una sorta di arresto del flusso se l’individuo si chiude
su sé stesso e sul suo piacere privato egoistico. Il desiderio di Deleuze e Guattari ha più
caratteristiche dell’agape cristiano che non dell’eros greco: non nasce da una mancanza, ma da
un’eccedenza, da una differenza positiva come surplus che ne genera la dinamica, ed ha carattere
relazionale e non legato al piacere individualistico. In maniera infelice, però, per caratterizzare
questo flusso, Deleuze e Guattari introducono la metafora della “macchina desiderante”, che si
contrappone al soggetto individuale ma anche alla struttura statica dello strutturalismo: questa
metafora rischia di dare una connotazione meccanicistica al divenire, che è considerato dalla
prospettiva di una sorta di una filosofizzazione radicale di una fisica quale dinamica energetica e di
una microfisica del desiderio. Si voleva così contrapporre, sempre sulla scia di una modifica dello
strutturalismo dominante in Francia, con impeto anarchico rivoluzionario, alle strutture del potere
delle macchine del desiderio.
La critica della metafisica dell’essere, della dialettica marxista e della psicoanalisi, li induce alla
teorizzazione di una schizo-analisi: eliminata la riduzione delle contraddizioni sociali al dramma
familistico privato dell’Edipo freudiano, Deleuze e Guattari colgono nella schizofrenia, al di là della
patologia clinica, il paradigma di una nuova possibilità del pensiero, che superi la riduzione
dialettica delle contraddizioni a sintesi positiva, ovvero di “logica schizofrenica” (in cui
l’affermazione è delle contraddizioni del divenire e l’alterità non è ridotta a negazione), che sola
potrebbe cogliere l’irrazionalità folle e le contraddizioni del reale e portare a una liberazione del
pensiero e a un’azione sociale antagonista alle strutture del potere. La microfisica del potere va
battuta da una microfisica del desiderio che diventa una micropolitica di flussi, di turbolenze e
vortici sociali impredicibili che fanno saltare, destabilizzandole, anche le macrostrutture
istituzionali del potere.
77
In Rizoma (il rizoma è un tubero, che è contrapposto all’albero e alla radice) già del 1976 (poi
ricompreso come introduzione in Mille piani) si presenta una forma di pensiero “rizomatico” che,
non binario-dualistico o non procedente per opposizioni logiche, e non gerarchico arborescente che
si costituisce in un tronco principale da cui si diramano le altre parti, invece procede in più
direzioni-associazioni, attraverso una molteplicità potenzialmente infinita di connessioni, e non più
ordinato in una sequenza lineare, nel seguire una corrispondente realtà “rizomatica”, complessa per
l’intreccio di connessioni dinamiche: un pensiero contrapposto al pensiero arborescente-deduttivo, a
un pensiero delle radici che costituiscono un fondamento, a un pensiero gerarchico, lineare della
tradizione metafisica (Rizoma girò già tradotto, come ciclostilato, nel 1977 nel movimento
studentesco italiano che lo accolse come progetto di liberazione, di un nuovo modo anarchico di
vivere e di pensare). Il pensiero come rizoma è un processo temporale, contingente che può sempre
ricadere in irrigidimenti arborescenti o in radicamenti che lo chiudono in sé.
In Millepiani. Capitalismo e schizofrenia II del 1980, si realizza una filosofia positiva del divenire,
della differenza, della frammentazione, della pluralità, delle molteplicità, delle singolarità, della
località, della temporalità e della relatività, dei processi e delle transizioni di fase, del caos
molecolare ed evolutivo, una filosofia che articola la microfisica del desiderio in una metageometria e in una meta-topologia (in geometrie e in topologie relativistiche dello spazio-tempo
metaforizzate) degli eventi nella loro singolarità impredicibile e nella loro ecceità, e si costituisce su
più piani autonomi e indica non tanto e non soltanto una deriva dei saperi, ma la stessa realtà come
divenire di differenze energetiche, sulla scia del prospettivismo leibniziano rivisitato da Nietzsche
per superare tutte le metafisiche delle rappresentazioni razionali e tutte le dialettiche delle
opposizioni logiche. Il pensiero di Deleuze e Guattari non è antropocentrico, non fissa una
discontinuità fra esseri umani e altri animali, ma non si è mai articolato in un’etica animale. La
prospettiva di Deleuze e Guattari, tuttavia, nella misura in cui non effettua un’analisi critica
profonda delle teorie matematiche e fisiche che metaforicamente usa, ricade in una meta-fisica
materialistica e meccanicistica (nell’abolizione della soggettività considerata come epifenomeno),
78
seppure non nella metafisica dei solidi criticata da Henri Bergson (1859-1941),39 ma in alternativa
metafisica dei fluidi, dei liquidi.
Bergson era stato il riferimento filosofico anche della nuova epistemologia della fisica del caos e
della complessità di Ilya Prigogine (1917-2003).40
Si tratta di un progetto filosofico che converge con quello dello storico della scienza Michel Serres
(1930) che aveva riscontrato il risorgere della fisica epicurea-lucreziana nella novecentesca fisica
del caos e analizzato la corrispondente geometria frattale:41 “C’era una volta l’età dell’oro. Dove e
quando, lo ignoro. Dopo, si dice, vennero l’età del bronzo e il secolo del ferro. Miti o storie,
sempre di metalli. Dei metalli o della pietra: levigata, tagliata, neolitica o paleolitica. Sappiamo
parlare soltanto di solidi, sappiamo scrivere soltanto sui solidi. Perché? A causa del loro ordine e del
loro legame. Coerenza , rigore e rigidità, la molecola cristallina locale qui è più o meno la stessa di
quella laggiù, prolunga la sua identità, la sua monotonia, sotto l’effetto di un forte vincolo. Così si
scrive la storia dove il locale ritorna al globale secondo la ripetizione di una legge omogenea. Il
discorso non è diverso dalla materia dura su cui è scritto. Meccanica dei sistemi solidi.
Ecco le acque , cataratte e flussi, fiumi e turbolenze , della fisica epicurea. Il locale qui fa scorrere la
sua debole viscosità, senza intaccare eccessivamente il volume globale. I vincoli svaniscono non
lontano dal suo intorno. Vi sono, come si dice, dei gradi di libertà. Il turbine si forma e si disfa,
nell’incertezza, ma ovunque, altrove, la pianura è calma, secondo i casi. Spazio seminato di
circostanze.
Inventare la storia e le età delle acque”.42
10.4 Michel Foucault e la genealogia storica
39
G. DELEUZE, Le Bergsonisme, PUF, Paris 1966; tr. it. di F. SOSSI, Il bergsonismo, Feltrinelli, Milano 1983.
I. PRIGOGINE & I. STENGERS, La Nouvelle Alliance. Métamorphose de la Science, Gallimard, Paris 1979; tr. it. di P.
D. NAPOLITANI, La Nuova Alleanza – metamorfosi della scienza, Einaudi, Torino 1981; e, anche, con un testo diverso:
I. PRIGOGINE, La nuova alleanza – uomo e natura in una scienza unificata; tr. it. a cura di R. MORCHIO, Longanesi,
Milano 1979.
41
M. SERRES, Hermes I-V, Minuit, Paris 1969-1980; tr. it. del vol. V di E. Pasini & M. Porro, Passaggio a Nord-Ovest,
Pratiche, Parma 1984.
42
M. Serres, La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce, Paris 1977, tr. It. Di P. Cruciani e A. Jeronimidis,
Palermo 1980.
40
79
Il pensiero di Michel Foucault (1926-1984) ha radici soprattutto nel pensiero di Nietzsche e di
Heidegger e nello strutturalismo. Gli inizi, legati a una critica della psicoanalisi e della psicologia
dominanti, si rifanno alla psicoanalisi esistenziale di Ludwig Binswanger (1881-1966), che aveva
inaugurato un’analisi esistenziale dell’essere-nel-mondo che superasse il dualismo psiche/corpo su
cui si basava la stessa psicoanalisi freudiana e la caratterizzazione del malessere nei termini di una
patologia medica estesa alla psyche: si trattava di ricomprendere il malessere, prima considerato
come malattia psichiatrica o nevrosi o psicosi, come un modo diverso di essere-nel-mondo, un
modo diverso di esistere, guardando al malessere non dall’esterno ma fenomenologicamente come
un vissuto interno dell’esserci, pur non riducendo i fenomeni inconsci alla coscienza come in
Husserl. In questo contesto, Foucault riprende inoltre, attraverso la mediazione di Sartre, la critica
di Heidegger a Kant volta alla valorizzazione dell’immaginazione trascendentale, per elaborare a
partire da una fenomenologia del fenomeno inconscio del sogno una sorta di “onirica
trascendentale” che ribaltasse completamente il rapporto fra sogno e ragione all’interno della
tradizione filosofica occidentale: la ragione risulta così secondaria rispetto al sogno, che costituisce
la forma originaria dell’esperienza del pensiero umano e dell’esperienza della libertà (Introduzione
a Sogno ed esistenza di L. Binswanger, 1954).
Ma un ribaltamento ancora più radicale della tradizione filosofica occidentale e del suo
razionalismo è effettuato da Foucault qualche anno dopo a partire dalla tematizzazione
fenomenologica della follia come esperienza vissuta al di là della sua medicalizzazione psichiatrica
(Storia della follia nell’età classica, 1961). La critica al razionalismo filosofico moderno è svolto
anche attraverso una critica dell’esclusione della follia dall’esperienza del pensare effettuata da
Descartes, con la sua identificazione della follia con la sragione: su questo punto si aprirà una
polemica con Jaques Derrida. Il ritorno all’esperienza stessa della follia è da comprendersi nella
prospettiva di un ritorno al fenomeno stesso della follia attraverso l’epoché husserliana applicata a
tutta la ragione e più ancora attraverso la distruzione heideggeriana della psicologia, della
psicoanalisi, della psicopatologia e della psichiatria. Husserl non gli basta perché la follia, come il
80
sogno, sfugge a una fenomenologia della coscienza che cerca di ricondurre l’immaginario onirico e
del folle proprio di un’attività inconscia a significati concettuali.
Il concetto di malattia mentale o psichica viene distrutto ed emerge l’esperienza di un diverso modo
di essere-nel-mondo. Foucault però si oppone all’interpretazione puramente soggettivistica del
Dasein e considera, al di là di un’originaria inautenticità umana dell’essere-nel-mondo, la
trasformazione del mondo che questa inautenticità comporta rendendolo a sua volta inautentico.
L’inautenticità del mondo economico, sociale, politico in cui vive il singolo rende impossibile
un’autentica dimensione spazio-temporale dell’Umwelt e un autentico Mitwelt, un autentico
Miteinandersein. Non ci si può fermare all’analisi formale ontologica dell’esistenza, ma bisogna
comprendere le concrete condizioni antropologiche e storiche dell’esistenza che provocano come
reazione, al di là delle razionalizzazioni sovrastrutturali, complesse strategie di sopravvivenza che
però non permettono di eliminare la sofferenza ma invece l’acuiscono in una rottura radicale col
mondo inautentico e le sue razionalizzazioni ideologiche: le contraddizioni reali del mondo si
traducono in conflitti interni. Foucault così scrive la storia della follia come storia della sua
costruzione sociale e della violenza che il mondo esercita sui “folli” come capri espiatori della sua
follia. Così, Foucault va molto oltre Binswanger: la follia non è solo un modo diverso di essere-nelmondo, ma rappresenta l’unica esperienza autentica della verità, in grado di superare le
mistificazioni della realtà ad opera della ragione attraverso processi di razionalizzazione che mirano
prima di tutto a un’esorcizzazione della morte. Da un punto di vista storico, la stessa esperienza del
Cristo e del cristianesimo che fino al rinascimento si manifesta nell’Elogio della follia di Erasmo da
Rotterdam (1466-1536) si caratterizzano in termini dell’esperienza autentica della follia. La follia
della croce e dell’amore cristiano a partire dal XVII secolo, nonostante il giansenismo, Port-Royal e
Pascal, non è più considerata come una sragione o una contro-ragione, ma come una ragione
superiore: solo con Dostojevskij e Nietzsche, dice Foucault, ritorna la gloria della follia del Cristo,
attorniato da tutti i folli del mondo di cui si è preso cura; la follia è stata parte del cammino di
Passione cui Dio ha preso parte e che così ha glorificato e redento. Ma ora non è più Follia
81
l’incarnazione di Dio nell’essere umano, ma follia è solo la caduta dell’uomo nella bestia senza
ragione, segno più evidente della sua colpevolezza e quindi della misericordia divina. C’è una
razionalizzazione del Cristianesimo senza più alcuna richiesta di abbandono delle pretese di
certezza della ragione: già dal IV secolo almeno il Cristianesimo si costruisce come teologia
filosofica, ma i dogmi restano come misteri inaccettabili, inspiegabili dalla ragione; solo con
Cartesio si passa ad un soggettivismo filosofico di una metafisica cristiana (il cristianesimo ridotto a
visione del mondo, dice Heidegger); mentre per Luther la ragione è la “puttana del diavolo”, per
Cartesio la ragione è il fondamento di tutta la fede.
Si profila quindi la necessità di una storia non della psicologia, ma una storia di quella esperienza
segregata e internata della follia con la legittimazione della psicologia e della psichiatria, della
separazione di ragione e follia. La necessità di una storia della separazione del sogno dalla ragione.
La necessità di una storia della separazione dell’Oriente dall’Occidente. Con la Storia della follia
Foucault inaugura una riflessione filosofica, che invero si è trasformata sostanzialmente in
un’indagine storica del tipo della genealogia nietzschiana delle pratiche discorsive in relazione alle
altre pratiche umane, che ne mettesse in evidenza le motivazioni ideologiche di dominio all’interno
di una vera e propria dinamica microfisica del potere nelle relazioni umane: l’esclusione e la
patologizzazione della follia viene criticata non solo attraverso una critica teoretica filosofica
astratta, ma mostrando tutta la storia concreta di violenza e di potere, delle istituzioni che l’hanno
“definita” e costretta fisicamente come un’anormalità.
Per superare il soggettivismo, Foucault si riconduce alla prospettiva strutturalista che integra con
Nietzsche ed Heidegger. Da Ferdinand de Saussure (1857-1913), che aveva elaborato uno
strutturalismo linguistico, lo strutturalismo aveva evidenziato nei vari campi del sapere (Claude
Lévi-Strauss (1908-2009) in antropologia, Georges Dumézil (1898-1986) nella storia delle religioni,
Louis Althusser (1918-1990) nella storia economica marxista) la priorità delle forme simbolicoculturali sui soggetti umani che le praticano, trasformando una struttura storica prodotta da soggetti
storici in un trascendentale oggettivo.
82
Così, Foucault va alla ricerca di quelle strutture storiche ma trascendentali del sapere e del potere,
come le epoche dell’essere di Heidegger ma integrate con la storia concreta che le realizzerebbe.
La modalità è simile a quella individuata da Foucault, sulla base dell’interpretazione di Kant data da
Heidegger43, come relazione sussistente fra la Critica della ragion pura e la Antropologia dal punto
di vista pragmatico di Kant44, e che portò Foucault a presentare l’essere umano come un “allotropo
empirico-trascendentale”45, per cui il trascendentale è sempre storico e deriva dall’empirico.
In Le parole e le cose (1966) delinea così, sulla falsariga della storia delle scienze naturali di
Thomas Kuhn (1922-1996) che aveva individuato le rivoluzioni scientifiche in termini di grandi
“paradigmi”,46 una storia delle scienze umane, che comprendono anche la filosofia, in termini di
cambiamenti di un’“episteme” individuata in termini di invarianti semiotici epocali, comuni a più
discipline. Con Kant l’unità della mathesis si spezza, fra ciò che è analitico e ciò che è sintetico, e
fra ciò che è fondato trascendentalmente e ciò che non lo è. Da Kant, le scienze venivano a
distinguersi fra quelle apriori e quelle aposteriori senza fondazione trascendentale, e dove le forme
deduttive della logica e della matematica sono applicate solo frammentariamente e localmente.
Sono gli ambiti disciplinari in cui si dà un discorso sulla vita, sul lavoro e sul linguaggio in cui si
concretizza l’esistenza dell’uomo, ovvero nella biologia, nell’economia e nella filologia, che
determinano concretamente la finitezza del sapere sull’uomo e le sue condizioni di possibilità e che
allo stesso tempo costituiscono il quadro di riferimento per le scienze umane che hanno come nuovo
oggetto appunto l’uomo. Le scienze, che studiano storicamente l’uomo che vive, l’uomo che lavora
e l’uomo che parla, non ritrovano mai però questo soggetto umano se non come un oggetto
43
M. HEIDEGGER (1929), Kant und das Problem der Metaphysik, Klostermann, Frankfurt am Main 1973 4, tr. it. di M. E.
Reina a cura di V. Verra, Kant e il problema della metafisica, Laterza, Roma-Bari 1981.
44
M. FOUCAULT, Introduction à l’Anthropologie, in E. KANT, Anthropologie du point de vue pragmatique, a cura di D.
Defert, Fr. Ewald e F. Gros, Vrin, Paris 2008, pp. 7-79; tr. it. di M. BERTANI & G. GARELLI, Introduzione
all’Antropologia di Kant, in I. KANT, Antropologia dal punto di vista pragmatico. Introduzione e note di Michel
Foucault, Einaudi, Torino 2010, pp. 9-94. L’edizione italiana non restituisce però il testo di Kant come tradotto da
Foucault, ma lo traduce dall’originale tedesco; nell’indice dei nomi, l’Heidegger conosciuto e citato da Kant viene
identificato con Martin Heidegger, citato nella presentazione francese come colui che ha influenzato quest’opera di
Foucault!
45
M. FOUCAULT, Les mots et les choses, Gallimard, Paris 1966 ; tr. it. di E. PANAITESCU, Le parole e le cose, Rizzoli,
Milano 1967.
46
T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Chicago1962; tr. it. di A. Carugo, La
struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 1969.
83
storicamente determinato dalla biologia, dall’economia e dalla filologia, e caratterizzano così questo
soggetto come storico, finito, relativo. Non solo: la vita, il lavoro, il linguaggio sono quegli ambiti
in cui heideggerianamente l’uomo è gettato nel suo essere-nel-mondo, ambiti che lo precedono e lo
sovrastano e ne mostrano la finitudine radicale perché è vissuto dalla vita, è prodotto dal lavoro, è
parlato dal linguaggio, immerso nelle loro storie diverse. Se è da queste scienze che si svilupperà
un’analitica della finitudine, termine che rimanda alla Daseinsanalyse a cui Foucault è legato, pure
queste si configurano all’interno di una metafisica dell’uomo come soggetto trascendentale che
diventa necessariamente oggetto del sapere, cioè di un’antropologia filosofico-metafisica che si
sostituisce alla teologia filosofica o di una metafisica antropologica. Con Nietzsche ed Heidegger, e
poi con lo strutturalismo epistemico che dissolve il soggetto epistemico in delle strutture
semiotiche, Foucault arriva ad affermare la fine dellla metafisica antropologica e dell’uomo e la
necessità di una completa analitica della finitudine alla Heidegger ma concreta, sviluppata anche
attraverso l’attività antiepistemica della psicoanalisi, dell’etnologia e della linguistica che
distruggono la metafisica dell’uomo, evidenziandone sul piano del sapere e dell’essere il fondo
impensabile e impensato, inconscio individuale e collettivo da cui emerge come un effetto di
superficie.
L’originalità di Foucault sta nel metodo archeologico-strutturale (L’archeologia del sapere, 1969),
nell’analisi storica concreta che dà contenuto alla prospettiva heideggeriana rispetto alle
individuazioni delle condizioni di vita inautentiche, ovvero di dominio e di potere, che determinano
l’episteme, nel rilievo dato allo snodo kantiano all’interno della classicità/modernità e alla correlata
questione delle scienze umane. Volendo distruggere il soggettivismo coscienzialistico di Husserl e
seguendo la prospettiva heideggeriana della non strumentalità e non antropologicità del linguaggio,
Foucault vuole risalire alle pratiche discorsive come cose stesse, come fenomeni indipendenti dai
soggetti umani: una fenomenologia delle pratiche discorsive è una sorta di fisica, di dinamica
interna delle pratiche discorsive che ne sveli l’architettura interna, che riveli come si formino da
queste delle discipline attraverso la chiusura di universi del discorso e la cancellazione arbitraria
84
delle interferenze, delle connessioni, in un’archeologia che fa emergere gli strati più nascosti, in
particolare gli invarianti che costituiscono le varie forme di episteme, e che non riguardano i
significati per i soggetti né i significanti puri che caratterizzano la struttura formale delle pratiche,
quanto le relazioni fra le “parole” e le “cose”, ovvero ciò che qualifica le pratiche discorsive come
tali rispetto al mondo e non rispetto a un soggetto. Questa ricerca di invarianti è però comunque una
ricerca di essenza delle pratiche, seppure storica, e fa trascurare le devianze, le pratiche minoritarie
e non dominanti che sole possono spiegare la transizione da un’episteme a un’altra. La genealogia
poi mette in evidenza l’essenza storica del sapere come potere, nelle sue varie articolazioni
disciplinari e discorsive, cioè la dinamica esterna delle pratiche discorsive, in quanto legittimazione
del potere e della violenza e in quanto progetto di potere e di violenza codificatore e regolatore delle
altre pratiche non discorsive umane in una sorta di trasformazione semiotica del kantismo in quanto
“strutturano” comunque le condizioni di possibilità dell’esperienza della vita e non solo della
conoscenza.
Certamente, lo spostamento dai discorsi alle pratiche discorsive permette di considerare i discorsi
all’interno della complessità delle pratiche umane, cosa che permette di analizzare molto meglio
quella dinamica che a livello discipline si suddivide nell’attestazione di un interno e di un esterno,
perché le discipline si situano solo a un livello del sapere distinto dalle altre pratiche umane, mentre
al livello delle pratiche cade il confine fra discorsivo e non discorsivo, fra sovrastruttura ideale e
struttura materiale. Non c’è più da una parte la complessità del sapere e dall’altra la complessità
della storia umana o del mondo, ma c’è un’unica complessità in cui anche le formazioni discorsive
sono eventi fra altri eventi della storia e del mondo: non si tratta più di una storia delle idee da una
parte e storia delle istituzioni, storia socio-economico-politica dall’altra; si tratta di una storia del
mondo umano in tutta la sua complessità.
Nascono così i grandi progetti storiografici (Nascita della clinica, 1963; Sorvegliare e punire.
Nascita della prigione, 1975; Storia della sessualità, 1976, 1984) intorno a una serie di esperienze
negate o controllate anche attraverso la costituzione di dispositivi teorici razionali che attraversano
85
varie pratiche discorsive, come i lavori sulla storia delle scienze umane, della medicina e della
psicoanalisi, sulla storia della follia e della sessualità che si avvalgono di un complesso intreccio di
apparati teorico-critici. Nell’ultimo periodo, Foucault sviluppa la prospettiva della cosiddetta biopolitica, che analizza come il potere controlli i corpi e la vita.
10.5 Jean Baudrillard e la seduzione
In un famoso testo del 1977, Dimenticare Foucault, Jean Baudrillard (1929-2007) contesta a
Foucault la trascendentalizzazione di queste strutture del sapere e del potere: la microfisica del
potere analizzata da Foucault, per quanto de-centralizzi la nozione classica del potere, che lo
identificava con il potere statale-politico, non raggiunge quella conclusione che ne sarebbe stata
l’esito necessario. La disseminazione del potere mostrerebbe che non esistono strutture
trascendentali del potere, che sono solo una costruzione teorica che ipostatizza il potere a partire
dalle libere scelte dei soggetti umani che non sono vincolate da alcuna struttura trascendentale
storica. A loro volta, le strutture del sapere non derivano necessariamente da strutture di potere, ma
più in generale sono generate da una libertà creativa. In una serie di testi, dal Sistema degli oggetti
del 1968, alla Società del consumatore: miti e strutture del 1970, fino a Per una critica
dell’economia politica del segno, del 1972 e Lo specchio della produzione del 1973, Baudrillard
aveva mostrato che il mondo dei segni non costituisce marxianamente una mera sovrastruttura
ideologica della struttura economica, ma esso stesso presenta un aspetto economico, con un suo
valore d’uso e di scambio, e svolge quindi un ruolo determinante la stessa struttura economica: anzi
lo stesso mondo degli oggetti, soprattutto nelle società post-industriali, si costituisce come un
mondo di segni sociali e produce una genesi ideologica di bisogni che fa sì che sia il consumo a
determinare la produzione e quindi la struttura economica della società. Le strutture delle società
contemporanea sono determinate dalle forme di comunicazioni dei segni, mediatiche, informatiche,
virtuali. Al modo della produzione degli oggetti, alla stessa ermeneutica dell’interpretazione, in una
critica radicale anche della psicoanalisi come economia energetica del desiderio e di un presunto
femminismo, Baudrillard contrappone il modo della seduzione (femminile) dell’apparizione degli
86
oggetti-soggetti de-semiotizzati al di là di ogni riduzione a un senso, a un significato, a una verità, a
una realtà che sono sempre prodotti della ragione: al posto della profondità del senso razionale o
inconscio, dell’intelletto o del sesso materiale (che è pure un effetto del discorso), bisogna ritornare
agli abissi superficiali della seduzione simbolica pura, in cui la Natura, la donna, le cose seducono i
soggetti (Della seduzione, 1979), ma non sono mai comprensibili razionalmente in discorsi di
verità. La loro immersione in un sistema di segni ci preclude l’accesso alla reale realtà degli oggetti
e ci consegna solo una versione simulata di realtà o di iperrealtà che sostituisce e provoca la
scomparsa della realtà. La de-materializzazione della realtà è tutt’uno con la fine delle
rappresentazioni razionali, la fine della storia e della politica, che caratterizzano la post-modernità.
All’economia dei segni, Baudrillard (Lo scambio simbolico e la morte, 1976) contrappone lo
scambio simbolico come dono (potlach), studiato in antropologia da Marcel Mauss (1872-1950)
come caratteristico delle società arcaiche, e che solo può decostruire il sistema economico dei segni:
secondo Baudrillard, l’esorcizzazione e l’esclusione della morte nelle nostre società è alla base di
tutti gli altri meccanismi di esclusione e discriminazione.
11. Jacques Derrida e il carnofallogocentrismo
Al di là delle soluzioni specifiche che ha dato ad alcuni problemi filosofici, l'importanza del
pensiero di Jacques Derrida (1930-2004) sta senz'altro in una serie di questioni critiche che ha
aperto. Il pensiero di Derrida è stato parte fondamentale anche della mia formazione, cosa che mi
spinse, ormai nel lontano 1988, ad andare a seguire le sue lezioni a Parigi.
Derrida parte da un’apertura sull'antropologia e sul mito portando all’attenzione filosofica l'opera
dell'antropologo André Leroi-Gourhan: questi ha messo in evidenza come nel Neolitico, con
87
l'invenzione della scrittura alfabetico-fonetico-lineare, ci sia stata la contrazione di un pensiero
complesso ad un pensiero lineare.47
Prima di questa transizione, i simboli sono disposti o su superfici bidimensionali o su volumi
tridimensionali, non sono direttamente legati o subordinati a fonemi, a suoni, e non sono ordinati in
una sequenza lineare come poi lo saranno con l’invenzione della scrittura fonetico-alfabetica
lineare: sono simboli multidimensionali e non-lineari, sono ideogrammi in cui le associazioni di
idee sono molteplici e in varie direzioni. Si tratta di un pensiero per immagini, multidimensionale,
non-lineare e complesso. A tali ideogrammi sono associate delle fonetizzazioni non univoche,
legate a dei rituali religiosi. Forse, alla scrittura fonetico-alfabetica, affermatasi intorno al 3000 a.
C., poi lineare, è da connettersi l’evento epocale più importante nella storia del pensiero umano: al
pensiero per immagini multidimensionale non lineare e complesso che si estrinsecava nei primi
simboli si sostituisce quasi totalmente un pensiero logico-verbale, linguistico, unidimensionale,
lineare e sequenziale. Si tratta di una riduzione estrema della complessità del pensiero per immagini
che resterà vivo solo in parte come sfondo ultimo su cui si fonda comunque il pensiero logicoverbale. Il pensiero matematico geometrico e la scrittura matematica non-fonetica e in parte nonlineare attuali sono residui di quell’arcaico pensiero complesso. Ed esito di ciò sarà il predominare
di una cultura scritta su quell’orale nel mondo greco del VI sec. a.C. e il separarsi di un logos dal
mythos con l’emergere di una nuova forma di sapere logico-filosofico, separato dalla religione, che
si oppone al sapere mitico, nella sua ricerca di un fondamento fisso, stabile, certo e univoco del
sapere: un sapere quello del logos basato ormai sulla scrittura lineare e non più su ideogrammi
associati in maniera multidimensionale come il mythos.
Derrida - pur non evidenziando che nelle considerazioni di Leroi-Gourhan era in questione la
possibilità stessa di una fondazione autonoma della filosofia che comunque ha le sue radici nel mito
(essendo impossibile una qualsiasi mito-logia filosofica) e va compresa antropologicamente in
modo concreto al di là della mera asserzione di un etnocentrismo occidentale - ha cercato
47
A. Leroi-Gourhan, Le geste et la parole: I. Techinque et langage; II. La mémoire et les rythmes, A. Michel, Paris
1964-65, tr. it. di F. Zannino, Il gesto e la parola, voll. I & II, Einaudi, Torino 1977, vol. I, pp. 221-254.
88
d’interpretare tali pratiche simboliche ideogrammatiche originarie come un’archi-scrittura trattabile
ancora all’interno di un nuovo sapere filosofico e ha interpretato la storia della metafisica
occidentale, dai presocratici ad Heidegger, come storia della metafisica della scrittura fonetica,
come storia del logos come phoné: come storia del logofonocentrismo, cui si contrappongono la sua
decostruzione e il nuovo sapere filosofico come grammatologia. quale scienza dei segni scritti.48
Qui Derrida eredita da Heidegger la convinzione di un continuum costitutivo della storia della
metafisica occidentale come storia, senza fratture, della metafisica dell'essere come presenza e
come onto-teologia, e la specifica ulteriormente come storia della metafisica del logos come phoné,
inserendovi dentro anche Heidegger.
Ora, non c'è dubbio che si può far risalire l'origine della metafisica alle astrazioni implicite nella
prima scrittura alfabetico-fonetico-lineare con la transizione da pratiche simboliche evocative e
iconiche a pratiche di segni denotativi e in parte convenzionali e arbitrari, la cui economia di
dominio della Natura e degli altri viventi è stata costitutiva della riduzione metafisica soggettivistica
di questi a concetti umani. Tuttavia, già la caratterizzazione heideggeriana della storia della
metafisica come un continuum senza soluzione di una onto-teologia è fallace: la storia del pensiero
cristiano non è tutta inscrivibile in esso; il Logos del Cristianesimo non è identificabile con il logos
della filosofia greca, e di ciò era consapevole la stessa prima riflessione di Heidegger.
L’esistenza di un simbolismo iconico non fonetico sulla scrittura alfabetico-fonetico-lineare viene
trasformata da Derrida in una priorità della scrittura sul linguaggio parlato, cosa ben diversa. In
questa prospettiva, Socrate e Platone (nel Fedro) determinano la tradizione filosofica successiva sul
primato del logos come parola parlata, come voce che si dà, per Platone, nel dialogo interiore
dell’anima con sé stessa, come costitutiva dell’anima stessa.
Derrida riprende così le tesi strutturaliste sul linguaggio elaborate da Ferdinand de Saussure:
considera quindi come primaria la struttura trascendentale della scrittura, per superare una
prospettiva soggettivistica e umanistica, come Heidegger voleva tematizzando l’essere, ma, per
48
J. Derrida, De la grammatologie, Minuit, Paris 1967, tr. it. di R. Balzarotti et al., Della grammatologia, Jaca Book
1969, pp. 5-7 e 97-100.
89
Derrida, però, non è possibile andare oltre i limiti della scrittura, e quindi questa dimensione non
soggettivistica e non-umanistica va ritrovata nella scrittura stessa; un testo scritto può essere
considerato indipendentemente da un soggetto umano che lo produce. Per lo strutturalismo
linguistico, il significato non risiede nell’intenzionalità del soggetto, in quello che il soggetto vuole
dire, ma nasce all’interno della struttura, dalle differenze fra i termini. Che non si possa andare oltre
i limiti della scrittura comporta però non solo che non si possa ricercare un significato esterno ad
essa, ma anche che non si possa determinare univocamente un significato anche interno alla
scrittura: eliminato un significato esterno, si può dare una molteplicità di significati potenzialmente
infinita, con una disseminazione del senso, con una deriva dei significati inarrestabile e non con una
mera polisemia. Mentre il linguaggio parlato indica la presenza di un soggetto, ed è quindi, per
Derrida, legato a una metafisica della presenza a un soggetto e di un soggetto, al contrario la
scrittura indica un’assenza, è la “traccia” di un’assenza, di qualcosa di mai attingibile, e la traccia è
segno di una differenza assoluta (différance) che non è più fra essere ed ente, ma fra scrittura ed
essere che cancella del tutto l’essere e il suo senso. La metafisica per Heidegger riduttiva dell’essere
ad enti semplicemente presenti viene reinterpretata da Derrida come metafisica della presenza a un
soggetto e di un soggetto, tipica del linguaggio parlato e della subordinazione ad esso della scrittura.
Il voler trovare o dare un senso per un soggetto, proprio del logos come linguaggio parlato, è non
solo pretesa illusoria ma anche violenza del soggetto umano, che riduce tutto a sé. Se questa
violenza si qualifica subito come propria del pensiero e della cultura occidentale, il logo-fonocentrismo si qualifica subito come un etno-logo-fono-centrismo. Ma c’è di più: perché in effetti nel
logos si strutturano e si legittimano tutte le relazioni di dominio, tutti i rapporti di violenza. Così, la
violenza dell’uomo maschio occidentale nei confronti della donna fa dell’etno-logo-fono-centrismo
un etno-fallogo-fono-centrismo, e la violenza sugli altri animali determina un etno-carno-fallogofono-centrismo. La metafisica del logos è così espressione non solo del dominio tecnico sulla
Natura come in Heidegger, ma della violenza del soggetto maschio occidentale carnivoro. Non è
90
possibile però, per Derrida, proporre una nuova filosofia priva di violenza, perché questa è insita nel
linguaggio: si può solo denunciarla e smascherarla.
L’esito della prospettiva di Derrida è quindi nichilistico nei confronti dell’ermeneutica: non c’è più
la prospettiva di una comprensione di un testo o della testualità generale propria della scrittura, ma
resta solo una molteplicità di interpretazioni. Derrida vorrebbe presentare questa sua prospettiva
come realizzazione della “morte di Dio” annunciata da Nietzsche, che qui si traduce nella morte del
senso. Tuttavia, il prospettivismo di Nietzsche è differente, è costitutivo della realtà del mondo
come per Leibnitz, e non è espressione di una deriva dei sensi di un testo.
La distruzione fenomenologica della metafisica operata da Heidegger e che porta a un’ontologia
ermeneutica si traduce in Derrida in una de-costruzione dei testi del logos, dei suoi sensi, attraverso
una deriva linguistico-interpretativa, attraverso la sovrapposizione di un’ipertestualità che si svolge
su testi molteplici paralleli per superare la linearità del pensiero sequenziale che si costituisce nella
scrittura alfabetico-fonetico-lineare. La deframmentazione di un testo fino alla disseminazione del
suo senso ha avuto applicazione nella critica letteraria fin anche dei testi biblici, dove il
decostruzionismo ha rappresentato un nuovo paradigma.
Seppure, la critica della violenza del logos della metafisica occidentale sia condivisibile in tutti i
suoi aspetti, è la specificità attribuita alla scrittura rispetto al logos che non convince: il logos
diventa cifra della metafisica dell’anima, invero, solo quando si astrae dalla concreta situazione di
dialogo e diventa soliloquio egoico che astrae e quindi nega l’altro; in questa prospettiva, anche la
scrittura è parola astratta dal dialogo concreto, e, anche quando si presenta sotto forma
apparentemente dialogica, è puro monologo escludente l’alterità. Pensare che la scrittura o un testo
si possa considerare come oggetto puro, indipendente dal soggetto che scrive, è un’illusoria
astrazione, e la disseminazione del senso non è indipendente da una pluralità infinita di atti
soggettivi arbitrari, che non fanno che moltiplicare all’infinito il soggettivismo.
91
La metafisica non è allora della phoné, in quanto tale e in quanto costitutiva dello spirito, come pure
Derrida ha pensato,49 ma della scrittura fonetica in quanto contrazione del pensiero astratto dalla
vita cui i simboli mitogrammatici erano sempre legati. E, in ogni caso, e contrariamente a quanto
affermato da Derrida, la metafisica non è solo metafisica della scrittura fonetica: anche la scrittura
non fonetica ha una parte fondamentale nella storia della metafisica occidentale, ed è questo che fa
comprendere come la metafisica non è della phoné in quanto tale. Quale scrittura non fonetica?
Certamente non i mitogrammi originari. La scrittura non fonetica della matematica e della scienza
ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della metafisica: la scienza non è estranea o contraria
all'imperialismo del logos e del fallogocentrismo.50
Già nel momento in cui, nella rivoluzione neolitica, i simboli matematici aritmetici e geometrici
perdono il loro valore evocativo e diventano rappresentazioni e strumenti di calcolo e di misura, o
sostituti sacrificali nel pensiero, per il conteggio di capi di bestiame da allevare o da sacrificare e
per la misura di appezzamenti di terreni agricoli, essi costituiscono un logos mathematikòs di una
metafisica in cui i viventi e la Natura sono ridotti a quantità interscambiabili e che si pone come
ideologia e progetto di un dominio tecnico, di uno sfruttamento, di un assassinio sistematico degli
altri viventi e dello stupro agricolo della Natura archetipo della violenza fallocentrica sulla donna. 51
Il pensiero topologico parmenideo e il pensiero geometrico platonico, ormai funzionali ad una
metafisica dell'essere come presenza da cui è stato escluso il tempo, costituiscono un logos
mathematikòs su cui si edifica una cosmologia e un'astronomia metafisica legata ad un'ontoteologia astrale che sarà dominante non solo nella filosofia e nella scienza greche ma anche nel
medioevo: la metafisica matematica platonica del cerchio e della sfera dominerà in astronomia e
cosmologia fino alla sua decostruzione con Giordano Bruno e Johannes Kepler.52
49
J. Derrida, La voix et le phenomenon, PUF, Paris 1967, tr. it. a cura di G. Dalmasso, introduzione di C. Sini, La voce e
il fenomeno, Jaca Book, Milano 1968; C. Sini, I segni dell'anima. Saggio sull'immagine,Laterza, Roma-Bari 1989.
50
J. Derrida, Della grammatologia, op. cit., p. 6.
51
E.R.A. Giannetto, Saggi di storie del pensiero scientifico, op. cit., pp. 37-41.
52
E.R.A. Giannetto, Saggi di storie del pensiero scientifico, op. cit., pp. 43-87 e 199-231.
92
La geometria meccanica di Archimede costituisce un logos mathematikòs technikòs che si identifica
con una metis mechaniké53 e sarà poi la base, nel corso della rivoluzione scientifica che portò alla
scienza moderna, della successiva riduzione della fisica a tecnica meccanica attraverso l'istituzione
del metodo meccanico-sperimentale galileiano, ovvero della scienza a tecnica; sarà la base della
concezione meccanicistica della Natura e degli animali ridotti da esseri viventi e animati a macchine
quale metafisica soggettivistica legata a un'onto-teologia meccanica e a una meccanizzazione e a un
dominio tecnico della Natura e dei viventi non umani, ormai consapevolmente epistemologizzato
quale scienza moderna non più sterilmente contemplativa ma tecnicamente produttiva secondo un
fallogocentrico baconiano <<parto maschio del tempo>>.54
Con la geometria analitica cartesiana, che, seppure riduce gli iconici simboli geometrici in arbitrari
convenzionali segni algebrici, permette di ricondurre ogni astratta dipendenza funzionale
matematica a un pensiero di immagini diagrammatiche,55 e con l'analisi del calcolo differenziale la
scienza moderna porta a provvisorio compimento la metafisica occidentale dell’essere come
presenza, della riduzione dell’essere ad ente semplicemente presente nella riduzione della Natura e
dei viventi a macchine deterministiche, costituite di mera materia inerte e passiva, quali meri oggetti
a disposizione dell'arbitrio manipolatorio tecnico della volontà di potenza del soggetto umano.56
Ma c'è di più: la scrittura non fonetica matematica, quale rappresentazione geometrica meccanica o
algoritmo di calcolo meccanico non ha svolto un ruolo fondamentale soltanto nella caratterizzazione
metafisica della Natura come oggetto, ma anche nella caratterizzazione metafisica del soggetto
umano come soggetto di conoscenza scientifica, come soggetto trascendentale quale controparte
dell'oggettivizzazione meccanica della Natura. Il soggetto trascendentale kantiano che, secondo
53
M. Detienne & J.-P. Vernant, Les ruses de l'intelligence – Les mètis des Grecs, Flammarion, Paris 1974, tr. it. di A.
Giardina, Le astuzie dell'intelligenza nell'antica Grecia, Laterza, Roma-Bari 1978.
54
E.R.A. Giannetto, Saggi di storie del pensiero scientifico, op. cit., pp. 63-65 e 235-266.
55
G. Pasqui, La scrittura delle scienze sociali, Jaca Book, Milano 1996.
56
E. Giannetto, Heidegger and the question of physics, in Proceedings of the "Conference on Science and Hermeneutics"
(Veszprém 1993), M. Feher, O. Kiss & L. Ropolyi, eds., Reidel, Dordrecht 1999, pp. 225-245; E. Giannetto, "L'esterno
dell'interno": il "paradigma" fisico dell'energia, in Le comunità scientifiche tra storia e sociologia della scienza. Atti del
Workshop (18-20 Aprile, 1991), a cura di G. Battimelli & E. Gagliasso, Serie di Quaderni della Rivista di Storia della
Scienza, n. 2 (1992), pp. 335-344; E. Giannetto, The Epistemological and Physical Importance of Gödel's Theorems, in
First International Symposyum on Gödel's Theorems, a cura di Z. W. Wolkowski, World Scientific, Singapore 1993, pp.
136-147.
93
Adorno ripreso da Derrida,57 ha espunto da sé ogni traccia di vitalità e di animalità per porsi
cartesianamente come pura sostanza pensante, non è altro che l'introiezione nell'uomo della
soggettività matematica-sperimentale-tecnica della scienza moderna che preordina secondo la
calcolabilità e la misurabilità l'esperienza umana: le forme a priori dell'intuizione, che caratterizzano
il soggetto trascendentale come soggetto formale al di là dei particolari soggetti empirici, non sono
altro che l'introiezione della forma-spazio della scrittura non fonetica della geometria e della formatempo della scrittura non fonetica dell'aritmetica, dell'algebra e dell'analisi. Che queste forme vuote
siano introiettate dalla scrittura matematica è evidente dal fatto che devono garantire la certezza e
l'univocità della conoscenza scientifica.
Non è allora la voce, la phoné a costituire il soggetto umano come spirito, come pura sostanza
pensante dell'idealismo, ma la scrittura non fonetica matematica che costituisce come tale il
soggetto della conoscenza della scienza moderna quale soggetto matematico-sperimentale del
dominio tecnico della Natura e dei viventi non umani.
Il fondamento dello stesso carno-fallogocentrismo denunciato da Derrida,58 il fondamento
epistemologico cioè dell'etnocentrismo e del maschilismo occidentale, dell'antropocentrismo e dello
specismo che costituisce il nucleo profondo del moderno soggetto umano quale maschio carnivoro
occidentale è la scrittura non fonetica matematica.
Se quindi è la scrittura matematica ad aver costituito la base della caratterizzazione della Natura
come puro oggetto meccanico di un soggetto umano formale che la trascende e che la domina, al di
là di ogni controversia speculativa filosofica, si può allora decretare il crollo della metafisica
occidentale e dello stesso carnofallogocentrismo.
Con la costruzione delle geometrie non-euclidee già dalla prima metà dell'Ottocento, delle algebre
non commutative, delle aritmetiche e delle analisi non standard, delle teorie degli insiemi e delle
logiche matematiche devianti, ovvero con la pluralizzazione di scritture matematiche alternative e
57
J. Derrida, L'animal que donc je suis, a cura M.-L. Mallet, Galilée, Paris 2006, tr. it. di M. Zannini, a cura di G.
Dalmasso, L'animale che dunque sono, Jaca Book, Milano 2006, pp. 150-155.
58
J. Derrida, <<Il faut bien manger>> ou le calcul du sujet, intervista con Jean-Luc Nancy, in Cahiers Confrontation
20, 1989, ripresa poi come Après le sujet qui vient in Points de suspension, Galilée, Paris 1992.
94
incompatibili fra loro, si è delineata la “decostruzione” del fondamento univoco e certo della
metafisica occidentale e del carnofallogocentrismo.59
Con le rivoluzioni della fisica del Novecento, con le teorie della relatività, del caos e dei quanti, si è
delineato il crollo del materialismo meccanicistico e deterministico e della sua controparte, ovvero
dell'idealismo matematico alla base della metafisica occidentale quale progetto di dominio tecnico
della Natura e dei viventi non umani in una prospettiva carnofallogocentrica.60
In particolare, con le teorie della relatività si distrugge la metafisica dell'essere come presenza e
della riduzione dell'essere a ente semplicemente presente, si distrugge la concezione volgare del
tempo e si delinea la dimensione fondamentale del tempo autentico-proprio degli eventi, di un
Dasein fisico che caratterizza non solo l’essere umano ma tutte le parti della Natura quali viventi. 61
Nella fisica contemporanea si delinea l'auto-dissoluzione del logos mathematikòs quale metis
mechaniké del dominio umano violento sulla Natura e sugli altri viventi e quindi del
carnofallogocentrismo per altro ancora imperante nelle società umane.62
Non siamo destinati quindi a restare prigionieri del carnofallogocentrismo, della sua logica
sacrificale, violenta, carnivora e anche cannibalica della fagocitazione, reale o simbolica nella sua
forma sublimata del logos come phoné della scrittura alfabetico-fonetico-lineare, dei suoi linguaggi
e delle sue concettualizzazioni, di cui sarebbero partecipi anche i vegetariani o i vegani più
radicali.63 La prassi di vita di etica radicale vegana del cristianesimo originario o comunque
effettivo64, come amore universale e rispetto per ogni vita, in cui si fa esperienza di un altro Logos
che è Dia-logos e distrugge la logica sacrificale della fagocitazione reale o simbolica nel pasto
eucaristico è il corrispettivo concreto di quella teoria/teologia negativa fatta di quei teo-remata
59
E. Giannetto, The Epistemological and Physical Importance of Gödel's Theorems, op. cit.; E.R.A. Giannetto, Saggi di
storie del pensiero scientifico, op. cit., pp. 299-305.
60
E. Giannetto, Heidegger and the question of physics, op. cit.; E.R.A. Giannetto, Saggi di storie del pensiero
scientifico, op. cit., pp. 299-437.
61
E. Giannetto, Heidegger and the question of physics, op. cit.; E.R.A. Giannetto, Saggi di storie del pensiero
scientifico, op. cit., pp. 317-325.
62
E. Giannetto, Physis, Bios, Psyché e Logos: note verso una fisica come dissoluzione delle pratiche simboliche, in
Metaxù 8, 1989, pp. 43-60.
63
J. Derrida, <<Il faut bien manger>> ou le calcul du sujet, op. cit.
64
E. Giannetto, Il Vangelo di Giuda –traduzione dal copto e commento, Medusa, Milano 2006.
95
negativi che costituiscono l'auto-dissoluzione del logos mathematikòs quale metis mechaniké, che
può ridonare all'uomo quell'esperienza del mondo, della Natura, di cui le sue concettualizzazioni
intrinsecamente carnofallogocentriche lo avevano privato e che, all'opposto di quanto pensato da
Heidegger,65 è propria di ogni parte minima della Natura, di ogni vivente, di ogni animale senza le
fagocitazioni simboliche, o meglio dia-boliche, delle concettualizzazioni umane.
11.1 Heidegger, Levinas, Derrida: il Cristianesimo originario e la filosofia
La consapevolezza, solo recentemente raggiunta dai critici e neppure unanime, di una radice etica
cristiana continuamente operante nella filosofia di Heidegger, cambia completamente la prospettiva
del rapporto Heidegger-Levinas dal punto di vista della storia della filosofia. La critica di
Emmanuel Lévinas (1906-1995) ad Heidegger, effettuata sulla base di una rivendicata priorità
dell’etica come disciplina filosofica sull’ontologia, si rivela quantomeno un fraintendimento, perché
l’ontologia di Heidegger nasce dall’ esperienza etica, è basata sulla vita etica cristiana, anche se poi
la ontologizza. Levinas pone l'etica come "filosofia prima" e come metafisica che contrappone
all'ontologia: l'ontologia si confronta con un essere astratto e generale che costituisce una totalità
che schiaccia la singolarità degli esistenti; l'etica, invece, nel teorizzare l'esperienza dell'altro apre
alla trascendenza, all'infinito, a Dio come Assolutamente Altro, e diventa quindi metafisica.
Jacques Derrida (1930-2004) vede in Levinas66, e nell’irruzione con lui della tradizione ebraica in
quella della filosofia occidentale, un’alternativa alla tradizione greca cui associa non solo Husserl
ma anche Heidegger, ma anche questo è, almeno in parte, un grave fraintendimento. Heidegger,
invero, anche se non ci riesce, sulla scia di Kierkegaard introduce per primo nella tradizione greca
l’esperienza storica ed esistenziale del Cristianesimo originario per distruggere la tradizione
filosofica e teologica occidentale, l’astrazione teoretica della metafisica greca che si distacca dalla
65
M. Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik – Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, Klostermann, Frankfurt am
Main 1983, tr. it. di P. Coriando, Concetti fondamentali della metafisica – Mondo – finitezza – solitudine, Il melangolo,
Genova 1999, § 42, pp. 230-232, § 47, p. 252; J. Derrida, L'animale che dunque sono, op. cit., pp. 199-222.
66
J. DERRIDA (1964), Violence et metaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel Levinas, in L'écriture et la différence,
Seuil, Paris 1967; tr. it. di G. POZZI, Violenza e metafisica. Saggio sul pensiero di Emmanuel Levinas, in La scrittura e
la differenza, Einaudi, Torino 1971, pp. 99-198, in particolare pp. 102-106.
96
vita, per distruggere quel “ferreo ligneo” sorto dalla mistione del Cristianesimo medioevale con una
metafisica platonico-aristotelica, che si riduce a onto-teologia. Levinas disconosce il suo maestro e
Derrida in parte difende Heidegger67 rispetto ai fraintendimenti di Levinas, ma in parte legittima
Levinas in quest’operazione consapevolmente perseguita, perché Heidegger si era macchiato di
adesione al nazismo. Levinas fraintende in parte l’essere di Heidegger come un concetto metafisico
generale, anziché considerarlo nelle singolarità esistenziali degli enti: come concetto metafisico
generale precluderebbe l’esperienza effettiva dell’altro nella sua singolarità e ci sarebbe una
violenza teoretica della luce rivelatrice dell’essere68. Al contrario è invece vero che l’esperienza
etica originaria dell’alterità, propugnata da Levinas in relazione all’epifania del volto degli altri
(seppure solo umani, per Levinas), è l’esperienza etica che sta dietro la tematizzazione dell’essere
come con-essere-con-altri-nel-mondo alla base dell’onto-logia heideggeriana; il problema di
Heidegger è che, ontologizzando trascendentalmente l’etica, la neutralizza.
Levinas, che pensa l’io e l’altro assolutizzati come del tutto separati originariamente, non riuscirà
mai a potere colmare questa distanza che è già un’astrazione metafisica soggettivistica.
Chiaramente, Levinas parte dal presupposto non dichiarato di voler trovare nel pensiero di
Heidegger le radici del totalitarismo politico violento nazista e crede di poter ritrovare una totalità
nell’essere come concetto metafisico generale in cui le alterità singolari sarebbero schiacciate69:
questo, però, non può che essere un fraintendimento malevolo, perché per Heidegger l’essere si dà
solo nelle singolarità degli altri a cui è legata la propria esistenza; queste singolarità non sono mai
riducibili o riconducibili a una totalità chiusa e anonima, ma costituiscono l’apertura originaria del
nostro essere singolare proprio perché l’essere si dà infinitamente in ulteriori alterità. La metafisica,
la teologia e l’ontologia della tradizione filosofica occidentale che Heidegger vorrebbe distruggere
sono la forme ideologiche del totalitarismo e della violenza della politica. Solo che il pensiero di
67
J. DERRIDA (1964), Violenza e metafisica. Saggio sul pensiero di Emmanuel Levinas, in La scrittura e la differenza,
op. cit., pp. 170-198.
68
J. DERRIDA (1964), Violenza e metafisica. Saggio sul pensiero di Emmanuel Levinas, in La scrittura e la differenza,
op. cit., pp. 106-138.
69
E. LEVINAS, Totalité et Infini. Essaie sur l’extériorité, Nijhoff, La Haye 1961; tr. it. di A. Dell’Asta, Totalità e
infinito. Saggio sull’esteriorità, Jaca Book, Milano 1980.
97
Heidegger astrae comunque l’essere dagli enti per superare il soggettivismo ontologico dell’io e per
dare una fondazione ontologica all’etica, per evitare la violenza della metafisica: così, per dare
forma filosofica trascendentale a quell’autentico pensiero non-violento, che è proprio
dell’escatologia etica del Cristianesimo originario, lo ingabbia in una tematizzazione trascendentale
dell’essere di una legge etica-ontologica che rischia di nullificare la moralità in termini di scelta
esistenziale.
Come spiega anche Derrida70, la pre-comprensione dell’essere è secondo Heidegger anche precomprensione pre-concettuale e pre-teoretica della divinità, precedente qualsiasi teologia o qualsiasi
opzione teoretica fra teismo e ateismo: per questo, Derrida71 dice che la prospettiva di Heidegger
non va confusa con alcuna teologia negativa (o più in generale con un’ontologia negativa), in
quanto comunque teoria; si può parlare, in una maniera non considerata da Derrida, di teo-logia
negativa (onto-logia negativa) in Heidegger, solo intendendo così un logos divino o dell’essere e
non teoretico umano. Ma in effetti l’ontologia di Heidegger riconduce la pre-comprensione a teoria.
Levinas coglie qui, inoltre, in Heidegger, però, un aspetto di paganesimo che
Derrida non
intravvede72. Questo perché l’ebraismo di Levinas, legato a una tradizione dominante nel
giudaismo, vede Dio come un Infinitamente Altro rispetto all’essere che è la Physis: questo fare
della Physis il luogo della manifestazione della divinità è per Levinas una sorta di divinizzazione
della Natura. Per Heidegger, invece, nella modernità, la Riforma Protestante, che recupera
quell’ebraismo, è all’origine di un processo di de-divinizzazione della Natura che porta
all’umanismo antropocentrico e preclude anche la pre-comprensione del senso di Dio73 (è da qui
che deriverebbe un’accusa metafisica all’ebraismo?). Heidegger, poi, riconsidera la Physis greca dal
70
J. DERRIDA (1964), Violenza e metafisica. Saggio sul pensiero di Emmanuel Levinas, in La scrittura e la differenza,
op. cit., pp. 182, 185-188, 192-194; M. HEIDEGGER (1946-1947), Brief über den “Humanismus”, Klostermann,
Frankfurt am Main 1976, tr. it. a cura di F. Volpi, Lettera sull’umanismo, Adelphi, Milano 1995 e in Segnavia, pp. 267315.
71
J. DERRIDA (1964), Violenza e metafisica. Saggio sul pensiero di Emmanuel Levinas, in La scrittura e la differenza,
op. cit., pp. 187-188.
72
J. DERRIDA (1964), Violenza e metafisica. Saggio sul pensiero di Emmanuel Levinas, in La scrittura e la differenza,
op. cit., pp. 185-187.
73
M. HEIDEGGER (1938), Die Zeit des Weltbildes, in Holzwege, Klostermann, Frankfurt am Main 1950; trad. it. a cura
di P. CHIODI, L’epoca dell’immagine del mondo, in Sentieri interrotti, La Nuova Italia, Firenze 1968, 1984, pp. 71-101;
E. R. A. GIANNETTO, Un fisico delle origini. Heidegger, la Natura e la scienza, Donzelli, Roma 2010, pp. 181-187.
98
punto di vista del pensiero dell’essere, legato comunque ad una prospettiva teologica cristiana:
l’essere non è Dio, la Physis come essere diventa dono, grazia, come il pensiero che è rivelazione e
non più discorso filosofico umano. Nel Cristianesimo originario, con cui Heidegger si è confrontato,
la prospettiva della Shekinàh ebraica si è radicalizzata nella considerazione dello Spirito Santo
come Ruchàh Qadòsh che vivifica la Natura dall’interno e nel rilievo del farsi carne del Logos
divino, rendendo la Physis ripiena di Dio. Solo che Heidegger antropocentricamente riduce il Logos
divino della Physis al logos umano.
Secondo Heidegger, Dio non è riducibile a un ente sommo, a un ente infinito, come determinazione
ontica dell’essere: sarebbe considerarlo come un ente fra altri enti, e l’infinito, rileva Derrida 74, non
permette una determinazione. La pre-comprensione dell’essere come con-essere-con-altri-nelmondo, formandosi solo in un’esperienza etica ontica, che Heidegger invece trascendentalizza, non
può, cristianamente, non basarsi sull’Amore che costituisce gli enti in questa connessione originaria
che precede qualsiasi azione etica umana: la pre-comprensione del con-essere implicitamente è precomprensione dell’Amore che è Dio75, e tale pre-comprensione, dopo la rottura originaria di questo
con-essere da parte dell’essere umano (“peccato originale”, un oblio totale della Physis), nella storia
dell’essere non potrebbe che basarsi sulla rivelazione storica di Dio-Amore in Gesù, che Heidegger
però come storia empirica trascura; chiaramente, questo non può essere un dato di un pensiero
filosofico umano, ma di un pensiero che deriva dalla fede che viene considerata da Heidegger solo
negli studi di Fenomenologia della vita religiosa.76 L’essere-di-Dio (che cristianamente è quindi
l’Amore che costituisce la trama degli enti della Physis), quindi è considerato implicitamente da
Heidegger all’origine della stessa differenza ontologica e dell’essere come con-essere77, ma non può
74
J. DERRIDA (1964), Violenza e metafisica. Saggio sul pensiero di Emmanuel Levinas, in La scrittura e la differenza,
op. cit., pp. 192-194.
75
A questa conclusione sembra giungere Derrida: J. DERRIDA (1964), Violenza e metafisica. Saggio sul pensiero di
Emmanuel Levinas, in La scrittura e la differenza, op. cit., p. 188 e relativa nota.
76
M. HEIDEGGER, Phänomenologie des religiösen Lebens. 1. Einleitung in die Phänomenologie der Religion (WS
1920/21), a cura di M. JUNG e T. REGEHLY. 2. Augustinus und der Neuplatonismus (SS 1921). 3. Die philosophischen
Grundlagen der mittelalterlichen Mystik (1918/19) a cura di C. STRUBE, in Gesamtausgabe LX, Klostermann, Frankfurt
am Main 1995; tr. it. di G. GURISATTI, a cura di F. VOLPI, Fenomenologia della vita religiosa, Adelphi, Milano 2003.
77
J. DERRIDA (1964), Violenza e metafisica. Saggio sul pensiero di Emmanuel Levinas, in La scrittura e la differenza,
op. cit., p. 192.
99
essere tematizzato come in Levinas, altrimenti si ricade nella metafisica e nella teologia che
riducono Dio a concetto, la verità a possesso umano e portano a un totalitarismo politico violento.
La possibilità di un pensiero non-violento, aspirazione di Levinas e negata da Derrida78, è invece
potenzialmente correlabile all’esito parzialmente non-filosofico e non greco della filosofia di
Heidegger, alla prospettiva di un pensiero poetante non oggettivistico, di un pensiero non umano
come rivelazione della Physis, come dono e come grazia da una parte e come rammemorazione,
ringraziamento e “pietà” (Amore) dall’altra: questo era implicito nell’inizio di Heidegger, volto a
superare il teoreticismo devitalizzante della filosofia greca, cui, sulla scia di Kierkegaard 79 pure
criticato per il suo soggettivismo, contrapponeva l’esperienza di esistenza autentica del
Cristianesimo originario.
In definitiva, in maniera nascosta e discreta – neanche Derrida se ne è reso conto80 -, è solo con
Heidegger che il Cristianesimo, dopo la sua confusione medioevale con la metafisica platonicoaristotelica, sarebbe potuto entrare nel pensiero occidentale, come radicale alterità al pensiero
filosofico greco, se Heidegger stesso non avesse ricondotto la Physis e l’esistenza all’antica
tematizzazione intellettualistica dell’ontologia greca dell’essere, che persiste anche nell’esito ultimo
heideggeriano presuntamente non-filosofico. Nell’ontologizzazione dell’etica e della storia operata
da Heidegger, questa rischia di restare chiusa nella dimensione comunque teoretica del pensiero e di
non manifestarsi nella prassi di vita se non di essere completamente elusa.
D’altra parte, Derrida ha ragione nel criticare l’idea heideggeriana del linguaggio come “dimora
dell’essere”,81 come luogo privilegiato in cui si possano incontrare le cose stesse, i fenomeni si
78
Derrida nega la possibilità di uscire fuori dal pensiero filosofico come logos umano che già nella predicazione fa
violenza alle cose: J. DERRIDA (1964), Violenza e metafisica. Saggio sul pensiero di Emmanuel Levinas, in La scrittura
e la differenza, op. cit., pp. 188-191, 194-197.
79
Derrida discute il rapporto fra Levinas e Kierkegaard: J. DERRIDA (1964), Violenza e metafisica. Saggio sul pensiero
di Emmanuel Levinas, in La scrittura e la differenza, op. cit., pp. 138-141.
80
J. DERRIDA (1964), Violenza e metafisica. Saggio sul pensiero di Emmanuel Levinas, in La scrittura e la differenza,
op. cit., pp. 196-198.
81
La critica di Derrida ad Heidegger si articola in molti testi, ma non è sempre condivisibile: J. DERRIDA, Geschlecht.
Différence sexuelle, différence ontologique, in J. DERRIDA, Psyché. Inventions de l’autre, Éditions Galilée, Paris 1987;
tr. it. di G. Scibilia, Geschlecht. Differenza sessuale, differenza ontologica, in J. DERRIDA, La mano di Heidegger, a
cura di M. Ferraris, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 3-29; J. DERRIDA, Geschlecht II: Heidegger’s hand, conferenza
pronunciata nel marzo 1985 presso la Loyola University di Chicago in occasione di un convegno organizzato da John
100
possano manifestare in sé stessi: si tratta comunque di un linguaggio umano, soggettivo, non si esce
quindi dal soggettivismo; c’è sempre uno scarto insuperabile fra il linguaggio e l’essere; il
linguaggio umano non è quello della Natura che ne comprende molteplici non umani; non si esce
dagli errori di prospettiva umana attribuendoli all’essere o alla Physis. Si riducono quindi le cose a
logos umano e si ricade comunque in una metafisica idealistica e soggettivistica umana: Derrida
chiama questa prospettiva “logocentrismo”, o “fallogocentrismo” evidenziando gli aspetti
patriarcali e maschilisti di questa cultura del logos, o anche “carno-fallogocentrismo” facendo
riferimento agli aspetti del logos come linguaggio umano, specista, antropocentrico modellato sul
carnivorismo e sulla fagocitazione umana di altri esseri viventi.82
Tuttavia, la proposta “positiva” di Derrida di risalire a una “archiscrittura” originaria, precedente il
linguaggio e la scrittura fonetica, a una scrittura iconica, ideogrammatica, indipendente dai soggetti
parlanti, indagata dalla scienza della grammatologia83, non permette di oltrepassare comunque la
soggettività umana e chiude la possibilità di qualunque accesso alle cose stesse, riducendo tutto il
sapere a un gioco scritturale che non è esente da un’ideologia, da una metafisica trascendentale che
non permette nemmeno alcun accesso etico alle cose e al mondo84.
Sallis, e successivamente pubblicata negli atti del convegno Deconstruction in Philosophy, University of Chicago Press,
Chicago 1987; poi come La main de Heidegger (Geschlecht II), in J. DERRIDA, Psyché. Invention de l’autre, Éditions
Galilée, Paris 1987; tr. it. di G. Scibilia, La mano di Heidegger, in J. DERRIDA, La mano di Heidegger, a cura di M.
Ferraris, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 31-79; J. DERRIDA, Heidegger’s Ears. Geschlecht IV: Philopolemology (conf.
del settembre 1989 alla Loyola University di Chicago), in J. Sallis (a cura di), Reading Heidegger. Commemorations,
Indiana University Pr., Bloomington – Indianapolis 1993, tr. it. di G. Chiurazzi, L’orecchio di Heidegger.
Filopolemologia, in J. DERRIDA, La mano di Heidegger, a cura di M. Ferraris, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 81-170; J.
DERRIDA, Heidegger et la question. De l'esprit et autres essais, Flammarion, Paris 1990; J. DERRIDA, De l'esprit:
Heidegger et la question, Galilee, Paris 1987; tr. it. di G. ZACCARIA, Dello spirito: Heidegger e la questione, Feltrinelli,
Milano 1989.
82
J. DERRIDA, <<Il faut bien manger>> ou le calcul du sujet, intervista con Jean-Luc Nancy, in Cahiers Confrontation
20, 1989, ripresa poi come Après le sujet qui vient in Points de suspension, Galilée, Paris 1992; J. DERRIDA, Après le
sujet qui vient in Points de suspension, Galilée, Paris 1992 ; J. DERRIDA, L'animal que donc je suis, a cura M.-L. Mallet,
Galilée, Paris 2006, tr. it. di M. ZANNINI, a cura di G. DALMASSO, L'animale che dunque sono, Jaca Book, Milano 2006.
83
J. DERRIDA, De la grammatologie, Minuit, Paris 1967, tr. it. di R. BALZAROTTI et al., Della grammatologia, Jaca Book
1969.
84
Si veda anche la critica di Habermas a Derrida: J. HABERMAS, Il sopravanzamento della filosofia temporalizzata
dell’originario: la critica di Derrida al fonocentrismo, in Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen,
Surkhamp, Frankfurt am Main 1985; tr. it. di Emilio & Elena Agazzi, Il discorso filosofico della modernità. Dodici
lezioni, Laterza, Roma-Bari 1987, terza edizione 1991, pp. 164-188.
101
12. Luce Irigaray e la filosofia di genere
Luce Irigaray (1930) ha tentato di dare concretezza al discorso di Derrida sul fallogocentrismo,
fondando una vera e propria filosofia femminista della differenza sessuale (Speculum. L’altra
donna, 1974; L’oblio dell’aria, 1983; Amo a te, 1992; Essere due, 1994; La via dell’amore, 2002;
Condividere il mondo, 2008) cercando di de-costruire soprattutto la centralità del fallo maschile nel
pensiero psicoanalitico di Sigmund Freud (1856-1939) e di Jacques Lacan (1901-1981) e in
generale in tutto il pensiero filosofico occidentale, e di gettare le basi di un nuovo linguaggio e di
una nuova cultura dell’amore non maschilista. Il rapporto fondamentale nella formazione
psicologica della personalità e dell’identità e della differenza sessuale è il rapporto con la madre:
all’origine della civiltà ci fu non l’assassinio del padre, come per Freud, ma della donna madre, e
questo fu l’atto inaugurale di una società e di una cultura patriarcali e maschiliste, basate sulla
negazione del femminile. All’ordine simbolico lacaniano del logos del padre e del fallo va
sostituito, con Julia Kristeva (1941) (Séméiôtiké. Ricerche per una semanalisi, 1969; La rivoluzione
del linguaggio poetico, 1974), l’ordine semiotico della madre e della donna, delle immagini del
linguaggio dell’inconscio femminile, rimosso dalla coscienza maschile.
102
13. La tradizione italiana
“Si può dire che il tratto peculiare del pensiero italiano della prima metà del Novecento sia la sua
integrale storicizzazione. Con questo termine non mi riferisco soltanto alla consapevolezza, pure
netta nei suoi principali esponenti, della determinatezza storica della propria, come di ogni altra,
filosofia; quanto piuttosto alla tendenza, tacita o proclamata, a farsi esso stesso storia o, per usare
un’espressione più carica di risonanze, ‘pensiero in atto’ – inteso nel senso, insieme dell’azione e
dell’attualità...Rompendo con una concezione tradizionalmente intellettualistica, il pensiero italiano
novecentesco si ricollega, nello stesso tempo, ai caratteri profondi della propria genealogia. E ciò
non solo perché porta a compimento la vocazione pratica, o civile, che fin dalle sue radici la
connota. Ma anche perché fornisce una risposta radicale alla questione, posta drammaticamente
nella stagione precedente, dello scarto insanabile tra ‘la scienza e la vita’ – dell’eccedenza che
quest’ultima manifesta rispetto a tutti i tentativi di comprenderla concettualmente. La soluzione
adesso avanzata sta nel ribaltamento dell’ottica con cui il problema era stato fino allora guardato:
anziché cercare, invano, di costringere la vita nei parametri formali della filosofia, conferire alla
filosofia i caratteri concreti della vita. Per potere attingere una falda vitale refrattaria alla
dimensione del concetto, un pensiero che voglia essere all’altezza del proprio tempo non può che
calarsi in essa, facendosi appunto ‘pensiero vivente’. Ma perché ciò sia possibile – è l’ultimo, e più
drastico, passaggio del ragionamento – esso deve incrociare la politica o, meglio, riscoprire la
propria costitutiva politicità. Solo in questo modo, operando praticamente nel mondo, la filosofia
può davvero rivitalizzarsi, riconoscersi in una storicità che fa tutt’uno col movimento inesauribile
della vita...condiviso il progetto di fare della pratica filosofica una potenza storica destinata a
cambiare il mondo”. Così, Roberto Esposito descrive il pensiero filosofico italiano del Novecento 85.
La filosofia italiana si ripropose il compito di delineare il carattere pratico di tutta la filosofia, non
solo della filosofia della Natura e della storia: tutta la filosofia si deve trasformare in filosofia
pratica. Rispetto al grande paradigma greco-tedesco dominante in filosofia, quello teoretico, la
85
R. ESPOSITO, Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010, pp.150-151.
103
filosofia italiana non poteva che risultare teoreticamente povera, ma questo è un giudizio in base a
un presupposto che invece dovrebbe essere dimostrato.
In Italia, che non ha vissuto la riforma protestante ma ha avuto solo l'umanesimo e il rinascimento,
oltre la scienza galileiana, questa opposizione di pensiero e fede non c'è mai: anche il contrasto
galileiano è esteriore, perché Galileo tenta una conciliazione fra pensiero e fede, come Bruno, non
mettendo limiti alla ragione per la fede, ma semplicemente ponendo una distinzione di due ambiti
ermeneutici separati ma illimitati: da una parte il libro della Bibbia, dall'altro il libro della Natura,
dove questo non è più fruibile secondo la vecchia metafisica greca teoretica ma dalla prassi di un
soggetto scientifico universale senza bisogno di soggettivizzare individualisticamente la fede che
resta legata alla comunità della Chiesa cattolica-universale. Così, in Italia, l'esito della modernità
non sarà anti-religioso o post-religioso e ateo come in Germania (o in Francia che ha conosciuto la
rivoluzione) attraverso una secolarizzazione che rifonderà
la modernità in senso deistico o
panteistico o ateo, ovvero non-cristiano, ma sarà cristiano-cattolico laddove, oltre la persistenza di
una metafisica neo-scolastica o ontologica cattolica, anche il più radicale immanentismo, da una
parte, dell'attualismo di Gentile si qualificherà come cristiano-cattolico, e, dall'altra parte, dello
storicismo di Croce arriverà alla spiegazione del Perché non possiamo non dirci cristiani (1942), in
una secolarizzazione e in un laicismo che si presentano non anti-cristiani ma come inveramenti
filosofici del Cristianesimo. La filosofia italiana non parte da Bruno, ma dalla rivoluzione
gioachimita e francescana, da una parte all'origine della storia dello spirito in cui si spiritualizza la
storia e si storicizza lo spirito, e d'altra parte all'origine del volontarismo e della prassi di vita,
distruttrici della metafisica greca e all'origine dell'umanesimo e del rinascimento. Posta sul piano
strettamente storico degli eventi, la modernità si presenta con varie facce perché in alcuni contesti ci
sono stati certi eventi come la Riforma che ha prodotto l'opposizione fra ragione e fede, e in altri
contesti come quello italiano cattolico non ci sono stati; e questo, come fa notare Esposito con
strumenti di geofilosofia deleuziana più che nazionalista hegeliana o poi spaventiana,
indipendentemente dalla costituzione di uno stato nazionale che in Italia si è formato solo dopo con
104
il Risorgimento, e quindi anche la secolarizzazione politica (con la negazione del potere temporale
della Chiesa e la confisca dei suoi beni e la riduzione ad un punto geometrico del suo territorio di
sovranità) è arrivata molto più tardi.
Ma in chi si realizzò effettivamente questo progetto di una filosofia pratica?
In Italia, fu Giovanni Gentile (1875-1944) con il suo libro su La filosofia di Marx (1899) a
enfatizzare la prospettiva di Marx come una filosofia della prassi. Maurice Blondel (1861-1949),
oltre e diversamente da Marx, aveva pure cercato di ritematizzare l’importanza fondamentale
dell’azione per la filosofia86 e insieme ad altri esponenti del modernismo cristiano del primo
Novecento ebbe una certa influenza sulla filosofia italiana.
86
M. BLONDEL, L’Action. Essai d’une critique de la vie et d’une science de la pratique, Alcan, Paris 1893 e poi Puf,
Paris 1950, 1973; tr. it. a cura di S. Sorrentino, L’azione. Saggio di una critica della vita e di una scienza della prassi,
San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 1993, 1997.
105
14. Lo storicismo di Benedetto Croce
Anche Benedetto Croce (1866-1952) ebbe, in qualche modo, un percorso parallelo e divergente
insieme da quello di Gentile. Tanto che si parla, per riferirsi ad essi congiuntamente, di neoidealismo italiano. Il loro pensiero è stato messo da parte nel dopoguerra e poi dimenticato: la
qualifica di Gentile quale filosofo del fascismo è stata certo determinante, ma ancora di più la
volontà di chiudere i conti con il fascismo in una maniera netta ma superficiale, condannando tutta
la cultura italiana di quel periodo come arretrata e chiusa alle istanze esterne. Nel dopoguerra, in
Italia, sono dilagate le mode di praticamente tutte le correnti di pensiero non-italiano,
dall'esistenzialismo all'ermeneutica, dal marxismo alla fenomenologia, dal neo-positivismo alla
filosofia analitica. Croce fu soprattutto uno storico e fece coincidere la storia con la filosofia. C’è
l’influenza della teoria di Vico del verum/factum. Se la filosofia è conoscenza della realtà e la realtà
si presenta all’essere umano nella storia, allora la filosofia non può che identificarsi con la stessa
storia. Non fu un professore universitario e scrisse soprattutto sulla rivista da lui fondata nel 1903,
La critica, cui collaborò anche Gentile fino alla rottura del 1924. Fu senatore, presidente del partito
liberale ed ebbe grande influenza sulla storia politica italiana, dal 1925 con il suo manifesto degli
intellettuali antifascisti a dopo la fine della seconda guerra mondiale. Nel 1893 pubblicò La storia
ridotta sotto il concetto generale dell’arte. Anche Croce iniziò a misurarsi con Marx, su spinta
anche di Gentile, con dei saggi scritti fra il 1896 e il 1899 poi raccolti in un volume: Materialismo
storico ed economia marxista è del 1900. Seguirono nel 1902 Estetica come scienza
dell’espressione e linguistica generale, nel 1905 Lineamenti di una logica come scienza del
concetto puro, nel 1906 Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel, nel 1909 Logica
come scienza del concetto puro e Filosofia della pratica. Economia ed etica, nel 1915 Contributo
alla critica di me stesso, nel 1917 Teoria e storia della storiografia, testi in cui si dipanava quella
che chiamò “filosofia dello spirito”.
Lo spirito andava inteso, sulla scia della riforma dell’hegelismo tentata da Bertrando Spaventa
(1817-1883), come soggetto conoscente umano e non più come lo spirito assoluto di Hegel. La
106
storia come l’arte riguarda il concreto individuale ed è il risultato dell’azione degli esseri umani
concretamente esistenti. Croce concretizza la concezione della conoscenza come prodotto del
processo storico di Hegel, anche attraverso la ripresa della prospettiva del materialismo storico che
non aveva accettato gli schemi ideali aprioristici di spiegazione: si trattava di de-teologizzare e di
de-metafisicizzare la filosofia di Hegel. L’analisi marxiana del capitalismo è, invece, per Croce,
legata a un presupposto morale di giustizia, perché anche la teoria del plusvalore non tiene conto,
per esempio, di un fattore come il ruolo del capitale nella formazione del valore della merce.
La prima distinzione fra le attività dello spirito è quella fra attività teorica che riguarda la
conoscenza e attività pratica che è legata a obiettivi da realizzare nell’azione. Estetica e Logica
costituiscono rispettivamente la conoscenza dell’individuale e la conoscenza dell’universale. Le
attività pratiche sono l’economia come volizione dell’individuale e l’etica come volizione
dell’universale. La volizione effettiva coincide con l’azione. Ma mentre l’azione deriva dalla
volontà del singolo, l’accadimento storico deriva dal complesso di tutte le volontà individuali, del
tutto, ovvero dello spirito universale. A queste quattro forme d’attività dello spirito corrispondono
quattro categorie, quella del bello, del vero, dell’utile e del buono. Fra queste quattro forme, vi è
circolarità dello spirito, l’una presupponendo l’altra o convertendosi nell’altra, senza bisogno di un
rinvio a una realtà esterna.
La filosofia non ha un ruolo trascendentale al di là di queste attività dello spirito, ma il suo tipo di
conoscenza si dà solo all’interno di queste forme di attività: non costituisce un sapere separato.
L'arte, per Croce, è il momento aurorale dello spirito, come emergere dell'intuizione-immagine dalla
notte della psiche, il “sogno della vita teoretica”: è legata a quella speciale forma di conoscenza
creativa che è l'intuizione, una forma di pensiero per immagini che si oggettivano in un'espressione,
una conoscenza immediata e pre-logica, pre-concettuale che non distingue fra fantasia e realtà, una
forma di attività dello spirito autonoma dalle altre (erronee sono perciò le estetiche edonistiche,
utilitaristiche o etiche che subordinano il bello all’utile o al buono): si tratta di un'attività espressiva
interiore che solo secondariamente si estrinseca in delle opere; da questo punto di vista, non c'è più
107
distinzione delle arti, ma solo delle opere artistiche. Nel Carattere lirico dell’intuizione artistica del
1908, nel Breviario di estetica del 1912, in Il carattere di totalità della espressione artisitica (1917)
e in La poesia del 1936 si fa strada l'idea della cosmicità dell'arte come sintesi a priori di sentimento
e immagine e della critica come sintesi di pensiero e di sensibilità, ovvero sintesi di contenuto e
forma: laddove il sentimento ha una catarsi in un’immagine pura, qui pure si mostra la presenza di
motivi trascendentali nella filosofia di Croce, che, pur presentandosi come uno storicismo legato
alla storia concreta, presenta dei tratti di trascendentalismo nel riconoscimento del ruolo attivo del
soggetto conoscente nella conoscenza storica.
Il linguaggio ha un’origine fantastica o poetica, e, in questo senso, ogni essere umano che esprime il
suo vissuto in immagini fa poesia: homo nascitur poeta.
La logica, invece, come conoscenza dell'universale, è una conoscenza per concetti, che però
presuppone la conoscenza intuitiva individuale propria dell'estetica: i concetti sono come delle idee
platoniche incarnate nelle cose individuali, come le forme aristoteliche, che Croce indica come
universali concreti. Concetto è la bellezza o la bontà, ma non 'cane' o 'casa' che sono 'pseudoconcetti', in quanto legati a una molteplicità di intuizioni individuali non sussumibili in un
universale: si tratta di 'pseudo-concetti' empirici. Ci sono poi anche degli universali non concreti e
non esperibili, come le forme matematiche, per esempio geometriche, che sono dei 'pseudo-concetti
astratti'. Così, le scienze naturali empiriche sono legate a pseudo-concetti empirici, e fanno parte
dell'attività pratica dello spirito e non hanno quindi valore teoretico o conoscitivo; le scienze
matematiche sono legate a pesudo-concetti astratti e sono vuote di contenuto e quindi solo strumenti
utili per attività pratiche, per contare o misurare.
Che Croce non abbia compreso pienamente la portata filosofica della scienza moderna, vedendone
solo l’aspetto strumentale, di contro a una presunta vera universalità concettuale filosofica è certo e
che abbia contribuito a un paradigma dominante di sottovalutazione della scienza è altrettanto vero,
ma che Croce o l’idealismo abbiano contrastato o ritardato lo sviluppo della scienza è impossibile,
perché la scienza italiana di quell’epoca non è seconda
a quella di alcun altro paese: è la
108
storiografia del dopoguerra giustamente autocritica, ma pure negativamente distruttiva dell’identità
culturale italiana, ad aver creato un falso problema.
La logica non è più anteposta alla fenomenologia come in Hegel, cioè non si dà indipendentemente
dalla vita dello spirito. La filosofia non è, come in Hegel, una sintesi finale in cui si ha la fine della
storia.
Il pensiero filosofico è quindi un pensiero superiore che articola verbalmente concetti in un
linguaggio, che dà loro forma di giudizi universali o individuali: la filosofia è quindi un sistema di
concetti che attraverso un giudizio universale costituisce delle idee, ma trova espressione in giudizi
individuali storici, in cui elemento logico universale dei concetti ed elemento empirico individuale
si legano in una sintesi della conoscenza storica che, nel Croce maturo, si distingue quindi dall'arte
come conoscenza meramente intuitiva ed individuale: la filosofia è sintesi apriori logica di concetto
ed intuizione.
La filosofia è storia e muta storicamente: non si può costruire quindi una metafisica che dia accesso
a verità eterne sovra-storiche, né esiste una filosofia definitiva che valga sempre: la filosofia è la
stessa storia dello spirito in tutte le sue forme di attività, e si concretizza, in un dato momento, come
risposta ai problemi di quel momento. Questa storia non si presenta, come in Hegel o in Marx, come
una mera dialettica degli opposti, ma piuttosto come una dialettica anche dei distinti (lo spirito è
unità dei distinti, di cui ognuno è sintesi di opposti), come arte, religione e filosofia, in un
superamento del panlogismo hegeliano che aveva decretato la risoluzione di tutte le attività dello
spirito nella filosofia. Il concetto senza l'intuizione è vuoto.
L'economia è una forma autonoma di attività pratica dello spirito, che tende all'utile, mentre l'etica
(Croce sviluppa un'etica del lavoro) dipende dall'economia nel legare il bene all'utile senza ridurlo
però all'utile. La religione è ridotta da Croce all'etica, alla filosofia e per i miti alla poesia e
all'estetica, come all’economia per l’organizzazione ecclesiastica. Il diritto e la politica si riducono
in qualche modo all'economia con l'uso di pesudo-concetti: non c'è primato dello stato sugli
individui, ma è fondamentale la volontà individuale. La storia però non è dei singoli, ma
109
dell'umanità nel suo complesso. Le res gestae si danno solo nell'historia rerum gestarum, nella
storiografia come conoscenza dell'universale concreto: la filosofia si qualifica quindi come quella
parte della storiografia che è la sua metodologia, il chiarimento delle sue categorie di conoscenza.
La storia è sempre contemporanea nel senso che ha a proprio oggetto l'attività pratica dello spirito,
l'azione etica e politica per l'interesse che il passato può avere per il presente: non giudica
eticamente, non è giustiziera, ma giustificatrice nella comprensione degli eventi. Ma, nei saggi che
compongono La storia come pensiero e come azione (1938), è sottolineato il ruolo emancipatorio
della storia per fondare l'azione efficace nella storia, per la lotta contro il “male” e per il progressivo
realizzarsi della libertà; Croce delinea così una “religione della libertà” di una storia etico-politica
come azione, anche in parte superando la visione hegeliana per cui coincidono essere e doveressere, realtà e razionalità con la riduzione della realtà del male a mero momento negativo della
storia solo per opposizione e non in sé, tanto da fargli giustificare anche la guerra. Croce cambierà
pensiero fino alla fine della sua vita, diventando meno ottimista e parlando di una forza bestiale che
è sempre presente nell’umanità e che costituisce un’irredimibile peccato originale che può portare a
La fine della civiltà (1946).
110
15. Giovanni Gentile e l’idealismo attuale
Gentile cercò di riacquisire
gli esiti marxisti ad un idealismo post-hegeliano: si trattava di
riconoscere l’inconciliabilità della marxiana filosofia della prassi con la concezione del
materialismo storico e di riacquisire all’idealismo la verità secondo cui “quando si conosce, si
costruisce, si fa l’oggetto, e quando si fa o si costruisce un oggetto, lo si conosce; dunque l’oggetto
è un prodotto del soggetto”. Così, Gentile, ribadendo la posizione di Vico ne assumeva anche
l’inversa.
Si spostava così dalla statica idea platonico-hegeliana al processo concreto del pensare,
considerando il pensiero una vera attività, in cui unitariamente stabiliva un’identità di teoria e
prassi; si trattava di ristabilire la dialettica dello spirito come actus purus, differente dall’actum
aristotelico statico in quanto potenzialmente infinita attività dinamica. Questa è la filosofia
dell’attualismo, del pensiero come atto puro.
Il riferimento di Gentile è alla Riforma cattolica di Gioberti del 1856-1857, e al modernismo
cattolico: alla poligonia del cattolicesimo come universalismo che contiene tutti. Invece, per Gentile
non c’è opposizione fra pensiero e fede, ma fra pensiero greco e fede. Gentile, nel 1906, scrive I
saggi di filosofia dell’azione del Laberthonnière, compreso in Il modernismo fra religione e
filosofia, e contrappone all’idealismo greco antico, quello moderno, cristiano, che considera la
verità non statica o già fatta, ma dinamica, storica come nella rivelazione, e Dio stesso non quello
greco immobile, perché Dio agisce e ama, s’incarna, come avrebbe compreso Hegel nella
fenomenologia.
La soggettivizzazione fichtiana dell'hegelismo operata da Bertrando Spaventa e compiuta in Gentile
lo ha de-realizzato, risogettivizzando l'idealismo, e ha ricondotto la storia del mondo a storia
dell'essere umano come nella materializzazione marxista della dialettica storica hegeliana, ma
trasponendo il piano della prassi sul piano del pensiero, dando concretezza al pensiero, anche
politica o etica, ma allo stesso tempo riducendo la storia, la politica, l'etica alla dimensione del
pensiero. L’essere di Gioberti diviene così immanente al pensiero. Gentile contrapponeva al
111
materialismo della cultura illuministica francese una nuova prospettiva religiosa che s’inverava
nella filosofia e che riprendeva lo spiritualismo di Rosmini e Gioberti.
L’attualismo o idealismo attuale, preannunciato nel 1911, vede in una pubblicazione del 1912,
L’atto del pensare come puro. Nel 1913 escono i saggi della Riforma della dialettica hegeliana e il
Sommario di pedagogia come scienza filosofica. Nel 1916 appare la Teoria generale dello spirito
come atto puro, insieme a I fondamenti della filosofia del diritto. Il Sistema di logica come teoria
del conoscere è in due volumi, il primo del 1917 e il secondo del 1923.
Si tratta di un soggettivismo immanentistico assoluto, che rende la storia, la natura e Dio come
immanenti al pensiero. La stesso spazio e lo stesso tempo non sono più i connotati materiali
dell’attività pensante, ma sono prodotti del pensiero.
Alla dialettica del pensato di Hegel, Gentile contrappone la dialettica del pensiero pensante, al logo
astratto un logo concreto che non presuppone astrattamente un mondo dato indipendentemente dal
pensare stesso: questo comporta che la fenomenologia dello spirito non presuppone la logica come
sua legge apriori, ma la logica si dipana nella stessa fenomenologia. Per Gentile, la logica
aristotelica è la logica del logo astratto, mentre la logica dialettica hegeliana è la logica del logo
concreto. L’altro dal pensiero è quindi posto dal pensiero stesso e non può essere altro che il
pensiero pensato, che si è fissato ed è diventato fatto, natura. Per poterci essere dialettica, però, la
sintesi non può essere finale, ma originaria, altrimenti non ci potrebbe essere movimento da un
opposto all’altro, che costituiscono dei pensati e come tali sono fissi. Il pensiero pensante racchiude
in sé soggetto e oggetto del pensiero. Conoscere è quindi riconoscere nel pensiero pensante
l’identità degli opposti, in qualche modo identificare e inglobare l’alterità nell’identità: gli altri non
esistono realmente fuori dall’io trascendentale. Il pensiero pensante, l’atto stesso del pensare è però
il soggetto trascendentale e non l’io empirico che è un dato: si tratta quindi di un processo autocostruttivo e non una sostanza statica. Comunque, questa prospettiva rischia non solo di risolversi in
un solipsismo trascendentale, ma anche di risolvere la stessa dialettica nell’identità, come anche di
risolvere il male a una mera astrazione superata dal bene attuale.
112
Le scienze naturali ricadono quindi nel logo astratto, riducendo ad oggetto, a dati empirici di
soggetti empirici, la natura: la Natura vera, cioè la realtà, si deve identificare invece con la stessa
attività dello spirito e la vera scienza con la filosofia del pensiero pensante. Le scienze naturali
costituiscono delle astrazioni che hanno valore meramente pratico, e che inglobano in sé una
posizione filosofica naturalistica, materialistica e meccanicistica.
L’arte rappresenta il sentimento come soggettività, la religione, a quella antitetica, la negazione del
soggetto in quell’oggetto che è Dio. La vera arte si realizza con la sua morte e il suo dissolversi
nella sintesi della filosofia. Lo stesso vale per la religione. La filosofia fonde insieme arte e
religione in una sintesi che le supera, che è propria del pensiero pensante: laddove la religione pone
un processo di creazione del soggetto da parte di Dio, cioè di eteroctisi, nella filosofia il soggetto
trascendentale è artefice della propria auto-creazione, ovvero dell’autoctisi, e si rivela quindi come
lo stesso Dio, non più concepito come un oggetto trascendente. La filosofia sostituisce alla
rivelazione la conoscenza, alla grazia la volontà produttrice del bene, a Dio come oggetto
trascendente un soggetto che si identifica misticamente con esso, all’immortalità dell’io empirico
l’assenza di morte per l’io trascendentale. Il male è solo un momento nella dialettica del pensiero
pensante, che nel momento in cui ne è consapevole lo supera come un errore. In questa prospettiva,
Gentile riconosce al cristianesimo lo statuto della religione più alta, inverata dalla filosofia: infatti,
il dogma dell’incarnazione, ovvero il dogma dell’Uomo-Dio in qualche modo è considerato
inverato in quel processo del pensiero pensante in cui io umano e Dio vengono a coincidere.
La stessa pedagogia di Gentile considera l’educazione come auto-educazione e riduce in qualche
modo l’altro da educare alla soggettività dell’educatore che lo pensa.
Se la storia è anche interna al pensiero pensante, allora non c’è differenza fra res gestae e historia
rerum gestarum: la storia s’identifica con la stessa storia della filosofia, e quindi con la filosofia in
quanto processo del pensiero pensante: così per fare filosofia occorre fare storia della filosofia e per
fare storia della filosofia occorre fare filosofia.
113
Per Gentile, c’è quindi una profonda unità dello spirito e non si devono distinguere varie forme di
attività come in Croce: non c’è neppure possibile distinzione fra teoria e prassi, perché il conoscere
è un fare. In effetti, però, Gentile riduce la prassi a teoria, più che la teoria a prassi: al di là dei
giochi di parole, che vorrebbero ridefinire il pensiero pensante come un’attività pratica, costruttiva e
non passiva come la contemplazione, si tratta sempre di un’attività teoretica che ha fagocitato
dentro di sé la prassi come prassi del pensiero.
Nel 1943, nel momento in cui si istituisce la repubblica di Salò, Gentile scrive Genesi e struttura
della società, pubblicato poi postumo nel 1946. Qui, si confronta con il tema della società e dello
stato etico hegeliano: neanche in questo caso però riesce a superare la sua posizione di
soggettivismo immanentistico, per cui la società è già e solo contenuta all’interno dell’io
trascendentale. Si tratta quindi di una società trascendentale (societas in interiore homine) e l’eticità
è già tutta dispiegata nel pensiero pensante dell’io trascendentale: l’unità di logica ed etica è quindi
considerata in termini di una riduzione dell’etica alla logica dialettica. Lo stato è la coscienza del
volere come volere comune e universale, e non è quindi un dato istituzionale, ma un atto stesso che
crea la nazione. La legge è volontà voluta dallo stato come autocoscienza del soggetto
trascendentale come volontà universale, come volontà volente universale, a cui devono subordinarsi
le volontà individuali. Non si può definire una libertà individuale al di fuori della società
trascendentale che si costituisce in stato, e la vera libertà è una libertà che riconosce
consensualmente allo stato il diritto di una forza coattiva degli individui. L’etica politica di Gentile
trova così la sua forma più alta nello stato etico, portando a una legittimazione dello stato totalitario
fascista. Certo, il fascismo di Mussolini è soprattutto prassi rivoluzionaria e poi statale che legittima
la violenza, ma non su un piano ideale che come tale è ancora marxianamente inteso come ideologia
che costituirebbe un’astrazione teorica dall’effettiva azione politica: non si può quindi identificare
con il neo-idealismo gentiliano, che, però, attraverso l’affermazione dell’identità di teoria e prassi e
della società trascendentale con lo stato etico-politico ne costituì un personale tentativo di
legittimazione ideologica.
114
16. Dopo Croce e Gentile
Antonio Gramsci (1891-1937) ebbe un’esistenza condizionata dalla condanna e dal carcere dove fu
dal 1928 alla morte per attività anti-fascista; ne nacquero i cosiddetti Quaderni del carcere in cui si
trovano le sue riflessioni più mature. Cercò una via personale al marxismo: fece proprie le istanze
gentiliane di identificazione di teoria e prassi, ribaltandola marxianamente in una filosofia della
prassi materiale; allo stesso modo, fece proprie le istanze della storia etico-politica di Croce che lo
portarono a una rivalutazione, rispetto alla storia puramente economica marxiana, del momento
dell’ideologia rivoluzionaria, non considerata più come una mera sovrastruttura passiva, ma come
un’attività in grado di produrre un cambiamento della struttura economica della società, svolgendo
un ruolo di egemonia culturale: l’intellettuale deve risultare organico al partito e all’azione
rivoluzionaria.
Mentre il pensiero di Croce, nonostante la qualifica del suo pensiero come una filosofia non
definitiva e contingente, come risposta storica a particolari problemi storici, diede vita, da parte dei
suoi allievi, sostanzialmente a una scolastica crociana, il pensiero di Gentile, o meglio, l’attualismo
si configurò come un movimento volto alla concretezza del pensiero, anche in direzioni molto
diverse da quella di Gentile.
Si distingue solitamente una destra gentiliana, sostanzialmente volta a riaprire una metafisica
ontologica cattolica: legati a questa tendenza si possono ricordare Armando Carlini (1878-1959) e
Augusto Guzzo (1894-1986). Si può poi anche ricordare Vincenzo La Via (1895-1982), che, data la
coincidenza di pensiero e realtà nell’attualismo, lo trasformò in un “realismo attuale” in cui non è
l’essere ridotto al pensiero, ma è il pensiero a essere ricondotto a un darsi dell’essere, con tratti
simili alla posizione di Heidegger in cui vi è rivelazione dell’essere nel pensiero.
Alla sinistra gentiliana, si riconducono l’idealismo etico di Giuseppe Saitta (1881-1958), il
problematicismo di Ugo Spirito (1896-1979), che arriva a conclusioni che riconducono la filosofia e
il pensiero in atto allo spirito scientifico problematizzante tutto. Anche Guido Calogero (19041986), viene legato alla sinistra gentiliana e all’attualismo. Tuttavia, il fraintendimento
115
dell’attualismo come movimento con l’idealismo attuale di Gentile, ha fatto sì che il pensiero di
Calogero venisse appiattito su quello di Gentile, senza che si comprendesse che ne costituiva
un’alternativa radicale.
116
17. Guido Calogero e la filosofia del dialogo
Guido Calogero (1904-1986) nasce a Roma nel 1904. Il padre, Giorgio, di origini messinesi,
studioso di letteratura francese, si era però interessato di filosofia etica e politica su cui aveva
pubblicato alcuni volumi, in particolare sul socialismo anarchico e sul pensiero di Tolstoj. La
madre, Ernesta Michelangeli, era la prima donna laureata in lettere all’Università di Messina, aveva
pubblicato un testo sulla donna in Grecia ed era figlia di Luigi Michelangeli, studioso e docente di
filologia greca. Nel 1920, Guido, educato alla letteratura pubblicò il suo primo libro: di poesie. In
università iniziò a studiare letteratura e filologia greca e solo dopo cambiò e studiò filosofia. Nel
1924 fece l’esame di storia della filosofia con Giovanni Gentile, mettendolo in difficoltà: portò tutto
Platone in greco. Si laureò subito dopo, nel 1925, con Gentile con una tesi sulla logica di Aristotele:
da questa tesi, nacque il volume su I fondamenti della logica aristotelica (1927).
Ma già del 1925 era un saggio in cui aveva definito in una prima forma la sua filosofia (Coscienza e
volontà). Ottenne la libera docenza in Storia della filosofia antica già nel 1927 (a ventitré anni) e
andò con una borsa di studio ad Heidelberg. Poi fu per tre anni incaricato di Storia della filosofia
antica all’università La Sapienza di Roma. Del 1928 è la traduzione e l’introduzione al Simposio di
Platone. Già dal 1929 fu schedato come antifascista per attività sovversiva. Dal 1929 iniziò la
collaborazione all’Enciclopedia Italiana Treccani fino al 1937, per cui scrisse migliaia di voci.
Vinse la cattedra a 27 anni, nel 1931, e andò a insegnare a Firenze. Del 1932 sono gli Studi
sull’eleatismo; nel 1934 si trasferì a Pisa dove nel 1935, finito lo straordinariato, fu nominato
professore ordinario in Storia della filosofia. A Pisa iniziò a tenere corsi anche alla Scuola Normale.
Non poté trasferirsi in altre università per la mancata adesione al partito fascista. Nel 1937 ottenne
la laurea in giurisprudenza a Siena, anche temendo l’espulsione dall’università: già dal 1937 infatti
aveva iniziato l’attività clandestina, ponendosi come un punto di riferimento per l’elaborazione del
Manifesto del liberalsocialismo, con Aldo Capitini (1899-1968) nel 1940. Pubblicò nel 1934-1936
il Compendio di Storia della Filosofia, La conclusione della filosofia del conoscere, è del 1938 (del
1960 è una seconda edizione ampliata). Del 1939 è La scuola dell’uomo (1956, in seconda edizione
117
ampliata), del 1944 Il metodo dell’economia e del marxismo, del 1945 la Difesa del
Liberalsocialismo, del 1946 Etica, giuridica, politica, del 1947 Estetica, semantica, istorica, del
1948 Logica, gnoseologia, ontologia, tre volumi (scritti in gran parte in carcere) che costituiranno le
Lezioni di Filosofia. Calogero fu arrestato il 27 Gennaio del 1942 a Firenze, sospeso e poi destituito
dalla cattedra universitaria. Poi fu condannato a 2 anni di confino e mandato al confino a Scanno,
negli Abbruzzi. Fu liberato, ma nel 1943 fu di nuovo recluso nel carcere di Bari e liberato solo dopo
la destituzione di Mussolini del 25 Luglio. Fu poi reintegrato come docente all’università di Pisa,
mentre nella prospettiva liberalsocialista, in contrasto con Croce, fondò il Partito d’Azione nel
1942-43. Dal 1948 al 1950 fu visiting professor in Canada e negli Stati Uniti.
Una sua nuova prospettiva filosofica è presentata in Logo e dialogo che è del 1950, e poi nella
Filosofia del dialogo del 1962.
Dal 1950 al 1955 fu direttore dell’istituto italiano di cultura a Londra. All’università di Roma tornò
ad insegnare Storia della filosofia antica dal 1950 al 1954 e fino al 1966 Storia della filosofia, e poi
passò a Filosofia Teoretica che insegnò fino al 1975, e nel 1981 divenne professore emerito. Nel
1967 era apparsa la Storia della logica antica, sui presocratici. Le sue pubblicazioni appurate sono
più di duemila.
E' molto importante questa doppia formazione insieme a questa doppia tipologia di ricerca, da una
parte di storia della filosofia, in particolare antica, e di filosofia teoretica, che lo ha sempre
caratterizzato. La visione della storia della filosofia, che Calogero si è fatto e che trova un primo
compimento nell'opera didattica del Compendio di Storia della filosofia, è quella che è stata seguita
fin qua: si tratta appunto del riconoscimento dell'intellettualismo greco che si contrappone al
volontarismo cristiano. Nel momento in cui il volontarismo cristiano, dopo la parentesi conciliativa
medioevale, si emancipa dalla filosofia teoretica pura espressione dell'intellettualismo greco, sorge
la modernità: il pensiero moderno è un inveramento filosofico della prospettiva cristiana della fede.
Ma questo non è che lo schema generale.
118
Calogero è stato considerato quasi sempre essenzialmente come storico della filosofia antica,
mentre la sua produzione teoretica è stata sottovaluta. La filosofia di Calogero è stata spesso
considerata come una mera variazione della posizione di Gentile: questo è accaduto anche per
l’iniziale presentazione del suo pensiero come il vero attualismo. Eventualmente, gli si è
riconosciuto il tentativo di integrare all’interno della prospettiva di Gentile quella di Croce: anche in
questo caso presentato dallo stesso Calogero come una sorta di inveramento del crocianesimo; per
cui sostanzialmente la sua filosofia non sarebbe originale, ma una sorta di sintesi, più o meno
plausibile o riuscita, di quelle due prospettive.
In verità, negli anni, Calogero ha operato una distruzione del neo-idealismo italiano di Gentile e di
Croce, e con questo, considerato come culmine di tutta una tradizione filosofica occidentale, greca e
intellettualistica, di tutta la filosofia nella sua mono-logicità e prospettato una nuova filosofia del
dialogo.
17.1 La storiografia come dialogo
Prima di entrare nei dettagli degli esiti della sua ricerca storiografica, si può brevemente delineare la
sua “metodologia”. Seppure la tematizzazione esplicita del dialogo come forma di “approccio
storiografico” sarà successiva alla formulazione della prospettiva della “filosofia del dialogo” del
1950, si può considerare già dagli inizi il suo lavoro storiografico nei termini di un’ermeneutica
dialogica. Qualsiasi testo va compreso risalendo al senso legato alle intenzioni dell’autore, il che
implica la conoscenza di tutte le competenze linguistiche, storico-contestuali, culturali necessarie.
Non si può considerare il testo scritto come un in sé, indipendentemente dall’autore. Fermarsi al
solo testo significa eliminare l’alterità che in esso si esprime: dare al testo un senso diverso da
quello voluto dall’autore non è solo forzare il testo, ma rifiutarsi di comprendere l’altro che lo ha
scritto, fare violenza all’altro. Il primo principio ermeneutico non può che essere il principio etico di
rispetto e comprensione dell’altro. In nessun modo si può evitare la soggettività della comprensione:
superare il soggettivismo rinunciando al senso, come proprio della prospettiva di Derrida e dello
strutturalismo, è del tutto impossibile. Bisogna superare l’illusione di una storiografia oggettivistica
119
di un testo o di un autore: qualsiasi forma di comprensione è legata all’esperienza, alla cultura e alla
filosofia del soggetto interpretante. La violenza non sta nel voler attribuire un senso a un testo, ma
nel non voler comprendere il senso dell’altro, nel disseminare il senso in un nichilismo ermeneutico,
come in Derrida. Si tratta invece di aprire un dialogo fra il soggetto interpretante e il soggetto
scrivente che non va mai ridotto all’oggettività impossibile di un testo. Così, in particolare, fare
storia della filosofia è far dialogare la propria prospettiva filosofica con quella dei filosofi studiati
ricompresi nella loro soggettività: questo permette di ridare rilevanza filosofica alla storia della
filosofia, che non si limita
a una mera analisi storica erudita di qualcosa di passato, ma si
caratterizza esplicitamente, come sempre non può non essere, quale una storia filosofica della
filosofia senza sovrapposizioni non esplicitate del proprio pensiero interpretante a quello
interpretando.
17.2 La storia della logica antica
La Storia della logica antica di Calogero, pubblicata nel 1967, contiene parti rilevanti già
pubblicate negli anni trenta. Esprime la consapevolezza che la storia della filosofia antica non si
contrapponga effettivamente alla storia della filosofia moderna, per la prevalenza del carattere
ontologico della prima e del carattere gnoseologico della seconda, ma solo per la indistinzione e
non-separazione nella prima di ontologia, logica e gnoseologia, e, per i pre-socratici, della realtà e
della verità del pensiero visivo e della parola.
Il pensiero arcaico è importante per comprendere gli inizi della filosofia in Grecia, gli autori presocratici.87 Come già accennato, si tratta essenzialmente di un pensiero visivo per immagini, in cui
ciò che è intuito, visto, è identificato con il reale: pensato e reale coincidono.
Il pensiero animale è un pensiero visivo, un pensiero sensibile, non un pensiero verbale basato sul
linguaggio: non c’è negli altri animali una sintesi fra funzione intellettiva e funzione comunicativa,
in cui il linguaggio è diventato il supporto su cui articolare il pensiero. Il pensiero animale è un
pensiero noetico, legato all’intuizione-visione, un pensiero intellettivo-intuitivo per immagini, e non
87
G. CALOGERO, Storia della logica antica, Laterza, Roma-Bari 1967.
120
un pensiero dianoetico88 di una ragione articolata su un linguaggio: un pensiero senza analisi e
sintesi linguistico-concettuali di esperienze percettive per mezzo delle immagini, inutile per la vita
nella sua immediatezza e legato a progettazioni di un dominio sistematico della Natura e degli altri
esseri viventi. Anche l’essere umano ha un originario pensiero visivo89, ma a cui si è sovrapposto,
fino quasi a nasconderlo e a renderlo inconscio, un pensiero verbale dominante: solo nei sogni, nelle
azioni “automatiche”, nelle arti figurative, nell’immaginazione poetica, nelle figurazioni
geometriche, si manifesta ancora un pensiero umano non-verbale, un pensiero umano visivo, per
immagini, e che originariamente si era espresso in simbolismi ideogrammatici o geroglifici90.
Conoscere è vedere e vedere ci restituisce immediatamente la realtà. Verità e realtà coincidono. I
primi filosofi traspongono nel linguaggio una logica della visione, o logica noetica, che invero
deriva da quel tipo di pensiero visivo che è la geometria antica sviluppata in un simbolismo ideogrammatico o geroglifico.91 Un tipo di logica che si basa sulla distinzione e sulle proprietà delle
varie forme, cioè su un principio di determinazione.
Solo quando si passò a una scrittura alfabetico-fonetico-lineare nacque la logica dianoetica, dal
tentativo di innestare la logica noetica nel linguaggio. Il logos filosofico, che si va separando nel
tempo dal mythos, nasce da questa esigenza di rigorizzare il linguaggio in una nuova forma di
sapere sulla base di questa logica noetica matematica, in un primo tentativo analogo a quello
posteriore della novecentesca filosofia matematica (possibile dopo la ri-matematizzazione della
88
La distinzione fra pensiero noetico e dianoetico è stata introdotta in: G. CALOGERO, I fondamenti della logica
aristotelica, Le Monnier, Firenze 1927, seconda edizione La Nuova Italia, Firenze 1968, e poi è stata rielaborata in
connessione alla distinzione fra una logica della visione e una logica della parola in: G. CALOGERO, Storia della logica
antica, Laterza, Roma-Bari 1967; G. CALOGERO, Lezioni di Filosofia I-II-III: Logica-Etica-Estetica, Einaudi, Torino
1947, seconda edizione 1960, e, in particolare, vol. I, Logica, pp. 12-24.
89
G. CALOGERO, Lezioni di Filosofia I-II-III: Logica-Etica-Estetica (1942-1943), Einaudi, Torino 1947, 1960, e in
particolare, vol. III, Estetica, pp. 164-178, 196-213.
90
A. LEROI-GOURHAN, Le geste et la parole: I. Techinque et langage; II. La mémoire et les rythmes, A. Michel, Paris
1964-65, tr. it. di F. Zannino, Il gesto e la parola, voll. I & II, Einaudi, Torino 1977, vol. I, pp. 221-254; E. R. A.
GIANNETTO, Saggi di storie del pensiero scientifico, Sestante for Bergamo University Press, Bergamo 2005, pp. 19-22;
E. GIANNETTO, Derrida, Leroi-Gourhan, la scrittura matematica e il carnologofallocentrismo, in A partire da Jacques
Derrida, a cura di G. DALMASSO, Jaca Book, Milano 2007, pp. 109-120.
91
La distinzione fra pensiero noetico e dianoetico è stata introdotta in: G. CALOGERO, I fondamenti della logica
aristotelica, Le Monnier, Firenze 1927, seconda edizione La Nuova Italia, Firenze 1968, e poi è stata rielaborata in
connessione alla distinzione fra una logica della visione e una logica della parola in: G. CALOGERO, Storia della logica
antica, Laterza, Roma-Bari 1967; G. CALOGERO, Lezioni di Filosofia I-II-III: Logica-Etica-Estetica (1942-1943),
Einaudi, Torino 1947, seconda edizione 1960, e, in particolare, vol. I, Logica, pp. 12-24.
121
logica), da cui è nata la filosofia analitica. Le prime cosmologie ioniche, pitagoriche e in generale
pre-socratiche, sono quindi delle proto-cosmo-logiche, il primo tentativo di comprendere
logicamente il mondo della physis.
In questa prospettiva, non si può parlare di verità in senso di un aletheia come verità ontologica
dell’essere: ancora non esiste un’ontologia distinta da una logica, ma l’identità di pensato e reale
implica anche l’identità di soggettivo e oggettivo. Non esiste quindi, come per Heidegger, una
prima connotazione non soggettivistica della verità; piuttosto, la verità si presenta sempre come
idea, come forma vista da un soggetto che la identifica con la realtà stessa.
La coincidenza di pensato e reale è, per questa logica della visione, anche la coincidenza di logos e
physis, ma questa coincidenza non indica una originaria connotazione ontologica del logos, come in
Heidegger, quanto il fatto che la physis si dà sempre in un logos soggettivistico umano. Così, le
antiche cosmologie sono delle cosmo-logiche; questo originario logos della visione costituisce
infatti una proto-logica intuitiva in cui sono articolate le prime cosmologie filosofiche.
Gli Studi sull’eleatismo del 1932 sono stati cruciali per questa consapevolezza: fanno comprendere
che la questione dell’essere e quindi l’ontologia nascono dall’entificazione di modalità proprie della
struttura del linguaggio greco e dalla sua logica verbale. Così, le cosmologie filosofiche si
strutturano come logiche ontologizzate, dove a una logica del vedere si va sovrapponendo e
sostituendo una logica del dire, a una logica intuitivo-visiva noetica si va giustapponendo una logica
dianoetica, e da un pensiero visivo, basato su simboli ideo-grammatici, iconici, si passa a un
pensiero verbale basato sul linguaggio e sulla sua codificazione in una scrittura alfabetico-foneticolineare. La logica nasce come onto-logica e questo indica che la logica nasce come cosmo-logica,
logica del mondo, come logos della physis, indicata dalla regolarità del moto dei corpi celesti che
implica, nell’interpretazione umana della sua non casualità e della sua ferrea (dalla solida struttura
sferica del mondo) necessità, una intelligenza intrinseca alla Natura. E l’essere umano proietta così
la propria logica sul mondo, come logica del mondo.
122
Calogero fa notare, infatti, come in Parmenide il principio d’identità non sia originariamente una
tautologia, ma presuppone l’identità in un moto ciclico rotatorio (per cui punti-stelle che appaiono
diversi sono lo stesso punto-stella, A=A’=A’’=...), cioè un’immutabilità nel moto rotatorio della
sfera, ovvero si tratta di un’invarianza per rotazione della sfera, riducibile a un’identità per un
tempo totalmente dispiegato al pensiero puro. Calogero non gli attribuisce direttamente il principio
di non-contraddizione e del terzo escluso nella Storia della Logica antica, se non con un cenno di
un ‘quasi’ quando parla invece di Empedocle, in quanto Parmenide passa subito dalla logica della
visione alla logica verbale. La determinazione noetica oggettiva deriva dalla possibilità di
ricondurre diversi percepiti ad un’unica determinazione intellettuale, e dalla possibilità di fissare in
maniera chiara e distinta le forme matematiche (celesti), le forme geometriche e le corrispondenti
forme numeriche, figure finite, limitate, dai contorni ben definiti, le cui connessioni possono essere
oggettivate in maniera indiscutibile e necessaria: per Parmenide, la struttura sferica del mondo, che
come superficie non ha parti distinguibili e limitata non ha limiti, nel puro pensiero in cui il tempo
si dispiega astrattamente come una totalità non successiva ma immediata, si mostra immobile ed
immutabile.
In Parmenide,92 si viene a delineare una prima logica della parola, una prima logica verbale che si
struttura sulla originaria logica della visione. Parmenide richiede che il linguaggio coincida con
l’intuito-pensato-visto e con il reale: bisogna allora riformare il linguaggio ed eliminare la
negazione. Solo così l’essere della copula, l’estìv, potrà coincidere con una realtà, ora concepita in
termini di essere. Si tratta di un’ipostatizzazione dell’essere come relazione fra soggetto e predicato,
in un essere della realtà. Parmenide struttura così una proto-logica verbale del giudizio, una protologica dianoetica, che si basa sul principio di determinazione e che si presenta come un’onto-logica.
Sul principio di determinazione noetica, ora anche ontologica, si costituirà il principio di non-
92
G. CALOGERO, Studi sull'eleatismo, La Nuova Italia, Firenze 1932, seconda edizione 1977; G. CALOGERO, Parmenide
e la genesi della logica classica, in Annali della Regia Scuola Normale Superiore di Pisa, serie II, v. 5 (1936), pp. 143185; G. CALOGERO, Storia della logica antica, Laterza, Roma-Bari 1967.
123
contraddizione, e da questo sarà derivato il principio del terzo escluso. L’ontologia non è che una
logica travestita, ipostatizzata.
17.3 La storia dell’etica
Lo Schizzo di una storia dell'etica è un testo breve, che risale già al 1932, ma che permette di
comprendere bene, insieme all’Introduzione al Simposio di Platone già del 1928, la prospettiva
etico-dialogica di Socrate, che sarà la base, seppure modificata in punti essenziali, della più matura
Filosofia del dialogo di Calogero, la metafisica platonica, e, in contrasto a queste, la fede cristiana,
che costituirà, pure per il non-credente Calogero, l’altro riferimento fondamentale della sua etica.
17.3.1 Prima di Socrate
Secondo Calogero, si deve riconoscere l’impossibilità di una storia dell’ethos greco che molti hanno
cercato di fare a partire da una storia della letteratura, storia dell’arte, storia della filosofia,
soprattutto per esaltare la grecità rispetto al Cristianesimo.
Possibile è certamente una storia dell’etica come disciplina filosofica autonoma, che come tale
propriamente nasce in Grecia.93 L’etica filosofica nasce svincolandosi, separandosi e opponendosi
all’etica religiosa del sapere mitico. I pensatori “pre-socratici” si oppongono all’etica dei culti
sacrificali, del carnivorismo, della predazione e della guerra della religione neolitica, legata a
divinità personali, antropomorfe e arbitrariamente capricciose nei loro voleri, e richiamano a un
ordine morale implicito nell’ordine cosmico di una Natura unitariamente considerata divina come
nella mitica età dell’oro. La Themis si esprimeva in un thesmos, in una legge divina da seguire,
corrispondente alla necessità di un ordine impersonale “oggettivo” che riesprime anche il fato del
pensiero tragico greco, con un fondamento oltreumano. Nella scuola ionica è soprattutto l’ordine
del tempo che va accettato, come in Anassimandro, nel rispetto reciproco dell’alternarsi dell’essere
e del non-essere degli enti; così in Eraclito, per cui anche il sapere filosofico è ancora una
rivelazione divina e non un sapere umano, nella considerazione della relatività del bene degli esseri
che lo induce a tener conto del bene di tutti. Nella scuola pitagorica, in cui ancora filosofia e
93
G. CALOGERO, Etica, in Enciclopedia Treccani (1932), vol. XIII, pp. 447b-454a, poi come Schizzo di una storia
dell'etica, in Saggi di Etica e di teoria del diritto, Laterza, Bari 1947, pp. 106-139.
124
rivelazione sono tutt’uno ed è sicuramente presente l’eredità orfica e mediorientale con la teoria
della reincarnazione, per cui l’etica è volta alla purificazione e alla liberazione dal ciclo delle
rinascite e il vegetarianesimo è legittimato dalla prospettiva in cui un’anima umana si è potuta
reincarnare anche in un altro essere vivente animale proprio a causa della reciproca fagocitazione.
Nella scuola eleatica, legata in parte a Pitagora e in parte alla critica all’antropomorfismo religioso
effettuata da Senofane, per cui la via dell’essere indicata da Parmenide è non solo via della Verità
ma anche della Giustizia, che si realizza nella decisione del rispetto dell’essere, e quindi della
molteplicità degli enti che compongono un essere unitario non-separabile. Ma fino a quando l’unità
uomo-Natura non è posta in dubbio, l’etica è implicita nella cosmologia, l’ordine etico è parte
dell’ordine cosmico e non richiede un’esplicita condotta che non sia implicita nella sua natura di
uomo e che vada al di là dell’accettazione dell’ordine naturale come un fato.
17.3.2 I sofisti, Socrate e la nascita dell’etica. Socrate, Platone e il Cristianesimo: un confronto
La messa in discussione dell’ordine naturale e del corrispondente ordine etico, nella convergenza di
un relativismo gnoseologico ed etico legato a un rifiuto della religione, avviene con Protagora (486411 a. C.) e la sua scuola sofistica:94 non c’è verità, si tratta semplicemente di persuadere
retoricamente gli altri alla posizione più conveniente per sé; così non c’è legge morale o politica,
ma solo una thesis come costruzione artificiale umana, come “convenzione”, imposta dai potenti
umani a loro vantaggio o accettata per convenienza, e contrapposta alla realtà effettiva della
physis.Vi è così l’affermarsi di un relativismo soggettivistico per cui bene coincide con il piacere
individuale che non si cura se questo comporta male per altri: edonismo. L’etica vera e propria,
come disciplina separata e autonoma dalla cosmologia, sorge quindi come reazione al relativismo
sofistico. E Socrate ne è il fondatore:95 è chiaro così perché Socrate non fondi l’etica in una “visione
94
G. CALOGERO, Schizzo di una storia dell'etica, in Saggi di Etica e di teoria del diritto, Laterza, Bari 1947, pp. 106139.
95
G. CALOGERO, L’età socratico-platonica nello sviluppo della logica classica, progettato come primo capitolo di un
preannunciato secondo volume della Storia della logica antica (che non sarà mai pubblicato), in Studi Filosofici (1979)
II, pp. 1-33; G. CALOGERO, Schizzo di una storia dell'etica, in Saggi di Etica e di teoria del diritto, Laterza, Bari 1947,
125
del mondo”, in quanto è proprio quella fondazione che è messa in discussione e bisogna rifondare
l’etica come sapere indipendente.
Fino a Socrate non esisteva un’etica separata: l’ordine morale era tutt’uno con l’ordine naturale del
cosmo, e con Parmenide l’etica era diventata tutt’uno con l’ontologia. Socrate reagisce ai sofisti, e
al relativismo gnoseologico da cui segue il relativismo morale: il relativismo gnoseologico fa
esplodere il problema della soggettività individuale della conoscenza della realtà; così, Socrate
cerca di fondare un’etica autonoma dalla cosmologia e dall’ontologia, che risultano soggettive. Per
Socrate, la verità etica non viene più ricercata tramite una logica della visione, ma tramite una
logica della parola e come esito di un dialogo fra più soggetti. Socrate pensa sia possibile arrivare
ad una verità unica, alla conoscenza del bene universale, attraverso il dialogo. Subordina così
ancora l’etica alla gnoseologia e alla logica: è questo l’intellettualismo etico di Socrate. La
conoscenza razionale è necessaria perché il bene è identificato con la felicità non immediata ma
globale nel tempo.
La risposta di Socrate sta, infatti, nella possibilità di giungere alla definizione di un bene oggettivo
attraverso il confronto intersoggettivo del dialogo: partendo da un dubbio metodico legato al sapere
di non sapere, attraverso la contrapposizione dei soggettivi logoi, si decostruiscono le definizioni
puramente individualistiche del bene e si afferma un concetto universale di bene, un universale
etico che nasce per induzione e astrazione dai casi particolari e individuali come un comune
invariante, per cui il vantaggio-piacere individuale si risolve nel bene universale; questo bene non è
però universale perché di tutti gli esseri, ma è universale solo nel senso in cui tutti convengono che
la felicità individuale è il bene. Non è vero che il bene è la felicità individuale, ma viceversa è la
felicità individuale che è definita dal bene. Tuttavia, anche se non si riduce il bene alla felicità
individuale, non c’è una definizione del bene in sé e il bene resta determinabile solo attraverso la
felicità individuale.
pp. 106-139; G. CALOGERO, Introduzione a, Platone, Simposio, tr. it. a cura di G. Calogero, Laterza, Bari 1928, pp. 174, poi ristampato in G. CALOGERO, Scritti minori di filosofia antica, Bibliopolis, Napoli 1985, pp. 175-228.
126
Che si tratti comunque di un’astrazione è evidente anche dalla scelta di Socrate della morte
volontaria pur di non violare la legge politica come un bene assoluto la cui validità deve comunque
sussumere ogni caso individuale. L’etica socratica così è edonistico-eudemonistica, economicoutilitaristica, anche se è l’economico a risolversi nell’etica e non viceversa: nel mondo greco si può
affermare un’etica solo legittimandola utilitaristicamente, egoisticamente. Platone spiega questa
prospettiva socratica nel suo dialogo Protagora. Il piacevole sembra non coincidere con il buono
solo in una considerazione che si limiti all’immediato presente, all’istante, non tenendo conto della
piena dimensione temporale che impone la considerazione del futuro: azioni piacevoli non buone
non tengono conto di futuri dolori maggiori del piacere presente; azioni buone non piacevoli non
tengono conto di futuri piaceri maggiori del dolore presente. L’escatologia socratica, stando
all’Apologia di Socrate e considerando solo platoniche le elaborazioni dei dialoghi successivi, è
molto semplice e rimanda o a un sonno impassibile senza sogni o a una continuazione della vita e
della prassi terrene. Non c’è quindi forse una valutazione dei piaceri che si estende a una vita
ultraterrena dopo la morte, ma solo una valutazione più ampia che quella immediata. Chiaramente,
qui sta una delle connotazioni più evidenti di quello che viene chiamato “intellettualismo socratico”,
perché l’individuazione del bene sta nel risultato di un calcolo razionale dei piaceri che va oltre
l’immediata soddisfazione istintuale: ciò implica che il bene non può essere raggiunto da un’azione
naturale nel senso puramente istintuale ma solo da un calcolo razionale teoretico che orienti la
prassi; bisogna conoscere teoreticamente il bene, perché il bene non è un dato immediato del
desiderio istintuale, ma il prodotto razionale di un calcolo dato da un’intuitiva somma integrale dei
piaceri nel tempo (in cui si contino i dolori come piaceri negativi). Si agisce male, allora, non
perché si voglia il male, ma perché non si conosce il bene. La massima virtù è quindi la conoscenza
del bene che sola permette di agire bene e che può essere insegnata. La volontà consapevole del
bene è attratta da un desiderio del bene, che è il daimon dell’eros: cioè, secondo Socrate, la
razionalità determina necessariamente la volontà fissandone univocamente le scelte. Il bene è ciò
che è consapevolmente voluto nell’azione e come tale ne è l’interno contenuto e non è qualcosa di
127
dato esternamente al volere e presente a un sapere teoretico indipendente da meramente
contemplare. Come tale, il bene è un fine futuro che non è attualmente presente; d’altra parte, per
essere criterio universale d’azione deve essere saputo, cioè presente anticipatamente alla mente nel
calcolo che lo pre-vede e da questa sempre contemplabile. Proprio questa caratteristica contribuirà a
convincere Platone che il bene sia un’idea eterna, esistente in sé, come bene in sé la cui
contemplazione teoretica sia considerata la massima attività etica dell’uomo, indipendente da
qualsiasi azione o volizione pratica.
Come Calogero spiega nell’Introduzione al Simposio di Platone del 1928, per Socrate, tuttavia,
l’eros non tende a un fine trascendente come in Platone, il bene è sempre un fine immanente: l’eros
è comunque la tendenza naturale-necessaria, per quanto consapevole, di un desiderio-volontà del
bene, che come tale è mancante, imperfetto, incompiuto, dialettica che dal male tende al bene e per
questo si manifesta come potenzialità d’azione umana, che si distingue dalla contemplazione
immota, già attuale e inattiva propria della divinità. L’eterna ricerca del bene in Socrate, viene
trasformata da Platone in una ricerca del bene eterno come idea pura. L’eros socratico-platonico,
comunque, anche quando si specifichi in amore degli altri, è sempre teso al bene inteso come
felicità individuale egoistica: l’altro, anche se non mero strumento di piacere, è sempre solo un
mezzo di felicità individuale. Socrate non sviluppa nemmeno una filosofia teoretica staccata dalla
vita: la conoscenza teoretica è quindi una consapevolezza interna alla stessa prassi della vita, legata
a un dialogo vivente e non a una scrittura morta staccata dalla vita.
Secondo Calogero, è solo con il Cristianesimo che appare una vera etica, perché anche quella
socratico-platonica dell’eros è egoistica. Il declino della civiltà ellenistico-romana vide la diffusione
di religioni misteriche, mitriache, orfico-dionisiache, di Cibele, di Atti; a livello filosofico, la ripresa
dell’escatologia orfico-pitagorica-platonica, con la negazione della vita e del mondo presente in
attesa di uno venturo, e quindi lo sviluppo di un neo-pitagorismo e di un neo-platonismo. Su tutti
questi movimenti religiosi e fiduciosi andò imponendosi il Cristianesimo: la visione escatologicaapocalittica ebraica da cui proveniva era stata in qualche modo realizzata o ribaltata; non si trattava
128
più di negare il mondo presente e di attendere un mitico mondo futuro, ma di affermare e realizzare
il mondo futuro nel presente. Questo comportava una nuova etica radicale, non come una disciplina
filosofica autonoma o parte di una teo-cosmologia o di una onto-teologia, non come parte di un
pensiero mitico-religioso, ma come una consapevole prassi di vita etica che, senza alcun
fondamento esterno, si autogenera e si autosostiene e si automoltiplica in una fede nell’Amore che
si manifesta come Dio: è la prassi etica che si fa fede, che si fa rivelazione divina.
Questa è l’etica più grande mai apparsa, anzi la prima e unica etica mai apparsa: l’etica precedente,
greca, romana, orientale, era stata solo un grande egoismo, in cui si trattava solo della propria
felicità individuale, della propria realizzazione/liberazione individuale, cura di sé in cui gli altri
esseri entrano in gioco solo in funzione di sé stessi. Anche quando Platone e Aristotele hanno
esaltato le virtù della giustizia e dell’amicizia, si è sempre trattato di virtù che erano funzionali
eudemonisticamente alla felicità individuale. L’immagine dell’Eros come un demone imperfetto
indica l’ideale greco di perfezione in una contemplazione in sé chiusa, senza volontà e azione e
amore: atarassia, apatia, adiaforia. Non bisogna scambiare la prospettiva cristiana per un’eudemonia
che si realizza in un futuro escatologico: non c’è propriamente eudemonia cristiana, si ama
indipendentemente dalla sofferenza o della felicità che ne sia effetto. Oppure si deve parlare di
amore che tende alla felicità altrui, anche se comporta propria sofferenza, e in cui la propria
sofferenza può essere vissuta come felicità che si moltiplica all’infinito per la felicità altrui: non più
cura di sé, ma cura attiva degli altri esseri, in cui l’alterità non è più mezzo per il proprio fine e
come tale oggetto, ma piena soggettività, persona e non cosa, fine e non mezzo (come sarà poi
chiaro nell’etica di Kant). La filosofia greca era di fatto solipsistica nella sua etica: era come se
l’altro non esistesse in quanto tale. Solo l’amore cristiano riconosce effettivamente l’essere
dell’altro, che non è mero dato ontologico o logicamente dimostrato, ma è riconosciuto come tale in
quella fede, fiducia consapevole, che è amore. La filosofia moderna etica non può che essere, per
Calogero, un inveramento filosofico della prassi etica cristiana.
17.3.3 Cirenaici ed Epicurei, Cinici e Stoici
129
Si comprendono così i vari sviluppi cui l’etica socratica diede vita. 96 Da un lato, si hanno i cirenaici
e i cinici, dall’altro Platone. Per i cirenaici, si può ricordare Aristippo (435-355 a. C.) di Cirene: a
lui si deve l’elaborazione propria dell’edonismo, a partire dall’identificazione del bene con ciò che è
desiderato e che dà la felicità individuale come massimo del piacere. Qui si vede l’insufficienza
dell’etica socratica che, in fondo, tesa a dimostrare che la felicità individuale è data dal bene
universale-vero e non da beni fallaci e particolari effimeri e istantanei, si basa su
un’indeterminazione del bene in sé. L’unico criterio individuato è quello del calcolo razionale del
massimo del piacere che però può essere solo intuitivo e indeterminato, legato come è a una previsione del futuro: nell’unica certezza futura della morte il massimo del piacere non sarà dato
dall’accumulo di tutti i piaceri possibili? L’edonismo di Epicuro (341-270 a. C.) si innesta
nuovamente in una cosmologia, quella atomistica di Democrito (450-360 a. C.) (erede in qualche
modo dell’empia visione ateistica di Anassagora di Clazomene (500-428 a. C.) e correlata al
pensiero tragico-fatalistico di Sofocle, Eschilo e Euripide, anch’egli allievo di Anassagora), e l’etica
non è più indipendente ma conseguenza della cosmologia: corregge l’edonismo cirenaico, in quanto
questo non è in grado di affrontare e superare i dolori della vita e non riesce a condurre a una vera e
stabile felicità individuale. Non c’è un senso della vita che sia ulteriore alla necessità naturale degli
atomi (anche se declinata come necessità del caso del moto come kinesis katà parenklisis, e anche
se non si riconduce ad un ordine cosmico divino implica una legge oggettiva), i piaceri e i desideri
soggettivi sono convenzioni non reali e la nostra propria morte non ci riguarda come dolore: l’uomo
deve quindi arrivare alla felicità individuale in una libertà che è distacco dal mondo e il massimo
piacere sta nel liberarsi dal desiderio dei piaceri la cui insoddisfazione sarebbe causa di dolori, in
una inerte quiete dell’anima come atarassia. L’edonismo si tramuta così in ascetismo e il piacere in
assenza di dolore e di sentimenti/percezioni in una contemplazione puramente intellettuale e quindi
distaccata delle vicende del mondo che non sono altro che perpetue aggregazioni e disgregazioni di
atomi nel vuoto.
96
Guido Calogero, Schizzo di una storia dell'etica, in Saggi di Etica e di teoria del diritto, Laterza, Bari 1947, pp. 106139.
130
L’esito ascetico di atarassia dell’edonismo lo avvicina alla scuola cinica che aveva interpretato la
felicità individuale socratica in termini opposti come implicante il superamento della soddisfazione
dei piaceri istintuali immediati, il superamento dei dolori immediati in un dominio di calcolo
razionale di tutti i tipi di passioni. I più importanti rappresentanti di questa prospettiva furono
Antistene (436-366 a. C.), il fondatore, e Diogene di Sinope (412-323 a. C.): si riunivano nel
Cinosarge (Cane agile), ginnasio ateniese in cui erano accettati anche i ‘semicittadini’, e furono
chiamati per questo cinici ma anche per la loro vita naturale da ‘cani randagi’, nel rifiuto della
cultura umana. Dall’ideale socratico dell’autogoverno, autarchia, e del dominio di sé e delle
passioni,
cioè
dell’enkrateia,
si
sviluppò
così
l’ideale
cinico
dell’autarkeia,
ovvero
dell’autosufficienza, che non poteva non comportare un’adiaforia, ovvero un’indifferenza alle cose
del mondo completamente svalutate, per raggiungere un’apatia, un distacco e una libertà dai legami
del mondo e conseguentemente una libertà dalla necessità dell’azione nel mondo divenuta così
inutile per raggiungere l’immota quiete dell’anima. Giustamente, allora, Calogero parla di
teologizzazione cinica dell’io che corrisponde alla simile teologizzazione dello spirito nel
buddhismo.
L’apatia cinica subisce una trasformazione reattiva nello stoicismo di Zenone di Cizio in Cipro
(336-264 a. C.), che riconduce l’etica a nuova cosmologia. Questa nuova cosmologia panteistica
considera il mondo come costituito in un ordine cosmico divino, retto da un fato razionale
espressione di un logos cosmico diffuso: in contrasto col cinismo, tutte le cose hanno quindi un
valore teologico fondamentale, ma proprio per questo l’uomo non può che accettarle con
rassegnazione, apatia, atarassia, autarchia e indifferenza di fronte agli eventi in quanto fiducioso
nella razionalità universale di ciò che accade. Si arriva così alla stessa conclusione cinica
sull’inutilità dell’intervento umano e alla stessa negazione del volere e dell’azione.
Seneca (4 a. C. – 65 d. C.), Epitteto (50-120 d. C.) e Marco Aurelio (121-180 d. C.) sviluppano
l’ideale stoico con qualche apertura in più (per esempio nella considerazione degli schiavi; Marco
Aurelio perseguitò crudelmente i cristiani).
131
17.4 Platone
(428-347 a. C.) In Platone,97 c’è un ritorno alla logica della visione per ridare un fondamento
ontologico all’etica, riducendo il bene a un’idea: la ricerca eterna del bene si traduce in una ricerca
del bene eterno. La logica della visione è legata alla conoscenza delle idee, la logica verbale del
giudizio, che si fonda su una relazione soggetto-predicato, esprime invece la partecipazione delle
cose alle idee.
La sua riflessione parte certamente da Socrate, lo prende a modello, lo fa portavoce delle sue
elaborazioni, ma certamente ne vuole costituire un superamento. L’etica di Socrate non è
conclusiva, si presta a differenti interpretazioni, la sua fondazione umana, seppure
nell’intersoggettività del dialogo, non riesce a superare comunque il soggettivismo sofista.
L’evoluzione dai primi dialoghi socratici a quelli dell’età matura testimonia in Platone l’esigenza di
rifondare l’etica socratica all’interno di una teo-cosmologia. Il bene non può essere meramente un
concetto umano, seppure universale e su cui possono convenire i vari individui; la verità non può
essere semplicemente l’esito di un dialogo umano. La teoria teo-cosmologica di Pitagora fornisce a
Platone il quadro in cui innestare e inverare l’etica socratica, precisando la prospettiva già mitica del
mondo terrestre come immagine del mondo celeste con la teoria delle divine idee-forme-numeri
eterne del cielo più alto e di cui partecipano tutte le cose terrene quali loro copie imperfette e che
costituiscono il loro vero essere al di là del divenire. La verità è un’idea divina eterna a cui l’uomo
può cercare di risalire al di là delle ombre terrene; il bene è la divinità somma, l’idea divina eterna
somma a cui tendere. Solo così si può fondare un’etica universale e oggettiva. Il bene non può
essere per Platone semplicemente il fine immanente al desiderio umano, alla volizione e all’azione
umane, ma, esistendo in sé, può essere effettivamente conosciuto nella sua realtà e non solo
indirettamente e vagamente intuito nell’anticipazione del calcolo dei piaceri, e conosciuto invero
97
Guido Calogero, Platone, in Enciclopedia Italiana, vol. XXVI (1935), pp. 510b-521b; Guido Calogero, Schizzo di
una storia dell'etica, in Saggi di Etica e di teoria del diritto, Laterza, Bari 1947, pp. 106-139); G. CALOGERO,
Introduzione a, Platone, Simposio, tr. it. a cura di G. Calogero, Laterza, Bari 1928, pp. 1-74, poi ristampato in G.
CALOGERO, Scritti minori di filosofia antica, Bibliopolis, Napoli 1985, pp. 175-228.
132
indipendentemente dall’azione, in quanto la sua realtà è spirituale, eterea, statica, perfetta e attuale
in sé non potendosi manifestare in volizioni e azioni. Anzi, in quanto realtà ideale il bene in sé
implica che l’attività etica massima non è un’azione, ma la contemplazione teoretica del bene che
comporta la beatitudine suprema. Vi è così un sapere che non è più la base della prassi, ma risulta
fine a sé stesso. La felicità individuale definitiva, vittoriosa sul dolore, è assicurata dall’escatologia
orfico-pitagorica, implicitamente negatrice della vita presente per una vita ultraterrena dell’anima
immortale, e che Platone rielabora e che prevede l’ascesa dell’anima all’idea del bene: l’eudemonia
porta così ad un’ascetica risalita attraverso la dialettica dinamica dell’eros come metaxù fra cielo e
terra, fra divinità e uomo, in cui l’eros stesso si sublima da desiderio eterno del bene a desiderio del
bene eterno, dall’amore per il corporeo, terreno, singolo ente temporale all’amore per lo spirituale,
celeste, universale essere eterno. La socratica consapevolezza del desiderio si trasforma in desiderio
della conoscenza senza desiderio.
Questa nuova considerazione del bene come idea comporta una visione dualistica dello spirito, in
cui si determina una superiorità del sapere sul volere, della teoria sulla prassi, della razionalità sul
desiderio. Da questa divisione ne consegue che il dominio del sapere sul volere non conduce a un
dover essere che non può non essere secondo una necessità naturale intrinseca, ma a un dover essere
che può non essere in caso d’indisciplina del mondo dei desideri e delle passioni e delle azioni,
secondo una specifica esigenza morale.
L’individuo è così una psyché che ha una parte razionale volta all’attività conoscitiva e una parte
irrazionale, volta alla prassi, ovvero ai desideri, agli affetti, agli impeti passionali, alle volizioni
tendenti a tradursi in azioni: la parte irrazionale è bipartita, da una parte le passioni estroverse,
dall’altra i desideri introversi. A ogni parte corrisponde una virtù: il coraggio alle passioni-impeti, la
temperanza/enkrateia ai desideri alimentari/sessuali, la sapienza/sophia alla ragione, tutte sottoposte
alla giustizia. A quest’etica della virtù che diventa una scienza corrisponde anche una politica che
riconosce nella società la classe economica corrispondente ai desideri, la classe militare
133
corrispondente agli impeti, la classe dei filosofi alla ragione e che deve costituire il governo che
domina e controlla desideri e passioni.
Se l’essere è idea, luce propria che si manifesta, la conoscenza è visione suprema. Sottesa alla
logica della parola è quindi una logica della visione, in cui si dà la verità dell’essere che però mai
sarà completamente posseduta, mai sarà conoscibile perfettamente se non solo alla fine di un’ascesi
ultraterrena e oltrecorporea che ci farà accedere direttamente alla visione suprema delle idee che
prima abbiamo solo come reminiscenza: la logica della visione si basa sulla dialettica dinamica
delle idee. Le idee si ordinano secondo una gerarchia di massima estensione e minore
comprensione: quella dell’Essere e del Bene sono di estensione massima in quanto ciascuna idea
partecipa dell’essere e del bene. La molteplicità delle idee platoniche è in qualche modo negazione
dell’unità assoluta parmenidea, ma risolve comunque il non-essere in essere-altro, nella dialettica
dell’identità e dell’alterità. Platone sfugge così ad una metafisica soggettivistica, ma riconduce la
filosofia come eros a una contemplazione teoretica negatrice della vita attiva, preparatrice alla
morte.
17.5 La logica di Aristotele
I fondamenti della logica aristotelica di Guido Calogero è un libro molto difficile, per contenuto e
per struttura (la non-presenza dei testi aristotelici solo indicati o riportati solo in greco). Adesso,
non gode di tanta fortuna perché considerato come un testo “attualista”, in cui si discuterebbe con
categorie “attualiste” Aristotele; ma questo non è affatto vero, anche se confronti dialogici con
l’attualismo sono presenti. In questo testo sono le basi di tutta la filosofia di Calogero.
Calogero spiega che, mentre, per Platone, la logica noetica è legata alla contemplazione delle idee e
la logica dianoetica del giudizio ha pure un valore ontologico perché denota la partecipazione delle
cose terrestri all’essere delle idee, della materia alla forma, invece per Aristotele, che pensa il sinolo
come un’unità originaria, la logica noetica è associata alla contemplazione degli individui reali in
‘concetti individuali’: il noema è intuitiva determinazione individuale del sinolo, sintesi in sé di
ideale e materiale; la determinazione noetica individuale lascia fuori di sé ciò che è altro da sé.
134
La logica dianoetica del giudizio perde per Aristotele qualsiasi valore ontologico e gnoseologico,
diventa meramente formale, mera esplicitazione di inerenze, sdoppiamento linguistico che fuorvia
dall’unità reale. La teoria del sillogismo, e invero tutta la logica, nasce in Aristotele in reazione ai
sofisti e ai retori per fissare le regole di un onesto colloquiare.
Il giudizio per Aristotele non ha più funzione ontologica né gnoseologica, essendo riducibile al
concetto individuale (il giudizio non è che un raddoppiato rapporto d’inerenza), e così il il
sillogismo e l’apodissi quali forme logiche di sviluppi del giudizio sono riducibili al singolo noema:
questa forma di linguaggio è legata solo al colloquio e quindi le sue regole sono regole etiche del
colloquio per capirsi e per non cadere in inganni. Anche la premessa-protasi del sillogismo (tutti gli
uomini sono mortali) non è pensata come legata ad un’induzione, che al massimo ne è una prova
empirica, ma ad un’appercezione dell’intelletto divino, che così fonda la conoscenza umana. Da
questo punto di vista, la logica aristotelica diventa puramente formale, e quindi vana esplicitazione
di ciò che è implicito. Che cosa dimostra effettivamente Calogero?
a) Che in Aristotele, dietro la logica verbale dianoetica, è presente e fondante una logica visiva
noetica, come riconosciuto pure da Heidegger in qualche modo nel §44b di Essere e tempo.
b) Che la logica dianoetica è totalmente riducibile in Aristotele alla logica noetica, anche se non
identitariamente. Calogero si accorge che alla base del principio di antifasi o di non-contraddizione
e anche del terzo escluso c’è il principio di determinazione noetica. Il principio del terzo escluso
non vale per la logica noetica. La logica noetica scoperta da Calogero in Aristotele è come la logica
intuizionista di Brouwer, ma a un livello più profondo (Heyting traduce in termini formali
dianoetici la logica noetica, per cui non si parla più di principio di determinazione, ma di principio
di non contraddizione e non si capisce più perché non dovrebbe valere il principio del terzo
escluso), la logica che soggiace al pensiero visivo geometrico e matematico.
c) Che l’ontologia di Aristotele non è che una logica ontologizzata, in un misto di logica noetica e
dianoetica, visiva e verbale. La prospettiva sul sinolo di materia e forma fuse insieme è specchio
dell’unità appercettiva del pensiero noetico, in contrasto con la prospettiva platonica della
135
partecipazione di ciò che è reale-materiale all’essere delle idee-forme che si rispecchia nella logica
dianoetica dualistica nei termini soggetto/predicato. D’altra parte, la prospettiva aristotelica della
verità come adeguazione del pensiero alla realtà, inverte la prospettiva teologica platonica
dell’adeguazione della realtà all’idea, in quanto il noema rispecchia un sinolo reale e non è mera
forma (idea, fantasia, allucinazione). Diventa così chiaro che tale garanzia o è data teologicamente
dall’intelletto divino le cui idee sono realtà (così, in Aristotele), oppure, al di là di Aristotele,
fuoriesce dalle possibilità di pensiero del singolo soggetto, sia nel senso che il pensiero deve essere
atto, azione sia anche nel senso che il pensiero va vagliato nel confronto dialogico con altri soggetti.
Il dialogo è quindi essenziale al raggiungimento della verità.
d) Che la logica noetica di Aristotele sarebbe alla base dell’unità dell’atto del pensiero pensante,
concepito come intuizione di un individuo e non universalizzante, di un vero attualismo, mentre
questa logica noetica non era riconosciuta da Gentile, che pensava comunque la logica dianoetica
aristotelica come un logo astratto rispetto al logo concreto della logica dialettica. La logica
dianoetica e la sillogistica costituiscono per Calogero una logica e una gnoseologia metafisica che
non coglie l’unità inoggettivabile e non formalizzabile del pensiero, e che è legata a una metafisica
dualistica delle sostanze e degli accidenti o degli attributi. La logica verbale e formale è una
sovrastruttura gnoseologico-metafisica. Decostruita tale logica dianoetica, è decostruita con essa
tutta la logica formale occidentale e la gnoseologia, come anche la metafisica platonica e la
metafisica sostanzialistica dualistica pure presente in Aristotele. Non ci sono leggi logiche, leggi del
pensiero oltre il principio di determinazione noetica. L’analisi di Aristotele è quella che permette a
Calogero di determinare ‘la conclusione della filosofia del conoscere’ e a prendere le distanze dagli
aspetti logico-gnoseologici dell’attualismo e dall’interpretazione gentiliana della logica aristotelica
e della logica dialettica hegeliana. D’altra parte, questa ‘conclusione’ gli sembrava già deducibile
dalla postulata illimitatezza del pensiero da parte dell’attualismo contro Kant e con Hegel:
certamente, la critica kantiana era postulata come un dovere di “pensare nei limiti dell’esperibile” e
mai come una necessità dell’essere e quindi ne seguiva l’impossibilità di pensare il noumeno;
136
Calogero pensa come metafisica la nozione di noumeno come realtà oltre il pensiero, perché non
può pensarsi una realtà che non si dia nel pensiero e quindi i limiti del pensiero sono i limiti
dell’esperienza-azione e non limiti propri (mentre la realtà è quella esperibile, non c’è realtà non
esperibile; il problema del pensiero è che quello che pensa viene ridotto a oggetto e quindi il
pensiero non può cogliere il soggetto pensante né porgli limiti).
e) Che la logica (dianoetica) non è solo tutt’uno con l’etica come nell’attualismo per cui banalmente
la teoria è prassi, ma non è altro che etica nel senso di regole di un dialogo etico in cui è bene non
contraddirsi e nel senso in cui i vari concetti della logica modale, il possibile e il necessario, come il
criterio realistico della verità e come i giudizi d’esistenza, non sono comprensibili se non in termini
di azione e non in termini di puro pensiero. Calogero si accorge che all’interno del pensiero puro,
nella teoria dei vari tipi di sillogismi compresi quelli modali, non è distinguibile la possibilità dalla
realtà o dall’esistenza, la possibilità dalla necessità, che si presentano tutte sullo stesso piano nella
stessa determinata attualità di ciò che è pensato. Cadono quindi le categorie della logica modale:
non si riesce, nella semplice assertorietà di una affermazione, a distinguere il necessario dal reale
esistente o dal possibile. Come oggetto del puro pensiero, la realtà appare necessaria nella sua
determinazione noetica; solo per una volontà agente si può distinguere una possibilità fra molte da
qualcosa di effettivamente realizzato. Qui, sorge la prospettiva calogeriana per cui l’atto di pensiero
pensante effettivo a cui tutto si può ricondurre non è di puro pensiero come nell’attualismo
gentiliano, ma è pensiero di una prassi, volontà attiva consapevole, vita attiva pensante o pensiero
vivente di uno spirito pratico: l’autocoscienza come pensiero di pensiero non solo è impossibile, ma
è anche metafisica gnoseologica che va al di là della prassi. Solo nell’azione si può distinguere il
possibile dal reale o dall’esistente o dal necessario. Il fatto è che il pensiero puro è solo della
divinità aristotelica la cui realtà è identica al pensiero del pensiero, in tutto è atto già compiuto.
Nell’essere umano il pensiero effettivo è sempre legato ad azioni, ad attività di vita, anche se
contemplativa, e quindi questi concetti sorgono e sono distinguibili solo nel pensiero che tematizza
un’azione e i suoi esiti, in una ricerca della verità che si concretizza in un’azione. Le leggi logiche
137
sono quindi leggi dell’azione determinata e compiuta in cui si ricerca la verità, leggi di un pensiero
concreto, che si concretizza nell’azione. Vi era quindi una consapevolezza implicita che si
comprende il mondo nell’azione corretta, nell’azione etica propria della vita, e che le leggi della sua
comprensione siano le leggi dell’azione compiuta. Mentre il pensiero in azione, il pensiero vivente,
il pensiero come vita non sottostà a leggi, queste riguardano il pensiero pensato e concretizzato in
azioni determinate e compiute. Il pensiero come vita, come volontà consapevole, si apre
continuamente a nuove possibili determinazioni, alla possibilità e all’alterità.
f) La negazione, da un lato, è ricollegata comunque alla determinazione noetica, dall’altro è
ricondotta all’indeterminatezza dell’alterità: così anche la negazione non si spiega nel puro
pensiero, in termini puramente logici, né ontologici (il non essere), ma nell’azione per cui il
pensiero non si chiude egoisticamente in sé stesso, ma eticamente si apre all’altro senza opposizione
dialettica.
17.6 La conclusione della filosofia del conoscere
Le conseguenze dell’indagine sulla logica aristotelica, che costituiva la sua tesi di laurea del 1925,
già presentate e anticipate nel saggio Coscienza e volontà del 1925 che aprirà poi il volume del
1938, La conclusione della filosofia del conoscere, portano quindi Calogero a una critica della
logica verbale-formale (dianoetica) e della logica dialettica (dianoetica), e quindi della gnoseologia
come erronee comprensioni del pensiero nel volerne codificare le leggi in una teoria, come alla base
di un’ontologia metafisica dualistica. Il riconoscimento della natura intuitiva originaria del pensiero
(logica noetica) ci rivela l’origine della metafisica arcaica e platonica della visione e ci apre alla
comprensione dell’illimitatezza del pensiero puro ma anche della sua impotenza a cogliere la realtà.
Nonostante quindi la sua presunta concretizzazione del pensiero, anche l’attualismo di Gentile
ricade in una metafisica idealistica e nelle astrazioni della logica e della gnoseologia. Se la filosofia
di Kant aveva in qualche modo, pur mantenendo ancora l’idea del noumeno, determinato la
conclusione della filosofia dell’essere, adesso si trattava di sancire la conclusione della filosofia del
138
conoscere. Metafisica oggettivistica ontologica e metafisica soggettivistica gnoseologica non sono
che due facce della stessa metafisica che ha le sue basi nella logica, nell’ipostatizzazione del logos
umano nelle sue varie forme della visione e della parola.
Per quanto riguarda la metafisica oggettivistica ontologica, realistica, la “realtà in sé”, spiega
Calogero, è un’astrazione, perché prescinde dall’esperienza di un soggetto, in cui invece sempre si
dà: una realtà non esperita e non esperibile da alcun soggetto non può essere che un’immaginazione
che si autocontraddice, perché nel momento in cui la si pensa è una realtà che si dà nel pensiero di
un soggetto. Se Kant fosse stato conseguente non avrebbe dovuto mantenere la nozione di
noumeno. La realtà in sé è quindi un concetto metafisico erroneo da rifiutare: non si può pensare
l’essere in sé. La realtà in sé è un concetto, il termine-oggetto di una mera conoscenza intellettuale,
come oggetto di una visione distaccata a distanza su cui non posso influire con la mia azione: anche
se non vista dagli esseri umani, secondo Berkeley la realtà esisterebbe in quanto vista-contemplata
da un Dio intellettualisticamente inteso, ma anche in questo caso si considera l’esistere e ciò che è
come ciò che è visto-contemplato, come, se addirittura non posto-creato da chi lo vede-osserva,
almeno un suo dato.
L’unica prova della gnoseologia realistica, scrive Calogero, è la permanenza del reale nel tempo al
di là dell’appercezione: la permanenza però, in prima istanza, implica eventualmente un infinito che
non è esperibile e presuppone una sostanzialità eterna non esperibile. Non solo: il visto a distanza o
con la mente, che ha come paradigma gli astri come sostanze permanenti eterne divine, idee
platoniche, potrebbe essere solo immagine o fantasma; solo agendo, toccando, ci si rende conto
della realtà. Pensata come permanente la realtà in sé rimanda a una realtà teologica, oppure creata
eternamente da Dio come già compiuta staticamente.
Ma c’è di più: la permanenza in un tempo al di là della percezione e dell’esperienza soggettiva,
anche se considerato finito, rimanda a un tempo astratto oggettivo non reale. Il pensiero puro, la
ragione teoretica pura non può cogliere il tempo nella sua effettività: lo coglie come una totalità
dispiegata staticamente di fronte a sé come una molteplicità spaziale; la costruzione kantiana è
139
allora erronea perché assume che noi non possiamo conoscere intellettualmente se non
temporalmente, mentre il tempo potrebbe apparire solo per l’azione; non potrebbe darsi tempo, non
solo per la ragione teoretica pura ma nemmeno per la ragione pratica pura. Così, Parmenide può
considerare il tempo totale come oggetto immediato del pensiero e ridurlo a una molteplicità
spaziale, e considerare il tutto, l’eon come totalità, come immutabile e negare la realtà del tempo dal
punto di vista del pensiero puro. Così, Parmenide, con tutto il fatalismo greco può pensare la realtà
come assolutamente determinata e necessaria solo quando non considerata nel suo farsi, ma
aposteriori come dato oggetto di un pensiero puro (non di un’azione) o quando il tempo è
spazializzato in relazione a un moto rotatorio ciclico considerato come un tutto, in cui si dispiega
indefinitamente la sfera dell’essere restando immobile senza cambiare luogo (che è solo della
traslazione).
Il pensiero puro, teologizzato in Aristotele, nella sua quiete e immobilità, e il soggetto
trascendentale conoscente, a sua volta teologizzato ed eternizzato, non possono cogliere il tempo, il
movimento, il mutamento;
Si tratta allora di superare l’idea di tempo come oggetto astratto del pensiero e di legarlo allora
all’azione di una volontà di un soggetto concreto e non trascendentale. Non si tratta però di una
soggettivizzazione umana del tempo, ma solo di chiarire come il soggetto possa cogliere la
temporalità della realtà: l’oggettivizzazione del tempo nel pensiero puro non lo può cogliere. Questa
considerazione del tempo non coincide con la soggettivizzazione del tempo operata da Heidegger,
dell’esserci come tempo; inoltre, nella misura in cui per Heidegger l’azione è ricondotta a
un’ontologia trascendentale, si annulla di fatto il tempo nel dispiegarlo trascendentalmente nella sua
totalità.
Così anche lo spazio non va considerato come una molteplicità astratta che si presenta
immediatamente nella sua totalità al pensiero puro, ma piuttosto come spazio in cui si esplica
l’attività di un soggetto: da ciò risulta chiaro che lo spazio non è esperibile se non temporalmente, in
140
una connessione spazio-temporale ma non astratta dall’attività di un soggetto, e che lo spazio e il
tempo sono molteplici e relativi ai differenti soggetti.
Il tempo reale è sempre tempo di un soggetto che agisce, non di un soggetto che si chiude nel
pensiero puro: per comprendere il tempo, in quanto comporta un’attività, bisogna essere soggetti
coinvolti in un’attività. La realtà che può permanere nel tempo reale al di là della nostra individuale
esperienza è realtà esperibile o esperita nel tempo dell’azione di altri, è insomma realtà sempre per
un soggetto che agisce e che la esperisce, mai realtà in sé oggettiva. Non si deve confondere la non
modificabilità di alcune realtà (lontane, più grandi) da parte della nostra azione con la loro non
esperibilità. Si esiste sempre nella reciproca esperienza attiva di altri. Da ciò ne segue che non è
possibile concepire neanche la Natura come un oggetto in sé: seppure le stelle non sono attualmente
modificabili da noi, le stelle che noi possiamo pensare come reali devono essere esperibili
attivamente da noi. Quando pensiamo a una Natura esistente in un tempo in cui l’umanità non era
presente, dobbiamo pensarla come esperibile attivamente da altre soggettività viventi non umane o
comunque sempre, potenzialmente, attivamente esperibile da una soggettività vivente; oppure
dobbiamo considerare la Natura leibnizianamente come costituita da parti che in diverso grado sono
soggettività viventi attive, e quindi si tratterebbe di concepire la Natura non come oggetto di
pensiero ma soggetto d’azione, la Natura nella sua attività come “spirito pratico”.
Il concetto come intuizione è dell’individuale: non esistono universali se non come astrazioni.
Filosofia e scienze hanno a che fare sempre con individui, non con universali: gli apparenti
universali delle scienze sono “universali empirici”, cioè scritture tachigrafiche di molteplicità di
casi individuali incontrati nella speriment-azione del soggetto umano.
Per quanto riguarda la metafisica soggettivistica gnoseologica, idealistica, si deve far notare il suo
presupposto teologico. Per Dio ogni pensiero corrisponde a una realtà perché ogni potenza è atto,
per l’essere umano, no: quindi la credenza nella realtà in sé deriva da una teologia aristotelica del
pensiero puro, come realtà somma, che la sostiene. Il pensiero puro invero non può accedere a una
realtà che non sia la sua stessa idealità. La gnoseologia idealistica crolla quindi nel non poter
141
distinguere fra possibile e reale, fra fantasia o allucinazione e realtà, e ricade nell’autoctisi
gentiliana in un delirio di onnipotenza del pensiero umano.
Il modo in cui invece il pensiero umano può corrispondere alla realtà è nella sua attuazione,
nell’essere pensiero di un’azione, altrimenti resta come pensiero-fantasia. Il criterio realistico della
verità come corrispondenza deve essere ripensato allora come un criterio della verità che si mostra
nell’azione che dà accesso alla realtà. La coscienza pura come pensiero puro non può cogliere la
realtà; solo la coscienza piena, la coscienza di sé come volontà agente, come coscienza di un mondo
(come Heidegger parla di essere-nel-mondo, ma per Calogero senza ontologizzazioni di ciò che
dipende dalla volontà e potrebbe non essere): nella risoluzione del teoretico nel pratico e del
conoscere nel fare, si ha una caratterizzazione etica dell’atto, ma l’attualismo gentiliano lo aveva
continuato a dipingere con valenze logiche e gnoseologiche. La detrascendentalizzazione del
soggetto operata da Calogero in termini di temporalità, contingenza, finitudine e volontà avvicina la
sua prospettiva alle filosofie della volontà e della vita di Schopenhauer e di Nietzsche e
all’esistenzialismo di Kierkegaard, ma la sua declinazione etica la contraddistingue fortemente.
Il concreto atto del pensiero pensante-volente per Calogero, non ammette quindi più alcuna apriorità
del soggetto che genererebbe l’oggetto appercepito, ma solo un’unità concreta dell’io e del mondo
in una dialettica etica dell’alterità che fa passare sempre dal tautòn (percepito-pensato) all’eteron
(immaginato
ideale
e
voluto)
nell’impossibilità
di
un’infinità
completamente
attuata
individualisticamente in sé: il pensiero pensante è il pensiero vivente-volente, il pensiero che si fa
azione e che è vita. L’ “idealismo” (attualista) e il “realismo” sono così entrambi superati nelle loro
astrazioni, perché la trasformazione del pensiero puro in volontà cosciente e agente, di cui il
pensiero è solo parte, come il saputo del voluto in Socrate, la trasformazione dell’atto teoretico in
atto pratico, non permette più la considerazione della realtà come parte del pensiero, ma piuttosto è
il pensiero che è parte della realtà che è attività.
Per Gentile, il mondo era interno al pensiero, ad esso immanente e quindi sua costruzione; per
Calogero, invece, il mondo non è coglibile dal pensiero puro, ma solo da un’azione-esperienza
142
consapevole etica a cui sola il mondo è interno, come interno al pensiero vivente di una prassi etica
che però come pensiero si trascende per incontrare il mondo che non gli può essere immanente
come soggettività pensante; come anche la propria stessa soggettività non può essergli immanente
non essendo possibile l’autocoscienza (il soggetto pensante è sempre diverso dal soggetto pensato
che è ridotto ad oggetto), per cui è il soggetto, il pensiero, che si realizza nell’azione immergendosi
nel mondo e non perché il mondo si fa rappresentazione: è il pensiero che deve corrispondere
nell’azione alla realtà e non la realtà che deve adeguarsi al pensiero.
Il pensiero che si fa azione raggiunge così una dimensione etica, come apertura all’altro, e tutta la
filosofia teoretica si converte in filosofia pratica, si converte effettivamente in prassi etica, perché il
problema della realtà è un problema dell’azione.
17.7 Misologia?
Questo è il titolo di un saggio di Calogero del 1935, in risposta a Croce, poi incluso ne La
conclusione della filosofia del conoscere. L’abbandono di una filosofia dello spirito teoretico,
concepita come logica o gnoseologia o teoria del conoscere o come filosofia della filosofia da parte
di Calogero era stata, infatti, oggetto di una critica di Benedetto Croce (La Critica, 33 (1935), pp.
221-222 e replica ulteriore in La Critica, 33 (1935), p. 318). L’accusa era appunto di misologia. Ma
che cosa è la misologia? Il riferimento è al Fedone di Platone (89d-91a, tr. it. di M. Valgimigli), alla
situazione d’incertezza che si era creata dopo le obiezioni di Simmia e Cebete, portate contro
l’argomentazione di Socrate che cercava di dimostrare l’immortalità dell’anima:
Ma prima di tutto bisogna stare attenti che non ci succeda un guaio. - Che guaio?, domandai. [d] Questo, disse: che non diventiamo misòlogi come si diventa misàntropi. Perché non può capitare a
uno peggior guaio di questo, che gli vengano in odio i ragionamenti. Misologia e misantropia
nascono allo stesso modo. La misantropia ci si mette indosso così, che riponiamo tutta la nostra
fiducia in qualcuno senza avere degli uomini nessuna pratica, e crediamo che costui sia la perla
della verità della sincerità e della fedeltà; e poi, dopo poco, troviamo che quest’uomo è tristo e
infido, e poi ancora lo troviamo diverso, e così avanti. Ora, se questo ci càpiti più volte, e massime
143
da parte di persone che reputassimo [e] intimissime e amicissime, si finisce, naturalmente, per le
continue delusioni, con l’odiare tutti quanti a un modo e col credere che addirittura non vi sia più
niente di schietto in nessuno. Non ti sei mai accorto tu che succede proprio così? Certamente, dissi.
- E dunque, egli disse, non è vergogna che codesto avvenga? non è evidente che colui a cui
càpitano di tali delusioni usa trattare con gli uomini senza avere nessuna pratica delle cose
umane? Perché, se trattasse con gli uomini avendone qualche conoscenza, giudicherebbe la cosa
come realmente è, e cioè che di uomini del tutto buoni e di uomini del tutto mal-[90a] vagi ce n’è
pochi da una parte e dall’altra, e che i più invece stanno nel mezzo fra gli uni e gli altri. - Come
vuoi dire?, dissi io. - Succede lo stesso, riprese, delle cose estremamente piccole e delle cose
estremamente grandi. Credi tu ci sia niente di più raro al mondo che trovare, per esempio, o un
uomo o un cane o un altro essere qualsiasi estremamente grande o estremamente piccolo? e così
pure, che trovar cosa estremamente veloce o lenta, estremamente brutta o bella, estremamente
bianca o nera? Non ti sei accorto che di tutte codeste qualità gli estremi dall’uno e dall’altro lato
sono rari e pochi, e che invece le qualità intermedie sono abbondanti e molte? - Certo, dissi io. - E
dunque, disse, non credi tu che, se si [b] facesse una gara di malvagità, ben pochi anche qui
sarebbero i primi? - E’ naturale, dissi. - Sicuro, disse, è naturale. Ma non è questo il punto in cui io
dico si possano assomigliare i ragionamenti agli uomini. Tu mi hai condotto or ora fuori strada, e
io ti son venuto dietro. Bensì è questo: e cioè che, quando uno ripone la sua fiducia in qualche
ragionamento con la persuasione che sia vero, ma senza ch’egli abbia alcuna conoscenza dell’arte
del ragionare; e poi, poco dopo, si metta in capo che codesto ragionamento è falso - e talora è
realmente falso, talora non è; - e poi di nuovo gli sembri diverso da prima, e poi ancora diverso e
così via... Ora tu sai bene [c] che sono precisamente quei tali che perdono il lor tempo a ragionare
pro e contro, i quali finiscono col credere di essere essi soli divenuti sapientissimi e di aver capito
essi soli che di tutte le cose di questo mondo non ce n’è una che sia sicura e salda, e così neanche
dei ragionamenti; e che insomma tutte quante, proprio come nell’Eurìpo, danno volta
continuamente su e giù, e che non c’è mai né un momento né un punto in cui esse rimangono ferme.
144
- Precisamente, risposi; è giusto come tu dici. - Ebbene, o Fedone, egli disse, non sarebbe dunque
una condizione lamentevole questa, di uno che, pur essendoci qualche ragionamento vero e saldo e
di cui sia pur possi-[d] bile capire che è vero e saldo; per il fatto che poi egli venga a trovarsi
dinanzi a ragionamenti i quali, per quanto siano sempre gli stessi, cioè veri o falsi, ora gli
appariscono veri ora no, non già incolpasse se medesimo e la sua particolare imperizia, ma, per il
piacere di liberarsi dal tormento di simile alternativa, finisse col respingere da sé quella ch’è
unicamente sua colpa e la gittasse addosso ai ragionamenti stessi, e così oramai seguitasse per
tutto il resto di sua vita, odiando e maledicendo ogni ragionamento, e si privasse della conoscenza
e della verità di ciò che realmente esiste? - Senza dubbio, io risposi, sarebbe una lamentevole
condizione.
- Per prima cosa dunque, egli disse, dobbiamo stare attenti a questo, e non lasciare che si faccia
strada [e] nel nostro animo il pensiero che il male abbia da essere nei ragionamenti; ma pensiamo
piuttosto che ammalati siamo noi, e bisogna comportarsi da uomini e procurare di esser sani: tu e
gli altri, per tutta la vita che vi resta ancora da vivere, io... sì, proprio per questa morte che m’è
[91a] addosso. Perché anch’io, trattando di un problema come questo in questo momento, corro il
rischio di non comportarmi da vero filosofo, bensì di voler ragione a ogni costo, come quei tali che
di educazione filosofica sono privi del tutto. Anche costoro, quando discutono intorno a qualche
argomento, non si curano già di ricercare dove sia realmente la verità in ciò di cui stanno
ragionando, bensì di fare apparir vere a chi discute con loro le questioni che essi stessi pongono;
di questo solo si preoccupano.
La replica di Calogero a Croce si basa sul fatto che la stessa pretesa concretezza del pensiero
ricercata da Gentile e lo stesso storicismo di Croce portano alla conclusione che non c’è e non ci
può essere alcuna effettiva logica o gnoseologia: non si deve e non si può fare però di questa
affermazione una certezza logica o gnoseologica positiva, perché si tratta di un’impossibilità
concreta, che si mostra nella prassi; è una verità della prassi che non può essere ridotta a teoria. Si
tratta di rifiutare la riduzione della vita a logo, di rifiutare la riduzione e l’ipostatizzazione del
145
linguaggio a strumento logico e gnoseologico mentre è mezzo di comunicazione, di dialogo: se
questa prospettiva si può chiamare misologia, allora Calogero è pronto a dichiararsi misologo. Ma
Calogero non ricade nello scetticismo, ma accetta come verità filosofiche indiscutibili queste
necessità della prassi, del dialogo, dell’etica, che si pongono sul piano della volontà consapevole e
non del pensiero puro.
17.8 La scuola dell’uomo
Compiuta questa critica, questa distruzione della tradizione metafisica occidentale, mostrata la
vanità delle costruzioni logiche del mondo, ontologiche o gnoseologiche, come “problemi da
rivivere, riconoscere e dimenticare”, Calogero passò a delineare la sua filosofia vivente, la sua
filosofia come prassi etica, quello che chiamerà il suo “moralismo assoluto” nelle lezioni de La
scuola dell’uomo, tenute all’Università di Pisa come corso di pedagogia nell’anno 1938-1939, e
pubblicate poi nel 1939: nella convinzione di una nuova identità fra vita morale ed educazione
vivente. Dato il contenuto estremamente composito delle sue varie parti, cercherò di darne qui una
descrizione sintetica per capitolo.
17.8.1 Io e gli altri.
Calogero inizia a discutere la prospettiva gentiliana dell’educazione come auto-educazione. Seppure
condivida la prospettiva per cui insegnare è sempre anche imparare ed educare anche auto-educarsi,
e per cui imparare non è ricezione passiva di un insegnamento e quindi essere educati è sempre
anche auto-educarsi, Calogero fa notare il rischio solipsistico ed egoistico di questa posizione
quando assolutizzata. L’educazione è infatti primariamente etero-educazione: si educano altri e si è
educati dagli altri. L’educazione è educazione morale e non c’è morale senza altri reali.
Certo, l’esperienza del mondo è sempre soggettiva, non si può prescindere dal soggetto che conosce
e non esiste una realtà in sé. La prospettiva della filosofia dell’essere, come quella dei metafisici e
di Heidegger, non può essere accettata: la caduta della metafisica ontologica si è avuta già con
Kant. E la caduta della metafisica, come discusso ne La conclusione della filosofia del conoscere,
implica la caduta della gnoseologia e della logica. Si tratta di vere e proprie malattie del linguaggio:
146
la logica e l’ontologia non sono che ipostatizzazioni della grammatica e della funzione verbale. Se
questa diagnosi della metafisica come malattia del linguaggio avvicina Calogero a Ludwig
Wittgenstein, la differente valutazione della logica produce una differente terapia e l’esito di
Calogero non è certo quello della logicizzazione del linguaggio ricercata da Wittgenstein, ma
piuttosto di liberarsi anche della logica come base della metafisica. Non ha senso per Calogero
effettuare un’analisi del linguaggio, a prescindere dai parlanti: significa disconoscerne la funzione
comunicativa, sostituendola con una funzione logica e gnoseologica. I problemi teorici della
filosofia si devono convertire quindi in problemi dell’azione, della prassi etica.
17.8.2 Il mondo morale
Non si può identificare l’etica con l’ontologia, come in Heidegger: questo significa annullare l’etica
come tale. Bisogna distinguere il “dover essere” dall’essere: se non fosse così, il comportamento
morale sarebbe comportamento naturale, sarebbe conseguenza necessaria del proprio essere e non
frutto di una libera scelta consapevole e responsabile. Bisogna accettare la prospettiva Kantiana del
dover essere, anche se reinterpretandola in termini non rigoristici di un dovere imposto, se non da
altri, da sé stessi. La morale si oppone essenzialmente all’ontologia, alla metafisica e alla logica,
che cercano di fondarla su esse: non ci sarebbe più libertà del volere, se esistesse un fondamento
necessario ontologico o logico della morale.
Tuttavia, l’idea di libertà del volere può essere solo la pre-condizione della moralità che si mostra
nelle azioni che si sceglie di compiere, e a nulla serve darle uno statuto ontologico-metafisico, che
contraddittoriamente la renderebbe necessaria: tutto ciò che è necessario non ha anche
un valore morale in sé. La legge morale come un programma della volontà, una volontà volente:
non si tratta di un destino, ma di un “dovere” nel senso di scelte che si devono compiere.
La legge morale non può essere puramente formale come quella di Kant: si deve presentare
concretamente come quella di Socrate o del Vangelo. L’amore del prossimo come amore personale
147
del Vangelo, Kant lo ha tradotto astrattamente nell’espressione per cui l’umanità non deve essere
considerata come mezzo ma sempre come fine.
Non c’è morale senza gli altri, ma l’esistenza degli altri è legata alla mia volontà di considerare il
loro dolore e la loro gioia come i miei: il riconoscimento morale non equivale alla mera
ricostruzione ermeneutica della loro personalità, perché si tratta dell’abnegazione di sé stessi per gli
altri, di dimenticare le mie cure per le cure degli altri: “ama il prossimo tuo come te stesso” è quindi
una traduzione che può essere fuorviante perché potrebbe essere intesa nel senso di un egoismo
allargato o di un amore che deve essere uguale all’egoismo, e sicuramente non comporta quel
rinnegamento di sé stessi (Matteo 16.21-27) o quel morire per gli altri (Giov. 15.13) che caratterizza
la vita e la morte di Gesù e la sequela da Lui richiesta. Bisogna tradurre, invece, l’insegnamento,
quando richiamato (Es. 20.12-17, Dt. 5.17-20) da Gesù nel Nuovo Testamento (Matteo 19.19, Luca
10.27, Marco 12.31, tenendo presente il ribaltamento del senso oggettivo in senso soggettivo del
prossimo di Luca 10 e seguendo l’interpretazione di Luther che elimina la connotazione egoistica
(secondo Luther, “ama il prossimo tuo, come [nel peccato ami] te stesso”)
98
: “Ama e fai l’altro
prossimo a te stesso”.
Questa abnegazione può esserci anche per animali e per piante anche senza comprensione
linguistica o logica, e anche quando potrei non essere in grado di distinguere se fossero macchine: si
tratta quindi di una comprensione più alta nell’amore, e quindi non di una logica ermeneutica ma di
un’ermeneutica dell’amore.
La morale è una fede: perché l’esistenza degli altri non è termine di una constatazione astratta del
pensiero puro, ma termine di azione etica: per riconoscere un altro debbo volerlo, il pensiero li
ridurrebbe a cose-oggetti.
Pascal prima e poi Kant hanno mostrato che il soggetto come libera volontà etica non è
empiricamente deducibile, non si può distinguere un essere volente da una macchina. Se questo
fosse possibile, riconosceremmo le azioni umane come eventi che violano le leggi di Natura che
98
A. NYGREN (1930), Eros e Agape, tr. it. di N. Gay dalla versione tedesca del 1955, a cura di F. Bolgiani, EDB,
Bologna 1990, pp. 724-731.
148
allora erano considerate meccanicistiche e deterministiche: l’essere umano non apparterrebbe alla
Natura.
Oggi che le leggi della Natura sono state sovvertite dalla fisica quantistica, si può rilevare, e
l’elettrone appare muoversi secondo una sorta di libero arbitrio aborrito da Albert Einstein (18791955), il meccanicismo e il determinismo precedenti sono stati falsificati, ma è sorto un altro tipo di
meccanicismo più sofisticato, quello che considera la Natura come una macchina calcolatrice, e
questa macchina può essere anche un “computer quantistico” che si sta cercando di realizzare: in
questo caso non è possibile distinguere comunque il comportamento umano da quello di una
macchina calcolatrice “libera”. Dal punto di vista della fisica quantistica, allora, sarebbe possibile
mostrare il comportamento libero e impredicibile del volere umano senza escludere l’essere umano
dalla Natura, ma non si potrebbe comunque escludere che un comportamento libero e impredicibile
sia di una macchina calcolatrice (l’enfasi è qui sulla libertà e non sull’intelligenza come nel test di
Turing e nelle sue modifiche).
Schopenhauer credeva di poter intuire la volontà noumenica nel proprio corpo, ma non si rendeva
conto che più precisamente la propria volontà, che non è più un noumeno per Calogero, si
comprende nel pensiero che è tutt’uno con l’azione, ma non si può sentire quella degli altri: l’etica
non è una questione di empatia fisica o naturale, ma di volontà simpatetica. Fichte poneva
l’esistenza degli altri a partire dall’io, ma non si tratta di porre-creare il non-io da parte dell’io, ma
di riconoscere effettivamente gli altri nell’azione etica.
L’amore è fede nell’Altro, non c’è bisogno di presupposizioni ontologiche su cui basare l’etica. Chi
fosse veramente solo al mondo non potrebbe uscire dal suo egoismo e non potrebbe vivere in un
mondo morale.
17.8.3 La morale come educazione
Si vuole veramente il bene dell’altro, quando questo bene non si identifichi con qualcosa che
comporta il male per altri terzi: non solo questo comportamento che comporti un male per altri terzi
149
non sarebbe morale, ma sarebbe anche diseducativo, un’affermazione dell’egoismo dell’altro.
Volere il bene dell’altro è volerlo nel bene di tutti gli altri, volere il tu insieme agli altri lui e lei. In
morale non ci sono doveri verso sé stessi.
La morale non si può basare né su un dogmatismo trascendente né su un rigorismo trascendentale,
che significano comunque obbedienza a un comando incondizionato. Volere l’abnegazione di sé
stessi per gli altri è sempre volere quello che si preferisce, altrimenti si farebbe qualcosa solo per
dovere e non per proprio impeto morale: l’impeto morale consiste nel preferire la felicità altrui alla
propria, nell’essere felici anche nella propria sofferenza per la felicità degli altri (Paolo in I Cor.
7.29-31), gusto del gusto altrui: questo non è egoismo o utilitarismo perché non si richiede nulla in
cambio, l’altro è termine di pura gratuita dedizione.
Si vuole il bene dell’altro laddove il suo bene è volere il bene di altri in un processo senza fine che
coinvolge tutti gli esseri, in una morale che è educazione: questa totalità di esseri non è limitata da
nessuna caratteristica ontologica, ma l’infinità è legata al fatto che dipende solo dalla mia volontà,
che la mia volontà etica si volge anche verso l’umanità futura e non solo per l’utilità di qualcuno o
di tutta l’umanità presente, o anche verso gli altri esseri viventi.
La moralità è questa apertura illimitata a riconoscere altri, e in questa sta la sua infinità, divinità,
eternità e non in ragioni teologiche o ontologiche.
17.8.4 La libertà
In questo riconoscimento dell’altro c’è una limitazione della mia libertà, e nel riconoscimento di
altri terzi c’è una limitazione della libertà del tu.
La libertà come una libertà della volontà, come una caratteristica trascendentale del soggetto, può
secondo Kant essere accessibile solo alla ragione pratica, ma questa definizione teoretica è
paradossale perché costituirebbe una necessità ontologica del soggetto: questa libertà del volere
equivale al volere, ed è invece la prassi a mostrarla.
150
La vera libertà che costituisce un valore morale non è quella dell’io soggetto del volere, ma la
libertà del tu oggetto del volere dell’io: la libertà dell’io è quella che si limita davanti alla libertà del
tu, e la libertà del tu quella che si limita davanti alla libertà di altri ancora.
La libertà dell’io soggetto del volere, c’è sempre necessariamente; questa libertà del tu oggetto del
volere può esserci o non esserci e dipende dalla volontà degli esseri umani, ed è quindi un ideale per
cui lottare, una libertà che si vuole e si ama e si difende ed è un valore in quanto può non esserci;
questa libertà non è eterna ma deve essere voluta eternamente.
Libertà e servitù non sono determinate dal trascendente o dal trascendentale, ma dalla nostra
volontà come fede nella moralità. La civiltà è promozione e limitazione voluta della libertà propria
per la libertà degli altri, limitazione della fruizione del mondo come mezzo per riconoscere altri
come fini. Si tratta di abnegazione della propria libertà per la libertà degli altri che a loro volta si
abneghino per altri ancora all’infinito: l’arresto di questo processo infinito, se accade, costituisce il
decadimento della morale in utilitarismo.
La mia libertà entra in gioco solo nell’educare il tu al rispetto della libertà degli altri: sarà l’altro
così a volere la mia libertà. Volere la libertà altrui è equivalente a volere il bene altrui, e questo
copre l’intera morale: non c’è bene morale che non sia convivenza di libertà. La felicità morale così
intesa in termini di libertà mostra che si basa sempre a una rinunzia al proprio arbitrio che come tale
è amorale.
La limitazione della libertà propria deve avvenire in modo da poter assicurare la libertà di tutti gli
altri senza limiti, per donazione e non per contratto utilitaristico. In questo senso, la libertà si
oppone alla giustizia, che fa riferimento se non a una norma giuridica, a un obbligo morale. Non
solo: mentre la giustizia solitamente intesa implica una parità di diritti e doveri morali o giuridici, la
libertà, che deriva dal dono dell’amore, che si ha nell’amore (la libertà è dell’azione che non ha un
secondo fine a cui è asservita: solo l’amore non ha secondi fini, si ama solo per amare), che è amore
della libertà altrui, può squilibrarsi verso gli altri e va oltre la giustizia classica che pesa ugualmente
i piatti della bilancia; la libertà dell’amore va fino all’annientamento di sé stessi per gli altri (si può
151
donare il mantello, a chi ti ruba la tunica, secondo il discorso della montagna di Gesù), fino alla
morte. Per la libertà, bisogna allora ricercare una “giustizia più alta”, bisogna ridefinire la giustizia
in termini della libertà. La giustizia sarà allora il volere la libertà giusta degli altri, ripartizione di
uguale libertà agli altri libertà anche di volere il bene altrui in eccesso rispetto al proprio o contro il
proprio. Bisogna essere giusti per libertà e in libertà, e non per dovere e in parità; bisogna essere
uguali non per natura, ma uguali nella libertà per volontà morale. In questo nuovo senso, libertà e
giustizia coincidono.
Se l’ideale della civiltà antica era l’ideale della giustizia, l’ideale della moderna civiltà cristiana è
l’amore, la libertà; la giustizia è quindi da ricomprendere non più secondo la formula “a ciascuno il
suo” che indica un dovere e una proprietà inviolabile di diritto, ma piuttosto in termini di equa
libertà, “a ciascuno secondo amore”.
17.8.5 Il diritto e la politica
L’idea di intervenire perché anche gli altri rispettino la reciproca libertà fa sorgere per Calogero la
necessità di un’autorità statale, di un diritto e di una politica che regolino e preservino questa
reciproca libertà.
D’altra parte, Calogero si confronta con la posizione di chi non si sente di porre costrizioni sulla
volontà e sulla libertà altrui, di chi auspica un ideale di non-violenza assoluta che eviti qualsiasi
forma di coercizione e che operi solo attraverso la persuasione nel dialogo e la testimonianza di
vita: non si tratta quindi di un non intervento.
La non resistenza al male, teorizzata da Tolstoj a partire dal Vangelo, ripresa da Gandhi e da tutti i
movimenti non-violenti, implica solo il non opporre male al male: si tratta piuttosto di una
resistenza passiva alla violenza, ostacolando l’esercizio della violenza su altri, mettendosi in mezzo
a scudo degli altri perché la violenza non si effettui. È questo l’ideale evangelico di una più alta
rettitudine o giustizia, l’ideale di una società degli esseri umani come dovrebbero essere, e quindi
ideale da perseguire nell’educazione e nella civiltà.
152
Calogero ammette che uno si lasci colpire da un altro per non rispondere con la violenza, ma non
ammette che si lasci colpire altri: in questo caso, però, la legge (che quindi è “solo” l’estensione
della morale all’uso della coercizione) opererebbe solo come prevenzione della violenza e non dopo
come punizione della violenza. È comunque la persuasione che deve decidere della eventuale
coercizione e non viceversa: è la costituzione accettata per convinzione che è la “legge della
formazione delle leggi”. Lo stato non è quindi che quell’attività di una parte rappresentativa di una
certa comunità sociale, volta a regolamentare l’uso della coercizione per garantire la giusta libertà.
Quando quest’obiettivo è tradito, allora lo stato legittima la violenza, l’ingiustizia, l’illibertà e la
diseguaglianza economico-sociale.
Anche l’esperienza politica non si distingue da quella giuridica se non per la distinzione fra la
funzione giurisdizionale e quella legislativa. Si tratta di un volontarismo etico-pedagogico che
estendendosi diventa giuridico-politico. C’è un’educazione giuridico-politica che è estensione di
quella morale e c’è una giurisdizione ovvero una politica dell’educazione che deve essere morale.
17.8.6 La storia, la civiltà e lo storicismo
Quest’operare morale costituisce la storia come storia della civiltà. C’è il dovere morale di
comprendere le personalità altrui di cui facciamo storiografia, senza giustificarle, e c’è il dovere di
fronte alle persone per le quali scriviamo questa storiografia. Le opere storiografiche non possono
più interessare a chi non ha più possibilità di agire, ma possono interessare chi è ancora coinvolto
nell’azione: così, si comprendono e si perdonano tutte le azioni compiute, ma si approvano e si
riprovano per chi ancora ha azioni da compiere e per cui il passato costituisce una testimonianza
positiva o negativa. La storiografia ci mette di fronte a storie di persone molto diverse, che hanno
fatto scelte diverse di vita, che sfilano davanti a noi e ci permettono di fare scelte personali anche
sulla base di quelle degli altri nel passato. Lo storico, così, da una parte, deve attenersi ai documenti
scrupolosamente e deve essere imparziale nella ricerca della verità per comprendere
ermeneuticamente l’esperienza altrui, come nell’esperienza dialogica e morale; sia per le persone
che non ci sono più sia per i fruitori della sua opera storiografica. Le opere di storiografia non
153
vengono scritte per malati o per folli, a cui potrebbe essere opportuno nascondere qualche verità sul
loro stato di salute: bisogna sempre dire la verità e non nascondere alcunché.
Dall’altra parte, pur comprendendo e perdonando, lo storico deve prendere posizione sul bene e sul
male della storia, affinché la storiografia abbia valore morale-educativo per orientare le azioni
future: così, anche la selezione dei fatti presentati va fatta in funzione di questo valore moraleeducativo, per sottolineare soprattutto quegli eventi e quei processi storici che segnano la storia
della civiltà come un’ascesa morale, a contrasto delle azioni opposte, per la loro testimonianza
etica.
Su questo punto c’è accordo con lo storicismo italiano di Benedetto Croce, anche se in esso
sopravvive, seppure modificato, tutto l’armamentario logico-dialettico di Hegel del motivo
realistico del “giudicare” e una parte di quietismo legata all’indifferenza dello storico. Lo
storicismo, certamente, riconducendo tutto alla storia, abbandona le varie realtà trascendenti e
presenta sé stesso come una mera posizione storica all’interno della storia; facendo così, però, lo
storicismo non coglie che non può pensarsi in questo modo se non all’interno della propria specifica
esperienza soggettiva, che resta sempre fuori da quella storia nel delinearla. Nella considerazione di
una storia dello Spirito come nuova divinità trascendente, inoltre, si presenta come una nuova
filosofia metafisica della storia, che ingabbia le storie dei singoli uomini che possono essere
schiacciati.
17.8.7 I pericoli dello storicismo
Lo storicismo rischia sempre di cadere nell’indifferentismo, nel quietismo, nel relativismo.
Non si deve più credere nella causalità naturale, né in senso ontologico né gnoseologico, come ciò
che ci toglierebbe libertà, né si deve credere in leggi naturali. La Natura è parte della nostra
esperienza, e la causalità e le leggi esprimono solo la necessità del passato delle nostre azioni. La
scienza della Natura non può dirci nulla sul senso e sul valore della vita, su come dobbiamo viverla
eticamente, ma è un complesso di conoscenze basate su esperienze tecniche, che possiamo usare per
154
prevedere le conseguenze di certe azioni e per valutare l’efficacia delle nostre azioni nel controllo
degli eventi della Natura.
Non bisogna quindi credere che la scienza ci fornisca un sapere superiore, nascosto a chi non si
dedica alla ricerca scientifica, relativo a una Natura, intesa come una realtà di una cosa in sé, di un
realismo metafisico. La Natura s’incontra sempre e soltanto nell’esperienza e nelle azioni
sperimentali; la scienza ha a che fare quindi solo con universali empirici che non hanno cogenza
teoretica e si distingue dalle altre forme di sapere solo per la maggiore efficacia d’azione che
consente. La conoscenza scientifica non è però inferiore alla presunta conoscenza teoretica della
filosofia, come in Croce e Gentile, perché anche la filosofia deve presentarsi come filosofia pratica
per non ricadere nella metafisica: non ci sono veri concetti o veri universali, dominio soltanto della
logica o della filosofia.
Neanche la matematica può accedere alla realtà più del puro pensiero e la cogenza che presenta è
quella del principio di determinazione della logica noetica e nulla di più (la matematica non è più
considerata come il linguaggio di Dio, ma è un nostro strumento per prevedere e anticipare nel
calcolo gli eventi): la ricerca scientifica non può quindi sfuggire più o meno di altre attività umane a
una valutazione etica. D’altra parte, questa pretesa della matematica si basava su un presupposto
teologico di una Ragione Divina che la istituisca come ciò che presiede alla storia e all’universo.
La concezione totalitaria e “infinitistica” di Dio (parmenidea e spinoziana) come una ragione
onnisciente non solo non permetterebbe la nostra moralità e la nostra responsabilità, ma non
permetterebbe neanche la nostra esistenza. E quindi il fatto stesso che ci siamo e ci poniamo
domande sulla sua esistenza è una prova dell’inesistenza di una tale divinità.
D’altra parte, il tema dell’onniscienza, derivante dalla teologia greca dell’intelletto, non è
conciliabile con la teologia cristiana della volontà onnipotente.
L’unica forma di religiosità ammissibile, esperibile, è quella cristiana in cui Dio come Amore si
manifesta nella stessa esperienza etica umana, a partire dall’esperienza dell’essere umano
considerato divino, Gesù, che ha introdotto nella storia umana quest’esperienza etica: l’idea di Dio
155
non è asserita in una duplicazione del reale oltre il reale, ma è incarnata nella storia umana singolare
di Gesù. Solo la divinità umana di Gesù può instaurarsi nella nostra esperienza e fare parte della
nostra esperienza etica: i veri cristiani non sono quelli che credono in una divinità in cui si
annullano, ma coloro che operano eticamente con Cristo e in Cristo.
Mentre l'etica normativa mira alla fondazione del giudizio morale per l'atteggiamento e per il
comportamento umano, la parenesi non si prefigge scopi conoscitivi e intellettivi. Mentre l'etica
normativa si rivolge all'intelligenza per far capire quale sia il vero giudizio morale, la parenesi si
rivolge alla volontà, al cuore, per esortare e ammonire. L’etica del Vangelo è parenetica e la fede
può essere solo parenetica (esortativa).
La provvidenza teologica, per Calogero, non appartiene all’originaria prospettiva cristiana, ma si
deve all’ellenizzazione del Cristianesimo, che causò l’innesto del razionalismo stoico nel
volontarismo cristiano, imprigionando nella ragione contemplante greca la bontà operante cristiana,
e dando adito a delle teologie della storia, della provvidenza storica, ancora presente, comunque, in
Vico, Hegel e Croce.
Si ridurrebbe la Grazia imperscrutabile a Ragione certa. L’idea della
provvidenzialità di ogni evento porta al quietismo del volere morale.
L’unica prospettiva condivisibile non è quella di una sovra-individuale ragione storica che ne regoli
il corso, ma piuttosto quella del trovare ragioni storiche delle azioni dei singoli, come implicito nel
motivo del nemo sua sponte peccat di Socrate, e del nesciunt quod faciunt e del nolite judicare del
Vangelo.
Le filosofie idealistiche della storia non duplicano il reale in un ideale separato, ma comunque
fanno del reale una manifestazione dell’ideale razionale del bene, nella prospettiva del Weltgeist e
dell’astuzia della ragione, in una esonerazione del fare morale dei singoli: per esse, la povertà non è
il frutto di un’ingiustizia, ma il necessario polo antitetico dialettico della ricchezza, voluto dallo
Spirito del Mondo, che dà ai suoi rappresentanti, Napoleone o Hitler o altri, il diritto di schiacciare
gli individui. Bisogna rideclinare invece il divenire spirituale dialettico dalla sfera della ragione alla
sfera dell’azione e della volontà.
156
Le leggi della logica e della dialettica sono cristallizzazioni delle regole di onestà nel dialogo,
nell’espressione della propria e altrui esperienza, in canoni logici e gnoseologici del pensiero e della
dimostrazione della verità, che poi, a loro volta, vengono trasformati in canoni ontologici e
metafisici della realtà. Così, la legge dell’universo è diventata la legge logica della non
contraddizione del singolo parlante o la legge dialettica della contraddizione degli opponenti nel
dialogo. Così, si è concepito il male come necessario presupposto dell’opposto bene e viceversa, per
cui il diavolo diventa l’agente della storia di Dio. L’immanentismo si risolve in relativismo.
Si deve contrapporre non la filosofia del non senso del mondo a una filosofia del senso del Logos
del mondo, ma piuttosto contrapporre a queste una filosofia della volontà morale che il mondo
abbia un senso.
La storia è storia dei singoli uomini, delle singole volizioni. Anche un momento di sofferenza di un
singolo essere umano, di un singolo ente, è un fatto storico gnoseologicamente e ontologicamente
più rilevante della storia universale, dei popoli, delle nazioni, dell’essere che costituiscono sempre
un’astrazione.
17.8.8 La storia come conquista di abitudini
Lo storicismo presenta però non solo una teologia della provvidenza razionale, ma anche una
teologia della “creazione” in relazione all’attivismo di Fichte: anche questa però è una visione
unilaterale, soggettivistica. Calogero effettua quindi tutta una critica dell'idealismo e del neoidealismo italiano, soprattutto di quello di Gentile, come complesso di novità e pure di residui
arcaici.
Si tratta di un atteggiamento che sfocia nell'ozio, perché crede di poter effettuare tutto col pensiero,
come nell'atteggiamento magico e poi miracolistico, e nella condivisione dell'ideale della tecnica,
dell'efficacia tecnica del pensiero umano: lo stesso creazionismo teologico non è, per Calogero,
altro che la sublimazione dottrinale del miracolismo tecnologico. L'ideale di una libertà assoluta
dell'io che non ha più nessun vincolo morale.
157
Bisogna liberarsi sia della provvidenza storica di Croce che dell'auto-creazione di Gentile per
salvare la prassi etica. L’educazione deve mirare all'innamoramento del bene altrui, per fare
comprendere che la gioia morale è la più alta: deve mirare a formare l'abitudine morale che
costituisce la civiltà.
17.8.9 Educazione e istruzione
Per la distinzione fra educazione pratica ed etica e istruzione teoretica, Calogero inizia a fare
un’analisi critica delle varie forme di gnoseologia.
Quando si critica la gnoseologia dell’azione, in quanto l’azione modificherebbe il reale, in qualche
modo falsificandolo, chiaramente lo si fa presupponendo la gnoseologia realistica dell’adeguazione.
In Kant, anche l’attività del pensiero è considerata come un’azione che modifica e falsifica il reale,
e quindi presuppone la concezione gnoseologica dell’adeguazione.
Qualunque gnoseologia si può ridurre a quella dell’adeguazione, se distingue la funzione teoretica
da quella pratica. L’ideale diventa quello del conoscere del conoscere, cioè del conoscere che
riflette sé stesso, come nella teologia aristotelica.
La critica moderna consiste nel mostrare che non si può definire un reale se non nel conoscere e che
l’attività teoretica è in realtà vita e cioè attività pratica essa stessa, in quanto stesso desiderio di
conoscere, e non mero conoscere, e il conoscere è fine di un desiderio (vita contemplativa: solo con
un riferimento a un pensiero incarnato nelle azioni della vita si possono comprendere le dualità fra
ideale e reale, fra possibile e necessario, fra immaginario-desiderato e reale, fra universale e
singolare-individuale). Il conoscere puro è solo quello della concezione aristotelica di Dio come
noesis noeseos che non può godere neanche di sé stesso e non può agire, all’opposto della
prospettiva cristiana.
Bisogna concludere invece con il pensiero moderno che il conoscere è agire e che le due cose non
sono distinguibili. Calogero critica poi la soluzione di Gentile, perché l’azione là resta subordinata
agli arcaismi della logica e della gnoseologia e attribuita alla somma delle attività teoretiche e
pratiche dello spirito. Croce è poi criticato perché, distinguendo teoria e prassi, subordina l’azione
158
alla gnoseologia dell’adeguazione e dell’universale, perché l’azione in sé stessa e tutto quello che vi
è legato (il sentimento, la passione in atto) potrebbero essere colti solo nel momento teoretico più
alto che comporta concetti universali, come se non ci potesse essere effettiva consapevolezza e
conoscenza se non nell’arte e nella logica e non nella vita stessa.
In questo senso, per Calogero, il conoscere è il vivere stesso e l’illuminazione della verità come luce
dello ‘spirito’ è sempre presente nella vita consapevole, ma non è un’illuminazione interiore a un
pensiero puro: l’illuminazione viene dagli altri nell’azione etica; bisogna riscrivere la poesia di
Ungaretti (non “m’illumino d’immenso”, ma piuttosto “m’illumini d’immenso”).
Dire che quella teoretica è una conoscenza superiore è possibile solo distinguendo la verità della
consapevolezza da una realtà cui avrebbe accesso solo l’attività teoretica, e così si ricadrebbe in una
gnoseologia dell’adeguazione a una realtà ontologicamente presupposta al conoscere.
17.8.10 La vita pratica e la vita scientifica
Ciò che per il senso comune è solo una distinzione di attitudini e di stili di vita, fra l’operosità
pratica e l’operosità teoretica, viene nella filosofia, come in quella crociana, ipostatizzato a una
distinzione assoluta fra due momenti dello spirito. Si tratta di distinzioni che si possono cogliere
solo facendo riferimento al passato del già fatto (factum) e al futuro del da fare (facendo). La stessa
differenza fra logica e dialettica sussiste nell’anti-teologica (nel senso greco aristotelico) del fare
che ha sempre un contenuto determinato-delimitato, ma allo stesso tempo sempre superabile
nell’alterità aperta dall’azione.
Questa distinzione è anche alla base della distinzione fra azione-atto compiuto e volizione d’azione,
cosa negata dall’idealismo gentiliano, che, a partire della negazione hegeliana della distinzione
dell’essere e del dover essere (seini e solleni sono identificati), cadeva nel delirio d’onnipotenza
creazionistico del pensiero che può porre tutto, fino al ‘volere è potere’ del fascismo mussoliniano.
L’attività teoretica come vita contemplativa, come ricerca, ha le stesse caratteristiche dell’attività
pratica, con finalità e intenzionalità del volere del suo comportamento. Anche la programmazione
dell’azione da parte dello scienziato ha un’incompletezza e un’imprevedibilità che rendono
159
possibile o meno una certa realizzazione dell’azione, che non è diversa da quella che sussiste per le
attività pratiche: solo per la ‘presunzione’ dell’essere umano che si volge a fini pratici o economici
immediati può in quel caso non sussistere.
L’idea stessa della rivelazione, per Calogero, non è altro che l’ipostasi mitica o mistica di
un’esperienza dall’esito imprevisto.
17.7.11 Le cose e il gusto delle cose
La prospettiva personale, soggettiva, dell’esperienza determina differenti modi di vedere, in
relazione a differenti ‘gusti’ che orientano differenti direzioni di vita, e non permette quindi di
accettare l’illusione di un mondo unico per tutti uguale, dato ontologicamente come indipendente
dalla molteplicità delle percezioni soggettive. I processi di astrazione e di identificazione visiva
trasposti sul piano del linguaggio, fermando nel linguaggio ciò che si è fermato nella visione,
costituisce la logica, pretendendo dagli altri che adottino lo stesso fermo linguaggio, interpretato
secondo la stessa ferma visione. Non bisogna giudicare male questo processo di astrazione e
identificazione rispetto a un presupposto piano ontologico, ma dobbiamo comprendere con
Nietzsche che c’è un bisogno pratico di fare così per un controllo tecnico delle cose come nella
fisica e nella meccanica che usano la scrittura più ferma della matematica.
Così si può comprendere come “l’attitudine a riassumere, ordinare e dominare nella memoria e
nell’azione la maggiore quantità possibile di esperienze utili” possa essere legata al mondo della
tecnica e della logica, e la pienezza del sentimento del mondo, non semplificata, sia invece connessa
al mondo dei valori e della morale.
Istruire è condurre al dominio tecnico delle cose, educare è condurre all’atteggiamento etico verso
le cose. L’istruzione raffredda spesso negli esseri umani la passione morale. Da qui si può spiegare
l’impossibilità di dimostrare l’etica logicamente; piuttosto per accettare la logica ci vuole la
disposizione etica: il richiamo alla coerenza semantica della non-contraddizione non basta per
fondare l’etica. L’indeducibilità logica non è che l’indice dell’incoercibile libertà morale. Altro è
160
parlare d’amore, comunque, altro è amare: riconoscere la necessità di una verità filosofica etica,
altro è operare eticamente.
Così, questo libro, spiega Calogero stesso, è sì l’esposizione di una prospettiva morale, ma anche
una predica morale. Da un lato, esprime una verità filosofica come dato inderogabile del suo volere,
come necessità della propria esperienza, dall’altro, è un invito agli altri a constatare la stessa
necessità del volere altruistico in loro stessi: è la proclamazione di un progetto di vita esposto con
amore perché desti amore, confessione di un gusto di carità che ha fede e speranza di essere
condiviso.
C’è anche una scuola della Natura e del suo silenzio per chi è stanco e ferito dal proprio gusto
dell’umanità, spesso deluso dall’umanità stessa.
17.8.12 L’educazione tecnica e la tecnica dell’educazione
Qui si parla della necessità dell’istruzione per l’educazione, perché è necessario appropriarsi di tutti
quegli strumenti che siano utili per l’affermazione della volontà morale. Anche per la creatività
artistica è necessaria una tecnica, e così per l’educazione morale. Studiare la poesia non è solo
conoscere tecnicamente il suo mondo espressivo e gustarla, né tantomeno estraniarsi dalla realtà,
ma piuttosto anche educare l’animo a quella passione e a quell’amore che in essa vive per fare della
vita poesia.
17.8.13 La scuola dell’arte
Né l’arte né la scienza possono restare al di sopra della morale. La prospettiva crociana dell’arte
come sintesi di immagine e sentimento è ancora valida, se spogliata dal suo carattere gnoseologico:
dire immagine è dire immagine sentita. Nel canto, l’amore deve continuare a vivere, anche se in una
forma diversa. C’è quindi un’educazione estetica. L'educazione estetica non può che coincidere con
l'educazione morale: la catarsi che si realizza nell'arte non può essere diversa dalla catarsi morale in
cui il dolore, la sofferenza sono riscattati non nella mera contemplazione di una bellezza
161
compositiva pacificatrice propria di un mondo che è diverso da quello reale e che da questo ci
aliena, ma piuttosto nell'amore reale che si trasfonde nella vera opera d’arte e trascende l'egoismo e
la sofferenza.
Le poesie, i testi, le opere, che esprimono questa purificazione ci devono stare vicino come le
compresse contro il mal di testa, perché possano ritrasmetterci quella forza morale che trascende la
sofferenza e possano costituire una continua alimentazione spirituale, un'iniezione continua di vita.
17.8.14 La scuola della religione
Qui, Calogero continua a contestare quell'esperienza religiosa di un Dio annichilente che è quello
della teologia e della mistica che derivano dalla teologia greca intellettualistica, aristotelica, che ha
fatto prevalere l'ideale contemplativo (monacale) anche all'interno del cristianesimo, per sua origine
legato all'attività della libertà e dell'amore che trascendono qualsiasi dimensione razionale
costrittiva. A questa critica di Calogero sfugge solo il misticismo etico di Albert Schweitzer.
L'assoluto, contrapposto al relativo, si presenta già in una definizione che lo rende relativo al
relativo. Ma la teologia si annida anche nelle filosofie della storia e dell'essere: hanno bisogno di
sentire fuori di sé stessi una forza che li appoggi, una ragione o un essere che guidi la storia e li
rassicuri che tutto sia razionale, ed eventualmente sia razionale stare dalla parte del vincitore.
Bisognerà liberarsi delle idee di paradiso e inferno che condizionano egoisticamente la nostra vita,
nell’attesa di una ricompensa individuale e di una punizione di altri: il paradiso è il continuare a
vivere negli altri.
Cristo non è morto in croce per la propria salvezza, ma per la salvezza degli altri! Ha insegnato a
pregare non per sé, ma per gli altri, in una dimensione comunitaria che è quella del Padre nostro.
La vera educazione religiosa è l'educazione morale, che non ha bisogno di far credere in teologismi
metafisici a chi non ne ha bisogno o di non far credere a chi invece ne ha bisogno.
Il Vangelo è il massimo testo di morale a disposizione dell'umanità.
162
Il 'questo è il mio corpo' aveva un senso di scelta di povertà e di cibi che non sacrificassero altre
vite, e quindi di dono della propria vita agli altri al contrario della fagocitazione egoistica di altri;
ma a livello teologico e liturgico è stato ridotto a egoistico impossessamento della divinità.
Anche la confessione, se non è vissuta come strumento di potere o abitudine, può essere educazione
morale.
Essere cristiani non è studiare la teologia dogmatica, ma mettere in atto la reale imitazione di Cristo.
Anche la morale, per il laico, è una religione, una fede, e, seppure è pronto a discuterne con altri, a
imparare sempre da altri e altri ancora, è una fede ferma: appartiene a una chiesa che non ammette
'tradimento di chierici'. Lavorare per questa chiesa è la sua missione, che costituisce il senso della
sua esistenza. La salvezza non è del proprio io, ma prolungamento del proprio operare morale.
Bisogna agire come se si dovesse morire subito e come se non si dovesse morire mai.
Partecipare nell’amore alla vita altrui, significa avere una vita negli altri che dura oltre la nostra
morte individuale: la resurrezione e l’ “immortalità” indicano non la sopravvivenza di un corpo
individuale da conservare-imbalsamare né la sopravvivenza di una sostanza spirituale incorporea
come l’anima platonica, ma il vivere la vita infinita dell’amore delle infinite altre vite altrui sempre
corporee-e-animate-insieme, nel dialogo infinito delle altre vite. Per questo, come dice Gesù, chi
vuole conservare la propria vita (individuale), perderà la vita (non individuale nella sua vera
dimensione).
Con Goethe, Calogero condivide la speranza che se l'attività mia è un continuo operare morale,
nella Natura stessa si avvierà un’altra forma d’esistenza in maniera che questo operare non cessi
mai.
17.9 Calogero, la filosofia pratica e la svolta comunicativa di Apel e Habermas e il
pragmatismo di Rorty
163
Ancora è grandemente vivo il dibattito, dalle origini antichissime, dei rapporti tra filosofia, etica e
politica.99 Solitamente, il problema di questi rapporti viene posto nei termini di un presunto nodo
epistemologjco fondamentale, che forse potrebbe essere racchiuso in questi tipi di quesiti: è
necessaria una fondazione filosofica (o "scientifica") dell’etica e della politica? Ma è realmente
possibile una tale fondazione? E se non lo fosse, si cadrebbe in una sorta di "relativismo" assoluto
per il quale "tutto va bene"?
Varie risposte a tali quesiti sono state date e si sono storicamente succedute: la maggior parte,
compreso il marxiano "rovesciamento della dialettica" con il tentativo di fondare un socialismo
"scientifico", ricade in quello che si potrebbe chiamare "paradigma fondazionale". In un tale
paradigma, la filosofia, se non più come metafisica dichiarata, soprattutto come teoria della
conoscenza o epistemologia, svolge un ruolo gerarchicamente dominante, riduttivo, fondativo e
normativo rispetto alle altre varie pratiche umane.
La prospettiva che qui seguirà si allontana radicalmente da un tale paradigma fondazionale. Oggi
come oggi, il rifiuto di un pensiero fondazionalista si sta diffondendo a livello mondiale in una
discreta, larga fascia di pensatori di avanzata ricerca filosofica nelle teorizzazioni della corrente
continentale dell’ermeneutica, come filosofia dell’interpretazione. Va di fatto, però, che
l’ermeneutica si avvii a divenire una filosofia puramente accademica, pacificata, ideologicamente
neutrale, un semplice "indebolimento" teorico di vecchie e definitivamente compromesse posizioni,
una nuova retorica del logos filosofico che non riesce mai ad oltrepassarsi, che non vuole rinunciare
al suo dominio sulla natura come sulle altre pratiche umane. Insomma, una filosofia formale e
vuota, sia che a-storicamente tenda a porsi come "teoria descrittiva della costituzione ermeneutica
dell’esistenza", come bene ha spesso stigmatizzato Gianni Vattimo, sia pure, tuttavia, come propone
lo stesso Vattimo, che tenda a storicizzarsi e a riconoscersi come "evento del destino", come
filosofia dell’epoca delle immagini del mondo e del loro conflitto, di quest’Europa secolarizzata,
della società della comunicazione di massa, della razionalizzazione scientifica e tecnologica del
99
E. GIANNETTO, La pratica ermeneutica del dialogos in Ermeneutica e Filosofia Pratica, a cura di N. De Domenico,
A. Escher Di Stefano e G. Puglisi, Marsilio, Venezia 1990, 99-112.
164
mondo, del passaggio ad una tecnologia informatica in cui soggetti e oggetti si vanno dileguando. In
entrambe queste tendenze, l’ermeneutica si avvia a perdere quell’eredità, che pure ha ricevuto
reinterpretandola, di tutte le riflessioni critiche sui rapporti sapere-potere che da Marx a Freud, da
Nietzsche a Foucault, a Baudrillard si sono sviluppate, ricadendo appunto in un neutrale,
ideologico, nichilismo, e lasciando elusi tutti i residui di antropocentrismo, di biocentrismo, di
violenza contenuti in ogni "logos" umano (pure quello ermeneutico) che comunque si auto-affermi.
D’altra parte, il rifiuto di un pensiero fondazionalista ha delle radici ben salde, non ha più come
semplice retroterra le istanze speculative della corrente ermeneutica: esso si può basare su delle
dimostrazioni di teoremi di impossibilità logiche che investono qualsiasi forma di sapere, quali
sistemi di proposizioni comunque giustificati o fondati; dimostrazioni che ancora prima che dai più
recenti sviluppi della corrente "analitica" derivano dallo stesso pensiero logico-scientifico, dalle
indagini di questo sui propri fondamenti. E’ solo una mistificazione filosofica quel tentativo di
aggirare gli ostacoli logico-matematici per fondare trascendentalmente il sapere, sia a livello
semiotico che "pragmatico".
Una riconsiderazione dei rapporti fra filosofia, etica e politica, da un punto di vista
antifondazionalista, implicherà allora un’analisi critica dei presupposti di tutto il pensiero filosoficoscientifico, e solo dopo si potrà impostare un discorso relativo ad etica e politica.
Un tale percorso, in effetti, è stato compiutamente realizzato nel pensiero di Guido Calogero. E’
questa, infatti, la via che seguirò: partendo da una genealogia critica della logica, si giunge a
riconoscere l’impossibilità della filosofia come teoria. Allo stesso modo, per l’etica e la politica
come discipline filosofiche: una loro fondazione logico-teorica è impossibile. Si tratta
semplicemente di pratiche discorsive non gerarchicamente ordinate. Ma, ancora, l’attestata
impossibilità di fondazione del "logos" filosofico indica il suo necessario oltrepassamento in una
pratica "ermeneutica" del dialogo (rimosso e cristallizzato nel "logos"), in una pratica etica e
politica, irriducibili alla filosofia o alla scienza e assolutamente indipendenti e irrinunciabili. E’ la
prospettiva dell’irriducibilità e dell’irrinunciabilità del dialogo che ci indica, nell’attuale non
165
realizzazione di una anarchia pura, il liberalsocialismo, come la più alta forma di democrazia
politica. Cercherò di mostrare, quindi, seguendo Calogero, che non solo una fondazione filosofica
della prassi etico-politica non è possibile, ma non è neanche necessaria: possiamo giungere
ugualmente a delle conclusioni per nulla ideologicamente neutrali.
17.9.1 La critica della logica, della gnoseologia e della teoria
Prospettive filosofiche, che muovono verso l’ermeneutica, nel rifiuto di un pensiero fondazionalista
di tipo strettamente metafisico o gnoseologico-epistemologico, si fanno oggi presenti nella
confluenza di istanze (non commensurabili) che derivano, da un lato, dalla corrente "esistenziale" o
continentale che segue da Nietzsche ed Heidegger, e, dall’altro, dagli sviluppi dello stesso pensiero
logico-scientifico e dalla corrente "analitica"100.
Seppure un’"archeologia" genealogica di tali recenti prospettive si perde, senza alcuna
presupposizione di un comune spazio di commensurabilità, nelle origini stesse del pensiero e
occidentale e orientale, uno "scavo" nell’ambito critico del neoidealismo italiano mostra, a mio
parere, come esse costituiscano anche l’originale, consapevole e pienamente articolato, esito del
pensiero di Guido Calogero. Aspetti del suo pensiero possono confrontarsi costruttivamente
soprattutto con successive e indipendenti tematizzazioni affini, seppure a volte con sviluppi
contrapposti, di Hans Gadamer (1900-2002), Karl Otto Apel (1922), Jürgen Habermas (1929),
Bruce Ackerman (1943) e Richard Rorty (1931-2007).
E l’ermeneutica come pratica del dialogo, cui giunge Calogero, non si pone come moderna "nuova
retorica" del logos. Guido Calogero muove da un’archeologia della logica che conduce alle radici
greche: la sua "ricostruzione ermeneutica" evidenzia l’effettiva valenza dei vari principi logici. Il
principio d’identità, come il principio di non contraddizione e del terzo escluso, e lo stesso ideale di
coerenza non sono altro, da una parte, che cristallizzazioni di mere regole del colloquio, di semplici
100
Si veda per esempio: K. O. APEL, Transformation der Philosophie, I-II, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1973; tr. it.
parziale di G. CARCHIA, introduzione di G. VATTIMO, Comunità e comunicazione, Rosenberg e Sellier, Torino 1977.
166
schemi verbali da seguire come "norme di onestà" nell’argomentazione; e, dall’altra parte, non sono
altro che l’espressione di particolari determinazioni delle nostre concrete esperienze101.
Come regole dell’agire comunicativo, essi nascono da una reazione, che ha inizio con Socrate e
culmina nella costruzione della sillogistica aristotelica, alle fascinazioni dell’eloquenza oratoria
propria dei sofisti102. Il tipo di coerenza formale implicita nei sillogismi, in cui è presupposta la
stabilità dei significati dei termini come quella dei termini stessi, è relativa a una specie di
situazione-limite, che cessa appena il discorso tende a farsi più complesso. Nella logica non vi è che
la grammatica, quale schematizzazione arbitraria, in funzione pratica, del linguaggio "vivente". Già
Aristotele, secondo Calogero, aveva svuotato il giudizio platonico e della sua giustificazione
metafisica e della sua imprescindibilità gnoseologica (ripresa poi da Kant), quale struttura e
fondazione, strumento e veicolo di verità, riconducendolo alla sfera propria della comunicazione
linguistica e dell’onesto argomentare. I principi logici non sono che indicazioni linguistiche per una
corretta ermeneutica, come attività interpretativa dei parlanti, e non come teoria (platonica) delle
"forme" dell’espressione razionale. La razionalità stessa non è che la cristallizzazione di una
esprimibilità linguistica. Allo stesso modo, l’essere stesso, se considerato metafisicamente
immutabile ed eterno, non è che l’ipostatizzazione ontologica della predicazione verbale, quale
espressione di una semplice pertinenza linguistica di una particolare determinazione temporale
transitoria.
Una tale decostruzione della logica si configura, così, come una decostruzione dell’ontologia, in un
percorso molto simile a quello compiuto già dal primo Wittgenstein nel tentativo di liberare la
filosofia dalle “malattie del linguaggio”: essa permette di disarticolare il linguaggio dalle
entificazioni arcaiche della sua esperienza sintattico-semantica e dalle sue connotazioni di violenza,
101
G. CALOGERO, I fondamenti della logica aristotelica, Le Monnier, Firenze 1927; G. CALOGERO, Studi sull'eleatismo,
Roma 1932, La Nuova Italia, Firenze 1977; G. CALOGERO, Parmenide e la genesi della logica classica, in Annali della
Regia Scuola Normale Superiore di Pisa, serie II, v. 5 (1936), pp. 143-185; G. CALOGERO, La conclusione della
filosofia del conoscere, Sansoni, Firenze 1938; G. CALOGERO, (1942-1943), Lezioni di filosofia I-III:I.Logica. II.Etica.
III.Estetica, Einaudi, Torino 1947-1960; G. CALOGERO, Difesa del Liberalsocialismo, Atlantica, Roma 1945; G.
CALOGERO, Logo e dialogo, Edizioni di Comunità, Milano 1950; G. CALOGERO, Filosofia del dialogo, Edizioni di
Comunità, Milano 1962; G. CALOGERO, Storia della logica antica, Laterza, Roma-Bari 1967.
102
Si confrontino le teorizzazioni molto differenti contenute in: J.HABERMAS, Moralbewusstsein und kommunikatives
Handeln, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1983; tr. it. di E.AGAZZI, Etica del discorso, Laterza, Roma-Bari 1985.
167
di tipo logico-ontologico, dalla retorica ontologica che Derrida, dopo Heidegger, riscontra nel
linguaggio stesso103.
D’altra parte, quella che si prospetta, in Calogero, è una radicale "pragmaticità" ed "empiricità"
della logica e dei suoi principi104. L’ideale della coerenza ed il non contraddirsi non sono affatto
imperativi del pensare: si deve, anzi, essere pronti a contraddirsi per correggersi, a rompere la
coerenza per aprirsi in umiltà al nuovo. Così, non esiste per il pensiero, per la sua volontà di capire,
un criterio o un canone che possano mai, effettivamente, dargli valore razionale: esistono solo delle
situazioni necessarie della sua concreta prassi; le regole della logica non sono che regole della
prassi della vita.
Il pensiero non è mai legato da "forme a priori" o "condizioni trascendentali", da leggi: è il suo
"contenuto" che presenta le "forme a posteriori" della prassi.
E’, cioè, il pensiero pensato, esplicitato, formalmente espresso in un linguaggio, che obbedisce a
regole logiche. Vi è una fatale antinomia in ogni logica come teoria del pensiero pensante: è questo,
in Calogero, il nucleo della critica teorica della logica. Tutte le volte che il pensiero pensante voglia
formulare leggi su sé stesso, voglia cogliere sé stesso come pensante, in quell’atto stesso di pensarlo
lo trasformerà in pensato; così qualsiasi asserzione di una sua legge è infirmata dal suo stesso
asserirla: l’auto-riferimento è impossibile, è auto-contraddittorio.
Questo dell’auto-riferimento è effettivamente il nodo determinante di ogni antinomia, ripresentatasi
nella moderna logica formale-matematica, su cui si sono potuti stabilire dei risultati di impossibilità:
i teoremi di Gödel di incompletezza sintattica e semantica, di indecidibilità e impossibilità di
dimostrazioni di coerenza, validità e non contraddittorietà di teorie formali; i teoremi di Löwenheim
103
J. DERRIDA (1964), Violence et métaphysique, essai sur la pensée d’Emmanuel Levinas, in L'écriture et la différence,
Seuil, Paris 1967; tr. it. di G. POZZI, in La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino 1971, pp. 99-198.
104
Esiti in questo senso derivano in fisica dalla problematica della logica quantistica: D. FINKELSTEIN, Matter Space
and Logic, in Boston Studies in the Philosophy of Science, v. 5 (1969), p. 199.
168
e Skolem sulla non adeguatezza espressiva, sulla non caratterizzabilità, e non unicità e non
isomorfismo, di modelli per teorie formali con (fino ad) un insieme numerabile di assiomi105.
Risultati che evidenziano un’assenza di fondamenti, l’assenza di un criterio di legittimazione per le
"istituzioni" della conoscenza; e da cui si delinea la transizione delle teorie scientifiche da un
carattere linguistico denotativo ad uno performativo, la loro caratterizzazione pragmatica. Le
conclusioni di Calogero sull’inesistenza di regole logiche del pensiero pensante, e sulla sua assoluta
"meta-formalità", si potrebbero presentare come delle controparti, rispettivamente, dei teoremi di
Gödel e di Löwenheim-Skolem per i sistemi formali: vi è un’indecidibilità di principi o di modelli
per il pensiero pensante descritto all’interno di qualsiasi sistema formale (pensiero esplicitato,
pensato).
Per Calogero, le norme logiche e le norme scientifiche non sono che regole pratiche: le “verità” non
sono della ragione, ma della prassi; non vi è contrapposizione tra filosofia e scienza. Quanto detto
per la logica come teoria del pensare vale per la gnoseologia o l’epistemologia come teoria del
conoscere: ogni universalità gnoseologica è inficiata dalla sua stessa asserzione. Vi è l’impossibilità
logica di una "filosofia" del conoscere, ovvero di una formalizzazione non contraddittoria del
processo conoscitivo del pensiero.
Ogni "verità" filosofica non è che la manifestazione di una impossibilità, di una incapacità di
pensare altrimenti. La critica della funzione gnoseologica del giudizio è anche critica del concetto
come strumento di razionalità, dell’universale come funzione gnoseologica, e relativa rivalutazione
dell’individuale concretezza dell’esperienza.
105
K. GÖDEL, Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica underwandter Systeme I, Montatshefte für
Mathematik und Physik 38 (1931), pp. 173-198, english translation in Gödel's Theorem in focus, a cura di S. G.
Shanker, Croom, London 1988; tr. it. a cura di P. PAGLI, Il teorema di Gödel: una messa a fuoco, Muzzio, Padova 1991;
L. LÖWENHEIM, Über Möglichkeiten im Relativkalkül, in Math. Annalen, v. 76 (1915), p. 447; TH. SKOLEM, LogischKombinatorische Untersuchungen über die Erfüllbarkeit oder Beweisbarkeit mathematischer Sätze nebst einem
Theoreme über dichte Mengen, Videnskapsselskapets Skrifter I, 4 (1920), pp. 1-13, english translation in From Frege to
Gödel. Source book in the history of mathematical logic, a cura di J. van Heijenoort, Harvard University Press,
Cambridge (Mass.) 1967, pp. 252-263; TH. SKOLEM, Über die Nichtcharakerisierbarkeit der Zahlenreihe mittels
endlich oder abzählbar unendlich vielere Aussagen mit ausschliesslich Zahlenvariabilen, in Fundamenta Mathemat. 23
(1934), pp. 150-161.
169
Il giudizio, comunque, non è che una delle forme della consapevole attività della vita: vi è anche
conoscenza non linguistica, senza giudizio. Analisi e sintesi, induzione e deduzione non svolgono
funzioni gnoseologiche, non costituiscono strutture mentali che conferiscono intrinseca razionalità
ad un loro dato: sono volontarie e consapevoli modificazioni di concrete esperienze. Anche lo
spazio ed il tempo non costituiscono ipostatizzanti categorie gnoseologiche, ma puri ambiti,
particolari del nostro consapevole esperire.
Non è corretto parlare, a rigore, né di "a priori" né di "a posteriori" nell’unità della conoscenza.
Non vi è infatti distinzione tra attività teoretica come conoscere, e pratica, come non conoscere:
"tutto è un fare" . Vi sono solo pratiche teoretico-discorsive e non: la distinzione è solo una
questione di grado nella relazione che lega l’azione, rispettivamente, meno o più ad una sua
consapevole precedente predittiva programmazione.
Caso particolare di antinomia gnoseologica è l’antinomia metodologica: è impossibile una
metodologia del conoscere. Ogni determinazione metodologica ha quella stessa contingenza
empirica che è propria di ogni regola strumentale della prassi. La ricerca (scientifica) è un’attività
della vita che non è pura, presente consapevolezza, ma implica anche una sua concreta
determinazione. Ogni consapevolezza metodologica non è che un’indicazione di comportamento,
un ricollegarsi ad una tradizione per usufruire delle esperienze dei precedenti ricercatori, ma questa
tradizione è poi concretamente modificata dalla novità di scoperte e di metodi. Tale critica della
metodologia (della scienza), derivante da un’analisi dei limiti di ogni teorizzare, si incontra adesso
con l’anarchismo metodologico che emerge dall’effettiva analisi storica della scienza, effettuata da
Paul Feyerabend106.
17.9.2 La critica di ogni filosofia come teoria
La più generale critica di ogni filosofia, come epistemologia o gnoseologia, da parte di Calogero,
ha invece molti tratti in comune, perlomeno nella tecnica decostruttiva, se non nella critica teorica o
nell’analisi storica effettiva della problematica, con quella condotta, più recentemente, da Richard
106
P. K. FEYERABEND, Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge, NBL 1975; tr. it. di L. SOSIO,
a cura di G. GIORELLO, Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza, Feltrinelli, Milano 1979.
170
Rorty107. Come in quest’ultimo, il problema epistemologico è legato al problema del soggetto,
all’"invenzione della mente". "La storia del soggetto e dell’oggetto è la storia di un errore", afferma
Calogero, che ha conclusione soltanto con l’eliminazione dell’errore stesso, cioè di questo stesso
schema dualistico. Questo schema nasce da un’indebita ipostatizzazione oggettiva, di carattere
arcaico, dei due termini del soggetto e dell’oggetto, che, caratterizzata da concezioni metaforiche
del pensiero che lo legano al modello della visione, si trova all’origine di ogni riflessione
gnoseologica. E’ in Cartesio, per Calogero come per Rorty, che si ritrova la concezione di un
soggetto come sostanza, contrapposto alla corporeità, e da cui nasce, in termini moderni, il
problema epistemologico della fondazione della conoscenza del mondo esterno, della
giustificazione del "dubitabile dall’indubitabile del mentale"108.
Anche l’attualismo, che pure ha messo l’accento sul concreto atto del pensare, ha ipostatizzato,
secondo Calogero, l’attività conoscente di un soggetto, anziché trarre le estreme conseguenze
dell’impossibilità di una teoria dell’atto di pensiero e cioè di una logica e di una gnoseologia. L’io o
la coscienza, di cui parla Calogero, non è altro che un nesso di volontà e consapevolezza, privo di
qualsiasi elemento contenutistico metafisico, come di ogni caratteristica categoriale-formale
gnoseologica
di
derivazione
kantiana,
privo
del1’ipostasi
metafisico-gnoseologica
di
un’autocoscienza: l’io si risolve in una concreta presenza esperienziale, non molto dissimile da quel
nesso di desideri e credenze che costituisce l’io di Rorty109.
La critica teorica di Rorty è per lo più interna alla filosofia analitica, della quale mantiene la
convinzione che la conoscenza sia puramente proposizionale-linguistica: così il suo discorso non
esclude la possibilità di una filosofia del linguaggio "pura", che identifica in quella elaborata da
Davidson.
Dal punto di vista di Calogero, questa filosofia del linguaggio, proprio perché per Rorty la
107
R. RORTY, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press, Princeton 1979; tr. it. di G. MILONE &
R. SALIZZONI, introduzione di D. MARCONI & G. VATTIMO, La filosofia e lo specchio della natura, Bompiani, Milano
1986.
108
G. CALOGERO, (1942-1943), Logica, in Lezioni di filosofia I-III:I.Logica. II.Etica. III.Estetica, Einaudi, Torino 1948.
109
R. RORTY, La priorità della democrazia sulla filosofia, tr. it. di F. SALZA, in Filosofia ’86 (a cura di G. VATTIMO),
Laterza, Roma-Bari 1987.
171
conoscenza è linguistica, non può che presentarsi ancora se non con inevitabili caratterizzazioni
gnoseologiche: è ancora "epistemologia travestita". La "misologia" dichiarata di Calogero è più
radicale.
La critica della metafisica (e della gnoseologia) non è effettuata da Calogero in base ad una critica
logica e linguistica del "senso" del discorso metafisico (come da parte dei neo-positivisti, della
tradizione analitica, e in parte dello stesso Rorty), in quanto, per Calogero, proprio nella logica e
nella linguistica sono da ritrovarsi le origini della metafisica come dell’ontognoseologia.
L’eliminazione del problema della gnoseologia, in particolare come problema del rapporto fra il
conoscere e l’essere, produce l’eliminazione dell’ontologia, i cui problemi si risolvono in problemi
del fare: l’essere non è che una possibile "base" dell’azione, come contrapporsi del passato al futuro
nella presenza consapevole. L’abbandono dell’impresa epistemologica"110 comporta non solo la
rinuncia all’idea di filosofia, della tradizione post-kantiana, come teoria della conoscenza e come
disciplina di fondazione della scienza, come per Rorty, ma più in generale della filosofia come
"teoria".
17.9.3 La pratica etico-politica del dialogo come oltrepassamento della filosofia teoretica
Per Calogero, un oltrepassamento del pensiero fondazionalista della metafisica e della
gnoseologia è possibile solo in termini pratici, caratterizzati “etico-politicamente”, derivabili
da una “ermeneutica” del dialogo111. E’ evidente l’affinità al percorso, seppure ad esso
incommensurabile, di Rorty, se si pensa alla sua tematizzazione della transizione
dall’epistemologia all’ermeneutica come “conversazione dell’umanità” e del “primato della
democrazia sulla filosofia”. Tuttavia, innanzitutto, Calogero evita “le conseguenze del
pragmatismo”, evidenziandone il carattere auto-contraddittorio che emerge quando questo si
voglia porre come dottrina che produca inevitabilmente un suo criterio logico-gnoseologico:
110
Per la possibilità di considerare un’epistemologia naturale e la sua dissoluzione, si veda: E. GIANNETTO,
L’epistemologia quantistica come metafora antifondazionistica, in Immagini Linguaggi Concetti (a cura di S.
PETRUCCIOLI), Theoria, Roma 1991, pp. 301-322.
111
G. CALOGERO, (1942-1943), Lezioni di filosofia I-III:I.Logica. II.Etica. III.Estetica, Einaudi, Torino 1947-1960; G.
CALOGERO, Filosofia del dialogo, Edizioni di Comunità, Milano 1962
172
teorizzare le verità in funzione della prassi negherebbe la “verità” incondizionata dello stesso
pragmatismo, quale appare nel puro esperire consapevole ma non teorizzabile. Bisogna
considerare il pragmatismo come una semplice “pratica discorsiva”, che non può mai essere
chiusa in una “teoria”. Nel pensiero non c’è alcunché che valga una volta per sempre, la cui
“verità” non sia sottoposta a critiche: la sua caratteristica è la non definitività, la sua storicità;
ma, ancora, non si deve fare di ciò stesso teoria (logico-gnoseologica), una dottrina che dia una
determinazione assoluta della natura del pensiero. Questa semplice consapevolezza non può
dire nulla in “positivo” in sede di logica o gnoseologia: non è una conquista filosofica, ma
soltanto l’enunciazione del nostro spirito di ricerca, la proclamazione della nostra modestia.
Non bisogna, quindi, concepire né la perenne novità storica, né l’illimitato superamento
evolutivo o dialettico, né la problematicità del pensiero (che non può ridursi ad accettazione
dogmatica, adeguazionistica, oggettivistica della verità della conoscenza), né lo stesso
scetticismo quali “categorie gnoseologiche”. Non c’è mai certezza su cui il pensiero possa
fondarsi, ma neanche dell’incertezza si può cartesianamente fare certezza, teoria, criterio
gnoseologico (ci sono, infatti, certezze in “negativo” contro ogni criterio gnoseologico). Questa
presenza consapevole del pensiero pensante, quando voglia effettivamente oltrepassare le sue
specifiche determinazioni e non ridursi a dottrina, a puro logos, è volontà ermeneutica di
dialogo. Mentre Platone, osserva Calogero, escogitò l’anima che dialoga con sé stessa, per
Socrate non c’è “ragionevolezza” senza effettivo dialogo con altri. Le regole pratiche del logos
sono “a posteriori” rispetto al logos altrui, e quindi rispetto all’effettivo dialogo: ognuno deve
migliorare i suoi argomenti in funzione dell’esperienza degli argomenti altrui, della
comunicazione. Se il cogito ergo sum è la situazione del logos (cartesiano), il tecum loquor
ergo es è la situazione del dialogo, afferma Calogero. Tale volontà ermeneutica di dialogo non
è fondata su verità, né da alcuna logica, gnoseologia, metafisica, che imporrebbero uno spirito
di intolleranza rispetto a ogni critica delle loro verità assolute. Il rifiuto di accettare la
posizione dogmatico-fanatica del logos non è una particolare affermazione di teoria
173
gnoseologica, ma la dichiarazione di una volontà di dialogo. E’ chiaro, quindi, come, per
Calogero, l’ermeneutica non sia una “teoria”, ma una pratica; come sia esclusa una qualsiasi
ontologia ermeneutica positiva, o di tipo puramente linguistico come l’ermeneutica del dialogo
successivamente elaborata da Hans Gadamer112: la conoscenza o la consapevolezza non si
riducono a linguaggio, e la volontà di dialogo è una volontà di comprensione al di là dei
linguaggi e del logos. Come resta esclusa qualsiasi tipo di logica ermeneutica113. Seguendo in
parte Dewey114, Calogero caratterizza la volontà ermeneutica di dialogo come un’esperienza
“morale”, di una allargata “religiosità” che non ha da costituirsi come dottrina (come in
Dewey), ma come atteggiamento da applicare a qualsiasi dottrina: è una “fede
nell’intelligenza”, nella ricerca e non in una “verità”, che riesamina continuamente l’acquisito,
e non può fondarsi non solo su alcun dogma o punto di dottrina, ma neanche su un criterio di
probabilità di un maggiore “rendimento conoscitivo”, il quale sarebbe sempre un criterio di
confronto gnoseologico. Questa volontà ermeneutica di dialogo si staglia su un’alternativa
categorica: “o hai altri di fronte a te o non li hai, o vivi un’esperienza ermeneutica di
«ricostruzione» degli altri in te o non la vivi”, afferma Calogero. Questo è un dilemma “etico”
dell’“agire comunicativo” cui non ci si può sottrarre, anche se la scelta del polo ermeneutico,
l’effettiva instaurazione del dialogo è sempre dipendente dalla volontà. Sottrarsi implicherebbe
non più un contraddirsi, ma un impossibile “contraffare”, ovvero una “contraddizione
performativa”: è questo lo stesso tipo di argomento, presentato da Karl Apel e Jürgen
Habermas per una fondazione razionale ma non deduttiva di un principio etico del dialogo, in
un contesto tematico del tutto affine se non fosse inteso, riduttivamente, in un senso puramente
linguistico, logico e gnoseologico115. Ogni logos, per Calogero invece, è da sottoporsi al
112
H. G. GADAMER, Wahrheit und Methode, Mohr, Tübingen 1960, 1965; tr. it. a cura di G. VATTIMO, Verità e metodo,
Bompiani, Milano 1990; H. G. GADAMER, Wahrheit und Methode. Erganzungen, Mohr, Tübingen 1999; tr. it. a cura di
R. DOTTORI, Verità e metodo 2. Integrazioni, Bompiani, Milano 2001.
113
J. HABERMAS, Zur Logik der Sozialwissenschaften, Mohr, Tübingen 1967; tr. it. di G. BONAZZI, Logica delle scienze
sociali, Il Mulino, Bologna 1970; P. RICOEUR, Logica ermeneutica?, in Aut-Aut nn. 217-218 (1987).
114
J. DEWEY, A Common Faith, Yale University Press, New Haven 1934; tr. it. a cura di G. CALOGERO, Una fede
comune, La Nuova Italia, Firenze 1959.
115
J. HABERMAS, Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, op. cit.
174
dialogo: non bisogna, quindi, concepire questa enunciazione di volontà di dialogo né come una
verità nella quale si attinga l’impossibilità di pensare altrimenti o di agire altrimenti, quanto
piuttosto un’assoluta volontà di non pensare altrimenti. Semplicemente non si dà teoria di
questa volontà ermeneutica di dialogo, come non si dà logica, che, diversamente, la sua validità
sarebbe subordinata alla validità logica della sua prova, di una sua qualsiasi dimostrazione:
questa sarebbe, comunque, autocontraddittoria, perché ridurrebbe il dialogos a logos come il
pensiero pensante a pensiero pensato. Al di là, quindi, dell'impossibilità teorica di ridurre il
pensiero pensante a pensiero pensato, chiuso in una logica, l'impossibilità pratica di farlo è
legata alla volontà effettiva di vivere come dialogos. Il dialogo non sottostà nemmeno al
dialogo, che lo possa affermare-fondare o negare: è indiscutibile, indubitabile a prescindere dal
consenso del logos altrui; diversamente, se ne farebbe ancora teoria, principio logico, certezza
gnoseologica. Il dialogo non “è”, accade come volontà ermeneutica: dirlo “principio” o “legge
etica”, per Calogero, significa in definitiva negarlo propriamente come principio o legge (che è
sempre e solo logica) . E' la libertà indeterminabile della presenza consapevole come volere
altruistico, senza alcuna eteronomia ad un logos che la qualifichi teoreticamente come valore o
supremo dover essere. Non è quindi la teoresi che oggettivizza, non è un atto gnoseologico a
costituire l'altro come presenza concreta di fronte a noi, accanto a noi. Il solipsismo è
superabile solo dal dialogo come volontà, che è anche l'unica consapevolezza che permette di
superare lo scetticismo ed il dogmatismo. D'altra parte, ogni sua “giustificazione” razionale,
logica non sarebbe sufficiente per la determinazione della scelta ermeneutica del dialogo. I
dubbi non si presentano più né come deficienze di certezze gnoseologiche né come certezze
gnoseologiche essi stessi: costituiscono una consapevolezza “morale” quali atti di “fede”
nell'intelligenza non individuale, ma di tutti. E' la “comunità della comunicazione”, per
Calogero, ad essere la sorgente di “valori morali”: la volontà di dialogo, come in Dewey, è una
“fede comune”; il pronome “filosofico” è il noi. Ogni conoscenza è il prodotto dell'attiva
cooperazione e comunicazione di uomini che vivono insieme: questo punto di vista
175
corrisponde allo spostamento di sistema di riferimento dalla coscienza morale isolata
(kantiana) alla comunità di discorso dei parlanti, successivamente effettuato da Apel e
Habermas116. Tuttavia, il dialogo calogeriano non si costituisce come una classe di volizioni,
ma come volontà (comune) di una classe di volizioni, e, per quanto abbia tali caratteristiche
anti-individualistiche,
non
è
possibile
entificarlo
come
un
dato
della
comunità,
oggettivisticamente e idealisticamente intesa come “a priori trascendentale-pragmatico” alla
maniera di Apel (che modifica la versione “scientista” della “comunità dei ricercatori”
tematizzata da Peirce, e riecheggia la “fusione di orizzonti” di Gadamer) ed Habermas 117: ciò
perché è da questo dialogo come volontà di comprensione dei parlanti che concretamente
deriva la comunità. Né si può considerare il dialogo stesso, come appunto in Apel ed
Habermas, come condizione trascendentale-pragmatica: il dialogo è volontà ermeneutica. Il
principio etico-dialogico di universalizzazione di Habermas, che pure ne esclude
un’applicazione nomologica, è un principio logico, di tipo induttivo, con specifiche funzioni
gnoseologiche, e di carattere puramente linguistico. Calogero è, invece, consapevole
dell’impossibilità di un’etica come sistema di proposizioni logicamente giustificate, come si
presenta, in definitiva, l’etica del discorso e di Apel e di Habermas. In questi è ancora presente
l’idea che per individuare ideali etici occorra e sia sufficiente la logica: in essi sopravvive
ancora una prospettiva logico-gnoseologica. Non si tratta di uno smascheramento nietzschiano
delle ragioni della morale: Calogero riscontra l’impossibilità di un’etica o morale come
dottrina o teoria, come logos ipostatizzato e staccato dal vivente dialogos. Non si può neanche
entificare gli altri, oggettivare la loro presenza, ipostatizzandola in una concezione ontologica,
come quella correttamente rimproverata da Derrida a Levinas: l’incontro con l’altro non è di
tipo empirico-oggettivistico, e Calogero non riduce l’ermeneutica e la comprensione a puro
116
J. HABERMAS, Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, op. cit.; K. O. APEL, Transformation der
Philosophie, I-II, op. cit. ; J. HABERMAS, Theorie des kommunikativen Handelns, I-II: 1. Handlungsrationalitat und
gesellschaftliche Rationalisierung, 2. Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1981;
tr. it. di P. RINAUDO a cura di E. RUSCONI, Teoria dell'agire comunicativo, I-II, Il mulino, Bologna 1988.
117
G. VATTIMO, Introduzione a K. O. APEL, Comunità e comunicazione, Rosenberg e Sellier, Torino 1977; C. S.
PEIRCE, Collected Papers, I-VIII, a cura di A. W. BURKS, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1931-1958.
176
linguaggio, come Gadamer o Apel o Habermas; ha, poi, comunque, sfrondato il linguaggio
dalle connotazioni di violenza di tipo logico-ontologico. La “certezza” del dialogo non è quella
di una legge che si imponga ad alcuno, negandone la libertà, perché semplicemente si constata
in me e negli altri ad avvenuta comunicazione: non si può presupporre al dialogo alcuna
necessità come condizione intrinseca dell’esistenza degli altri o della sua riconoscibilità. Il
prossimo non è chi, essendo prossimo, deve essere capito; il prossimo è chiunque, afferma
Calogero, capito nel dialogo, diviene prossimo118. Così, il dialogo non può essere condizionato
da una presupposta natura dell’altro (in quanto “persona”, “anima”, “figlio di Dio”,
“prossimo”), fosse anche la necessità di un principio etico a definirla. La volontà ermeneutica
di dialogo non pone alcuna “domanda” ontologica o gnoseologica all’altro, che implicherebbe
o il solipsismo o la risoluzione stessa dell’alterità in una gnoseologia dell’adeguazione.
L’instaurazione dell’altruità accade in accordo alla plausibilità ermeneutica, che è relativa non
.ad una semplice intelligenza “analogica” (come propria di una analogia reinterpretata dalla sua
iniziale connotazione negativa, “contrologica”, a logos, invece, alla seconda potenza, così da
poter costituire la base comune di commensurabilità fra due differenti logoi), ma propria di
un’intelligenza dialogica. La comprensione storica, per Calogero, non è che una particolare
ermeneutica del dialogo, in cui la comunità “morale” della comunicazione si estende al
passato. La “comunità della comunicazione”, per Calogero, è idealmente illimitata: essa si
estenderebbe, oltre i confini della specie “homo sapiens”, a tutti gli altri viventi (anche se,
ovviamente, perlopiù nel presente stato dell’organizzazione civile il campo dei doveri giuridici
sia limitato a quei confini). Si ammazzano i virus, responsabili di malattie, affinché non ci
ammazzino, solo perché non si è riusciti a stabilire con essi alcun rapporto di comunicazione e
di mutua volontà di capirsi: perché ogni comunicazione è, al momento, “interdetta”,
“interrotta”. Imprescindibile praticamente è, infatti, solo una comune volontà di dialogo,
118
Qui, Calogero ha fatto suo il senso della parabola evangelica del buon samaritano di Luca 10, in cui l’amore del
prossimo della Toràh è riconsiderato come un genitivo soggettivo e rivoluzionato nel suo significato: prossimo è il
“soggetto” dell’amore, non l’oggetto; prossimo si fa chi ama e l’amore è illimitato, cioè non limitato a un prossimo già
dato staticamente e appartenente a un qualunque contesto finito, come quello etnico ebraico.
177
indipendentemente da ogni fisica o metafisica differenza di natura. Ma, come non si può
definire coloro che si vogliano intendere in alcuna classe ontologica di enti (ci mostreranno
loro la propria irriducibile presenza dialogante), allo stesso modo, non si può diffonderli
ovunque, considerando il dialogo come una relazione onnipresente data nell’universo: non
bisogna entificare, oggettivare i termini della relazione o gli interlocutori del dialogo. L’altro è
tale solo in quanto si mostra tale nella illimitata volontà di dialogo: la sola molteplicità,
immune dalla convenzionalità aritmetica, è, per Calogero, quella dei partecipanti al dialogo,
accettabile solo in base al suo esercizio e alla sua volontà. Calogero si dimostra consapevole,
cosi, dell’impossibilità, già riscontrata da Schopenhauer119, di un’etica della non violenza
assoluta, in relazione all’interdizione del dialogo nella natura nei conflitti fra i viventi, quando
la volontà di vivere individualistica domini la volontà di dialogo.
In ogni caso, nelle Lezioni di Filosofia di Guido Calogero120 è chiarito pienamente come, anche
oggi che prevale una forma di pensiero logico-verbale, linguistico, legato appunto a linguaggi o
scritture fonetiche, è possibile comprendere che pensare è prima di tutto una sorta di
percezione interna, di visione interna: pensare è pensare per immagini, è immaginare, ideare. E
solo in questa prospettiva si può comprendere come il pensiero non nasca con l’uomo e
superare il fondamento stesso dell'antropocentrismo e dello specismo: tipiche dell’uomo sono
le pratiche simboliche in cui il pensiero umano si estrinseca, ma vi è un pensiero animale quale
associazione interna di immagini, ideazione-visione interna; la differenza è solo di grado
d'elaborazione e di contenuti, non sostanziale o formale121.
La sua “etica “ non è mai dottrina, etica come disciplina filosofica; è semplice consapevole
volontà pratica ermeneutica del dialogo. Cosi, il consenso fra dialoganti non è, per Calogero,
né un mero indizio di una preesistente comune razionalità, né un possibile strumento di
119
A. SCHOPENHAUER, Die Welt als Wille und Vorstellung, Brockhaus, Leipzig vol.I 1818/1819, vol. II 1844; tr. it. di
P. SAVJ-LOPEZ & G. DI LORENZO, Il mondo come volontà e rappresentazione, I-II, Laterza, Roma-Bari 1972:
120
G. CALOGERO, Lezioni di Filosofia I-II-III: Logica-Etica-Estetica (1942-1943), Einaudi, Torino 1947, 1960, vol. III
Estetica, pp. 164-178, 196-213.
121
G. CALOGERO, Lezioni di Filosofia I-II-III: Logica-Etica-Estetica, op. cit., vol. I, Logica, pp. 12-24.
178
fondazione di verità: al consenso si aspira soltanto, eventualmente, e si ignora se ci sarà. Infatti,
effettiva esplicitazione della volontà di dialogo è un’incondizionata difesa della libertà del
dissenso, come la sola posizione che possa tenersi senza riguardo a dissensi: è su questa, non
su un fondamento logico di eticità, che si costituisce ogni sviluppo di civiltà giuridico-politica
di libertà e di eguaglianza civica e sociale.
17.9.4 Il liberal-socialismo come la più alta forma di democrazia.
Da queste argomentazioni, segue l’impossibilità di ogni deduzione contrattualistica, come quella di
John Rawls122, difesa da Rorty, della democrazia o del liberalismo, la quale tende a prospettare una
genesi consensuale del principio del consenso. La calogeriana volontà ermeneutica del dialogo è al
di là del dissenso, e vive, più che nella semplice solidarietà consensuale usata in un primo tempo da
Rorty per una definizione non oggettivistica della verità (e poi da lui stesso abbandonata) 123, nel
concreto “dissidio” dei logoi e dei linguaggi, di cui parla Lyotard124. La “decisione politica” non è
relegata in un mitologico inizio della storia, come anche in Rawls, ma si rinnova ogni volta nella
convivenza, nel dialogo sociale. Non è il contratto, per Calogero, che può generare la legge, in
quanto è il primo che acquista natura giuridica nella seconda, quando la volontà di dialogo si
“deforma” in coercizione. E’ mia opinione che dal puro dialogo non possa che derivare
coerentemente altro se non un’anarchia etico-giuridico-politica, come l’anarchia logicognoseologica strenuamente prospettata dal Calogero, e che, sola, può rispettare pienamente la
libertà. Che la specificazione “dottrinale” storica del dialogo, che Calogero unicamente si concede
in campo giuridico-politico (coercizione, “giustificazione” dello stato), sia da oltrepassare nella sua
stessa pratica ermeneutica del dialogo è implicito nel suo stesso pensiero, che pure nel
122
J. RAWLS, A Theory of Justice, Belknap, Cambridge (Mass.) 1971; tr.it. di U.SANTINI a cura di S. MAFFETTONE,
Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano 1984. La prospettiva di Calogero s’incontra con la problematicizzazione e
il riconoscimento d’improbabilità dell’ordine sociale, relativi alla indeterminatezza della complessità sociale, riscontrati
da N. Luhmann; tuttavia, Luhmann, come Apel per la contraddizione performativa, usa questa stessa indeterminatezza
quale figura retorica per la chiusura di un sistema teorico in una (impossibile) fondazione logica autoreferenziale: N.
LUHMANN, Wie ist soziale Ordnung möglich?, in Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie
der modernen Gesellschaft, I-IV, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1981, vol. II; tr.it. di A.MAGGIORE, Come è possible
l’ordine sociale, Laterza, Roma-Bari 1985.
123
R. RORTY, Consequences of pragmatism: essays 1972-1980, University of Minnesota Press, Minneapolis 1982; tr. it.
di F. ELEFANTE, Conseguenze del pragmatismo, Feltrinelli, Milano 1986.
124
J.-F. LYOTARD, Le differend, Minuit, Paris 1983; tr. it. di A. SERRA, Il dissidio, Feltrinelli, Milano 1985.
179
liberalsocialismo ha saputo cogliere la più alta forma di democrazia. Bruce Ackerman,
recentemente, ha proposto, in polemica con Rawls, una teoria del dialogo come fondamento di una
teoria della giustizia e della democrazia liberale125: nonostante le affinità con il pensiero di
Calogero, il suo concetto di dialogo resta vincolato a condizioni di razionalità, coerenza e neutralità,
e, concepito come fondamento, resta espressione teorica, logico-dottrinale. L’affinità delle
concezioni dialogica della giustizia di Ackerman e contrattualista di Rawls, realizzabile
nell’interdipendenza dei presupposti, da una parte, di neutralità, e, dall’altra, di ignoranza dei
contraenti sui loro fini e sulle loro differenze, trova effettivo riscontro nella caratterizzazione antiteorica della volontà di una pratica ermeneutica del dialogo di Calogero. Questi non deriva una
teoria della giustizia socio-politica dall’etica, che come teoria rifiuta; come rifiuta la “filosofia”
come teoria della natura umana o del bene, della ragione o quale ancora teologia o metafisica,
epistemologia o dottrina: vi è, in questo, piena convergenza con Rawls e Rorty. Al contrario però
della loro tesi contrattualistica della giustizia, che presenta residui dottrinali nei suoi presupposti
“intuitivi”, non sottoposti al dialogo, per Calogero è la stessa volontà ermeneutica del dialogo, che
si specifica, come pratica giuridico-politica, nella sua irriducibilità (e non priorità logica) alla
“filosofia”. Nessuna “critica dell’ideologia” presente in Apel ed Habermas, (che non sia
effettivamente tale, critica, cioè, di ogni teoria, come pratica del dialogo), concepita sul modello di
scienze logico-oggettivistiche, è ammessa da Calogero ad integrare la pratica ermeneutica; anche se
riconosce il darsi di “opacità” nel concreto dialogo, che presenta effettivi conflitti d’azione. La
contingenza storica di ogni concretamento nell’azione della volontà ermeneutica del dialogo, infatti,
è caratteristica, secondo Calogero, di ogni esperienza etico-giuridico-politica, e non è
meccanicamente deducibile da quella volontà, come un particolare dell’universale: è un risultato del
dialogo, delle esigenze derivanti dai risultati dell’effettiva comprensione e dell’avvenuta
comunicazione; il dialogo (come in parte in Apel) non è inteso in maniera puramente formale e
125
B. A. ACKERMAN, Social justice in the liberal state, Yale University Press, New Haven 1980; tr. it. di S. SABATTINI,
introduzione di F. ROMANI, La giustizia sociale nello stato liberale, Il Mulino, Bologna 1984. Si veda anche: S. VECA,
Una filosofia pubblica, Feltrinelli, Milano 1986.
180
linguistica come in Gadamer, e non si concretizza in un perfetto intendersi. In quanto la “comunità
della comunicazione”, per Calogero, non può darsi né come soggetto trascendentale di scienza né
come oggetto di scienza, la “trasformazione semiotica del kantismo” teorizzata da Apel, seppure
storicizzazione delle istanze kantiane e delle metafisiche, ricade all’interno del paradigma
fondazionale. Per Calogero, è necessario riconoscere l’insussistenza della maggior parte dei
problemi della ricerca e della conquista della verità, dei problemi che, tradizionalmente, vengono
designati come pertinenti alla logica, alla gnoseologia, alla metodologia, all’ontologia o alla
metafisica, e riconoscere la pertinenza di quelli che possiedono carattere effettivo alle varie
pratiche, linguistiche e non, del dialogo della comunità. Dal confronto di teorie o logiche, si passa al
riconoscimento della libertà nel dialogo. La “superstite filosofia dei nostri tempi”, abbandonate le
realtà metafisiche e le certezze logiche, serve, per Calogero , ad indicare il dialogo come modalità
di convivenza civile al di là delle divergenze nelle soluzioni dei problemi: l’ermeneutica si
caratterizza, come in Rorty, quale “educazione”-“edificazione”. La volontà ermeneutica del dialogo
si presenta in Calogero, come la “fede comune” e la “religiosità” di Dewey, quale laicismo:
l’oltrepassamento della metafisica e dell’epistemologia non è altro che la secolarizzazione della
violenza sacrificale umana, in senso dissolutivo ed emancipativo. La pratica ermeneutica del
dialogos si dà quale che sia la diversità di universi in colloquio: “le nostre prospettive saranno
diverse e si integreranno e correggeranno all’infinito: questa non è che la storia...”126.
17.10 Filosofia del dialogo
La filosofia del dialogo nasce in Calogero dal superamento etico del soggettivismo immanentistico
e solipsistico di Gentile. Si tratta di riconoscere gli altri con la volontà morale del dialogo, perché
con il pensiero si presentano solo come oggetti del pensiero, fenomeni per il soggetto; si tratta di
riconoscere gli altri non come altri soggetti che sussistono solo come contenuti del pensiero, ma
piuttosto come soggetti di pensiero con cui dialogare e da amare: come già detto, potrebbe non
essere possibile distinguere col pensiero puro macchine che simulano da esseri senzienti e pensanti.
126
G. CALOGERO, Filosofia del dialogo, op. cit., p. 385.
181
La concretezza dell’attività dello spirito non sta più per Calogero nel pensiero, seppure pensante, di
Gentile, ma nella volontà e nell’azione: il rapporto fra pensiero e volontà e fra teoria e prassi,
rispetto a Gentile è rovesciato, perché l’identificazione presunta operata da Gentile era più che altro
un inglobamento della volontà all’interno della dialettica del pensiero e della prassi all’interno della
teoria. Questa identificazione come inglobamento faceva sì che in effetti la filosofia di Gentile si
qualificasse come un neo-idealismo perché tutto restava chiuso all’interno di una soggettività
pensante, solipsistica seppure trascendentale, a cui tutto era immanente.
Calogero comprende che allora il pensiero pensante non può essere pensato, conosciuto, l’autoconoscenza o l’auto-coscienza non è possibile. La critica di Calogero però procede oltre e
comprende che il pensiero non ha in sé alcuna dinamicità propria e nessuna possibilità dialettica,
che stanno nella volontà volente e nell’azione: la concretezza sta nell’azione. La realtà non può
spiegarsi a partire dal pensiero, ma solo dall’azione: la volontà non è noumeno sostanziale come in
Kant, ma attività. Ma il pensiero può solo ridurre a pensato, a oggetto e l’unico mondo che può
conoscere è oggettuale; eppure il mondo è soggettivo, secondo l’attualismo. Calogero ne deduce
allora che solo la volontà volente le volontà volenti altrui può comprendere l’irriducibile
soggettività del mondo, e la concretezza non è del pensiero pensante che non supera il logo, ma solo
del dialogo: si passa dal pensiero pensante
al dialogo in atto che solo può riconoscere le
soggettività. Il reale non è allora immanente al pensiero, ma all’azione mossa dalla fede che è
amore. Pensiero pensante è pensiero vivente, e vivente significa volontà consapevole e non pensiero
puro: quindi la filosofia di Calogero è filosofia del dialogo, dell’azione etica, della volontà d’amore.
La volontà etica oltrepassa il limite d’immanenza del pensiero e opera un trascendersi del pensiero
nell’azione e un trascendersi della soggettività egoica nel riconoscimento volontario ed etico di altre
soggettività e di altri pensieri/logoi. Se il pensiero riduceva ogni pensato a suo oggetto (era questo
in Gentile un residuo di oggettivismo che combatteva), in quanto la volontà non etica riduceva ogni
voluto a suo oggetto (l’oggettivismo del pensiero è l’ideologia che maschera la violenza di una
volontà che riduce l’altro a proprio oggetto; un pensiero non oggettivistivico è quello ‘dell’io ti
182
penso’, del ‘pensare a qualcuno’ e non del ‘pensare qualcosa’; non è un pensiero che vuole
conoscere la realtà, ma un pensiero che è tutt’uno con l’amore: quando amiamo qualche persona e
siamo distanti, pensare a lei è il nostro modo di amarla; amare è l’unico verbo che correla due
soggetti e non un soggetto e un oggetto, per cui ‘io-ti-amo’ permette la scambiabilità-reversibilità
dei ruoli, dell’io e del tu, cioè come soggetti; l’unica frase la cui inversione mantiene i due
interlocutori su un piano di simmetria, la cui relazione è sostanzialmente simmetrica e non solo
formalmente), al contrario la volontà etica sta nel riconoscere in ogni voluto un volente, un soggetto
pensante e volente mai riducibile a voluto.
Questo è il passaggio dall’eros greco all’agàpe cristiana, come volontà etica: si tratta di riconoscere
la trascendenza dell’alterità. La volontà etica di dialogo si pone quindi come superamento etico di
qualsiasi soggettivismo solipsistico ed egoistico, per cui la volontà stessa si qualifica qui come un
principio trans-individuale e non come una mera facoltà-funzione individuale. Il dialogo stesso è ciò
che ci fa riconoscere l’un l’altro come soggetti: ciò che ci qualifica come individui è qualcosa di
trans-individuale, ma non in interiore, come in Gentile o in Platone dove l’anima dialoga con sé
stessa, ma in una effettiva comunità. Il dialogo con Dio rischia di essere solipsismo, e per questo
non può non esercitarsi nel dialogo con altri. Anche il dialogo con la Natura, nella scienza moderna,
è mediato, in qualche modo, da un dialogo con altri. L’oggettivismo non è altro che la proiezione
illusoria di un soggetto; il soggettivismo si supera solo con il riconoscimento della pluralità dei
soggetti a partire dall’istanza trans-soggettiva che è l’Amore cristiano. La filosofia non è che questa
chiarificazione, questa consapevolezza di un’esperienza storica.
Una persona è viva fino a quando dialoghiamo con essa anche oltre la morte, continuando ad
ascoltarla. La verità dell’Amore non è falsificabile perché non è legata ad un enunciato sulla realtà,
ma è una fede, un volere che sia.
Qui, risulta chiaramente che Calogero ha modificato la sua precedente prospettiva trascendentale
attualistica: là, si partiva dalla individuale soggettività intrascendibile e quindi trascendentale, che
costituiva una ‘filosofia della presenza’; qui, appunto intrascendibile è il dialogo all’interno del
183
quale soltanto si riconoscono i soggetti. Si passa da una metafisica soggettivistica ad una fede
dialogica: anche l’io non è prioritario al dialogo ma si riconosce nel dialogo; intrascendibile non è la
propria prospettiva ma il confronto e la reciproca comprensione e il reciproco rispetto delle varie
prospettive possibili. Ciò significa che l’io si dà solo all’interno di un dialogo sociale, di un dialogo
della storia, di un dialogo della Natura, di un dialogo con Dio eventualmente: tutto questo però non
è metafisicamente presupposto come un dato e quindi comunque oggetto della nostra soggettività,
ma è incontrato in un’esperienza etico-dialogica primaria che si costituisce come fede nell’Alterità
ed è irriducibile a dato ontologico.
Allo stesso modo tale situazione dialogica non è un prioritario mit-sein, ma piuttosto una volontà di
Altri (non individuale, ma plurale e comune, e non individualistica: una fede comune) che ci
costituisce come soggetti in un dialogo plurale. Nell’agire pratico etico-dialogico-amoroso si
incontrano altri, non in una mera speculazione teoretica.
C’è una verità etica del dialogo, che si rivela nella fede nel dialogo, che è a fondamento di tutte le
altre verità particolari: questa verità non è quindi puramente inter-umana, ma inter-soggettiva in un
senso più vasto in cui anche l’oggettività della realtà, della Natura o di Dio sono ricomprese come
soggettività inoggettivabili; il dialogo umano è parte del dialogo della storia che è parte di un più
vasto dialogo della Natura o di Dio.
Il dialogo non si fonda su un essere comune cui tutti si acconsente, ma piuttosto il dialogo permette
il riconoscimento di esseri diversi: la comprensione non si basa sull’univocità dell’essere, non è
identitaria e non è analogica, ma dialogica. Si tratta di una pratica ermeneutica dialogica, in cui la
comprensione non è mai assicurata apriori, non è mai fondata assolutamente da una condizione di
possibilità della conoscenza immanente a un soggetto, pur anche universale e trascendentale, ma
unico: c’è sempre il rischio di sbagliarsi, di fraintendere, il rischio dell’inganno e del dolo, di
mistificazioni personali o ideologiche. L’invarianza che coglie solo ciò che è comune ai soggetti,
coglie molto poco, non ci può mai restituire la realtà: può cogliere solo questa volontà comune di
dialogo, ma non i suoi contenuti concreti.
184
E questa verità di una delle prospettive non potrà che essere stabilita attraverso il confronto/dialogo
con le altre, altrimenti resterebbe una verità basata solo su una presupposizione soggettiva e non
sarebbe una verità per tutti.
Dal fatto che il riconoscimento degli altri si ha soltanto nella prassi etica che è la stessa fede morale,
e non in una fondazione ontologica o gnoseologica, comunque metafisica, della filosofia, se ne
deduce che lo stesso io non si dà se non nel riconoscimento che gli altri fanno di noi stessi nella loro
prassi etica. Passando dalla volontà cosciente alla volontà che si attua nel dialogo si passa da una
volontà individuale a una volontà d’Amore che non è più volontà di un io ma un Amore che vuole
in noi e oltre noi in quanto principio d’alterità e di altruismo.
Se chiamiamo dialogo il reciproco riconoscimento, che si dà nella prassi etica, degli altri e di noi
stessi, allora la fede morale ci mostra un altro possibile inizio per la filosofia: non si può più partire
dal soggetto singolo seppure trascendentalizzato, ma si deve partire dal dialogo; solo nel dialogo io
posso essere riconosciuto e riconoscermi quale effettivo soggetto etico. La fede morale diventa così
non il fondamento logico, ma la radice vitale di una nuova filosofia del dialogo, che rompe con il
soggettivismo e con il monologismo che ha sempre dominato la filosofia occidentale.
La metafisica monologica si basa sul rifiuto dell’alterità: l’alternativa fra filosofia teoretica greca e
fede cristiana si ripropone come alternativa fra filosofia teoretica greca e fede morale che si articola
in una filosofia pratica. La fede morale ci assicura che l’unica trascendenza effettiva cui possiamo
accedere non è quella della metafisica né quella di una teologia fideistica, ma piuttosto è la
trascendenza di noi stessi nell’Amore dell’altro.
La fede morale ci apre al superamento della visione monologica, e non in un prospettivismo statico
come quello di Leibnitz o di Nietzsche, ma al riconoscimento di una pluralità potenzialmente
infinita di prospettive che si confrontano dinamicamente nel dialogo. Non si tratta più di fondare
una propria filosofia individualistica per un accesso a una verità unica che si dischiude a un’unica
prospettiva teoretica, ma si tratta invece di una “fede morale comune” che apre l’orizzonte di una
verità non accessibile individualmente, di una verità etica che è propria del dialogo e dell’amore.
185
La verità che è dell’amore trascende la presunta verità di un altrettanto presunta verità ontologica,
logica o gnoseologica.
Il principio del dialogo coincide con la regola aurea evangelica: “Tutto quanto volete che gli
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti (Matteo 7.12,
Luca 6.31). Matteo 22.40 mostra che quel fare indica un fare bene, ovvero amare! Si può ritradurre
meglio dall’aramaico siriaco la regola aurea: Tutto l’amore che gli esseri umani dovrebbero darvi,
voi comunque datelo a loro.
L’indiscutibilità del principio del dialogo si mostra da sé: se un altro mi dicesse che non vuole
essere ascoltato, per capirlo dovrei ascoltarlo; si costituirebbe altrimenti una contraddizione
performativa, una contraffazione impossibile.
L’autonomia della morale, invocata da Kant, dipende da questa indiscutibilità, ma è un’autonomia
che aprendomi alle prospettive e alle ragioni altrui apre all’eteronomia: altrimenti si ricade in un
egoismo trascendentale..
Ognuno deve migliorare i propri argomenti in funzione dell’esperienza degli argomenti altrui: così,
se il dialogo costituisce l’apriori, il nostro logo è aposteriori rispetto a quell’altrui che
concretamente si dà nel dialogo.
Il dogmatismo e lo scetticismo non sono criticati sulla base di un diverso logo, ma sulla sola base
della volontà di dialogo, del principio del dialogo che li esclude.
La condizione trascendentale del dialogo appartiene alla volontà e alla prassi etica, e non alla
ragione.
La filosofia del dialogo è un’ermeneutica più alta di quella teoretica della comprensione teoretica di
altri, è un’ermeneutica dell’amore che supera la comprensione del pensiero, un’ermeneutica pratica,
che si compie in una prassi etica: un’ermeneutica del dialogo, un’ermeneutica dialogica: questo
significa che il mondo non si dà a una coscienza, a un soggetto che lo costituisce, né come senso
esistenziale per un soggetto individuale o umano, ma si dà in una pluralità di sensi irriducibile, e
nella relazione dialogica fra noi e il mondo, o meglio il mondo è un dialogo in cui siamo immersi.
186
Si può ricordare, qui, la disamina, fatta da Calogero, dell’Eutifrone platonico, in cui si afferma che
il bene è oggettivo e non può dipendere dal soggettivo volere delle divinità: qui, però la discussione
è inficiata dal fatto che l’etica socratico-platonica è eudemonistica e quindi lo stesso bene ideale ed
eterno è egoistico e l’individuale volontà divina non può che sottostare come ogni individualità a
quell’universale egoismo che lo comprende. Al contrario, il Dio-Amore cristiano risolve questa
opposizione perché la divinità non è un intelletto o una volontà individuale e non si può sussumere
in una universalità, ma è non un logo individuale, ma un dialogo infinito iper-individuale, è lo
stesso principio etico personificato o meglio iper-personificato: si ha l’eticizzazione della teologia,
la trasformazione di una teologia individualistica o etnica in un’etica trans-individuale. La Parola
giovannea aramaica si dà in un dialogo originario: tradurla con logos ha significato tradirne
completamente il senso, identificare il Dio che si fa carne con un intelletto puro, ma il Dio che si fa
carne è sempre una Parola che apre un Dialogo con gli esseri umani a cui si rivolge non un intelletto
che governa razionalmente il mondo; Dio crea parlando, la creazione è un dialogo, in cui si pone
un’alterità e Dio-Amore non è un’egoità che è, come in Esodo 3.14, ma un farsi-altro. Calogero dice
che Dio non può amare se non incarnandosi (come l’Eros del Simposio di Platone, che passa da una
divinità perfetta e chiusa in sé a una “mezza” divinità metaxù fra cielo e terra). Dio ha una natura
spirituale e materiale, di pensiero e azione, perché una potenza realmente infinita non può mai
essere finitamente attuata, ma continua attuazione-azione, actus e non actum, azione infinita. Se la
perfezione non sta nel finito, ma si realizza infinitamente, allora c’è amore, azione, creazione, vita,
sofferenza, morte.
Il criterio antico di adeguazione del pensiero alla realtà era però legato all’ideale contemplativo, per
Calogero sta nell’azione. Ma la stessa corrispondenza nell’azione del singolo alla realtà non dà
certezza di verità, ma bisogna connettere e confrontare le azioni di tutti i soggetti, senza ricercare
una riduttiva invarianza, ma nell’insieme di tutte le prospettive e nel loro rispetto non riduttivo.
Tolstoj direbbe che Dio ci ha creato così, incapaci di attingere da soli la verità, perché ci amassimo
e perché comprendessimo che la verità ultima è l’amore.
187
Alla certezza logico-gnoseologico-metafisica del cogito, ergo sum, per Calogero va sostituita la
certezza della volontà della fede morale di un tecum loquor, ergo es. All’esistenza dell’io,
l’esistenza degli altri, dei tu.
Si tratta dell’amo, dunque sono di Sibilla Aleramo (1876-1960). L’amamus, ergo sumus di Roger
Garaudy (1913-2012). Noi è il pronome filosofico. Noi non siamo se non per gli altri che ci
riconoscono come tali, non siamo se non negli altri. Noi non conosciamo se non con gli altri. Questa
è la condizione di possibilità della nostra esistenza e della nostra consapevolezza del mondo. Questa
nostra condizione non è un male metafisico, ma costituisce la nostra possibilità di comprendere la
realtà dell’Amore. Ricadiamo in questo male, che non è metafisico ma morale, se non trascendiamo
la nostra condizione soggettiva e individuale e umana nell’Amore.
L’angoscia autentica non è mai egoistica, ma è un’angoscia per gli altri; non è mai per un nostro
astratto essere nulla, ma per il nulla che noi siamo senza gli altri, nella separazione dagli altri. Si
può essere felici soffrendo quando si ama, non perché masochisticamente si provi piacere soffrendo,
ma perché l’amore permette di partecipare della felicità altrui superando i limiti del proprio ego: è
questo che intende san Paolo in I Corinzi 7.29-31.
Il male fisico, la sofferenza e la morte costituiscono altresì la condizione di possibilità per
trascendere la propria soggettività individuale e conoscere la realtà dell’Amore. Si soffre e si muore
per Amore. Il problema del male si risolve nell’Amore. Il bene non è il bene individuale, ma è
l’Amore: l’Amore vince la sofferenza, la morte, il male individuale, superandoli, proprio come il
senso della vita non è nella propria ma in quella degli altri. La soluzione del problema teologico e
filosofico del male non è metafisica, ma morale.
I Giov. 3.14 Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i nostri fratelli e
le nostre sorelle. Chi non ama rimane nella morte. Questo si contrappone a Esodo 3.14: Io sono
colui che sono.
Dio non esiste metafisicamente: Dio esiste nell’Amore, l’Amore è Dio (I Giov. 4.8 e 16). Chi non
ama, ricade nel nulla.
188
Calogero chiarisce il senso della vita per tutti attraverso la prospettiva etica cristiana: non solo si
deve agire per la felicità degli altri nel superamento dell’egoismo e si deve imparare a essere felici
per gli altri seppure individualmente sofferenti, ma questo ci fa capire che la nostra vita ha senso
anche se solo sofferenza, anche se la morte ci coglie in un fallimento individuale o lo segna, perché
il senso della nostra vita è nella realizzazione della vita di altri, anche della vita di altri “futuri”.
Con molti di voi, questo è l’ultimo corso che facciamo insieme. A parte il dialogo dell’esame, con
alcuni di voi, forse, continueremo un percorso di tesi, con altri, forse, non ci si incontrerà se non in
altre sedi. Al di là della differenza di idee e di età e di tante altre cose, abbiamo condiviso un
percorso, abbiamo dialogato e non solo con le parole. Abbiamo forse vissuto appena l’inizio di una
“filosofia del dialogo”, tutti abbiamo, se vogliamo, da realizzarla nella vita.
So che la mia vita è nulla senza di voi, so che il senso della mia vita è e sarà nella vostra.
19 Dicembre 2014, Bergamo
189
190