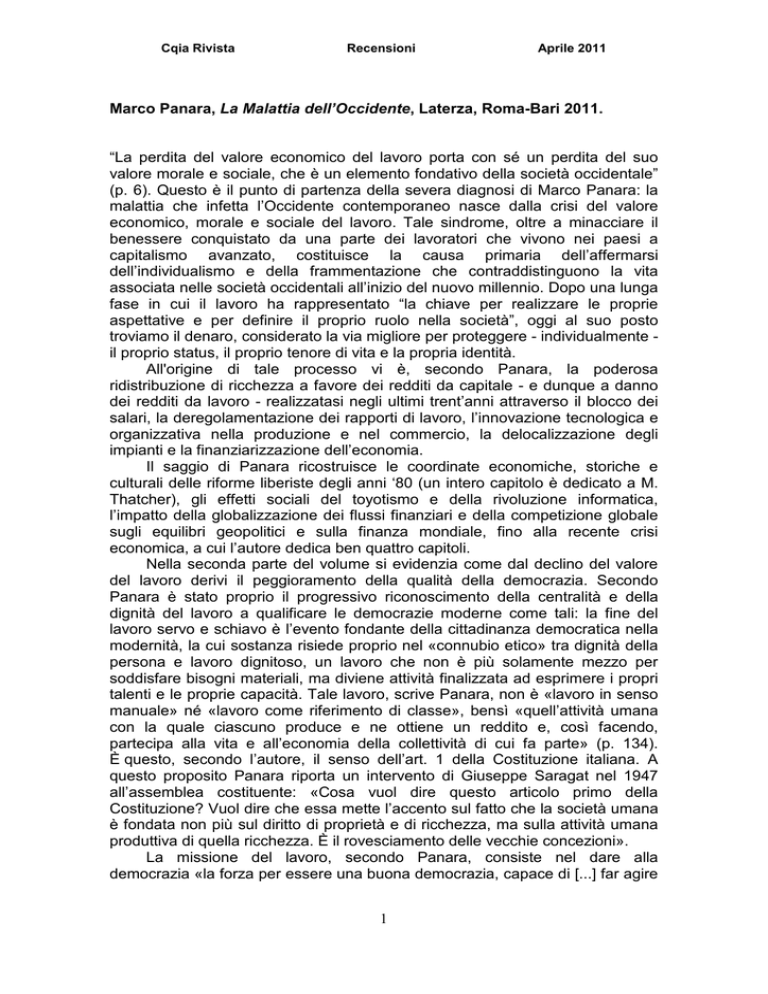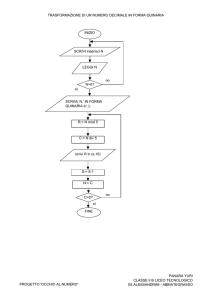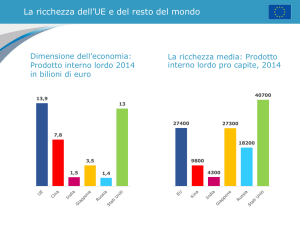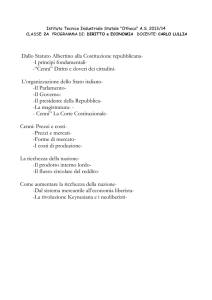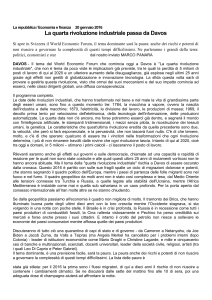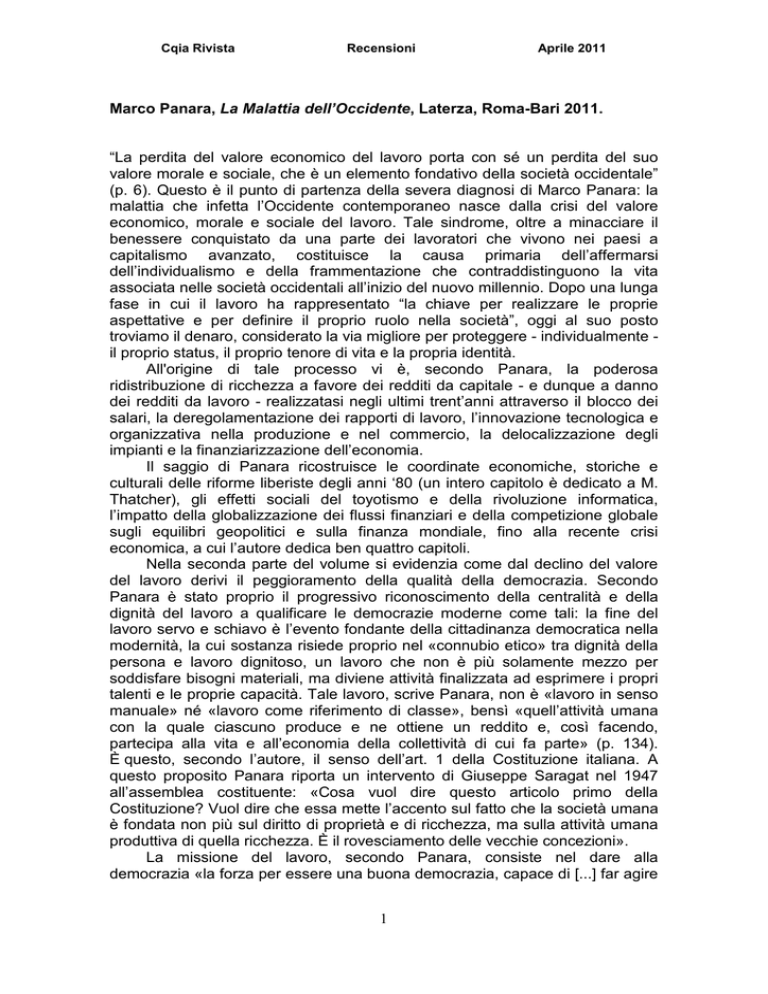
Cqia Rivista
Recensioni
Aprile 2011
Marco Panara, La Malattia dell’Occidente, Laterza, Roma-Bari 2011.
“La perdita del valore economico del lavoro porta con sé un perdita del suo
valore morale e sociale, che è un elemento fondativo della società occidentale”
(p. 6). Questo è il punto di partenza della severa diagnosi di Marco Panara: la
malattia che infetta l’Occidente contemporaneo nasce dalla crisi del valore
economico, morale e sociale del lavoro. Tale sindrome, oltre a minacciare il
benessere conquistato da una parte dei lavoratori che vivono nei paesi a
capitalismo avanzato, costituisce la causa primaria dell’affermarsi
dell’individualismo e della frammentazione che contraddistinguono la vita
associata nelle società occidentali all’inizio del nuovo millennio. Dopo una lunga
fase in cui il lavoro ha rappresentato “la chiave per realizzare le proprie
aspettative e per definire il proprio ruolo nella società”, oggi al suo posto
troviamo il denaro, considerato la via migliore per proteggere - individualmente il proprio status, il proprio tenore di vita e la propria identità.
All'origine di tale processo vi è, secondo Panara, la poderosa
ridistribuzione di ricchezza a favore dei redditi da capitale - e dunque a danno
dei redditi da lavoro - realizzatasi negli ultimi trent’anni attraverso il blocco dei
salari, la deregolamentazione dei rapporti di lavoro, l’innovazione tecnologica e
organizzativa nella produzione e nel commercio, la delocalizzazione degli
impianti e la finanziarizzazione dell’economia.
Il saggio di Panara ricostruisce le coordinate economiche, storiche e
culturali delle riforme liberiste degli anni ‘80 (un intero capitolo è dedicato a M.
Thatcher), gli effetti sociali del toyotismo e della rivoluzione informatica,
l’impatto della globalizzazione dei flussi finanziari e della competizione globale
sugli equilibri geopolitici e sulla finanza mondiale, fino alla recente crisi
economica, a cui l’autore dedica ben quattro capitoli.
Nella seconda parte del volume si evidenzia come dal declino del valore
del lavoro derivi il peggioramento della qualità della democrazia. Secondo
Panara è stato proprio il progressivo riconoscimento della centralità e della
dignità del lavoro a qualificare le democrazie moderne come tali: la fine del
lavoro servo e schiavo è l’evento fondante della cittadinanza democratica nella
modernità, la cui sostanza risiede proprio nel «connubio etico» tra dignità della
persona e lavoro dignitoso, un lavoro che non è più solamente mezzo per
soddisfare bisogni materiali, ma diviene attività finalizzata ad esprimere i propri
talenti e le proprie capacità. Tale lavoro, scrive Panara, non è «lavoro in senso
manuale» né «lavoro come riferimento di classe», bensì «quell’attività umana
con la quale ciascuno produce e ne ottiene un reddito e, così facendo,
partecipa alla vita e all’economia della collettività di cui fa parte» (p. 134).
È questo, secondo l’autore, il senso dell’art. 1 della Costituzione italiana. A
questo proposito Panara riporta un intervento di Giuseppe Saragat nel 1947
all’assemblea costituente: «Cosa vuol dire questo articolo primo della
Costituzione? Vuol dire che essa mette l’accento sul fatto che la società umana
è fondata non più sul diritto di proprietà e di ricchezza, ma sulla attività umana
produttiva di quella ricchezza. È il rovesciamento delle vecchie concezioni».
La missione del lavoro, secondo Panara, consiste nel dare alla
democrazia «la forza per essere una buona democrazia, capace di [...] far agire
1
meglio proprietà e mercato, ovvero i capitalismo, senza farsi mettere i piedi in
testa». In questa prospettiva l’antagonista del lavoro non è il capitale, bensì la
rendita, che «fa male tanto al lavoro quanto al mercato» (p. 138); per questa
ragione è auspicabile un’inversione di tendenza, perché «non si può
razionalmente pensare che sia costruttivo per lo sviluppo e la creazione di
ricchezza tassare il lavoro e l’impresa più del patrimonio e della rendita» (p.
146).
Ad ogni modo, per «uscire dalla trappola», è necessario ridare valore
sociale al lavoro. Questa deve diventare, secondo Panara, la missione di una
classe politica all’altezza dei tempi. «Ogni volta che il lavoro è stato messo al
centro, che sia stato da San Benedetto, da Calvino o dalle costituzioni, ne é
sempre seguita una fase di progresso civile ed economico e di conquiste di
libertà» (p. 150).
Affinché ciò si realizzi, bisogna tornare «a ragionare di produzione della
ricchezza e di sua ridistribuzione, che non sono due momenti diversi» perché «il
modo in cui si crea dipende anche dal modo in cui si distribuisce» (p. 146) e
viceversa. Secondo Panara è necessario intervenire su tre livelli: «creare un
offerta di lavoro di qualità investendo nella formazione; creare una domanda di
lavoro di qualità attraverso una nuova politica industriale che incentivi lo
sviluppo di nuovi settori e il perseguimento della qualità da parte delle imprese;
Imporre nuove regole la mercato «nell’interesse di un suo migliore
funzionamento e non della possibilità di pochi di spremerlo» (p.149).
Lo Stato deve svolgere un ruolo diretto sul primo punto, ossia la
formazione, e indiretto sugli altri due, ossia la domanda e il mercato (che
Panara definisce «il modello che abbiamo scelto per le nostre società»). In
sintesi, Panara si rivolge alla classe politica attuale, nonché alla società civile,
affinché si rimetta al centro il valore sociale e democratico del lavoro, attraverso
una «policy» che ne ristabilisca il valore economico - «da ogni lavoro deve
uscire un prodotto capace di remuneralo adeguatamente», (p. 148) - e
un’«operazione culturale che ne ristabilisca la dignità, il ruolo, la centralità» (p.
148).
Declinando il concetto di lavoro in una accezione generica - come attività
umana produttiva, indipendentemente dalle sue coordinate storiche e sociali
particolari - e collocandolo al di fuori del conflitto con il capitale, il discorso di
Panara sul valore del lavoro elude la questione, ad esso strettamente
connessa, del potere del lavoro. L’autore, infatti, auspica una nuova alleanza
tra imprese e lavoratori fondata sul valore etico della legalità, del bene comune
e dello Stato: «non è più l’ideologia lo strumento, ma la non subalternità a
pensieri opportunistici [...] e la costruzione di una nuova consapevolezza del
valore della legalità, dello Stato, della opportunità di condividere collettivamente
alcuni rischi e alcune responsabilità, lasciando tutto il resto alla libera scelta di
ciascun individuo» (p. 146). Ciò spiega la marginalità - tanto nell’analisi quanto
nella proposta di Panara - della dimensione del conflitto sindacale e sociale,
delle sue vittorie e delle sue sconfitte.
Eppure, se il novecento ha visto la crescita di una dialettica progressiva
tra riconoscimento del valore del lavoro e democrazia reale, ciò non è avvenuto
semplicemente grazie alla sensibilità di una classe dirigente e di una cultura
politica e civile oggi in declino. A dare sostanza ai diritti formali è stato un lungo
Cqia Rivista
Recensioni
Aprile 2011
ciclo di lotte dei lavoratori, la loro capacità di unirsi e di esprimersi come
soggetto politico e rivendicativo, fino a divenire la leva principale della
trasformazione sociale. E a sostenere tale spinta progressiva non è stato il
riconoscimento della centralità del lavoro in senso morale, bensì la
consapevolezza della centralità del processo di valorizzazione nella società
capitalistica, e dunque della centralità del lavoro nell’accumulazione, da cui
deriva il potere che esso è stato in grado il esprimere attraverso la sua
organizzazione sindacale e politica.
Se si guarda alla storia, il riconoscimento del valore economico e morale
del lavoro presuppone il recupero del potere dei lavoratori. La capacità del
mondo del lavoro di riconoscersi e unificarsi è stata la forza che nel passato ha
saputo porre il lavoro come vincolo sociale, introducendo elementi di rigidità nel
mercato del lavoro e costringendo il capitale a percorrere la via dell’innovazione
e della produttività - anziché quella della riduzione del costo del lavoro - nella
ricerca del profitto. Panara sembra credere che oggi tale dinamica virtuosa
possa realizzarsi senza la partecipazione attiva e conflittuale dei lavoratori e
delle loro organizzazioni, bensì, mediante l’intervento dall’alto della politica e
dello Stato. Uno Stato guidato da una classe dirigente illuminata e sensibile al
valore del lavoro, che stimoli la produzione di qualità e definisca i parametri
etico-morali entro cui lasciar agire liberamente le forze del mercato.
Michele Dal Lago
3