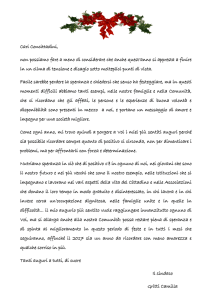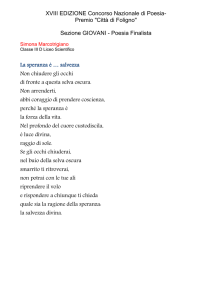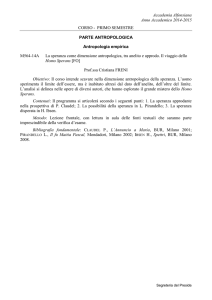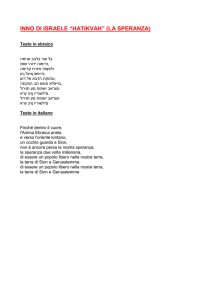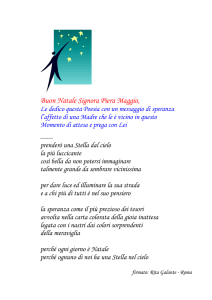International
RIVISTA TELEMATICA QUADRIMESTRALE - ANNO XXVII
NUOVA SERIE - N. 79 – GENNAIO-APRILE 2013
1
Segni e comprensione International
Pubblicazione promossa nel 1987 dal Dipartimento di Filosofia e
Scienze sociali dell’Università degli Studi di Lecce, oggi Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università del Salento, con la collaborazione del “Centro
Italiano di Ricerche fenomenologiche” con sede in Roma, diretto da Angela
Ales Bello.
General Editor/Direttore responsabile
Giovanni Invitto ([email protected])
Steering Comittee/Comitato direttivo
Giovanni Invitto, Università del Salento (Editor/Direttore
responsabile) Angela Ales Bello, Università Lateranense; Angelo Bruno,
Università del Salento; Daniela De Leo, Università del Salento; Antonio
Delogu, Università di Sassari; Aniello Montano, Università di Salerno; Paola
Ricci Sindoni, Università di Messina.
Editorial board/Comitato editoriale
Jean-Robert Armogathe, École Normale Supérieure de Paris (F);
Renaud Barbaras, Paris I – Sorbonne (F); Francesca Brezzi, Università di
Roma 3 (I); +Bruno Callieri, Università di Roma 1 (I); Mauro Carbone,
Université Jean Moulin Lyon 3 (F); Giovanni Cera, Università di Bari (I);
Claudio Ciancio, Università del Piemonte Orientale (I); +Françoise Collin,
fondatrice di «Les Cahiers du Grif» (F); Umberto Curi, Università di Padova
(I); Roger Dadoun, Université de Paris VII-Jussieu (F); Franco Ferrarotti,
Università di Roma 1 (I); Renate Holub, University of California – Berkeley
(Usa); Roberto Maragliano, Università Roma Tre (I); William McBride, Purdue
University, West Lafayette, Indiana (Usa); Augusto Ponzio, Università di Bari
(I); Pierre Taminiaux, Georgetown University (Usa); Christiane Veauvy, Cnrs
(F); Sergio Vuskovic Royo, Universidad de Valparaiso (RCH); Chiara
Zamboni, Università di Verona (I)
Team/staff di redazione
Siegrid Agostini; Daniela De Leo (responsabile); Lucia De Pascalis;
Maria Teresa Giampaolo; Rosetta Spedicato.
Sede
2
Comitato Scientifico e Segreteria hanno sede presso il Dipartimento
di Studi Umanistici, Università del Salento – Via M. Stampacchia – 73100
Lecce
–
tel.0832.294627;
fax
0832.294626.
E-mail:
[email protected].
Amministrazione e pubblicità
Piero Manni s.r.l., Via Umberto I, 51 73016 San Cesario di Lecce –
Tel. 0832.205577. Periodico iscritto al n. 389/1986 del Registro della Stampa,
Tribunale di Lecce.
3
Questa rivista è sui siti: http: //www.segniecomprensione.it e
http://www.mannieditori.it/rivista/segni-e-comprensione; e ha dei rimandi al
Dipartimento di Studi Umanistici e al Siba con i link: dipfil.unile.it/seostart/page/home.rivista_online/seo-stop/index.php?
e
sibaese.unisalento.it/index.php/segnicompr
NOTE PER GLI AUTORI
I contributi scientifici possono essere scritti in una delle seguenti
lingue: italiano, francese, inglese e saranno pubblicati nella lingua in cui
perverranno. L’articolo deve riportare, prima del testo, il titolo, Autore e il
relativo istituto di appartenenza, indirizzo per la corrispondenza e un abstract
(di max 900 battute, scritto in italiano/inglese/francese) con parole-chiave
(fino a 5) ed essere redatto secondo le norme redazionali riportate sul sito.
Per la sezione “Saggi” i testi non dovranno superare le venti cartelle
di 30.000 battute, spazi inclusi e comprese le note bibliografiche. Per le
“Note” non si dovranno superare le 10.000 battute, spazi e note inclusi, con
le medesime caratteristiche dei Saggi.
I testi vanno inviati alla Direzione, indirizzati alla seguente e-mail:
segniecomprensione@ libero.it.
I testi, in forma anonima, verranno esaminati da due referees,
esterni al Comitato Direttivo, e competenti nelle diverse tematiche trattate dai
contributi. Questi forniranno al Comitato Direttivo gli elementi necessari per
valutare la correttezza e l’utilità, segnalando la necessità di modifiche o
integrazioni per migliorarne le caratteristiche o evidenziando gli aspetti che,
se non correttamente modificati, ne potrebbero impedire la pubblicazione.
4
INDICE
Saggi
7
Dino Cofrancesco
PERCHÉ IN ITALIA É MANCATA UNA RELIGIONE CIVILE.
COMMENTANDO IL SAGGIO DI MARCELLO VENEZIANI
«DIO, PATRIA E FAMIGLIA DOPO IL DECLINO»
37
Maurizio Candiotto
MODALITIES OF THE SUBLIME
MODAL CATEGORIES BETWEEN REASON, UNDERSTANDING, AND
SENSIBILITY
46
Carmine Luigi Ferraro
P. LAIN ENTRALGO E LA LETTERATURA RIFLESSIVA:
LA ESPERA Y LA ESPERANZA
90
Roberta Sofi
JAN PATOCKA: LA FENOMENOLOGIA ASOGGETTIVA
Note
103
Alessandra Peluso
ALBERT CAMUS E JEAN-PAUL SARTRE
SENSO DELLA MISURA E MEDITERRANEITÀ
119
Cristina Manzo
IL RESPIRO DEL BOSCO È IL RESPIRO DELLA VITA.
L’UOMO ALBERO NELLA SOCIETÀ.
DA THOREAU A FERRAROTTI
5
Resoconti
133
Ilaria Malagrinò
STORIA E "STORIE" DELLA FILOSOFIA.
A PROPOSITO DI UN RECENTE VOLUME
143
Cristina Manzo
LA PERCEZIONE DI SÉ ATTRAVERSO
LA STRUTTURA DEL COMPORTAMENTO
161
Antonio Stanca
DI UN’UGUAGLIANZA FINITA
165
Pubblicazioni ricevute
6
PERCHÉ IN ITALIA É MANCATA UNA RELIGIONE CIVILE.
COMMENTANDO IL SAGGIO DI MARCELLO VENEZIANI
«DIO, PATRIA E FAMIGLIA DOPO IL DECLINO»
di Dino Cofrancesco
Il saggio di Marcello Veneziani, Dio, Patria e famiglia è uno di quei testi ai quali si è
costretti ad interessarsi, in quanto da esso emana lo ‘stato di coscienza’ della
nostra epoca. Siamo di fronte ad un’epoca che manca di punti di riferimento e di
certezze, fosse anche quella del nulla, ed è proprio questo ciò che l’autore
rimpiange. Contrariamente alle apparenze, infatti, il nulla è suscettibile di dare il
proprio contenuto ad una conoscenza che sarà poi in grado di emanciparsene, a
vantaggio dell’intera civilizzazione. In altri termini, essere sicuri che non c’è nulla,
piuttosto che non essere sicuri di nulla. Né tradizioni, né valori poiché sono negati,
gli uni dopo gli altri, senza venire per questo sostituiti da nuovi valori. Tuttavia, il
fatto che l’uomo li neghi non significa che egli non abbia bisogno di radici. Forse
questo è tutto il paradosso dell’uomo moderno: distruggere senza essere capace di
ricostruire, distaccarsi dalle tradizioni senza poter totalmente rinunciare al suo
bisogno di essere attaccato a qualcosa – un Dio, una patria, una famiglia, quali
garanzie indispensabili per sentirsi appartenere al mondo anziché essere un
semplice passeggero; in una parola, per avere un’identità. Ma quale Dio? Quale
patria? Quale famiglia? Quale è, oramai, il contenuto di tali concetti? Senza
umanità, la religione non è più che fanatismo; la famiglia, valore assoluto, diventa
una cellula di ripiego contro un mondo in declino; la patria, considerata come una
divinità, non è più che idolatria, giustificando così degli ideali libertari tuttavia
incapaci di creare valori nuovi sotto il segno della comunità, aggravando il senso
della perdita di un’identità nazionale e testimoniando, soprattutto, una ‘perdita’,
quella di un ‘centro’, cioè di un Dio, di una patria, di una famiglia, suscettibili di
essere condivisi pur vissuti, individualmente, in libertà, senza i quali non è possibile
sfuggire all’horror vacui.
L’essai de Marcello Veneziani, Dio, Patria e famiglia est un de ces textes auxquels
l’on est obligé de s’intéresser en tant qu’il s’en dégage l’ « état de conscience » de
notre époque. Une époque en mal de repères et de certitudes, serait-ce celle du
néant, ce que déplore l’auteur. Contrairement aux apparences, en effet, le néant est
susceptible de donner son contenu à une connaissance capable ensuite de s’en
émanciper, au profit de la civilisation entière. En d’autres termes, être sûr qu’il n’y a
rien, plutôt que n’être sûr de rien. Ni traditions, ni valeurs, puisqu’elles sont niées,
les unes après les autres, sans pourtant être remplacées par de nouvelles. Et
pourtant, ce n’est pas parce qu’il est nié que notre besoin de racines, d’attaches,
est devenu moins fort. Peut-être est-ce là tout le paradoxe de l’homme moderne :
détruire sans être capable de reconstruire, se détacher des traditions sans pouvoir
SAGGI
Abstract
7
totalement renoncer à son besoin d’être rattaché à quelque chose – un Dieu, une
patrie, une famille, des garanties incontournables pour se sentir appartenir à au
monde au lieu d’être un simple passager ; en un mot, pour avoir une identité. Mais
quel Dieu ? Quelle patrie ? Quelle famille ? Quel est désormais le contenu de ces
concepts ? Sans humanité, la religion n’est plus que fanatisme. La famille, érigée
en valeur absolue, devient une cellule de repli contre un monde en déclin, la patrie
considérée comme une divinité n’est plus qu’idolâtrie, justifiant des idéaux
libertaires pourtant incapables de créer des valeurs nouvelles sous le signe de la
communauté, aggravant le fléau de la perte d’une identité nationale et témoignant,
surtout, d’une « perte », celle d’un « centre » auquel se rattacher et s’identifier
ensemble. C’est seulement en retrouvant ce centre, un Dieu, une patrie et une
famille susceptible d’être partagés tout en étant vécus, individuellement, dans la
liberté, qu’on pourra, pourtant, échapper à l’horror vacui.
Marcello Veneziani’s essay, Dio, Patria e famiglia is one of those type of
texts you are forced to take an interest in, as the 'state of consciousness' of our time
comes from it. We are living in an time which has neither reference points nor
guarantees, a time made of nothing, which the Author deplores. As a matter of fact,
in spite of its appearances, the nothing is susceptible to give its contents to a
knowledge which will be able to get rid of it hereafter to the benefit of the whole
civilization. In other words, to be sure that there is nothing, rather than to be sure of
nothing. Neither traditions nor values because they are denied, one after the other,
without being replaced by new ones. However, the fact that the man denies them
does not mean that our need of roots has become less strong. Maybe this is the
whole paradox of the modern man: to destroy without being able to reconstruct, to
move away from the traditions without totally give up to his need to be attached to
something - God, home, family, some guarantees which are necessary to make him
feel like he belongs to the world instead of being a simple passenger; in one simple
word, to have an identity. But which God? Which Home? Which Family? What is,
now, the content of these concepts? Without Humanity, Religion has become
nothing more than Fanaticism. Family, established as an absolute value, has
become a makeshift cell against a world in decline; Home, considered a Divinity, is
nothing more than Idolatry which justify libertarian ideals, nevertheless unable to
create new values under the sign of the community, and worsening the feeling of
loss of a national identity, and above all witnessing a 'loss', the loss of a 'center' to
which to cling to and empathize together. Only finding again this center, God,
Home, and Family which could be shared as they have been lived individually in
freedom, it would be possible to escape the horror vacui.
Ci sono libri con i quali si è costretti a fare i conti giacché,
se ne condividano o meno le tesi, registrano fedelmente, come
pochissimi altri, lo «stato di coscienza» dell’epoca in cui ci tocca
vivere. È il caso del nuovo saggio di Marcello Veneziani, Dio,
8
Patria e Famiglia dopo il declino (Mondadori, 2012), un saggio che,
come gli altri del prolifico pubblicista pugliese, può far storcere il
naso sia agli addetti ai lavori accademici, che vedranno nella sua
cultura filosofica l’ombra del dilettantismo e del non
approfondimento teorico, sia agli «intellettuali militanti», se ancora
ce ne sono, scandalizzati dalla riproposta di temi classici del
pensiero reazionario e conservatore.
Sulle competenze storico-filosofiche di Veneziani - le sue
letture mi sembrano vaste e tutt’altro che superficiali - non mi
pronuncio e, d’altra parte, pur avendo scritto molto, Veneziani, a
quel che mi risulta, non ha mai presentato una domanda a un
concorso a cattedra; quello che mi sento di dire, in piena
coscienza, è che il libro Dio, Patria e Famiglia dopo il declino pone
all’uomo contemporaneo - e in particolare all’italiano di questi
tristissimi tempi- questioni cruciali, relative all’etica, alla politica,
alla religione, che non si possono liquidare con l’aria di sufficienza
di chi se ne occupa, nelle aule scolastiche e nei laboratori delle
scienze sociali, solo per dovere professionale o per guadagnarsi lo
stipendio o (ed è il caso più frequente) per «far politica» con altri
mezzi.
Come tutti i «pensatori della tradizione», Veneziani
analizza con spietatezza la modernità e le sue illusioni e rivolge
agli immemori e a quanti vivono la vita senza prenderla affatto sul
serio domande tanto ineludibili quanto imbarazzanti. Avverto subito
che, forse perché segnato dall’illuminismo empiristico angloscozzese - quello francese, nel bene e nel male, era altra cosa trovo metafisiche le tesi che vengono dedotte dalle analisi storiche
e filosofiche svolte nel libro e che, in quanto metafisiche, mi
sembrano il rovescio delle Weltanschauungen della vulgata
progressista che vi vengono demistificate, spesso - va riconosciuto
- in maniera brillante e convincente.
Mi spiego meglio: il dramma dell’uomo, dopo la «‘caduta»’
seguita al peccato originale (un dogma che i credenti farebbero
bene a non archiviare tra le metafore pedagogiche divenute ormai
inservibili nell’età della ragione), consiste nell’incertezza ontologica
in cui sono immerse tutte le cose, da quelle naturali a quelle che
vengono costruite e distrutte nel corso della storia millenaria dei
9
figli di Adamo. Nei periodi di crisi, nel passaggio da un orizzonte di
vita a un altro, quell’incertezza diventa angosciosa: non ci sono più
autorità terrene o divine a indicare il cammino, a prescrivere norme
di condotta, si ha la sensazione di procedere lungo un tunnel
senza vie d’uscita. In questi frangenti, alle visioni del mondo stabili
e conchiuse, dove tutto era ordine e senso - si ricordino i versi del
Canto I del Paradiso dantesco:
Le cose tutte quante/ hanno ordine tra loro, e questo è forma/ che
l'universo a Dio fa simigliante./ Qui veggion l'alte creature l'orma/ de
l'etterno valore, il qual è fine/ al quale è fatta la toccata norma./ Ne
l'ordine ch'io dico sono accline/ tutte nature, per diverse sorti,/ più al
principio loro e men vicine;/ onde si muovono a diversi porti/per lo gran
mar de l'essere, e ciascuna/ con istinto a lei dato che la porta
- succedono quadri desolati della condizione umana: non è il
Paradiso ad attenderci ma le bocche spalancate dell’Inferno
ovvero il «nulla eterno» evocato da Ugo Foscolo nel sonetto Alla
sera. Può sembrare strano ma anche la certezza del nulla ha
qualcosa di consolatorio e può aiutare, in qualche modo, a vivere
(o, se si preferisce, a morire). Le filosofie della crisi non ci fanno
sentire in un paesaggio incognito, ma in una città maledetta di cui
conosciamo fin troppo bene vie e piazze: i luoghi sono orrendi ma
li dominiamo col pensiero e, abbandonando questa valle di
lacrime, andiamo incontro verso la liberazione.
In realtà, non dominiamo proprio niente: nelle porcilaie
possiamo non accorgerci delle perle che vi sono state gettate
mentre nei luoghi della più alta spiritualità possiamo assistere a
rappresentazioni teatrali che ci sembrano cariche di sostanza
spirituale mentre sono soltanto villaggi Potemkin costruiti da
anime moribonde. Insomma non sappiamo, affatto, da dove può
venire (se verrà) la salvezza, né da dove possono venire le insidie
che minacciano la vita nostra e degli altri. Per questo è
consigliabile rinunciare ai voli (immaginari) nell’etere celeste come
alle discese agli Inferi: rimaniamo coi piedi sulla terra, chiedendoci
sempre, con Montaigne, que sais-je? e accontentandoci di
congetture
e
di
nessi
causali
riguardanti
fenomeni
irrimediabilmente circoscritti. Ciò non significa la rinuncia a
«pensare alla grande», a identificare bisogni «essenziali» e valori
10
che fanno parte del nostro dna antropologico ma dismettere la
pretesa che quei bisogni e quei valori s’incarnino in istituti posti al
riparo dal continuo, implacabile, rimescolamento delle carte
operato dal Tempo.
Porsi sul terreno dell’empiria significa prendere atto della
«realtà effettuale», con le sue luci e le sue ombre, assumere
l’esistente come qualcosa che va compreso e non,
programmaticamente, mutato perché «cattivo», non sottrarsi alle
spinte al cambiamento, guardandosi bene, però, dallo stravolgere i
connotati dell’ambiente materiale e spirituale che si vuole
cambiare. Per dirla in poche, semplici, parole, l’uomo è insieme
radici e progetto, è tradizione e innovazione, è l’albero che sfida i
secoli ma anche la cesoia d’acciaio che spezza le catene. La
tragedia dell’illuminismo - che si perpetua non soltanto nei filoni
libertari del nostro tempo ma, altresì, nelle ideologie ufficiali dei
partiti e dei governi - sta nell’incomprensione, se non nella
cancellazione, delle radici: l’uomo è l’essere libero, responsabile e
pensante, che deve emanciparsi da tutti i legami non scelti, dalle
condizioni esistenziali in cui lo ha messo la sorte, deve
considerarsi faber fortunae suae. Sennonché l’uomo non è soltanto
raison, è anche comunità e destino. E qui i filosofi della tradizione
colgono nel segno ed è difficile dar torto a Veneziani quando
scrive, citando Giovanni Gentile:
In fondo all’Io c’è il Noi e nella nostra interiorità abita un mondo comune.
Non possiamo tradurre questo connaturato legame sociale con la
semplice considerazione di essere abitanti e cittadini del mondo; siamo
prima di tutto figli e poi genitori, legati alla dimensione famigliare, via via
allargando per cerchi concentrici dai legami naturali e culturali, affettivi ed
elettivi, per affinità e prossimità di luogo, di lingua, di lavoro, di fede, fino
ad ambiti più vasti. È innaturale pensare il contrario, come ritengono i
cosmopoliti, capovolgere la scala e partire dall’universo; è astratto amare
l’umanità se non si parte da chi ti è davvero prossimo. È contro la nostra
sensibilità, la nostra vita, la realtà. Siamo esseri in relazione, identità
aperte e comunicanti, c’è una trama di energie che ci collega al mondo.
Ciò non scalfisce l’esigenza di solitudine, il riconoscimento delle irripetibili
individualità, la libertà personale di decidere. In interiore homine habitat
communitas.
11
Resta vero, però, che l’anelito alla libertà, a rimuovere i
vincoli dei costumi e delle tradizioni,a costruirci un’esistenza a
nostra misura, è altrettanto forte e insopprimibile del bisogno di
radici e che, almeno in Occidente, da quell’anelito sono nate le
grandi civiltà, l’Atene dell’Accademia e del Peripato, che fa a pezzi
la paidèia omerica e aristocratica, la Firenze dell’Umanesimo e del
Rinascimento, che ripropone in veste cristiana il protagoreo
anthropos metron panton chrematon ,«l'uomo è la misura di tutte le
cose», la Parigi dei lumi che fissa le premesse teoriche dei diritti
dell’uomo e del cittadino, e l’Edimburgo degli empiristi, che nella
«ragionevolezza» coniuga Montaigne con Galileo. Prigionieri del
tetro carcere del Passato, gli esseri umani sarebbero restati allo
stadio della tribù, non avrebbero mai costruito la polis, l’impero
romano, lo stato nazionale. Comunità e società - intesa,
quest’ultima, come luogo d’incontro di individui liberi ed emancipati
- sono i «trascendentali» della civiltà ovvero le categorie fondanti
senza le quali sarebbe impossibile pensare e realizzare una
convivenza libera e sicura. Ma una volta riconosciuto che la
sinistra (erede dei Lumi) tende ad abbattere gli alberi della
tradizione e che la destra (depositaria dei Valori trasmessi dal
«mondo di ieri») misconosce l’insopprimibile bisogno di «far da
sé», di peregrinare nell’esistenza assumendosi la responsabilità
del proprio agire autonomo, il diritto di dire no e affrontare le
conseguenze del rifiuto - il successo o lo scacco -, rimane il
problema di come far convivere il Dr. Jekyll (della tradizione) e il
Mister Hyde (dell’innovazione).
Ed è qui, su questo punto cruciale, che diventa saggio
rinunciare alle folgoranti visioni utopiche e/o apocalittiche e ci si
deve rassegnare, crocianamente, a compiere, nel breve passaggio
in questo mondo, la nostra umile parte di operai della storia (con la
esse minuscola), lasciando all’immaginazione di quest’ultima la
fatica di tener unite le due parti del visconte dimezzato. Scriveva
Croce: «Il moto della storia ha due estremi astratti e inattuabili, il
radicale e integro rivoluzionarismo e il radicale e integro
conservatorismo, ma nella sua concretezza e realtà corre sempre
nel mezzo». Solo che a farlo scorrere nel mezzo è un insieme
complesso di fattori -culturali, economici, politici, religiosi - che
12
rinviano non a una «scienza del governo» ma a un’ «arte del
governo», il cui successo è spesso opera del caso, come dimostra
un paese come l’Inghilterra che ha fondato le sue istituzioni liberali
non sugli individui «atomi razionali», che avevano in mente i
rivoluzionari francesi, ma su persone in carne e ossa, su comunità
storiche viventi, su classi, chiese, associazioni determinate a
rimanere se stesse, inalterate nel tempo, ma costrette poi,
dall’imperativo stesso della sopravvivenza, ad aprirsi al nuovo, a
cooptare attori sociali prima esclusi e a servirsene per puntellare
un edificio politico in continua necessità di manutenzione.
Veneziani, nel suo linguaggio scintillante che a volte par
quello della filosofia che si riveste di poesia e altre volte quello
della poesia che si fa intuizione filosofica del Vero, spiega assai
bene la natura e la funzione della religione, della patria, della
famiglia (a quest’ultima dedica le pagine, forse, più belle del libro):
Ma cosa sono, cosa erano, Dio, patria e famiglia? Erano e sono gli argini
di sicurezza per fronteggiare la paura di perdersi, di soffrire e di morire.
Erano la triplice unità di misura per vivere. Dio, patria e famiglia sono i
custodi della Casa dentro cui abita l’uomo. Dio è il tetto, la patria è il
pavimento, la famiglia è il focolare. Dio ci collega con il cielo e ci protegge
dal cielo, la patria ci collega col mondo e ci protegge dal mondo, la
famiglia ci collega ai bisogni e ci protegge dai bisogni.
E conclude: « Dio, patria e famiglia appaiono oggi come
vincoli e limitazioni, ma per lungo tempo furono argini di sicurezza
per vivere la vita e superare le sue tragedie sapendo di poter
confidare in loro. Insieme, come le tre Parche, filarono il nostro
destino».
I liberali farebbero bene a meditare su questa tesi giacché
raramente, nel «secolo breve», hanno affrontato il tema del
rapporto tra «comunità politica» e diritti civili. Non lo avevano
affrontato neppure i liberali del «secolo lungo», l’Ottocento (un
secolo che si apre nel 1789 e si chiude nel 1914) ma unicamente
perché c’erano per loro dimensioni del politico scontate, che, come
tutte le cose scontate, non potevano costituire oggetto di
riflessione. Quando si leggono certe pagine di Alexis de
Tocqueville - ad es. sull’Algeria o sui rapporti tra Francia e
Inghilterra - o di John Stuart Mill - vedi le considerazioni sul
13
principio di nazionalità o sull’espansione oceanica della Gran
Bretagna - si ha quasi l’impressione di trovarsi dinanzi a ideologi
protonazionalisti (è il motivo per cui di quelle pagine si occupano
solo gli studiosi che non ne possono più dell’esaltazione scolastica
e obbligatoria di quei giganti del pensiero liberale), ma è
un’impressione superficiale.
In realtà, sia per l’aristocratico normanno che per
l’intellettuale londinese, i diritti di libertà avevano senso all’interno
di una comunità politica già data, erano abiti istituzionali da far
indossare a individui concreti, con i loro costumi, la loro lingua, le
loro tradizioni plasmati da una storia millenaria. Il liberalismo non
era il verbo che si fa carne e, in quanto tale, «fa» gli Inglesi e
(come avrebbe voluto Tocqueville) i francesi, ma era uno «stile di
vita», per così dire, inteso a rendere più «civili» i rapporti sociali e
politici all’interno di una «famiglia»,esistente da tempo
immemorabile, che, grazie ad esso, sarebbe diventata più
prospera e coesa. Non è un caso che, nella società del superficiale
universalismo buonista, questa dimensione non sia sfuggita a uno
dei pochi studiosi (col nostro Giuseppe Bedeschi) che si siano
cimentati in una storia del liberalismo, in una prospettiva teorica e
metodologica liberale, Pierre Manent. Mi riferisco al libro In difesa
della nazione. Riflessioni sulla democrazia in Europa (trad. it.,
Rubbettino 2008) che, in una cultura dominata da sterili dibattiti
sulla giustizia come equità a fondamento della ragione pubblica, è
passato quasi inosservato - almeno in Italia, va precisato, giacché
negli Stati Uniti il tema del rapporto tra liberalism e nationalism è
dibattuto in centinaia di saggi da noi sistematicamente ignorati. In
quell’aureo saggio, si leggono frasi come queste: «L’eguaglianza di
diritti e l’eguaglianza di fronte alla legge hanno senso, e d’altra
parte sono possibili, solo tra cittadini di una comunità già esistente
e organizzata secondo un regime democratico»; « l'umanesimo
che pretenda di staccarsi del tutto da ogni responsabilità verso un
popolo specifico o da una prospettiva chiara sul bene umano è
vano e vuoto»; o ancora:
Una forma politica – la nazione, la polis – non è un abito leggero che si
può usare e mettere da parte a piacimento rimanendo quel che si è.
Essa è quel Tutto nel quale ogni elemento della nostra vita si riunisce
14
e acquista un senso. Se la nostra nazione scomparisse all’improvviso,
e se ciò che essa mantiene unito si disperdesse, ognuno di noi
diverrebbe istantaneamente un mostro per se stesso. Quelli che si
ritengono i più emancipati dalla loro nazione vivono ancora fortemente
della sua fecondità.
Se dovessi riassumere il vero limite del saggio di
Veneziani, direi che esso non sta nell’averci ricordato che senza
Dio, senza la patria, senza la famiglia non si costruisce nulla di
durevole - contrariamente a quel che pensa l’universalismo
libertario per il quale l’apologia di quei tre termini suona come
apologia del trono e dell’altare - ma nell’aver tenuto separati, la
Tradizione, da un lato, e i Lumi, dall’altro, pur nel riconoscimento e in questo Veneziani si distingue decisamente dai tradizionalisti
alla Gustave Thibon, il filosofo-contadino amico di Simone Weil delle buone ragioni dell’una 8l.a Tradizione e degli altri (i Lumi).
Per lui, quel riconoscimento, al quale è approdata una destra
problematica e pensosa come la sua - a sinistra non s’è mai visto e
difficilmente si vedrà. «Sinistra e destra - scrive in una pagina tanto
malinconica quanto spiritosa che ricorda le riflessioni di Augusto
Del Noce sull’età della secolarizzazione - morirono insieme dopo
una lunga agonia. Ma agli orfani della sinistra fu riconosciuta la
pensione, la riconvertibilità e il credito culturale; gli orfani della
destra ebbero invece il vituperio e lo sfratto esecutivo dalla casa
paterna, dichiarata inagibile. A loro si nega pensiero ed esistenza,
salvo abiura e integrazione nel nichilismo come braccio obbediente
del libero mercato».
Dio, Patria e Famiglia dopo il declino è stato scritto proprio
per ricordare agli «smemorati di Collegno», quali sono divenuti i
nostri connazionali, quel che si è perso e quel che si acquistato
con il tramonto di quegli «idola». Il bilancio, però, è neutrale solo in
apparenza, come può vedersi in questo brano in cui si parla della
fine della famiglia:
Al posto della famiglia c’è soprattutto la solitudine dell’Io; il singolo è
misura di tutte le cose; il resto è passeggero, variabile dipendente del
soggetto. Alle origini c’è il rigetto dei legami ereditati, non scelti ma
assegnati dalla sorte o pietrificati da suggelli indissolubili. Ma al posto
della famiglia c’è stata anche una grande conquista: la liberazione
della donna come soggetto indipendente. Non ci sarebbe stata la sua
15
ascesa senza quel declino: abbiamo pagato l’emancipazione
femminile con la decadenza della famiglia (non è la sola ragione, per
carità). Sarebbe falso negare l’una nel nome dell’altra. Grande
conquista, grave perdita. Ciascuno poi valuti se il baratto è stato
vantaggioso o meno.
Non critico Veneziani per questa sua poco credibile
«obiettività» - conservatori e progressisti non possono uscire dai
loro gusci: si ritroverebbero come tartarughe prive di carapace ma per aver diviso, nel pensiero, quel che è unito nella realtà
storica. Dio, Patria e Famiglia rinviano a bisogni essenziali e
ineludibili - anche se, lo ripeto fino alla noia, il radicalismo
illuminista non li ritiene tali - ma quale Dio? Quale Patria? Quale
Famiglia? Siamo sicuri che la diversa configurazione assunta, nei
secoli, da quei simboli «venerandi» non si debba al fatto che, nella
natura più intima di ciascuno di essi, finisce per penetrare «l’altro
da sé», insinuando misure umane e razionali per cui la «comunità
di destino» si vede costretta a confrontarsi con la «società del
perché? e del cosa significa (ti estì)» e a rassegnarsi a un «ibrido»
sociale, in cui è difficile distinguere tradizione e innovazione,
appartenenza e ragione? Per dirla con parole chiare etiam Turcis,
cosa fa sì che Moloch, il crudele Dio dei Cananei, la cui sede di
culto era la Geenna, diventi il Dio cristiano che «atterra e suscita,
che affanna e che consola»? È pensabile la religione cristiana
senza il «logos» al quale si riferì Papa Ratzinger nel discorso di
Ratisbona? E le dispute medievali tra agostiniani-platonicifrancescani, da una parte, e domenicani-tomisti-aristotelici,
dall’altra, non sono gli incunabili del razionalismo moderno e non
hanno nulla a che vedere con l’alba dell’età della
secolarizzazione? In questo malinconico mondo sublunare è tutto
mescolato ed è proprio tale mescolanza a indurci a non
avventurarci in ricostruzioni troppo impegnative del passato e del
presente dell’uomo.
Del resto, sempre rimanendo nell’ambito della religione, lo
stesso Veneziani, in giusta polemica con Gustavo Zagrebelsky,
ricorda l’importanza, per le società anglosassoni della religione
civile.
16
Una società libera e matura ha bisogno di una fonte comune e super
partes da cui attingere principi, fondamenti comuni e valori non
negoziabili. Quella fonte, diversamente nominata, non può essere che
una tradizione riconosciuta come religione civile. La religione civile va
distinta tanto dall’integralismo e dalla teocrazia quanto dalle religioni
secolari, che pretendono di sostituire le religioni trasferendo i paradisi e
gli inferni in terra. La religione civile non è Dio che entra in politica né la
Rivoluzione, il Partito, la Razza, la Classe, lo Stato, la Storia che
surrogano Dio. La religione civile fonda il legame sociale su tradizioni,
eventi, costumi, miti, principi, valori, sensibilità che precedono la sfera
politica e trascendono quella amministrativa. Per Zagrebelsky la religio
civilis è nemica della democrazia perché non nasce dalla libertà ma la
precede; dunque è autoritaria e teocratica. Ma il massimo fautore della
religione civile fu Machiavelli, tutt’altro che un devoto clericale, e il suo
riferimento era ai padri del mondo classico, precristiano.
Già, ma almeno nel Nord America, è pensabile la
«religione civile» come benedizione della comunità politica se
questa non incorpora un «destino» che è fatto anche di libertates
antiche, di diritti individuali inalienabili, di «fucile e Bibbia», di quel
rapporto diretto tra il credente e il suo Signore che fonda, in
definitiva, l’autonomia della coscienza? La «religione civile» parla
di Dio ma non è certo lo stesso Dio del Visconte Louis de Bonald e
perché non lo è? Non lo è perché nella prima sono entrati elementi
«spuri» (per un tradizionalista), sono entrate cose come la libertà e
la dignità degli individui uti singuli, conciliabili certo col senso della
trascendenza - che, per il credente, ne sarebbe la garanzia più
sicura, in quanto sottratta al relativismo etico e alle tentazioni
nichilistiche - ma certo imparentate con i valori dell’89.
Come Dio è un metallo che non si trova mai allo stato puro
- e proprio per questo è una delle basi delle civiltà umane - così la
patria non è dissociabile da elementi che non fanno parte del
«destino». Qui, forse, è l’aspetto più problematico del discorso di
Veneziani che, nel momento in cui mette in luce la realtà
imprescindibile di certi bisogni, sembra poco attento alle modalità
con le quali vengono soddisfatti, nella lunga storia dell’umanità
occidentale.
La patria è la mia casa, la mia lingua, il mio paesaggio, il luogo delle
origini, la terra dei padri e delle madri e di tutto ciò che è nostrano, a
cominciare dalle persone. Un bene essenziale, puro, senza offesa verso
17
altri, che suscita amore senza scatenare odio e possesso, che ti fa sentire
non occasionale passeggero di questo mondo, ma abitante di una terra e
proveniente da una storia. Un amore che non preclude altri amori per
luoghi elettivi ma quel luogo lo avverti come speciale, originario,
famigliare. Sbucciate l’amor patrio di ciò che non è essenziale, vivo e
meritevole di vita, anziché gettarlo per intero, come frutto avvelenato o
inacidito. Puntate diritto al cuore della patria e vedete quel che resta. […]
Al posto della patria fisica e spirituale, di terra e corpo, c’è la patria web
dell’etere tra provvisorie comunità, contatti fluttuanti senza carne né
confini. Labili consorterie, occasionali convergenze, compagnie virtuali.
Non patrie ma fratrie di naviganti.
Al di là dell’immancabile pathos, si possono pure
condividere queste tesi che, oltretutto, evidenziano l’inconsistenza
etica e culturale del «patriottismo costituzionale»:
Il problema, però, non è quello di prendere atto di un
generico - ma non per questo meno reale - bisogno di «radici»,
bensì l’altro di capire, nel caso italiano, perché, ad esempio, la
Puglia (o altro luogo) non basta e avanza per appagare quel
bisogno di cui parla Veneziani. Perché, a un certo punto, il luogo
«dove ti senti a casa, dove i cinque sensi percepiscono il mondo
come familiare», gli odori, i sapori, le canzoni, le parlate della tua
gente, si allarga al punto da ricomprendere regioni il cui dialetto
(pardon, la cui lingua: non voglio peccare contro il «politicamente
corretto»), se sei nato a Imperia, è per te meno comprensibile del
francese? Che cosa fa sì che, nel tuo cuore e nella tua mente,
irrompa, per usare l’espressione di Benedict Anderson, la
«comunità immaginata», l’Italia del libro Cuore (1886) - un libro
fondamentale a torto guardato con sufficienza da cattolici, marxisti
e laico-razionalisti - in cui le montagne della Sila e quelle del
Piemonte diventano un luogo dell’anima sia per lo scolaro torinese
che per quello calabrese?
Ce lo spiega Pierre Manent nel saggio citato:
Lo Stato-nazione fu per l'Europa moderna ciò che la polis fu per la
Grecia antica: quel che produce l'unità della vita, e dunque l'universo
di senso, generando la cosa comune. Nonostante eccellenti lavori
storici, il paragone tra le due forme politiche conserva ancora
insegnamenti che sarebbe importante portare alla luce. Quel che si
può dire in ogni caso, è che la polis e lo Stato-nazione sono le due
sole forme politiche che sono state in grado di realizzare, almeno nella
18
loro fase democratica, l'unione profonda tra incivilimento e libertà. Vi
furono grandi imperi civilizzati i quali, anche nei loro giorni migliori,
ignorarono la libertà. La vita delle tribù, più generalmente la vita
«primitiva», comporta una forma molto chiara di libertà, ma ignora il
fascino e le grazie della civiltà. Vorrei ora prendere in considerazione
la forma dello Stato-nazione, lasciando da parte, a malincuore, la
questione della polis. La familiarità nutre il disprezzo. In ogni caso, non
sappiamo più apprezzare quel che è stato compiuto dallo Statonazione europeo nel suo sviluppo storico. Si è trattato di un'impresa
straordinariamente audace, che ha richiesto una mobilitazione, inedita
per la sua intensità e soprattutto per la sua durata e la varietà dei suoi
toni, di risorse dell'anima non soltanto da parte dei capi e degli
ispiratori ma anche di tutti i cittadini. Si è trattato di estendere la vita
civica, il «vivere libero», fino ad allora, nel migliore dei casi, privilegio
di un piccolo numero d'individui, a innumerevoli associazioni di uomini.
Si è trattato di governare enormi assemblee di uomini lasciandoli liberi.
L’Italia, quale la pensarono i padri del Risorgimento, fu
appunto «l'unione profonda tra incivilimento e libertà», fra la tribù e
l’Umanità: fu «il liberalismo in un solo paese», non in quanto
ritenuto privilegio di una sola etnia culturale ma in quanto pensato
realisticamente come valore perseguibile solo in presenza di
risorse culturali, politiche, economiche in grado di sostenerlo. Per
garantire seriamente i diritti civili, infatti, occorre uno Stato forte,
capace di far rispettare l’ordine e la legge, occorre una comunità
storica, seppur politicamente ancora disunita, caratterizzata da una
fitta rete di rapporti di scambio e da una lingua parlata e compresa
da tutti. Giustamente, dal loro punto di vista, i tradizionalisti italiani
- letti da Veneziani con filiale devozione - vedevano nel
Risorgimento l’ombra sanguinaria dell’Illuminismo e della
Rivoluzione francese. Il Risorgimento era anche questo, era la
nostra rivoluzione sia pure più vicina allo spirito di Filadelfia che a
quello di Parigi, come ben vide Alessandro Manzoni nell’opera
incompiuta, scritta negli anni 1862-1864, Saggio sulla rivoluzione
francese del 1789 e la rivoluzione italiana del 1859. Quel che si
proponevano i Minghetti, di De Sanctis, i Mazzini era la
«nazionalizzazione» di un immenso patrimonio di arte e di storia, di
bellezze naturali, di cui avrebbero dovuto beneficiare i popoli di un
vastissimo territorio esteso dal Monte Rosa a Pantelleria.
Sull’orgoglio dell’appartenenza doveva fondarsi un riscatto
civile e politico, atto a trasformare «un volgo disperso che nome
19
non ha» in una comunità di cittadini, fieri dei loro diritti e protesi
verso il futuro. «Libertà», come acquisizione di rispetto, di dignità,
di autonomia per sudditi diventati, finalmente, cittadini e
«proprietà» come custodia e garanzia di una «particolarità» che ci
distingueva da altri popoli e rappresentava il «materiale» prezioso
sul quale costruire l’edificio civile che ci avrebbe ricongiunto
all’Europa vivente. Di qui l’oggettiva - ma positiva - ambiguità
ontologica degli artefici dello Stato nazionale: erano «nazionalisti»
ante litteram? erano portatori di idealità universali, maturate nel
secolo dei lumi? Erano entrambe le cose, anche se non erano
nazionalisti nel senso di Enrico Corradini e non erano universalisti
nel senso di Luigi Ferrajoli e dei filosofi politici e sociologi
«antagonisti» o semplicemente «patrioti del mondo» come Edgar
Morin. Solo che la natura mista della nuova comunità politica che
sostituirono alla vecchia Staaterei italica era quella di ogni grande
realizzazione umana e, con ciò, si ritorna al punto dell’impossibile
separazione, nel corpo vivente della storia, di tradizione e
innovazione.
In un brano non poco significativo del suo libro, Veneziani
scrive: «Se si è sicuri della propria identità, è possibile anche
integrare gli stranieri, da un verso accogliendo la loro identità e
dall’altro favorendo la loro integrazione. Ma perché questo
avvenga è necessario che ci sia una forte identità di base, larga e
sentita. A questo paese è mancata una religione civile, ovvero un
sentire comune fondato sulla propria tradizione civile e religiosa,
sulla propria storia e sul valore delle esperienze tramandate; il
sentire religioso ha sempre fatto a pugni con la lealtà istituzionale».
Le riflessioni di Veneziani colgono spesso nel segno ma,
altrettanto spesso, nascondono, l’altra faccia della luna. La relativa
estraneità, spesso trasformata in aperta ostilità, dell’universo
cattolico al processo unitario - un’estraneità motivata, va
riconosciuto, dalla preoccupazione per un pontefice privo di
sovranità temporale e quindi riducibile a cappellano di corte - è,
senza dubbio, uno dei drammi della storia d’Italia, contrariamente a
quel che pensa una superficiale storiografia laica, di cui
Risorgimento laico di Massimo Teodori (ed. Rubbettino) è
esempio da manuale. Ed è un dramma non certo per la
20
contrapposizione di una superstizione condivisa dalla maggioranza
del popolo delle parrocchie al generoso disegno riformatore dei
patrioti - come credono appunto i laicisti - ma per il mancato
supporto della religione-bisogno fondamentale dell’uomo,
indipendentemente dalle forme che essa assume - a un’impresa
civile iscritta nel progetto moderno.
Sulla linea, del resto, delle varie chiese e sette inglesi che
prepararono la stagione delle grandi riforme, sensibilizzarono i
sudditi di S.M. Britannica alla questione sociale, contribuirono a
infondere nel patriottismo un senso dell’onore e della
responsabilità che richiamava la missione che nell’Eneide Virgilio
assegnava alla città eterna: «Tu regere imperio populos, Romane,
memento: hae tibi erunt artes, pacisque imponere morem, parcere
subiectis et debellare superbos» («di reggere col tuo impero i
popoli, o Romano, ricorda: queste saranno le tue arti, e alla pace
d'imporre una regola,risparmiare gli arresi e sgominare i superbi»):
non a caso Rule Britannia (1740) era seguito da God save the King
(1743): Dio, appunto. Ma come poteva realizzarsi qualcosa di
simile in Italia dove «il sentire religioso» trovava la sua
codificazione nel Sillabo di Pio IX che, tra gli errori del mondo
moderno, annoverava quello riportato al XV paragrafo: «È libero
ciascun uomo di abbracciare e professare quella religione che,
sulla scorta del lume della ragione, avrà reputato essere vera»?
Come si poteva venire a patti con un potere spirituale che, a
prendere alla lettera i suoi anatemi, avrebbe indotto a riguardare gli
Stati Uniti come il regno del demonio, giacché proprio su
quell’«errore» gli americani fondavano le loro libertà civili e
politiche?
Al quindicesimo «errore» elencato da Pio IX avrebbe
replicato Marco Minghetti nel libro - sempre meno letto e pour
cause dai cattolici, soprattutto teocon—Stato e chiesa (1878): «vi
ha nella religione qualche cosa di così personale, intimo, e
profondo che si ribella ad ogni costringimento esterno, e quando vi
cede, egli è che lo spirito vivificatone vi è dileguato, e ne resta solo
la parte, per così dire, meccanica e di abitudine» da cui nasceva
la domanda «il suddividersi delle sette religiose è poi un male
assoluto? Ovvero non rappresenta i molteplici aspetti della verità
21
religiosa dirimpetto alla diversità infinita che si riscontra nell’umana
natura?». Spirito profondamente religioso, Minghetti vedeva nella
fede un bisogno ineliminabile, declinato, però, in un senso
inequivocabilmente individualistico:
Imperocché a chi ponga mente ai fatti della coscienza e a quelli della
storia apparisce chiara e ferma, sotto varie forme, una tendenza del
pensiero verso l'infinito, ed una irrequieta brama che non trova posa
nelle cose transitorie e relative e vuol salire all'assoluto. E sarebbe uno
smentire la coscienza e la storia il negare che l'uomo si pone tre
quesiti terribili, e si affanna a chiederne la soluzione. Questi si
presentano egualmente all'intelletto del pastore vagante nell'Asia, e
del pensatore educato nella moderna scuola, e ne crucciano l'animo
con eguale ansia: donde vengo? perché mi trovo in questo mondo? e
dove andrò dopo la vita presente? Ora posto che la scienza si dichiari
incompetente a risolvere tali problemi, non può negare la esistenza
loro come problemi e perciò come fatti interni, e di conseguenza gli è
mestieri di riconoscere nella coscienza umana un elemento
indistruttibile che è la base delle credenze religiose, avvegnaché esse
sole volgano a darvi soddisfazione.
Se nell’area cattolica maggioritaria fossero prevalsi gli «stili
di pensiero» dei Marco Minghetti, dei Bettino Ricasoli, dei Raffaello
Lambruschini, dei Gino Capponi, dei Ruggero Bonghi non sarebbe
mancata, con ogni probabilità, all’Italia una «religione civile» e gli
aspersori che, negli anni trenta del Novecento, avrebbero
benedetto le truppe in partenza per l’ultima, assurda, conquista
coloniale, meno di cent’anni prima benedissero il ricongiungimento
delle sparse membra della penisola in uno stato unitario,
costituzionale e, seppur carente sotto il profilo liberale, suscettibile
di miglioramento - a differenza degli stati pontificio e borbonico. Il
cattolicesimo liberale fu la grande occasione perduta della
«religione civile» nel nostro paese. Esso, tra l’altro, esprimeva le
sue ragioni con accenti che sembravano davvero riconciliare «due
secoli l’un contro l’altro armato». Per convincersene basta leggere
- tra i tanti documenti teorici del tempo - l’articolo di Raffaello
Lambruschini, Diffidenze di parte del clero verso la libertà,
apparso su «La Patria» di Firenze il 21 novembre 1847:
Ragioniamo dunque. La libertà può essere certamente abusata. I
disordini generati dalla licenza sono spaventosi. Ma se per questi
22
eccessi, che tutti i buoni detestano e deplorano, dovesse aborrirsi e
proscriversi la libertà; non si dovrebbe ugualmente, e forse più,
aborrire e proscrivere l'autorità, per l'abuso che di quella può farsi, che
se ne è fatto, che se ne fa tuttavia? Se si potessero numerare e
descrivere tutte le crudeltà, le stragi, le persecuzioni consigliate e
operate da' tiranni sitibondi di sangue, i quali tormentando, scannando,
fucilando, si sono vantati e si vantano di sostenere l'autorità regia, di
difendere la religione, di beneficare i popoli, di salvar loro l'anima; se
queste nefande scelleratezze si ponessero a confronto, si pesassero
insieme con le scelleraggini commesse da popoli abbandonati a libertà
sfrenata; quali prevarrebbero in numero, in durata, in enormità?
E il prelato genovese concludeva:
Siamo dunque di buona fede: gli eccessi della libertà, non provano
contro di lei nulla di più, provano forse meno, di quel che provino
contro l'autorità le sue insensatezze e la sua ferocia. Una
conseguenza se ne deve inferire; ed è che libertà ed autorità non si
possono disgiungere; ma si hanno a stringere e contemperare
insieme, come due forze reggitrici del mondo morale. E una seconda
conseguenza ne va dedotta; la quale i difensori tenaci dell'autorità
devono molto considerare: ed è, che se temono schiettamente le
smodatezze della licenza, non devono opporsi alla libertà. Combattere
la libertà, è irritarla: volerla incatenare è darle una forza da gigante, e
una forza sovvertitrice. La libertà non vuol servire, ma vuole obbedire:
non soffre il piede dell'autorità sul collo, ma ne riceve la mano che la
conduca e la sostenga. Iddio le ha fatte sorelle: qualunque di loro
pretenda signoreggiare sull'altra, fa dell'oppressa una tiranna.
Era il manifesto della «nuova alleanza» non più fra il trono
e l’altare, ma fra la libertà degli individui e dei popoli, che anelano a
liberarsi dalle catene dei tiranni (religiosi e secolari) e l’Autorità intesa dantescamente come la trinità della «divina potestate», della
«somma sapïenza» e del «primo amore»--che, in una visione
religiosa dell’esistenza, quella libertà garantisce, regola e modera.
Perplessità analoghe a quelle suscitate dall’analisi del
declino di Dio e della patria nascono dalla lettura delle pagine
dedicate alla famiglia (pagine, peraltro, talora struggenti e sotto il
profilo letterario molto belle) che, da un lato, viene descritta, nel
suo appannarsi nel cuore dei contemporanei, con tratti fin troppo
realistici e, dall’altro, ottiene un’indulgenza, non sempre meritata,
in base al ragionamento che centomila casi di crudeltà consumate
tra le mura domestiche non possono cancellare i milioni di casi in
23
cui quelle mura hanno custodito e protetto la vita. Il che è anche
vero ma non elimina il problema: la civiltà avanza nella misura in
cui si restringe la violenza potenziale delle istituzioni pur
necessarie alla convivenza umana e se, in esse, qualcosa talora
va male, non è un buon motivo per non metterci mano.
Scrive Veneziani:
Il paradosso della famiglia: è la comunità originaria più devastata in
Occidente ma è l’unica struttura portante intorno a cui ruota la vita
pubblica e privata e la principale mediazione tra l’individuo e la società.
La sua catastrofe non impedisce la sua strenua sopravvivenza come
rifugio del singolo, luogo in cui siamo messi a nudo e siamo più
autentici; dove i bisogni, gli affetti, le prime relazioni col mondo e le più
intime espressioni di vita trovano il loro alveo naturale, psicologico e
rituale. La famiglia ha smesso per molti di essere valore, ma non
smette di essere fatto, universalmente; e chi ha perso quel baricentro
nella vita lo vive in memoria, in raffronto, anche polemico; comunque
non riesce a cancellare la sua originaria dipendenza. Non c’è
emancipazione che non sia punteggiata dal suo riaffiorare,
influenzando non soltanto la sfera emotiva. Ma non solo: il racconto –
nei film, nei libri, ovunque – per farsi coinvolgente si fa intimistico,
autobiografico e famigliare, nel ricordo di padri, madri, figli. È l’unica
letteratura che emoziona, dopo la crisi del racconto pubblico, storico o
ideologico. Ci sono cordoni ombelicali che non si recidono ma mutano
stato, facendosi invisibili, perdendo in fisicità ma acquistando in
tenacia. Possiamo essere ormai fuori dalla famiglia in ogni senso; ma
la famiglia non è fuori da noi.
Sono considerazioni che è difficile non condividere ma,
ancora una volta, ci si chiede: quale famiglia? Certo non la famiglia
di Suor Virginia Maria, al secolo Marianna de Leyva y Marino,
meglio nota come la Monaca di Monza, della cui tragedia nulla
sapremmo se non l’avesse rievocata un cattolico liberale, «autor
d'un romanzetto ove si tratta di promessi sposi», per citare il
geniale Giuseppe Giusti e il suo famoso Sant’Ambrogio? Ma
neppure la famiglia del «nostro vecchio Sud», con le anziane zie
rimaste zitelle, che si spegnevano come candele, senza aver
potuto studiare (se non un po’ di pianoforte), senza aver
conosciuto le «sante gioie del matrimonio», ridotte a tener i
collegamenti tra il luogo natio di avi e genitori e i nipoti sparsi nel
24
mondo, ai quali comunicavano nascite e decessi di cugini spesso
visti una sola volta in modo da farsi vivi, almeno con un
telegramma di auguri o di condoglianze. Le legislazioni moderne
hanno azzerato l’arbitrio del «padre padrone», hanno tutelato i
diritti di figlie e di figli, hanno sottratto le madri al destino di
«schiave domestiche». Lo «spirito dell’89», sono d’accordo, è
debordato in nome di un’astratta eguaglianza e di una libertà
concessa a soggetti non ancora ‘maturi’ ma i guasti del
permissivismo dilagante non cancellano i sottili sadismi e i
meccanismi di potere all’interno della famiglia tradizionale. Che
conosceva momenti di elevata eticità e di intensa affettività quando
l’idillio comunitario era totale ma le norme della società circostante
- fossero quelle della polis o dello stato nazionale - erano fatte
rispettare e anzi, al suo interno, ci si poteva preparare ad essere
bravi cittadini, giusta i consigli che Enrico Bottini riceveva dal padre
nel ricordato capolavoro di Edmondo De Amicis.
Quando si raggiungeva l’equilibrio tra affetti e norme
(«comunità» e «società»), tornando a casa con una punizione
inflitta dall’insegnante, si sapeva bene che sarebbe mancata la
solidarietà dei genitori giacché essi, per principio, prendevano le
parti del professore o del preside, ritenendo questi ultimi, in virtù
del loro ufficio, del tutto disinteressati e quindi impossibilitati a
commettere ingiustizie. (Nella società permissiva contemporanea,
al contrario, la tolleranza per i comportamenti dei figli maleducati
diventa intolleranza per i malpagati insegnanti che li cacciano
dall’aula se disturbano durante le lezioni e non mostrano alcun
rispetto per quanti danno l’anima per insegnare loro qualcosa. A
casa non verranno più accolti con cipiglio severo e con le classiche
parole: «non si va a suola, per scaldare i banchi!»). La famiglia
degna di rimpianto è quella che difendeva, sì, il «noi», il nido
comunitario, che garantiva un amore senza condizioni -nella
consapevolezza malinconica, come dice il padre di Titta (Armando
Brancia), nel felliniano Amarcord (1973), che quello che un padre
fa per cento figli, cento figli non fanno per un padre - ma, insieme,
acculturava, insegnava a volare con gli altri, a rispettare le regole
della convivenza civile.
25
È il rapporto con la libertà, ovvero col bisogno di
emancipazione e di autonomia altrettanto iscritto nell’umano
quanto il bisogno di radicamento, a segnare la sorte di Dio, Patria,
Famiglia. Veneziani, invece, sembra pensare che tutto il malum
mundi venga da una scissione interna di quella triade, dalla perdita
di armonia derivante dalla pretesa di ciascun elemento di fare da
sé, di rinunciare agli altri o a uno dei due. In qualche passo del
libro, sembra che si tratti di una ybris antica: «Prima che il rigetto
in blocco di Dio, patria e famiglia come frutto di una stessa visione
organica, vi è la separazione conflittuale tra questi mondi, più varie
subordinate, compresa la conventio ad excludendum verso
ciascuna: Dio e patria escludendo la famiglia, per i seguaci di
Platone; Dio e famiglia escludendo la patria, per i seguaci delle
religioni che vedono la patria come idolatria ideologica o
naturalistica; Patria e famiglia escludendo Dio per i conservatori
laici che reputano Dio intruso nella sfera pubblica e civile». In altre
pagine, invece, si introduce un quarto termine, l’umanità, che non
si capisce bene, tuttavia, perché non debba, in qualche modo,
ricomprendersi in Dio, che, per i seguaci delle grandi religioni
universali monoteistiche, è il creatore del cielo e della terra e quindi
del suo abitatore in cui Egli si è compiaciuto.
Scrive, infatti, Veneziani: «La religione separata
dall’umanità diventa fanatismo, la famiglia eretta a valore assoluto
diventa familismo a scapito del mondo, la patria elevata a divinità
diventa idolatria nazionalista. Contemperandosi a vicenda, si
previene la loro degenerazione. Ogni reductio ad unum diventa
prima o poi reductio ad nihilum. Azzerando il contesto, si azzera
anche il testo; e non c’è due senza tre. L’uno assoluto e isolato,
anche se divino, diventa il cavallo di Troia del Nulla. Il deserto
ingoia l’Unico; il monismo cannibalizza tutto ciò che è intorno a sé;
e poi si suicida». Sennonché la «religione separata dall’umanità» è
una delle infinite species di religione, quella politeistica, per i quali
«uomini» sono soltanto gli appartenenti alla «tribù»: almeno in
Occidente, la religione non si è mai separata dall’umanità
riguardata come res publica christiana da proteggere e da
difendere, al di là delle frontiere politiche, dagli eretici, dagli atei,
dai rinnegati, dai ribelli che non accettano il primato di Pietro o da
26
quelli che obbediscono ciecamente alle direttive papiste. Anche se
in assoluta minoranza, la stessa setta si è sempre percepita
come compendio dell’intera umanità redenta dal peccato
d’orgoglio, come popolo eletto incaricato di salvare il mondo.
In realtà, i tre simboli comunitari - Dio, Patria, Famiglia non evitano la «degenerazione» «contemperandosi a vicenda»,
come pensa Veneziani, ma aprendosi alla libertà, alle esigenze
dell’individualità «moderna» che fa proprio il motto kantiano
«sapere aude!» e che vuol muoversi nel mondo senza esserne
impedita da lacci e vincoli familiari, patriottici, religiosi. Veneziani
ha ragione quando obietta a chi ricorda le vittime dei soffocanti
legami comunitari che i roghi e le torture dell’Inquisizione trovano
un riscontro, non meno crudele, nella ghigliottina francese e nei
«campi di lavoro» siberiani intesi a rigenerare l’umanità traviata. Al
«quantum potuit religio!» di Lucrezio, in effetti, si può sempre
contrapporre, idealmente, nel precipitare dei secoli, l’amara
esclamazione di Madame Roland «Oh libertà quanti crimini in tuo
nome!». Qui, però, non si tratta di stabilire graduatorie di
efferatezza o di ricorrere a spiegazioni rassicuranti dei delitti
compiuti nel nostro campo - per citare qualche topos
argomentativo: in un caso,la violenza politica giacobina o sovietica
non viene spiegata come un portato dell’ideologia illuministica o
del materialismo storico, ma come il residuo di costumi premoderni
e di superstizioni antiche di cui i rivoluzionari, «amici del genere
umano», non riuscirono a liberarsi del tutto; nell’altro, si sostiene
che le crudeltà di cui si sono macchiati i sacerdoti di Cristo non
sono iscritte nei Vangeli o nei testi dei Dottori della Chiesa ma
nella fragilità e nella corruzione della natura lapsa che non
risparmiano neppure gli uomini che hanno dedicato la vita al
servizio divino.
Si tratta, invece, di prendere atto che, al di là delle loro
mutevoli e contraddittorie manifestazioni nello spazio e nel tempo,
la passione della libertà e il bisogno di radici sono egualmente forti
e insopprimibili nell’animo umano e se calpestare l’anelito
all’emancipazione degli individui dai lacci avvolgenti della famiglia,
del paese, della chiesa conduce alla popperiana «società chiusa»,
voler azzerare nell’umanità il legame con la trascendenza
27
orizzontale - la proiezione di sé oltre il proprio «particulare», la
dedizione incondizionata alla famiglia e alla patria - e con la
trascendenza verticale - il legame totalizzante con Dio e l’attesa
del suo Regno - conduce a quell’inferno sulla terra descritto
nell’indimenticabile film di John Ford La croce di fuoco (The
Fugitive) del 1947, liberamente ispirato al romanzo Il potere e la
gloria di Graham Greene(1940).
Gli osservatori delle vicende umane che si sono formati sui
grandi testi della filosofia della crisi o della decadenza (ma crisi e
decadenza non sono la stessa cosa), ravvisano nella dialettica
comunità/società,
tradizione/innovazione,
destino/ragione
l’indebolimento del primo termine e in tale indebolimento prossimo all’estinzione - intravedono la fine di un mondo e l’inizio
di una nuova era votata alla catastrofe. E indubbiamente le loro
sconsolate analisi possono venir comprese e condivise anche da
quanti hanno alle spalle letture o militanze politiche molto diverse.
Specialmente in paesi come l’Italia, che sembrano «navi senza
nocchiero in gran tempesta», dove non solo le autorità tradizionali
appaiono, per dirla con una straordinaria metafora di Robert Musil,
uccelli impagliati su alberi di cartone ma il senso stesso
dell’identità nazionale è divenuto evanescente sicché ci si chiede,
sempre più spesso, perché si continui a stare insieme e se
l’unione di realtà regionali e culturali tanto diverse non sia stata
un’avventura finita male.
E tuttavia su questi «stati d’animo» pur giustificati non si
ricostruisce nessuna solida teoria che ci aiuti davvero a capire la
realtà in cui ci tocca vivere. Siamo attori - con diversi ruoli, ad
alcuni di noi è stata assegnata la parte del protagonista ad altri
quella di semplici comparse - sul grande palcoscenico della storia
e, in quanto attori, non possiamo essere insieme spettatori e
giudici. Certi fenomeni - mode, trend intellettuali, nuove credenze
collettive più o meno inconsce - ci colpiscono e talvolta
dolorosamente giacché ci fanno sentire parte di un mondo in
estinzione ma non possiamo prevedere come e se i due bisogni
fondamentali discussi in queste pagine - il radicamento comunitario
e l’emancipazione individualistica - troveranno nuove forme
espressive e nuovi istituti. È troppo facile dire: senza Dio, patria,
28
famiglia, l’individualità precipita nel vuoto del nichilismo, come,
d’altronde, è troppo facile dire: se l’individualità viene compressa e
soffocata dai legami comunitari Dio, patria e famiglia diventano
tetre prigioni dalle quali ci libereranno solo la morte e il suicidio. Il
problema che si pone allo studioso che, con grande fatica, cerca
di porsi a una certa distanza critica dagli eventi che gli sfilano
davanti, è quello di spiegare le ragioni per le quali proprio quelle
determinate forme storiche - sorte dai bisogni di Dio, della patria,
della famiglia - che ci sono note e familiari non hanno più
funzionato sicché ci si ritrova con una libertà anemica e anomica
(laicistica, si potrebbe dire) - perché priva di contenuti comunitari -,
da una parte, e con i fantasmi di una comunità cieca - perché non
più animata da individualità vitali e assetate di «autonomia»
dall’altra.
C’è una pagina del libro di Veneziani che vale la pena
citare per esteso in quanto compendia, come poche altre, la
filosofia politica che lo ispira. È la pagina dedicata alla crisi
dell’autorità :
E se il deficit maggiore nella società del nostro tempo fosse l’Autorità? Se
l’amor patrio, come del resto Dio padre e la famiglia patriarcale, ruotano
intorno alla figura autorevole del padre, riferimento e guida, la sua
mancanza si traduce, soprattutto in ambito civile, come perdita di autorità.
Impronunciabile parola ormai da troppi decenni, ci assoggettiamo senza
critiche solo ai comandi impersonali del mercato, della borsa, della
tecnica, del progresso. O accettiamo poteri e strapoteri in loro servizio,
ma guai a sentir parlare di autorità. L’autorità sconta un discredito
stagionato. Nel dopoguerra perché odorava ancora di fascismo e di
antidemocrazia. Nel Sessantotto perché era la bestia nera della
liberazione giovanile, femminile, proletaria. Nei socialismi, sovietici e
liberali,
perché
considerata
da
ambedue
nemica
giurata
dell’egualitarismo. Nelle società liberali e permissive perché vista come
l’antagonista funesto della libertà. La principale carenza dei populismi
liberali del nostro tempo non è la deriva autoritaria, come spesso si è
ripetuto, ma, al contrario, l’assenza di un principio di autorità e di
autorevolezza, la ricerca di compiacere i cittadini, allentando le regole e
assecondandoli, rinunciando in partenza a correlare educazione e libertà.
/ Se la modernità sorge sulla fratellanza, l’uguaglianza e la libertà,
l’autorità fu ritenuta uno sfregio a tutte e tre; perché l’autorità non è
fraterna, semmai paterna, o al più materna; non indica uguaglianza,
semmai promuove differenza e gerarchia; e non è considerata amica
della libertà ma il suo inevitabile rovescio. Oppressiva in pubblico,
29
repressiva in privato, l’autorità è stata l’innominabile belva della nostra
epoca. Per riammettere una sua vaga parente, si è preferito ribattezzarla
in Italia col più rassicurante termine di authority, anglo-americano,
tollerata perché «di servizio», a tutela delle regole. O dissimulata
nell’invocazione diffusa di leadership. E invece l’autorità ci manca.
Nei Pensieri sulla democrazia in Europa (1846), Giuseppe
Mazzini aveva scritto che «Il mondo ha sete in oggi, checché per
altri si dica, di autorità». Per Veneziani, quella sete sembra essersi
dileguata ma la scomparsa del suo oggetto dall’orizzonte umano ci
confina nella waste Land di T. S. Eliot. Ma se l’autorità è divenuta
sospetta, un fardello pesante che ci si vuole scrollare di dosso, ciò
non dipenderà anche dal fatto che i suoi detentori, in Italia e
altrove, non si sono mostrati all’altezza del loro compito? In
un’Inghilterra, dove pure non sono poche le crepe dell’edificio
politico e del sistema sociale, chi mette in questione l’autorità di
Elisabetta II? La dignità, la compostezza, lo stile umano di Giorgio
VI sono stati trasmessi alla figlia - che non a caso recentemente ha
potuto toccare con mano l’affetto e la devozione dei suoi sudditi - e
quei tratti rendono il simbolo della più alta autorità politica delle
Isole britanniche al riparo da ogni delegittimazione.
Nel novembre del 2008, lo sconfitto senatore John Sidney
McCain pronunciò un memorabile discorso di ringraziamento ai
suoi sostenitori. «Io e il senatore Obama - disse tra l’altro abbiamo avuto divergenze e ci siamo confrontati su di esse, e lui
ha prevalso. Indubbiamente, molte di quelle divergenze
rimangono. Sono tempi difficili per il nostro paese, e io questa
notte mi impegno con lui a fare tutto quanto sarà in mio potere per
aiutarlo a guidarci attraverso le tante sfide che dobbiamo
affrontare. Esorto tutti gli americani che mi hanno sostenuto a
unirsi a me non soltanto per fargli le congratulazioni per la sua
vittoria, ma per offrire al nostro presidente la nostra disponibilità e i
nostri sforzi più convinti per trovare dei modi per marciare uniti, per
trovare i necessari compromessi, per superare le nostre
divergenze e per contribuire a riportare la prosperità, a difendere la
nostra sicurezza in un mondo pericoloso e a lasciare ai nostri figli e
nipoti un paese più forte, un paese migliore di quello che noi
abbiamo ricevuto». Al di là dell’apprezzamento per queste nobili
30
parole e della commozione suscitata dal ricordo di Booker
Washington, il primo ‘negro’ che cenò alla Casa Bianca con un
Presidente degli Stati Uniti (era il grande Theodore Roosvelt)
fummo in molti ad avere la sensazione che in America, l’autorità,
l’autorità delle istituzioni, esiste, ed è una realtà che ha lo spessore
dell’acciaio che cola dagli altiforni di Detroit.
«L’autorità sconta un discredito stagionato», annota
Veneziani. È indubbio, per quel che riguarda il nostro paese, ma
occorre pur chiedersi il perché. La patria fascista, che per anni
aveva riscosso il consenso degli italiani stanchi di conati
rivoluzionari senza senso e senza futuro - ce lo ha ricordato
Roberto Vivarelli nel suo recente, coraggioso e provocatorio,
saggio, Storia delle origini del fascismo. L'Italia dalla Grande
Guerra alla marcia su Roma, (ed. Il Mulino) - non ci ha dato le leggi
razziali e la tragica alleanza col regime totalitario più spietato del
XX secolo (spietato non tanto per il numero, pur raccapricciante,
delle vittime della sua folle ideologia quanto per le motivazioni
biologiche e razziali che ne costituivano il fondamento)? Se
l’autorità di una pur benemerita dinastia (nelle celebrazioni del
centenario pressoché ignorata) alla quale si deve l’unità italiana, è
miseramente caduta in pezzi, la ragione non sta nella complicità
col fascismo? E se il nemico giurato di quest’ultimo, l’antifascismo,
può vantare un’autorità morale solo nei discorsi ufficiali e nella
retorica resistenziale, ciò non si deve alle vicende rievocate da
Giampaolo Pansa nei suoi libri «revisionistici»? Il settarismo
azionista - che ha incarnato l’antifascismo eterno persino più di
quello social comunista - non ha contribuito a un discredito che
investe egualmente destra e sinistra?
Oggi il nostro «mito di fondazione», il Risorgimento, non fa
più palpitare i cuori: la political culture espressa da forze politiche
votate dalla maggioranza degli italiani, all’inseguimento dei voti
clericali, riabilita Pio IX, ripropone la tesi della «conquista regia» e
della colonizzazione piemontese del Sud, lamenta la presunta
estraneità dei cattolici al processo unitario (presunta, sì, giacché se
è vero che le masse specialmente rurali furono caratterizzate da
un’alienazione politica nei confronti dello stato sorto nel 1861,
alimentata dalle parrocchie, è non meno vero che non ci sarebbe
31
stato il Risorgimento senza il sostegno attivo e convinto delle
«classi medie» e aristocratiche, soprattutto urbane, che nella
stragrande maggioranza erano cattoliche alla maniera di Massimo
d’Azeglio non di Monaldo Leopardi). D’altronde, la difesa del
Risorgimento da parte di un’area ideologica da sempre estranea ai
suoi valori - a quest’area appartenevano quanti, nel 1919,
irridevano ai combattenti della quarta guerra d’indipendenza - non
ha certo contribuito a farci ritrovare l’orgoglio dell’appartenenza.
Nel sessantotto, l’autorità, rileva Veneziani, «era la bestia
nera della liberazione giovanile, femminile, proletaria» e certo
averne travolto i simulacri ancora rimasti, a mio avviso, ha creato
un ambiente più invivibile di quello che aveva determinato la
«ribellione giovanile»: l’Università, almeno per quanto riguarda le
Facoltà umanistiche, non esiste più, la famiglia si è spappolata, il
mondo politico, a destra e a sinistra, si è riempito di
«professionisti» che fanno venire in mente il caustico Leo
Longanesi che, vedendo dal loggione dei giornalisti i deputati della
Prima Legislatura, aveva sospirato: «E pensare che un giorno ce li
dovremo persino rimpiangere!». Quel giorno è venuto e ci
ritroviamo qui costretti a riconoscere che, al confronto con i leader
della D.C., del P.C.I., dei partiti laici minori, dello stesso M.S.I.,
questi di oggi sembrano gli imperatori della decadenza rispetto a
quelli dell’età di Traiano e dei suoi immediati successori.
Ciò riconosciuto, era forse così immotivata la «rivolta
giovanile»? Se Dio, patria, famiglia «pesavano troppo», se ci si
sentiva prigionieri di «regole» fuori stagione - e il discorso vale in
special modo per la condizione femminile -, era per colpa del
«nichilismo» dissolutore di ogni autorità costituita? Se il «nuovo» fa
oggi rimpiangere il «vecchio», forse per questo dobbiamo credere
che non c’erano buone ragioni per una richiesta generazionale di
«svecchiamento» dei costumi, della cultura, delle istituzioni?
Edmund Burke nelle sue Riflessioni sulla rivoluzione francese
(1790) si chiedeva perché non si fosse riusciti a restaurare, in
modo saggio e prudente, l’edificio già esistente e fosse prevalso,
invece, il partito di quanti volevano far tabula rasa della Francia e
del suo passato. Noi dovremmo domandarci perché il sessantotto ove si eccettui la ricordata emancipazione della donna che,
32
indubbiamente, ha segnato una svolta di civiltà non sottovalutabile,
anche se, con ogni probabilità, si sarebbe verificata egualmente
senza la «rivoluzione culturale» all’italiana, pur se con maggiore
lentezza - ci abbia lasciato solo rovine e, tutt’al più, una libertà
libertaria prossima al libertinaggio e alla «perdita del centro».
Insomma se qualcosa è andato storto, si ha il dovere di dirlo (e
dispiace che a dirlo sia solo il pensiero della destra) ma si ha,
altresì, il dovere di comprendere perché s’è messo in moto il
processo innovatore e perché, da più parti, non si era soddisfatti
dell’esistente.
Nel discorso di Veneziani, però, il punto più debole, a mio
parere, è il mancato approfondimento della genesi e della natura
del liberalismo. Come molti filosofi tradizionalisti e conservatori,
egli vede la libertà liberale come «svuotamento», sovranità
assoluta di un individuo che, in campo morale, religioso, politico
etc., si è «liberato» di vincoli, regole, obblighi eteronomi -ovvero
imposti da un esterno sempre più delegittimato - e gode della
conquistata emancipazione come Icaro nelle prime fasi del suo
volo fatale. In realtà, la libertà liberale non è «disimpegno» ma
«impegno» scelto con convinzione, seguendo i dettami della
coscienza, disposizione a vivere e a collaborare con gli altri - una
disposizione che può essere dettata non solo dall’intelletto astratto
(la «raison») ma, altresì, da moti del cuore, da affinità elettive, da
inclinazioni profonde che appartengono solo al singolo, nella sua
irriducibile «particolarità». Non dimentichiamo che il secolo del
liberalismo è l’Ottocento ovvero l’età del romanticismo e del grande
romanzo borghese e che, in Francia, a fare da battistrada letterari
alla nuova sensibilità sono due liberali doc, Benjamin Constant l’autore dell’Adolphe (1816) - e M.me de Staël - l’autrice De
l’Allemagne (1810).
Veneziani sembra rendersene conto allorché, tirando le
somme della sua densa riflessione sul «dopo declino», accantona
per un momento il suo pessimismo e azzarda un modo possibile
che ci risparmi il destino degli «ultimi giorni di Pompei» e che
riassume nella formula ossomorica della «società comunitaria».
Scrive:
33
Nelle società organiche – scrive - Dio patria e famiglia erano considerati
principi naturali e la precettazione autoritaria ricadeva su cui se ne
chiamava fuori ed era considerato empio, traditore o contro-natura. Nelle
società moderna fondate sulla libertà dei singoli e il relativismo delle
scelte, ciascuno può vivere come ritiene, avere un suo dio, una sua
patria, una sua famiglia, o non averne affatto, senza attenersi a un
canone prescritto. Le prime offrivano sicurezza e coesione a prezzo della
libertà e dei diritti individuali. Le seconde, viceversa, riconoscono libertà e
diritti individuali a prezzo della dissoluzione e del cinismo. La scommessa
futura, per non naufragare nel nichilismo senza arretrare nel dispotismo,
sarà fondare una terza società che definiamo comunitaria dove nella
sfera privata è garantita a ciascuno la libertà di scelta e di vita in relazione
a Dio, patria e famiglia; ma nella sfera pubblica si riconosce un orizzonte
comune, venuto dalla tradizione di un popolo, dalla sua storia e dalla sua
esperienza di vita, verso cui orientare la comunità, pur nel rispetto delle
singole libertà di aderirvi o meno. Sforzo immane e delicato, fondato
sull’equilibrio - difficile ma necessario - tra responsabilità personale e
l’educazione comunitaria. Ma non c’è altra soluzione per evitare
nichilismo e fanatismo, horror vacui e cupio dissolvi.
È non poco indicativa l’espressione usata da Veneziani:
«precettazione autoritaria» giacché essa identifica, in maniera
scultorea, proprio ciò contro cui insorge l’homo liberalis: la
conformità a codici e a «valori comuni» imposta dal braccio
secolare dell’autorità spirituale - chi viene allontanato dai
sacramenti o scomunicato, per essersi fatta un’immagine non
ortodossa di Dio, del creato, dei doveri e dei diritti iscritti nella
nostra natura, può perdere quanto gli appartiene, a cominciare
dalla vita, non può più contare sulla collaborazione sociale, gli è
sottratta la patria potestà. Sennonché alla «precettazione
autoritaria» dell’epoca sacrale Veneziani contrappone un’antitesi
irreale, il nesso, registrato nell’epoca della secolarizzazione, fra
riconoscimento delle libertà e dei diritti individuali, da un lato, e la
china pericolosa che porta alla «dissoluzione» e al «cinismo».
L’autorità (tradizionale) protegge così tanto che finisce per
soffocare, la «libertà dei moderni» emancipa così tanto da togliere
il terreno sotto i piedi: la prima è il pieno che non concede spazio al
movimento, la seconda è il vuoto che fa precipitare nel nulla. Ma le
cose stanno davvero così? O non è forse vero che le stagioni più
belle della storia dell’uomo occidentale sono quelle in cui si sono
incontrati il Cielo e la Terra, in cui la Tradizione ha arato il campo
34
perché vi fiorissero le libertà - l’esempio classico delle tredici
colonie che insorgono in nome delle libertà al plurale riconosciute
da sempre ai popoli di lingua inglese, ivi compreso il principio «no
taxation without representation» - e l’allargamento dei diritti civili e
politici è stato visto come la conseguenza naturale del patriottismo
- se si è «fratelli d’Italia», «enfants de la patrie», dignità e libertà
vanno riconosciute a tutti.
È in quelle stagioni che si è realizzata de facto quella
«terza via» che, nel discorso di Veneziani, assume i tratti di
un’improbabile utopia o, meglio, di un nuovo, problematico, «mito
di rifondazione»: è allora che, «nella sfera privata», è stata
«garantita a ciascuno la libertà di scelta e di vita in relazione a Dio,
patria e famiglia, nella sfera pubblica» ci si è riconosciuti in «un
orizzonte comune, venuto dalla tradizione di un popolo, dalla sua
storia e dalla sua esperienza di vita» e verso quell’orizzonte si è
orientata «la comunità, pur nel rispetto delle singole libertà di
aderirvi o meno». Non ricorda tutto questo l’America visitata e
descritta da Alexis de Tocqueville?
Come i «clercs» di tutti i tempi, Veneziani sembra affidare
l’improbabile salvezza alla Parola, a una sorta di resipiscenza
culturale, a un’inversione di tendenza che
susciti una
(contro)riforma morale e intellettuale degli italiani (e degli europei).
È la solita sopravvalutazione delle «risorse simboliche» che già
troviamo in un proto-intellettuale militante come Paolo Sarpi
allorché scriveva: «La materia de’ libri par cosa di poco momento,
perché tutta di parole; ma da quelle parole vengono le opinioni del
mondo che causano le parzialità, le sedizioni e finalmente le
guerre. Sono parole sì, ma che in conseguenza tirano eserciti
armati». Tale sopravvalutazione può venir ritorta contro quanti
considerano il «potere spirituale» una mera sovrastruttura e si
rifiutano, pertanto, di vedere in esso una variabile autonoma
nell’incessante conflitto dei valori e degli interessi che agita il
mondo umano (in primis,naturalmente, v. il materialismo storico
che riduce a «ideologia» ogni tipo di filosofia) ma cade in una
diversa unilateralità nella misura in cui sembra non tener conto né
degli assetti di potere internazionali - è la domanda, cruciale: «chi
porta le armi e decide, sia pure indirettamente, il destino dei
35
popoli?» né della ripartizione e del controllo delle risorse
economiche, fattori che incidono non poco sugli stati della mente,
sulle visioni del mondo, sull’autostima delle nazioni.
Il «radicamento» che può indurre l’essere sudditi di una
potenza navale, come l’Inghilterra del Settecento e dell’Ottocento,
regina degli Oceani, è diverso da quello che può essere sentito da
un paese che aveva aspirato a entrare nel concerto delle Grandi
Potenze, dove si assegnano le aree di influenza, e si è, invece,
ritrovato tra le macerie di una guerra così inutile rovinosa per il
fisico e per il morale dei cittadini da indurre a pensare che la
nascita dello ‘stato nazionale’ non sia stato un ‘buon affare’. Il
radicamento ipotizzabile in una comunità politica alla quale non
mancano le risorse naturali, lo spirito industriale, la capacità di
innovazione tecnologica, la disponibilità di mercati sempre più
ampi per i suoi prodotti è diverso da quello che può essere
suscitato ad arte - ricostruendo diversamente,nelle aule
scolastiche e nei palinsesti mass-mediatici, le vicende del passato
-, in popoli impoveriti, incapaci di far sopravvivere quel poco o
molto di Welfare State che erano riusciti a installare, umiliati
dall’abbassamento di un tenore di vita che sembrava raggiunto per
sempre. Una comunità reale e vitale non sorge dal fiat di un
«pensiero nuovo», da una diversa angolazione da cui guardare il
mondo, dalla correzione di giudizi distorti su questo o quel periodo
storico ma è il precipitato di un insieme complesso di fattori che al
presente non sono ancora né prevedibili nè visibili.
Quel che è certo, e qui Veneziani coglie nel segno, è che
una political culture caratterizzata dal mancato accordo sui principi
che stanno a fondamento del confronto tra i partiti e le classi non
potrà mai diventare la civic culture di una nazione coesa, pur nella
diversità delle sue componenti,e decisa a marciare unita nelle
tempeste politiche ed economiche che, periodicamente, si
abbattono sull’estremo promontorio dell’Asia.
Questo testo è stato scritto per il Liber Amicorum di Domenico
Coccopalmerio, a cura di Gian Luigi Cecchini.
36
To Lia (and her cat), Paola, Julia, Gregor, Fabrice, Silvana, Gaetano,
Teresa de España, Haruki from Japan, Linda (schon lang weg), friends in Berlin
MODALITIES OF THE SUBLIME
MODAL CATEGORIES BETWEEN REASON,
UNDERSTANDING, AND SENSIBILITY
di Maurizio Candiotto
Abstract
Kant distingue il sublime in «matematico» e «dinamico»: il primo è esperito grazie
alla sproporzione quantitativa tra l’osservatore e l’osservato, il secondo grazie alle
forze smisurate dispiegate dalla natura. Fra le kantiane categorie «dinamiche»
rientrano però anche i concetti modali; ora, esiste di fatto un sublime che si lascia
pensare per mezzo di essi. Se ne può fare esperienza per vie puramente
intellettuali (senza pregiudizio per eventuali operazioni artistiche volte a trasporre
questa esperienza sul piano sensibile), leggendo taluni testi della tradizione
filosofica – il Parmenide di Platone, la Scienza della logica di Hegel, il Tractatus di
Wittgenstein – in cui necessità e possibilità giocano un ruolo ambivalente: mettere
in scacco l’intelletto da un lato, elevarlo a una comprensione superiore dall’altro –
alla ragione.
Kant distingue le sublime « mathématique » du sublime « dynamique » : on fait
l’expérience du premier en vertu de a disproportion quantitative entre l’observateur
et ce qui se passe devant (ou autour) de lui, alors que le deuxième se laisse
expérimenter en présence de forces immenses déployées par la nature. Les
concepts modaux, cependant, font eux aussi partie des catégories « dynamiques »
kantiennes ; or, il existe en fait un sublime qui se laisse penser précisément par
ceux-ci. On peut en faire l’expérience par des voies purement intellectuelles (sans
préjudice pour des mises en œuvre artistiques visant à la transposer sur le plan de
la sensibilité), notamment en lisant certains textes de la tradition philosophique –
tels le Parménide de Platon, la Science de la logique de Hegel, le Tractatus de
Wittgenstein – où nécessité et possibilité jouent un rôle ambivalent : mettre
l’entendement en échec d’un côté, l`élever à une compréhension supérieure de
l’autre – soit, à la raison.
Kant distinguishes between the «mathematical» and the «dynamical» Sublime: the
former is experienced by the disproportion in size between the viewer and what is
given to her sight, the latter by unlimited forces deployed by nature. However,
Kant’s «dynamical» categories include modal notions also; in facts, there exists a
Sublime that is essentially marked by them, too. One can experience it by purely
37
intellectual means (without prejudice for any artistic attempt to transpose it into a
visual or otherwise sensible field), namely by reading some philosophical texts –
such as Plato’s Parmenides, Hegel’s Science of Logic, Wittgenstein’s Tractatus –
where possibility and necessity play an ambivalent role: to checkmate
understanding on the one hand, and to raise it to a superior comprehension on the
other, namely to reason
Sublime is, according to Kant, what has the effect of
intimidating the viewer inasmuch she is a sensible being, while at
the same time elating her as an intelligible one. Kant divides the
Sublime in Mathematical and Dynamical, according to the ‘means’
by which this effect is brought about: impressively big dimensions
of what is offered to the sight or overwhelmingly huge forces at
work, respectively. In the first case, the viewer directly feels her
own smallness due to the fact that she cannot capture what she is
confronted with in one comprehensive grasp of perception; in the
second case, what is felt is rather one’s own extreme weakness by
contrast with the indomitable force of nature. In both cases,
however, the feeling of one’s own impotence and insignificance as
a sensible being has the counter-effect of exalting one’s own
awareness of being an intelligible being, along with the pride and
the hopes that this carries with it.
Dynamic Categories Claiming for Equality
Thus, the Sublime deserves the label ‘mathematical’ when it
is tied to dimensions, so to the categories of extensive quantity,
‘dynamical’ when tied to force, so to one category of relation
(namely, causality). But: why should the dynamic Sublime be
limited to the categories of relation only? May the modal categories
not claim for an equal status?
If so, they must appeal to some experience that is both one
of the Sublime and intimately marked by possibility and necessity –
so intimately as to allow these categories to play a role in giving
birth to the Sublime itself, and not merely – as Kant himself allows
for – in accounting for judgments on its moral. So, let’s ask
ourselves whether one can experience anything which prompts her
38
to call it sublime, while the experience itself is shaped by modal
categories.
Many of us did in fact experience a somehow sublime
intimidation under the performance of necessity and possibility as
they feature in some capital philosophical texts; first of all, in
Plato’s Parmenides. The reader, when facing its second part, is
likely to feel overwhelmed by the force of necessity. At each
hypothesis, we are led to explore one more possibility of thought, a
way of the understanding (namely, to understand the One);
however, we are baffled each time by an aporetic conclusion. By
the force of necessity, namely of cogent arguing, each possibility
turns into (an aporetic) impossibility; which is itself necessity, given
the well-known interdefinability between possibility and necessity
via negation. Necessity, therefore, is not only what directs each of
our steps along the way, but is also what the conclusion of the
entire dialogue (and of each hypothesis in it) is like – namely, a
cogent impossibility.
Does this deserve the name of sublime? If so, it is for sure a
piece of the wanted modal Sublime; I daresay it is in facts sublime,
too. It is, however, a Sublime conveyed by an intellectual
experience – one of performing a reasoning; better: of following
one carrying us away – rather than by a sensible experience, as is
the case with the Sublime Kant talks about. Is therefore the so
conveyed Sublime itself intellectual? Does an intellectual Sublime
as distinguished from the sensible one exist – or else do these
predicates only pertain to the different ways to experience it? I tend
to opt for the second answer, namely to talk of modal Sublime tout
court and of an intellectual experience of it. However, if the modal
Sublime turned out to be possibly known only by an intellectual
experience, the above distinction would be likely to be idle. At any
rate: if the modal Sublime we have so encountered is itself
intellectual, it is also, and more profoundly, a piece of rational
Sublime. The understanding (as a faculty of concepts and
judgments) is the hero rather of the first part of the dialogue, where
it is confronted with its own difficulties (cf. Parmenides’ objections
to Socrates’ theory of ideas) in a quite straightforward way,
namely, in its own way, properly. In the second part of the
39
dialogue, on the other hand, it is rather reason as a faculty of
inferences aiming at a totality that plays the game. The totality
aimed at is one of conditions and conclusions, up to a knowledge
of nothing less than the One. Here conclusions are drawn from
hypotheses which are, at the very least, incompatible with each
other. The difficulty of composing them coherently, of thinking all of
them in one, is the result of a coherent reasoning. Thereby, we
experience both our possibility of cogently thinking and our cogent
impossibility to conceive of the result. But we are nonetheless led
to grasp that impossibility as our own, as a necessary result of our
reasoning, of our capability to explore the possible (at each
hypothesis); as a baffling one, and, though, attained by steps of
ours, made while being aware of what we were doing. Thus, in one
sense, we do understand our result.
This does ease – without erasing – the frustration we are
experiencing. It is not, however, as sensible beings that we feel
oppressed, but rather in our very intellectual performances. It is the
intellectual rather than the sensible limitation that is overcome: the
reader both feels trapped in untenable conclusions and rises above
her own incapability to grasp them in their necessity since the
intimate possibilities of her thinking. Thus, understanding stares at
reason. Understanding is exalted by being shown how its own
coherence can lead it beyond itself, although not out of its own
impasse. Far before paraconsistent logic attempted to educate us
to tolerate some contradictions, Plato offers us an experience of
paraconsistency.
Whereas Socrates’ theory of ideas was hit by Parmenides’
objections, now the intellect dwells in its own impasse. Aporia is
here ambivalent, just like Achilles’ spear, which could both wound
and heal. Many philosophers – Plotinus, Nicholas of Cusa, most of
all Hegel – will subsequently take the rise of understanding to a
superior comprehension through its own aporias very seriously.
They will manage to make its dwelling within them into a step
further – which is not, however, an exit toward a noncontradictory
stay, for contradiction somehow does remain: it now dwells within
the result. Hegel will call this reason – which now turns out to be a
faculty for totality (as in Kant) that is also one for containing
40
(without killing) contradictions. Aufhebung is Hegel’s specific
manner to walk the pathway of aporia, to rise by means of the
latter – with its necessity – to the dimension of intelligibility. Does
each step of Aufhebung offer the opportunity to experience, in a
further fashion, the modal Sublime?
Back to Sensibility
Up to this point, the modal Sublime has been spanning
between reason and understanding. And sensibility? Does it have
no access to the extreme tip of the dynamical Sublime, namely the
modal one? This is questionable: after all, many artists do strive to
show us some unforeseen possibilities for perception – which are
possibilities for perception, i.e. in the sensible domain. Do they
lead further – in some cases at least – to the intelligible? This,
however, would only result in an experience of the modal Sublime
if the disclosure of the new possibility went along with an
impossibility – a quite distressing one. To this effect, I just recall
the final scene of Peter Weir’s The Truman Show, when Truman
touches with his hand... the (cardboard) horizon of his entire life.
And opens it to step forth.
But let’s step back to the door from where one can see new
possibilities for perception while feeling constrained by an
impossibility. Will one then look toward an intelligible realm, or
better: through the intelligible dimension of the world? Now,
intelligence itself has been construed in terms of an – unattainable,
ever displacing – horizon strictly tied with the one of sensible
experience (Husserl, Merleau-Ponty; cf. also Kant’s Was heißt:
sich im Denken orientieren?). Here, however, the question is
whether the relation between sensibility and intelligence as
dimensions of experience provides an access to the intelligible
dimension of the world. If so, this would qualify as a sensible
experience of the modal Sublime, provided it would take place by
means of, or at least go along with, the experience of an
impossibility of ours.
41
Here further investigation and excursion within the arts is
needed. I only sketch some clues: it is question of an open path
but somehow impossible to walk along – and though, it is open to
me. It is some impossibility of my perception that I grasp, an
impossibility pertaining to me as a sensible being; thereby, I
become aware of it as an impossibility of mine, as the open door I
am staying in and looking from. Toward an intelligible dimension of
the world? I leave this issue open. However, thanks to the artist
who showed me the (obstructed) way, the door to it is now open, to
me.
Perhaps more; is it, just like the Door of the Law, open for
me?
So, is there hope, much hope – for God, but not for us? If art
is sublime, it is because it opens the door. In order to stay in it,
then, there is no need for any guardian.
Appendix. Qualifying a Quantum of Sublime
A Midsummer Daydream
And at the instant he knew, he ceased to know
(Jack London)
When quantity is in play, it is typically, extensive quantity;
however, there is still room for a Sublime tied to the effects of a
seemingly infinite intensity. Recall that Duns Scot, in order to
convey the idea of the Summum Ens, had recourse to the highest
degree of a quality (namely, whiteness), i.e. to an infinite intensive
quantity; could not the latter be sublime? Its power is likely to be so
annihilating for our senses as to suggest a step beyond the very
domain of sensibility; if the limit of a sensible intensity cannot be
born by the sight, if the highest degree of, say, whiteness is
blinding, it seems thereby to hint at the equally and even more
unbearable highest degree of being – the one whereby even
Moses could not look into... God’s face. (According to Rilke, angels
42
themselves ought to be careful: «Gott sah mich an; er
blendete...»).
Not to mention a whiteness that goes in the very opposite
direction: think of Moby Dick...
Appendix II. How to Make Intelligible a Sensible World
Prolegomena to Any Future Pictures at a Tractarian Exhibition
If the limit of a sensible intensity cannot be born by the sight,
what exactly does it hints thereby at? Either at a realm beyond the
sensible one – in a Kantian way; or else at the very limit of this
realm, if we think the world as one, nothing lying beyond it,
properly. This may pave the way to a rather Wittgensteinian
approach to the Sublime. Here what is intelligible is not a second
world, but rather the only world inasmuch as is comprehended as
one, from within it, by virtue of its very showing itself – as one, and
as existing. Which is what the first and the second hypothesis of
Parmenides undertake to say.
The intelligibility of the world, then, consists in its showing
itself; and symbols do also participate of just this kind of
intelligibility, by playing a role in the self-showing of the world.
Facts in the world consist of (sensible?) objects and can be said by
means signs that are themselves complexes of such objects, while
their form on the one hand, and on the other hand the unity and
existence of the world can only show themselves; but sensible
signs only become symbols (themselves facts) because they are
related to the world, because they say and show something about
it, thereby housing the self-monstration of the world itself.
Each sensible sign becomes a symbol by showing the way
(it says that) things are, i.e. how the world is; that the world is, as
one and once for all, shows itself throughout each sign becoming a
symbol, by accompanying their showing how things are. To have a
meaning (vs. merely existing as a sensible piece of ink on paper,
or wave in the air) is just to say and show something of the world.
By showing the form they share with the facts, they cooperate to
the self-showing of the world, thereby acquiring, in turn, an
43
intelligible status. Here ‘intelligible’ means, without equivocality,
both ‘meaningful’ and ‘intrinsically related to the intellect’, i.e. given
essentially in intellectual terms – although of course symbols are
always instantiated by sensible signs; as the world is itself one,
intelligible and made out of sensible objects at the same time.
Kant also talks often in terms of a one-world conception of
being (in the Critique of Judgment, in particular, see his frequent
talk of a «noumenal substrate» of phenomena) such that the
intelligible domain is conceived rather as an order of the world (the
one allowing for a Kingdom of Ends) rather than as a second
world. However, in Kant the relationship between this noumenal
substrate and (its) phenomena remains unclear. In Wittgenstein’s
Tractatus, on the other hand, this is exactly what is highlighted: the
world is intelligible inasmuch as it shows itself while consisting of
sensible (so Hintikka) objects to be said (named); symbols are
intelligible facts saying (stating) facts by showing their own form
and by means of objects (signs) which they do not name nor
mention anyway, but rather put in use.
So, provided the mystical is omnipresent, namely
ceaselessly, if tacitly, present at any token of speech; could it be
experienced as sublime? Could the experience of it turn into one
whereby it unfolds as, specifically, sublime? As a reader of the
Tractatus, I dare answer simply yes. Sublime is, in fact, what a
reader of the very words of Wittgenstein’s experiences, what the
mystical experienced by reading the Tractatus is like. With its final
gesture of throwing back the ladder used to climb up, it makes
intelligence culminate along with the impotence of ordinary,
intellectual symbols implemented in sensible signs to say. Thus,
the Sublime can be experienced just by reading Wittgenstein’s
lines, quite apart from any – if any – further mise en scène in a
sensible domain. In facts, I do not know whether any artist has yet
elicited some sort of intimidating and elating experience from the
Tractatus as a ground-text but by means of a sensible material
(say, in an exhibition) other than words printed in a book.
(Berlin, mid-July 2012)
44
P. S. In order to convey a vague idea of what a transposition of the modal Sublime
into a perceptual (say, visual) domain might be like, a poem by Octavio Paz may be
of some help:
Paisaje
Landscape
Los insectos atareados,
los caballos color de sol,
los burros color de nube,
las nubes, rocas enormes que no pesan,
los montes como cielos desplomados,
la manada de árboles bebiendo en el arroyo,
todos están ahí, dichosos en su estar,
frente a nosotros que no estamos,
comidos por la rabia, por el odio,
por el amor comidos, por la muerte.
Insects bustling,
Sun-coloured horses,
Cloud-coloured donkeys,
Clouds, huge weightless rocks,
Mountains like heavens tumbled down,
A herd of trees drinking in the brook,
They all stay there, happy in their staying,
Before us who do not,
Eaten by anger, by hate,
By love eaten, by death.
Thanks to Robert R. Clewis (Gwynedd-Mercy College, Pennsylvania) for both his
remarks and the reference to Moby Dick's whiteness; for the linguistic revision, both
to him and to Julia, from Hamburg in Berlin (plus Mariana, natively speaking
Spanish and English from Argentina onward). One last little help is owed to
Theodora l’Anglo-Saxonne in Geneva.
45
P. LAÍN ENTRALGO E LA LETTERATURA RIFLESSIVA:
LA ESPERA Y LA ESPERANZA
di Carmine Luigi Ferraro
Abstract
L’autore analizza l’opera La espera y la esperanza (1956) dello spagnolo Pedro
Lain Entralgo (1908-2001) allievo di J. Ortega y Gasset e X. Zubiri. La speranza è
per Entralgo una caratteristica fondamentale dell'ontologia umana: essa è uno degli
abiti che definiscono e costituiscono l'esistenza umana. Cinque sono gli interrogativi
intorno ai quali ruota l’opera di Entralgo (1. Cosa hanno sperato gli uomini lungo la
storia? 2. Come gli uomini hanno sperato ciò che in verità sperarono? 3. Come gli
uomini hanno inteso la loro stessa speranza e la speranza umana in generale? 4.
Come la speranza è concepita dall'uomo di oggi? 5. Cos'è in se stessa la speranza
umana?) e ai quali è possibile rispondere attraverso una prospettiva storicofilologica che permette di evidenziare la novità che il concetto della speranza
cristiana introduce nella storia. I motivi per cui il cristiano si sente condotto a
sperare sono l’indubitabile fedeltà di Dio alle sue promesse e la bontà suprema
della realtà sperata. Dio, quindi, è la somma verità ed è per questo che crediamo in
ciò che promette. Tuttavia è la fede ad essere sempre il presupposto di ciò che si
spera; infatti è la fede che convince il cristiano della realtà di ciò che si spera e della
possibilità di raggiungerlo al termine della propria vita.
L'auteur analyse l’œuvre La espera y la esperanza (1956) de l’espagnol Pedro Lain
Entralgo (1908-2001) élève de J. Ortega y Gasset et X. Zubiri. L'espoir est pour
Entralgo une caractéristique fondamentale de l'ontologie humaine: c'est l'une des
robes qui définissent et qui constituent l'existence humaine. Le travail d’ Entralgo
tourne autour de cinq questions (1. Que les êtres humains ont-ils espéré à travers
l'histoire? 2. Comment les hommes ont-ils espéré ce que, en vérité, ils ont espéré?
3. Comme les hommes ont-ils conçu leur propre espérance et l'espérance humaine
en général? 4. Comment l'espérance est-elle conçue aujourd'hui par l'homme? 5.
Quelle est l'espérance humaine?). On peut répondre à ces questions en utilisant
une perspective historico-philologique qui permette de détecter la nouveauté que le
concept d'espérance chrétienne introduit dans l'histoire. Les raisons pour lesquelles
le chrétien se sent conduit à espérer sont l'indéniable fidélité de Dieu à ses
promesses et la bonté suprême de la réalité espérée. Dieu, alors, est la vérité
ultime et c'est pourquoi nous croyons en ce qu'il promet. Cependant, c'est toujours
la foi qui le présupposé de ce que nous espérons, car c’ est la foi qui convainc le
chrétien de la réalité de ce qu'il espère et de la possibilité de l'atteindre à la fin de
sa vie.
46
The author analyzes the opera La espera y la esperanza (1956) by the Spanish
author Pedro Lain Entralgo (1908-2001), one of J. Ortega y Gasset’s and X. Zubiri’s
students. For Entralgo, hope is a fundamental characteristic of human ontology: it is
one of the habits which determine and form human existence.
Entralgo’s work focuses on five questions (1. What did men hope throughout
history? 2. How did men hope what they really hoped? 3. How did men understand
their own hope and human hope in general? 4. How is hope conceived by
nowadays man? 5. What is human hope in itself?) that we can answer through a
historical-philological perspective which can draw attention to the change introduced
in history by the Christian concept of hope.
The reasons why a Christian feels that he has to hope are the undeniable loyalty of
God towards his promises and the supreme goodness of the reality we hope.
God, then, is the highest truth and that is why we believe in what he promises.
However, it is the faith the requirement of what we hope for; it is the faith indeed
which convinces Christians of the reality of what we hope for and the possibility of
reaching it at the end of our life.
Lungo il percorso che lo ha condotto alla elaborazione
della sua Antropologia medica, Pedro Lain Entralgo (1908-2001)
trovatosi di fronte all'annosa e ricorrente domanda sull'europeità
della Spagna iniziata con la generación del 98, cerca di essere
nella propria opera più europeo degli europei.
Egli cerca cioè di lavorare con il massimo rigore scientifico,
uscire dal tema della Spagna, per occuparsi di temi universali.
Per far questo, si avvale della teoria della ragione storica,
elaborata da J. Ortega y Gasset, suo principale maestro oltre a X.
Zubiri.
La ragione storica è fondamentalmente la descrizione della
struttura della realtà (naturale, sociale, culturale, storica),
assistendo alla nascita della stessa. Ed infatti, Lain Entralgo
1
nell'opera che analizzeremo: La espera y la esperanza (1956) .- al
pari di altre-, divide il testo in una parte storica (come si è vissuta la
speranza nella tradizione occidentale) o diacronica; ed una parte
teorica (la sua costruzione di una teoria sulla speranza) o
sincronica.
Ora, nella sua Introduzione, l'autore cerca in primo luogo di
definire qual'è, cos'è il sentimento della speranza, la profondità e
47
l'universalità del suo impianto nel cuore dell'uomo (p. 313), giacchè
la speranza si configura da subito come uno degli abiti che
definiscono e costituiscono l'esistenza umana; tanto più che la
realtà della nostra esistenza è temporanea ed imprescindibile. Non
c'è attesa senza speranza. Ed allora la speranza è una
caratteristica fondamentale dell'ontologia umana, che può essere
indagata attraverso l'Antropologia, quale centro e sintesi di quelle
discipline che costituiscono -secondo Kant- la risposta alle quattro
domande cardinali per l'uomo. Ossia: 1. Cosa posso sperare?
(Metafisica); 2. Cosa devo sapere? (Morale); 3. Cosa mi è lecito
sperare? (Religione); 4. Cos'è l'uomo? (Antropologia).
In questo modo, si esplicita il carattere costitutivo che la
speranza ha nella realtà dell'uomo secondo Kant, per il quale un
uomo senza speranza sarebbe un assurdo metafisico, come lo
sarebbe un uomo senza intelligenza o senza attività.
Ora, per uno studio sulla speranza che sia ad un tempo
storico e sistematico, Lain ritiene che si debbano trattare alcuni
punti fondamentali, che costituiscono la base della sua
metodologia: 1. Cosa hanno sperato gli uomini lungo la storia; 2.
Come gli uomini hanno sperato ciò che in verità sperarono; 3.
Come gli uomini hanno inteso la loro stessa speranza e la
speranza umana in generale; 4. Come la speranza è concepita
dall'uomo di oggi; 5. Cos'è in se stessa la speranza umana?
Stabilita questa metodologia, occorre una prospettiva
storico-filologica per lo studio della costituzione dell'idea cristiana
della speranza. In questo contesto, essa si definisce in antitesi con
una vita costituita da un'ansia spirituale non soddisfatta, 'in attesa'
di essere consolata con la venuta del Regno di Dio, con la
presenza di Cristo fra i suoi fedeli fino al termine dei tempi. Questa
antitesi fondamentale nell'idea cristiana della speranza, che Lain
non esita a definire piuttosto come 'necessità', ha dato vita, nel
corso della storia, ad una elaborazione di una 'teoria della
2
speranza' .
La prospettiva storico-filologica aiuta Lain ad evidenziare
qual'è la novità che nella storia introduce il concetto della speranza
cristiana. Infatti per il greco classico, 'elpis' aveva un significato
opposto: speranza, attesa ma più nel senso della preoccupazione,
48
del timore, come si può anche vedere nel mito del vaso di
Pandora. Alla sua apertura, escono tutti i mali che affliggono
l'uomo: il dolore, l'infermità, la morte; all'interno ci resta solo 'elpis',
la speranza quale consolazione dei mortali, che, tuttavia, per
essere efficace, deve essere cieca. E' così che sperare assume un
significato ambivalente: consolazione nel dolore, ma anche grande
possibilità d'insuccesso visto che la speranza è cieca. Nel primo
caso viene connotata da attributi come: buona, allegra, dorata; nel
secondo caso, come: incerta, indesiderabile, pericolosa,
compagna del pericolo. Per cercare di superare tale ambivalenza, i
greci adottarono: la mantica, quale previsione razionale e il
credente affidamento al mistero. Ma, ancora una volta: la
previsione fisiologica dell'avvenire poteva render certo e sicuro il
futuro dell'uomo. La risposta è ancora negativa ed Eraclito, in
particolare, affermava che per l'uomo è necessario rivolgersi a
motivi e fondamenti superiori alla propria ragione, nell'atto di
sperare. Ma un'altra causa della connotazione fondamentalmente
negativa della speranza, sta nella concezione greca del tempo. Per
il pensiero greco, cosmologico e naturalista, il tempo viene
concepito secondo l'idea astronomica del cielo, per cui la durata
delle cose sarebbe circolazione, eterno ritorno. Tale concezione, di
fatto, impedì la formazione di una nozione sufficientemente
profonda del nuovo e conseguentemente s'impose una visione
pessimista e peggiorativa del corso temporale. Per questo, nella
cultura greca, si concepisce l'origine e non l'originalità, la genesi e
non la novità, la fine e non l'ultimo periodo della vita, secondo
quanto affermato da Aristotele. Mentre Platone, da parte sua,
ritiene che solo ciò che è appena costruito è sano e forte, per cui la
legge che presiede il corso delle istituzioni politiche è destinato alla
decadenza. Insomma, nel corso della sua storia, «l'uomo ellenico afferma Lain- solo potè aspirarare a una vita nec spe nec metu,
3
senza speranza e senza paura» .
Di fronte alla 'temuta' speranza dei greci e poi dei romani,
Lain sottolinea la febbrile speranza degli israeliti che, da sempre,
costituì uno dei suoi nervi più intimi ed efficaci. Ed allora, se per i
Greci il cosmo è un organismo perfetto che si disfa nel suo ritmico
cammino verso la fine dei tempi; per gli israeliti è invece una voce
49
che canta con la creatura umana la gloria di Dio e la speranza
della pienezza. Oltre all’opposizione storia naturale (greci)/storia
personale (ebrei), Laín ne individua un’altra che si caratterizza in
modo preponderantemente filologico: la concezione della verità e
della parola nelle due culture. Se per il greco, verità è: alétheia,
scoperta, un atto di evidenza intellettuale, per cui la parola viene
ad essere l’espressione, la dichiarazione di una verità evidente
all’intelligenza. Per l’ebreo, la verità è qualcosa in cui si può
confidare; non la visione intellettuale del presente, ma la
confidenza nel compimento del futuro e di ciò che è promesso. Per
questo, la parola non è espressione, dichiarazione, bensì spirito
creatore e promessa di ciò che sarà. Da qui discende anche la
concezione della Parola di Dio: creatrice del mondo e fondatrice
dell’alleanza. Se in Grecia, quindi, esiste il sophós, il saggio che
dichiara ciò che è; in Israele c’è il profeta, il nabi, che annuncia ciò
4
che sarà .
Diversa ancora la visione paolina della speranza, cui
sottostà, come per le altre occasioni, una diversa concezione del
tempo. Quella di San Paolo si esprime in cinque concetti
fondamentali: 1) la pienezza che in questo caso è: maturità
spirituale, o meglio un certo livello di perfezione metafisica; in
Cristo, infatti, abita ogni pienezza. Per cui, il tempo è un cammino
verso la perfezione, costellato da: 2) opportunità o occasioni
corrispondenti alle manifestazioni storiche di Dio, la cui massima
espressione è l’incarnazione del Verbo. 3) L’unicità che
caratterizza ciascuna delle manifestazioni storiche di Dio. 4) la
novità che Cristo ha introdotto nel tempo umano consiste: da un
punto di vista storico, nell’equiparazione fra giudei e gentili; da un
punto di vista essenziale, nella rottura della servitù del peccato e
della morte, che vengono abolite dal battesimo e dalla resurrezione
futura, oggetto della nostra speranza, grazie alla vittoria di Cristo
sulla morte. 5) Il secolo: se il secolo presente è composto
dall’Antico Testamento (tempo della legge) e dal Nuovo (tempo
della fede), si aspetta un secolo futuro interminabile che si avrà
5
grazie alla fine dei secoli .
Ora, se questo è lo schema paolino della concezione della
storia: cosa spera e cosa deve sperare il cristiano? Secondo S.
50
Paolo ci sono due ordini di realtà che costituiscono l’oggetto
materiale della speranza. Da una parte, una realtà escatologica: il
compimento della fine del mondo e dell’uomo, la seconda venuta
di Cristo, la redenzione del corpo, la vita eterna… Dall’altra, una
realtà materiale: l’occasione per visitare i crisitiani di Roma, la
perseveranza dei fedeli di Corinto, la glorificazione del corpo di
Cristo, il diritto a ricevere alimenti dagli evangelizzati. Questa
seconda forma di speranza, ossia quella del raggiungimento di
beni visibili e terreni, vengono spiegati secondo la “formula”: in spe
contra spem. Ossia: il cristiano che deve sperare la seconda
venuta di Cristo, la resurrezione del proprio corpo e la gloria
eterna, non può fare a meno di quei beni che la realtà terrena
dell’uomo necessita ed esige.
Ma, se questo è l’oggetto della speranza paolina, qual è
invece il soggetto? È tutto l’uomo, con tutta la sua anima e tutto il
suo corpo. Naturalmente non è solo l’uomo ad essere coinvolto
nella speranza, ma tutte le creature che insieme a lui, in quanto
esseri, si muovono verso la possibile perfezione terminale, la
libertà della gloria; una perfezione alla quale l’uomo può arrivare
direttamente, mentre il mondo non umano potrà conseguire
attraverso i figli di Dio.
Quali sono i motivi per cui il cristiano si sente condotto a
sperare, ossia qual è l’oggetto formale, per il quale si spera? Laín
individua due attributi fondamentali di tale oggetto: 1) l’indubitabile
fedeltà di Dio alle sue promesse; 2) la bontà suprema della realtà
sperata. Dio, quindi, è la somma verità ed è per questo che
crediamo in ciò che promette. Possiamo quindi riscontrare la
latenza dell’idea ellenica e di quella ebraica della verità, nella
visione paolina della speranza; essa si colora inoltre del carattere
della lucidità, perché si basa su fatti umanamente comprovabili, ma
anche dell’affidarsi, della fiducia, visto che non si ferma al mero
calcolo di fatti umanamente prevedibili. Allo stesso modo, se senza
la fiducia, la speranza sarebbe solo calcolo; senza la lucidità
sarebbe mera illusione. Altre caratteristiche della speranza sono: la
pazienza (chi sopporta limiti e dolore erriverà alla meta
consolatrice e sperata), la sicurezza (= la speranza non confonde),
l’allegria e la pace (= Dio riempie di allegria e pace). Cos’è allora la
51
speranza cristiana? È una virtù teologale, secondo la teologia.
Tuttavia, S. Paolo non usa tale definizione; infatti quando dichiara i
nomi di quelle che per noi sono le virtù teologali, le chiama: queste
tre cose (fede, speranza, carità). Ora, siccome S. Paolo usa il
termine speranza in due sensi: oggettivo (= le cose che si sperano)
e soggettivo (= l’atto di sperare), ecco che, secondo Laín, per S.
Paolo: «la speranza cristiana è una fiducia abituale dell’uomo nella
fedeltà di Dio alle sue promesse. Spera cristianamente, quindi, chi
confida nel fatto che Dio compirà ciò che dall’inizio della Storia ha
6
promesso al genere umano» .
Tuttavia è la fede ad essere sempre il presupposto di ciò
che si spera; infatti è la fede che convince il cristiano della realtà di
ciò che si spera e della possibilità di raggiungerlo al termine della
propria vita. Allo stesso modo, la carità dell’uomo in cammino è
carità nel tempo, amore per realtà che esisteranno e che lui non sa
come finiranno per essere. Insomma, S. Paolo è definito da Laín
come la «luce nel mistero, ma anche cammino verso una nuova
luce. La sua aurorale visione della speranza cristiana insegna
molte e molto profonde cose sull’umano sperare; ma, insieme,
pone una larga serie di problemi alla mente del teologo e
7
dell’antropologo» . Problemi che vanno dalla relazione fra
promessa-speranza-predestinazione, all’articolazione fra speranza
naturale e speranza cristiana; dalla relazione fra speranza
soteriologica e metafisica della creazione e la speranza cristiana,
8
all’essenza dell’atto dello sperare .
In S. Paolo, quindi, il simbolo della speranza è l’ancora,
che sta a significare il raggiungimento di una certa sicurezza
nell’esistenza terrena. Da questo punto di vista, una teoria della
speranza cristiana, secondo Laín, dovrebbe contenere almeno tre
punti: 1) il rapporto speranza/predestinazione; 2) antropologia della
speranza cristiana; 3) il rapporto speranza/storia. Punti che si
possono ritrovare nella riflessione di S. Agostino, il quale risponde
al primo punto con la sua dottrina sulla predestinazione umana,
secondo cui si salvano gli eletti fra i chiamati. Ma come S. Agostino
contempla ed intende lo sperare umano? In primo luogo, tramite la
connessione fra memoria e speranza; infatti:
52
La memoria è il testimone psicologico della nostra temporalità e della
nostra totalità […]: la memoria mi permette di vivere il passato nel
presente, i progetti e le speranze del futuro. Ex memoria spes. La
memoria e la speranza, questa fondata su quella, si trovano
essenzialmente connesse fra loro: l’una e l’altra sono, anzitutto, modi di
espressione dell’essenziale temporalità dell’esistenza terrena dell’uomo.9
La memoria agostiniana assume quindi anche una
connotazione esistenziale, ontologica. Infatti, S. Agostino parte
dalla dottrina platonica della reminiscenza, secondo cui le verità
che apprendo, esistevano già in me prima di apprenderle, per cui
apprendere sarebbe in realtà riconoscere, scoprire ciò che è già in
me; per esaminare la propria memoria e scoprire se in quella vi è
ciò che ama, quando ama Dio. Rispetto tuttavia a questo
interrogativo ontologico, si vede costretto ad ammettere che la
memoria umana non basta per trovare Dio; riguardo a ciò, infatti,
occorre trascendere il mondo dei propri ricordi. In questo modo,
per chi sottoscrive la dottrina platonica della reminiscenza, ma
ritiene poi rispetto a Dio che occorra trascendere la memoria, si
apre un’aporia che S. Agostino supera attraverso la ricerca della
vita felice, dietro la quale c’è Dio. Tutti gli uomini infatti ricercano
una vita felice, la cui prima conoscenza è nella memoria: essa, in
tal modo, passa ad essere da visione psicologica, a visione
metafisica. Infatti ora le vestigia della vita felice non deriva più dalla
mia esperienza, ma risulta radicata nel mio stesso essere ed
appartiene alla mia memoria quale testimone della mia realtà
totale. Siamo di fronte ad un platonismo intellettuale, che anziché
porre il termine della propria avventura nel mito, scopre il mistero
della propria relazione con Dio. Agostino non è, secondo Laín, un
platonico cristianizzato, bensì un cristiano platonizzante: è questa
la sua originalità storica.
Tutti gli uomini tendono alla felicità, e più o meno
coscientemente hanno dentro se stessi la vita beata. Il desiderio di
felicità può diventare speranza quando l'uomo percepisce,
lucidamente o meno, di possedere la vita beata:
tale speranza di felicità arriverà a convertirsi in felicità reale e compiuta
quando il sospetto arriva ad essere piena e chiara visione… Sperare la
felicità, vivere unitariamente e simultaneamente l’attesa e la reminiscenza
53
metafisica di una esistenza beata, è, secondo ciò, una possibilità sempre
aperta all’essere concreto e terreno dell’uomo.10
S. Agostino riesce così ad unire memoria e speranza, non
più sotto l'ordine psicologico, ma nell'ordine della realtà ontologica,
dato che entrambi posseggono un medesimo presupposto
metafisico che appartiene alla costituzione stessa della realtà
11
dell'uomo .
Il ricordo della storia umana influisce sull'esercizio della
speranza? S. Agostino parte da una tesi fondamentale: la radicale
storicità dell'uomo cristiano; tuttavia l'esistenza del cristiano ha il
suo fondamento ultimo nell'eternità, non nel tempo. Ma allora, il
cristiano deve essere indifferente al proprio destino storico? No,
perché la Storia è insieme il transito progressivo del genere
umano, dall'origine alla fine, e la melodia delle diverse
manifestazioni di Dio nell'esistenza successiva delle sue due
creature: l'universo e l'umanità. La visione cristiana della Storia che
ha la sua canonizzazione con S. Agostino, comporta una rottura
con la concezione ciclica del tempo, a favore di alcune idee
fondamentali: creazione, redenzione, progresso, giudizio finale,
12
provvidenza e libertà .
Se S. Paolo rimprovera ai gentili di non possedere la
speranza, intesa come virtù teologale: ciò significa che c’è
differenza fra la speranza naturale dell’infedele e quella
soprannaturale del cristiano? A questo proposito, S. Agostino
attraverso la contrapposizione fra civitas terrena e civitas Dei
conferma l’incompatibilità fra le due diverse modalità della
speranza sopra indicate. Diversamente, S. Tommaso sostiene che
l’uomo, poiché è ordinato verso la vita eterna, spera da Dio non
solo il soccorso per i benefici spirituali, ma anche per le necessità
temporali. Egli distingue tre modi della speranza nella vita terrena
dell’uomo. Spes come: 1) passione irascibile; 2) presupposto della
virtù cardinale della forza; 3) virtù teologale. A partire da questa
distinzione, S. Tommaso afferma il carattere soprannaturale che
connota la virtù dello sperare in Dio. Essendo un umanista
cristiano, sussume la natura nella grazia potendo così legare: le
passioni (la passione irascibile), le virtù naturali (virtù cardinale
della forza) e le virtù teologali dell’uomo (virtù teologale della
54
speranza). Per arrivare a ciò, S. Tommaso dimostra la relazione
analogica esistente fra la speranza come passione e la speranza
come virtù, essendo entrambe l’attiva aspirazione verso un bene
futuro, arduo e possibile; condividono la parte appetitiva
dell’anima; richiedono l’aiuto di una virtù aliena; contraddistinguono
l’esistenza temporale, riassumendo la fiducia e la paura, si
relazionano con l’amore e la credenza; mentre hanno il loro
13
opposto nella disperazione . Grazie poi alla dottrina tomista della
forza, la passione di sperare, umanizzata e resa nobile grazie alla
magnanimità acquisita e quella infusa, arriva ad essere un
14
momento costitutivo della speranza teologale .
In quanto sentita da un animale dotato di ragione –afferma Laín-, la
passione naturale della speranza chiede apertamente o segretamente il
suo coronamento attraverso una virtù teologale; in quanto esercitata da
un uomo in via, la virtù soprannaturale necessita ineludibilmente il suo
appoggio nel movimento di un appetito sensitivo, e per ciò certi stati
psicofisici possono portare alla disperazione teologale. Con ciò
rimanevano assunte in un’antropologia cristiana l’elpís e la spes dei
gentili.15
Se S. Agostino scopre l’essenziale connessione fra
memoria e speranza, per cui nel fondo metafisico della memoria si
trova la possibilità ed il fondamento della speranza –da qui che
l’incontro con Dio si ottiene trascendendo la memoria-: che
relazione esiste fra memoria e speranza nel senso della realtà
umana e fra esse e l’unione dell’uomo con Dio? A tali domande
Laín ritiene che abbia risposto S. Giovanni della Croce, il quale
sviluppa
una
considerazione
mistica
della
relazione:
memoria/speranza. Essa si sviluppa secondo due direttrici: 1)
l’anima che spera sempre la propria deificazione. Qualcosa di cui è
pienamente cosciente solo il mistico, che si sforza di conseguire
l’unione con Dio durante l’esistenza terrena. La presenza
metafisica o essenziale di Dio nell’anima deve farsi causa prima e
fondamento costante della realtà dell’uomo e convertirsi
soprannaturalmente in motivo e ricreazione della propria vita
personale e successiva. Per ciò occorre disinteressarsi di tutto ciò
che non sia Dio ed a partire da ciò l’anima esiste esclusivamente
attenta a ciò che spera: la presenza affettiva di Dio nell’integrità
55
della sua essenza e sue potenze. Deificata nella propria sostanza,
l’anima avverte che il sapere di Dio diventa sapore di Dio; per cui
mossa divinamente nelle sue potenze, esse non operano in virtù
degli stimoli del mondo, bensì secondo la spinta intima, diretta ed
efficace dello Spirito Santo. 2) La memoria in stato di perfetta
unione, per la quale non si producono più le sospensioni
dell’attività memorativa. In questo stato infatti l’anima vive il tempo,
ricorda e spera, ma in modo inedito. Ricorda soprattutto mossa
dallo Spirito Santo, per cui ricorda Dio e ricorda in Dio; così come
spera Dio e spera in Dio. La memoria insomma è fondata nella
speranza, ossia: ricordare è sperare.
La vivente ed operatrice installazione dell’esistenza –conclude Laín- nel
fondamento metafisico e soprannaturale del proprio sempre, permette
che si stabilisca una connessione molto più profonda e visibile fra la
speranza ed il ricordo. La temporeità dell’esistenza umana, presupposto
reale della memoria e della speranza, resta costantemente riferita al suo
centro sopratemporaneo e si realizza in una vita terrena senza shock,
quasi senza inquietudine. L’esistenza psicofisica dell’uomo viene ad
essere un misterioso e ben accordato connubio successivo fra il tempo e
l’eternità… . A forza di annichilare i propri ricordi, San Juan de la Cruz
trova che la propria speranza è capace di dare vita nuova alla propria
memoria.16
Nella storia moderna, Laín individua diversi tipi di speranza
che seguono sostanzialmente l’idea cristiana della stessa. Così in
Dante vede il campione della: 1) speranza escatologica, visto che
la Divina Commedia è una raffigurazione poetica dell’escatologia
17
cristiana: inferno, purgatorio, paradiso . 2) Speranza terrena che
mostra una linea centrale e due attitudini estreme: ordinare verso il
fine ultimo dell’uomo tutti i fini temporali dell’uomo; ma anche:
riduzione della speranza terrena ad un minimo (negazione ascetica
del mondo), o retta esaltazione della magnanimità acquisita
(ricreazione umana della realtà), cui si è attenuto il cattolicesimo
18
dei secoli moderni (= Montaigne. Bossuet…) . 3) Teoria della
speranza, nell’ambito della quale Laín trova nei cattolici moderni
tre novità, dovute alla situazione moderna dell’esistenza umana: a)
speranza teologale apportata dal nominalismo del Basso Medioevo
ed il naturalismo del Rinascimento, con la crescente stima
56
dell’individualità e le possibilità della natura umana. b) Cambio
dell’idea di Dio che indica il nominalismo con la susseguente
maturazione del pensiero moderno. L’amore di speranza: è
interessato o disinteressato? Quando il cristiano ama Dio con puro
amore di speranza e non con amore di carità, lo ama per la
ricompensa che spera da Dio, o per ciò che Dio è e merita? c)
Aspetto storico della speranza cristiana, ossia: le relazioni fra
19
l’umana libertà, il corso della Storia e la provvidenza divina .
Ma la speranza è una chiave di lettura importante anche
nella Riforma protestante; tant’è che Aranguren afferma che il
luteranesimo non è dato dalla concupiscenza, ma dalla
disperazione: sentimento predominante nell’anima di Lutero ed a
partire dal quale si è costituito anche il suo modo di vivere ed
intendere il Cristianesimo. Ciò è dovuto sostanzialmente a due
motivi: 1) circostanza storica: favorevole alla disperazione
spirituale per l’incertezza di un’epoca nuova; 2) disperazione
psicologica, perché Lutero sin da piccolo visse tormentato da
paure, scrupoli ed angustie religiose, che lo portarono a concepire
Dio come un essere infinitamente arbitrario e tremendo. Unica
consolazione rispetto a tutto ciò: la fede giustificante, ossia l’intima
e vissuta convinzione che la fede, intesa come pura confidenza o
fiducia in Dio, può, senza opere, giustificare il cristiano.
La fede quindi si riduce in mera fiducia e più che credere la
verità di Dio, il luterano confida nella buona volontà di Dio che lo
salverà per quella confidenza con cui si abbandona alla
onnipotenza divina. Tuttavia, tale confidenza non annulla la
disperazione, le cui cause perdurano intatte e che impediscono,
dal punto di vista della teologia cattolica, definire questa come una
forma di speranza. Infatti, se il luterano definisce speranza: una
confidenza insieme sicura, inattiva e disperata, che nasconde la
disperazione; per il cattolico, la speranza è una confidenza
insicura, ma operativa e lietificante, capace di allegria, a partire dal
suo stesso fondamento metafisico, la realtà personale dell’uomo
che spera. Lutero inoltre distingue e separa nettamente nell’uomo
individuale il cristiano dal cittadino, l’intimità dalla vita esterna e
civile… . Alla concezione luterana della vita nel mondo si aggiunse
il modo calvinista d’intendere la morale. Infatti Calvino centra la
57
sua riflessione su una ferrea idea della predestinazione; mentre
per ciò che riguarda la vita terrena dell’uomo, con tenace ed acuta
vigilanza scopre i segni dell’eterna predestinazione di ogni
individuo al bene ed al male. Calvino parte dal testo della Genesi
nel quale si dice che il Signore assistette Giosuè, e tutto quanto
questi faceva gli veniva bene; e prendendo alla lettera questo
testo, sostenne che segno della beatitudine eterna era da
considerare la buona riuscita nei commerci del mondo. Il che
indusse fra i fedeli una forte preoccupazione nel conseguirli; per
cui, per il calvinista, la speranza terrena ha come suo oggetto
primario il trionfo sociale, mezzo di salvezza. Adotta inoltre la
forma di una previsione del futuro superlativamente razionale ed
20
esforzada .
Nel protestantesimo attuale si possono distinguere
fondamentalmente due linee di riflessione su ciò che è la
speranza: 1) un ritorno alla scoperta della disperazione come
sentimento religioso fondamentale; una sorta di: Torniamo a
Lutero!. Su questa linea si pongono autori come: K. Barth, E.
Brunner, F. Gogarten; nella dialettica della loro teologia si riscontra
non già un dialogo diretto ed intimo con Dio, bensì un disperato
intento di affermare la reale simultaneità spirituale di due serie di
termini contraddittori: disperazione/speranza, grazia/peccato,
fede/ragione. Dio diventa per l’uomo l’assolutamente Altro,
l’Inaccessibile; per cui, davanti ad una simile relazione, cos’è la
speranza? È tutto, perché la fede è comunque confidenza in Dio,
quantunque disperata, nell’incontro salvatore con Lui dopo la
morte; ma è anche nada perché l’anima umana vede e non può
lasciar di vedere l’assurdità delle promesse divine. Ed allora,
sperare cristianamente è solo l’atto di consegnarsi al futuro con
una salvatrice confidenza che nasce dalla disperazione. La
speranza cristiana, per Brunner, non consiste nel prolungamento
soprannaturale della vita dopo la morte, ma nel vincere la morte,
nella resurrezione dei morti, nella vita divina opposta a quella
21
umana che è morte . 2) La ricerca di una visione demitologizzata
della speranza, che passa attraverso la demitoligizzazione del
Nuovo Testamento in autori come: a) Bultmann, secondo cui per
rendere accettabile la verità cristiana del Nuovo Testamento in un
58
contesto dominato dalla visione scientifica del mondo, non è
ammissibile ad esempio una divisione dell’universo in tre livelli
(terra, inferni, cielo). Per cui, del Nuovo Testamento conserva
senz’altro solo lo Scandalo della Croce, ossia l’efficacia
genuinamente religiosa del messaggio evangelico.
Ed allora, cosa si spera? Si spera il Giorno del Signore che
nel Nuovo Testamento è diversamente descritto da S. Paolo
(resurrezione dei morti con nuova venuta di Gesù e l’elevazione al
cielo dei giusti ancora viventi) e da S. Giovanni (per il quale c’è il
transito dei giusti subito dopo la morte). Ma anche queste
sarebbero costruzioni mitologiche che non reggono davanti ad un
razionalista moderno. Insomma, in Bultmann si ricerca inutilmente
di conciliare la pleitesía del Nuovo Testamento con le nuove
esigenze del pensiero scientifico e con quelle filosofiche ed inoltre
si riscontra la negazione della possibilità di creare una teologia
dell’esistenza gloriosa, fedele al contenuto dello stesso
Testamento.
Cos’è allora la speranza?
La speranza cristiana –afferma Laín- non sa ora cosa sperare: la vita
speranzosa è in tal caso il risoluto ed animoso camminare dell’uomo
verso un modo di esistere –la vita in patria- del quale sa e nulla può
sapere. Vivere umanamente e cristianamente sarebbe essere per la
morte ed essere-in-Dio… per opera di Cristo.22
Davanti a tutto ciò, senza una metafisica, una teologia ed
una dogmatica, Laín ritiene che la comprensione esistenziale e
23
l’ermeneutica storica si riducono a qualcosa di molto soggettivo .
È nell’occuparsi della speranza nei secoli XVII e XVIII,
ossia quando si diffonde la secolarizzazione, che, secondo me,
Laín apre una discussione che ha profondi risvolti, anche etici, di
tutta attualità.
La secolarizzazione si diffonde anche per un’enfatica
proclamazione della dignità umana da parte dell’Umanesimo,
portatrice di una tesi positiva ed ottimista circa il potere dell’uomo:
senza l’ausilio di una virtù altra, e con la sua sola virtù, la creatura
umana è capace d’ordinare in modo ragionevole e soddisfacente
ciò che riguarda la sua vita terrena e molto di ciò che riguarda la
59
propria vita ultraterrena. L’estremo pessimismo antropologico della
Riforma, non si oppose a tale processo ed anzi finì –insieme ai
cattolici (Cartesio, Bacone, Pascal, Leibniz)- per affermare
l’autonomia dell’uomo nel reggere la propria vita su cui fino ad
allora c’era stato timore. In questo modo, il canto alla dignità
umana si trasforma in chiara e risolta pretesa di esclusività, di
monopolio. Ora, se la speranza umana è la speranza di una
pienezza, cosa possono sperare coloro che secolarizzano la
propria vita? Per questo, occorre considerare che i secolarizzati
del XVIII secolo non negano Dio, ma lo considerano come un ente
astratto, impersonale e lontano, che dopo la creazione del mondo,
si limita solo a contemplarlo senza intervenire (= deismo).
Con tale Dio, l’uomo dell’Illuminismo intratterrà una doppia
e contrapposta relazione: 1) da una parte, lo terrà lontano dalla
propria ragione; 2) dall’altra, cercherà d’identificarsi con lui,
negando l’esistenza di un peccato originale e divinizzando l’attività
della natura umana. Dalla conciliazione con Dio, alla deificazione
della creatura umana, tutto dipende dall’uomo. Se il cristiano, presecolarizzazione, crede che la creazione, e quindi la Storia, è
sottomessa ad un disegno divino che l’uomo può in qualche modo
scrutare (Provvidenza), pur restando la Storia retta dall’esterno
(Filosofia della Storia). Per il secolarizzato invece, il corso della
Storia ha in se stesso il proprio senso; da qui che si parla di legge
storica, in contrapposizione alla Provvidenza. Un processo simile
riguarda anche l’idea di Redenzione: Cristo, con la sua passione e
morte, ha redento gli uomini dal peccato. La Redenzione non ha
cancellato il peccato dalla Terra, ma ha permesso che se ne
potesse ottenere il perdono definitivo. Gli illuministi non possono
certo negare l’evidenza del male e l’ingiustizia nella vita dell’uomo;
ma nemmeno possono credere al peccato originale, né accettare
una redenzione soprannaturale del genere umano. Semmai
affermano la redenzione naturale, o storica e sostituiscono Cristo
con l’uomo in genere, o con la collettività umana: l’unica a rivelarsi
come qualcosa di grande ed a mostrarci la sua origine divina. La
società, in questo modo, diventa causa e rimedio dei mali
dell’uomo.
60
Il cosmopolitismo diventa risultato della secolarizzazione
del concetto cristiano di corpus mysticum. Da tutto ciò, come
cambia il concetto della speranza cristiana con la
secolarizzazione? La speranza ha il suo oggetto nella
consumazione escatologica del Regno di Dio:
verso di essa tende –afferma Laín- per un cristiano, la sua individuale
speranza e la speranza collettiva dell’Umanità intera, da Adamo fino
all’ultimo uomo. Da un punto di vista spirituale e soteriologico, la storia
universale è il progresso del genere umano verso la seconda e definitiva
pienezza dei tempi… Attraverso cadute e fallimenti, l’Umanità
guadagnerà una progressiva maturità spirituale per affrontare il passo
supremo e ultimo della Parusia ed il Giudizio.24
È così chiaramente espressa la trasposizione del futuro
escatologico al futuro storico:
il progressismo, la fede nel progresso, è il termine a cui arriva la
secolarizzazione della speranza cristiana nel mondo moderno. (p. 486).
Il progressismo, da parte sua, non fu un’idea, ma una
credenza, secondo l’opportuna distinzione posta da Ortega fra le
due realtà. Infatti, più che essere una speculazione di ideologi, si
presenta come religione del progresso, che cerca di abbracciare
tutti i campi della realtà dell’uomo: la morale, l’intelligenza, la
convivenza…, che non potevano non ricevere gli immensi benefici
del progresso. Grazie ad essi sarebbero sparite le malattie dalla
faccia della terra, e la vita dell’uomo arrivata ad età anagrafiche
sempre maggiori, fino a paventare la possibilità di superare
quell’agente che più limita l’uomo: la morte. La speranza di questo
tipo di fede ha una struttura tutta centrata nel fisiocentrismo
dell’Illuminismo; ossia la fede nelle virtualità della Natura. È quindi
una speranza esclusivamente terrena che tende al raggiungimento
di una perfezione suprema. E ciò Laín ritiene sia valido sia per
quanti credono nella futura pienezza dell’uomo (o stato finale del
progresso umano); sia per chi sostituisce il raggiungimento
dell’infinitud cui l’uomo aspira e che il cristianesimo promette, con
l’interminabilità del movimento perfettivo della Storia, proponendo
quindi la dottrina del progresso indefinito. Per ciò, Laín afferma:
61
tutto ciò che spera il progressista appartiene a questo mondo ed è
ineludibilmente sottomesso al tempo. Ma lui non spera per se stesso in
quanto individuo; lui spera, oltre la sua morte, la perfezione della natura
umana, sia questa perfezione uno stato terminale, o il retto, felice ed
indefinito esercizio migliorativo delle virtualità di questa natura, e ciò
imprime alla propria speranza un carattere escatologico e sacrale. Con la
secolarizzazione dell’idea cristiana della vita, il saeculum del futuro si
sacralizza, ricopre una dignità assoluta: nessun progressista tralasciò di
considerare sacra la sua speranza e non pochi si inginocchiarono davanti
ad una nuova dea, la Posterità.25
All’aspetto del fisiocentrismo ed alla mondanità, quale
ulteriore caratteristica della fede progressista, si deve aggiungere
la necessità; per cui tale è la perfezione progressiva della natura
umana, prodotto secolarizzato della crescita spirituale dell’umanità;
mentre ciò che prima veniva indicato come disegno della
Provvidenza, con la secolarizzazione diventa legge naturale, una
regola necessaria nel buon ordine dell’universo. Altra caratteristica
della speranza progressista è: la totalità; si passa cioè dalla
antropologia cristiana nella quale il presupposto delle azioni umane
è la persona (ciò che l’uomo è), contrapposta alla natura (ciò per
cui l’uomo è), all’antropologia fisiocentrica dell’Illuminismo in cui è
la natura umana generica il presupposto, per ogni uomo, della sua
natura umana individuale. È la secolarizzazione dell’omnia in
omnibus di S. Paolo. Quinta ed ultima caratteristica è: la
comunitarietà, che rende impersonale la speranza progressista,
perché si spera il bene del genere umano. Si passa cioè dalla
speranza di una convivenza amichevole con i santi nella gloria
celeste di fray Luis de Granada, alla speranza storicizzata di
Herder che sogna una vita futura frequentando tutti i saggi ed i
buoni affannatisi per l’Umanità. Qualcosa che la Storia già ci offre,
se pensiamo alle opere di Platone, Socrate, Marco Aurelio…
Siamo cioè davanti ad una concezione della storiografia come
dialogo con gli uomini del passato, oltre che ad un concetto della
Storia come scienza.
Insomma, conclude Laín, tutte le caratteristiche della
speranza cristiana vengono trasposte al saeculum nella speranza
progressista, con tutti gli interrogativi che possono sorgere in
merito: all’effettiva soddisfazione dell’anima umana nel momento in
62
cui si spera soltanto sulla propria natura; al fatto che la speranza in
una futura felicità mondana, possa dare un fondamento
26
soddisfacente per il presente .
Ora, a partire almeno dall’Illuminismo, ogni riferimento alla
dignità dell’uomo, con validità pubblica e civile, si fa all’interno di
un marco di legislazione positiva e laica: Costituzioni politiche,
dichiarazioni di diritti…
Per esempio, la Costituzione spagnola del 1978 afferma
all’art. 10: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que
le son inherentes…, son fundamento del orden político y de la paz
social”.
Nella Costituzione italiana non abbiamo un riferimento
esplicito alla dignità umana, ma vengono indicati dei diritti
inviolabili dell’uomo, come individuo e come parte di una società
nella quale svolge la propria personalità (articolo2); oltre
all’eguaglianza di fronte alla legge, per la quale viene bandita
qualsiasi possibile discriminazione potendosi così svolgere
pienamente la persona umana, partecipando all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese (articolo 3). Questi diritti
hanno il fine nel loro fondamento ultimo: la dignità umana.
La recente Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea (2000), stabilisce nel Capo I: l’inviolabilità della dignità
umana (come declaratoria generale). Essa si articola in: 1. diritto
alla vita come esclusione dalla condanna a morte. 2. Diritto
all’integrità della persona (fisica e psichica) che in medicina e
biologia prevede: a) consenso libero ed informato della persona,
secondo legge; b) divieto di pratiche eugenetiche (selezione delle
persone); c) divieto di far lucro del corpo umano; d) divieto di
donazione riproduttiva degli esseri umani. 3. Proibizione della
tortura o pene e trattamenti umani degradanti. 4. Proibizione della
schiavitù e del lavoro forzato, che prevede anche la proibizione
della tratta degli esseri umani.
Dalle evidenze portate fin qui, sembrerebbe che dignità è
un concetto astratto, attraverso il quale si riconosce qualcosa da
proteggere da parte dei poteri pubblici e fra essi c’è sicuramente la
vita.
63
Ma cosa s’intende per dignità? Nei casi elencati (ma se ne
potrebbero fare altri) non lo si dice con chiarezza. Il suo significato
si risolve in tautologia all’interno dei termini del testo. Il suo valore,
come i diritti susseguenti, non sembrano sostantivi ma condizionati
all’ordine politico e la pace sociale, ad esempio. Condizionati
quindi ad una qualità: un rango ontologico inferiore a quello
sostantivo. Non si considera la dignità come un’essenza originaria,
ma condizionata dai diritti che alla persona derivano dall’ordine
politico e sociale.
Probabilmente, l’abbandono da parte del pensiero debole
(che non è solo cosa di quest’epoca) di concetti non già religiosi,
ma classici della filosofia spiega una tale caduta nel soggettivismo,
nel relativismo, nel volontarismo, nel sociologismo… in cui pare
immerso oggi il nostro mondo.
A partire da queste considerazioni, andrebbe sicuramente
ripensato il concetto di dignità di fronte alla morte, perché non
sembra possa sostenersi senz’altro l’inizio e la fine della vita nella
mera volontà generale, in diritti generalisti, o nell’ordine politico e
nella pace sociale. Almeno per chi desidera pensare con radicalità,
non sembrano convincenti queste argomentazioni.
Ma tornando a Laín, ed alla speranza secolarizzata, egli
individua tre tappe nella formazione storica della speranza
secolare: 1) l’inizio di un disegno di una visione progressista della
storia secolare, sovrapposta alla concezione cristiana della storia
religiosa dell’Umanità, cui principale fautore è Cartesio. Questi
interpreta la speranza come: passione della natura umana;
sentimento storico; virtù cristiana vissuta nell’intimità. 2)
Secolarizzazione dell’esistenza storica dell’uomo, nella quale il
deismo ed il progressismo secolarizzati costituiscono i punti di
riferimento della vita spirituale europea. Esponente massimo di
questa tappa, iniziata da Fontanelle, è Condorcet (progressismo
illuminato). Il progressismo storico dell’Umanità è così sicuro da
poter essere previsto come qualsiasi altro fenomeno naturale. La
Storia viene quindi interpretata come crescita della natura umana;
per cui il suo corso deve essere diviso in relazione alle conoscenze
scientifiche maturate, non secondo gli avvenimenti politici o
religiosi. La speranza è nel progresso e nella sopravvivenza
64
indefinita dell’individuo umano. 3) Lo sforzo kantiano di unire il
cosmopolita ed il soggetto morale nella struttura dell’essere
umano. Kant con i suoi scritti cerca, rispondendo alla speranza del
suo secolo, di insegnare all’uomo del futuro ciò che la mente
umana può sapere, ciò che la condotta umana deve essere, ciò
che l’uomo è e come deve essere educato per il retto uso della
ragione. Da questo punto di vista, la speranza è il modo d’essere
dell’uomo che la pone davanti alla felicità ed il mondo morale. In tal
modo, il progressismo diventa evoluzione necessaria verso uno
stadio finale ed assoluto dello Spirito, dell’Umanità, o della Vita,
come si può vedere in autori come: Hegel e Marx principalmente.
In Marx, per esempio, sotto la trama dei suoi concetti economici e
sociologici, c’è una fedele ed ultimata secolarizzazione della
visione giudeocristiana della Storia. Il peccato originale dell’uomo
viene individuato nello sfruttamento; il che porta ad essere il
proletario, vittima principale dello sfruttamento, il nuovo popolo
eletto e redentore, perché grazie al suo sforzo rivoluzionario,
consentirà all’Umanità di entrare in una nuova tappa della propria
esistenza: il cammino verso un secolo futuro di felicità e libertà
definitive e totali. Marx quindi reintroduce il concetto di caduta e di
27
redenzione restati sconosciuti al XVIII secolo .
Per meglio far risaltare il significato della speranza, Laín
ritiene opportuno opporlo a quello di disperazione. Come definire la
disperazione? come la negazione radicale ed assoluta della
speranza, o come il sentimento di non sapere o non poter sperare
ciò che di suo l’uomo può sperare, a mo’ della vecchia teologia?
Ossia: l’uomo può non sperare? Laín cerca di rispondere a questa
domanda esaminando l’opera di Giacomo Leopardi, ritenuto da
molti come l’archetipo della disperazione del secolo XIX. Laín
esamina Leopardi da un doppio punto di vista: 1) l’autore dello
Zibaldone, i Pensieri, le Operette morali, che è il Leopardi
moralista e considera la vita umana dal punto di vista della felicità,
la verità ed il bene a cui quella aspira, non si stanca di proclamare
la necessità della speranza, l’essenziale ed ineludibile pertinenza
dello sperare alla costituzione stessa dell’esistenza umana. Come
all’uomo gli è consustanziale pensare, così gli è consustanziale
sperare; giacchè la speranza è vita e stimolo di vita e per ciò è
65
anche infinita. Anzi, da questo punto di vista, la speranza è meglio
del sapere, giacchè contiene un quid indefinito che la realtà (=
sapere) non può contenere. Da ciò si può ricavare che la speranza
dell’uomo fa sempre riferimento a due termini autoimplicantesi: la
realtà sperimentabile, di fronte a progetti riducibili a saperi
propriamente detti; la trans-realtà indefinita ed inconcepibile,
consistente nella possibilità di essere infinitamente felice. Da qui
anche una duplicità nella produzione leopardiana: a) opposizione
sapere/sperare, scienza/speranza; b) tensione fra la necessità di
un certo sapere per sperare e l’azione letale della scienza sulla
speranza. 2) L’autore dei Canti, ossia il Leopardi che esprime
liricamente la sua intimità, che invece proclama la disperazione.
Questa viene cioè vissuta come posizione soggettiva, tanto che
Leopardi distingue fra: speranza di natura, quella di cui è dotato
l’uomo come essere vivente e per la quale non può disperare;
speranza di ragione, propria dell’essere spirituale e pensante per il
quale la disperazione è possibile, perché la sua mente scopre che
la speranza viene distrutta dalla verità (= tragedia dell’esistenza
umana). Tuttavia, anche nella disperazione, non si estingue la
speranza, perché quella non esisterebbe senza questa, né l’uomo
potrebbe disperare se non sperasse. La disperazione del Leopardi
è quindi solo causa di fatti biografici: l’infermità, il tedio e la perdita
della fede religiosa, già all’età di 21 anni. Di tale speranza che
persiste, abbiamo anche traccia nel: Diaologo di un Venditore
d’almanacchi e di un Passegere, nella quale chiaramente si
esprime una preferenza per la vita futura, nei confronti della quale
28
anche Leopardi afferma: Speriamo .
Altro poeta indagato da Laín è Baudelaire e la sua opera: I
fiori del male, nella quale mostra di essere un uomo moderno al
culmine della propria avventura storica. Ossia è l’uomo che si è
sentito Dio e nel confronto con la realtà limitante ed opprimente ha
visto decadere la propria speranza infinita, che si è fatta
disperazione. Il suo spirito moderno è quindi costellato da un
soggettivismo idealista e pragmatico e dalla visione nominalista
della Divinità. Baudelaire è completamente incastonato nel
Romanticismo per la sua inestinguibile sete d’Infinito ed il suo
senso del dolore. Elementi che faranno di lui un Dio-Satana fallito,
66
cavilloso ed estetizzante; nonostante ciò, la speranza non smise
29
mai di essere caratteristica principale della sua anima .
Fra la pretesa impossibile di un’esistenza satanico-divina
ed il ritorno alla speranza del cristianesimo, s’interpongono altre tre
possibili vie: l’evasione, il progetto di un ritorno all’origine, la
rassegnazione disingannata, animosa e tragica. Da questo punto
di vista, Laín ritiene che –inteso come accadimento della storia
generale, il Modernismo non fu altro che un tentativo di evasione
dell’anima di fronte all’angustia; così come l’ucronia (la
considerazione di ciò che sarebbe successo se…) di Renouvier, o
la filosofia di Bergson e Dilthey, sono l’immaginazione o il progetto
di un ritorno all’origine della storia moderna, e perfino della storia
d’Europa. Oltre a questi due aspetti, la rassegnazione ascetica.
Infatti, durante il secolo XIX, uomini come Hegel, Comte,
Leopardi… credettero di essere Dio in potenza; ma interrogativi
come: e se l’uomo non fosse altro che un mero uomo? e se
l’esistenza umana, finita e temporanea, non avesse altro destino
se non quello di fare se stessa nella biografia e nella Storia?,
sollevati dall’esistenzialismo e dallo storicismo, producono la crisi
del nostro tempo e, quindi, una decisione rassegnata. Ciò perché
la Storia ha saputo dimostrare a tutti la radicale inanità della
speranza progressista. Ora, come sostiene Ortega, c’è crisi storica
quando fallisce il sistema di credenze su cui si fondava l’esistenza
dell’uomo. Tuttavia Laín non crede che l’uomo sia solo credenza,
bensì che la sua vita si fondi su tre abitudini (Zubiri): credenza,
speranza e dilezione, cui l’uomo in modo diretto, o indiretto, in
modo conscio o inconscio si rifà. Per cui la crisi nasce quando si
smette di credere sufficientemente alla natura umana ed a credere
che la Storia conduce progressivamente ed inesorabilmente alla
felicità terrena universale. Per questo motivo, si è passati ad
amare le finzioni (l’arte astratta, le macchine automatiche), diverse
e distanti da ciò che nel corso del XIX secolo era considerato come
naturale. Ed ecco allora che l’uomo oggi non sa cosa ama
realmente e la sua esistenza è disorientata.
Ciò permette –secondo Laín- di dividere in tre gruppi
quelle che sono le disposizioni dell’uomo di fronte alla speranza:
67
1. Negazione della crisi contemporanea ed affermazione
della forma secolarizzata della speranza: quella scientifica e
tecnica del positivismo comtiano; oppure quella rivoluzionaria e
sociale del marxismo; o quella di coloro che vogliono arrivare a
sintesi dei due modelli precedenti.
2. Chi vive ed esprime la crisi, contro i negatori,
riscoprendo così il tema della speranza e della disperazione nel
corso del XX secolo.
3. Riscoperta del cristianesimo e della sua concezione
della speranza, sia dal punto di vista soprannaturale, sia da quello
30
delle cosiddette realtà terrestri .
Chi inverte implacabilmente e sistematicamente le tesi
tradizionali sulla speranza è: Martin Heidegger. Se, infatti, tutto il
pensiero tradizionale fino ad Hegel afferma che il futuro autentico
consiste nella speranza, perché è l’unico a porre l’esistenza
davanti all’immortalità, alla pienezza dell’essere. Secondo
Heidegger, al contrario, il futuro è autentico solo quando apre lo
sguardo dell’esistenza verso la morte, la possibilità di non esistere,
il nulla. È autentica solo l’angustiosa apertura dell’esistenza verso
la possibilità di non essere. Magnanimità è la conversione
dall’angustia in audacia creatrice; ossia: la grandezza di chi sa
vivere e creare appoggiando il proprio piede sul nulla. Laín si
chiede allora se è possibile vivere un’esistenza senza dare spazio,
senza contemplare la speranza, e considerando l’essere
31
esclusivamente finito .
Anche se più difficile da ricostruire vista l’assenza di una
riflessione sistematica sulla speranza, di sicuro interessante è la
concezione di Gabriel Marcel sull’argomento. Nelle diverse opere
del filosofo francese, dalle quali è possibile ricavarne il suo
concetto, si può rilevare sicuramente una prevalenza di
un’intuizione ontologica, descrittiva o metafisica del proprio
esistere, quale realizzazione individuale e concreta dell’esistere
umano in genere. Ed ecco allora che Marcel individua
un’opposizione tematica fra l’io sono e l’io ho; infatti l’avere è la
mia relazione con qualcosa che, in un modo o in un altro, è esterno
a me, come nel caso del mio stesso corpo. Siccome poi ciò che si
possiede ci divora, da ciò non è escluso il mio corpo. In
68
contrapposizione al possesso, all’io ho, vi è l’essere, l’io sono:
costitutivamente aperto, disponibile, anche quando sembra
chiudersi in se stesso. Essere ed avere non sono tuttavia
determinazioni irriducibili della realtà; infatti l’avere s’incorpora
all’essere per opera
dell’amore. Alla contrapposizione
essere/avere, ne corrisponde un’altra: problema/mistero. Se il
primo è qualcosa che trovo davanti a me e che posso delimitare e
ridurre; il secondo è qualcosa in cui io stesso mi trovo coinvolto. Il
mistero è la sfera nella quale ciò che sta davanti a me e ciò che sta
in me perde la sua distinzione iniziale. Altro concetto fondamentale
è quello d’incarnazione che parte da un io esisto: ossia la
coscienza di me nel mio corpo.
Da questa coscienza si deduce che l’esistenza è
un’esistenza incarnata. A partire da questi presupposti vediamo
qual è la fenomenologia della speranza in Marcel. Innanzitutto ciò
che la speranza non è: non è desiderio (qualcosa di concreto e
determinato, rispetto alla trascendenza degli oggetti particolari cui
si riferisce); non è ottimismo (la superficialità del “tutto si
aggiusterà”, contro l’implicazione personale nel processo che la
determina); non è vitalità (perché la speranza sopravvive alla
rovina dell’organismo). Gli elementi che invece si oppongono alla
speranza sono: l’inesperancia come angoscia inconcreta,
indeterminata e pre-riflessiva di sentirsi consegnato al tempo;
disperare è capitolare davanti al fatum imposto dal giudizio e
quindi disfarsi davanti all’inevitabile. Contrariamente a tutto ciò, chi
spera è caratterizzato da: cattiveria, comunità, pazienza e
disponibilità. Cattiveria è il sentimento dell’impossibilità di accedere
con mezzi propri ad una pienezza vissuta, ora del sentire, ora del
pensare (cattivo può essere un ammalato, un prigioniero, un
artista…). La speranza è su ciò che non si ha e si può avere e
siccome chi spera vive in una comunità, non esiste vera speranza
senza amore personale: Io spero in te e per noi. Per ciò che
riguarda invece l’oggetto della speranza, esso si caratterizza per:
trascendenza, incalcolabilità ed indipendenza dello sperato rispetto
alle possibilità di chi spera.
A partire da questi elementi, qual è la situazione storica
della speranza secondo Marcel? Secondo Marcel, il XX secolo è
69
stato programmaticamente refrattario al vero sperare, rispetto al
quale sono finiti col prevalere: la sfiducia e l’ottimismo; qualcosa
che ha procurato un’attenzione frenetica per la felicità e la
sicurezza del vivere terreno ed ha indotto all’ignoranza verso
l’esistenza ultraterrena, a negare il mistero della morte, finendo col
distruggere la vita umana.
Dal punto di vista ontologico, l’essere che sperimenta in se
stesso la cattiveria e la privazione implicita nell’Io spero è di per sé
deficiente e spera nella sua perfezione. Per chi è deficiente e
speranzoso, la realtà è inesauribile, infinita e responsiva. Grazie
alla creatività che sentiamo in essa, la realtà risponde alla
deficienza che avvertiamo in noi, così come la nostra speranza
risponde alla propria creatività. La speranza è, cioè, una risposta
dell’essere.
Per il solo fatto di sperare –afferma Laín-, chi spera scopre nel fondo
stesso della realtà la omnimoda esistenza di un Tu assoluto, con il quale
la sua stessa esistenza mantiene una stretta relazione colloquiale. Un Tu
di cui non si può disperare, ma del quale si può rinnegare.32
Ossia: si può tornare a disperare.
Da qui che la speranza si riferisce all’essere e non
all’avere; è un mistero e non un problema, quantunque l’uomo non
possa fare a meno di avere (corpo, facoltà, vizi…). Una vita
speranzosa è, infatti, una vita creatrice, aperta alla novità, non già
classificata, costituita: il che sarebbe disperante.
Quale allora la dinamica dello sperare nella realtà concreta
dell’esistenza umana? Per capire ciò, bisogna considerare il fatto
che colui che spera è un uomo nella prova. Ed allora, cosa deve
fare l’uomo per far fronte alla prova? Ci sono due possibilità: la
retroazione (cessione alla tentazione di ritrarsi in se stesso, come
se il futuro non possa che essere solo ripetizione) e la creazione
(capacità di sviluppare un’attività personale dell’esistenza sperante
in relazione alla realtà in cui si spera). Da questo punto di vista, l’Io
spero in te, in quel Tu assoluto è il laccio vivente e la garanzia
della mia relazione con il tu empirico e particolare della mia
speranza. Ora, una reazione speranzosa alla prova esige coraggio
e sacrificio; occorre affrontare la prova affermando e negando
70
insieme. È come un soldato in battaglia che deve insieme
riconoscere l’esistenza del rischio di morire, ma di agire come se
33
questo rischio non esistesse .
A questo punto inizia l’esame della formazione di una
teoria della speranza, passando attraverso alcuni autori, di diversa
estrazione professionale. Abbiamo infatti Minkowski, uno psichiatra
per il quale la speranza ha il suo fondamento nell’idea bergsoniana
del tempo; per cui, la speranza ci offre un intenso piacere perché ci
permette di guardare all’avvenire sotto una molteplicità di forme,
tutte possibili. A partire da ciò, la nostra esperienza del tempo
avrebbe due forme: il tempo razionale dell’orologio e quello vissuto
o intuito in cui ci si rivela immediatamente il corso della nostra
stessa vita, il divenire. Tale divenire viene però convertito in
avvenire dall’uomo, perché mosso dalla spontaneità vivente e
creatrice del suo primario impulso personale. Tutto ciò determina
un futuro che viene vissuto sotto due diverse forme: un futuro
previsto o saputo ed un futuro vissuto, da una parte; dall’altra
genera tre stadi successivi nella vita. 1) La vita si confronta con
l’immediato sotto forma d’attività ed attesa; 2) tende verso il
mediato attraverso il desiderio e la speranza; 3) ha la meta
nell’assoluto per mezzo della preghiera e l’atto etico. La
prospettiva dell’avvenire trova così alcance y majestad, fino a
fondersi nell’irrebassabile regione del mistero.
A questo punto, sul piano dell’avvenire immediato,
all’attività si oppone l’attesa; ma non è l’attesa quantificabile del
viaggiatore che attende il treno, bensì la ritrazione della vita su se
stessa, davanti a ciò che il divenire più immediato possa portarle.
Dal punto di vista del desiderio e della speranza: se il primo va
oltre l’attività e la ribassa in tutti i sensi, perché la sua meta è
sempre oltre l’immediato e può estendersi anche oltre la morte (si
desidera sempre che succeda qualcosa dopo la nostra morte). La
speranza, da parte sua, va oltre l’attesa e si dirige verso un
avvenire lontano, più ampio e pieno di promesse.
Chi attende con speranza, si allontana dal doloroso contatto immediato
con l’ambiente e presagisce…; cosicchè la speranza non una una
prolungazione lineare dell’attesa, ma un fenomeno vitale qualitativamente
diverso da essa.34
71
Desiderio e speranza sono fra loro diversi. Se il primo ha in
sé l’attività; la speranza ci libera da ogni ansiosa attesa, per
trovarsi in più intima connessione con l’io. La speranza, quindi,
anche rispetto all’intimità va in maggior profondità rispetto
all’attesa; infatti chi spera vive più dentro di sé rispetto a chi
35
aspetta .
Bollnow parte invece da un testo della seconda parte del
Faust di Goethe, nel quale la speranza e la paura sono definiti
come i due peggiori nemici dell’uomo, per l’influenza dell’ideale
stoico della atarassia (=uccidere la preoccupazione del futuro e
quindi i due aspetti in cui tale preoccupazione si manifesta: paura e
speranza). La speranza viene così considerata come un’illusione
pericolosa; confidare in essa, una necessità. Se quindi, da una
parte, la speranza non può essere rifiutata; dall’altra, non cessa di
essere ingannatrice: questa la considerazione della speranza,
indotta dalla teoria dei sentimenti dei secoli XVII e XVIII.
A partire da ciò, Laín evidenzia come Bollnow introduca
delle distinzioni che la mente deve fare; ossia: 1) speranza come
radicale indole dell’animo speranzoso, la speranza universale, che
non ha un oggetto intuitivamente rappresentabile e non può
condurre alla delusione; e le speranze concrete, cui l’uomo tende
nel suo vivere, che hanno un oggetto intuibile e deludono di
frequente. 2) L’attesa concreta, o aspettativa, che si riferisce ad
avvenimenti che possono essere fausti o infausti e riguarda
l’immediato; la speranza propriamente detta che, invece,
contempla solo eventi fausti e che lascia libertà interiore ed ha un
oggetto più indeterminato. 3) Il tempo dell’aspettativa che è un
tempo chiuso, perché si compie escludendo l’orizzonte del futuro; il
tempo della speranza che è, al contrario, un tempo aperto
contenendo una molteplicità di possibilità aperte, imprevedibili.
Ora, se nella vita umana, alla speranza si oppone
apparentemente la paura, l’angustia e la disperazione; in realtà, la
speranza occupa un posto più profondo ed originario nell’esistenza
reale. Per cui quella si configura come la struttura fondamentale
che sostiene quest’ultima. Tuttavia, visto che in Bollnow occupa un
ruolo importante la temporalità dell’esistenza, e che secondo
72
Heidegger la temporalità si concretizza nella cura; in opposizione a
ciò, il nostro autore sostiene che anche rispetto a quest’ultimo, la
speranza è una determinazione più radicale e profonda della vita
36
umana. Da qui la necessità di revisionare l’esistenzialismo .
Dal punto di vista medico, Brednow affronta il problema
della speranza cercando una spiegazione a quanto sostenuto dal
clinico Joh. Chr. Reil: i malati incurabili perdono la vita, mai la
speranza. Nel cercare di spiegare come ciò sia possibile, Brednow
(biologo e patologo) elabora una personale visione dello sperare
umano che parte dalla distinzione introdotta da Fr. Kraus
(patologo) fra: persona profonda che avrebbe la sua sede
anatomica nelle strutture paleoencefaliche ed è costituita da
impulsi, istinti ed affetti della nostra vita; la persona corticale,
somaticamente
corrispondente
al neoencefalo,
integrata
dall’attività intellettuale e volontaria. A partire da ciò, cosa sarà la
speranza? Se nella prima forma, la speranza è una tendenza vitale
e primaria, non diretta ad un oggetto determinato e sussistente
durante la vita; da qui partono impulsi che tendono a definire
l’indifferenziato, dirigendosi verso fini concreti. Quest’ultima è
l’opera della persona corticale. Volendo allora rispondere alla
domanda sulla possibilità che l’uomo possa vivere senza
speranza, si deve rispondere: fino a quando possiede l’impulso
vitale della speranza, l’uomo vive. Naturalmente, le avversità della
vita, necessità, malattie… possono alterare il dominio biologico ed
estinguere la speranza vitale. Ma un uomo, può morire senza
speranza? L’esperienza medica, porta Brednow a fare una
distinzione fra: i giovani gravemente ammalati, animati da una
poderosa speranza vitale e senza riflessioni angustiose; gli adulti e
gli anziani che, coscienti del loro orizzonte di vita, si appoggiano su
una speranza vitale più debole e stanca.
Da questo punto parte H. Plügge per indagare, dal punto di
vista clinico, come si manifesta il principio metafisico che nell’uomo
presidia e fonda l’affermazione della vita e dell’essere. Una di
queste manifestazioni è proprio la speranza, nell’ambito della
quale, a partire da esperienze cliniche con due pazienti morte di
cancro, Plügge distingue fra la speranza degli incurabili, dalla
speranza quotidiana. Questa si caratterizza per essere orientata
73
verso qualcosa di mondano, esteriore, contingente, implicando un
certo grado d’illusione e quindi di azzardo e delusione. Dalla rovina
di questa forma di speranza nasce la speranza genuina che tende
verso l’indeterminato, qualcosa che riguarda l’ammalato e
concerne il suo futuro. Una speranza che non riguarda solo i suoi
dolori, i problemi fisici…., bensì qualcosa di più ampio e profondo
in cui tutto si sussume; una trasformazione che implica il
passaggio verso un livello più alto:
La nuova speranza permette di sorpassare l’anteriore riferimento della
vita all’io, crea nuovi doveri e vincoli e procura una libertà ed
un’autonomia interne insospettabili prima dello sprofondamento fisico del
malato.37
Ora, questa forma di speranza non è rivolta solo al futuro –
come evidenzia Laín- ma comprende il presente, attraverso la sua
caratteristica fondamentale: la pazienza. Inoltre non riferendosi ad
un oggetto determinato, non è neppure soggetta all’inganno.
Insomma:
la speranza… è una determinazione fondamentale ed entitativa della
persona. Mentre qualcuno vive, vive grazie alla speranza. Qualcuno, non
solo il cristiano.38
E qui risulta evidente la differenza fra la speranza genuina
e la virtù cristiana della speranza, che è certa ed inaccessibile alla
disperazione, perché speranza della resurrezione soprannaturale
39
dell’essere umano .
Quali, a questo punto, le risposte spirituali all’attuale crisi
della speranza?
In ambito cattolico, possiamo evidenziare tre punti
fondamentali: 1) una rinnovata esposizione della dottrina
tradizionale della speranza cristiana. Si è assistito cioè al
passaggio da una visione che considerava l’individuo quale
soggetto principe dell’oggetto della speranza (il possesso della
visione beatifica di Dio), alla considerazione della società,
dell’universalità degli uomini quale soggetto della speranza. Essa
diventa quindi un tesoro che può essere condiviso nella comunità.
2) Sviluppo vitale e teologico della stima del mondo, per cui chi
74
vuole e sa far proprio il perenne modo di esistere in Christo
contemplerà e vivrà le realtà terrene, naturali o artificiali, come enti
dotati di senso dell’economia della creazione e della salvezza. 3)
Crescente attitudine alla comprensione dell’avversario per poter
40
vivere il cristianesimo come chiave di tutta la Storia .
Laín non trascura di considerare anche la concezione
filosofico-culturale della speranza nella Spagna del XX secolo,
esaminando alcuni intellettuali. Primo fra essi: Miguel de
Unamuno, figura emblematica della Spagna, visto che arriva
anzitutto alla totale disperazione per vivere una doppia
impossibilità: la sua ragione non arriva a fare della verità
consolazione ed il suo sentimento è incapace di fare della
consolazione una verità. Questo perché la sua ragione filosofica
non attribuisce un senso all’inquietudine dell’uomo sull’immortalità
della propria anima e la persistenza della sua coscienza dopo la
morte; d’altra parte, il suo forte sentimento vitale, il suo anelito alla
sopravvivenza e l’irrassegnabilità all’annichilimento della morte,
non sanno come rendere ragionevole e vero il contenuto del suo
sentire. Ad ogni modo, la sua angosciosa disperazione non
conduce Unamuno al suicidio, o alla rassegnazione, ma a
combattere per una nuova vita; convertendo, in tal modo, la
disperazione in fonte di creazione vitale. In tal modo egli ci fornisce
una personale interpretazione all’affermazione di S. Paolo,
secondo cui la speranza crea ciò che il possesso uccide. Tutto ciò
fa sì che Laín indichi quale caratteristica fondamentale di
41
Unamuno quella della disperazione speranzosa .
In Antonio Machado, al contrario, Laín indica quale oggetto
della speranza: Dio e la morte, a causa anche delle sue
vicissitudini personale (la morte della moglie anzitempo).
Parlare con Dio, vedere Dio, ricevere la totale e plenaria compagnia di
Dio. Dio è –scrive Laín- per il solitario Antonio Machado […], la somma ed
unica realtà in cui possono trovare soddisfazione senza cenere la
speranza e l’impazienza dell’uomo.42
Tuttavia è solo attraverso il sogno fugace che l’autore
riesce a sentire nel cuore la presenza vivificante di Dio; mentre
75
nella veglia, la sua resta sempre una ricerca incerta e penosa di
43
Dio che finisce per farsi: invenzione di Dio .
Nell’opera di Ortega y Gasset, Laín evidenzia prima di tutto
i diversi modi in cui l’autore ha interpretato se stesso: cacciatore e
navigante. Come cacciatore l’uomo si sforza di catturare la preda
perseguita; mentre come navigante cerca di raggiungere il porto
desiderato. In entrambi i casi, vi è sottesa la ricerca di scrutare
l’avvenire. A partire da ciò, Ortega ritiene che la vita è per lo più
felice, per cui il valore della stessa si ritrova nella vita stessa. La
vita è tuttavia anche deficienza ed affanno. Una verità limitata è
contenuta in ogni presente del vivere umano ed è parte integrante
della totale verità divina, per cui Ortega ritiene che l’uomo è
costitutivamente orientato a cercare un’istanza superiore. Ortega
ammette quindi che la vita umana poggia metafisicamente su una
realtà trascendente alla stessa, che costituisce anche il
fondamento postumo della propria felicità e verità, oltre che il
termine definitivo di riferimento dei propri desideri e progetti. Tale
fondamento viene definito da Ortega: Dios a la vista, il cui
significato Laín esplicita con qeste parole:
la felicità vera, l’occasionale coincidenza fra ciò che vogliamo essere e
ciò che effettivamente siamo, è fugace tangenza con l’eternità, felice
intuizione di un possibile modo di vivere nel quale l’uomo eternizzato,
coincida per sempre con il meglio di se stesso.44
Insomma, la speranza di Ortega è quella di una nuova
rivelazione per l’uomo, nella quale si mostri una realtà
45
trascendente le teorie dell’uomo: la vita .
Volendo analizzare la situazione della speranza nella
Spagna contemporanea, Laín torna ad analizzare –fra le altre- le
figure di: M. de Unamuno ed A. Machado, appartenenti alla
Spagna della generación del 98; una situazione religiosa, storica
ed una stima del vivere intimista che rivolge attenzione al sogno ed
alla sopravvivenza più che agli accadimenti quotidiani della carne.
Tutto ciò impedisce un’affermazione sicura ed ottimista della
speranza, quantunque non siano mai arrivati all’assoluta
disperazione, volendo sempre sperare. Per contrasto, Ruben Darío
76
afferma la speranza della vita e di fronte alla vita, per la diversa
46
situazione storica in cui visse .
Completata la ricostruzione storico-culturale del concetto di
speranza, completata cioè la parte diacronica dell’opera, Laín nella
quinta parte cerca di costruire, in modo sincronico, un’antropologia
della speranza.
Essendo l’antropologia un discorso sull’uomo, Laín si
sofferma anzitutto su tre idee dell’uomo: 1) la definizione ellenica di
animale razionale; 2) la definizione nietzscheana di animale che
può promettere; 3) la definizione conduttista, secondo cui l’uomo è
una modalità peculiare di condotta. Tutte queste idee dell’uomo
hanno come fondamento comune la condizione zoica dell’essere
umano, oltre alla sua condizione cosmica, secondo cui l’uomo è
frammento individuale dell’Universo; ciò lo rende, in qualche modo,
divino. Tenuto conto di queste tre idee dell’uomo, Laín ritiene che
in uno studio dell’attività umana dello sperare risponderà: nel primo
caso, il modo in cui l’animale razionale si rivolge al futuro. A questo
proposito, essendo l’uomo un frammento del cosmo, deve e può
sperare ciò che il cosmo gli permette. Come parte del cosmo,
l’oggetto principale che ha influito da sempre sulla speranza
umana è stata l’idea della fine del mondo. Essendo parte del
mondo, il suo futuro non può che interessarci e coinvolgerci.
Sicurezza della perdurazione dell’universo e timore per una fine
del mondo sono i due poli di un problema che l’uomo ha sempre
affrontato, con diversa prevalenza dell’uno o dell’altro, a seconda
delle diverse circostanze storiche e/o personali. Ora, all’interno di
quello che possiamo definire come futuro mondiale, si possono
individuare almeno tre futuri regionali di realtà cosmiche e terrestri:
1) quello minerale che possiede sempre un futuro indeterminato,
che non è solo esterno, ma costitutiva. La materia è infatti in se
stessa un’attività indeterminabile e tuttavia al suo interno possono
individuarsi delle isole cosmiche per le quali il futuro è determinato:
gli esseri viventi. 2) Quello della realtà vivente (animale o vegetale)
che è un futuro determinato, ordinato da cinque tappe
fondamentali: nascita, crescita, riproduzione, declinazione e morte.
Il futuro quindi di ogni essere vivente è determinato dalla sua
situazione presente nel corso del suo invariabile ciclo vitale.
77
In cosa però si distingue il ciclo vegetale da quello
animale?
Se la pianta esiste passivamente e qualora non riceve il
nutrimento necessario dal terreno è destinata a soccombere;
l’animale è caratterizzato da altri cicli vitali subordinati: veglia,
sonno, cattura e sazietà, l’aggressione e la fuga, il riposo ed il
gioco, la malattia e la cura. Attraverso questi cicli subordinati,
l’animale compie il suo ciclo vitale basico che lo porta verso la
morte individuale, ma alla perpetuazione della specie tramite la
riproduzione; in tal modo, realizza anche pienamente la sua
animalità. Ossia, proprio la sua protensione verso il futuro: una
caratteristica che scaturisce già nella prima infanzia, prima ancora
che compaia il riferimento retrospettivo verso il passato (= ricordo).
Tale protensione nell’animale oscilla fra i due stadi vitali: la veglia,
in cui si trova al massimo livello; il sonno, in cui è ad un livello
minimo. Entrambi sono modi dell’attesa animale, durante la quale
esso: cattura, gioca, si rifugia, inventa…
Quale la struttura comune a tutti questi modi concreti di
sperare? Laín individua, a tal proposito, due concetti biologici utili:
1) il concetto di circolo figurale di von Weizsächer, ossia la
peculiare connessione dinamica della relazione sensitiva fra
l’individuo animale ed il suo ambiente; 2) la formalizzazione di X.
Zubiri, ossia la capacità d’includere in contesti figurali diversi ogni
elemento che compone il campo percettivo. Maggiore è la
perfezione del processo di formalizzazione, più l’animale riesce ad
utilizzare i diversi oggetti che percepisce per fini diversi. Questo
genera naturalmente libertà ed intelligenza astrattiva e
generalizzatrice, diverse in tutti i livelli della vita animale, anche
negli antropoidi. Dell’animale è quindi l’attesa, non la speranza,
giacchè essa è caratterizzata da una struttura fisiologica diversa,
non posseduta biologicamente dall’animale.
Ora, nell’uomo la biologia dell’attesa si caratterizza come
forma più complessa di quella animale da punto di vista
quantitativo, non qualitativo. L’uomo è capace di rinunce alle
soddisfazioni istintive che l’ambiente propone ed il corpo richiede.
Insomma, l’uomo è capace di un’attesa radicalmente sopraistintiva, perché la sua capacità di maneggiar, osservare…
78
l’ambiente è indefinitamente ampio, ed altrettanto ampie sono le
sue possibilità d’intervento su di esso, come pure l’infinità di eventi
diversi che si possono attendere in ogni situazione.
La differenza biologica si deve quindi al fatto che mentre
l’attesa dell’animale è sempre adattata all’ambiente, secondo la
dinamica della vita istintiva; nell’uomo, invece, il suo organismo –
ed in particolare il suo sistema nervoso- esige un’attitudine diversa
di fronte al futuro: il progetto, ossia la condizione in cui il cervello
umano pone l’uomo nella situazione di dover pensare. Ciò
converte l’attesa in speranza.
Naturalmente non si deve pensare che tali attività
biologiche siano qualcosa di soggiacente alla vita spirituale, visto
che nell’uomo fra attività biologica e mentale c’è un legame di
reciprocità. In poche parole, nell’uomo la speranza è attesa e non
vi è attesa che non si faccia speranza. E così anche: esistendo
una fisiologia della speranza, vi è anche una patologia, ossia una
relazione fra lo stato del corpo e la capacità di sperare. Esempio
chiaro di ciò sono le biografie di alcuni grandi autori come Leopardi
e Nietzsche, il cui stato fisico impediva la personale disposizione
alla speranza. Da ciò si deduce la stretta relazione fra la fisicità e
47
la spiritualità dell’uomo, l’unione esistente fra corpo ed anima .
Ora, se vivere umanamente nel mondo, ossia: se vivere è
sperare, allora vivere è progettare, ed il progettare porta con sé un
domandare, una curiosità sulla propria possibilità d’essere e voler
essere. La domanda, il chiedere intorno alla mia possibilità
d’essere, porta con sé implicita la possibilità, la minaccia del non
essere ciò che io pretendevo o aspiravo ad essere. Ciò vuol dire
che il domandare apre la mente umana alla prospettiva della
propria determinazione esistenziale, dell’essere finito; si scopre in
tal modo la possibilità del non essere.
Ma questa possibilità –si chiede Laín- equivale al nulla
assoluto?
In ogni tipo di domanda che l’uomo pone vi è anche una
sua congettura previa sul proprio futuro; nel senso che, nel
momento in cui la risposta verrà prodotta: 1) sarà una risposta
adeguata alla domanda; 2) chi la pone sarà ancora se stesso
quando la risposta verrà data. Tutto ciò lo si può congetturare con
79
sufficiente sicurezza in base all’esperienza ed al sapere; per cui,
se da una parte la domanda apre la mente umana alla possibilità
del non essere, per altra svela le credenze su cui si poggia
48
l’esistenza interrogante .
Cos’è la credenza? Se per W. James è il senso della
realtà, è cioè un elemento costitutivo e radicale della vita umana;
Ortega, al contrario, contrappone le idee alle credenze. Con ciò
riesce a dimostrare che queste ultime hanno una primaria
importanza nella costituzione del fondamento dell’esistenza
umana, visto che rappresentano le idee che siamo non le idee che
abbiamo; viviamo, quindi, nelle idee, e non ci troviamo con esse.
L’animo umano è quindi portato alla credenza; ad essa si oppone il
dubbio. Esso, tuttavia, non è un non credere; bensì un credere che
ci conduce ad una realtà ambigua, nella quale combattono due
credenze antagoniche. Ed allora, James come Ortega affermano la
sostanziale credenza dell’uomo; anche quando l’uomo sembra non
credere, realmente e che nuove credenze si sono sostituite alle
vecchie, o queste ultime si sono depurate per espulsione dalle
credenze superflue. Ed allora, se la mia domanda mi apre
all’essere, ma anche al non essere; la credenza e la confidenza mi
pongono nell’aspettativa di essere e mi rivelano l’apertura
all’ambito dell’essere della realtà.
Quindi la credenza è la «porta di accesso –afferma Laínalla realtà ed all’essere [che apre] la mente dell’uomo alle idee di
49
eternità ed infinito» .
Accade però che se la domanda mi apre all’essere, come
alla possibilità di non essere: quest’ultima viene veicolata da una
vera sfiducia, di dubbio che porta insita in sé. La risposta,
insomma, può anche tradursi in un non essere; quel non essere
50
insito nello stesso fatto della mia esistenza .
Ma la domanda è in relazione anche con la creazione. Dal
punto di vista antropologico infatti: una domanda può essere
paragonabile all’esplosione di una saetta. La saetta sarebbe ciò
51
che domandiamo: nuove possibilità d’essere .
«In quanto conato di creazione, la domanda apre
l’esistenza umana, non solo a ciò che è, termine formale dell’atto
80
creatore, ed a ciò che c’è, materia delle quasi-creazioni umane, ma
52
anche a ciò che fa che ci sia» .
53
Ossia la domanda apre anche alla comunità .
Se quindi la struttura dell’attesa umana è qualcosa che
coinvolge la realtà e l’essere dell’uomo nel suo progettarsi,
proiettarsi verso il futuro, nel suo domandarsi circa esso,
implicando quindi un aspetto eminentemente antropologico; qual è
invece la struttura della speranza umana?
Se nell’attesa si manifesta qualcosa di insito alla natura
umana: la sua temporalità, la sua finitezza; per altro verso, l’uomo
non può sperare senza fare qualcosa, senza un operare
simaticamente o psichicamente. In quanto essere vivente, ad ogni
modo, l’uomo non può non sperare, perché di ciò è fatto il suo
abito costitutivo. Un abito che si esprime come attività empirica nel
corso della vita, nella quale l’appetitus diventa passio.
Chi spera si muove, agisce –afferma Laín- perché l’uomo non può essere
un vegetale, e la sua speranza non arriva mai a convertirsi in passiva e
muta aspettativa. Nemmeno nel sogno… Dormendo o in stato di veglia,
vivere è per l’uomo sperare, e sperare è muoversi appassionatamente,
agire verso il futuro lungo la linea melodica delle diverse passioni nelle
quali si realizzano il proprio essere e la propria vita.54
Nello sperare l’uomo agisce e crea dunque, ma la sua
creazione non potrà mai essere creatio ex nihilo subiecti. Sarà
invece sicuramente ricreazione, elaborazione originale di qualcosa
di ricevuto ed in qualche modo elaborato. Conclude Laίn:
Sia o no arduo l’impegno […], il conseguimento dell’attesa umana e,
pertanto, il termine dell’operazione ricreatrice a cui tale conseguimento
conduce, sono sempre entificazioni della realtà, lavoro ontopoetico.55
Siccome l’attitudine dello sperare suppone una consegna
dell’esistenza di chi spera, Laín distingue diversi gradi di tale
consegna, che può essere: inane, ossia superficiale, tipica di chi
cerca solo di passare il tempo; circospettivo, ossia di chi cerca di
raggiungere un desiderio, il conseguimento di un bene o di evitare
un dolore, cercando quindi di possedere ciò che si spera e, di
conseguenza, si cercherà di preservare la propria vita, la propria
81
salute fisica affinché tutto ciò che può sopravvenire non impedisca
il godimento terreno del raggiunto oggetto della speranza. La
speranza autentica e radicale è invece quella che corrisponde al
grado più profondo della consegna, perché è quella che conduce
al compimento di una vocazione personale, mettendo in conto la
possibilità del fallimento e della morte personale.
Vive quindi personalmente chi cerca di realizzare la propria
vocazione, mentre muore chi vi rinuncia. Afferma l’autore:
La vocazione è l’alveo proprio della creazione umana e la forma espressa
della sua essenziale gratuità: per questo la sentiamo come una chiamata
che dal profondo del nostro essere ci spinge a fare qualcosa con
originalità, a creare»56.
Quest’atto creativo che cerca di conoscere la propria
vocazione personale, il proprio essere, con ciò trasformandosi in
volontà di essere sempre (ciò secondo l’accezione greca del
termine, per cui la contemplazione oscura dell’essere delle cose,
rotta dall’intelligenza di esse, passa alla contemplazione di ciò che
è, procurando un passaggio alla dimensione temporale del
sempre, dato che l’essere è ciò che sempre è) fa sì che nell’uomo
la speranza assuma un valore trascendente alla morte.
Ed allora: siccome la speranza si fonda su un dono
gratuito (= la vocazione personale a farsi uomo) ed è sempre
interrogazione confidente o confidenza interrogante, ecco che
suppone il dialogo metafisico e trans verbale con un Tu assoluto.
In altri termini, Laín afferma che la speranza umana è genuina
quando è religiosa. Le tappe quindi che portano al passaggio
dall’attesa alla speranza umana sono le seguenti: l’attesa come
abito entitativo della prima natura umana, diventa speranza, ossia
abito della seconda natura, quando:
l’uomo confida con maggiore o minore fermezza nella consecuzione di ciò
verso cui l’attesa in primo luogo si muove: continuare ad essere. La
speranza, a sua volta, arriva ad essere genuina, autentica o radicale
quando quel continuare ad essere esige in modo risoluto e lucido
l’espressione a cui naturalmente tende: essere sempre. Se l’uomo si
consegna alla conquista di quell’essere sempre con magnanimità e
forza… la speranza si costituisce come virtù naturale. ed in quanto il
possesso e l’esercizio di questa virtù riconoscono ed accettano la sua
82
costitutiva relegazione al fondamento della propria esistenza e di tutta la
realtà –più precisamente: in quanto l’uomo… spera nella Divinità-, lo
sperare arriva alla condizione di virtù naturale religiosa.57
Ora, per chi vive cristianamente, la speranza è in attesa di
58
essere sempre e di essere in Dio secondo le promesse di Cristo .
Conclusioni
Con questa sua opera, insieme ad altre come: Sobre la
amistad, Teoría y realidad del otro, Laín muove un ulteriore passo
nella costruzione di quella che sarà la sua opera fondamentale
Antropología médica para clínicos (1984).
Anche in La espera y la esperanza è possibile ritrovare
una ricostruzione di come nella storia sia stata concepita l’attesa e
la speranza (dagli ebrei ai filosofi, letterati, fisiologi…
contemporanei, passando attraverso la fondamentale esperienza
cristiana), utilizzando quindi un metodo diacronico. Considerando
cioè l’insieme dei fatti ed elementi dal punto di vista della loro
evoluzione nel tempo. E tuttavia, non essendo la sua un’opera
meramente storiografica, ma un’opera prospettica, che tende a
formulare una teoria moderna sull’argomento, egli apre la
considerazione della storia, all’osservazione di altri elementi
scientifici (psicologia, fisiologia, biologia…), oltre che alla
costituzione metafisica dell’uomo: vera molla che consente il
passaggio dalla semplice attesa, alla speranza. Utilizza, in questo
modo, un metodo sincronico, che tende ad osservare i fatti e gli
elementi indipendentemente dalla loro evoluzione storica.
La sua diventa, quindi, una comprensione della cultura
(storia, psicologia, fisiologia…) come fatto collettivo, nel quale
nasce ed è resa possibile la speranza. Da qui anche la costruzione
di un’ontologia della speranza, dato il suo essere connaturata
psico-somaticamente all’uomo, nonostante o insieme all’angoscia,
alla disperazione; legata alla fondamentale religiosità (=
religazione) dell’essere umano: ossia a quell’apertura che la
speranza consente all’esistenza umana e grazie alla quale si
scopre che il fondamento ultimo della realtà non solo è
fondamentale, bensì anche fondamentante (Zubiri).
83
La speranza è quindi anche inerente all’uomo, una
caratteristica grazie alla quale riesce a progettare e realizzare il
proprio essere, diventando così anche necessaria al suo stesso
essere; ed inerenza e necessità sono due altre caratteristiche di
un’ontologia. La speranza è l’espressione, possiamo dire,
dell’appropriazione del mio essere e della realtà delle cose che mi
circondano, che avviene grazie alla continua azione di stimolo, di
pro-vocazione forzosa che la realtà svolge nei miei confronti,
costringendomi a farmi persona. Persona è allora chi si
impossessa della realtà, ossia delle possibilità che quella offre,
attualizzandola. Ora, nella concezione dell’uomo di X. Zubiri –
ampiamente seguita da Laín Entralgo- si distingue un dinamismo
della mismidad (ove per dinamismo s’intende proprio
l’impossessamento delle possibilità e quindi la creazione di una
personalità), da un dinamismo della suidad.
La prima forma di dinamismo è propria dell’animale, il
quale mantiene la propria identità, nelle continue modifiche del suo
dinamismo, pur non essendo mai lo stesso. Nell’uomo, invece,
abbiamo il dinamismo della suidad: una forma più ricca e profonda,
perché l’uomo è un soggetto dotato di storia. A partire da essa,
l’uomo elabora preliminarmente un progetto, quindi un momento
dinamico anteriore all’impossessamento delle cose:
Ogni possibilità consiste nell’avviamento di un progetto. Orbene, nel
progetto appunto si trova qualcosa che non è reale, che è irreale… Così
in questo dinamismo l’uomo è reale facendo il giro dell’irrealtà nella
configurazione della propria personalità… Questo dinamismo consiste
nella realizzazione di un elenco di possibilità. L’uomo si è appropriato di
una possibilità ed è rimasto posseduto dalla medesima.59
Possiamo ricavare un criterio della speranza nello studio
condotto da Pedro Laín Entralgo?
Abbiamo sicuramente appreso da Laín ed è sicuramente
esperienza ontologica di ognuno di noi, che la speranza è un abito
che definisce e costituisce l’esistenza umana.
L’esistenza umana si svolge in una circostanza
determinata, diversa per ciascun individuo (fisica, economica,
biografica…); diversa quindi sarà necessariamente anche il tipo di
speranza che ognuno di noi potrà nutrire. Cosa posso e cosa devo
84
sperare, sono domande che resteranno sempre legate a questa
circostanza iniziale e nel corso della sua trattazione, Laín ci ha
esposto il caso di Nietzsche e Leopardi, quale duplice
testimonianza: disperazione, a causa della loro costituzione fisica;
speranza nonostante tutto, a causa della loro fondante costituzione
umana. Alle domande sopra riportate, i due autori non possono
che rispondere: poco o nulla sul piano della vita individuale, da qui
la disperazione. Questo atteggiamento negativo sul piano
individuale, si è però tradotto positivamente dal punto di vista
personale. Abbiamo visto, infatti, che persona è chi si impossessa
della realtà e delle possibilità offerteci, attualizzandole. Il loro aver
preso coscienza del loro essere ha fatto sì che essi guardassero
non esclusivamente a sé, bensì all’umanità di cui erano e restano
parte. Ciò gli ha portati a dover sperare, considerando il percorso
che l’umanità deve fare verso la felicità, la verità, il bene cui da
sempre aspira. In questo modo, han saputo passare dalla propria
realtà sperimentabile, dalla condizione soggettiva, ad una transrealtà, quella della personalità, consistente nella possibilità per
l’umanità di essere infinitamente felice. Così si son anche aperti ad
un tempo diverso da quello strettamente soggettivo e determinato;
sono approdati ad un tempo aperto ad una molteplicità di
possibilità imprevedibili. La disperazione soggettiva è diventata
fonte di creazione vitale per l’umanità.
Nei due autori è quindi riscontrabile una progettualità
nonostante la loro condizione: ossia un voler essere che va oltre la
certezza del proprio orizzonte vitale. Questo li avrebbe portati
presto a non essere più, oltre che a non essere come gli altri;
l’impossibilità di vivere emozioni, esperienze….come avrebbero
voluto.
Ma sperare non è possedere; è piuttosto ricerca
dell’avvenire, di un oggetto concreto, è ricerca di una qualità che
va oltre se stessi, più che di una quantità che riguarda solo se
stessi. Ed all’avvenire si giunge per l’essenziale e fondamentale
valore della vita che porta comunque con sé deficienza ed affanno.
Tutto ciò influisce non solo in una prospettiva
antropologica, ma sicuramente anche medica.
85
Pensiamo ad una persona il cui destino è segnato da una
malattia incurabile, o ad una persona gravemente segnata nella
sua autonomia da un evento clinico grave.
Pensiamo quanto sia importante nel loro stato vitale, nel
quale è facile riscontrare la parte patologica della speranza: la
disperazione, condurre queste persone alla scoperta di nuove
possibilità e quindi di condurli ad appropriarsi di esse, di progettare
nuovamente qualunque sia la loro prospettiva vitale; di continuare
a sperare, perché senza di essa avrebbero una morte biografica
prematura rispetto a quella biologica. Beata spes!
Una speranza contro che si rende tanto più necessaria
quando vediamo sempre più corto il nostro orizzonte vitale e verso
la quale ci deve indurre anche il medico, l’uomo che è dietro e
nello scienziato che cura il corpo, ma anche l’anima del paziente.
Dote molto rara questa oggi, perché assistiamo più spesso ad un
trattamento spersonalizzante del paziente: questi è un semplice
numero, più che essere una persona. In questo modo, numero lo
diventano anche i medici, incapaci di offrire la propria umanità e la
propria personalità. Incapaci di seguire fino in fondo il progetto da
loro scelto, optano per la loro stessa spersonalizzazione.
Da qui la necessità di uno studio antropologico, ossia
culturale e metafisico dell’uomo, con la sua mutevole condizione
esistenziale.
Ora, nella vita dell’uomo e nella condizione di malattia in
particolare, un ruolo decisivo è svolto dalla fede religiosa: chi crede
che la vita terrena sia un breve passaggio, chi crede
nell’insegnamento di Cristo, in una vita eterna, di là dalla vita
terrena, ha la possibilità di fare un salto nell’irrealtà, di fare quel
giro di cui ci parla Zubiri, per configurare questa sua nuova realtà –
quella della malattia- con una personalità sorridente: il sorriso della
speranza, dell’umanità confidente in un Tu assoluto, dell’uomo che
si è appropriato del proprio essere e della possibilità d’essere
sempre, nella propria come nell’altrui memoria, nell’altrui vita: Ho
yes siempre todavía (A. Machado).
Questa la forma di speranza radicale e genuina; quella di
chi si consegna radicalmente al proprio progetto, al proprio essere.
Beata spes, contra spem!
86
Ed allora, perché il medico stabilisca una corretta relazione
con l’ammalato, occorre che si stabilisca un rapporto di
cameratismo, come per due compagni di viaggio che affrontano un
cammino fatto d’inquietudine. Per questo il medico deve, per
rispondere alla richiesta d’aiuto del paziente, sentire qualcosa con
l’altro (Scheler), deve cioè compartire, condividere, entrare in
simpatia con l’altro, giacché per curare non occorre solo la
conoscenza scientifico-fisiologica, bensì anche la conoscenza
psichica dell’altro. Il paziente non è un oggetto fisico, ma una
persona che, in quanto tale, è un essere credente, sperante ed
amante e verso la quale il medico deve agire con uguale fede,
speranza e tre specie d’amore: eros (l’amore che ascende verso
l’ideale), agápe (l’amore effusivo) e filía (l’amore fraterno).
Questo significa sovrapporre ai principi scientifici, la realtà
del malato, ossia la sua biografia, la sua memoria. La memoria
consente all’essere umano di rivivere il passato nel presente, di
ricostruire in un attimo la sua esistenza arrivando alla
considerazione del valore assoluto della vita, nella quale ha pur
incontrato non pochi ostacoli, non poche delusioni, mille
inquietudini, tante deviazioni. Ognuna di esse, pur nella negatività
del momento, fa sì che il ricordo sia oggetto di un sorriso vitale,
segno del valore della vita vissuta/riscoperta anche e nonostante la
negatività che proprio per essere stata vissuta si è potuta
trasformare in una positività più generale: quella della propria
esistenza.
Inevitabile quindi per un medico accedere alla biografia
dell’ammalato, alla sua memoria. Oggi, chissà, è forse la medicina
antroposofica quella che presta maggior attenzione a questi aspetti
nella cura del paziente.
Medico e familiari, con il loro rispettivo amore, possono
aiutare l’ammalato ad appropriarsi della propria malattia, possono
aiutarlo a co-creare delle nuove possibilità: un modo di vivere
produttivo con una malattia incurabile, secondo una terapia che è
creazione cooperativa di una speranza: passaggio dalla deficienza
alla pienezza, dall’imperfezione alla perfezione.
Insomma, Laín ritiene che il criterio per la nascita della
speranza in un ammalato, si trova nell’amicizia fra medico e
87
paziente. Come abbiamo avuto modo di affrontare in altro scritto
60
su un’opera di Laín Entralgo: Sobre la amistad , tale amicizia
viene definita come: benevolenza e beneficenza, ossia una forma
di amicizia che involucra il desiderio di salute dell’ammalato, per
cui non ci deve essere nessuna parola negativa nella
conversazione del medico. Altri due aspetti sono: la beneficenza e
la beneficenza nella doppia dimensione della confidenza e della
fiducia. Ogni atto è accompagnato in Laín dagli affetti creatori e
sono tutti sentimenti che devono caratterizzare la personalità del
medico a prescindere dal contatto immediato con l’ammalato. Da
qui l’importanza del dialogo e della parola come arti catartica che
61
può condurre ancora a sperare, a creare .
1
P. LAÍN ENTRALGO, La espera y la esperanza. Historia y teoria del esperar
humano, in Obras Selectas, Petronio, Madrid 1965, pp. 308-879.
2
Ivi, pp. 314-318.
3
Ivi, p. 320.
4
Ivi, pp. 327-331.
5
Ivi, pp. 331-335.
6
Ivi, p. 343.
7
Ivi, p. 346.
8
Ivi, pp. 331-347.
9
Ivi, p. 335.
10
Ivi, p. 359.
11
Ivi, pp. 348-363.
12
Ivi, pp. 364-379.
13
Ivi, pp. 382-392 e 400-406.
14
Ivi, pp. 392-400.
15
Ivi, pp. 308-407, in part. p. 407.
16
Ivi, pp. 408-424, in part. p. 424.
17
Ivi, pp. 434-443.
18
Ivi, pp. 443-452.
19
Ivi, pp. 453-456.
20
Ivi, pp. 457-468.
21
Ivi, pp. 469-472.
22
Ivi, p. 477.
23
Ivi, pp. 469-478.
24
Ivi, p. 485.
25
Ivi, pp.488-489.
26
Ivi, pp. 480-495.
27
Ivi, pp. 495-522.
28
Ivi, pp. 527-542.
29
Ivi, pp. 543-562.
30
Ivi, pp. 563-569.
88
31
Ivi, pp. 571-584.
Ivi, p. 595.
33
Ivi, Ipp. 584-598.
34
Ivi, p. 619.
35
Ivi, pp. 616-622.
36
Ivi, pp. 626-630.
37
Ivi, p. 634
38
Ivi, p. 635.
39
Ivi, pp. 630-636.
40
Ivi, pp. 637-656.
41
Ivi, pp. 666-701.
42
Ivi, p. 713.
43
Ivi, pp. 702-716.
44
Ivi, p. 734.
45
Ivi, pp. 717-734.
46
Ivi, pp. 735-746.
47
Ivi, pp. 751-781.
48
Ivi, pp. 782-791.
49
Ivi, p. 800.
50
Ivi, pp. 792-801.
51
Ivi, pp. 801-809.
52
Ivi, p. 812.
53
Ivi, pp. 809-813.
54
Ivi, p. 821.
55
Ivi, p. p. 823.
56
Ivi, p. 828.
57
Ivi, p. 877.
58
Ivi, pp. 821-879.
59
X. ZUBIRI, Estructura dinámica de la realidad, Madrid 1989, pp.
questi argomenti cfr anche: F. Sanguinetti, Dinamismo filosofico
Morlacchi, Perugia 2000, pp. 161-167.
60
C. L. FERRARO, “Sobre la amistad” di Pedro Laín Entralgo,
pubblicazione su: www.storiadelmondo.com, n. 168.
61
Su questi temi, cfr. N. ORRINGER, La aventura de curar, Cfrculo
Barcellona 1997.
32
89
237-238. Su
di X. Zubiri,
in corso di
de Lectores,
JAN PATOČKA: LA FENOMENOLOGIA ASOGGETTIVA
di Roberta Sofi
Abstract
Questo saggio affronta la questione della soggettività nel pensiero dell’ultimo allievo
di Husserl, il fenomenologo Jan Patočka, in relazione ai concetti di “mondo della
vita”, “movimento” ed “epoché”. Benché la riflessione di Patočka proceda in accordo
con le analisi husserliane, il filosofo abbandona il piano della fenomenologia
trascendentale e teorizza una versione “eretica” della stessa. Il nuovo approccio
filosofico, denominato “fenomenologia asoggettiva” costituisce il più importante
tentativo di rinnovare la ricerca fenomenologica la quale non elimina il ruolo del
soggetto nella sfera fenomenale, ma suggerisce di pensare ad una concezione forte
e aperta della soggettività che scopre la totalità dell’apparire.
Cet article se propose d’affronter la question de la subjectivité dans la pensée du
dernier élève de Husserl, le phénoménologue Jan Patočka, et thématise
notamment le « monde de la vie », le « mouvement » et l’« épochè ». La réflexion
de Patočka, tout en procédant dans le sillon de l’analyse husserlienne, quitte le plan
de la phénoménologie transcendantale et en théorise une version « hérétique ». La
nouvelle approche philosophique, appelée « phénoménologie asubjective »,
constitue la tentative la plus considérable de renouveler la recherche
phénoménologique autour de la question de la subjectivité : le rôle du sujet dans la
sphère phénoménale n’est pas supprimé, mais on suggère une conception
dynamique de la subjectivité qui découvre la totalité de l’apparaître grâce au
mouvement de manifestation du monde où le sujet opère et agit.
This paper deals with the question of subjectivity in the thought of Husserl’s later
disciple, the Czech phenomenologist Jan Patočka, in its connection to the concepts
of “life-world”, “movement” and “epoché”. Although Patočka’s reflection is developed
in continuity with and under the influence of Husserlian analyses, he moves beyond
Husserl’s transcendental phenomenology and theorizes a “heretical” version of it.
The new philosophical approach, called “a-subjective phenomenology”, represents
his most relevant attempt to renew phenomenological research. It doesn’t eliminate
the role of the subject in the phenomenal sphere, but supports the reflection on a
strong and open subjectivity able to manifest being.
90
La questione della soggettività, intesa come sostrato
unificante di tutte le differenti pratiche umane, ha da sempre
imposto, per la sua fecondità, una rivisitazione delle posizioni
acquisite, generando nuovi e urgenti interrogativi. L’elaborazione di
un’ontologia della soggettività rappresenta una delle articolazioni
essenziali della filosofia moderna che vede il suo apogeo nell’ ego
cogito cartesiano. Descartes delinea infatti i tratti di un soggetto
razionale, detentore del sapere e principio di verità del pensiero
che troverà successivamente in Kant e in Hegel la sua massima
1
espressione . Tale concezione costitutiva della soggettività sarà
progressivamente sottoposta ad una profonda revisione critica da
parte di alcuni filosofi che rileggono l’elaborazione tradizionale del
soggetto alla luce delle condizioni che ne determinano la logica
della sua finitezza essenziale (la storia, la società, l’economia, la
sessualità,...). Da Nietzsche a Freud, fino a Foucault, la
soggettività non garantisce più la certezza assoluta della
conoscenza ma appare piuttosto come il termine problematico di
una riflessione destinata ad alimentare a lungo il dibattito filosofico.
Il pensiero contemporaneo ha gradualmente messo in
discussione il primato del cogito, scorgendo la crisi di un soggetto
che inizia a mostrare le sue crepe e debolezze, per affermare la
“concretezza” dell’esistenza. Michel Foucault ha elaborato una
genealogia della soggettività che ha rintracciato l’origine “recente”
dell’uomo come soggetto e oggetto dei dispositivi di sapere-potere.
Dopo aver dedicato la propria attività allo studio “archeologico”
delle istituzioni di esclusione del soggetto, quali la clinica e le
carceri, la riflessione di Foucault si è indirizzata verso l’analisi della
soggettività secondo la prospettiva delle tecniche del sé, ovvero
mediante l’idea di nuove possibili modalità di costituzione degli
individui e della collettività. Lungo questo percorso Foucault ha
segnalato che il soggetto, “invenzione recente”, può emergere
dalle sue determinazioni, pur essendo un mero prodotto dei
meccanismi di potere, adottando una prospettiva critica su se
2
stesso e sul mondo . In altri termini la soggettività, così ripensata,
da un lato mostra la ricchezza della possibilità dell’esperienza e
dall’altro la propria dipendenza da un “fuori” che la plasma e la
91
subordina all’esteriorità delle pratiche cui è sottoposta. A
conclusioni diverse è giunta invece la ricerca fenomenologica che
ha affrontato la cruciale questione della soggettività nel suo
rapporto con il fenomeno. Nella versione fondativa husserliana la
fenomenologia, servendosi dei concetti di intenzionalità, coscienza
ed epoché supera la certezza cartesiana di un cogito solipsistico
per scoprire la vita, popolata da una coscienza localizzata nella
Lebenswelt, ovvero la dimensione soggettiva della percezione,
della conoscenza, dell’etica e di tutte le questioni legate
all’esistenza.
Ritengo interessante, all’interno di questo dibattito aperto,
il contributo fenomenologico offerto dal filosofo ceco Jan Patočka.
Mediante un lavoro di analisi, interpretazione e integrazione della
proposta filosofica di Husserl, Patočka formula una versione
“eretica” della fenomenologia, la cosiddetta “fenomenologia
asoggettiva” che si muove nella prospettiva del completamento
dell’opera del maestro. La denominazione del nuovo approccio alla
questione della soggettività è radicale e pone immediatamente
alcuni interrogativi: cosa si intende per “asoggettivo”? Si elimina il
ruolo del soggetto o, al contrario, il soggetto rappresenta un ente
sui generis?
Cercheremo di rispondere a questi interrogativi nei
paragrafi seguenti ma anticipiamo fin da subito che il nucleo
centrale della fenomenologia asoggettiva patočkiana ruota intorno
ad una soggettività attiva che può essere compresa solo a partire
da una concezione dinamica dell’esistenza, attraverso il
movimento di manifestazione del mondo in cui il soggetto opera e
agisce.
Mondo della vita e soggettività
3
La meditazione sul mondo è l’orizzonte che sostiene la
riflessione fenomenologica di Patočka in un dialogo e confronto
incessante con il problema del mondo della vita condotto da
Husserl nella stesura della Crisi delle scienze europee e consente
di rilanciare il discorso sulla soggettività. Il filosofo ceco rilegge in
quest’opera il cammino che la filosofia deve compiere per spiegare
il rapporto tra il soggetto e mondo, passando attraverso la
92
coscienza di sé cartesiana, la logica hegeliana, la filosofia kantiana
e giungendo a parlare di fenomenologia, ovvero lo studio del modo
in cui ogni singola cosa appare a noi, si scopre e si mostra per
quello che è. Patočka riconosce ad Husserl il merito di aver
scoperto la sfera fenomenale, ovvero la sfera di ciò che si mostra
nel suo apparire e, con un procedimento analogo a quello utilizzato
da Descartes, condivide il suo tentativo di evidenziarla e di
4
assicurarla da un punto di vista metodologico . La fenomenologia
non ha per oggetto la realtà bensì l’apparizione di tutto ciò che
appare e l’elemento che accomuna la riflessione di Patočka al
pensiero del maestro concerne proprio il suo compito precipuo: la
5
ricerca delle condizioni di possibilità dell’apparire in quanto tale .
Tuttavia il filosofo ceco rintraccia nella Crisi delle scienze
europee
una
questione
teoretica
aperta,
determinata
dall’affermazione dell’attività costitutiva dell’ego trascendentale
come fonte ultima per la validità dei contenuti del «mondo della
vita». In tale interpretazione Patočka coglie il pericolo che Husserl
aveva cercato di evitare: il raddoppiamento dell’oggettivazione e il
conseguente oblio di quel fondamento esistenziale della scienza
che il filosofo tedesco voleva recuperare attraverso la riabilitazione
6
della Lebenswelt . La strada indicata da Patočka è invece quella
della regressione al mondo della vita, di un ritorno all’origine di
ogni intuizione ed evidenza per cogliere il fondamento del
processo universale di oggettivazione. Il mondo della vita è infatti il
contenitore di vissuti e situazioni soggettive che si scontra con il
tentativo di matematizzazione della natura, atto a tradurre ogni
correlato della ricezione sensibile in una struttura geometrica
7
indubitabile .
Tale opera di certificazione e trascrizione della Lebenswelt
in caratteri geometrici determina la conversione in fenomeno della
realtà concreta, scandita dall’efficacia e dalla utilità come sue
formule fondamentali. In altri termini la scienza risulta priva di
appoggi sicuri e tutto ciò che prima aveva un senso reale e vitale
viene accantonato, perde interesse. In altri termini, la Lebenswelt
husserliana, nata per rendere conto del mondo della vita scandito
dalle operazioni costitutive compiute dal soggetto, inteso nella sua
esistenza umana consapevole delle proprie azioni e relazioni,
93
radicato nel sensibile, nella percezione, nella causalità effettiva e
non astratta, nei vari condizionamenti, secondo varie motivazioni,
sembra paradossalmente tramutarsi in una sorta di tacita
celebrazione dell’oblio del mondo della vita. Da questo quadro
emerge da un lato l’identificazione del soggetto con ciò che è
oggettivo e contemporaneamente la consapevolezza della sua
dimensione soggettiva in quanto il soggetto è esecutore delle
pratiche e attività che, in ogni istante, si dirigono verso il mondo
che si offre a noi nell’attività intenzionale. L’attività intenzionale
soggiace così ad una costante evoluzione, tuttavia il mondo
continua ad apparirci unitario, cambiando solo nei contenuti.
Husserl, approfondendo il problema della coscienza intesa come
coincidente con l’essere dell’uomo una volta purificata da tutti quei
residui che la collocano tra gli oggetti del mondo, animata da meri
rapporti causali, tenta di fondare una nuova idea di scientificità
indagando il senso delle operazioni precategoriali che fondano il
senso d’essere del mondo della vita.
Il “trascendentale”, con la sua correlazione di soggettività
operante e oggettività naturale, costituirà il terreno privilegiato di
questa indagine sulla Lebenswelt e la fenomenologia husserliana
si servirà dell’epoché, della sospensione di tutte le verità
scientifiche obiettive, per attingere al rapporto tra coscienza e
mondo. In altri termini, la coscienza diventa per Husserl un
fenomeno puro che si mostra veramente per ciò che è, in grado di
fornire un esame valutabile e scientificamente verificabile
8
dell’essenza dell’essere umano . Husserl procedeva verso la
fenomenologia pura cercando nella soggettività un accesso
adeguato alla sua idea di logica pura che la psicologia empirica dei
suoi contemporanei non poteva garantire. L’epoché è in questo
senso lo strumento che consente al maestro di accedere all’essere
di ogni ente, qualunque sia il suo modo di essere e a Patočka di
introdurre la sua proposta di fenomenologia asoggettiva.
La svolta asoggettiva
L’elaborazione della nuova versione asoggettiva di quella
9
che il filosofo ceco definisce la sua “filosofia fenomenologica” ,
nata per indagare i rapporti tra i fenomeni e gli enti reali, viene
94
10
sviluppata tra gli anni Sessanta e Settanta con la pubblicazione
dei saggi Epoché e riduzione (1975), Il soggetttivismo della
fenomenologia husserliana e la possibilità di una fenomenologia
11
asoggettiva
(1970), Il soggetttivismo della fenomenologia
12
husserliana e l’esigenza di una fenomenologia asoggettiva ,
(1971). L’ “eresia” asoggettiva di Patočka costituisce una novità
assoluta rispetto alle riflessioni precedenti e alle successive
elaborazioni fenomenologiche intraprese dagli allievi di Husserl ed
13
Heidegger e si muove verso il soggettivo come elemento di
comprensione, ma non di fondamento, dell’apparire come tale. La
proposta dell’asoggettività, guadagnata mediante un ripensamento
dell’epoché, si dirigerà oltre la sfera della coscienza trascendentale
husserliana per risalire al fondo della manifestazione del mondo
che non è più costituito dal soggetto ma piuttosto codeterminato da
esso. Esaminiamo meglio la questione.
La filosofia antica a partire da Platone si è interessata ai
fenomeni ma, invece di affrontare la questione dell’apparire,
secondo Patočka ha confuso l’oggetto della manifestazione con la
14
manifestazione stessa . Se il fenomeno fosse solo manifestazione
ciò implicherebbe non solo la presenza degli oggetti, ma anche la
loro apparizione, la loro manifestazione. Ma esiste un’apparizione
che non appare a nessuno? Laddove entra in gioco l’umano non
solo le cose sono ma si mostrano, pertanto il fenomeno è la
manifestazione dell’oggetto, della cosa. Tuttavia, osserva Patočka,
anche il fenomeno è un oggetto, non è solo ciò che si mostra.
Allora qual è il rapporto tra il fenomeno e ciò che si mostra?
Affinché qualcosa si manifesti è necessario che si manifesti a
qualcuno, occorre il riferimento ad una soggettività. In altri termini
non è possibile conoscere la manifestazione in quanto tale: il
mostrarsi, il fenomeno rimangono sullo sfondo rispetto al fatto che
per noi le cose sono. Tuttavia l’essenza stessa dell’uomo e la
questione della sua specificità e delle sue possibilità sono legate al
problema dell’apparire.
Secondo Husserl la possibilità di cogliere il fenomeno
come tale non può basarsi sul suo uso ma è necessario modificare
15
il nostro modo di relazionarci al mondo pertanto la sua ricerca
fenomenologica verterà sulla modalità di apparire dell’oggetto,
95
ovvero sulla sfera dell’apparire che conferisce alle cose la
possibilità di manifestarsi. In questa ricerca della modalità di datità
dell’apparire degli oggetti, Husserl ritiene che gli atti intenzionali,
ovvero i vissuti privi di realtà oggettiva, debbano appoggiarsi alla
coscienza pura e trascendentale. In altri termini, nella soggettività
husserliana non c’è più spazio per una sfera fenomenica ma
16
assistiamo alla riduzione all’immanenza pura : il mondo non è
solo una somma di oggetti ma si identifica con la soggettività
trascendentale. La fenomenologia come scienza del fenomeno si
configura pertanto come una ricerca paziente all’interno
dell’atteggiamento non oggettivo che non utilizza il fenomeno solo
17
per svelare le cose . La filosofia fenomenologica di Patočka, che
non intende analizzare i fenomeni in quanto tali ma cerca di trarne
alcune conseguenze metafisiche, si interroga sul rapporto tra il
fenomeno e gli enti, ponendo una differenza, che per Patočka
18
consiste in una irriducibilità, tra l’apparire e ciò che appare .
Si stratta di individuare una correlazione tra ciò che appare
e l’apparire. Tale relazione costituirà il terreno fertile per
l’elaborazione della fenomenologia asoggettiva che apre al mondo
dell’apparire facendo del soggetto non un hypokéimenon che
soggiace ad esso e ne è la causa ma come il referente al quale
l’apparire appare e contemporaneamente come parte integrante
del processo di apparizione, senza esserne però l’autore. In
Husserl l’intenzionalità è diretta all’apparire come tale, verso la
sfera fenomenale ma viene tracciata mediante termini che
provengono dalla sfera del soggettivo: non c’è una messa in
evidenza del campo fenomenale come tale ma c’è una riduzione
19
all’immanenza pura . La soggettività diventa per Husserl la fonte
di tutto ciò che appare e tale impostazione risulta agli occhi di
Patočka un ritorno a Descartes e alla certezza di sé della
20
coscienza . A questo punto per rintracciare la relazione tra ciò che
appare e l’apparire senza cadere nel soggettivismo e senza
eliminare il ruolo del soggetto, la radicalizzazione dell’epoché è la
via maestra che conduce Patočka all’individuazione di quell’a priori
senza il quale nessun ente pre-esistente potrebbe manifestarsi.
Tale a priori non costituisce la causa di ciò che appare e, pur
96
accompagnando la nostra esperienza, non può essere ridotto
all’esperienza stessa perché è assolutamente originario.
A questo punto vorremmo porre una domanda: che cosa
succederebbe se l’epochè non dovesse fermarsi davanti alla tesi
del proprio sé, ma fosse intesa in senso del tutto universale? In
un’epochè così concepita io non metto in dubbio l’indubitabile, il
cogito che pone se stesso. Solamente, io non mi servo di questa
tesi per così dire «automatica», non ne faccio alcun uso. Ma forse
è solo ritirandomi da questa tesi che mi diventa davvero
accessibile la tesi dell’io, nell’a priori che la rende possibile. Forse
l’immediatezza della datità dell’io è un «pregiudizio», e l’esperienza
di sé, proprio come l’esperienza della cosa, ha il suo apriori che
rende possibile l’apparire dell’io.
Husserl
aveva
concepito
l’epoché
come
quell’atteggiamento volontario della soggettività atto a mettere tra
parentesi il mondo naturale e le scienza per trovare un metodo che
cogliesse il senso puro del rapporto del soggetto con il mondo
fenomenico, senza includere la tesi del proprio sé. La
radicalizzazione dell’epoché operata da Patočka comporta invece
una messa tra parentesi della soggettività stessa, guadagnando
così uno spostamento dell’ego, un “arretrare” del soggetto che,
lungi dallo scomparire o dal fissarsi nel dubbio dell’esistenza di un
cogito produce l’effetto di eliminare l’assolutismo della coscienza
husserliana. In altri termini, la radicalizzazione dell’epoché
ripensata da Patočka, richiede una sottrazione del sé che non va
intesa come un’eliminazione del soggetto ma piuttosto come la
scoperta, da parte della coscienza, della propria finitezza, il
ritrovamento di quell’apriori che rende possibile la tesi dell’io e che
mostra qualcosa che lo precede e lo fa essere soggetto.
L’effetto di questa rinnovata interpretazione dell’epoché
consente, da un lato di procedere fino all’origine stessa della
manifestazione dell’essere - senza ricondurla ad un fondamento
ontico quale la coscienza assoluta – e, dall’altro, disloca la
soggettività rispetto alla necessità di un fondamento ultimo mentre
solleva il problema della relazione tra il soggetto e il mondo. Si
apre così una zona che è anteriore sia al soggetto che all’oggetto
che appaiono e che pone il problema delle condizioni di possibilità
97
dell’apparire a partire da questo movimento di arretramento della
soggettività. Patočka dunque, con la svolta asoggettiva, non
elimina il ruolo del soggetto ma lo subordina all’esigenza della
correlazione a priori in base alla quale solo rapportandosi al mondo
egli può rapportarsi al proprio sé e condurre la propria esistenza.
Tale relazione sarà guadagnata attraverso il concetto di spazio, di
spazialità originaria strutturata attorno alla declinazione plurale io21
tu-quello e attraverso i concetti di movimento, corpo e mondo che
in questa sede non possiamo affrontare. Il soggetto in questione
decentra la sua posizione e in questo arretramento, in questo
movimento il mondo si mostra, appare. In altri termini la
soggettività è un momento del mondo dell’apparire, è «ciò a cui
qualcosa appare» e la fenomenologia asoggettiva procede oltre il
22
soggetto, ricercando la struttura ultima dell’apparire .
Una struttura che dell’apparire, deve cioè basarsi su se
stessa, sulla propria autoreferenzialità. La stessa soggettività va
pensata come qualcosa che appare, come ciò che fa parte di una
struttura più profonda- il mondo come totalità, l’apparire- come una
certa possibilità appena abbozzata e indicata in questa struttura.
Con la proposta della fenomenologia asoggettiva Patočka non
intende dimostrare che sia possibile un apparire che non appare a
nessuno ma, in ogni caso, questo “qualcuno” non può esserne
l’autore, né il portatore. Colui che se ne fa carico è invece la
struttura dell’apparire e il referente di questa apparizione è un
momento e una parte integrante di questa configurazione
23
puramente fondamentale . In questo senso la “a” di “a-soggettivo”
pur designando un alfa privativo può essere interpretato, come
farebbe presupporre la riflessione filosofica di Patočka con un
24
valore allativo .
Il filosofo ceco ci ha condotto, infatti, nella direzione di una
soggettività che si muove arretrando e in questo suo incedere
all’indietro appare e contemporaneamente consente al mondo di
apparire ai suoi occhi. Questa impostazione farebbe quindi
pensare ad una soggettività che è allativa e non privativa perchè il
suo movimento è generativo e svelativo a partire dal suo
arretramento. Secondo questa lettura dell’asoggettività, la “a” che
introduce e conferisce una determinata connotazione all’aggettivo
98
“soggettivo” non assegnerebbe in questo caso un valore negativo
come previsto già nella declinazione greca del termine in cui
prevale l’accezione dell’alfa privativo. La parola “asoggettivo”
potrebbe a nostro avviso essere considerata non nei termini di un
annullamento del soggetto, di una sua rimozione, ma di un nuovo
movimento che precede, senza essere originario, il mondo e
compartecipa alla sua manifestazione. La soggettività così
ripensata nella sua forma di asoggettività, non ha infatti la funzione
di costituire il mondo ma rappresenta un carattere della sfera
fenomenica, ovvero il luogo in cui il mondo si mostra secondo
25
nuove modalità e prospettive . L’asoggetività segnala dunque
l’elaborazione di una rinnovata soggettività che non fonda ma
costruisce, non genera ma partecipa alla generazione e il cui
statuto risulta essere la posta in gioco più alta della fenomenologia
asoggettiva. Da un lato il fenomeno “soggetto” è un prodotto
dell’apparire del mondo, dall’altro il soggetto si distingue dagli altri
26
enti perché l’apparizione si dà solo se rivolta ad un soggetto . La
tematica del movimento del mondo è il tratto costitutivo di una
soggettività profondamente dinamica che è chiamata a essere
presente e a partecipare alla fenomenicità per creare sempre
nuove possibilità d’essere. Patočka rilancia dunque l’immagine di
un soggetto che è parte integrante e allo stesso tempo “specchio”
del mondo: il soggetto fa apparire il mondo senza essere però il
punto sorgivo di tale apparire e allo stesso tempo dipende da esso
27
in quanto ne fa parte .
1
Hegel ha in mente uno spirito soggettivo, «coscienza che si desta a se stessa» ai
suoi albori, coscienza dell’individualità dell’uomo che, per essere veramente se
stesso, deve negare se stesso come pura soggettività individuale e aprirsi agli altri,
diventando spirito oggettivo e, infine un soggetto che conosce se stesso come
luogo dell’unità di se stesso e dell’unità di sé con la sua essenza divina e infinita
elevandosi come soggetto assoluto, un «pensiero che pensa se stesso», un
soggetto nel quale Dio, attraverso tutte le forme della coscienza umana, diventa
cosciente di sé, Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, parte
terza, Filosofia dello spirito, Biblioteca Universale Laterza, 2002, cit., pp. 377-577.
2
L’uomo «è solo un’invenzione recente, una figura che non ha nemmeno due
secoli, una semplice piega nel nostro sapere e che sparirà quando sarà trovata una
forma nuova», M. FOUCAULT, Le parole e le cose, Rizzoli, Milano 1967, cit., pp. 413414.
99
3
La questione del “mondo” è fondamentale nell’indagine fenomenologica. Con
l’elaborazione della riduzione trascendentale Husserl introduce il mondo inteso
come intreccio intenzionale e luogo di esplicazione di ogni esperienza, orizzonte
che rende possibile ogni sapere e azione umana, «il mondo che è per noi, che nel
suo essere e nel suo essere-così è il nostro mondo, attinge il suo senso d’essere
esclusivamente dalla nostra vita intenzionale». E. HUSSERL, La crisi delle scienze
europee e la fenomenologia trascendentale, tr. it. a cura di E. Paci, Il Saggiatore,
Milano 2008, cit., p. 207. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al saggio di Vincenzo
Costa, Mondo, azione e storia in Jan Patočka, in cui la nozione di mondo diventa
cruciale per la comprensione dell’esistenza umana dal momento che ogni
manifestazione del mondo è un disvelarsi dell’essere che interpella l’uomo in modi
diversi, cit., V. COSTA, Mondo, azione e storia in Jan Patočka in V. MELCHIORRE,
Forme di Mondo, Vita e Pensiero, Milano 2004, cit., pp. 257-286
4
Vincenzo Costa ha mostrato come l’analisi fenomenologica condotta da Husserl
nelle Ricerche Logiche escluda l’idea di mondo in quanto la ricerca dell’evidenza si
limita ai rapporti causali che spiegano i fenomeni facendo riferimento solo alle
strutture fisico organiche. In questo senso, non essendoci un mondo non si dà
coscienza, non si dà soggetto che si rapporti a se stesso, non si dà un io. Con
l’introduzione della riduzione trascendentale l’unità dell’io e l’apparizione degli
oggetti non è più legata a rapporti causali ma dischiude l’orizzonte del mondo,
ovvero una totalità di relazioni di carattere fenomenologico, V. COSTA, La
fenomenologia tra soggettività e mondo, Leitmotiv 3/2002.
5
Il nucleo centrale della riflessione fenomenologica di Patočka ruota intorno
all’«essenza dell’apparire», J. PATOCKA, Papiers phénoménologiques, tr. fr. a cura
di E. Abrams, Millon, Grenoble, 1995, cit., p. 176.
6
La fenomenologia trascendentale risponde al tentativo husserliano di superare lo
sdoppiamento dell’obiettivismo e del soggettivismo, E. HUSSERL, La crisi delle
scienze europee e la fenomenologia trascendentale, cit., pp. 51-127.
7
Ivi, cit., pp. 297-309.
8
Dopo aver “messo tra parentesi” l’intero mondo naturale e le relative teorie
scientifiche, nel tentativo non di negarne la validità e verità ma, al contrario, di
trovare un metodo che cogliesse il senso puro del rapporto del soggetto con il
mondo fenomenico, Husserl scopre che «la coscienza in se stessa ha un suo
essere proprio che non viene toccato nella sua propria assoluta essenza dalla
fenomenologica messa fuori circuito. Essa quindi rimane come ʽresiduo
fenomenologicoʼ, come una regione dell’essere per principio peculiare, che può di
fatto diventare il campo di una nuova scienza – della fenomenologia», E. HUSSERL,
Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, tr. it. a cura di
V. Costa, Einaudi, Torino, 2002 cit., pp. 76-77.
9
Il nome deriva dal titolo “Introduzione alla Filosofia Fenomenologica” del corso
accademico tenuto da Patočka durante il suo ultimo anno di lavoro presso la
Univerzita Karlova v Praze. Tuttavia, secondo Miroslav Petříček tale cambio di rotta
non significa necessariamente una rinuncia al pensiero del maestro e, anche
l’apertura alla più innovativa versione heideggeriana della fenomenologia non deve
essere intesa come un allontanamento o semplicemente un superamento della
posizione husserliana ma piuttosto come il tentativo di elaborare, estendendole, le
due proposte fenomenologiche di Husserl e Heidegger, M. PETŘÍČEK, Jan Patočka:
100
Phenomenological Philosophy Today, in I. CHVATÍK – E. ABRAMS, Jan Patočka and
the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers, Springer, London New York
2011, cit., p. 4.
10
In particolare si rimanda a J. PATOČKA, Epoché e riduzione, tr. it. di A. Pantano,
“Aut-aut”, 299-300, cit., pp. 142- 151; si rimanda anche a J. PATOČKA, Qu’est-ce que
la phénoménologie? tr. fr. a cura di E. Abrams, Millon, Grenoble, 1988.
11
Il saggio è contenuto in J. PATOČKA, Che cos’è la fenomenologia? Movimento,
mondo, corpo.
12
Ibidem.
13
Rispetto alla proposta fenomenologica heideggeriana che in parte risolve,
secondo Patočka, alcune difficoltà dell’approccio trascendentale husserliano, il
filosofo ceco è ugualmente critico. Heidegger infatti avvia una completa
riformulazione della fenomenologia incentrata sui presupposti ontologici che non
sono stati indagati dalla fenomenologia husserliana ma, anche in questo caso,
Patočka scorge un limite: l’assenza dell’analisi del tema dell’apparire come tale, J.
PATOČKA, Che cos’è la fenomenologia? Movimento, mondo corpo, cit., p. 262.
14
J. PATOČKA, Platone e l’Europa, cit., p. 176.
15
«Io metto quindi fuori circuito tutte le scienze che si riferiscono al mondo naturale
e, per quanto mi sembrino solide, per quanto le ammiri, per quanto poco io pensi a
obiettare alcunché, non faccio assolutamente nessun uso di ciò che esse
considerano come valido», E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura e per una
filosofia fenomenologica, cit., p. 72.
16
J. PATOČKA , Che cos’è la fenomenologia? Movimento, mondo, corpo, cit. pp.285287.
17
E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia
fenomenologica, cit. pp. 45-55.
18
Patočka ha ampiamente trattato la tematica della differenza, individuata nel
concetto di chorismòs nel saggio Il Platonismo negativo. Qui il negativo non è un
polo che si oppone a un positivo ma indica piuttosto la differenziazione ed
eccedenza dell’apparire rispetto a ciò che appare, J. PATOČKA, Liberté et sacrifice.
Ecrits politiques. tr. fr. a cura di E. Abrams, Millon, Grenoble, 1990.
19
A tal proposito Ullman precisa: «The appearance and importance of the reduction
after the trascendental turn is a clear symptom of Husserl’s Cartesianism and of its
metaphysical residues. For Patočka , this Cartesianism originates in Husserl’s
confusion of subjectivity and phenomenality. At first, phenomenality was subjective
solely in the narrow sense that all phenomena appear to me, in this given
perspective, in this given aspect. It shifted, however, from this neutral position to a
central one, and subjectivity became the source of all that appears», T. ULLMAN,
Negative Platonism and the Appearance-Problem, in I. Chvatík – E. Abrams, Jan
Patočka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers, cit., p.76.
20
J. PATOČKA , Che cos’è la fenomenologia? Movimento, mondo, corpo,
Fondazione Centro Studi Campostrini, Verona, 2009, cit., p. 345.
21
La soggettività viene compresa a partire dal movimento dell’essere in via di
manifestazione aperto dal mondo, ovvero dalle possibilità di azione che ci
interpellano destando una direzione di senso, V. COSTA, La fenomenologia tra
soggettività e mondo, cit., pp. 269-270.
101
22
Alessandra Pantano utilizza l’espressione “dislocazione del sé” per indicare la via
che conduce alla conoscenza dell’apparire. Essa non si percorre a partire dal
soggetto ma, al contrario, «osservando la sfera fenomenica e ponendola quindi al
centro di un nuovo sguardo fenomenologico, si può accedere al senso della figura
della soggettività», A. PANTANO, Dislocazione. Introduzione alla fenomenologia
asoggettiva di Jan Patočka, Mimesis, Milano 2011, cit., p. 123.
23
J. PATOČKA, Che cos’è la fenomenologia? Movimento, mondo corpo, cit., pp. 279283.
24
Nella linguistica italiana l’«allativo» fa riferimento al caso grammaticale indicante il
moto verso un luogo esterno. Dal latino allātus, pp. di afferre, ovvero «portare
vicino», l’allativo è una formazione nominale tipica anche di alcune lingue uraloaltaiche che esprime un ravvicinamento senza penetrazione: per esempio,
nell’ungherese kert-hez, «presso il giardino»; hajó-hoz, «presso la nave», P.
SANTANGELO, Fondamenti di una scienza dell’origine del linguaggio e sua storia
remota; con miscellanea storico-linguistica, University of California, 1953, voll. 1214.
25
Ivi, cit., p. 14.
26
Ivi, cit., p.124.
27
J. PATOČKA, Che cos’è la fenomenologia, cit., p. 304.
102
ALBERT CAMUS E JEAN-PAUL SARTRE.
SENSO DELLA MISURA E MEDITERRANEITÀ
di Alessandra Peluso
Nel saggio, Camus descrive il senso del limite in maniera chiara nella figura del
dottor Rieux de L’homme revoltè, come lo è nel Le mythe de Sisiphe. L’assurdo è
un antidoto privilegiato contro ogni ebbrezza di onnipotenza, mentre in Sartre la
presenza dell’altro comporta un limite alla nostra libertà. Ma la libertà, per Sartre, la
si dimostra vivendo: non affonda radici in nessun luogo. Il filosofo algerino incarna i
valori del limite, della misura e della libertà nel pensiero meridiano decantato nelle
sue opere. Il Mediterraneo che potrebbe essere considerato uno spazio di salvezza
per l’uomo.
Dans l'essay, Camus decrive le sens du limi t en façon claire dans la figure du
docteur Rieux de L'homme Revolte', comment lui est Dans Le mythe de Sisiphe.
L'absurd est un antidote privilege' contre chaque forme de ebriete' de omnipotence,
lorsque en Sartre la presence de l'autre comporte un limit a notre liberte'. Mais la
liberte', pour Sartre, la se demontre en vivend: elle n' enfonce pas de racines en
auquin lieu. Le philosophe algerien incarne les valeurs du limi t, de la mesure et de
la liberte', dans le pensée meridien vante' dans ses oeuvres. La mediteranée qui
pourrait etre considere' un espace de salut pour l'homme.
In the essay, Camus describes clearly the sense of limit in the figure of Dr Rieux de
L'homme Revolte', like he is in 'Le mythe de Sisiphe'. The absurd is a favoured
antidote against every inebriation of omnipotence, whereas in Sartre the presence
of another one means a limitation to our freedom. But freedom, for Sartre, it is
shown, only living: it doesn't ground Its roots in nowhere. Algerian philosopher
personifies limit, mesure and freedom values in the meridian thought extoled in his
works. Mediterranean Who could be considered a savin space for man.
Il tema del «pensiero meridiano» si è riaffacciato timidamente nel
dibattito culturale negli ultimi decenni. Eppure ha avuto, nella storia
del pensiero occidentale, dei fautori importanti. Ha scritto
NOTE
Abstract
103
Aniello Montano, relativamente alla sostanza della cultura
filosofica contemporanea: «il Mediterraneo rappresenta nell’opera
di Camus il punto di origine e il punto di arrivo. Già nelle opere
giovanili il Mediterraneo era lo sfondo condizionante la vita dei suoi
abitanti. I poveri algerini, ma anche i cittadini di tutti gli altri paesi
rivieraschi, riuscivano ad essere sereni e pacatamente felici, o a
mitigare le sofferenze dovute alle loro condizione, grazie al
1
Mediterraneo» .
Diverso il discorso per Sartre, il cui nome viene
normalmente accostato a quello dell’algerino. Infatti Albert Camus
e Jean Paul Sartre sono accomunati nel pensiero filosofico
esistenzialista, pur essendo entrambi non disposti ad accogliere
etichette. Ambedue si trovano in un periodo in cui il mondo non
vive una situazione pacifica né di benessere. Siamo negli anni
delle guerre: conflitto e assolutismo sono le parole chiave.
Camus proviene da una famiglia di origine modeste, ma
non si sente affatto svantaggiato, tant’è che più tardi assegnerà
all’esperienza della povertà la funzione di una vera scuola di vita. A
tal proposito, infatti, scrive: «La povertà intanto non è mai stata una
disgrazia per me: la luce vi spandeva le sue ricchezze. Persino le
mie rivolte ne sono state illuminate. Quasi sempre, credo di poterlo
dire senza barare, furono rivolte per tutti e perché la vita di tutti
fosse elevata nella luce. Non è certo che il mio cuore fosse
disposto per natura a questa sorta di amore. Ma le circostanze mi
hanno aiutato. Per correggere una indifferenza naturale venni
messo a mezza strada fra la miseria e il sole. La miseria mi impedì
di credere che tutto sia bene sotto il sole e nella storia; il sole mi
2
insegnò che la storia non è tutto» .
È un filosofo, un letterato, un artista, uno scrittore dallo
stile cangiante: «Ho adottato la forma al soggetto all’argomento,
3
ecco tutto» . Ama l’arte come Sartre che considera l’opera d’arte
un fine assoluto. Essa - dice Sartre, riportando una affermazione di
Simone de Beauvoir - porta in sé la sua ragion d’essere, quella del
4
suo creatore e forse anche quella dell’intero universo .
Sartre proviene da una famiglia borghese, impegnato nelle
lotte politiche del suo tempo, protesta anche contro la guerra
104
d’Algeria. È alla continua ricerca, come Camus nel quale il dubbio
diviene l’elemento portante della sua vita.
L’ipotesi è di una messa a confronto, accomunati, a
dispetto della terribile disputa di natura politica che li porterà a
rompere definitivamente un rapporto di amicizia nato da giovani.
Accade infatti, alla fine del 1946, che Camus nella serie di
5
articoli Ni victimes ni bourreaux apparsi su Combat , scrive: «era
necessario cambiare la realtà, ma nell’opera di cambiamento, in un
mondo immerso nell’omicidio, ci si doveva decidere a riflettere
sull’assassinio e a scegliere tra coloro che accettano
rigorosamente di essere assassini e quelli che si rifiutano con tutte
le loro forze di esserlo». Alla tragica scomparsa di Camus, nel
gennaio 1960, Sartre scrisse di getto per il France-Observateur un
commosso ricordo: «Non andavamo d’accordo, io e lui: ma cos’è
un disaccordo? Non è nulla, solo un altro modo di vivere senza
6
perdersi di vista nel piccolo mondo stretto che ci è dato» . Si tratta
di un’ammenda interiore? O forse solo - come ha ben documentato
7
Olivier Todd nella sua ampia biografia Albert Camus, une vie
(Gallimard, 1996) - la prima delle contraddizioni in cui andò ad
arenarsi Sartre quando negli anni seguenti volle ricordare il suo
rapporto con Camus.
Camus purtroppo non è riuscito ad avere una giusta
collocazione nel pensiero filosofico, letterario e artistico del ‘900.
Nelle ultime pagine del L’homme révolté (1951) Camus tenta di
fornire una soluzione al problema della rivolta nella storia e di
riabilitarla come «valore fondatore d’umanità», contro le sue
deviazioni, aprendo la strada ad un’etica della misura oltre
l’idealismo morale e il realismo cinico: «Se la rivolta potesse
fondare una filosofia, questa sarebbe [...] una filosofia dei limiti,
8
dell’ignoranza calcolata e del rischio» .
Secondo Arnaud Corbic, filosofo e teologo francese,
Camus, dedicandosi ad una rilettura critica della dialettica
hegeliana del padrone e dello schiavo, pensa che la rivolta implichi
l’idea del limite. Tale limite è posto all’oppressione dalla rivolta
dello schiavo, ma è posto anche alla stessa rivolta quando lo
schiavo scopre che tutti gli uomini hanno pari dignità e quindi
riscopre, nel diritto degli altri alla rivolta, i limiti del proprio stesso
105
9
diritto . Emerge in parte la dialettica di Hegel, ma nel rapporto
dialettico Hegel, invece, riconosce la lotta per il riconoscimento e,
10
quindi, l’inversione dialettica dei mali . La libertà si realizza col
diritto.
Nulla di più contrastante è, per Canus, dell’hegelismo al
pensiero meridiano che, per il filosofo di Algeri, è il pensiero della
misura, presente sin dalla filosofia greca. In tal senso scrive
Montano: «La radice teorica primaria di questo estremo
soggettivismo e del conseguente occultamento del senso del
limite, Camus la individua nell’idealismo classico tedesco, in Hegel
in modo particolare. Questo idealismo fa tutt’uno con il pensiero
germanico, con l’ideologia tedesca considerata opposta alla
11
filosofia mediterranea» .
Nell’affermazione e riconoscimento del proprio diritto,
Camus riconosce il giusto limite nella rivolta, senza il quale si
cadrebbe nel disordine, si cadrebbe nella ipotesi che ad un
omicida tutto sia permesso. Mentre con Paul Ricoeur si può
riconoscere nella misura una rivolta di secondo grado, una rivolta
della rivolta contro il nichilismo.
Tuttavia Camus invoca la misura come valore della
mediazione e scrive: «Esistono dunque per l’uomo, un’azione e un
12
pensiero possibili a quel livello medio che gli è proprio» . È ciò
che il filosofo chiama pensiero meridiano.
L’idea di un pensiero meridiano è uno dei punti nei quali il
13
poliedrico intellettuale è profondamente influenzato da Nietzsche ,
14
come sosterrà anche Franco Cassano . Ed è difficile - aggiunge
Cassano - che lo stesso non si sia imbattuto nel fascino e nella
profondità del pensiero nicceano, nel “grande meriggio”, nella
riscoperta del sud come cura «dall’orribile chiaroscuro nordico,
dallo spettrale guazzabuglio dei concetti e povertà di sangue dove
il sole è assente». Chi ama il sud può invece trovare in esso come
«una grande scuola di risanamento, rispetto a quel che v’è di più
spirituale e di più sensuale, come un’incontenibile pienezza e
trasfigurazione solare, dilatantesi sopra un’esistenza sovrana e
15
colma di fede in se stessa» .
D’altro canto, Sartre, sulla dottrina della dialettica, afferma
che è un sapere puro e irrigidito, incapace di autocorreggersi,
106
16
perché ormai trasformato in dogma . La dialettica non concepisce
la ricerca e la cultura che diventa strumento critico nelle mani
dell’uomo nei confronti del mondo.
Simone de Beauvoir ricorda, nell’opera La force de l’âge,
che Sartre «detestava le routines e le gerarchie, le carriere, avere
regole da osservare e da imporre; [...] non avrebbe messo radici in
nessun posto, non si sarebbe mai gravato di un possesso: non per
17
conservarsi oziosamente disponibili ma per sperimentare tutto» .
Una volta sperimentato che l’uomo è un ente del mondo, come l’io
di un altro, è l’essere la cui apparizione fa sì che esista un mondo.
Ma il mondo non è l’esistenza, e quando l’uomo non ha più scopi, il
mondo resta privo di senso. Questa tesi è espressa da Sartre in La
18
nausée , dove l’autore contrappone l’assurdo ai valori positivi
della filosofia classica.
Il concetto di assurdo diviene positivo quando l’uomo
riconosce la sua libertà. Nel pensiero di Camus l’assurdo è
psicologicamente un’esperienza di impotenza e umiliazione come
in Sartre. Il suo gusto è irrimediabilmente amaro, suoi colori sono
19
di cenere o di sangue . È la finitudine umana sofferta e subìta. È il
dolore che gli uomini attraversano nelle opere di Camus come Il
mito di Sisifo, Lo straniero, La peste, dove si assiste ad una chiara
immagine dell’assurdo rappresentata dalla sofferenza atroce e
dalla morte dei bambini.
Occorre dire che gli uomini di Camus, pur vivendo
nell’assurdo, senza speranza, non sono disperati perché
riconoscono il “peso della libertà”, l’unico vero inflessibile padrone
dell’uomo. Nell’uomo di Camus, come nel singolo di Kierkegaard e
nel superuomo di Nietzsche, si verifica quel processo di
esasperazione dell’esperienza individualistica come nell’unico di
Stirner o nell’eroe di Wagner, tant’è che Bobbio considera questo
modo di concepire l’individuo come tipico della crisi
20
esistenzialistica . Tuttavia, secondo Camus, si tratta di recuperare
non solo l’individuo, ma la specie, e quindi assumere l’ideale di
21
«superumanità» per assicurare la salvezza di tutti .
Il senso del limite è chiaro nella figura del dottor Rieux de
L’homme révolté, ma lo è ancor prima nel Le mythe de Sisiphe:
107
l’assurdo è un antidoto privilegiato contro ogni ebbrezza di
onnipotenza, non si configura come una sconfitta.
Sartre parimenti osserva che noi ci conosciamo nello
sguardo dell’altro. L’altro, quindi, toglie la nostra libertà sino al
limite dell’alienazione (diventare dell’altro), ma anche fonda la
22
nostra libertà come limite . E nella categoria del limite riluce
nitidamente la libertà anche nel pensiero di Camus.
Sartre valorizza la «condanna alla libertà» proprio
radicalizzando la prospettiva etica. L’uomo è «condannato perché
non si è creato da solo, ed è, nondimeno, libero perché, una volta
23
gettato nel mondo, è responsabile di tutto quanto fa» . C’è
responsabilità, quindi, e una nuova morale della responsabilità che
è quella del rispondere in prima persona di noi stessi e degli altri.
Non esiste la Provvidenza nel pensiero sartriano né in
quello di Camus. C’è la storia costruita dai soggetti e quella storia
deve essere tessuta di valori. Dalla critique de la raison dialectique
alla critique de la raison éthique. Le teologie filosofiche avevano
inevitabilmente sottolineato il nesso tra libertà divina e bene.
Descartes, Leibniz, Spinoza sono assunti da Sartre come precisi
punti di riferimento. Nei Cahiers pour une morale, opera
incompiuta ed apparsa postuma nel 1983, Sartre coglieva in
Descartes un salto: «La libertà supplicata non è, come il Dio di
Leibniz, sottomessa al Bene [...] ma, come quella di Descartes,
24
costituente il Bene» .
Nell’esistenzialismo ateo, «che io rappresento», affermava
Sartre, «c’è almeno un essere in cui l’esistenza precede l’essenza,
un essere che esiste prima di poter essere definito da alcun
concetto: quest’essere è l’uomo, o, come dice Heidegger, la realtà
25
umana» . Non c’è uomo che non preceda la propria definizione;
egualmente è per la natura, perché per il pensatore tedesco non
c’è un Dio che concepisca, prima del loro essere, uomo e natura.
Quindi il sé dell’uomo non può definirsi che a posteriori. Noi «ci
siamo» come fatto originario e ingiustificabile. L’essenza viene
dopo ed è costruzione e proiezione.
Camus sembra identificare la Provvidenza con l’amore,
riconosce l’amore come necessità per ogni individuo per godere
del rispetto e della libertà. Egli, infatti, afferma che l’amore non può
108
essere vissuto se non nel modo radicale, cioè del disinteresse e
della gratuità assicurati dall’assenza di ogni trascendenza in una
26
lotta senza speranza . E non a caso traspare questo sentimento
che permea tutta l’opera di Camus, lungi dall’essere il risentimento
o, peggio, il pessimismo, ma è senza dubbio l’amore: amore
contemporaneamente profondo e incolmabile quanto lucido e
realista; è l’amore di chi si rifiuta di mentire e, allo stesso tempo, di
27
darsi per vinto . Inoltre, recupera una serie di valori quali l’amicizia
come virtù, la sincerità, il rifiuto di salvarsi da soli e il gusto di
essere felici insieme agli altri, il rispetto della “natura umana” in tutti
gli uomini. Questi valori che sembrano avvicinarlo, come afferma
28
Montano, a Maritain, Mounier e Péguy .
Tuttavia, Camus si definisce anche il filosofo del diritto e
del rovescio, del limite e della libertà, della misura e della
dismisura, di queste contraddizioni che permangono nell’uomo e
vengono riconosciute come positive. Camus stesso rappresenta
tutto questo nel suo pensiero meridiano e raffigura tale antinomia
nei due poli del continente europeo, nella loro vita e cultura: il nord,
pervaso dall’ideologia storicistica di formazione tedesca, e il sud
dallo spirito mediterraneo. Nel primo egli vede rappresentata la
“dismisura”, nel secondo la “misura”, le quali si sono contrastate in
un processo iniziatosi anticamente e durato fino ai nostri giorni.
Nell’uomo mediterraneo, come compresenza e interazione degli
opposti, intravede la sola via perché l’umanità recuperi il proprio
vero essere e continui ad esistere.
La misura, nata dalla rivolta, non può viversi né
sperimentarsi se non mediante la rivolta. È il costante conflitto,
perpetuamente suscitato e signoreggiato dall’intelligenza che non
trionfa dall’impossibile né dall’abisso. Si adegua ad essi.
Qualunque cosa facciamo - afferma Camus - la dismisura serberà
sempre il suo posto entro il cuore dell’uomo, nel luogo della
solitudine. Tutti portiamo in noi il nostro ergastolo, i nostri delitti e le
nostre devastazioni. Ma il nostro compito non è quello di scatenarli
attraverso il mondo; sta nel combatterli in noi e negli altri. La
rivolta, la secolare volontà di non subire, ancor oggi è al principio di
questo combattimento. Madre delle forme, sorgente di vita vera, ci
29
tiene sempre ritti nel moto informe e furioso della storia .
109
Rivolta e misura, misura e dimensione umana, dimensione
umana e naturalità e solarità e mediterraneità. In sé e per sé
l’uomo moderno, sulle tracce dell’antico, avrebbe dovuto cercare i
mezzi per liberarsi ed unirsi ad un’umanità pur essa liberatasi.
Questo doveva avvenire all’insegna di una rivolta illuminata da
quella luce mediterranea, nella quale egli avrebbe ritrovato i suoi
eterni ed inconfondibili contorni. Come agli albori l’antica umanità,
così ora la moderna era chiamata a trarre dal Mediterraneo la sua
origine, libertà ed unità nella diffusa coscienza della propria
30
“misura” .
Quindi occorre un gioco di contemperamento del no con il
sì da cui “emerge il concetto cardine di pensiero meridiano, vale a
dire il concetto di misura. Concetto che Camus trova già
perfettamente elaborato emesso a punto in non pochi pensatori
31
dell’antichità classica, attivi nei paesi del Mediterraneo” .
È evidente l’ispirazione poetica nella descrizione del sud,
del Mediterraneo che identifica con la sua Algeri, dove sostiene di
aver vissuto a metà strada tra la miseria e il sole, nella quale sono
le radici della rivolta e della misura: «La miseria mi impedì di
credere che tutto sia bene sotto il sole e nella storia; il sole mi
insegnò che la storia non è tutto. Cambiare la vita, sì, ma non il
32
mondo di cui facevo la mia divinità» .
Questa presenza del sole e della luce avrebbe regalato a
Camus la “felice immunità” dal risentimento e dall’invidia, la
bellezza generosa della natura lo ha per sempre liberato dalle
patologie della mimesi. Il suo ideale positivo della vita lo si può
intravedere anche in questo, dove i beni più importanti sono
accessibili a tutti e non sono solo di qualcuno, allora qui è possibile
33
controllare l’invidia . Il sud di Camus è profondamente trasformato
e sembra essersi liberato da una vergogna della povertà.
Probabilmente è un idillio, è poesia, considerare la “povertà felice”,
oppure poteva essere sperimentata solo in alcune zone privilegiate
del sud in cui la terra incontra il mare.
Pertanto, è proprio qui, nella consapevolezza della miseria,
nella propria tradizione, nelle proprie radici che egli non rinnega,
che si può comprendere la rivolta libertaria di Camus. Dal
Mediterraneo rinasceva una razza, un’Europa, un'anima nuova,
110
che avrebbe dovuto rinnovare il mondo nella rinnovata coscienza
della sua dimensione umana.
Il male, dunque, persiste autonomamente nella sua
essenza insensata e tumorale, sordo ai lamenti umani, cieco al
sangue versato irreparabilmente. Camus insegna che nel cuore del
reale, oltre e contro il male, ci sia l’uomo e la sua capacità di
amare. Egli è l’unico responsabile del bene, l’unico essere che con
la sua rivolta è capace di porre rimedio, quanto più possibile, ad
una condizione intrinsecamente ingiusta e dolorosa. Sicché, anche
nel buio più totale delle guerre e degli olocausti, deve sempre
riemergere dal fondo degli animi abbattuti quel «sole invincibile»
capace di scacciare le tenebre del male - siano esse connaturate
al reale, siano esse prodotte dagli uomini stessi.
Inoltre, Camus ribadisce che la libertà per essere tale non
può essere senza limiti. «Solo i tiranni possono esercitare la
libertà senza limiti; e, per esempio, Hitler era relativamente un
uomo libero, l’unico d’altronde di tutto il suo impero. Ma se si vuole
esercitare una vera libertà, non può essere esercitata unicamente
nell’interesse dell’individuo che la esercita. [...]. La libertà esiste e
ha un senso e un contenuto solo nella misura in cui viene limitata
dalla libertà degli altri. Una libertà che comportasse solo dei diritti
34
non sarebbe una libertà, ma un’onnipotenza, una tirannia» .
Sartre, come Camus, privilegia la libertà. Nell’opera L’Être
et le Néant la libertà nei riguardi dell’altro è intesa come rapporto e
come scelta. Abbagnano sottolinea che la libertà sartriana diventa
essa stessa giustificazione di ogni scelta possibile, dato che
“l’uomo non può scorgere, dentro e fuori di sé che mere possibilità,
35
ognuna delle quali implica una minaccia e un rischio” .
36
Anche Sartre ama il sud, e diviene un turista “engagé” come lo definisce Montano - dell’Italia. Il nostro Paese che appare
come una sorta di paradigma positivo su cui realizzare le sue idee.
Era stato colpito soprattutto dalla cultura, dalla duttilità ideologica
degli intellettuali del tempo, dalle bellezze barocche, da città come
Napoli, Venezia, Roma e dal barocco di Lecce e della Sicilia.
Sartre lo si è definito un filosofo post-moderno, per la sua
37
diffidenza nei confronti delle totalizzazioni ; un portatore di una
modernità nata dal “disincanto del moderno”, non da intendersi per
111
il modo di negare ogni pretesa universalistica e stabilizzante
38
dell’estetica, della storia, della politica e dell’etica .
Sartre, riprendendo il concetto di libertà, evidenzia il suo
fallimento, dal momento che la libertà è fondata sull’angoscia che
attanaglia l’uomo nel vivere la sua esistenza come una libertà
falsa, basata sul nulla. Infatti scrive:
Questa libertà, che si rivela nell’angoscia, può caratterizzarsi con
l’esistenza di quel niente che si insinua tra i motivi e l’atto. Non già perché
sono libero, il mio atto sfugge alla determinazione dei motivi, ma, al
contrario, il carattere inefficiente dei motivi è condizione della mia libertà.
E se si domanda qual è questo niente che fonda la libertà, risponderemo
che non si può descriverlo perché non è, ma si può almeno indicarne il
senso, in quanto questo niente è stato per l’essere umano nei suoi
rapporti con se stesso. Corrisponde alla necessità per il motivo di non
apparire come motivo altro che come correlazione di una coscienza del
motivo. In una parola, poiché rinunciamo all’ipotesi dei contenuti di
coscienza, dobbiamo riconoscere che non vi sono motivi nella coscienza
ma solo per la coscienza. E per il fatto stesso che il motivo non può
sorgere come apparizione, si costituisce da sé come inefficace.39
Simone de Beauvoir afferma che «parlando con lui
intravedeva nella teoria della contingenza la sua ricchezza» e
40
avrebbe avuto un’ottima intuizione dato il seguito delle sue opere .
Sartre considera la storia come un movimento esplicantesi
esclusivamente nella dimensione mondana e nella più assoluta
contingenza. La storia, secondo Sartre, è assolutamente priva di
una direzione necessaria e prevedibile e ha rivendicato
all’individuo il ruolo di protagonista degli eventi storici, contro lo
41
Spirito di Hegel o le classi in lotta di Marx .
La storia è libertà, è originariamente contingente, possibile,
casuale. È creazione e di conseguenza ogni avvenire è
42
imprevedibile in rapporto ad ogni presente . Così, afferma Sartre,
non è la dialettica a spiegare la Storia, ma è la Storia che si
43
rinchiude su ogni dialettica e l’assimila . Il vero principio motore
della Storia che per Sartre appunto è l’alterità, è più ampio della
44
dialettica e la avvolge .
Il concetto hegeliano di dialettica, come anche quello
marxista, diventa l’obiettivo privilegiato della critica sartriana.
Sartre, nonostante le critiche, dimostra ampio interesse verso le
112
posizioni di Hegel e Marx: ad Hegel riconosce il merito di aver
compreso che la dialettica è prerogativa essenziale ed esclusiva
della realtà umana, pur non avendo prestato attenzione agli
“elementi passivi” della storia come il lavoro, mentre, per lui, Marx
ha rivolto grande attenzione al lavoro, ma ha considerato la
dialettica come un processo svolgentesi su un piano differente
dalla coscienza.
In sostanza, riprendendo il concetto di libertà e
dell’individuo che è libero e si riconosce tale rispetto all’altro,
occorre constatare l’analogia del concetto di limite tra Sartre e
Camus che è ribadita proprio nell’agire di ogni individuo rispetto
all’altro. Occorre una misura morale tutta umana - come si legge
ne I fratelli Karamazov di Dostoevskij - incentrata sulla difesa degli
innocenti e sull’incremento della libertà dei singoli. Vero è che
Sartre conduce l’individuo ad una situazione di “scacco” proprio
perché libero, mentre Camus ne L’uomo in rivolta cerca di risolvere
45
questo assurdo con la solidarietà tra gli uomini . Come l’ultimo
Sartre farà con il valore della fraternità.
Le cose del mondo sono gratuite e un valore non è
superiore ad un altro. Le cose sono prive di senso e fondamento, e
le azioni degli uomini sono senza valore. La vita è un’avventura
assurda, dove l’uomo si proietta di continuo al di là di se stesso,
46
come per voler diventare Dio . In un certo senso, Sartre sembra
accettare l’assurdo e ciò che concerne la vita dell’individuo
nell’assurdo, ciò che invece non fa Camus vedendo anche, come
detto poc’anzi, in questa condizione una positività necessaria per
l’uomo ad affermarsi e vivere.
In Le mythe de Sisiphe si chiede il filosofo algerino “se la
vita valga o no la pena di essere vissuta” e risponde con un
quesito: «assodato che non si può uscire dal male, si tratta di
sapere se è possibile o no trovare una soluzione che ci sottragga
al nichilismo disperante e alla conseguente scelta del suicidio di
47
fronte all’assurdo della vita» . Camus risolve questo quesito con la
“rivolta”.
L’uomo in rivolta è l’uomo consapevole di «essere» solo
48
nello sforzo di dare un senso alla propria vita . Una volta scoperto
che il mondo non è governato da una razionalità interna, né da una
113
divinità provvidente, l’uomo in rivolta dovrà riconoscere “che il
mondo non persegue alcun fine” e che, pertanto, è inutile sia
inveire contro di esso sia aspettarsi da esso una risposta al nostro
bisogno di felicità. Al rifiuto del mondo o all’insana speranza e
fiducia in esso bisogna sostituire “un’adesione intera ed esaltata a
49
questo mondo”, una decisiva volontà di essere ciò che si è .
Ebbene l’individuo prende consapevolezza contro
l’assurdo sull’uguaglianza dei destini e sviluppa una forte
solidarietà. L’uomo in rivolta, animato da uno spirito di solidarietà,
supera l’esperienza individuale, condividendone la sofferenza. E
se Nietzsche attua la trasmutazione dei valori ritornando all’origine
del pensiero occidentale, ai Presocratici, allo stesso modo fa
Camus, riferendosi a quello che definisce il pensiero meridiano,
acclamando la purezza del Mediterraneo, dei Greci in particolare, e
adotta il concetto di misura perchè è soprattutto qui che vede
realizzarsi la solidarietà tra gli esseri umani e l’accomunarsi dei
destini.
La metriotes, l’ideale della misura lo si trova già in
Pitagora, e dopo nei versi di Orazio che decanta la medietas,
ispirandosi ad Aristotele che propugnava la mesotes. Secondo il
filosofo, il giusto mezzo è la via migliore da raggiungere per avere
50
una vita giusta, virtuosa e saggia .
Il senso della misura diventa indispensabile anche per
Camus. Il “giusto mezzo” permette di realizzare non solo il dominio
delle proprie passioni, dei propri desideri, ma di stabilire dei
rapporti corretti nella città. È la regola, la stessa che afferma il
“buon nichilismo” rappresentato, appunto, nelle opere Le mythe de
Sisiphe e L’homme révolté, dal Mediterraneo. Nel Mediterraneo,
Camus vede una miniera di saggezza, capace di suggerire i
modelli teorici e pratici, utili a far sperare e a fornire la possibilità di
salvaguardare l’uomo e la vita come valori e rendere possibile la
speranza nella felicità, per quanto Camus sia consapevole che la
51
speranza sia debole ma realizzabile .
Nel limite o nel senso della misura è radicato un diritto
inalienabile che appartiene ad ogni essere umano e che è la
libertà. Quando Camus parla di libertà specifica contro ogni forma
di assolutismo, si tratta di una libertà relativa, non assoluta, ossia
114
di una libertà che comporta nel limite dell’altro il diritto a rispettare
l’altro e ad essere solidale e caritatevole. Se si ama se stessi, si
ama anche l’altro e lo si rispetta comportandosi come faremmo con
noi stessi, evitando il male.
Questa considerazione sembra analoga ad una forma di
imperativo kantiano o, meglio, cristiano, più consona al
comandamento: “Ama il prossimo tuo come te stesso”. Dove infatti
c’è l’affermazione della libertà assoluta c’è la negazione di ogni
valore e dove c’è l’affermazione di un valore assoluto c’è la
negazione di ogni libertà.
Pertanto, Camus ribadisce la necessità della libertà e
dell’onore senza i quali non si potrebbe vivere. La libertà è
necessaria per lottare, per la rivolta, per affrontare la peste: in ogni
condizione l’uomo deve essere libero e sarà felice di immergersi
52
nel cinico mare del vivere, nell’ondosa indifferenza del reale .
Gilles Deleuze, nell’Épuisé, distingue due categorie che
calzano alla perfezione parlando di Camus e di Sartre: lo stanco
(potrebbe essere l’uomo dipinto da Camus) e l’esausto (potrebbe
essere l’uomo dipinto da Sartre). Lo stanco, pur essendo stanco,
ha delle possibilità che sono esigue, ma ci sono. L’esausto, invece,
ha esaurito il possibile o, meglio, il possibile non è neppure più una
categoria. Lo stanco fa fatica a realizzare, l’esausto non può
53
neppure più possibilizzare .
Mentre, lo scrittore e filosofo francese, Michel Onfray
scrive a proposito della personalità di Camus: «Camus è il
libertario per eccellenza, un grande filosofo perchè non fu un
prodotto dell’Università, ma un autodidatta. Camus incarna la
tradizione del pensiero libero, indipendente, autonomo, padrone di
sé, un uomo che non dipende dalla tribù, che non si costruisce
guardandosi nello specchio della storia, che non deve niente a
nessuno, che si è costruito da solo, senza i vantaggi degli
ascensori tribali parigini, ma vivendo sotto l’occhio di un padre
assente depositario dei valori della gente semplice e modesta: la
54
verità e l’equità che è giustizia» .
In conclusione, si potrebbe in sostanza dire che il
Mediterraneo ripensato da Camus è un’offerta, un opportunità per
un’umanità in pieno naufragio in un oceano senza punti di
115
riferimento. Sono i valori del limite, della misura e della libertà
incarnati nel suo pensiero meridiano che Camus vorrebbe vedere
trionfare ed estendere a tutti e a tutto, per “procedere verso l’unità
senza rinnegare le origini”.
1
A. MONTANO, Camus e il pensiero meridiano, in Sermo civilis. Note di etica
pubblica tra storia e vita, Delta 3, Grottaminarda 2012, p. 269.
2
A. CAMUS, L’Envers et l’endroit. Noces. L’Été (1939-1953), Gallimard, Paris 1958,
p. 6; A. Camus, Il rovescio e il diritto, in Saggi letterari (1939-1953) , tr. it. di S.
Morando, Bompiani, Milano 1960, ed. aggiornata 2000, p. 9.
3
Ivi, p. 14.
4
Cfr. S. DE BEAUVOIR, La force de l’âge (1929), Gallimard, Paris 1960, p. 26 e s.,
ed. aggiornata 2002; S. De Beauvoir, L’età forte, tr. it. a cura di B. Fonzi, Einaudi,
Torino 1979, p. 10 e ss.
5
Cfr. A. CASTRONUOVO, Albert Camus. Il lessico della rivolta, Stampa Alternativa,
Roma 2011.
6
ID., Un’episodio emblematico d’intolleranza intellettuale: Jean-Paul Sartre e il
processo ad Albert Camus, «Bibliomanie, Ricerca umanistica e orientamento
bibliografico», 29, aprile/giugno, 2012.
7
Ibidem..
8
A. CAMUS, L’homme révolté (1951), Gallimard, Paris 1951, p. 32, ed aggiornata
2011; ID., L’uomo in rivolta, tr. it. L. Magrini, Bompiani, Milano 1960, p. 34.
9
Cfr. A. CORBIC, Albert Camus e Dietrich Bonhoeffer. Due visioni dell’uomo «senza
Dio» a confronto, tr. it. a cura di U. Sartorio, Edizioni Messaggero, Padova 2011, p.
74.
10
Cfr. G.-W.-F. HEGEL, Wissenschaft der phänomenologie des geistes (1807),
Gebhardt, München 1969; G.-W.-F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, tr. it. a cura
di V. Cicero, Rusconi, Milano 1995.
11
A. MONTANO, Camus e il pensiero meridiano, cit., p. 271.
12
A. CAMUS, L’homme révolté, cit., p. 359; A. Camus, L’uomo in rivolta, cit., p. 329.
13
Cfr. F. NIETZSCHE, Die fröhliche Wissenschaft (1882), Werke in dreï Bänden,
München 1954; F. Nietzsche, La gaia scienza, tr. it. a cura di G. Colli, F. Masini,
Adelphi, Milano 1991, p. 170 e ss.
14
Cfr. F. CASSANO, Il pensiero meridiano, Laterza, Bari 1999.
15
Ivi, p. 94 e ss.
16
Cfr. J.-P. SARTRE, Critica della ragion dialettica (1960), tr. it. a cura di P. Caruso,
I, Il Saggiatore, Milano 1963, p. 206 e ss.
17
S. DE BEAUVOIR, La force de l'âge, cit., p. 17; S. De Beauvoir, L’età forte, cit., p.
20.
18
J.-P. SARTRE, La nausée (1932), Gallimard, Paris 1938, ed. aggiornata 2005, p.
246 e s; ID., La nausea, tr. it. a cura di B. Fonzi, Einaudi, Torino 1965, ed
aggiornata 2005, p. 140 e s.
116
19
Cfr. A. CAMUS, Le mythe de Sisiphe. Essai sur l’absurde (1942), Gallimard, Paris
1942, p. 73 e ss.; A. Camus, Il mito di Sisifo, tr. it. a cura di C. Rosso, A. Borelli,
Bompiani, Milano 2011, p. XIV.
20
Cfr. N. BOBBIO, La filosofia del decadentismo, Chiantore, Torino 1944.
21
Cfr. A. MONTANO, Solitudine e solidarietà. Saggi su Sartre, Merleau-Ponty e
Camus, Bibliopolis, Napoli 2006, p. 15.
22
Cfr. G. INVITTO, Sartre. Dal “Gioco dell’essere” al lavoro ermeneutico, II ed.,
FrancoAngeli, Roma 2005, p. 63.
23
Ibidem.
24
J.-P. SARTRE, Cahiers pour une morale (1947-1948), a cura di A. Elkaïm-Sartre,
Gallimard, Paris 1983, p. 226; ID, Quaderni per una morale, tr. it. a cura di F.
Scanzio, Edizioni Associate, Roma 1991, p. 401.
25
ID., L’Existentialisme est un humanisme, Nagel, Paris 1960, p. 21; J.-P. Sartre,
L’esistenzialismo è un umanismo (1946), tr. it. a cura di G. M. Re, Mursia, Milano
1971, ed. aggiornata 2010, p. 34.
26
Cfr. A. CAMUS, Taccuini: maggio 1935 -febbraio 1942, II, tr. it. E. Capriolo,
Bompiani, Milano 1963, p. 65.
27
Cfr. G. GAETANI, Oltre il nichilismo: il «sole invincibile» di Albert Camus, «Rivista
telematica di filosofia», in http://mondodomani.org/dialegesthai/, 12 agosto 2010.
28
Cfr. A. MONTANO, Solitudine e solidarietà. Saggi su Sartre, Merleau-Ponty e
Camus, cit., p. 15.
29
Cfr. A. STANCA, Camus: “l’uomo mediterraneo”, in Filosofare dialogando. Studi e
testimonianze per Angelo Prontera, a cura di A. Calì, J. F. Durand, M. Forcina, P. I.
Vergine, Milella, Lecce 2002, p. 617 e ss.
30
Cfr. Ibidem.
31
A. MONTANO, Camus e il pensiero meridiano, cit., p. 267.
32
A. CAMUS, L’Envers et l’endroit, cit., p. 70; A. Camus, Il rovescio e il diritto, cit., p.
77.
33
Cfr. F. CASSANO, Il pensiero meridiano, cit., p. 99.
34
A. CAMUS, L’avenir de la civilisation européenne (1955), Gallimard, Paris 2008; A.
Camus, Il futuro della civiltà europea, tr. it. A. Bresolin, Castelvecchi, Roma 2012, p.
39.
35
N. ABBAGNANO, Esistenzialismo positivo, due saggi, Einaudi, Torino 1948, p. 33.
36
Cfr. A. MONTANO, Solitudine e solidarietà, cit., p. 87.
37
Cfr. W. L. MCBRIDE, Sartre e il postmodernismo, «Segni e comprensione», 16,
1992, p. 21 e ss.
38
Cfr. A. MONTANO, Il disincanto della modernità. Saggi su Sartre, La Città del Sole,
Napoli 1994, p. 18 e ss.
39
J.-P. SARTRE, L'Être et le néant: Essai d'ontologie phénoménologique (1943),
Gallimard, Paris 2004, p. 323; J.-P. Sartre, L’Essere e il nulla: saggio di ontologia
fenomenologica, tr. it. G. Del Bo, a cura di F. Fergnani, M. Lazzari, Il Saggiatore,
Milano 2008, p. 69 e s.
40
Cfr. F. PAPI, L’ingresso di Sartre in Italia, in G. Invitto, Fenomenologia ed
esistenzialismo in Italia, Adriatica Editrice Salentina, Lecce 1981, p. 116 e ss.
41
Cfr. A. MONTANO, Solitudine e solidarietà. Saggi su Sartre, Merleau-Ponty e
Camus, Bibliopolis, Napoli 2006, p. 22; si confronti in particolare G. Invitto, Sartre.
Dal “gioco dell’essere” al lavoro ermeneutico, FrancoAngeli, Milano 2012.
117
42
Cfr. J.-P. SARTRE, Cahiers pour une morale, op. cit.
Cfr. Ivi.
44
Cfr. Ivi.
45
Cfr. A. MONTANO, Solitudine e solidarietà, cit., p. 61.
46
J.-P. SARTRE, L'Être et le néant, cit., 323 e ss.; J.-P. Sartre, L’Essere e il nulla, cit.,
p. 70.
47
A. CAMUS, Il mito di Sisifo, cit., p. 39 e s.
48
Cfr. ID., L’homme révolté, cit., p. 25.
49
Cfr. Ibidem.
50
Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, I (A), 2-3, 1094 a-b, tr. it. a cura di C.
Mazzarelli, Bompiani, Milano 2000, p. 4 e ss.
51
Cfr. A. MONTANO, Solitudine e solidarietà, cit., p. 62.
52
Cfr. A. CAMUS, Le mythe de Sisiphe, p. 65; A. Camus, Il mito di Sisifo, cit., p. XXI.
53
Cfr. G. DELEUZE, L’épuisé (1944), Ed. de Minuit, Paris 1992; G. Deleuze,
L’esausto, tr. it. a cura di G. Bompiani, Cronopio, Napoli 2005.
54
M. ONFRAY, Intervista su Camus, Rivista «Magazine Littéraire», n. 520, giugno
2012. Si veda anche M. ONFRAY, L’ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert
Camus, Flammarion, Paris 2011.
43
118
IL RESPIRO DEL BOSCO È IL RESPIRO DELLA VITA,
L’UOMO ALBERO NELLA SOCIETÀ.
DA THOREAU A FERRAROTTI
di Cristina Manzo
Essere filosofi non significa soltanto avere pensieri acuti, o fondare una
scuola, ma amare la saggezza tanto da vivere secondo i suoi dettami:
cioè condurre una vita semplice, indipendente, magnanima e fiduciosa
. […] Andai nei boschi perché volevo vivere in profondità e succhiare
tutto il midollo della vita
[…] per non scoprire in punto di morte di non aver mai vissuto.
Henry David Thoreau
119
Abstract
La dottrina del bosco è antica quanto la storia dell’uomo. Nell'immaginario comune,
ai diversi livelli della formazione culturale e della competenza letteraria, attorno
all'immagine del bosco si coagula una serie di connotati e suggestioni tutto
sommato simili e comuni, che spaziano fra un'idea positiva, quella di contesto
ambientale rigoglioso, brulicante di vita e incontaminato, gradevole e riposante, e
un'idea negativa, di luogo oscuro e misterioso, di entità impenetrabile, inquietante,
ostile. Ma c’è anche chi, come Franco Ferrarotti, decano dei sociologi italiani,
nonché professore emerito di sociologia, presso la facoltà La Sapienza di Roma, ha
assegnato al bosco e al suo respiro, un posto significativo nell’esistenza umana,
riconoscendogli il merito altissimo di alimentare la vita, e di essere vita. Così come
Thoreau quando afferma che lo studioso che ha solamente armi letterarie è
incompleto, che egli deve infatti “imparare” la lingua della natura, ma bisogna
andare oltre la speculazione filosofica e dottrinale, Ferrarotti sostiene che l’uomo
deve essere “pratico”, vivere la realtà della natura per comprenderla e comprendere
se stesso, fino a desiderare come nel suo caso di poter rinascere albero, e
assicurarsi così l’immortalità che è negata agli uomini.
La doctrine de la forêt est aussi vieux que l'histoire humaine. Dans l'imaginaire
populaire, les différents niveaux de la compétence culturelle et littéraire, autour de
l'image de la forêt coagule un certain nombre de connotations et des suggestions
tout en tous semblables et communs, se situant entre une idée positive, celle d'un
environnement verdoyant, grouillant de vie et immaculée, calme et reposant, et une
vue négative des sombres et mystérieuses entités, impénétrables, effrayant,
hostiles. Mais il ya ceux qui, comme Franco Ferrarotti émérite, doyen des
sociologues italiens, et professeur de sociologie à la faculté de Rome La Sapienza,
affecté à la forêt et son souffle, une place centrale dans la vie humaine, tout en
reconnaissant le bien-fondé élevée pour maintenir la vie, et la vie d'être. Comme
Thoreau quand il dit que le seul universitaire armes littéraire qui est incomplet, en
fait, qu'il doit "apprendre" le langage de la nature, mais nous devons aller au-delà
de la spéculation philosophique et doctrinal Ferrarotti considère que l'homme doit
être «pratique», vivre la réalité de la nature pour comprendre et comprendre luimême, à désirer dans son cas, d'être né arbre, et assurez-vous que l'immortalité qui
est refusé à des hommes.
The doctrine of the forest is as old as human history. In the popular imagination, the
different levels of the cultural and literary competence, around the image of the
forest coagulates a number of connotations and suggestions all in all similar and
common, ranging between a positive idea, that of lush green environment, teeming
with life and pristine, quiet and relaxing, and a negative view of the dark and
mysterious, impenetrable entities, scary, hostile. But there are those who, like
Franco Ferrarotti, dean of Italian sociologists, and professor emeritus of sociology at
the Faculty of Rome La Sapienza, assigned to the forest and its breath, a central
place in human life, recognizing the merit high to sustain life, and to be life. As
Thoreau when he says that the only weapons literary scholar who is incomplete, in
fact, that he must "learn" the language of nature, but we must go beyond
philosophical speculation and doctrinal Ferrarotti holds that man must be "practical",
live the reality of nature to understand and understand himself, to be desired in his
case to be born tree, and make sure that the immortality which is denied to men.
Premesse
Vi è mai capitato di attardarvi in un bosco fino al
crepuscolo? Di distendervi per terra al centro di una fitta radura di
120
alberi e alzare lo sguardo in alto, in cerca di uno spiraglio di luce
che riesca ad attraversare il fitto fogliame? Di chiudere gli occhi e
riaprirli dopo qualche secondo, senza avere più la netta percezione
di dove vi troviate? Inalare il respiro del bosco a pieni polmoni,
ascoltare i suoi rumori, osservare le ombre misteriose di tutta la
vegetazione attorno a voi, e immedesimarvi così tanto da pensare
di farne parte? Scambiare il fruscio del fogliame con un sussurro
di parole, come un invito a restare lì mimetizzati nella natura? Fino
a desiderare, magari, di rinascere albero…? Comincia così un libro
bello e importante: Atman il respiro del bosco di Franco Ferrarotti,
decano dei sociologi italiani, e professore emerito di sociologia
presso l’università di Roma, la Sapienza, che fa del suo scritto un
vero e proprio atto d’amore verso l’essenza del bosco che, nella
sua vita, come vedremo, ha avuto un ruolo vitale. Egli scrive:
Questo libro è dunque, in essenza, un atto d’amore e di gratitudine al
bosco e al suo respiro. Dovessi rinascere, non mi spiacerebbe far parte
del regno vegetale. So che fra l’umano e il vegetale-due specie viventi-si
danno tuttora grandi, sostanziali differenze. Parenti ed amici mi hanno in
proposito pazientemente erudito […] mi hanno a lungo istruito sulle
differenze fra la circolazione del sangue nel corpo umano e la
circolazione della linfa negli alberi. Non ho capito granché, ma li ringrazio
tutti di cuore. […] Quello che credo di aver capito è che tagliare un ramo
d’albero è come infliggere una ferita a un essere umano, che gli alberi
parlano, chiacchierano fra loro, cantando e stormendo, vivono, nascono e
muoiono come noi. Gli alberi sono nostri fratelli, o fratellastri, discreti,
forse timidi ma, a modo loro, affettuosi. Vorrei tanto che morendo, la
decomposizione del mio corpo facesse almeno a loro da concime1.
Alcuni miti raccontano che gli uomini sono nati dagli alberi.
Per la tradizione giudaico-cristiana gli alberi sono una
rappresentazione dello spirito, nel paradiso terrestre vi era, infatti,
l'albero della vita, fonte della conoscenza universale e della vita
2
eterna. Nell'Epopea di Ghilgamesch , il più antico poema di cui si
abbia traccia, l'albero della vita dava i frutti per ottenere
l'immortalità e quel frutto era chiamato "Il vecchio diventa di nuovo
giovane"; ma di quell'albero si sono perdute le sembianze e anche
le sementi. Alle foglie, ai rami, alle radici, alle fonti che sono intorno
alle acque sotterranee sono legati i miti degli Dei e la vita degli
uomini. Ai nomi degli alberi erano collegati i mesi lunari e le
121
stagioni. Plinio scriveva: "Non meno della effigie degli Dei, non
meno dei simulacri d'oro e d'argento, si adoravano gli alberi
maestosi delle foreste". Attorno agli alberi consacrati veniva eretto
un recinto dove non tutti potevano entrare: spazio rinchiuso
diventava sacro e il terreno intorno "luogo religioso". A volte il
recinto veniva alzato e diventava tempio che al centro aveva
l'albero.
Inoltre gli alberi sono spesso legati alle vicende di dei e
dee ai quali erano consacrati. Il leccio era sacro a Giove, il tasso a
Ngetal e ad Ecate, il tiglio alla ninfa Filira, l'alloro a Dafne, senza
dimenticare l'ambrosia, il nettare di cui si nutrivano gli dei
dell'Olimpo. Platone, era solito dire che l’uomo è una pianta
celeste. Non ci sarà vita senza alberi e boschi! Il panismo o
sentimento panico della natura è una percezione molto profonda
del mondo esterno (soprattutto se riferita a paesaggi naturali) che
crea una fusione tra l'elemento naturale e quello più
specificamente umano. È noto che il termine deriva dal nome Pan,
dio greco dei boschi, ma, dal momento che presuppone una
concezione panteista del divino, lo si può far derivare anche
3
dall'etimologia greca πάν (pàn), che significa "tutto" da cui
probabilmente scaturisce la stessa terminologia del dio.
Nel panismo l'Io si viene a mettere in secondo piano,
immergendosi
completamente
nella
natura,
ma
non
nascondendosi del tutto in quanto, si possono esprimere i propri
stati d'animo, attraverso oggetti naturali.
Nella filosofia jüngeriana il bosco è il luogo metafisico di
raccoglimento del ribelle, il quale si dissocia dalla società e le
sfugge scegliendo appunto di "passare al bosco," il bosco, per
l’appunto, dimora dell’essere nella quale l’io torni a vincere sulla
massa, su un noi collettivo sempre più impersonale e
spersonalizzante. Per Ernst Jünger è il passaggio fondamentale
per la dimensione della lotta come preservazione e realizzazione
interiore. E' un atto di libertà nella catastrofe. La grande esperienza
4
del bosco, sostiene Jünger nel suo Trattato del ribelle , è l'incontro
con il proprio io, con il nucleo inviolabile, l'essenza di cui si nutre il
fenomeno temporale e individuale. Porta verso quello strato sul
quale poggia l'intera vita sociale e che sin dalle origini è sotteso a
122
ogni comunità. È verso quell'essere umano che costituisce il
fondamento di ogni elemento individuale e da cui si irradiano le
individuazioni. In questa zona non ritroviamo soltanto la
comunanza: qui c'è l'identità. Nel bosco è racchiusa la sostanza
della storia, nell'incontro dell'uomo con se stesso, o meglio, con la
propria divina potenza. Il bosco, dunque, non solo come
dimensione metafisica di lotta politica e ma anche come
dimensione rigenerante e purificatrice.
Il bosco è l'idea-forza, nel senso soreliano del termine, è
lo spazio dal quale l'uomo può sperare non solo di condurre la
lotta, ma anche di vincere. Il bosco è segreto. Heimlich, segreto, è
una di quelle parole della lingua tedesca che racchiudono in sé
anche il proprio contrario. Segreto è l’intimo, ben protetto focolare,
baluardo di sicurezza. Ma nello stesso tempo è anche ciò che è
clandestino, assai prossimo in quest’accezione all’Unheimliche,
l’inquietante, il perturbante. Quando ci imbattiamo in radici simili a
questa, possiamo essere certi che vi risuona un’eco della grande
antitesi e dell’equazione ancora più grande di vita e morte, alla cui
soluzione si dedicano i misteri. In questa luce il bosco è la grande
casa della morte, la sede del pericolo di annientamento. Il compito
della guida spirituale è di condurvi per mano il discepolo per
liberarlo dalla paura. Il bosco lo fa morire e risorgere
simbolicamente. A un passo dall’annientamento c’è il trionfo. Chi
ha inteso questo, sa innalzarsi al di sopra della violenza temporale.
L’uomo impara che questa violenza non ha alcun potere su di lui,
anzi è destinata unicamente a confermarlo nel suo valore
supremo.
Siamo nel 1845 quando Thoreau scrive Walden, ovvero
5
la vita nei boschi un’opera nella quale si può capire il tentativo
dell’autore di trovare un punto di incontro tra l’uomo e la natura.
L’uomo è artefice del proprio destino. Questo è il pensiero di
Thoreau, che segue il movimento filosofico del trascendentalismo,
ispirato dall’amico Ralph Waldo Emerson. Thoreau scrive questo
saggio durante un soggiorno a Concord, nel Massachusetts, sulle
sponde del lago Walden, dove per due anni, due mesi e due giorni,
vive in prima persona una importante esperienza di vita, in una
capanna di tronchi d’albero molto austera che si costruisce da
123
solo. L’esperienza della vita fra i boschi, a pieno contatto con la
natura, porta l’autore a vivere una “solitudine gioiosa”, fatta di
contemplazione estatica della natura, di lunghi periodi di tempo
dedicati alla meditazione distaccata e serena, che gli permettevano
di lasciarsi invadere dalla pace interiore. Per Thoreau quello che
conta è il “necessario”: una tenda, un sacco a pelo, e la natura che
lo circonda. Quello che si realizza attraverso questa interessante
esperienza esistenziale è la “vera” realtà umana. Dove a parlare
sono le voci della natura, e non il rumore della città; dove l’anima
ritrova i suoi spazi, i suoi silenzi benefici, i suoi orizzonti vasti e
puri. Tutto ciò si può realizzare solo vivendo lontano dal caos, dalle
costrizioni di una vita di routine che si ripete all’infinito. L’anima ha
bisogno di spazio. Lo spazio che solo la natura può offrirci.
Il filosofo tenta di uscire da un proprio senso di solitudine
che gli schemi di pensiero e la società hanno generato, attraverso
una ricerca creativa, e lo fa seguendo un processo di
estraniamento dal contesto sociale. In questo modo egli tende a
valorizzare la dimensione interna, calandosi in una solitudine
particolare. L’autore ci spinge a riflettere su come l’uomo riesca a
comprendere ciò che aveva e a dargli significato solo quando
arriva a perdere tutto. “solo quando abbiamo perduto il mondo,
cominciamo a trovare noi stessi”. Possiamo pensare a Walden
come a un posto magico in cui la nostra anima, o Psiche, viaggia
liberamente. Tra le pagine di questo libro, in cui viene
rappresentata la semplicità della vita fra i boschi, si scopre anche
perché Thoreau è l'autore cui si ispireranno Gandhi e le
controculture contemporanee, che lo rileggeranno e lo
rielaboreranno, criticandolo sì, ma assumendolo come punto di
partenza. L'uomo, secondo Thoreau, che non è in grado con i
propri mezzi di conciliare spirito e materia, solo nel contatto con la
natura può sperimentare una parvenza di unità ed imparare così a
riprodurla e ciò perché nella natura c'è un elemento che coinvolge
spirito e materia allo stesso modo, una sorta di sintesi tra i due
opposti. Questa sintesi è rappresentata dal “selvatico”, dal contatto
puro con la natura, che serve, secondo Thoreau per essere
testimoni della trasgressione dei nostri stessi limiti. Una massiccia
esposizione al “selvatico” riesce a rieducare l’individuo e a
124
riportarlo in grado di sentire la vita, che è un continuo fermento e
brulichio di cuore e stomaco: se il cuore batte in ciascuno di noi ad
un ritmo diverso, lo stomaco è più o meno lo stesso per tutti e
rappresenta l’elemento in grado di annullare i rischi
dell’individualismo.
Atman, il respiro del bosco
C'è un vecchio proverbio che dice: "Non si può guardare
l'albero e vedere il bosco". Possiamo applicare quest'idea alla
prospettiva sociologica. Il proverbio implica che un bosco è grande,
troppo grande per essere visto tutto in una volta e, da vicino,
possiamo solo vedere degli alberi. Possiamo vedere parte del
bosco, ma questo non ci fa comprendere bene il bosco nella sua
interezza Nella vita di tutti i giorni, entriamo in contatto con altre
persone. Le possiamo vedere; possiamo solitamente parlare con
loro. A volte possiamo toccarle, ma dobbiamo stare attenti al dove.
Non possiamo vedere, né toccare una società, una comunità o una
famiglia. Anche se prendessimo un aereo non potremmo vedere
un bosco dall'alto, perché è un ecosistema e comprende tutti i
rapporti tra il suolo, le piante, gli animali e l'aria in quel sistema. È
molto più di un insieme di alberi. E così è anche una società. Non
consiste di persone che possiamo vedere, ma di convinzioni e
azioni, ed è un sistema; non c'è alcuna posizione fisica da cui poter
guardare una società. Le famiglie e le comunità sono
organizzazioni sociali e, perciò, un qualcosa di diverso dagli
6
individui al loro interno . L’uomo moderno è spesso infelice. Siamo
spesso chiusi all’interno di schemi sociali che la società moderna ci
impone.
La parola Atman (in sanscrito si pronuncia come Atma)
Ātman (devanāgarī
) è un termine di genere maschile, che
indica l'"essenza" o il "soffio vitale". Viene tradotto anche col
pronome personale riflessivo di terza persona Sé. Esso trae il
7
significato da varie radici an (respirare), at (andare) va (soffiare) ,
questa descrizione come "essenza" e "soffio che dà la vita" propria
125
del Ṛgveda viene interpretata come una unità, trascendente ed
immanente al tempo stesso, di tutta la realtà cosmica, e in questo
senso, un analogo del Brahman, la formula sacrificale che genera
.
e mantiene il Cosmo, ma significa anche l’Essenza Principale
dell’uomo, il suo “Io” Superiore. In sostanza, l’Atman è la parte
migliore, divina dell’organismo pluridimensionale di ognuno di noi.
L’Atman è il Fuoco Brahmanico, col quale diventiamo tutt’uno, è
l’energia Atmica della kundalini, il prezioso contenuto del
“salvadanaio”, nel quale sono depositati gli accumuli di tutto ciò
che di meglio siamo riusciti a mettere da parte durante tutte le
incarnazioni precedenti. Risulta che in ogni nuova incarnazione
non tutta l’anima si reincarna nel corpo, ma, prima di tutto, quella
parte che deve essere corretta. La parte migliore, cioè, quello che
ognuno di noi ha coltivato in sé sullo sfondo dell’emozione del vero
amore finissimo, è messo da parte da Dio per conservarlo in
questo “salvadanaio”. Eppure, la kundalini fa parte dell’organismo
pluridimensionale dell’uomo e partecipa alla sua attività vitale.
Quando giunge “la fine del mondo”, tutte le kundalini affluiscono
nella coscienza del Creatore. Ma le anime che non hanno fatto in
tempo ad unirsi con l’Atman, vengono distrutte fino allo stato di
protopurusha. Ritorniamo al tema della trasformazione delle
energie. I nostri corpi, essenzialmente, sono delle specie di
fabbriche che trasformano le energie “materiali” nell’energia della
coscienza. La qualità della coscienza che cresce dipende, prima di
tutto, dalle emozioni in cui viviamo: fini o finissime oppure “grigie” o
“nere”, grossolane. Quando, dopo un susseguirsi di incarnazioni
l’uomo matura fino al grado, nel quale la sua attuale incarnazione
potrebbe risultare finale, e quando sono eliminate tutte le
imperfezioni nella parte incarnata della coscienza, arriva il
momento di portare la kundalini al corpo, farla passare attraverso il
corpo ed unire con esso la parte restante della coscienza
individuale. Poi è necessario confluire, insieme ad essa, nel
Paramatman (cioè, il Supremo Atman, l’oceano della
consapevolezza primordiale universale del Creatore nella sua
dimora). Così Atman, il respiro del bosco, altro non è che l’anima,
l’essenza del bosco stesso, il suo alito vitale, che può essere
paragonato esattamente al respiro di un uomo-albero, in cui scorre
126
la linfa vitale al posto del sangue, ma vive e respira esattamente,
come noi, tanto che potremmo definirci come fratelli.
In Atman Franco Ferrarotti si chiede se l’uomo della
società industriale saprà mettersi in dialogo con la natura, con il
paesaggio, riadattando per la scena contemporanea abitudini e
sensibilità di un passato contadino, come antidoto alla tentazione
di credersi un infallibile padrone. Ma la sua non è una domanda
casuale, bensì, scaturita da tutta una storia, legata in un certo
senso ad un bosco, la storia della sua vita. Egli è nato nel 1926.
Quello stesso anno, Mussolini, dietro le pressioni della destra
nazionalista, e per rassicurare ceti medi risparmiatori e dipendenti
pubblici, importante segmento delle basi di massa del regime
fascista, rivalutava fortemente la lira, portando il valore della
sterlina a non più di novanta lire. Per molti proprietari terrieri e
produttori agricoli, tra cui i Ferrarotti di Palazzolo Vercellese, fu la
rovina economica, per gli effetti deflattivi e la contrazione delle
esportazioni seguiti all’azzardata manovra.
Con le Edizioni Empiria di Roma, Ferrarotti ha appena
pubblicato due libri che intrecciano autobiografismo letterario e
pagine di sociologia vissuta. L’ultimo è intitolato appunto L’anno
della quota novanta e racconta la sua infanzia in Piemonte,
quando i genitori, per farlo crescere meglio, lo mandarono a
respirare aria buona dai bisnonni, in una grande casa circondata
da un bosco. Un bambino nato nel 1926, che cresceva malaticcio
dietro una zanzariera tra le risaie del Vercellese. Il “bambino” oggi
ha 86 anni ed è tornato nel bosco, ci si è smarrito, ha vissuto
un’ovidiana metamorfosi in albero e ce l’ha raccontata. In un breve
proemio delle Metamorfosi Ovidio formula un suo ambizioso
progetto: “narrare le mutatas formas in nuovi corpi” con un “carmen
perpetuum” dall’origine del mondo, cioè dal caos primitivo, fino alla
contemporaneità. Alla fine del poema il filosofo Pitagora enuncia la
teoria della metempsicosi, il principio alla luce del quale leggere le
tante metamorfosi: l’universo è altamente instabile, ed è
attraversato da un irresistibile dinamismo che coinvolge le cose
inanimate e gli esseri viventi. In questa realtà fluida e sfuggente gli
uomini vivono un’esistenza incerta in balia del caso o del capriccio
divino.
127
La metamorfosi è una morte meno definitiva e dolorosa
perché è anche inizio di una nuova esistenza, afferma Pitagora:
niente mantiene la forma con cui appare e la natura, eterna
innovatrice, crea sempre nuove figure dalle vecchie: nulla va perso
nel vasto mondo, ma solo cambia e rinnova il proprio aspetto. “Si
chiama nascita il cominciare ad essere qualcosa d’altro rispetto
all’essere precedente; si chiama morte il cessare di essere quella
cosa”.” Il mio animo mi spinge a narrare il mutare delle forme in
nuovi corpi; o dei, ispirate la mia impresa,(ciò che io ho intrapreso)
infatti voi avete mutato anche quello (vostre sono queste
metamorfosi) e dalla prima origine del mondo conducete questo
8
mio carme ininterrotto fino ai miei giorni” .
Il bosco è quel che è rimasto, della Partecipanza di Trino,
reliquia di un’antichissima foresta planiziale. La Partecipanza si
costituì nel 1275 come amministrazione collettiva della foresta da
parte dei cittadini di Trino Vercellese, ma nel 2011, dopo più di
sette secoli, la giunta regionale guidata da Roberto Cota, senza
consultazioni, l’ha spogliata della sua autonomia. Se guardiamo la
vita con lo sguardo del cosmo, non possiamo far altro che vederla
come un cerchio perfetto, un ciclo che si compie, si torna
esattamente da dove siamo venuti, «Con il sudore del tuo volto
mangerai il pane finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato
tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!». Così, recita il versetto
2,19 della Genesi. Nel suo libro, Ferrarotti, parte dalle sue origini,
legate proprio alla terra, quando ricorda il padre che come un
rabbino in preghiera, con un cappello nero calato sulla fronte,
lavorava nei campi. Poi per un problema burocratico, dopo tanti
anni, trascorsi da quei ricordi egli viene chiamato a tornare in quei
luoghi, proprio a causa del bosco. Quel bosco avuto in eredità dal
9
padre , condiviso con i fratelli, ma la cui spettante quota, reclama
la sua attenzione e la sua responsabilità,
I Ferrarotti, sono membri della Partecipanza da generazioni. Tutti a turno
potano e tagliano regolarmente la legna. Il primo conservatore della
partecipanza mi fa sapere che io sono l’unico partecipante che non
partecipa, che non si fa vivo, da anni. […] Come posso io, giuridicamente
proprietario pro-quota, rifiutare il mio apporto, trincerarmi dietro le
trasferte didattiche e di ricerca all’estero? […] Non avevo più scuse.
Dovevo tornare. Ma ancor prima di ogni iniziativa
politica
o
128
amministrativa, dovevo rendermi conto di persona dello stato del mio
“quarteruolo.” Dovevo, in altre parole, entrare finalmente nel bosco, nella
mia “selva oscura” nella mia selva “selvaggia e aspra e forte.” […]
Finalmente dovevo ora affrontare il mio bosco, viverci dentro, decidere il
da farsi, per opporsi al cieco arrogante arbitrio di una struttura
burocratica, onnipotente e irresponsabile10.
Ed è a questo punto, che Ferrarotti avverte il forte
desiderio, che, dovendosi concludere il ciclo della vita, quando il
momento arriverà, non sarebbe affatto dispiaciuto di diventare un
tutt’uno con esso, cioè di ritornare alla terra da cui ha avuto
origine, di diventarne concime per il suo bosco, quel bosco il cui
respiro servì a rinforzare la sua salute quando era piccolo, gracile
e malato, e a cui donando la sua stessa materia organica, gli
parrebbe in fondo di ricambiare il favore. Sarebbe contento persino
di poter rinascere albero, di essere un elemento di quella
meravigliosa natura che lo ha generato, godendo così di
un’immortalità che alla specie umana non è concessa.
È stato forse un errore entrare nel bosco di buon mattino, un dolce
mattino di primo settembre. La rugiada mi bagna le caviglie. Dalle foglie
mi cadono sul collo e sulla lucida calvizie stille di pianto e di gioia, come
fra parenti che si rivedono dopo una lunga separazione. Tutto sulle prime
mi sembra facile e rido fra me e me del ribelle Waldgänger di Ernst
Jünger. E mi pare incongrua l’altera solitudine di Henry David Thoreau
nella sua baracca di legno sulla riva del laghetto Concord nel freddo
bosco del New England. […] sono vittima consenziente di illusioni
letterarie, […] è sogno e documento, magia e menzogna. Il bosco mi ha
salvato la vita da piccolo con i suoi sbuffi freschi e la musica del vento
sulla cima dei pioppi sottili, dei lecci anneriti e contorti, delle querce
maestose. Mi aspetto dal bosco silenzio e solitudine11.
Nel Festival della filosofia, tenutosi a Modena nel 2012, il
tema era la “Natura”. La natura, a lungo trascurata, riguadagnava
la ribalta e diventava oggetto di riflessione e d’azione anche per i
grandi pensatori. Una natura non più solo oggetto di sfruttamento,
ma in grado di soggettivizzarsi nel recupero di un rapporto
equilibrato con l’uomo. In quell’occasione sociologi e filosofi hanno
evidenziato l’urgenza di una coscienza umana in grado di creare
un nuovo rapporto con l’ambiente, non più basato sul puro
utilitarismo.
129
Ferrarotti, in Atman identifica la natura come una grande
madre, sempre pronta ad accoglierci in una dimensione simbiotica,
dove ognuno di noi diventa un figliol prodigo che, dopo il male
procurato, ritorna agli affetti primordiali. Lo studioso, in una
12
intervista ha risposto ad alcune domande, sul tema della natura e
del suo rapporto conl'uomo.
Egli non presenta alternative al capitalismo e alla
globalizzazione, ma invoca misure per evitarne la “bulimia”. Ed
ecco una prima risposta ma di notevole impatto: il luogo. Luogo
inteso come territorio, spazio che appartiene all’uomo e che l’uomo
considera proprio fattore costitutivo. Cosa significa? L’identità di
una popolazione, di una comunità non è solo cultura, tradizione,
costumi: quel locale che si integra nel globale e non si
contrappone. Il luogo come sede di valori condivisi e identitari, a
cominciare dal paesaggio naturale e di quello che risulta dal lento
operare dell’uomo. Il luogo che produce il proprio genius loci, la
divinità ctonia che connota il carattere, la sensibilità e l’intelligenza
dei suoi ospiti, ne giudica e ne sanziona il comportamento. La
storia del Mediterraneo è piena di questi esempi.
Si può parlare, anche in questo senso, di un’etica della
natura intesa come paesaggio di boschi, giardini, campi, ville, vero
e proprio linguaggio della terra. Si tratta di un paesaggio che
l’uomo guarda e che a sua volta guarda l’uomo che lo sta
guardando, creando una simbiosi che produce emozioni, valori,
identità, cultura. Il paesaggio come sede irripetibile del miracolo
della natura da una parte, del lavoro e dell’agire dell’uomo
dall’altra. Ogni territorio ha la sua storia e ciò lo rende inimitabile,
facendolo nel contempo essere parte del tutto, quell’unità del
diverso e degli opposti che rimanda al pensiero greco. Franco
Ferrarotti svolge questa nobile lezione come docente di indiscusso
valore ma soprattutto come uomo che vive il proprio tempo e sente
13
il dovere di portare un contributo per un suo futuro migliore.
La quercia madre intuisce, dal mio silenzio pensoso, l’angoscia dei
ricordi. Sa che si tratta di ferite destinate a buttare sangue tutta la vita. Mi
consola. Sussurra: «È stato detto: lascia che i morti seppelliscano i loro
morti». Non so bene dove voglia andare a parare. Non avrei mai
immaginato che una quercia potesse citare il Vangelo a proposito. Mi
costringo a starmene zitto. Impresa tutt’altro che facile. In una vita
130
mediamente longeva ci sono riuscito solo un paio di volte. Credo di capire
che la quercia-madre mi vedrebbe volentieri morire come uomo per
rinascere come albero. Riprende infatti, con un tremito : «Ma che ci stai a
fare nell’orda umana, proprio tu che ti sei sempre schierato, e con
decisione, contro la logica dell’armento?... » La quercia-madre continua
impietosa: «Guardati bene dentro, professore. Non hai vie d’uscita.
Guarda con attenzione, professore emerito di poco merito, la tua vita
passata. Guardala bene. Non siamo al giudizio finale, non siamo nella
biblica valle di Giosafat. Non ancora. Ma guardala bene, la tua lunga vita.
Sei al termine, ormai. Sei al capolinea. Guardala bene dunque e che ci
trovi? Non fermarti ai riconoscimenti ufficiali, ai corsi universitari che hai
tenuto in tutto il mondo. Sciocchezze. Non fermarti ai “premi della cultura,
alle medaglie, ai riconoscimenti ufficiali, alle pergamene delle onoranze,
così vicine alle onoranze funebri, alle altisonanti nomine ai vari livelli di
cavalierato… Tu sei sempre rimasto, nonostante tutto un outsider. Per
questo ti vogliamo bene ». All’improvviso tutto il bosco ha un fremito.
«Vieni,[...]tu hai capito che la vera saggezza sta nel riconoscere che
animali non umani, esseri umani, e tutto il vario e vivo mondo vegetale
sono una grande fratellanza. Finalmente l’hai capito. Vieni. Sei uno di noi
». Così è cominciata, dopo quella umana, la mia storia di albero:
tranquilla, silenziosa, autosufficiente e autoposseduta, contemplante.
Respiro. Il silenzio s’allarga nella notte. Tutto tace. Il mondo non c’è più.
Essere. Esserci nell’essere. Accettarsi pulviscolo nel cosmo14.
Qui il sociologo e il filosofo coincidono.
1
F. FERRAROTTI, Atman. Il respiro del bosco, Empiria, Roma 2012, pp. 7-8.
L'Epopea di Gilgamesh è un ciclo epico di ambientazione sumerica, scritto in
caratteri cuneiformi su tavolette d'argilla, che risale a circa 4.500 anni fa, tra il 2600
a.C. e il 2500 a. C.
3
Si tratta in questo caso del genere neutro del vocabolo greco «πάς πάσα πάν».
4
E. JÜNGER, Il trattato del ribelle, Adelphi, Milano 1990.
5
H. D. THOREAU, Walden ovvero vita nei boschi, Rizzoli, Milano 1988.
6
PH. BARTLE, La prospettiva sociologica, www.cec.vcn.bc.ca
7
Cfr. M. MONIER-W ILLIAMS,. Sanskrit-English Dictionary. Ma anche M. Stutley e J.
Stutley. Dizionario dell'Induismo, Ubaldini, Roma 1980, p. 46.
8
Publio Ovidio Nasone, Metamorfosi, contributi di I. CALVINO, a c. di P. Bernardini
Marzolla Mondadori, Milano 2005, p.309.
2
131
9
Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, sopravvissuto fino nostri giorni
grazie ad un sistema di amministrazione collettiva e di utilizzo che risale ai secoli
medioevali, il Bosco delle Sorti della Partecipanza (570 ha), è immagine del nostro
territorio nei secoli passati: bosco di pianura, sorgenti naturali, dossi da superare,
vie di attraversamento in terra battuta. "Zattera" verde nel cuore della risaia, è ciò
che rimane di quella grande foresta estesa da Crescentino a Costanzana. Dal 1991
è Parco Naturale Regionale. La valenza storica dell'Area Protetta è valorizzata
dall'ampia documentazione conservata presso la Partecipanza dei Boschi, che dal
1275, per donazione del marchese del Monferrato Guglielmo il Grande, è
proprietaria pro indiviso della Selva. La Partecipanza è ora composta (agosto 2007)
da 1272 soci. Fonti Bibliografiche: Archivio di Stato di Vercelli, Archivio Storico
Partecipanza dei Boschi.
10
F. FERRAROTTI, op. cit., pp. 63, 70, 74.
11
Ivi, p. 177.
12
L’ intervista è Natura e sociologia: incontro con Franco Ferrarotti, a cura di
Mariano Colla, Italy@Magazine, consultato il 27/12/2012
13
Cfr. A. BAGNATO, Il senso del luogo secondo Franco Ferrarotti, “L’albatros
trimestrale culturale”, online, consultato il 27/12/2012.
13
F. FERRAROTTI, op. cit., pp.99-100,108. 13 La valle di Giosafat o valle di
Giosafatte, di cui si parla nel testo, è una valle identificata oggi con una parte del
Cedron che si trova esattamente tra il Monte del Tempio e il Monte degli Ulivi vicino
a Gerusalemme, in Israele. Essa viene menzionata in Gioele 3,2. Nel passo si parla
di un'adunata di tutte le nazioni e questo ha fatto pensare che si tratti in effetti del
Giudizio universale.
132
Nuova e originale è la trama riflessiva che anima le
ricerche contenute nel recentissimo volume Storia del pensiero
filosofico in Calabria da Pitagora ai giorni nostri, Rubbettino,
Soveria Mannelli 2012, a cura del compianto Mario Alcaro.
Obiettivo principale dei saggi ivi raccolti è quello di investigare e
approfondire una tradizione filosofica che, ben lontana da ogni
enfatizzazione regionalistica, viene valorizzata invece per essersi
sempre mossa in sintonia con il grande sviluppo speculativo
dell'Occidente. In effetti, mancava, fino ad oggi, un'opera di tal
genere, che ricostruisse in una determinata area geografica, senza
cedere a municipalismi e localismi, tanto le voci di grandi
pensatori, da Gioacchino da Fiore a Telesio a Campanella a Salfi a
Galluppi, quanto le voci di tanti pensatori erroneamente considerati
"minori", solo perché non sufficientemente studiati o conosciuti.
Del resto, lo stesso Alcaro osserva, nell'Introduzione, che
«esiste una sorta di geografia mentale fatta di stili di pensiero,
culture, modi di dire, tecniche e saperi che s'inscrivono nella carne
del paesaggio e in cui il tempo e lo spazio, la storia e la geografia
si modellano reciprocamente. Il recupero della componente geofilosofica limita, per di più, la pretesa di mitizzare il tempo storico,
di rappresentare cioè una sorta di "philosophia perennis" che
segue il suo corso nel tempo, senza alcun riferimento allo spazio».
La prima sezione del volume - articolato in quattro parti intitolata Da Pitagora al Rinascimento, è aperta da uno scritto di
Aniello Montano che, nel trattare La filosofia nella Calabria della
Magna Grecia e dell’intenso fervore di Crotone con Pitagora e
della Scuola italica con Alcmeone, Democede e Filolao, dà
testimonianza della parte attiva svolta dalla Calabria
nell’elaborazione della civiltà e cultura classica, ovvero dell’identità
culturale italiana, europea e occidentale, caratterizzata
RESOCONTI
STORIA E "STORIE" DELLA FILOSOFIA
A PROPOSITO DI UN RECENTE VOLUME
di Ilaria Malagrinò
133
dall’apertura a tutte le problematiche relative all’uomo e alla vita
associata, dall’esaltazione dell’iniziativa umana e dall’adozione di
una procedura metodologica di tipo razionale. Segue un testo di
Raffaele Perrelli dedicato alla figura di Cassiodoro, nella cui attività
è possibile ravvisare due periodi: il primo si staglia sullo sfondo
storico dell’affermazione della potenza bizantina ed è
caratterizzato dall’intreccio ciceroniano tra vita activa e
contemplazione e dal desiderio inappagato di creare un’unità
gotico-romana, ricongiungendo la frattura tra mondo classico e
mondo germanico; il secondo, invece, come testimonia
puntualmente il Vivarium, è mosso dall’intento di salvare il
patrimonio culturale dell’antichità attraverso la trasmissione dei
testi classici e cristiani alle generazioni future.
Filippo Burgarella, da parte sua, analizza La cultura
bizantina in Calabria, provincia fra il VI e l’XI secolo dell’Impero
Romano d’Oriente: essa, da una parte testimonia un vero e proprio
processo di "bizantizzazione", confermato dalla diffusione sul
territorio delle opere di San Gregorio di Nazianzo, di Basilio il
Grande e Gregorio di Nissa, nonché di altre opere della tradizione
ascetica e spirituale dell’Oriente mediterraneo; dall’altra, è
caratterizzata dall'essere espressione della cosiddetta “civiltà del
libro”. Il libro, infatti, alimento per la vita interiore del fedele
ortodosso, è il principale veicolo di trasmissione culturale in un
contesto religioso-intellettuale-educativo in cui al monaco
amanuense spetta un ruolo fondamentale di conservazione,
edizione e diffusione delle opere.
Chiudono la prima sezione due saggi di Luca Parisoli, il
primo dei quali è dedicato alla figura e al pensiero di Gioacchino da
Fiore: si tratta di un’interpretazione che tende ad esaltare la
“diversità” e la “novità” della riflessione del monaco calabrese
rispetto agli altri pensatori cristiani dell’epoca. Gioacchino, infatti,
non potendosi considerare per questo eterodosso, si discosta
dall’approccio di Pietro Lombardo e dalla metodologia scolastica,
offrendo un’interpretazione del testo sacro che si dispiega nella
sfera politica. Nel secondo saggio del Parisoli, dedicato alla figura
di Angelo Clareno, intento precipuo dell’Autore è palesare
l’influenza
geo-culturale
mediterranea,
greco-cristiana,
134
nell’interpretazione
della
spiritualità
francescana,
come
testimoniato appunto dall’opera di Angelo Clareno: questi, nella
sua Expositio Regulae, cita infatti autorità dedotte dalla patristica
greca. Da questo punto di vista, pertanto, lecito sarebbe postulare
l’esistenza di due anime del francescanesimo: una settentrionale e
una meridionale, quest’ultima avrebbe trovato patria e terreno di
diffusione propriamente sul suolo siciliano e calabrese.
La seconda parte del volume, dedicata a Scienza e
filosofia tra Cinquecento e Seicento, è introdotta da un saggio di
Raffaele Cirino, il quale sapientemente mostra come l’impegno
speculativo calabrese nei secoli XVI e XVII, sebbene nato dal
dialogo e dal contatto con i canoni della coeva riflessione europea,
sia nondimeno contraddistinto da una peculiarità di “matrice
mediterranea”. Infatti, malgrado la situazione di arretratezza
economico-culturale, generata dal persistere delle strutture feudali,
dall’assenza di organismi universitari locali, dal ripetersi costante
delle epidemie, dai terremoti e dalle incursioni straniere situazione questa che porta le giovani menti calabre a spingersi
vero le sedi accademiche siciliane, napoletane ed europee - e
sebbene non sia possibile rintracciare le linee di influenza di un
pensatore su un altro e, quindi, non si possa propriamente parlare
di Scuola, nondimeno è possibile ipotizzare l’esistenza di una
“corrente” di pensiero calabrese tipica dell’epoca. Tale corrente
troverebbe la sua nota caratteristica nell’elaborazione comune e,
pur sempre, differenziata di un naturalismo filosofico-scientifico
radicato nel territorio e nella condivisa consapevolezza di essere
eredi dei pensatori della Magna Grecia. A riprova dell’esistenza di
tale tradizione “comune”, l’Autore del saggio porta le testimonianze
di vari intellettuali, ingiustamente relegati in secondo piano dalla
storiografia, quali: Luigi Lilio o Giglio, ovvero di colui che ebbe il
merito di risolvere il problema del Calendario Giuliano; Giovanni
Antonio
Pantusa;
Tiberio
Russiliano
Sesto;
questi,
contrapponendosi agli scolastici a ai tomisti e prendendo le difese
degli averroisti, delinea la sua visione filosofico-naturalistica di un
mondo retto da norme intimamente e interamente naturali e
pienamente conoscibile attraverso le leggi fisiche del movimento;
ed ancora, Annibale Rosselli, autore di un commento minuzioso al
135
pensiero e agli scritti attribuiti ad Ermete Trismegisto, nell’intento di
utilizzare le stesse dottrine ermetiche rinascimentali per
promuovere la fede cattolica; Antonio Oliva, “maestro” nelle
discipline di scienza medica; Elia Astorini, figlio fedele della
modernità nella sua tendenza all’organizzazione unitaria del
sapere e nell’interesse per la scienza sperimentale e per le
verifiche empiriche condotte osservando scrupolosamente e
rigorosamente ogni fenomeno fisico concreto; Gabriele Barrio,
autore di un’opera di geografia storica, tendente a rivendicare la
fecondità del rapporto Calabria-Magna Grecia, un'opera che cerca,
al tempo stesso, di lumeggiare la stretta relazione intercorrente tra
uomo e natura nell’interscambio armonico tra ambiente biologico e
geologico; Paolo Antonio Foscarini, da parte sua, interessandosi di
meteorologia e di astronomia, si mostra sostenitore di una vera e
propria forma di scienza moderna, depurata da ogni credenza
metafisica e magica, basata sull’empirica corrispondenza tra causa
ed effetto; Tommaso Cornelio, infine, facilita l’ingresso della
filosofia di Cartesio in Italiana, dandole, tuttavia, una
caratterizzazione squisitamente meridionale, orientata a conciliare
e a suggerire una mediazione tra astrazione matematica e
concretezza fisica e facendo proprio l’ideale telesiano, secondo cui
la natura va studiata e compresa a partire dai suoi stessi principi.
La parola passa, quindi, al saggio di Roberto Bondì, rivolto
alla chiarificazione dei rapporti tra Telesio e il telesianesimo, che
trova in Campanella e Persio i suoi maggiori rappresentanti; nel
contraddistinguersi per le forti venature neoplatoniche, la tradizione
telesiana si allontana, in qualche modo, dall’originaria ispirazione
naturalistica presenti nelle pagine del pensatore cosentino. Ancora
alla figura e al pensiero di Campanella è dedicato lo scritto di Mario
Alcaro, il quale, dopo aver rimarcato l’ampia produzione filosofica e
scientifica calabra tra Cinquecento e Seicento, ne sottolinea
l’originalità. Originalità ben esemplificata dal “naturalismo
campanelliano”, in cui la natura non rappresenta soltanto la
principale fonte di conoscenza, ma costituisce il modello cui
improntare la condotta degli uomini e l’organizzazione sociopolitica. Una natura che, considerata alla stregua di un “animale
perfetto” e pervasa in ogni sua parte di sensibilità e vita, si
136
allontana decisamente dall’immagine che ne dava in quel tempo la
modernità, impegnata nel ridurla e nel piegarla al meccanicismo
delle leggi di causa-effetto.
Al genio di Gian Battista Amici è dedicato lo scritto di
Franco Piperno, il quale sapientemente mette in mostra la grande
statura intellettuale di questo “astronomo mancato” che ha avuto il
merito di introdurre un’innovazione non soltanto disciplinare, ma
addirittura metodologica, anticipando di oltre mezzo secolo l’opera
di Galilei. Lo sforzo di G.B. Amici, infatti, si profonde tutto nel
tentativo di unificare astrologia matematica e filosofia naturale e
nel proporre tale plesso come unico criterio valido di verità,
consolidato dalla descrizione fedele della realtà e dalla capacità di
formulare previsioni verificabili. Ma, se esatta è l’indicazione
metodologica, non altrettanto percorribile si rivela la strada che il
pensatore indica, la quale, avendo la sua chiave di volta nell’ormai
“superato” sistema aristotelico, finisce per legarlo a vetuste teorie
del passato e lo rende miope al “nuovo” che, percorso
integralmente, lo avrebbe spinto verso il futuro. Segue, quindi, un
saggio di Emilio Sergio che chiude la sezione, informando
dell’intensa attività intellettuale dell’Accademia Cosentina e
dell’influenza che in essa ebbe il pensiero telesiano, testimoniata
dalle opere di Doni, Quattromani e Marco Aurelio Severino.
La terza parte, dedicata a La filosofia moderna e
contemporanea, è anch’essa fortemente ricca di spunti riguardo
alla vivacità del pensiero calabrese. Così, Fabrizio Lomonaco nel
suo denso e articolato scritto offre un’immagine di Caloprese come
“renatista di Scalea”, che assume certo fino in fondo la lezione
cartesiana riguardante la presunta dualità della mente e del corpo,
separati nella loro differenza ontologica, ma, nello stesso tempo,
ne postula la possibile unione, come è testimoniata dall’attività
della fantasia. Nell’alveo della scuola di Scalea si colloca anche
l’attività speculativa di Gravina, il cui sforzo di chiarificazione della
natura del diritto si appunta nel prius di una natura umana,
investigata sulla scorta di un cartesianesimo mediato dalla lezione
classico-umanistica e dalla filosofia platonica e neoplatonica.
Nell'esprimere l’esigenza di una rielaborazione sistematica e
razionale del diritto, il filosofo calabrese si colloca a pieno titolo
137
nella tradizione meridionale a lui contemporanea, vichianamente
impegnata a teorizzare il diritto come sistema. La scientia iuris,
teorizzata da Gravina, fa perno su un’originale antropologia
incentrata sulla recta ratio, che, vincolando la validità del comando
divino ai poteri della ragione, postula in tal modo l’esistenza di un
principio universale di senso immanente alla realtà umana. La
ricerca della “forma” e della materia del diritto avviene sul piano dei
fatti storici, secondo una modalità d’indagine che pur, non
rinunciando all’idea di una “ratio” superiore, propria dello ius, si
distanzia dall’impostazione metafisico-teleologica della filosofia
della storia di matrice agostiniana e si riallaccia alla tradizione
cartesiana. Di segno diverso, invece, è l’orientamento di Spinelli,
definito come “il più metafisico” dei cartesiani meridionali
dell’epoca, per l’impegno da lui profuso nel riabilitare l’ontologica
separazione tra res cogitans e res extensa. In tal senso, originale
risultano la ripresa dell’Aristotele della Metafisica riletto e
“riscattato” alla luce dell’idealismo platonico e la lettura di un
Platone presentato come precursore della cartesiana separazione
tra l’attività e unità della mente dalla passività e divisibilità del
corpo.
Certamente, non meno originale appare anche l’impegno
di Antonio Serra, che le pagine di Fortunato M. Cacciatore
presentano come il primo e più antico scrittore di scienza politicoeconomica. Sotto il segno della categoria dell’ineguaglianza
compare, invece, il pensiero di Grimaldi; di esso Maurizio
Martirano sottolinea, in particolare, il tema del contrasto tra idealità
e realtà della storia. L’interesse etico-politico del pensatore
calabrese non esita a contrapporsi alle teorie di Rousseau, di
Pufendorf, di Wolff e di Hobbes, nell’intento di mostrare
l’“artificiosità” dei vari sistemi metafisici e di portare l’attenzione sul
“vero” uomo naturale, da lui ritenuto non diverso da quello che
abbiamo sotto i nostri occhi. In tale quadro antropologico, dunque,
l’ineguaglianza si presenta come un dato di fatto che, nascente dal
bisogno, è un tratto tipico e stabile della natura socievole
dell’uomo. Seguono due saggi di Romeo Bufalo, il primo dei quali è
dedicato a Francesco Salfi, pensatore che, nel porsi nel punto di
convergenza del vario e complesso panorama intellettuale del
138
Settecento, fornisce un’ideale sintesi tra i motivi offerti dalla cultura
meridionale
dell’epoca,
variamente
rappresentati
dalla
speculazione di Vico, Genovesi, Filangeri, Cuoco, Pagano, da una
parte, con i temi centrali della filosofia illuministica di Locke,
Voltaire, Hélvetius, dall'altra. Egli propone, così, un progetto di
scienza dell’uomo fondata sulla scienza sperimentale, che,
rimodulando la vichiana teoria del verum-factum, classifica i fatti
riportandoli accuratamente a determinati aspetti della natura
umana ed inquadrandoli nella categoria logica non della necessità,
bensì della possibilità e della verosimiglianza. In un secondo
contributo, invece, lo sforzo di Romeo Bufalo va in direzione di
un’interpretazione che allontana il “coscienzialismo” di Pasquale
Galluppi dal cogito cartesiano. e lo avvicina, invece, al “pensiero
meridionale” del Settecento, contraddistinto per una tipica
“impronta” empiristica e sperimentale. Il pensatore calabrese,
infatti, intendendo il fatto primitivo della coscienza nei termini di
percezione immediata dell’esistenza di me, soggetto conoscente, percezione considerata come verità indeducibile e sperimentale -,
radica il pensiero nella vita sensibile dello spirito. In tal modo, il
cogito cartesiano risulta, per così dire, rovesciato; ciò conferisce
all’intera speculazione del Galluppi un’impostazione empiricofenomenica, consistente nel sostenere l’intelligibilità delle cose
come presente già nella sfera percettivo-sensibile.
Un posto di particolare rilievo nell’ambito della tradizione
filosofica calabrese, come afferma Pio Colonnello nel suo saggio,
spetta senz’altro anche a Francesco Fiorentino. Profondo
conoscitore e indagatore del pensiero rinascimentale italiano,
Fiorentino si interroga sul principio di legalità che presiederebbe ai
fatti storici, distanziandosi, in tal modo, dalla posizione che
sull’argomento andava assumendo la storiografia francese di tipo
positivistico. Le scienze morali, infatti, per il pensatore calabrese
che segue in questo la tradizione vichiana, non sono traducibili nei
termini delle discipline naturali. Centrale nell’elaborazione del suo
pensiero è anche la dottrina kantiana, di cui dà un’interpretazione
particolare, che si differenzia decisamente da quella tedesca,
mentre si incrocia con influssi provenienti dalla psicologia
sperimentale ottocentesca, dalla fisiologia e dal pensiero di
139
Herbart, di Galluppi, di Helmotz e di Spencer. Altro esponente
tipico del neokantismo italiano, nell’interpretazione fornita da
Fortunato M. Cacciatore e da Santina Manieri, è Felice Tocco, la
cui originalità è chiarita non soltanto dall’allontanamento dalla
predominante impostazione neoidealistica, ma anche da una
ripresa del criticismo, che converge con le istanze del positivismo
critico, umanistico e metodologico del Villari nel proporre
l'elaborazione di un metodo storiografico che fa del documento e
del fatto umano l’elemento propulsore, limitante le pretese
costruttive del soggetto conoscente.
Se di originalità si parla, certo, non è possibile dimenticare
la figura di Pasquale Rossi, il quale, inserendosi a pieno titolo nel
dibattito culturale dell’Ottocento, facendo proprie le istanze del
positivismo mediato attraverso la lezione marxiana e labrioliana del
materialismo storico e assumendo come oggetto d'indagine
privilegiata la folla, acquista un ruolo di rilievo nella comunità
scientifica internazionale. Teorizzando l’intersezione di istanze di
natura politica con quelle scientifiche, il pensatore calabrese,
osserva Stefania Tarim, suggerisce una scienza dell’educazione di
quel soggetto politico emerso chiaramente solo con la rivoluzione
francese. Come a dire: una vera e propria prospettiva politica deve
tendere a riscattare le masse subalterne, specialmente quelle della
Calabria, di cui Rossi non esita ad elaborare una sottile critica e
analisi storica, politica e sociale. Complessa anche la figura
intellettuale di Felice Battaglia, che, formandosi alla duplice
sorgente della giurisprudenza e della filosofia e passando
dall’iniziale posizione idealistica e dalle simpatie per il gentiliano
Stato etico, attraverso la mediazione dell’esistenzialismo, finisce
per approdare - come osserva Pamela De Patto - sulle rive di un
vero e proprio spiritualismo e col promuovere una rinnovata
filosofia dei valori e un liberalismo etico. Non manca, inoltre, il
riferimento all’importante figura di Antonio Padula, di cui il saggio di
Domenico Scafoglio ha il merito di mettere puntualmente in rilievo
l’afflato riformatore. Il filosofo di Acri, infatti, richiamandosi
all’insegnamento degli economisti della scuola napoletana e al
Genovesi, mobilita tutta la sua ricchezza intellettuale in favore di
un rinnovamento della società calabrese, fornendo di quest’ultima
140
un’analisi meticolosa e, inaugurando così un tipo di etnografia, che
di quella moderna ha già tutte le caratteristiche. Facendo propria la
metodologia di Vico, egli incentra la sua proposta riformatrice sul
concetto di persona. La rinascita religiosa, in particolare, dovrà
farsi carico di una trasformazione dello Stato basata sui valori
patriottici e liberali.
Importante appare anche lo scritto di Luigi M. Lombardi
Satriani
che
testimonia
dell’alta
tradizione
di
studi
demoantropologici diffusasi sul suolo calabrese. Richiamandosi
all’opera di Meligrana, Lombardi Satriani sottolinea l’originalità di
approccio e di risultati raggiunti nel campo della demologia
giuridica calabrese. All’analisi della particolare configurazione che
la teorizzazione della morte assume nella tradizione contadina
calabrese, è dedicato il saggio di Rocco Brianza, il quale,
richiamandosi a Il ponte di San Giacomo di L. M. Lombradi Satriani
e di M. Meligrana, sottolinea la presenza nel mondo contadino di
una sorta di filosofia del sacro naturale o naturalismo sacro, che se
ha la sua origine nei lasciti della filosofia antica, tuttavia si alimenta
anche del pensiero di Telesio, Campanella e Bruno. Chiude la
terza sezione del volume un saggio di Romeo Bufalo sulla
significativa riflessione condotta da Carlo Diano, in pieno clima
neoidealista, sul pensiero greco: essa tende a rimarcare come
caratteristica della classicità l’unicità di forma ed evento, tipica
propria di quel “pensiero mediterraneo” che riesce a collegare,
senza confonderli, piano logico e piano estetico, particolare e
universale.
La quarta parte, riservata alla Cronaca degli orientamenti
filosofici attuali, è aperta da un saggio di Giuseppe Cantarano, il
quale sostiene la “calabresità” del noto esponente del pensiero
debole Gianni Vattimo, coincidente con la riscoperta della
speculazione filosofico-teologica di Gioacchino da Fiore.
Interessante appare anche il contributo di Francesco Lesce sulla
rinascita, a partire dagli anni Novanta, del pensiero "meridiano" nel
Meridione d'Italia, contraddistinto come sforzo culturale, politico e
civile tendente a liberare il Mezzogiorno dalla cosiddetta
“questione” meridionale, col restituirle finalmente autonomia da
quei modelli socio-culturali e politico-economici a cui la
141
modernizzazione lo avrebbe costretto, finendo col distruggerne le
specificità simboliche. Facendo perno sulla tipicità geoculturale,
tale pensiero si salda nel duplice percorso di valorizzazione delle
identità locali e di autogoverno delle città, filtrato attraverso lo
sguardo di un Sud che guarda il Sud: tale progetto vede nella
ripresa dei valori tradizionali non una sorta di autodifesa, ma un
modo di confrontarsi con l’altro, offrendo soluzioni identitarie.
Il saggio di Luigi Rocca, poi, passando attraverso le figure
di Mortati, Rodotà, Ripepe e Corradini, offre in pennellate veloci i
principali orientamenti della riflessione filosofica contemporanea
sul diritto e sulla politica. La sezione è chiusa dal saggio di
Giuseppe Bornino e Santino Cundari, i quali riportando le posizioni
di Valentini, Cotroneo, degli studi telesiani di De Franco, di
Mastroianni, di Siciliani De Cumis e di altri ancora, informano sugli
attuali Percorsi di storiografia filosofica in Calabria.
Da quanto illustrato, appare chiaramente l’originalità del
volume. Dando voce per lo più a personalità costrette
ingiustamente all’oblio da una certa storiografia, perché
considerate “minori”, questa Storia del pensiero filosofico in
Calabria ha il merito di delineare nei suoi tratti essenziali, ma
nondimeno pregnanti, una tradizione di pensiero indubbiamente
viva e feconda.
142
LA PERCEZIONE DI SÉ
ATTRAVERSO LA STRUTTURA DEL COMPORTAMENTO
di Cristina Manzo
È una buona cosa vederci come ci vedono gli altri. Potremmo fare tutti i
tentativi che vogliamo, ma non riusciremo mai a conoscere appieno noi stessi,
specialmente la nostra parte peggiore. Ciò può accadere soltanto se non siamo
arrabbiati con i nostri critici, ma accettiamo senza offenderci qualsiasi loro
affermazione.
Mahatma Gandhi
Viktor: Chi conosce chi? Tu conosci te stessa?
Lena: Non del tutto, ma a volte mi sembra di conoscermi bene. Poi
all'improvviso capita qualcosa, ti guardi da fuori e pensi: «Sei tu o non sei tu?». Ti
succede mai?
Viktor: Di continuo*.
Ognuno di noi, almeno una volta, si sarà trovato a doversi
chiedere: «Chi sono io? Sono davvero quello che penso di
essere?» E soprattutto, «La visione che ho di me stesso,
corrisponde a quella che gli altri hanno di me?» Interrogativi
inderogabili che ci accompagnano all’esistenza, quando ci
troviamo in situazioni imbarazzanti che sembrano prendere la
piega dell’inganno o della malafede, quando siamo convinti che le
nostre intenzioni siano state male interpretate, quando non
riusciamo a percepire chi abbiamo di fronte. Sorge doveroso il
nostro esame di coscienza: ”È colpa mia, è stato il mio
atteggiamento a generare l’equivoco? Ho dato di me una falsa
impressione? O inconsciamente ho solo lasciato trasparire la mia
verità senza schermi? Cioè, io sono veramente così come vengo
percepito, quando abbasso il muro delle mie difese, che erigo
continuamente, solo in ossequio doveroso, alla società che lo
richiede? Esiste un punto in cui è possibile che quello che noi
siamo realmente, possa coincidere con la visione che l’altro ha del
nostro sé? Quanto conta avere una corretta misura di sé nel nostro
143
relazionarci con il mondo, e nell’autorealizzazione della nostra
esistenza?»
Si potrebbe dire che sicuramente la misura di sé è
fondamentale. Costruire un’esistenza su una falsa idea del nostro
sé è in un certo senso come innalzare un grattacielo su delle fragili
fondamenta che prima o poi sono destinate a crollare, e le cui
conseguenze si allargheranno come onde concentriche,
coinvolgendo inesorabilmente altri da noi. Bisogna però
considerare, che il nostro vivere è una metamorfosi continua,
l’essere che prosegue il suo cammino nel continuo divenire non
può in alcun modo essere ancorato a una figura iconografica di sé
e, in conseguenza di ciò, la percezione che ne è data non può
restare immutata. Siamo sempre noi, anche quando le circostanze
della vita e la nostra crescita interiore ci portano a cambiare, e con
questi cambiamenti, cambia anche la soglia di percezione del
nostro sé e quella dell’essere percepiti dagli altri, anzi cambia
persino il nostro modo di percepire gli altri, e le cose che sono
all’esterno del nostro sé, in base alla percezione che abbiamo di
noi stessi.
La misura di sé
“L'uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in
1
quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono” . Con
“uomo” (secondo l'interpretazione dell'asserzione fatta da Platone)
Protagora intese il singolo individuo e con “cose” gli oggetti
percepiti attraverso i sensi. Quindi, molto semplicemente, il sofista
voleva dire che la realtà oggettiva appare differente in base agli
individui che la interpretano: «quali le singole cose appaiono a me,
tali sono per me e quali appaiono a te, tali sono per te: giacché
2
uomo sei tu e uomo sono io».
Nel libro La misura di sé tra virtù e malafede, Giovanni
Invitto scrive:
Si tratta di mettere in conto che il sé è in permanente divenire, perché la
realtà, il contesto, gli eventi chiedono integrazioni, crescite, tagli. Allora
abbiamo la consapevolezza del sé, di essere un sé». Ma cos’è il sé di cui
ognuno di noi dovrebbe o vorrebbe avere misura? E con quali categorie
144
misurarlo? Ed è possibile questa misurazione che ci permetterebbe di
evitare sopravvalutazioni o sottovalutazioni di quello che “siamo” o
potremmo “essere?”3
La genesi del sé, nel processo sociale, è una condizione di
controllo, il sé è un emergente che mantiene la coesione del
gruppo. La volontà individuale viene armonizzata attraverso i
mezzi di una realtà ben definita. Nella teoria sociale di Mead ci
sono due dimensioni: l’interiorizzazione degli atteggiamenti degli
altri verso se stessi e verso gli altri, e l’interiorizzazione degli
atteggiamenti degli altri verso gli aspetti dell’attività sociale
comune. Il sé fa riferimento ai progetti sociali e ai traguardi.
È con i mezzi del processo di socializzazione che
l’individuo è portato ad assumere gli atteggiamenti degli altri nel
gruppo: e gli altri sono coinvolti con lui nelle sue attività sociali. Il
sé è perciò uno dei più sottili ed efficaci strumenti di controllo
sociale. Possiamo provare a immaginare il nostro sé suddiviso in
tre parti: un sé che denota il senso che una persona ha di sé ed è
unico, tranne che nelle patologie, un sé che è la totalità degli
attributi di una persona incluse le credenze su sé stessi ed il sé
che simboleggia il tipo di persona che siamo considerati dagli altri.
Il secondo e il terzo sé possono essere molteplici, visto che
«mentre nello spazio si può avere un unico sé, poiché esiste in un
4
solo corpo, nel tempo la persona può avere e ha molti sé» ,
considerato nondimeno che esistono vari sé chiamati in causa in
occasioni diverse e nei dialoghi con persone diverse.
Così pare inevitabile, come scrive nel suo libro Invitto, che
dobbiamo necessariamente accettare il nostro sé come
provvisorio, sapendo che nell’averne misura possiamo chiedergli
5
oggi, alcune cose, che domani potrebbero diventare altre .
Tuttavia, il nostro sé dovrebbe coincidere con la nostra identità, e
viviamo in un mondo che è saturo di singolarità tra le pluralità, che
si dimenano in un equilibrio barcollante, alla continua ricerca di
senso, dove diventa difficoltoso per l’uomo riuscire ad attribuire
questa identità prima a se stesso e poi agli altri. In un mondo dove
niente è come ci appare dobbiamo possedere una grande abilità
per distinguere la nostra vera identità e divenirne padroni
consapevoli.
145
La virtù nella misura di sé
Forse, un aiuto in questo difficile percorso potrebbe
provenire dalla virtù, che è sin dall’antichità considerata simbolo di
medietà, come già sosteneva Aristotele. Ma cosa si intende
esattamente per virtù? Qualcosa che è insito dentro di noi o che si
impara crescendo? Se si impara crescendo, bisogna riconoscere
che è insegnabile. La virtù [areté] è insegnabile [didactón]? Si
produce con l’esercizio, o si possiede per natura? Per rispondere
al problema è necessario scoprire qual è l’essenza della virtù. Nel
Menone, dialogo platonico che si svolge tra Menone e Socrate,
incentrato sul rapporto tra la virtù, che si giunge ad identificare con
la conoscenza, e la teoria delle idee, vengono affrontati proprio
questi due problemi: l'essenza della virtù e l'insegnabilità della
virtù. Socrate definirà la virtù in modo ipotetico come una qualità
posseduta dall’anima, e se essa è insegnabile dovrà essere
scienza, perché solo la scienza è insegnabile. Tuttavia mentre
appare chiaro che ci sono scolari che desiderano apprendere la
virtù, (come lo stesso Menone) secondo Socrate non esistono
maestri capaci di insegnarla.
Le conclusioni sembrerebbero, che anche la virtù è una
dimensione strettamente soggettiva, che dipende dalla dimensione
interiore del nostro sé. Dunque: l’idea regolativa della misura di sé,
si affida unicamente alla conoscenza che abbiamo di noi stessi.
L'anima, che conosce le relazioni logico-matematiche, non è uno
6
strumento privato (òrganon ìdion), ma qualcosa che è, in quanto
ente conoscente, intrinsecamente pubblico e interpersonale,
perfino quando ha a che fare col pensiero di un pensatore solitario:
“come un ignorante io cerco di spiegarti la cosa; ma insomma
l'anima, quando pensa, io non la vedo sotto altro aspetto che di
persona la quale conversi (dialégesthai) con se medesima,
7
interrogando e rispondendo, affermando e negando.” Ma la
cosiddetta anima ha ancora la capacità di conoscere se stessa e il
8
proprio soggetto? . Il conoscere se stessi può sembrare in
opposizione al conoscere il mondo, ma le due conoscenze
possono considerarsi due facce di una sola medaglia: la filosofia è
slancio dell'uomo verso il conoscere e una conoscenza viva e
146
attuale non può prescindere dalla mente che conosce (e dai suoi
condizionamenti). L'esortazione “conosci te stesso” è un motto
greco (Γνῶθι σεαυτόν, gnôthi seautón), scritto sul tempio
dall'Oracolo di Delfi e può ben riassumere l'insegnamento di
Socrate, in quanto esortazione a trovare la verità dentro di sé
anziché nel mondo delle apparenze. La locuzione latina
corrispondente è Nosce te ipsum. La frase scritta sul tempio,
tradotta recita: "Uomo, conosci te stesso, e conoscerai l'universo e
gli Dei". Accanto al “Conosci te stesso” era scritto “Niente di
troppo” che, attestazione o invito che fosse, evidentemente era
comunque collegato al se stesso. La seconda formula voleva dire il
rifiuto di ogni eccesso, di ogni presunzione infondata, della
9
tracotanza. Il significato originario è incerto, deducendo da alcune
formule a noi pervenute (nulla di troppo, ottima è la misura, non
desiderare l'impossibile), sarebbe quello di voler ammonire a
conoscere i propri limiti, «conosci chi sei e non presumere di
essere di più»; sarebbe stata dunque una esortazione a non
cadere negli eccessi a non offendere la divinità pretendendo di
essere come un dio.
Del resto tutta la tradizione antica mostra come l'ideale del
saggio, colui che possiede la sophrosyne (la saggezza), sia quello
della moderazione, cioè della misura. Un concetto simile si trova
anche nel monito di Sant'Agostino: “Noli foras ire, in te ipsum redi,
10
in interiore homine habitat veritas”. Il processo conoscitivo,
sostiene infatti Agostino, non può che nascere all'inizio dalla
sensazione, nella quale il corpo è passivo, ma poi interviene
l'anima che giudica le cose sulla base di criteri che vanno oltre gli
oggetti corporei. Si può notare come Agostino assimili quei concetti
perfettissimi alle idee di Platone, ma, diversamente da
quest'ultimo, egli le concepisce come i pensieri di Dio che noi
intuiamo non in virtù della platonica reminiscenza, ma per
illuminazione operata direttamente da Dio. L'intelletto umano trova
la verità come oggetto ad esso superiore: la verità misura di tutte le
cose, e lo stesso intelletto è “misurato” rispetto ad essa, al punto
tale che in riferimento alla verità non si potrebbe neppure parlare
propriamente di oggetto, bensì di soggetto. Per Platone, inoltre se
in generale l’amore rende cieco l’uomo, in particolare l’uomo
147
mediocre è accecato dall’amore di sé, che lo rende incapace di
distinguere il vero ed il giusto. L’uomo davvero grande è invece
profondamente umile, disposto a riconoscere e ad ammirare la
superiorità negli altri.
Il sé nella comunicazione con l’altro
Quando avremo imparato a conoscerci e a comunicare
con intelligenza emotiva, saremo veramente padroni dei nostri
pensieri, delle nostre emozioni, delle nostre scelte, del nostro
comportamento e della nostra vita. Saremo in grado di riconoscere
e accettare i nostri limiti e i nostri punti di forza. Tutti concordano
sull'importanza di un’efficace comunicazione come conditio sine
qua non per creare relazioni sane e reciprocamente gratificanti.
Nonostante ciò, comunicare bene diventa sempre più difficile.
Basta guardare le innumerevoli situazioni di conflitto interpersonale
che finiscono inevitabilmente nello sterile gioco a somma zero, che
vede tutti perdenti, anche se qualcuno conserva l'illusione di aver
vinto a spese dell'altro. La risposta al perché questo accada
sembra essere che non siamo emotivamente intelligenti,
manchiamo di quella forma sofisticata, ma indispensabile di
intelligenza umana di livello superiore, che è appunto l'intelligenza
emotiva, e così il nostro modo di comunicare risulta inefficace e
inappropriato, qualche volta anche socialmente scorretto, e
comunque disfunzionale, rispetto agli obiettivi in gioco. È proprio
l'intelligenza emotiva a fare la differenza.
Se si avesse maggiore consapevolezza di sé e del proprio
stile di comunicazione, si eviterebbero tanti errori nel rapportarsi
agli altri. È importante rendersi conto che quando si comunica solo
con la testa razionalizzando sempre tutto, si arriva al confronto o
alla discussione con un sé fragile, conflittuale, carico di ansia e
paure e generalmente questo porta ad uno scontro tra due
persone bloccate da emozioni angoscianti, che si sentiranno
reciprocamente minacciate e insicure, e quindi più propense a
stare sulla difensiva e a vedere l'altro come un nemico da
affrontare e battere a tutti i costi, con il risultato di trasformare un
costruttivo incontro dialogico, per effetto della dissonanza
cognitiva, in una situazione di aspro conflitto che generalmente
148
diventa guerra psicologica ad oltranza. Chi perde l’etica della vita
e non vive a livello psicospirituale, entra in un delirio di
onnipotenza. Vuole essere potente proprio perché è un im-potente,
un incapace. La parola è, per Merleau-Ponty, un corpo attraverso il
quale appare un’intenzione. La parola non è un semplice
automatismo al servizio del pensiero, ma ne è lo strumento di
attualizzazione. Il pensiero si realizza veramente solo quando ha
11
trovato la propria espressione verbale. Con il dialogo non solo
conosco l’altro, mi apro e mi dono verso di lui con una forte e
generosa disponibilità d’animo, ma posso anche ritrovarmi in lui,
avvicinato dalle stesse paure, dalle medesime riserve, in una
iniziale forma di chiusura che, a suo modo, nasconde,
paradossalmente, un insopprimibile bisogno di apertura. Si tratta di
un percorso ermeneutico di vicendevole arricchimento, un’opera di
mutuo e reciproco riconoscimento che mette in risalto certezze e
presunte verità, in un gioco di personalità che si incontrano per
mediare le prospettive e aspettative: “Comunicare con l’Altro vuol
dire avviare un’attività di corpi e, in questo, è pure la parola. Anche
il timore dell’artista, vedi il caso di Cézanne e quanto ne scrive
Merleau-Ponty, è generato dalla risposta che si attende dallo
sguardo dell’altro alla propria visione. Perché un quadro non può
12
né deve essere spiegato ma solo percepito.” .
Con il dialogo, testimonianza per Socrate di una ricerca
interiore e di un cammino verso la verità e la sapienza, si possono
superare i limiti tratteggiati dall’Io individuale, il quale si renderà
accogliente, disponibile, tollerante, pronto ad uscire da sé perché
fiducioso nella reciprocità. In Sartre ed Heidegger la
comunicazione, intesa come relazione con l'altro richiede il
superamento di sé stessi, la rinuncia alle proprie caratteristiche
esistenziali, alla propria individualità al fine di generare il “conflitto”
reciproco e l'annullamento delle proprie coscienze individuali. In
senso generalissimo parliamo di coscienza per indicare una certa
capacità: la capacità ( propria dell’uomo)
di cogliere la
manifestazione dell’essere (ovvero della realtà) e di esprimerla in
13
giudizi. La coscienza è detta “morale” in quanto è anche capacità
di cogliere il bene (l’essere come bene) e di valutarlo: la
149
valutazione del bene ontologico dà luogo a “giudizi di valore” (cioè
14
giudizi di apprezzamento sulla desiderabilità di qualcosa).
La valutazione del bene morale dà luogo a “giudizi morali”
15.
(cioè giudizi sulla qualità morale di comportamenti e azioni) In
tedesco si distingue lessicalmente tra la coscienza nel senso
generalissimo di consapevolezza (Bewusstsein) e la coscienza in
senso specificamente morale (Gewissen). “Coscienza” è la
traduzione del greco synéidesis (da syn+idéin) e del latino
conscientia (da cum+scire): entrambe le parole esprimono un “convedere” o un “con-sapere”. Il termine greco compare nei testi
pitagorici (Pitagora raccomandava ai suoi seguaci di fare ogni
giorno, prima di alzarsi e prima di addormentarsi, l’“esame di
16
17
coscienza”), il termine latino compare in Seneca .
Struttura del comportamento e percezione: io nel mondo
Sul piano squisitamente filosofico, Merleau-Ponty
radicalizza il rapporto tra coscienza e mondo e prende le distanze
dalla prospettiva sartriana, ancora fondata sul dualismo cartesiano
di res extensa e res cogitans. Infatti, com’è noto, la
contrapposizione tra il per sé e l’in sé di cui parla Sartre, che
concepisce il per sé quale puro non-essere e l’in sé quale puro
essere, è identificabile con la rappresentazione dualistica del
mondo fornitaci da Cartesio. Rappresentazione dualistica che di
fatto culmina in una filosofia riflessiva del “soggetto puro” (cogito
ergo sum) da cui deriverebbe l’intera esistenza. Soggetto e oggetto
invece vengono a costituirsi, sin dalla “Struttura del
comportamento” come rapporto di implicazione reciproca e non di
fronteggiamento o contrapposizione. Qui, le analisi sulle strutture
comportamentali condotte da Merleau-Ponty si rivelano essere una
vistosa critica dei risultati della psicologia contemporanea, dal
comportamentismo all’introspezionismo, alla psicologia della
forma.
Ma, se nella Struttura del comportamento il problema era
quello di delineare, contro le concezioni della psicologia
dominante, il rapporto tra l’organismo che percepisce e il suo
ambiente, nella Fenomenologia della percezione il compito diventa
più radicale. È in quest’opera, infatti, che il filosofo imprime una
150
svolta decisiva al suo itinerario di pensiero: la classica opposizione
tra soggetto e oggetto, direttamente derivante dalla
contrapposizione tra essenza ed esistenza si colloca dentro una
nuova prospettiva, non più logica o psicologica, ma esistenziale. Il
nostro essere-al-mondo svela come primaria la nostra esperienza
percettiva che co-nasce all’intersezione del soggetto e dell’oggetto,
dell’io e del mondo. Vengono così respinti sia il realismo sia il
razionalismo. Il primo in quanto priva la percezione della facoltà di
“inaugurare la conoscenza”, disgregandola in una miriade di
sensazioni; esso risolve infatti l’atto di coscienza in una mera
concatenazione di avvenimenti, ribaltandolo drasticamente
nell’esteriorità delle cose e nascondendoci così gli orizzonti umani,
culturali e naturali entro cui si svolge la nostra vita. In altri termini,
riduce il percepito ad una somma di proprietà fisiche, degradando
a illusione il mondo culturale - “mentre tale mondo è l’alimento
della nostra esperienza” ed è quello in cui siamo immersi da
sempre. E, in pari tempo, “sfigura anche il mondo naturale”
riducendolo ad un insieme di stimoli e qualità. La percezione è,
quindi, comunione, coesistenza, relazione vissuta e ambigua degli
elementi soggettivi e oggettivi.
Essa non è né uno stato o una qualità, né, tantomeno, la
coscienza di uno stato o di una qualità. Bisogna dimostrare che il
soggetto della percezione non è né un pensatore che annota una
qualità né un ambito inerte che sarebbe colpito o modificato da
essa, bensì una potenza che “co-nasce” ad un certo contesto di
esistenza. Si capisce, in tal senso, perché il soggetto della
percezione è - per Merleau-Ponty - anonimo. Scrive infatti il
filosofo: ”se volessi tradurre esattamente l’esperienza percettiva,
18
dovrei dire che si percepisce in me e non che io percepisco”
La percezione è dunque “anonima”, “fungente” e si installa
“nel mondo del Si”. Questo “Si” percettivo prelude così a quella
presenza inalienabile di me nel mondo e del mondo in me che è
costitutiva dell’essere-al-mondo. Di qui la valenza ontologica che
presto essa acquista nel discorso di Merleau-ponty. “Essere-almondo” significa essere in comunicazione interna con esso prima
di qualsiasi atto riflessivo. Il corpo, nodo vivente di interiorità ed
esteriorità, sopporta e realizza questa specie di permutazione o
151
scambio delle rispettive situazioni del soggettivo e dell’oggettivo.
Esso è, insieme, senziente e sentito; è, dunque, rapporto di sé con
sé e vincolo tra me e le cose. La percezione diviene così il filo
conduttore che apre il nostro esserci all’alterità, divenendo così,
geneticamente al di là di ogni riduzione idealistica o positivistica, il
luogo originario entro cui accade il mondo. L’esigenza di mettere a
fuoco il primato del momento percettivo, inteso come momento
unitario del modo in cui l’uomo sente e vive, permea l’intera
riflessione merleau-pontyana, volta ormai a radicalizzare, fuori da
ogni pensiero metafisico, l’interrogativo filosofico fino a risalire alla
questione originaria dell’Essere. L’opera prima di Merleau-Ponty,
La structure du comportement, si chiudeva con questa domanda:
“È possibile pensare la coscienza percettiva senza sopprimerla
come modo originale, è possibile conservarne la specificità senza
renderne impensabile il suo rapporto con la coscienza
19
intellettuale?” ” [...] La nostra esperienza è nostra, il che significa
due cose: che non è misura d’ogni essere in sé immaginabile, e
che tuttavia è coestensiva ad ogni essere di cui possiamo aver
20
nozione” L’individualità è la cifra della mia universalità: sono, in
quanto soggetto, estensibile, se è vero che, in quanto esistente,
sono coesistente; «la mia esperienza, appunto in quanto mia,
21
m’apre a ciò che non è me”. Ogni cogito non esprime, come
voleva il cartesianesimo, la certezza di uno spirito pensante per se
stesso, quanto piuttosto il fatto di esistere a condizione che esista
un altro da sé. L’homo mensura non vuole più essere principio,
paradigma, legge, ma, proprio sfuggendo a dogmatismi, si propone
22
come eco, come metro dall’andatura titubante.
Bisogna rinunciare a cercare l’origine del senso in una
coscienza costituente, dal momento che l’ego trascendentale non
rinvia ad altro che ad una positività della costituzione e
rappresenta una condizione privilegiata, nonché astratta. “Ora io
chiuderò gli occhi, mi turerò le orecchie, distrarrò tutti i miei sensi,
cancellerò anche dal mio pensiero tutte le immagini delle cose
corporee, o almeno, poiché ciò può farsi difficilmente, le reputerò
vane e false; e così intratterrò solamente me stesso e
considerando il mio interno, cercherò di rendermi a poco a poco
23
più noto e familiare a me stesso”. «l’interiore e l’esteriore sono
152
24
inseparabili. Il mondo è tutto dentro ed io sono tutto fuori di me».
La struttura della percezione implica, in forma inderogabile,
l’intenzionalità, che è sempre un protendersi oltre, verso il
percepito. Non posso, in definitiva, rendermi familiare a me stesso
se non attraverso le continue e obbligate pro tensioni, le incursioni
verso ciò che erroneamente viene definito oggetto, e che in realtà
descrive in maniera profonda la mia stessa soggettività. L’io e il noi
sono temporali proprio nella misura in cui sono strutturalmente
incompiuti e quindi funzionalizzati, e perciò costituiscono delle
storie nel corso delle quali succedono delle cose e sopraggiungono
degli eventi. L’io e il noi sono due fasi dello stesso processo,
perché innanzitutto, condividono lo stesso fondo pre-individuale in
25
cui si costituisce l’orizzonte transindividuale. Siamo in presenza
di un trascendentale totalmente radicato nell’orizzonte tellurico;
l’opacità del cogito tacito fa appello ad una coscienza attraversata
dalla contingenza, che si riconosce come indissolubilmente e
irrevocabilmente relazionata al mondo in un mutuo rapporto.
Laddove la totalizzante trasparenza del cogito cartesiano
faceva leva solo su se stessa, l’opacità di quest’altro genere di
cogito vuole, implica l’altro. Il punto è: com’è possibile pensare
questo nuovo cogito al di fuori del linguaggio se è vero che, come
lo stesso Merleau-Ponty afferma, non c’è pensiero fuor di parola?
Nella traduzione da un cogito tacito ad uno parlante, qualcosa
resta invischiato in un’ambiguità, qualcosa resta nell’inarticolato,
così come avviene sempre, quando di traduzione si parla. La
transizione vive di mancanza, che non va però letta come perdita:
è vero che non vedo, ma è vero anche che intravedo. Il pensiero
occidentale ha incastrato la meditazione ontologica tra due
estremi: l’intuizione dell’essere e la ne intuizione del nulla.
Entrambi questi atteggiamenti sono stati solidali: essi hanno
trattato l’essere e il nulla come oggetto di pensiero, totalmente
pieni, da un lato un essere pieno di essere, dall’altro un nulla vuoto
del tutto; il negativismo assoluto non è che l’altra faccia di un
positivismo assoluto. Il nulla invece non va pensato come buco,
ma come quello spazio cavo costitutivo dell’essere; un nulla inteso
come annientamento radicale è solo un nulla di principio, in una
153
pluralità di modi che ci impone di slabbrare costantemente i
margini dei saperi.
La coscienza e la malafede
In che senso aver coscienza è un vedere-con (syn) o un
sapere-con (cum)? Nel senso che la coscienza è la capacità, tipica
di un soggetto razionale, di vedere qualcosa (qualunque cosa)
sullo sfondo di qualcos’altro, cioè di un orizzonte che ha l’ampiezza
dell’essere. Vedere qualcosa nell’ambito di tale orizzonte,
comporta la possibilità di relativizzare quel qualcosa:
problematizzarlo, paragonarlo ad altro. La coscienza, dunque, è un
vedere, che è capace di vedere sempre più e sempre meglio; e
quindi di ri-vedere (e anche, eventualmente, di ravvedersi sul già
visto). Proprio perché è strutturale alla coscienza avere un
orizzonte, non esiste una coscienza “chiusa”: la coscienza è, in
quanto tale, aperta su un orizzonte senza limiti. Quando essa
pretende di chiudersi, cioè di non vedere qualcosa che pure è in
vista, allora è in “malafede”, cioè tradisce se stessa. La malafede è
l’atteggiamento di chi fa finta di non sapere quello che in realtà sa.
La coscienza è appunto in malafede, quando socchiude i propri
occhi, ignora l’orizzonte in cui le cose le si offrono, e si lascia
vincere dalle cose (in quanto non le relativizza più in riferimento
all’orizzonte di cui pure è capace). La malafede è la scelta di non
scegliere, ma di farsi scegliere dagli eventi e dalle loro circostanze
passionali: essa è, insomma, la scelta occulta di agire in modo non
26
responsabile, bensì reattivo. Si può ben dire, allora, che quella
tra responsabilità e reattività sia la scelta cui la coscienza è tenuta
27
in primo luogo.
La coscienza in senso generalissimo ha presente
l’orizzonte dell’essere come un orizzonte strutturato da alcuni
elementari principi: tra tutti ricordiamo il “principio di non
contraddizione”, secondo cui ogni realtà è se stessa, e non è l’altro
28
da sé. Analogamente la coscienza morale ha presente un
orizzonte, quello del bene, che è a sua volta strutturato da un
principio fondamentale: la legge morale. La tradizione filosofica,
dall’età patristica in poi, distingue tra due aspetti della coscienza
morale: uno intuitivo e uno applicativo. La coscienza morale è una
154
capacità che ha bisogno di condizioni opportune per passare dalla
potenza all’atto. Il primo è l’approfondimento della capacità di
riconoscere la legge morale; il secondo è la crescita della
responsabilità. Il primo catalizzatore è senz’altro l’educazione che
si riceve in famiglia: educazione che ci introduce, in prima battuta,
29
ad un ethos,
cioè ad un contesto vissuto e condiviso di
atteggiamenti e di rapporti morali. La coscienza procede
ordinariamente formulando giudizi, e non seguendo impulsi. Ci
sono comunque casi nei quali è talmente evidente il bene da fare o
il male da evitare, che essa procede quasi intuitivamente. Si parla
allora di “voce della coscienza”.
Nella sua Apologia, Socrate parlava in proposito di una
“voce” divina che, in alcuni casi, gli vietava certi comportamenti
incompatibili con la sua dignità. Non sono mancate, nella storia
della filosofia, voci che hanno preteso che la coscienza fosse
qualcosa di assoluto e indipendente. Si tratta di una concezione
che trova la sua espressione massima nell’idealismo romantico di
J. A. Fichte, il quale afferma che «la coscienza non erra mai e non
può mai errare», e, in quanto è «essa stessa giudice di ogni
30
convinzione, non conosce alcun giudice sopra di sé». A ben
vedere, lo stesso Nietzsche è l’erede (tardo-romantico) di una
simile posizione, quando descrive l’“oltre-uomo” come colui che
riscrive le “tavole della legge” (cioè, come colui che reinventa per
31
sé, di volta in volta, la legge morale). Il maggior teorico della
autonomia e della libertà della coscienza è stato Tommaso
d’Aquino, che ne parla in riferimento, non solo alla legge positiva,
ma anche alla Rivelazione. Da un lato, Tommaso riconosce che «è
cattiva la volontà che non concorda con la ragione, anche quando
questa è errante». Infatti, la volontà inevitabilmente si rapporta alla
qualità morale di un possibile contenuto d’azione, «secondo il
32
modo in cui tale contenuto le è proposto dalla ragione» In altre
parole, anche la verità rivelata deve passare attraverso l’inevitabile
riconoscimento della coscienza, e non può dunque venire imposta
coattivamente (se non in modo violento e velleitario). Riconoscere
che la coscienza è un vedere nel quale non possiamo essere
sostituiti (in quanto nessuno può vedere al posto di un altro), non
vuol dire concepirla come sottratta a qualsiasi rapporto. Infatti, se è
155
vero che si vede da soli, è altrettanto vero che si può guardare e di
fatto, sempre si guarda, insieme ad altri; altri che possono farci
notare qualcosa che prima non vedevamo: l’educazione consiste
appunto in questo processo. La coscienza che non intenda
chiudersi nella malafede, deve rimanere aperta a guardare tutto
quel che c’è da vedere; e quindi accettare anche di essere educata
e istruita da altre voci, purché essa abbia buone ragioni per
riconoscerle come autorevoli.
Il sé come recita e malafede
Come termine filosofico, Sartre ha utilizzato “malafede”
(mauvaise foi) per definire i “concetti di malafede”, che sono quelle
affermazioni che in una posizione esistenziale devono essere
credute, contemporaneamente, sia vere che false. Chi abbraccia
uno di questi concetti non sta ingannando altre persone, e
nemmeno si può dire che commetta un errore logico; ma sta, in un
certo senso, ingannando sé stesso. Il termine “malafede” è dunque
utilizzato in un senso lontano dal suo significato comune. Sartre
sceglie come oggetto di quest’analisi la malafede perché non è
soltanto uno dei comportamenti in cui l’uomo prende atteggiamenti
negativi, ma un comportamento, al tempo stesso, essenziale alla
realtà umana, e tale che in esso la coscienza invece di dirigere la
negazione verso l’esterno la rivolga verso se stessa. Ma cosa
intende Sartre per malafede? Non la semplice menzogna.
Quest’ultima infatti implica, da un lato la dualità dell’ingannatore e
dell’ingannato, e dall’altro la completa coscienza da parte
dell’ingannatore della completa verità che egli maschera. Se la
malafede è menzogna a sé, colui che si pone in malafede
33
maschera la verità a se stesso. Come dice Invitto nel suo libro,
infatti, “La malafede è un mentire a se stessi, la menzogna è
mentire agli altri. Ma perché mentiamo a noi stessi? Perché non
accettiamo la coscienza come Nulla, cioè soltanto come spazio di
34
attraversamento dei fenomeni.
Eccolo che avanza: "Ha il gesto vivace e pronunciato, un
po' troppo preciso, un po' troppo rapido, viene verso gli avventori
con un passo un po' troppo vivace, si china con troppa premura, la
voce, gli occhi, esprimono un interesse un po' troppo pieno di
156
sollecitudine per il comando del cliente […]. Tutta la sua condotta
sembra un gioco. Si sforza di concatenare i movimenti come se
fossero degli ingranaggi che si comandano l' un l' altro, la mimica e
perfino la voce paiono meccanismi; egli assume la prestezza e la
35
rapidità spietata delle cose. Gioca, si diverte." Sta giocando,
naturalmente, ad essere cameriere. Non c'è bluff, il cameriere
realizza la sua condizione di cameriere in perfetta sincerità. Una
condizione che presuppone, come tutte le altre, una serie di atti,
riflessioni e concetti, come, ad esempio, l’obbligo di alzarsi ad una
certa ora, provvedere alle pulizie del locale, apparecchiare e
sparecchiare i tavoli, i diritti alla retribuzione, alle mance, ecc...,
anche se tutto questo, in un certo senso, rinvia al trascendente.
Chiunque di noi, per esercitare il proprio particolare lavoro,
deve per forza, sempre in quel certo senso recitare la particolare
parte che questo richiede. Credo sia assolutamente ovvio. Ma è
altrettanto ovvio che il cameriere in sé non è un cameriere (non
come, ad esempio, un qualsiasi oggetto è quel dato oggetto: una
penna, un bicchiere sono oggettivamente penna e bicchiere): egli
sta rappresentando l' essere cameriere, e purtuttavia non sta
mentendo quando sente d' esserlo. Ecco che egli si trova nella
condizione d' essere ciò che non è. Noi non siamo alcuno dei
nostri atti o comportamenti. "Il buon parlatore è colui che recita a
parlare, perché non può essere parlante [...] Perpetuamente
assente al mio corpo, ai miei atti, sono a dispetto di me stesso la
'divina essenza' di cui parla Valéry. Non posso dire né che sono
qui, né che non ci sono, nel senso in cui si dice 'questa scatola di
fiammiferi è sulla tavola'; sarebbe confondere il mio "essere-nelmondo” con un “essere-in mezzo-al mondo”[...] Da ogni parte
36
sfuggo all' essere e tuttavia sono." Con quale certezza, quindi,
possiamo dirci sinceri? Esiste un' oggettiva possibilità di
identificazione con la sincerità?
Poniamo il caso che un uomo sia cattivo e se lo confessi.
Egli, con l'atto della sincerità, contempla sé stesso nell' esercizio
della sua “libertà di scegliere il male” ed in tale contemplazione la
disarma, perché essa non è più nulla al di fuori dal piano del
determinismo: confessandola egli le contrappone la sua libertà, il
suo avvenire è potenzialmente vergine, tutto sarà possibile. Così
157
l’uomo cattivo sincero si costituisce come ciò che è per non
esserlo. La sincerità ha dunque la stessa struttura essenziale della
malafede. “Se la malafede è possibile, è perché essa è la minaccia
immediata e permanente di ogni progetto dell' essere umano, è
perché la coscienza nasconde nel suo essere un rischio
permanente di malafede. E l' origine del rischio è che la coscienza,
nel suo essere e contemporaneamente, è ciò che non è, e non è
37
ciò che è.”
In conclusione di questo lavoro, Invitto sembra evidenziare
che è una speranza puramente utopica, quella di poter stabilire
che esista una corretta valutazione della misura di sé. Infatti, se
anche volessimo considerare che lo sguardo degli altri possa
anche essere il nostro specchio, esattamente come nella storia di
Uno
nessuno
centomila
di
Pirandello,
dipenderebbe
esclusivamente dalla percezione di noi stessi poterci riconoscere
nella visione che ci viene rimandata da tutto ciò che è altro da noi,
con il rischio di avere anche seri problemi con la nostra stabilità
psichica. Quindi ”Il sé è in interiore ma non è veritas: lasciamolo in
noi come idea regolativa, come l’orizzonte che è linea illusoria, che
non attingeremo mai, ma che comunque, nel momento in cui lo
poniamo come linea ipotetica da perseguire, ci fa compiere
davvero un “cammino in avanti,” ci fa progredire e accumulare
38
esperienze del nostro essere.”
*Lunga felice vita (in russo Долгая счастливая жизнь, Dolgaya šastlivaya žizn) è
un film del 1966 diretto da Gennadij Špalikov.
1
PLATONE, Teeteto, 152a (Protagora fr.1)
2
Ivi, 152a
3
G. INVITTO, La misura di sé tra virtù e malafede, Mimesis, Milano-Udine 2012,
pp.10-11.
4
R. HARRE, (1998). The Singular Self. London: SAGE; La singolarità del sé.
Introduzione alla psicologia della persona, Raffaello Cortina, Milano 2000, p. 190.
5
G. INVITTO, La misura di sé tra virtù e malafede, cit., p. 14.
6
Platone, Teeteto,. cit., 85d.
7
Ivi, 189e-190d
8
G. INVITTO, La misura di sé tra virtù e malafede, cit., p. 22.
9
Ibidem.
10
AGOSTINO, De vera religione, XXXIX.
11
La conscience et l’acquisition du language in Merleau-Ponty à la Sorbonne.
Résumé de cours 1949-1952, Cynara, Grenoble 1988, p. 39.
12
Invitto, op. cit., p. 91.
158
13
All’interno della manifestazione del reale, di cui siamo capaci, si dà anche il
nostro io: si parlerà allora di “auto-coscienza”
14
Esempio di un giudizio di valore: “questo tuo scritto è valido, e merita di essere
conosciuto”.
15
Esempio di giudizio di coscienza: “è bene che io vada a lavorare, anche se oggi
non ne ho voglia”
16
Cfr. PORFIRIO, Vita Pythagorae, 40; Giamblico, De pythagorica vita, 356.
17
Nell’ambito della coscienza bisogna decidere come se si fosse davanti a tutto il
popolo (cfr. Seneca, De vita beata, 20, 4), in modo da evitare poi di subire l’interiore
flagello del rimorso (cfr. Epistula 97). Seneca raccomanda anche la pratica del
quotidiano “esame di coscienza” (cfr. De ira, III, 34), col quale si dà voce in noi a
Dio stesso: «Dio è vicino a te, è con te, dentro di te. Dico questo: uno spirito sacro
ha sede dentro di noi, scrutatore e custode del nostro bene e del nostro male» (cfr.
Ad Lucilium epistulae morales, IV, 12, 41). Analoghi accenti e raccomandazioni
troviamo in altri autori stoici, come Marco Aurelio ed Epitteto.
18
M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologia della percezione, Il Saggitore, Milano1965,
cit. p. 292.
19
ID., La struttura del comportamento, Bompiani, Milano 1963, cit., p. 358.
20
ID., Senso e Non Senso, Garzanti, Milano 1962, cit., p. 116.
21
Ivi, p. 117.
22
Merleau-Ponty parla di andatura titubante a proposito della logica sottesa al
linguaggio: «Occorre che la lingua sia, intorno ad ogni soggetto parlante, come uno
strumento dotato dell’inerzia sua propria, delle sue esigenze delle sue costruzioni e
della sua logica interna, e tuttavia resti sempre aperta alle loro iniziative (come
d’altronde agli apporti bruti delle invasioni, delle mode e degli eventi storici), sempre
suscettibile di quegli slittamenti di senso, di quegli equivoci e di quelle sostituzioni
funzionali che conferiscono a questa logica come un’andatura titubante». Ivi, p. 111
23
R. DESCARTES, Meditazioni metafisiche, in Opere, a cura di E.Garin, vol. II,
Laterza, Bari 1997, p. 33.
24
M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologia della percezione, rinviando a detto
agostiniano interiore homine habitat veritas, aveva scritto: «La verità non «abita»
soltanto l’«uomo interiore» o meglio non v’è uomo interiore: l’uomo è nel mondo, e
nel mondo egli si conosce», Il Saggiatore, Milano 1965, p. 19.
25
B. STIEGLER, Passare all’atto, Fazi, Roma 2005, cit., p. 11.
26
Sul tema della “malafede” ha scritto pagine rilevanti J.-P. SARTRE (cfr. L’essere e il
nulla [1943], trad. it., Il Saggiatore, Milano 1997, pp. 84 ss.)
27
La “malafede” sa anche creare quel chiaroscuro che la coscienza consente che si
crei intorno al bene da compiere, in modo che si deformi, ad opera delle passioni,
l’evidenza di ciò che è da fare, e si dia via libera ad un agire non più giudicato,
bensì reattivo. La malafede si ha, in concreto, quando si riconosce il bene da
compiere, ma ad esso si oppongono delle obiezioni (dei “ma”, dei “però”) che non
hanno fondamento in un diverso, più complesso, vedere, bensì in un non voler
vedere quel che c’è da vedere.
28
Nella formula più semplice: A non è non-A
29
Il termine greco ethos corrisponde al latino mos, moris, e indica un modo stabile e
articolato di comportamento: un “costume”. Da ethos deriva il termine “etica”; da
mos deriva il termine “morale”.
159
30
Cfr. J. G. FICHTE, System der Sittenlehre, III, 15, in Werke, vol. 4, Berlin 1971, p.
174.
31
Cfr. F. NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra, (1885), Parte III.
32
Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I IIae, q. 19, a. 5. D’altra parte,
Tommaso precisa che la volontà che concorda con la ragione erronea, non è
cattiva, solo se l’errore è dovuto ad una ignoranza assolutamente involontaria.
Mentre, la volontà che concorda con la ragione erronea è cattiva, se l’errore di
coscienza è dovuto ad una ignoranza evitabile, cioè «in qualche modo voluta, sia
direttamente, sia indirettamente [ovvero per negligenza]». Dunque, nessuno è
scusato se la sua coscienza è erronea circa qualcosa che egli è tenuto a sapere
(cfr. ivi, I- IIae, q. 19, a. 6)
33
J. P. SARTRE, L’essere e il nulla, cit. p.109.
34
G. INVITTO, La misura di sé tra virtù e malafede, cit., p. 77.
35
J. P. SARTRE, L’essere e il nulla, cit., p .95.
36
Ibidem.
37
Ivi, p. 109.
38
G. INVITTO, La misura di sé tra virtù e malafede, cit., p. 134.
160
DI UN’UGUAGLIANZA FINITA
di Antonio Stanca
Il lavoro più recente dello scrittore israeliano Amos Oz
s’intitola Tra amici, è una raccolta di racconti che ritraggono la vita
1
che negli anni Cinquanta si svolgeva in un Kibbutz.
Oz ha settantatré anni, è nato a Gerusalemme nel 1939.
Dopo un’infanzia travagliata a causa del difficile rapporto tra i
genitori e dopo il suicidio della madre è andato a vivere, da quando
aveva quindici anni, nel Kibbutz di Hulda. Qui è rimasto per oltre
trent’anni, si è sposato, ha avuto i suoi figli ed è uscito nel 1986
quando da tempo scriveva. Si stabilirà con la famiglia ad Arad
dove ancora risiede mentre insegna Letteratura presso l’Università
Ben Gurion del Negev.
Durante gli anni Cinquanta Oz, com’era d’obbligo nel suo
paese, è stato militare nelle Forze di Difesa Israeliane ed ha preso
parte agli scontri armati che si sono verificati tra Israele e Siria, in
seguito ha combattuto nella Guerra dei Sei Giorni e in quella del
Kippur. Dopo ha ripreso gli studi e si è laureato in Letteratura e
Filosofia presso l’Università di Gerusalemme. A ventidue anni ha
cominciato a scrivere. La sua produzione diverrà sempre più ricca,
scriverà racconti, romanzi, saggi, articoli per giornali e la sua
notorietà sarà definitivamente stabilita dal romanzo autobiografico
Una storia di amore e di tenebra del 2002. In esso lo scrittore
ripercorrendo quanto era avvenuto nella sua famiglia ricostruisce la
storia dello Stato d’Israele dalla fine del protettorato inglese ai
tempi più recenti. In verità le condizioni del suo popolo, i continui
contrasti con gli arabi, gli ambienti e le azioni dell’esercito, la vita
nei Kibbutz saranno temi ricorrenti nella narrativa di Oz. Molti
riconoscimenti questa gli procurerà dal 2004, quando conseguì i
premi Catalunya e Sandro Onofri, ai nostri giorni quando è
considerato uno dei probabili candidati al premio Nobel per la
Letteratura.
Vicino alle sue esperienze di vita e soprattutto alla realtà
dei suoi luoghi mostra di voler rimanere l’Oz scrittore che è anche
l’intellettuale concretamente impegnato nelle gravi situazioni, nella
161
politica del suo paese, nella ricerca di soluzioni per gli eterni
problemi d’Israele. Spesso egli ha personalmente rappresentato le
sue convinzioni politiche, si è direttamente confrontato con quanto
avveniva al fine di raggiungere una condizione per tutti favorevole.
Circa i rapporti con gli Arabi ha sempre perseguito la “soluzione dei
due stati”, ha combattuto ogni posizione estremista in nome di una
democratica. Ha fatto parte del movimento “Pace ora”, è stato un
rappresentante di rilievo nel Partito Laburista, si è opposto alla
Destra, ha lasciato i laburisti, è entrato in polemica con loro
quando non ha più visto rispettate le regole che li avevano uniti. Ha
svolto un’azione concreta, precisa a favore, a difesa dei diritti
umani e sociali della sua gente. Di questa gente ha narrato Oz
mostrandosi capace, nei romanzi e racconti, di andare oltre
l’evidenza, di superare la realtà esterna, d’indagare nell’animo
umano alla ricerca delle debolezze, delle inquietudini, delle
insoddisfazioni che lo agitano pure a livello di una persona
comune, di un semplice operaio, artigiano, di una sconosciuta
donna di casa, moglie, madre, figlia.
È questa la nota distintiva della sua scrittura, la
rappresentazione di quell’interiorità, di quei bisogni dell’anima che
rimangono insoddisfatti, di quelle azioni, di quei gesti che sono il
segno di un travaglio mai risolto.
Tra amici è un altro esempio di tale maniera dello scrittore.
Qui si vive nel Kibbutz Yekhat intorno agli anni ’50 e in prima
persona l’autore narra di questa vita, di alcuni suoi casi. ‹‹ E’
andata scalza vicino alla finestra aperta e ha pensato che quasi
tutti hanno bisogno di più calore e più affetto di quanto gli altri sono
capaci di dare, e che questo scarto tra richiesta e offerta non ci
2
sarà mai nessun comitato del kibbutz che riuscirà a colmarlo›› . E’
come se egli, attraverso i personaggi dei racconti, ripercorresse la
sua lunga esperienza avvenuta nel Kibbutz di Hulda dal 1954 al
1986, come se volesse mostrare le tristi situazioni alle quali aveva
assistito da ragazzo e tra le quali era cresciuto, vissuto fino all’età
di quarantasette anni. E mediante le storie narrate vuole anche far
sapere che molto era cambiato nel Kibbutz rispetto ai suoi inizi,
che molte regole risultavano ormai inosservate, che l’uguaglianza,
la parità erano diventate principi di altri tempi, che anche in quella
162
comunità si assisteva al fenomeno dell’avidità, dell’egoismo,
dell’arricchimento perseguiti da pochi ai danni di molti. ‹‹ Adesso
che la dirigenza del kibbutz era passata dalle mani dei pionieri
fondatori a quelle di Yoav e dei suoi compagni, il kibbutz era
condannato a scivolare lentamente verso l’imborghesimento. […]
Fra venti, trent’anni, i kibbutz sarebbero diventati niente più di
graziosi quartieri residenziali, i loro abitanti dei pasciuti padroni di
3
casa›› . Anche in un posto di uguali erano sopravvenute le gravi
disuguaglianze sofferte nella moderna società dei consumi da
parte di chi non partecipa alla corsa verso la ricchezza e rimane a
vivere dell’idea, anche lì lo spirito era stato sopraffatto dalla
materia e c’erano ormai vincitori e vinti. Di questi ultimi vuole
scrivere Oz nel libro, dei loro problemi e a volte drammi vuole far
sapere.
Dirà, così, del maturo giardiniere che vive da scapolo e
che ha ridotto la sua diligenza alla mania di diffondere le brutte
notizie apprese da una radiolina, della povera Osnat che lavora
nella lavanderia del Kibbutz e che, nonostante la giovane età e la
bellezza, è stata lasciata dal marito per una donna che le era
amica, dell’elettricista che ha perso la moglie, il figlio ed è chiamato
ad assistere all’unione tra la figlia diciassettenne e il suo maturo e
navigato insegnante, del sedicenne Moshe che frequenta la scuola
del posto, è esposto per la sua timidezza allo scherno dei
compagni, presta le sue ore di lavoro presso il pollaio. Ha il padre
malato e, nonostante tutto, accetta di rimanere in quella condizione
perché la considera unica, del falegname Roni che scopre sulla
porta di casa il piccolo figlio sfinito in seguito ai maltrattamenti
subiti dai coetanei nella casa dei bambini, del guardiano di notte
che durante il suo servizio incontra la giovane e bella Nina che è
fuggita da casa e non vuole più farvi ritorno perché continuamente
offesa dal marito, della difficile situazione di Yotam, il ragazzo
diviso tra l’idea di fuggire dal Kibbutz per recarsi in Italia dove uno
zio gli permetterebbe di studiare e l’altra di attenersi alla volontà
dell’Assemblea che prevede per i giovani il servizio militare e tre
anni di lavoro prima di proseguire negli studi, del calzolaio malato
di enfisema polmonare che non smette di fumare e muore nella
speranza che l’esperanto diventi una lingua studiata in tutte le
163
scuole del mondo perché dovrebbe essere quella di tutti i popoli e
portare alla fine di ogni contrasto tra loro.
Sono alcuni esempi delle tante persone che nel contesto di
un Kibbutz rimangono sconfitte nel loro spirito. Vicini, familiari a chi
legge risultano con Oz questi casi perché egli scrive come se li
avesse visti, vi avesse partecipato e perché chiara, facile,
scorrevole è la sua lingua anche quando tratta di complicate
vicende sentimentali, di oscuri problemi interiori, di pene
dell’anima. Accanto ad un’umanità che soffre è sempre stato lo
scrittore con le sue opere, di essa ha voluto essere il banditore.
Oltre che saggista, giornalista, politico, uomo d’azione, molto
importante è sembrato ad Oz essere scrittore dell’anima, dei
drammi che questa sopporta e che senza la sua scrittura
sarebbero rimasti sconosciuti. Con essa acquistano una voce che
non è soltanto ebrea perché ovunque nel mondo si soffre oggi per
le conseguenze comportate dal materialismo dei tempi moderni,
ovunque c’è disagio per lo spirito e una scrittura che come quella
di Oz si fa interprete di questo disagio supera i confini dei suoi
luoghi, perviene ad una dimensione più estesa, vale per tutti.
1
In Italia è stato pubblicato a Giugno del 2012 dalla Feltrinelli, Milano, nella serie “I
Narratori” con traduzione dall’ebraico di Elena Loewenthal (p. 131).
2
Ivi, p. 118.
3
Ivi, p. 121.
164
Pubblicazioni ricevute
Volumi
J.-R. ARMOGATHE, Histoire des idées religieuses et scientifiques dans
l’Europe modern. Quarante and d’enseignement à l’École Pratique des
Hautes Études, Brepols, Turnhout 2012, pp. 220;
G. CAMPANINI, Mounier. Eredità e prospettive, Studium, Roma 2012, pp.
298;
A. CAPUTO, M. BRACCO a c. di, Nietzsche e la poesia, Stilo, Bari 2012, pp.
224;
A. CAPUTO, L’arte nonostante tutto. Ricerche sulla musica, la pittura e la
poesia: tra estetica ed ermeneutica, CVS, Roma 201w2, pp. 174;
R. CELADA BALLANTI, Filosofia e religione. Studi su K. Jaspers, Le Lettere,
Firenze 2012, pp. 234;
G. CERA, Il prima e il dopo delle cose, Edizioni di pagina, Cassano delle
Murge 2012, pp. 98,
C. CIANCIO, Percorsi della libertà, Mimesis, Milano-Udine 2012, pp. 184;
P. COLONNELLO e S. SANTASILIA, a curadi, Intercultura democrazia società.
Per una socioetà educante, Mimesis, Milano-Udine 2012, pp. 251;
E e se abolissimo la filosofia? Il contributo della scienza alle nuove
esigenze della filosofia, a c. di S. Arcoleo, Quintessenza, Novara 2012, pp.
316;
P. DE GIORGI, La rinascita della Pizzica, Congedo, Galatina 2012, pp. 376;
F. FERRAROTTI, Atman. Il respiro del bosco, Empirìa, Roma 2012, pp. 112;
P. GUIDA, La rivista post-unitaria «Cornelia». Donne tra politica e scrittura,
Angeli, Milano 2012, pp. 188;
G. INVITTO, La misura di sé tra virtù e malafede. Lessici e materiali,
Mimesis, Milano-Udine 2012, pp. 158;
G. INVITTO, Il diario e l’amica. L’esistenza come narrazione, Mimesis,
Milano-Udine 2012, pp. 208;
N. LAVERMICOCCA, Puglia bizantina. Storia e cultura di una regione
mediterranea (876-1071), Capone, Lecce 2012, pp. 168;
M. MAISETTI, F. MAZZEI, G. CALDANA, L. LA STELLA a c. di, Pinocchio mito
dell’umano, cinema e psicoanalisi, Milano 2012, pp. 96;
A. MIGLIETTA, Via crucis Via Lucis, Basilica S. Maria de Finibusterrae,
Editrice Salentina, Galatina 2012, pp. 76;
A. MONTANO, Sermo civilis. Note di etica pubblica tra storia e vita, Delta 3,
Grottaminarda 2012, pp. 300;
R. NIGRO, Ascoltate, signore e signori. Ballate banditesche del Settecento
165
meridionale, Capone, Lecce 2012, pp. 196;
R. RUCCO, Sensi per Versi, AlebBooks, Civitavecchia 2012, pp. 60;
G. SACINO, A. ZUCCALA, La Fede è, pres. di R. Fischella, Elledieci,
Leumann 2012, pp. 110;
F. SPEDICATO ESPOSITO, L’avventura. Tappe di un viaggio dentro il
Pensiero e l’Opera dei Maria Zambrano, Saggistica, Fondazione M. Luzi
Editore, Roma 2012, pp. 212;
STERN DANIEL, Storia della Rivoluzione del 1848, a c. di M. Forcina, G.
Laterza e figli, Roma-Bari 2012, pp. LXXXVIII, 804;
Periodici
Itinerari, n. s., Lanciano, n. 2. 2012;
Les Temps Modernes, a. 67, avril-juin 2012, n. 668, Franco Basaglia, une
pensée en acte
L’immaginazione, n. 271, 2012; Manni, San Cesario di Lecce;
Il delfino e la mezzaluna, a. 1, n. 1; Fondazione Terra d’Otranto, Nardò;
166