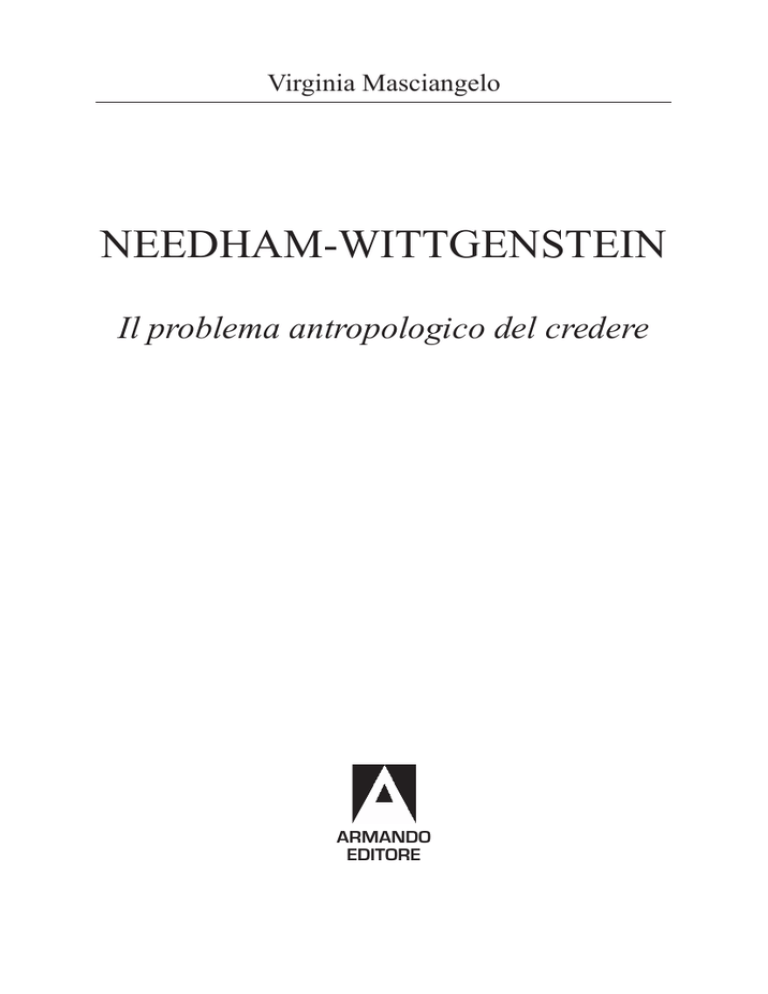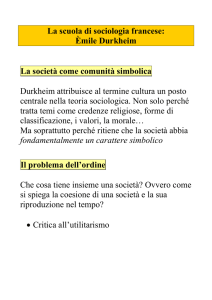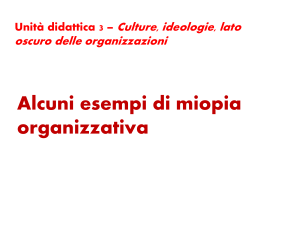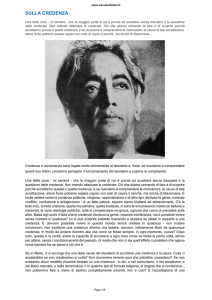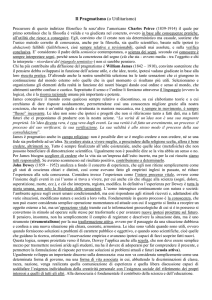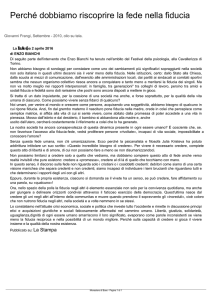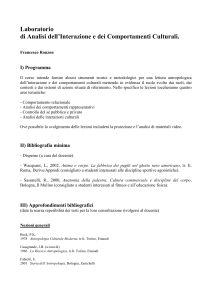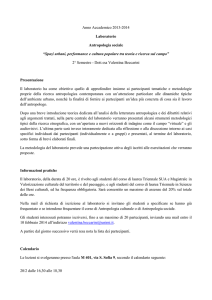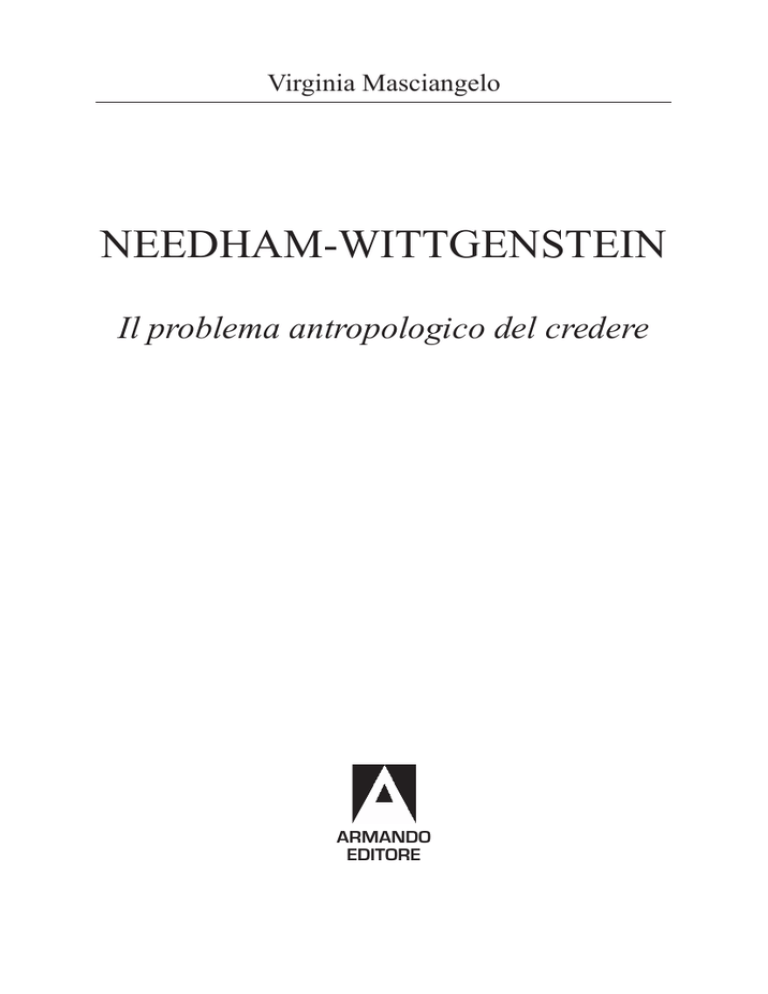
Virginia Masciangelo
Needham-Wittgenstein
Il problema antropologico del credere
Armando
editore
Sommario
Introduzione
1. Il problema antropologico del credere
1.1.Cenni sulla letteratura antropologica
1.2.Credenze e rappresentazioni collettive 1.3.Credenze e senso comune
1.4.La spiegazione delle credenze 1.5.La credenza come costruzione sociale
2. Il credere e la credenza nella tradizione
antropologica occidentale
2.1. Definizioni enciclopediche
2.2.Gli intellettualisti e le credenze
2.3.Gli emozionalisti e le credenze
2.4.I sociologi francesi e le credenze
2.5.I funzionalisti e le credenze
2.6.Gli antropologi marxisti e le credenze
2.7.Dan Sperber e l’epidemiologia delle credenze
2.8.Credere secondo natura: continuità tra il biologico
e il culturale 3. Wittgenstein e il credere come disposizione
3.1. Wittgenstein-Needham: un primo contatto
3.2. Wittgenstein e la definizione del problema del credere
3.3. Quaderni 1914-16
7
13
13
17
20
24
28
33
33
40
49
50
51
54
54
56
59
59
61
63
3.4. Note al Tractatus: le espressioni di credenza
(5.54-5.5421)
3.5. Wittgenstein e la psicologia
3.6. Wittgenstein e i verbi psicologici
3.7.Libro blu e Libro marrone
3.8. Ricerche filosofiche e Zettel 3.9. Della certezza 3.10.Osservazioni sulla filosofia della psicologia
64
67
71
76
78
87
93
4. Belief Language Experience
4.1.Introduzione all’autore
4.2.Analisi dell’opera
99
99
101
5. Oltre Needham
5.1.Credenze, linguaggio e realtà
5.2.Peter Winch e le credenze estranee alla tradizione
occidentale
5.3. Winch e Wittgenstein
5.4. Belief, un concetto da abolire?
113
113
116
124
129
Bibliografia
133
Introduzione
Il concetto di credere e quello di credenza hanno da sempre
rappresentato un nodo problematico all’interno della letteratura
antropologica e non solo.
Gettiamo semplicemente uno sguardo alla storia della filosofia:
potremmo citare Platone, Aristotele, Agostino, ma, più avanti col
tempo, anche Hume, Kant addirittura, filosofi che si sono interrogati per secoli sulla questione relativa alla semplice entificazione
e definizione dello stato mentale del credere. Pensiamo anche a
James a Peirce e ai loro studi sul pragmatismo della credenza.
La credenza ha da sempre giocato un ruolo cruciale in tutte le
scienze sociali, coinvolgendo anche la psicologia, la sociologia e
l’economia.
Ora il credere e la credenza (userò il termine credenza per
indicare, a fini esplicativi, non tanto lo stato mentale, espresso
più che correttamente dal credere, quanto il contenuto semantico
di tale atto) sono stati materia di indagine nel testo da me preso
in esame Belief Language Experience del famoso antropologo
sociale Rodney Needham, proveniente dalla scuola di Oxford e
allievo del padre dell’antropologia sociale britannica, sir EvansPritchard.
Chiunque sia addentro agli studi demo-etnoantropologici, ma
anche il semplice appassionato di antropologia, non può non riconoscere in Needham lo studioso che ha contribuito in maniera
determinante all’indagine sul pensiero e sul problema religioso.
7
Ma non solo nel campo dell’antropologia sociale e religiosa
l’antropologo inglese si è fatto strada.
Nel capitolo IV della mia tesi, dedicato alla concezione del
credere in Needham, avrò modo di presentare l’autore e di passare in rassegna i contributi da lui apportati all’antropologia
britannica e al pensiero antropologico in generale. Per il momento mi sembra opportuno il riferimento diretto al testo preso
in esame.
L’opera Belief Language Experience è, come sostiene lo stesso autore nell’introduzione, una lunga nota in margine alla proposizione di Wittgenstein: “L’espressione di una credenza è soltanto
una frase; e la frase ha un suo significato soltanto quando fa parte
di un sistema linguistico” (Wittgenstein 1958, p. 42).
Del resto tutto lo scritto di Needham altro non è che il tentativo di rispondere alla domanda di Wittgenstein: “Credere è
un’esperienza?” (Wittgenstein 1961, p. 89).
Tale scritto non è riconducibile a un ambito disciplinare ben
definito. Infatti Needham non ha la presunzione di definire la sua
un’opera di filosofia. È un’opera a metà strada tra antropologia
e filosofia; è un’opera metateorica dove è sottoposto a critica il
punto di vista degli antropologi.
Il primo tentativo di Needham è infatti quello di stabilire il
significato effettivo del termine belief. Tentativo assai arduo se
pensiamo che è molto più semplice confrontarsi con altri etnografi, rilevatori di campo, parlando di usi e costumi che non di
contenuti psicologici e di stati psichici. Questo perché l’antropologia si è occupata, sin dal passato, più dell’ambiente che non
delle facoltà dell’uomo. Needham dichiara che l’espressa volontà
del libro è quella di fondare un’antropologia critica, definire le
condizioni di comprensibilità del mondo umano, chiarire le funzioni dei costrutti intellettuali (i concetti), discutere il problemapossibilità della traduzione, illuminare i rapporti tra linguaggio,
8
concettualizzazione, operazioni mentali, esperienze e strutture
socioculturali sia nell’ambito di una stessa cultura che in culture
diverse.
Le suddette problematiche si affiancano all’analisi linguistica,
filosofica e antropologica del belief.
L’antropologo propone innanzitutto un’analisi filosofica del
linguaggio con uso della comparazione, da buon comparativista
qual è, ponendosi contro la ristrettezza concettuale e linguistica
della filosofia analitica.
Ma, tornando a noi, cosa significa credere? Qual è l’utilità della credenza?
Per analizzare il contenuto delle credenze di un popolo possiamo prescindere dallo studio della cultura di appartenenza e dal
linguaggio parlato da quel popolo? In quale rapporto l’umanità si
pone con la realtà e soprattutto come si costituisce il nostro bagaglio concettuale? I termini da noi adoperati hanno un contenuto
semantico unico e unicamente determinato?
Questi sono i tanti interrogativi che l’autore si è posto durante
la sua ricerca e ai quali ha cercato di dare una risposta esaminando la stretta relazione tra credenza, linguaggio ed esperienza.
Investigando, nel periodo compreso fra il ’51-’52, sui Penan,
popolazione del Borneo centrale, l’antropologo Needham, da
empirista scettico e seguace del padre di tutti gli scettici, David
Hume, giunse alla conclusione che i Penan o i Nuer, così come
potrebbe dirsi di altre popolazioni di interesse etnologico, non
hanno un termine concettuale simile a “io credo” per il fatto che
essi non dispongono del concetto di credere poiché l’esperienza
del credere non è parte della loro forma di vita.
Detto con le sue stesse parole: “L’argomento specifico della
ricerca che ho intrapreso in questa sede consiste nel negare che la
nozione di credenza si accordi con una concezione empirica della
mente umana, o con una dettagliata descrizione delle motivazioni
e della condotta dell’uomo. L’atto del credere non è un’esperien9
za di tipo perfettamente isolabile, non costituisce un’affinità naturale fra gli uomini, e non rientra in un comune comportamento
dell’umanità” (Needham 1976a, p. 185).
Needham si pone così in maniera polemica nei confronti
dell’antropologia acritica evidenziando che non tutti i popoli hanno un bagaglio concettuale identico, esprimibile nel linguaggio
cui corrisponde una stessa esperienza.
Dunque, prima di chiedere a cosa una popolazione creda,
compito dell’antropologo è quello di capire se essa abbia o meno
esperienza del credere.
Il lettore cui Needham si indirizza non è il solo studioso o appassionato di antropologia, ma è anche il filosofo, il linguista, lo
studioso di scienze umane e sociali, il teologo.
L’argomento specifico della mia tesi sarà dunque la peculiare
analisi needhiana del concetto di credere e la mia attenzione sarà
principalmente rivolta all’enorme debito intellettuale di Needham nei confronti di Wittgenstein, in risposta alla cui proposizione l’opera Belief Language Experience ha visto i suoi natali.
Nel capitolo primo esaminerò il credere come problema antropologico, passando in rassegna alcune opere tratte dalla vasta
letteratura antropologica di cui siamo eredi.
Sono consapevole della ricca tradizione filosofica del concetto
di credenza, ma lo scopo della mia tesi non è l’ontologia della credenza o la realtà psicologica delle credenze in quanto stati
mentali. Lascio alla filosofia e alla psicologia, più specificamente
alla teoria rappresentazionale della mente, dove queste due questioni hanno trovato un trattamento unitario, il compito di investigare su ciò che è di loro competenza.
La mia sarà un’analisi antropologica della credenza, sebbene
poi sia impossibile operare in un campo ben definito, essendo
molti gli sconfinamenti nelle altre discipline.
Nel secondo capitolo affronterò il concetto di credere e di credenza all’interno della tradizione antropologica occidentale.
10
Il terzo capitolo sarà invece dedicato alle considerazioni di
Wittgenstein in merito al credere.
Il quarto capitolo sarà una breve presentazione del pensiero e
dell’opera needhiana.
Nel quinto e ultimo capitolo accennerò al relativismo antropologico, prendendo come spunto le considerazioni di Peter Winch
sulle credenze estranee alla nostra tradizione culturale.
Esporrò poi per sommi capi la critica needhiana al modello
tradizionale di conoscenza, causa di etnocentrismo, che sostiene
che il rapporto dell’uomo con la realtà (esperienza) è fondamentalmente identico in tutti i popoli e trova espressione in linguaggi
diversi ma sostanzialmente omogenei. Il nuovo modello proposto
da Needham e da me condiviso prevede che l’esperienza non sia
più considerata, per un verso, uniforme ed invariante per tutte
le culture, per l’altro verso indipendente dalla sua espressione
linguistica.
Esperienza, concettualizzazione e linguaggio stanno tra loro
in un rapporto di fondazione reciproca, nell’ambito di ciascuna
cultura, sebbene non sia possibile una corrispondenza biunivoca
tra elementi del linguaggio, concetti ed elementi dell’esperienza,
così come questa è stata configurata da Wittgenstein nel Tractatus Logico-Philosophicus.
Nella conclusione discuterò, assumendo una posizione costruttivista, il nichilismo concettuale sfiorato da Needham quando alla
fine nega la realtà e un qualsiasi tipo di rapporto con l’esperienza
al belief definendolo inutilizzabile come strumento concettuale,
quasi ridotto ad un mero flatus vocis.
11
1. Il problema antropologico del credere
1.1. Cenni sulla letteratura antropologica
Sembrerà strano ma, nonostante la letteratura etnografica sia
stracolma di allusioni al problema del credere, non esiste alcuna
definizione convenzionale del concetto di credenza che sia caldeggiata o raccomandata dagli antropologi.
In molti studiosi c’è la tacita assunzione che questa normale
categoria psicologica della lingua inglese denota una comune facoltà umana che possa essere estesa a tutti gli uomini e che abbia
quindi carattere universale.
Il concetto di credenza è implicito in molti scritti antropologici, quasi fosse un termine descrittivo standard. Pensiamo a
Cassirer, il quale nel Saggio sull’uomo afferma che: “nell’immaginazione mitica è sempre implicato un atto di credere”, cioè che
senza la credenza nella realtà del proprio oggetto il mito perderebbe ogni fondamento e che tale credenza è “una condizione
intrinseca e necessaria della modalità di percezione propria del
mito” (Cassirer 1944, p. 75).
Notes and Queries, la guida alle ricerche sul campo, pubblicata dal Royal Anthropological Institute, dedica un sostanzioso
capitolo, il settimo, al rituale e alla credenza. Balza immediatamente all’occhio che la comprensione di quest’ultima è data
per scontata. “Non è stata ancora trovata alcuna popolazione, tra
quelle finora studiate, che non creda in una qualche sorta di po13
tere sovrannaturale” – così comincia Notes and Queries (Royal
Anthropological Institute 1951, cap. 7).
Per tutto il corso della trattazione di questo argomento capitale, la facoltà di credere è costantemente nominata, ma la definizione di tale concetto non è mai messa in dubbio.
Dando uno sguardo ai manuali di antropologia – si pensi a
Beattie e a Uomini diversi da noi: lineamenti di antropologia sociale (1972) – è mancante una definizione antropologica di credere. Scorrendo ancora le pagine della letteratura antropologica,
Leach in Virgin Birth scrive a questo proposito che “quando un
etnografo riporta che i membri della tribù X credono che… egli
descrive in realtà un’ortodossia, un dogma, qualcosa che è vero
di una cultura nel suo insieme” (Leach 1966, p. 40).
Per Needham bisognerebbe assumere che le differenze psicologiche dell’atto del credere siano inerenti alle ortodossie condivise da ogni singola popolazione altrimenti questo tratto distintivo dovrebbe essere eliminato nell’uso etnografico che si riferisce
alle credenze. È però anche vero che gli uomini non credono necessariamente a ciò che la propria cultura li spinge a dichiarare
e, se eliminiamo la dimensione psicologica, non vi è più la distinzione tra cosa creduta e la supposta capacità di credere che
attribuisce valore alla descrizione.
“Una larga parte della letteratura antropologica sulla religione
– continua Leach – si impegna quasi interamente nella discussione sul contenuto del credere e sulla presenza o meno di razionalità in tale contenuto. La maggior parte di queste argomentazioni
mi sembrano sciocchezze accademiche […] Porre domande sul
contenuto delle credenze che non siano implicite nel contenuto
dei riti è un puro nonsenso […] L’azione rituale e la fede sono
simili nella misura in cui sono intese come forme di affermazione
simbolica circa l’ordine sociale” (Leach 1954, pp. 13-14).
Per Needham, come dicevo, il problema continua a sussistere
perché non c’è alcun vantaggio nel parlare di rappresentazioni
14
collettive o di dogmi in termini di credenze se gli individui che
compongono le società primitive non credono effettivamente ad
esse. Bisognerebbe rettificare il vocabolario dell’etnografo, ma
forse il vero problema consiste nel giustificare una simile implicazione.
Continuando con questa breve rassegna vorrei sottolineare
che in antropologia culturale le definizioni di religione includono
convenzionalmente la credenza come indispensabile componente
di essa; per esempio Durkheim, padre della scuola sociologica
francese, ne Le forme elementari della vita religiosa, sostiene che
“alla base di tutti i sistemi di fede e di tutti i culti deve esserci
necessariamente un certo numero di rappresentazioni fondamentali e di atteggiamenti rituali che risentono ovunque dello stesso
significato oggettivo e adempiono dunque alle stesse funzioni.
La religione diviene così un sistema di rappresentazioni e
di riti (un sistema unificato di credenze e pratiche) attraverso il
quale gli individui partecipano misticamente e collettivamente di
questa entità provvista di una forza soprannaturale che è la società” (Durkheim 1912).
Più avanti avrò modo di chiarire lo stretto rapporto tra la rappresentazione collettiva e la credenza nelle società etnologiche.
Ancora, Marcel Mauss, nipote nonché allievo di Durkheim,
rimarcando il carattere sociale delle rappresentazioni collettive,
ribadiva che a proposito della credenza una spiegazione sociologica si ottiene quando si è visto che cosa è che la gente crede
e quali sono le persone che lo credono e lo pensano (Dumont
1964).
Radcliffe-Brown ritiene che la definizione più soddisfacente
della religione sia nel dire che essa è “la credenza in una grande
forza o potere morale” (Radcliffe-Brown 1922); e Geertz sostiene addirittura che i comportamenti religiosi sono “non soltanto
modelli di ciò che essi, i fedeli, credono, ma anche modelli per
crederlo” (Geertz 1966).
15
Dal canto mio potrei continuare nella citazione di molti altri
resoconti etnografici sulle religioni primitive in cui si legge che
certi popoli credono che Dio abbia creato il mondo in un certo
modo, che le offese contro gli antenati apportino calamità, che il
rispetto delle norme del rituale procuri la pioggia, etc.: non troveremo tuttavia una seppur minima definizione di credenza.
Il manuale di antropologia religiosa di Alessandra Ciattini
affronta nel capitolo quinto il tema della credenza, con l’aperto
richiamo a Needham, dimostrando di aver ben in mente il problema del credere nella letteratura antropologica. “… la parola credenza fa problema e quindi deve essere utilizzata con una certa
cautela” (Ciattini 1997, p. 149).
La Ciattini prosegue: “Qui la impiegheremo non per indicare un particolare stato mentale ed affettivo, quanto piuttosto per
segnalare una certa struttura organizzativa di tipo cognitivo, ma
dotata anche di immediate implicazioni pratiche e morali, individuabile negli insiemi di enunciati espressi dagli attori a proposito
del loro comportamento e del loro modo di concepire il reale,
o ricavati indirettamente dai ricercatori dall’osservazione e dai
complicati tentativi di dotare di coerenza e di significato i gesti,
le espressioni, gli atteggiamenti dei primi” (ibidem).
Ma per Needham l’etnografo dovrebbe rettificare il suo vocabolario e parlare di credenze solo laddove ci siano, senza attribuire a culture altre concetti o costrutti che risultano essere dell’etnografo che li elabora per spiegare relazioni tra eventi che in altro
modo sembrerebbero privi di senso. Si pensi all’intricata questione antropologica che affronta, relativa all’interpretazione della
caccia alle teste praticata in alcune zone del sud-est asiatico.
La nozione di forza mistica, forza di tipo animistico contenuta nel cranio del nemico, non sarebbe altro che un costrutto
dell’etnografo, elaborato con lo scopo di spiegare la relazione tra
la caccia alle teste e la fertilità. Ma neanche di questa relazione
causale tra cranio e fertilità sembra esserci traccia nelle rappre16
sentazioni collettive di questi popoli che, a differenza nostra, non
hanno elaborato a quanto pare concetti come causa o forza da noi
ereditati dalla fisica del diciannovesimo secolo.
1.2. Credenze e rappresentazioni collettive
Il rebus dell’antropologo inglese resta quello di indovinare
come un semplice etnografo possa comprendere e spiegare le
credenze dei membri di remote civiltà. Un primo passo per la
risoluzione di questo enigma è il richiamo all’esistenza di comuni
caratteristiche mentali definite “fattori primari dell’esperienza”.
Needham si riferisce chiaramente alla nozione junghiana di
archetipo (Reconaissances 1980), ritenendo che ci sia una certa
uniformità nelle rappresentazioni collettive, elaborate dalle varie
società, nonostante le differenze tra le forme di organizzazione
sociale e quelle della tradizione conoscitiva.
Qui si pone un altro nodo problematico dell’antropologia, ovvero la questione relativa alle rappresentazioni collettive che intendo affrontare perché le credenze delle società etnologiche non
sono altro che il prodotto di queste rappresentazioni.
Lo storico Marc Bloch, infatti, in La guerra e le false notizie
storiche, ci tiene a precisare l’anteriorità della rappresentazione
collettiva rispetto alle credenze popolari o alle false notizie storiche quando dice: “Una falsa notizia nasce sempre da rappresentazioni collettive che preesistono alla sua nascita” (Bloch 1995).
Il termine di rappresentazione collettiva fu introdotto da Durkheim e poi ripreso da Needham.
Innanzitutto per rappresentazioni collettive si intendono quelle idee aprioristiche di “verità”, condivise da tutti i membri di una
società, che sono inerenti alle relazioni tra il singolo e la comunità
e ai valori fondamentali del gruppo sociale (sul concetto di verità
rimando ad Ayer, autore di Linguaggio Verità e Logica (1961)).
17
Le idee e credenze sulla morte, sulla stregoneria, sulla malattia sono rappresentazioni collettive condivise universalmente
pena l’estraneità del soggetto dalla comunità. Esse non trovano
infatti una giustificazione nei fatti contingenti ma rimandano al
campo delle rappresentazioni dominato da un orizzonte magicoreligioso.
Ne Le forme elementari della vita religiosa Durkheim, sostenendo che l’esistenza e il divenire della religione pongono un
problema che non è solubile nello schema delle teorie individualistiche e psicologiche, parte da una doppia distinzione: in primo
luogo distingue tra sacro e profano (ma non è questa la sede per
discuterne) e in secondo luogo tra credenze e rituale. Influenzato infatti profondamente dal pensiero di Robertson Smith, uno
dei padri fondatori dell’antropologia meridionalista, che aveva
privilegiato nettamente la dimensione dell’azione su quella della
rappresentazione ideale, Durkheim aveva posto l’accento sulla
dimensione collettiva e pubblica del fenomeno religioso e sul dominio che tale dimensione sociale esercitava sul comportamento
e sul pensiero individuale.
È interessante riprendere per sommi capi il pensiero durkheimiano che ripropone il dibattito tra intellettualisti e ritualisti. Ricordo brevemente che gli intellettualisti (Tylor, Frazer e più tardi
Horton) attribuivano anteriorità genetica alla credenza rispetto
al rituale, mentre invece i ritualisti (Robertson Smith, Durkheim
in un certo senso) vedevano il rito collettivo come fons et origo
delle credenze di una società. La società per Durkheim, infatti,
sorge attraverso l’interazione, l’azione comune, la cooperazione
attiva.
Gli individui, interagendo, creano una realtà sui generis che
si impone con quei caratteri religiosi della trascendenza, della
superiorità e dell’imperatività costitutivi, secondo l’autore in
questione, della stessa società. Un esempio molto calzante è dato
dal fatto che tutte le istituzioni sociali, prima di acquisire indipen18
denza le une dalle altre, sono collegate alla religione e agli aspetti
fondanti di essa (Durkheim 1912).
Appare chiaro che per Durkheim la società crea le stesse coscienze, che senza di essa non potrebbero emergere come tali.
Il sociologo francese sostiene a proposito delle categorie conoscitive, e cioè degli strumenti mentali attraverso cui gli uomini
conoscono, che nella disputa filosofica tra gli aprioristi, i quali
sostengono che le categorie sono date all’uomo come possibilità
prima dell’esperienza empirica, e quella degli empiristi, i quali
sostengono invece che le categorie derivano dall’esperienza sensibile, non è possibile una scelta scientificamente fondata. Il motivo è che è vero che le categorie sono a priori e vincolanti per gli
uomini, ma hanno origine sociale, tanto che variano da società
a società. Esse sono le rappresentazioni collettive e, come tali,
sono il prodotto di un’immensa cooperazione che si estende nello spazio, ma anche nel tempo; nella loro costruzione molteplici
individui diversi hanno associato, mescolato, combinato le loro
idee e i loro sentimenti.
Anche Needham sembra concordare con il carattere della trasmissione culturale delle rappresentazioni collettive pur se l’ipotesi della predisposizione naturale caldeggiata da molti studiosi
continua ad offrire possibilità di indagini comparative.
Infatti un altro nodo problematico affrontato dall’antropologo di Oxford resta quello della contestualità. Needham non può
perdere il senso del contesto e delle tradizioni storiche e culturali, investigando su una cultura altra, motivo per cui insiste sulle
differenze tra sistemi di convinzioni che possiedono un apparato
critico per la speculazione epistemologica e sistemi che invece,
come le religioni e le culture dei popoli illetterati, ne sono privi.
Le religioni dei popoli senza scrittura non sono state costruite per Needham per affrontare i problemi relativi alla domanda
“Cosa posso conoscere?”.
Alla loro base c’è un atteggiamento acritico, che non implica
19
mancanza di intelligenza o perspicacia, ma “l’assenza dell’abitudine a prendere in considerazione, dal punto di vista critico,
le proprie opinioni e dottrine religiose per valutarne i contenuti
conoscitivi”.
Come Needham dice: “le opinioni debbono essere mantenute,
non messe in discussione” (Needham 1981, pp. 74-75). Egli così
traccia una netta linea di demarcazione tra i differenti sistemi di
credenze che è nello stesso tempo un confine tra le diverse forme
di organizzazione sociale, tra atteggiamenti differenti nei confronti della realtà e dei prodotti del pensiero.
Needham considera i sistemi che sono forniti di un apparato
critico epistemologico e speculativo, cioè la riflessione filosoficoscientifica, e i sistemi che non prevedono la necessità di tale apparato, annoverando tra questi ultimi i sistemi di credenze delle società primitive e tutti quei modi di pensare legati al senso comune,
alla ideologia spontanea appartenenti anche alle società complesse. È noto che le religioni universali, a differenza delle religioni
primitive, distinguono tra ortodossia ed eterodossia e considerano
le loro credenze assolutamente vere e le altrui assolutamente false. Ciò è spiegabile in base al fatto che nelle culture etnologiche
la religione permea la vita dell’individuo e assume funzioni diverse trasformandosi in una pretesa conoscenza della realtà.
1.3. Credenze e senso comune
Avendo affrontato il discorso relativo alla relazione tra le credenze e la rappresentazione collettiva, ritengo che ora la credenza
abbia assunto un significato un po’ meno vago.
Ne ho infatti evidenziato la funzione conoscitiva, in quanto
parte costitutiva di un sistema religioso. La religione, infatti, definita in termini generici, è un modo di riflettere, organizzare in
senso conoscitivo, etico, politico, estetico il mondo delle cose.
20