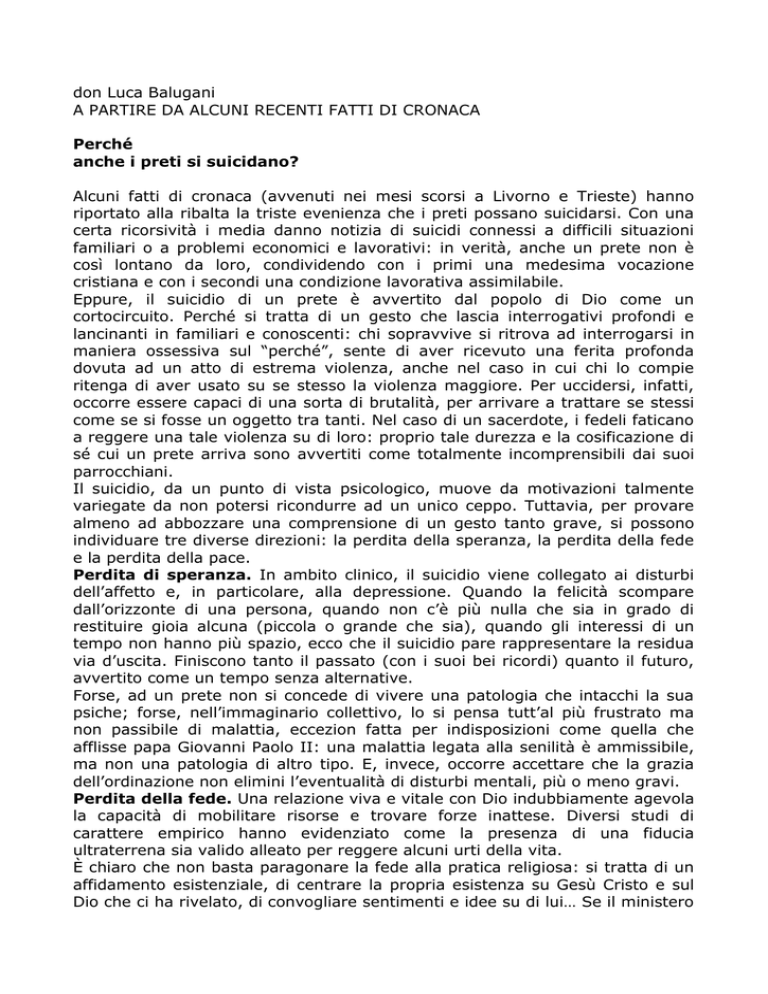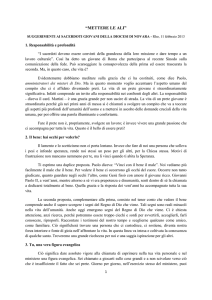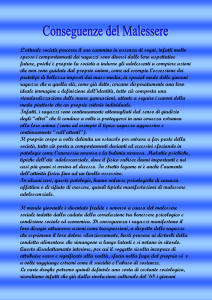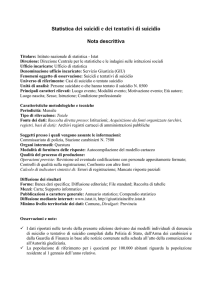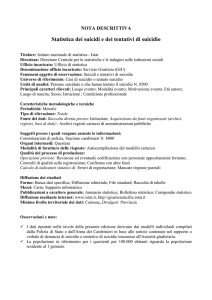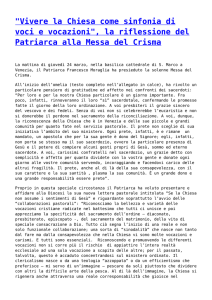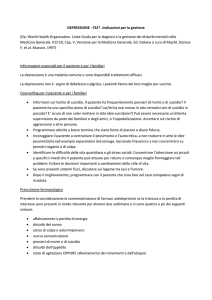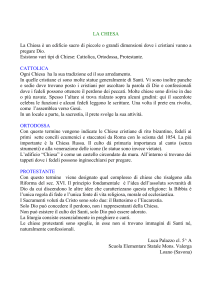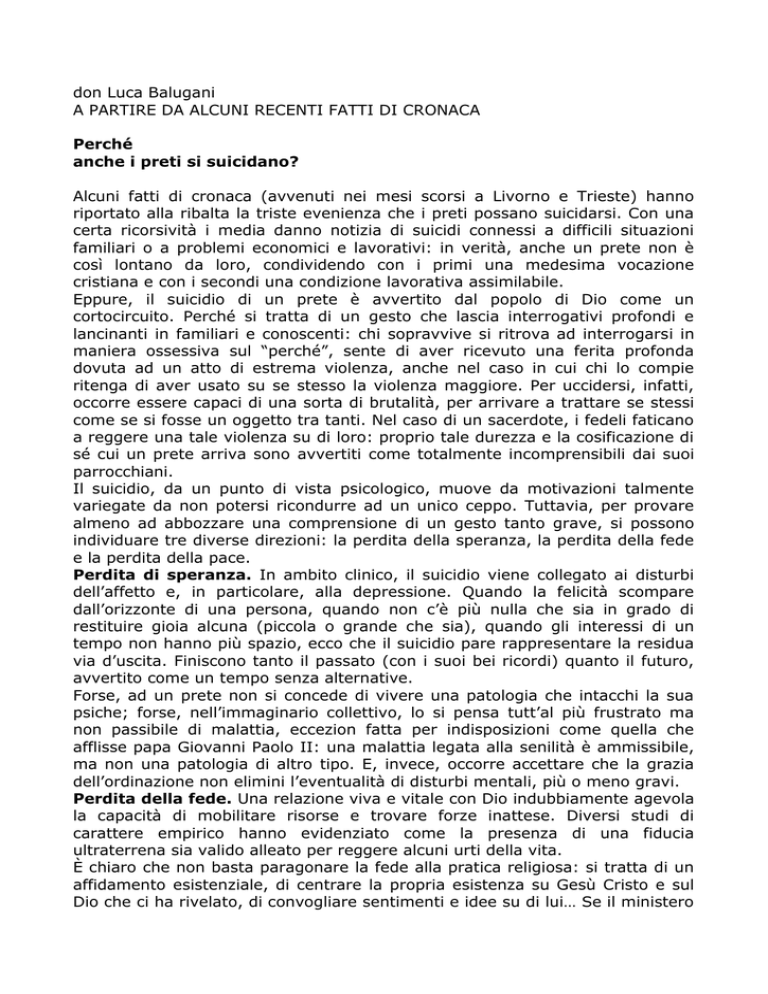
don Luca Balugani
A PARTIRE DA ALCUNI RECENTI FATTI DI CRONACA
Perché
anche i preti si suicidano?
Alcuni fatti di cronaca (avvenuti nei mesi scorsi a Livorno e Trieste) hanno
riportato alla ribalta la triste evenienza che i preti possano suicidarsi. Con una
certa ricorsività i media danno notizia di suicidi connessi a difficili situazioni
familiari o a problemi economici e lavorativi: in verità, anche un prete non è
così lontano da loro, condividendo con i primi una medesima vocazione
cristiana e con i secondi una condizione lavorativa assimilabile.
Eppure, il suicidio di un prete è avvertito dal popolo di Dio come un
cortocircuito. Perché si tratta di un gesto che lascia interrogativi profondi e
lancinanti in familiari e conoscenti: chi sopravvive si ritrova ad interrogarsi in
maniera ossessiva sul “perché”, sente di aver ricevuto una ferita profonda
dovuta ad un atto di estrema violenza, anche nel caso in cui chi lo compie
ritenga di aver usato su se stesso la violenza maggiore. Per uccidersi, infatti,
occorre essere capaci di una sorta di brutalità, per arrivare a trattare se stessi
come se si fosse un oggetto tra tanti. Nel caso di un sacerdote, i fedeli faticano
a reggere una tale violenza su di loro: proprio tale durezza e la cosificazione di
sé cui un prete arriva sono avvertiti come totalmente incomprensibili dai suoi
parrocchiani.
Il suicidio, da un punto di vista psicologico, muove da motivazioni talmente
variegate da non potersi ricondurre ad un unico ceppo. Tuttavia, per provare
almeno ad abbozzare una comprensione di un gesto tanto grave, si possono
individuare tre diverse direzioni: la perdita della speranza, la perdita della fede
e la perdita della pace.
Perdita di speranza. In ambito clinico, il suicidio viene collegato ai disturbi
dell’affetto e, in particolare, alla depressione. Quando la felicità scompare
dall’orizzonte di una persona, quando non c’è più nulla che sia in grado di
restituire gioia alcuna (piccola o grande che sia), quando gli interessi di un
tempo non hanno più spazio, ecco che il suicidio pare rappresentare la residua
via d’uscita. Finiscono tanto il passato (con i suoi bei ricordi) quanto il futuro,
avvertito come un tempo senza alternative.
Forse, ad un prete non si concede di vivere una patologia che intacchi la sua
psiche; forse, nell’immaginario collettivo, lo si pensa tutt’al più frustrato ma
non passibile di malattia, eccezion fatta per indisposizioni come quella che
afflisse papa Giovanni Paolo II: una malattia legata alla senilità è ammissibile,
ma non una patologia di altro tipo. E, invece, occorre accettare che la grazia
dell’ordinazione non elimini l’eventualità di disturbi mentali, più o meno gravi.
Perdita della fede. Una relazione viva e vitale con Dio indubbiamente agevola
la capacità di mobilitare risorse e trovare forze inattese. Diversi studi di
carattere empirico hanno evidenziato come la presenza di una fiducia
ultraterrena sia valido alleato per reggere alcuni urti della vita.
È chiaro che non basta paragonare la fede alla pratica religiosa: si tratta di un
affidamento esistenziale, di centrare la propria esistenza su Gesù Cristo e sul
Dio che ci ha rivelato, di convogliare sentimenti e idee su di lui… Se il ministero
si svuota di senso e perde proprio questa dimensione relazionale con il Figlio di
Dio, la cosa assume una serietà maggiore di quella che riguarda la vocazione
matrimoniale.
I surrogati per riempire una vita in cui Cristo non sia più motivo dell’esistenza,
nel caso di un presbitero, faticano a colmare il vuoto avvertito. Proprio l’essere
celibe per il Regno lo proietta oltre l’orizzonte mondano: non può appoggiarsi
all’affetto di una donna, non può lottare per il benessere dei suoi figli e dei
nipoti e, dal punto di vista professionale, non può sperare in grandi traguardi
(perché diventare vescovi non pare oggi essere una vera promozione).
Perdita della pace. Un ultimo fattore lo si potrebbe descrivere come assenza
di pace: quando un prete va a paragonare le proprie aspettative con le
realizzazioni concrete della sua missione, il malessere può crescere. Mancati
riconoscimenti sociali o ecclesiali, oneri eccessivi, compiti assegnati e non
supportati da adeguata preparazione, attese irrealistiche di fedeli o superiori...
possono andare ad intrecciarsi con bisogni che il presbitero non vede
soddisfatti nella condizione in cui si trova. Se, ad esempio, un sacerdote si
aspettasse di essere atteso, accolto e amato da una comunità mentre, al
contrario, percepisse freddezza e poca partecipazione, ne potrebbe conseguire
una spirale involutiva: l’insoddisfazione fiorirebbe e, contemporaneamente, un
modo acido di relazionarsi con i fedeli in un crescendo di reciproche
incomprensioni. Dove possano sfociare questi malcontenti è difficile
immaginarlo: sicuramente, comunque, non si parla più di pace ma di
inquietudine.
Non all’improvviso. Se non abbiamo risposte esaustive in ambito clinico e se il
dono del ministero ordinato non elimina dal presbitero la possibilità di essere
colpito da un disturbo (fisico o psichico che sia), quello che della situazione
colpisce è che un suicidio non arriva improvviso, ma viene preparato da una
serie di segnali che evidentemente nessuno ha visto. Spesso, infatti, ci sono
ansia e panico, insonnia e abuso di alcol, tristezza cronica e brutti pensieri.
Prima di togliersi la vita, le ruminazioni sono talmente tante e durano così a
lungo che viene da chiedersi perché nessuno se ne accorga.
Forse oggi il prete vive una tale solitudine che non c’è nessuno che possa
rendersi conto di quello che passa per la sua mente. Chi è in grado di ascoltare
le sue grida spesso inespresse a parole, ma assordanti nella sua mente?
Va anche aggiunto che, nella psiche del suicida, spesso è presente un
“persecutore”: forse è proprio così che egli avverte le richieste che vengono
dall’autorità o dai fedeli riguardo al suo ruolo. Come percepisse di essere fuori
contesto, sociale ed ecclesiologico e, nello stesso tempo, sovraccaricato di
grandi attese.
La vita concreta dei preti, quella che si svolge nelle canoniche spesso solitarie,
resta poco conosciuta sia dalle comunità sia da molti vescovi. A ciò va aggiunto
che il clima ecclesiale si è radicalmente trasformato: di quali comunità cristiane
un parroco è oggi pastore? Su quanti collaboratori può contare? Come deve
organizzare la pastorale? In base a quali criteri seleziona le domande delle
persone e a quali dà risposta?
Se volessimo poi leggere la situazione con una chiave di lettura psicosociale,
quando un’“organizzazione” deve riconvertirsi, non ci si può aspettare che il
proprio personale sia già automaticamente pronto a cambiare identità e ruoli.
Ma difettano nelle diocesi luoghi di ripensamento del ministero, spazi di
confronto e dialogo, formazioni che non siano meramente informative…
Invisibili. Tanto è difficile trovare le ragioni per un suicidio, tanto è semplice
mettersi in cerca di un colpevole: lo si può scovare nell’interessato, nella
comunità, nei suoi confratelli o, addirittura, nel vescovo… Ma anche in questo
caso le cose non sono né semplici né univoche: forse è proprio l’immaginare
che le cose si mettano a posto da sole la più grande delle illusioni, il più
temibile dei veli che coprono le situazioni di disagio.
Nel caso di un prete, l’aggravante è data dall’impossibilità, incapacità o
mancanza di volontà di radiografare la situazione reale e concreta della sua
vita quotidiana e della sua situazione esistenziale. Forse nemmeno l’interessato
è disponibile a lasciare a qualcuno la possibilità di vedere le pieghe della sua
vita: il celibato diventa la premessa di una solitudine che porta all’incapacità di
comunicare.
Del resto, sarà anche vero che i confratelli non si sono accorti del disagio (o,
peggio ancora, hanno fatto finta di niente), ma è altrettanto vero che
sperimentano il malessere sulla loro stessa pelle e hanno il problema di trovare
a loro volta risposte a domande non facili.
Il suicidio indubbiamente non è l’unica via d’uscita: ma, quando una persona è
sola e non vede alternative, quando il tempo che scorre non porta
miglioramento alcuno ma ripropone gli stessi problemi e dilemmi, quando
nessuno si accorge del circolo vizioso nel quale sta cadendo, allora i pensieri
suicidari aumentano e un gesto disperato li può attuare, magari anche solo
nella speranza che a quel punto (in ogni caso troppo tardi per alcun rimedio)
qualcuno si accorga di qualcosa.
Quale Chiesa. Il nostro è un tempo di profondo ripensamento ecclesiale,
perché le difficoltà personali oggi non possono essere disconnesse dal contesto
nel quale viviamo. Accanto ad un lavoro personale per rinforzare le motivazioni
e le prassi individuali, si rende sempre più necessario ricollocare l’intera
missione della Chiesa e interrogarsi su quale prete, quale laico, quale
parrocchia e quale evangelizzazione, come ricordava il concilio. Diversamente,
il divario tra agito e parlato aumenterà inesorabilmente, con l’illusione che una
buona enciclica, una buona inchiesta o un buon progetto di riorganizzazione
pastorale possano generare soluzioni miracolose al malessere esistenziale dei
presbiteri.