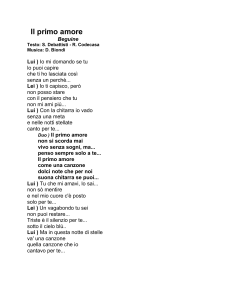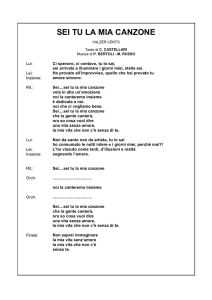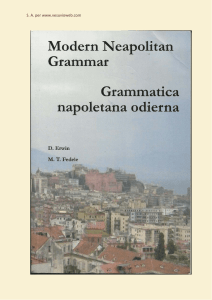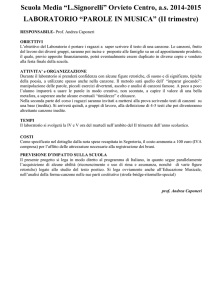Non siamo noi che siamo razzisti,
sono loro che sono neomelodici…
di GIUSEPPE AIELLO
Alla prof. di lettere di mia figlia, signora
S.M., che la settimana scorsa ha fatto
piangere mezza classe facendo ascoltare in
aula ‘O pate di Nino D’Angelo.
Se non l’avete mai visto, non ho timore di consigliarvi un filmato qualsiasi di Jalacy
Hawkins, molto meglio noto come Screamin’ Jay Hawkins, sciamano color catrame
dotato di una voce dalla potenza e duttilità sovrumane, neanche ciclopi del blues come
Big Joe Turner o Howlin’ Wolf, arrivarono mai a tanto. Uno stregone vudù, o una specie
di tamarro al cubo formato centrafricano, che iniziava gli spettacoli uscendo da una bara
e continuava cantando brani surreali (tipo Constipation Blues) agitando un bastone con
un teschio infilato sopra, mentre canini di qualche animale gli spuntavano dal naso e
una mano mozza, solitaria, tamburellava sul pianoforte. Dopo un certo successo alla
fine degli anni ’50 la sua stella cominciò a declinare e finì a suonare in club anonimi
davanti a poche decine di persone. Forse perché troppo impegnato a seminare figli per il
mondo (nell’ultima parte della sua vita dichiarò che dovevano essere 57, ma non era
sicuro che il conto fosse giusto), forse perché troppo nero e troppo africano per il palato
delicato del pubblico bianco, di Screamin’ Jay quasi nessuno si ricordava più. Poi, pian
piano, successe qualcosa: le superstar Creedence Clearwater Revival incisero una cover
del suo brano più famoso, andò più volte in tournée in Europa, fino al vero colpo di
fortuna. Nel 1984 esce infatti il primo lungometraggio di un giovane regista americano,
Jim Jarmusch, dove la protagonista sente a ripetizione I put a spell on you da uno di
quei mangiacassette con i quali tutta la mia generazione ha consumato per decenni
nastri tdk e sogni anglofoni. E quando uno sta vedendo Stranger than paradise non può
fare a meno di pensare «ma chi è questo forsennato che urla?», poi arriva John Lurie
che spegne il mangiacassette («odio questa musica») e non puoi fare a meno di pensare
«che spegni, deficiente, lo senti come canta quello?» – e la ragazzina ungherese gli dice
Giuseppe Aiello
«è Screamin’ Jay Hawkins, un uomo selvaggio» e tu non potevi fare a meno di pensare
«e perché mai io non ho mai ascoltato, né visto, un disco di questo wild man? Come
potrò rimediare?»
Con il successo di Jarmusch, Screamin’ Jay, che per fortuna non si era nel frattempo
disintegrato con le droghe e con l’alcol come tanti altri, riuscì a non perdere le occasioni
che gli si presentarono e si fece restituire dalla fortuna almeno una parte di ciò che gli
era stato sottratto nei decenni precedenti, amato e acclamato da un pubblico non
immenso ma consistente e fedele fino alla morte, sopraggiunta nel 2000.
Bella storia vero? Quasi a lieto fine.
Beh, tranquillizzatevi, di storie così nel blues ce ne sono parecchie, nella musica
napoletana no. A Napoli, essere un musicista popolare e appartenere al popolo al tempo
stesso è un peccato grave, anzi: imperdonabile.
La cultura musicale di un paese è un’entità strana, segue dinamiche sfuggenti e i suoi
legami con la storia e l’economia dei luoghi e delle persone che li vivono e li hanno
vissuti sono a volte difficili da interpretare. È impensabile poter raccontare anche una
minima parte della storia musicale degli Usa senza considerare l’apporto degli africani
trascinati dagli europei a fare da forza lavoro coatta per il modello di sviluppo della
nascente era industriale. Blues, jazz, rhythm’n’blues, funky, hiphop, sono (o sono state)
musiche erotiche e volgari – musiche da negri, si diceva un tempo – che hanno
rappresentato, in genere dopo qualche operazione di sbiancaggio e riciclaggio, la
potenza americana nel mondo. Contraddizione insanabile, gli ex-schiavi dettano ai
padroni il ritmo sul quale ballare; i bianchi possono detestare i neri, ma non possono
evitare di ascoltare, comprare, imitare la loro musica.
Casi diversi, ma analoghi nella relazione profondamente contraddittoria tra etnia
(significherà poi qualcosa questa parola?) dominante ed etnia minoritaria che trova nella
musica larga parte della propria identità culturale, sono quelli degli zingari nell’Europa
dell’est e soprattutto dei gitani spagnoli. La musica che spiega al mondo cos’è la Spagna
è, per ognuno, il flamenco, ma quelli che sono riconosciuti come gli interpreti più
autentici del ballo e del canto “nazionali” non sono in genere percepiti come spagnoli a
tutti gli effetti.
406
Non siamo noi che siamo razzisti,sono loro che sono neomelodici…
La nostra situazione è palesemente più complicata. Quella che fu individuata come
canzone rappresentativa di un inesistente popolo italiano era la musica proveniente
dall’ex-capitale di una colonia annessa manu militari dopo la metà del XIX secolo. Da
quella metropoli provennero le strofe gioiose (‘O sole mio), quelle nostalgiche
(Signorinella) e quelle patriottiche (La leggenda del Piave) e soprattutto le musiche che
accompagnavano gli emigranti nei loro viaggi, viaggi spesso senza ritorno. I suoi
abitanti, i napoletani, venivano e vengono percepiti come tendenzialmente mariuoli
(come i neri e gli zingari), non troppo puliti, vittimisti, lagnosi e pigri (come i neri e gli
zingari), e, in definitiva, italiani ma fino a un certo punto, come gli afroamericani sono
statunitensi e i gitani sono spagnoli, sì, ma fino a un certo punto.
La musica di Napoli ha avuto, come tutte le vere musiche popolari, la capacità di
rielaborare i linguaggi nuovi senza dimenticare quelli antichi. Nessun cantante italiano
conosce le canzoni italiane di un secolo fa, mentre avrebbe breve carriera un
neomelodico incapace di eseguire Reginella a un matrimonio. L’idea di sessantamila
persone che per festeggiare la vittoria della propria squadra si mettono a cantare
all’unisono una canzone antibellicista del 1915 parrebbe insensata, eppure è ciò che
accade un paio di volte al mese allo stadio S. Paolo. Napoli comunica e diffonde la sua
personalità nel mondo sostanzialmente attraverso la musica, e il valore di questo
esprimersi è inestimabile: forse esagerando si potrebbe dire che è la musica che ha
mantenuto insieme una città che troppi si impegnavano a fare a pezzi. La produzione è
immensa e variegata e si espande dai vicoli, alle periferie fino – una volta che sia stata
ben filtrata – al Festival di Sanremo. Tutto bene allora?
Mica tanto. Perché nel cuore pulsante della produzione culturale e musicale
napoletana, nella vera musica popolare, quella fatta dal popolo che canta se stesso,
purtroppo o per fortuna, ci si trova un sacco di gente poco raffinata, poco intellettuale,
poco edulcorabile, maledetti neomelodici, irriducibili tamarri.
«Oje Pe’, all’intellettuale nce piace ‘e parla’ ‘e ll’operaje, ma nun ce piace si ll’operaje vonno
parla’ lloro…» (Franco Cardinale, poeta operaio, 1995)
Mi rendo conto che in un contesto in cui si vorrebbe qualche ragguaglio sugli
sviluppi della musica popolare urbana di Napoli l’autobiografismo può sembrare
407
Giuseppe Aiello
inappropriato se non molesto, purtroppo confesso di non essere capace di fare altrimenti
e mi affido alla clemenza di chi legge.
Un po’ più di quindici anni fa mi sono imbattuto quasi per caso in un gruppo di
persone (Goffredo Fofi e Silvio Perrella tra loro) che cercava qualcuno che sapesse
qualcosa della musica che allora veniva definita, quando andava bene, “musica
sottoproletaria”. Fofi aveva già scritto qualcosa sui giornali a proposito di Nino
D’Angelo, ma restava un problema: non c’era letteralmente nessuno che sapesse nulla
di quel mondo e che fosse capace di scriverne. Silvio sapeva che io quella musica la
conoscevo bene e mi chiesero prima un articolo per la rivista Dove sta Zazà e poi un
capitolo per il libro Concerto napoletano in cui mettessi giù qualcosa su quello
sconosciuto universo. Invece di una rassegna folcloristica e un comodo elenco di luoghi
comuni mi sforzai di elaborare una descrizione della struttura della musica a Napoli in
base alle esigenze che questa espressione culturale va a soddisfare, e della dicotomia
con la musica pop-rock napoletana “alternativa”. In quei modesti contributi sottolineai
anche l’esigenza di dover sostituire l’insopportabile terminologia razzistica che
contraddistingueva i pochi articoli che sfioravano l’argomento e, in maniera un po’
provocatoria, coniai il termine Neomelodica solo per dare la possibilità a tutti di usare
un vocabolo neutro, del tutto privo di intrinseche valutazioni estetiche o etiche. Siccome
non ero e non sono giornalista i miei articoli (e la parola stessa) sarebbero rapidamente
caduti nel dimenticatoio se non ci fosse stato Federico Vacalebre (che conoscevo solo di
vista, per la comune frequentazione dei concerti punk-new wave negli anni ottanta, e di
voce per le sue trasmissioni a Radio Spazio Popolare) al quale le cose che avevo scritto
piacquero e che rimpallò l’argomento sui giornali e poi nel libro Dentro il vulcano –
Racconti neomelodici. In questo modo Vacalebre ottenne il risultato per me stupefacente
di far diventare quel neologismo, che avevo inventato senza nessuna convinzione, una
parola di uso universale e mi regalò il divertimento, cosa per la quale sempre gli sarò
riconoscente, di osservare l’incredulità delle persone che magari mi conoscono da anni
quando rivelo (molto di rado, in effetti) le mie responsabilità in merito.
Scrissi ancora qualche superfluo articoletto, ma il mondo del giornalismo non mi si
addice e pensai, si parva licet, che se Johann Kaspar Schmidt aveva scritto tutto in un
libro e gli era bastato (a lui e alla storia del pensiero occidentale), in effetti potevo
ritenere che quello che avevo da mettere in campo sulla canzone popolare urbana più o
408
Non siamo noi che siamo razzisti,sono loro che sono neomelodici…
meno l’avevo già sistemato in quei due brevi scritti e potevo dedicarmi ad altro
(crostacei fossili, cibi tossici, comuni libertarie). Inoltre, un po’ per merito nostro (cioè
di Federico, di Fofi e mio) e moltissimo grazie a Nino D’Angelo che in quegli anni
aveva intrapreso la sua coraggiosa svolta che lo sta portando a diventare il punto di
riferimento per le future generazioni di cantanti napoletani, sembrava che le acque
fossero definitivamente smosse, che la Neomelodica non potesse venire ancora trattata
come la musica dei tamarri, dei sottoproletari, dei niggaz dei vicoli e dei palazzoni di
periferia. Anche perché contemporaneamente era scoppiato il fenomeno Gigi D’Alessio,
del quale pare sia obbligatorio parlare male ma senza aver ascoltato i primi cinque
dischi che costituiscono un’opera di modernizzazione della canzone napoletana
assolutamente fuori dell’ordinario, come del tutto fuori dell’ordinario era la sua voce.
Ora che sono stato inopinatamente riesumato quale persona atta a scrivere di musica
(di ciò devo ringraziare Anita Pesce e Maria Luisa Stazio), posso dire che la valutazione
che feci al tempo, ossia di una Neomelodica di cui si dovesse ormai necessariamente
tenere conto nella produzione culturale della città, era irrimediabilmente ottimistica e in
buona sostanza errata. Il solo fatto che D’Alessio abbia perseguito con ostinazione per
la sua strada commettendo errori madornali (come il non nascondere le sue simpatie
centro-destroidi in un mondo dove pure Baglioni – un tempo star di ogni festival
democristiano – risulta ormai essere uno di sinistra) e sia nonostante tutto arrivato a
vendere milioni di dischi e a imporre la sua presenza nei grandi media, non gli sarà mai
perdonato. L’episodio del concerto di Pino Daniele in piazza Plebiscito, nel 2008, con i
fischi del pubblico tutti rivolti all’ospite D’Alessio, ha dato l’ennesima conferma del
fatto che il ghetto c’è sempre, e ci sono sempre una serie di ricatti ai quali un cantante
che viene da Napoli deve sottostare. Edoardo Bennato si lamentava perché «gli
impresari di partito / mi hanno fatto un altro invito / e hanno detto che finisce male…»,
D’Alessio ha compreso che per raggiungere certi risultati doveva smettere di cantare in
napoletano, come d’altronde aveva già fatto in precedenza lo stesso Pino Daniele, con
risultati che ci lasciarono sgomenti («che dio ti benedica / che fica»).
Mentre Nino D’Angelo (ri)scopriva che l’identità, la personalità, la ricchezza delle
nostre musiche crescono e si sviluppano con un utilizzo rigoroso della lingua madre,
l’idea che per avere successo si doveva cantare per forza in italiano ha avuto degli
409
Giuseppe Aiello
effetti curiosi su una piccola schiera di parolieri neomelodici che hanno indirizzato una
gran parte della loro produzione verso un linguaggio impoverito oltremisura.
«Giuvannenie’ Giuvanne
già tiene mente
ce sta chi parla bbuono
e chi malamente»
(Roberto De Simone, Giuvanneniello, 1977)
Uno dei problemi centrali della nostra identità è proprio il rapporto con la lingua.
Napoli è l’unica grande città italiana dove l’italiano sia ancora la seconda lingua e dove
i bambini la cui lingua madre è il napoletano vengono pervicacemente osteggiati e
perseguitati dal corpo docente della scuola dell’obbligo affinché la smettano di parlare
ciò che si parla a casa. Nei Paesi Baschi o in Catalogna durante il franchismo le lingue
autoctone venivano represse con la polizia, a Napoli invece delle guardie ci sono le
maestre elementari. Del napoletano va bene infilare qualche parola colorita qui e lì, ma
parlarlo davvero non sta bene. Gli intellettuali non sanno come sono il singolare e il
plurale della parola piede, non sanno come si dice culla, datti da fare, cammina più in
fretta, tovaglia, asciugamano, in effetti non sanno nulla, però si permettono di
disdegnare il napoletano della canzone neomelodica, che non è quello di Bovio né
quello di Viviani – ma che strano. Allo stesso modo, ci si può recare a un convegno
sulla canzone napoletana con la chiara percezione che gran parte dei relatori non
saprebbe fare un discorso, neppure elementare, in napoletano. Però se un neomelodico
che viene intervistato molla qualche strafalcione ciò diviene immediatamente oggetto di
derisione, perché in nessun momento vi viene il dubbio che stia parlando una lingua
straniera, e che voi sareste molto, molto più ridicoli se provaste a parlare nella sua
lingua.
Perché, nonostante tutto, quella lingua c’è ancora, e in suo aiuto è arrivato un piccolo
esercito di parlatori scorretti e confusi ma altrettanto pieni di energie che sono i ragazzi,
molti dei quali davvero giovanissimi, del rap napoletano.
Alcuni sono stati quasi famosi, altri hanno giusto un po’ di visibilità, ma quelli che
sono per noi più interessanti sono sconosciuti, sono davvero tanti e si sono dedicati
integralmente al vituperato blà-blà-blà («ma po’ ‘a musica addo’ stà?») che aveva reso
410
Non siamo noi che siamo razzisti,sono loro che sono neomelodici…
James Senese ‘ngazzato niro. I loro versi a volte sono forti ed emozionanti, altre volte
fanno veramente schifo, ma, consapevolmente o per istinto, molti rapper napoletani
coltivano una conoscenza preziosa. Come il primo Pino Daniele, come l’ultimo Nino
D’Angelo, come Viviani, la maggior parte di loro (purtroppo non tutti) hanno capito che
la forza sta nel linguaggio del popolo, e che se vogliono produrre qualcosa di vero e di
originale devono farlo nella lingua che si parla per strada. Marracash o Fabri Fibra
hanno fatto i soldi parlando in italiano (o quello che è), giusto, è la loro lingua, ma per
quanto riguarda gli mc napoletani se volete capire cosa dicono dovete impegnarvi, farvi
spiegare da chi è padrone della loro, della nostra lingua, studiarvi i testi. Proprio come
facevamo noi con quelli dei Clash trenta anni fa.
Hanno nelle loro mani un potenziale comunicativo enorme, un abbozzo di percorso
già tracciato anni fa da Franco Ricciardi con Luca Persico, unire il potere melodico
viscerale della canzone napoletana con la consapevolezza dell’hip hop, come dire
Patrizio + Scott La Rock (tutti e due morti giovani, peccato), ma il sentiero è
disseminato di trappole. La prima è la solita, quella che mette un solco tra una città e
l’altra, quella perbene e quella permale.
Ed è veramente strano perché i rapper si ispirano a modelli originali dove ci si faceva
punto d’onore di essere i più duri, i più criminali, gente tutt’altro che per bene.
Eppure…
«‘A cosa strana ca je nun aggio maje capito e vulesse c‘a gente ce pensasse, cioè pecché dint’a
colonna sonora d’o film ca è addivintato ‘o rigalo ‘e Natale ‘ell’anno passato ca, dicimmo,
avessa denuncià, avessa dicere certi cose, avessa fa’ capì all’Italia che succere cà abbascio,
pecché stanno sulo neomelodici? Vintitré tracce, una d’e’ Massive Attack ca nun c’azzeccano
niente cu’ Napule e ati vintidoje ‘e neomelodici. Je vulesse domandà stu fatto, ma pecché è tutta
‘na denuncia e po’ aropp’ ce stà ‘a collaborazione?»
(Co’Sang, Momento d’onestà, 2009)
Dopo quindici anni io continuo a chiedere perché Snoop Dogg e Notorious Big sì e
Tommy Riccio e Nello Amato no? E le risposte che ottengo non sono soddisfacenti,
dietro tante chiacchiere riesco a percepire solo un contenuto, tangibile, solido, per me
intollerabile oggi come allora, cioè che, parafrasando il vecchio adagio, «non siamo noi
che siamo razzisti, sono loro che sono neomelodici».
411
Giuseppe Aiello
Ma ho il sospetto che il problema sia molto più grande, e non è possibile parlarne
qui: se dopo trent’anni dal sequestro Cirillo ci sono ancora dei buontemponi che parlano
di camorra come “antistato”, come posso io pretendere che abbiano le idee chiare
ragazzi che non sanno manco chi era Ammaturo?
Però una cosa avrei voglia di pretenderla, una cosa molto più modesta. Un po’ più di
rispetto per le persone che vivono, da generazioni, in questa città e per chi canta, per
loro, le loro vite.
Passione, ovvero una cartolina da Broccolino
Non vado al cinema, ma per Passione non potevo rifiutare l’invito di Lucia: Turturro
che fa un film sulla canzone napoletana, irresistibile. Tra l’altro nella mia memoria
Turturro era il pizzaiolo razzista di Fa’ la cosa giusta, un film cruciale per la storia
dell’hiphop, con Fight the power dei Public Enemy – più che una canzone un manifesto
politico-culturale degli afroamericani, e non solo, del secolo passato – pompata tutto il
tempo.
Sono entrato scevro di pregiudizi e sono uscito con il fegato marcio. Non perché il
film sia fatto male, né perché la musica contenuta sia brutta, tutt’altro. Ha dei meriti
grandissimi, come dare finalmente il giusto spazio a personaggi che ho sempre amato,
su tutti James Senese e Peppe Barra, il cui immenso contributo alla nostra musica è
stato costantemente sottovalutato; come riscoprire un Fausto Cigliano in magnifica
forma o filmati d’epoca straordinari (un Carosone pianista, non più giovane, da restare a
bocca aperta). Ottima la scelta anche quella di inserire bravi cantanti un po’ collaterali
rispetto alla canzone napoletana come Rino Della Volpe o la Montecorvino; molto meno
buona la scelta di altri inutilissimi e scialbi interpreti. È un film gradevole e divertente
se non ci fosse il piccolo inconveniente di un continuo sproloquiare su quanto sia
importante la musica per la città, su quanto la città e la musica costituiscano un corpo
unico. Verissimo, il concetto, ma l’amara verità è diversa: Turturro è venuto da
Broccolino e ha fatto l’ennesima Cartulina ‘e Napule.
Tutto il film è girato nel nostro meraviglioso (sì, un po’ logoro) centro storico, ma in
quei vicoli e in quelle piazze dove nel film si esibiscono gli interpreti, nella vita di ogni
412
Non siamo noi che siamo razzisti,sono loro che sono neomelodici…
giorno forse solo due dei personaggi citati vengono ancora oggi ascoltati, cioè Sergio
Bruni e Angela Luce. Quando scendo di casa la mattina io per strada sento altra musica
e questa musica nel film non c’è affatto. Il fatto che proprio i personaggi più amati dalla
gente, quelli che per la musica popolare urbana sono il legame tra il passato e il presente
– prima di ogni altro, Mario Merola e Pino Mauro – non vengano neanche nominati, ha
per me dell’incredibile. La neomelodica non esiste, non esiste Nino D’Angelo né Gigi
D’Alessio. La musica popolare nella rappresentazione di Napoli può dunque essere solo
quella del passato, oggi l’unica che si possa filmare è musica non-popolare.
E se in Passione di musica popolare urbana vera non ce n’è, dove sarà mai?
Basterebbe aprire le orecchie. In questi ultimi anni il cambiamento più macroscopico
riguarda il mezzo di diffusione, che prima era essenzialmente la radio. Le centinaia di
microemittenti che in maniera straordinariamente orizzontale sintonizzavano la città –
comprese le stanze di Poggioreale e Secondigliano – con i loro idoli in un rapporto
simbiotico, sono state quasi del tutto sterminate dalla politica delle frequenze, sostituite
da un certo numero di televisioni che passano neomelodici a getto continuo. A questo si
vanno a sommare i filmati disponibili su youtube (nel momento in cui scrivo il più
vecchio dei video di Ma si vene stasera di Alessio, con il solo testo, senza immagini,
conta 4.847.288 visualizzazioni), a diffondere modelli ben diversi da quelli imperanti,
con ragazze protagoniste che certo hanno poco in comune con le modelle anoressiche
delle riviste patinate, budget evidentemente assai contenuti, classiche storie d’amore e
tradimento o piccoli capolavori surreali. A chi si dimostrasse scettico di quest’ultima
affermazione consiglio la visione, solo a titolo d’esempio, di ‘E carrub di Gianni Dany,
una specie di Police on my back, però iperbolica e multirazziale.
Nei vicoli continua a sentirsi tanta musica, un po’ meno di una volta, molta roba
singalese, dell’Europa dell’est, magrebina, africana, un’internazionale neomelodica,
bellissima, peccato i cinesi non partecipino. E sempre tanta musica napoletana, canzoni
di oggi, di dieci anni fa – da qualche parte spunta fuori inevitabilmente Ragione e
sentimento di Maria Nazionale, esempio primigenio e insuperato di rap neomelodico –
canzoni di molti anni fa, da un basso si sente la voce inconfondibile di Pino Mauro che
canta Nun t’aggia perdere. E sentendola per l’ennesima volta penso che in fondo va
bene così, questa è una musica che non sopravvive grazie ai media o alle sovvenzioni
statali, ma vive perché è capace di scandire le giornate della gente, quelle di festa,
413
Giuseppe Aiello
quelle gioiose come quelle terribili. È una musica che quei giorni sa come raccontarli,
che è partecipe delle emozioni quotidiane, che assolve al suo compito. Che fa cioè
quello che deve fare, quello per cui è nata tutta la musica popolare, di ogni tempo, di
ogni paese.
E il popolo lo sa, e se la tiene stretta, anche se a molti di voi forse questo non piace.
414



![Musica_e_immagine.pps [modalità compatibilità]](http://s1.studylibit.com/store/data/007525709_1-5cde61487a57acc65bf762230b059028-300x300.png)