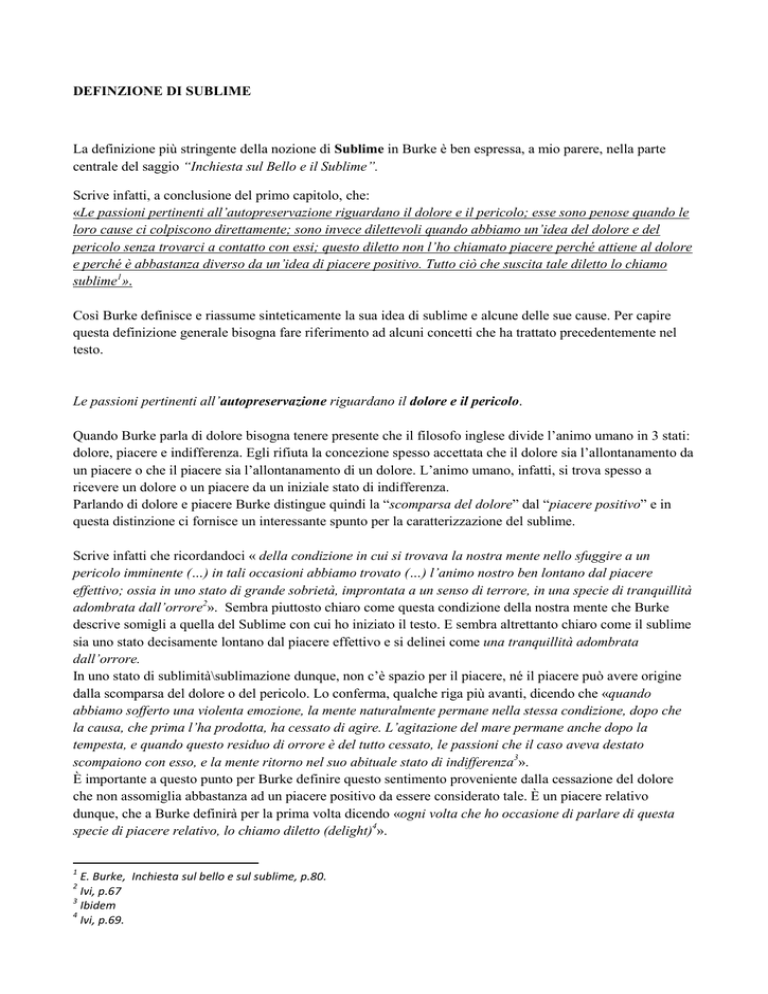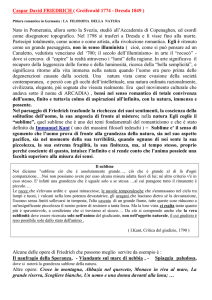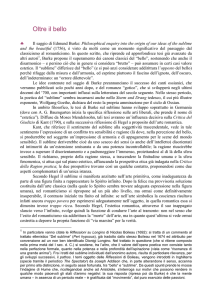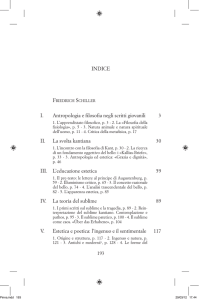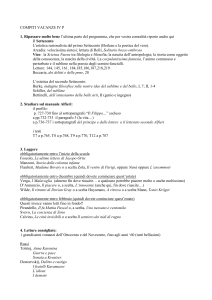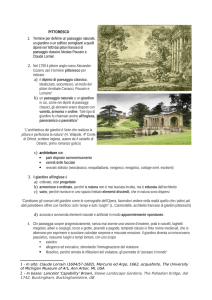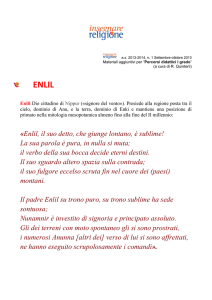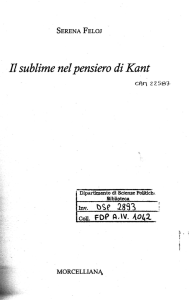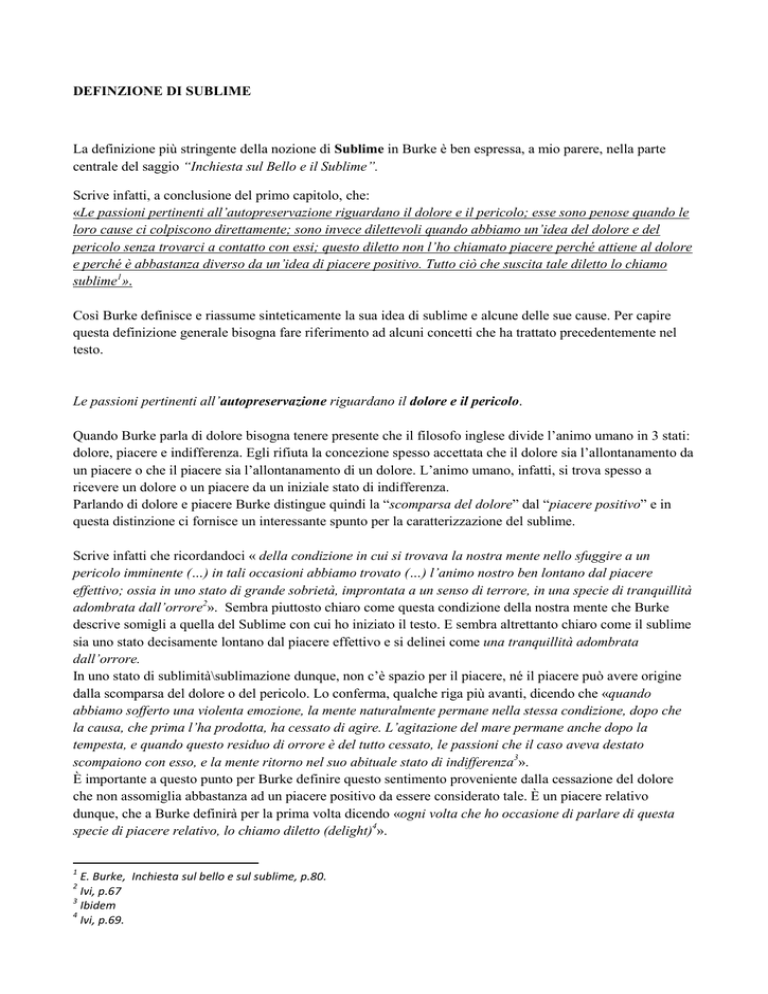
DEFINZIONE DI SUBLIME
La definizione più stringente della nozione di Sublime in Burke è ben espressa, a mio parere, nella parte
centrale del saggio “Inchiesta sul Bello e il Sublime”.
Scrive infatti, a conclusione del primo capitolo, che:
«Le passioni pertinenti all’autopreservazione riguardano il dolore e il pericolo; esse sono penose quando le
loro cause ci colpiscono direttamente; sono invece dilettevoli quando abbiamo un’idea del dolore e del
pericolo senza trovarci a contatto con essi; questo diletto non l’ho chiamato piacere perché attiene al dolore
e perché è abbastanza diverso da un’idea di piacere positivo. Tutto ciò che suscita tale diletto lo chiamo
sublime1».
Così Burke definisce e riassume sinteticamente la sua idea di sublime e alcune delle sue cause. Per capire
questa definizione generale bisogna fare riferimento ad alcuni concetti che ha trattato precedentemente nel
testo.
Le passioni pertinenti all’autopreservazione riguardano il dolore e il pericolo.
Quando Burke parla di dolore bisogna tenere presente che il filosofo inglese divide l‟animo umano in 3 stati:
dolore, piacere e indifferenza. Egli rifiuta la concezione spesso accettata che il dolore sia l‟allontanamento da
un piacere o che il piacere sia l‟allontanamento di un dolore. L‟animo umano, infatti, si trova spesso a
ricevere un dolore o un piacere da un iniziale stato di indifferenza.
Parlando di dolore e piacere Burke distingue quindi la “scomparsa del dolore” dal “piacere positivo” e in
questa distinzione ci fornisce un interessante spunto per la caratterizzazione del sublime.
Scrive infatti che ricordandoci « della condizione in cui si trovava la nostra mente nello sfuggire a un
pericolo imminente (…) in tali occasioni abbiamo trovato (…) l’animo nostro ben lontano dal piacere
effettivo; ossia in uno stato di grande sobrietà, improntata a un senso di terrore, in una specie di tranquillità
adombrata dall’orrore2». Sembra piuttosto chiaro come questa condizione della nostra mente che Burke
descrive somigli a quella del Sublime con cui ho iniziato il testo. E sembra altrettanto chiaro come il sublime
sia uno stato decisamente lontano dal piacere effettivo e si delinei come una tranquillità adombrata
dall’orrore.
In uno stato di sublimità\sublimazione dunque, non c‟è spazio per il piacere, né il piacere può avere origine
dalla scomparsa del dolore o del pericolo. Lo conferma, qualche riga più avanti, dicendo che «quando
abbiamo sofferto una violenta emozione, la mente naturalmente permane nella stessa condizione, dopo che
la causa, che prima l’ha prodotta, ha cessato di agire. L’agitazione del mare permane anche dopo la
tempesta, e quando questo residuo di orrore è del tutto cessato, le passioni che il caso aveva destato
scompaiono con esso, e la mente ritorno nel suo abituale stato di indifferenza3».
È importante a questo punto per Burke definire questo sentimento proveniente dalla cessazione del dolore
che non assomiglia abbastanza ad un piacere positivo da essere considerato tale. È un piacere relativo
dunque, che a Burke definirà per la prima volta dicendo «ogni volta che ho occasione di parlare di questa
specie di piacere relativo, lo chiamo diletto (delight)4».
1
E. Burke, Inchiesta sul bello e sul sublime, p.80.
Ivi, p.67
3
Ibidem
4
Ivi, p.69.
2
È da notare che fino a qui Burke non ha ancora menzionato la parola sublime nel testo, che è tuttavia
rintracciabile a livello concettuale da questa definizione primaria.
Avendo chiarito cosa intende Burke per “dolore e pericolo” passiamo alla nozione di autopreservazione.
I due concetti sono strettamente legati. Burke riconduce la totalità delle idee che producono un‟impressione
sulla nostra mente (siano esse di dolore o di piacere) a due scopi principali : il rapporto con la società e
l‟autopreservazione. Quest‟ultimo è il settore che ci interessa maggiormente poiché secondo Burke è proprio
all‟ambito dell‟autopreservazione dell‟individuo che si riferiscono le passioni riguardanti il dolore, il
pericolo, la morte e quindi le fonti del sublime, che per la prima volta viene introdotto nel testo con la
seguente definizione – «Tutto ciò che può destare idee di dolore e di pericolo, ossia tutto ciò che è in un
certo senso terribile, o che riguarda oggetti terribili, o che agisce in modo analogo al terrore è una fonte del
sublime; ossia è ciò che produce la più forte emozione che l’animo sia capace di sentire (dico più forte
perché sono convinto che le idee di dolore siano molto più forti di quelle che riguardano il piacere) […]
quando il pericolo o il dolore incalzano troppo da vicino, non sono in grado di offrire alcun diletto e sono
soltanto terribili; ma considerati a una certa distanza, e con alcune modificazioni, possono essere e sono
dilettevoli5».
Tuttavia anche nell‟ambito delle passioni sociali si possono trovare fonti del sublime. Se le passioni
riguardanti la preservazione dell‟individuo si riferiscono esclusivamente al dolore e al pericolo, quelle che
riguardano le passioni sociali hanno la loro origine nell‟appagamento e nel piacere. La più importante e
significativa delle passioni sociali per il discorso sul Sublime è la nozione di Simpatia, che Burke considera
come una specie di sostituzione, in forza della quale ci mettiamo al posto di un‟altra persona e siamo colpiti
da ciò che colpisce quella persona. Questo tipo di passione può quindi partecipare alla natura di quelle che si
riferiscono all‟autopreservazione e, rivolgendosi al dolore, può essere una causa del sublime.
Oltre a ciò la simpatia può rivolgersi a idee di piacere. È questo il motivo per cui le arti trasmettono
passionalità da un animo all‟altro e sono spesso capaci di aggiungere diletto alla disgrazia, alla miseria, e alla
morte. È stato infatti spesso osservato, e ribadito anche nel seminario, come oggetti che nella realtà
urterebbero sono capaci di offrire un piacere elevato nelle rappresentazioni della sventura, etc. Il motivo di
tale soddisfazione, secondo Burke, non è da ritrovare dal conforto che storie così brutte sono di pura
invenzione (anche perché se facciamo riferimento all‟apparition narrative li le storie erano scritte tutte il più
realisticamente possibile, o al tale of terror che riprendeva fatti realmente accaduti), né tantomeno dal fatto
che vederli in scena ci libera dai mali che vediamo rappresentati. Non è, per Burke, imputabile una reazione
di questo genere a un fatto razionale derivato dalla ragione.
Il Sublime appartiene alla dimensione del pathos.
Per comprendere questo punto Burke parte dall‟assunto secondo il quale noi proviamo un certo diletto nelle
disgrazie e nei dolori degli altri, poiché aggiunge che “il terrore è una passione che produce sempre diletto
quando non incalza troppo da vicino, e la pietà è una passione accompagnata dal piacere, poiché nasce
dell’amore e dall’affetto sociale6”. Ed ecco il passaggio chiave «Dio, poiché ha voluto che fossimo uniti dal
legame della simpatia, lo ha rafforzato con un diletto adeguato, soprattutto là dove più occorre la nostra
simpatia, cioè negli affanni altrui. Se questo sentimento fosse semplicemente doloroso, noi eviteremmo le
persone e i luoghi che suscitassero una tal passione […] ma non è così; non v’è nessuno spettacolo che
ricerchiamo con tanto interesse quanto quello di una disgrazia insolita e dolorosa […] esso non è un diletto
puro, ma va unito ad una certa inquietudine. Il diletto che proviamo in tali casi è quello che ci vieta di
5
6
Ivi, p.71
Ivi, p.76
fuggire scene di miseria, e il dolore che noi proviamo ci incita a confortarci nel consolare chi soffre; tutto
ciò previene qualsiasi ragionamento, in forza di un istinto che ci porta ai suoi fini, senza la nostra adesione
razionale7».
Quindi il sublime è un predicato cha agisce sul piano irrazionale, sul piano del logos e non necessita, per
partecipare, della nostra adesione razionale. Viene prima: è ancora il pathos che precede il logos.
Conclude poi specificando che nelle «disgrazie reali o in quelle immaginarie non è la nostra immunità che
desta il diletto8» spiegando che il fatto di essere al sicuro nel guardare la tragedia sia solo una condizione
necessaria ma non sufficiente per scatenare il sublime. Il che può entrare in parte in contraddizione con
l‟Addison di “On the Pleasures of the Imagination” il quale ci dice che il sublime attrae perché ci fa
“schifo”, ma noi in questo schifo siamo dall‟altra parte. C‟è il pericolo da una parte e noi siamo dall‟altra. Ci
sentiamo safe. Più e pericoloso quello che vediamo, e più è grande il piacere che traiamo dal fatto di trovarci
dall‟altra parte.
7
8
Ibidem.
Ivi, p.78
CAUSE DEL SUBLIME
Causa primaria del Sublime è per Burke lo Stupore, definito come lo stato d’animo in cui, ogni moto
sospeso, regna un certo grado di orrore9. Una mente stupita è talmente assorta nel suo oggetto che non può
pensare ad altro, e, di conseguenza, non è nemmeno in grado di ragionare su un oggetto che la occupa
totalmente. È qui che nasce il Sublime, che non è quindi il prodotto dei nostri ragionamenti, perché è prima
di essi, li previene.
Lo Stupore quindi, è «l’effetto del sublime nel suo più alto grado10».
E che cosa priva più di tutti l‟efficacia delle mente di agire e ragionare? Secondo Burke la paura. Da qui tutto
ciò che è terribile alla vista (quindi pauroso) è anche sublime. Anzi, il terrore, aggiunge Burke, è la
principale causa del sublime ed è indissolubilmente legato allo stupore, come testimoniano alcuni fenomeni
linguistici: il verbo stupeo può essere usato per esprimere l‟effetto di un timore o dello stupore, o il termine
attonitus.
E allora, andando ancora indietro. Che cosa rende un oggetto molto terribile?
Innanzitutto l‟Oscurità. L‟oscurità genera terrore perché, dice Burke, ci impedisce di conoscere l‟intera
estensione di una superficie, l‟intera estensione di un pericolo. Nell‟oscurità siamo sempre in balia di eventi
che non riusciamo a controllare, e pensiamo ad esempio agli episodi di “The Castle of Otranto” e ai
sotterranei del castello.
Burke confuta l‟idea di Locke riguardo l‟oscurità, il quale sostiene che «avendo una volta una nutrice o una
vecchia associata le idee di fantasmi e di demoni all’idea di oscurità, la notta d’allora in poi è diventata
penosa e orribile11». Seguendo questo ragionamento dunque potremmo dedurre che per chi non ritiene
l‟oscurità penosa o terribile, essa possa non essere causa di sublime.
Burke rigetta l‟idea di Locke ribandendo che l‟oscurità non può essere frutto solo di un‟abitudine, ma che è
orribile per propria natura e che sia fonte di sublime non solo in quanto produce terrore ma anche in quanto
causa di sofferenza. Infatti in una situazione di oscurità le nostre pupille sono sempre in tensione, in un
continuo sforzo per percepire la luce.
Oltre all‟idea di pericolo, l‟idea di sublime è connessa con il senso della potenza. La potenza, o la grandezza
generatrice del sublime deve però essere legata a oggetti di non utilità sociale o legati al non-quotidiano12.
E ancora sulle dimensioni – introducendo il paragrafo Perché gli oggetti visivi di grandi dimensioni sono
sublimi13 - Burke dà una spiegazione di natura “tecnica” sul perché gli oggetti grandi producono in noi una
sensazione di sublime, sia che consideriamo la visione ottico-retinica come l‟impatto di un‟immagine che si
dipinge integralmente sulle terminazioni nervose dell‟occhio (e quindi causa di impressione, meraviglia,
stupore), sia se consideriamo l‟immagine non come un tutto immediatamente percepito, ma come un totalità
di cui uniamo le parti con rapidi e violenti movimenti dell‟occhio. Movimenti rapidi, nervosi, e dolorosi,
contrazioni che generano in noi una dimensione di sublime.
9
Ivi, p.85
Ibidem.
11
Ivi, p.148
12
Ivi, p.92
13
Ivi, p.148
10
LA DISTINZIONE TRA BELLO E SUBLIME
La separazione di Bello e Sublime, già operata da Addison definendo il Sublime un orrore piacevole, in
Burke quasi si polarizza e muove da una concezione del Bello decisamente anti-romantica che riprende il
superamento delle posizione empiriche già avvenuto con Shaftesbury e Addison.
Sinteticamente… il Bello in Burke non risiede nella perfezione, ne tantomeno nella proporzione. Si distacca
cosi da criteri neoclassici, restituendo ancora la categoria della bellezza non alle facoltà razionali che
organizzano la materia sensibile razionalizzandola.
Né tantomeno il bello appartiene alla categoria dell‟utilità sociale14 riprendendo in questo un concetto già
precedente espresso da Shaftesbury che, mediato da Addison, arriverà a Burke. L‟esperienza estetica, a
differenza dell‟empirismo, non è legata a un fine.
A ben vedere però anche al sublime Burke aveva negato qualsiasi capacità di convenienza e utilità sociale
quando, parlando di grandezza e di oggetti legati al non quotidiano, aveva legato la grandezza generatrice del
sublime alla non utilità sociale. E precisamente: «Noi siamo continuamente a contatto con animali di una
forza che è considerevole, ma non dannosa. Tra di essi non cerchiamo mail il senso del sublime; questo
senso ci coglie nell’oscura foresta e nella landa ululante […] Ogni volta che la forza è soltanto utile non è
mai sublime15» perché, sintetizzando, è una forza che agisce per la nostra volontà e non dominando la nostra
volontà, caso nel quale può darci il sublime.
Contrasto tra Bellezza e Sublime
Ricercando quindi le cause della bellezza, che agisce sulla mente umana attraverso i sensi, e non in seguito a
facoltà razionali, Burke le individua in primo grado nella “piccolezza”. Opera qui quindi quel contrasto
dialettico, quella netta separazione tra Sublime e Bellezza, come vi è grande differenza, dice lui, tra
ammirazione e amore. «Se le qualità del sublime e del bello si trovano talvolta unite, ciò prova forse che
siano la stessa cosa? O che essi siano in un certo senso affini? Od anche che non siano opposti e
contraddittori? Il bianco e il nero si possono mitigare e armonizzare, ma non per questo sono la stessa
cosa16».
È evidente quindi il carattere di separazione nel concetto di Burke. Il contrasto tra Sublime e Bellezza è
individuabile nelle cause che secondo Burke generano Bellezza, e prima fra tutte la piccolezza.
Dopo aver delineato le caratteristiche della piccolezza ed avendo associato a questo qualità la bellezza,
Burke la mette per la prima volta a confronto con il sublime.
«Vi è una grande differenza tra ammirazione e amore. Il sublime, che è causa della prima, risiede sempre in
oggetti grandi e terribili, mentre l’amore si rivolge a oggetti piccoli e piacevoli; noi ci sottomettiamo a ciò
che ammiriamo, ma amiamo ciò che a noi si sottomette. […] In breve le idee di sublime e di bello poggiano
su basi cosi diverse che è difficile pensare di conciliarle nello stesso oggetto senza attenuare l’effetto
dell’uno e dell’altro. Cosicché, riguardo alla loro quantità, gli oggetti belli sono relativamente piccoli17».
E ancora ricorda il contrasto tra sublime e bellezza, legandolo non solo alle qualità delle dimensioni ma a
tutte quelle qualità che lui ha descritto come causa di bellezza negli elementi sensibili.
14
Ivi, p.119
Ivi, p.91
16
Ivi, p.136
17
Ivi, p.127
15
«Nel chiudere questa visione d’insieme della bellezza sorge naturale l’idea di paragonarla col sublime, e in
questo paragone il contrasto appare notevole. Gli oggetti sublimi sono infatti vasti nelle loro dimensioni, e
quelli belli al confronto sono piccoli; se la bellezza deve essere liscia e levigata, la grandiosità è ruvida e
trascurata; la bellezza deve evitare la linea retta, ma deviare da essa insensibilmente, la grandiosità in molti
casi ama la linea retta e quando se ne allontana compie spesso una forte deviazione; la bellezza non deve
essere oscura, la grandiosità deve essere tetra e tenebrosa; la bellezza deve essere leggera e delicata, la
grandiosità solida e perfino massiccia. Il bello e il sublime sono davvero idee di natura diversa, essendo
l’uno fondato sul dolore e l’altro sul piacere, e per quanto possano scostarsi in seguito dalla diretta natura
delle loro cause, pure queste sono distinte tra loro18».
Nel capitolo successivo analizza come e se la bellezza possa coesistere con il sublime dicendo che «L’effetto prodotto dai corpi grandi, ornati dagli elementi della bellezza, è una tensione continuamente
mitigata, che si avvicina al senso della mediocrità […] il sublime soffre meno d’essere unito ad alcune delle
qualità della bellezza, di quel che la bellezza non soffra ad essere unita alla grandezza delle dimensioni o ad
alcun’altra proprietà del sublime. In tutto ciò che ci ispira timore e terrore, c’è qualche cosa di cosi
imperioso e opprimente, che null’altro può stare in sua presenza. Qui le qualità della bellezza giacciono
morte e inattive o tutt’al più impiegate a mitigare il rigore e la durezza del terrore, che è il naturale alleato
della grandezza19.
E riguardo alla grandezza «ciò che è grande e gigantesco, sebbene sia in misura compatibile col sublime, è
contrario al bello. È impossibile che un gigante sia oggetto di amore». E fa alcuni esempi tratti dalla
letteratura e dai miti in cui i giganti siano legati a idee di tirannia, crudeltà e violenza e che nella narrazione
siamo spesso spinti a porci dalla parte non dei giganti, ma dei loro avversari, delineando quindi la grandezza
(e quindi il sublime) come pericolo e nostro nemico e dall‟altra parte la piccolezza dei loro avversari (e
quindi la bellezza) come amore e nostro alleato.
18
19
Ivi, pp.135-136
Ivi, p. 159
IL PARAGONE CON LA CONCEZIONE DEL SUBLIME DI ADORNO
Adorno parla di sublime a distanza di due secoli dalla concezione di Burke. In mezzo c‟è stato molto.
C‟è stato soprattutto Kant, che porta la riflessione al suo sviluppo più maturo. Rispetto alla concezione di
Burke, che risente, pur distaccandosene nei punti evidenziati, delle correnti empiristiche del XVIII Secolo,
Kant porta la riflessione su un altro livello in cui il sublime non è un oggetto analizzabile, o una qualità di
alcune realtà fenomeniche. Il sublime diventa con Kant il risultato di un giudizio.
Uno dei punti più importanti che Adorno riprenderà da Kant è la distinzione del sublime dal bello.
Laddove il bello esprime l‟accordo delle nostre capacità conoscitive, alla base del sublime c‟è invece il
contrasto tra immaginazione e ragione, e quindi un dissidio, un movimento all‟interno delle nostre facoltà
conoscitive.
Questo ricorda l‟evoluzione di quello che Burke sosteneva per definire l‟opposizione tra bello e sublime,
definendo quest‟ultimo come lo “stare sul limite” e il bello per antitesi il “non stare sul limite”. Da qui il
bello dipendente dalla ragione sociale, lo stare nel discorso comune e il fine utilitario (come la bellezza delle
donne il cui fine è la procreazione).
La definizione di Kant come contrasto tra le nostre facoltà conoscitive riprende anche le idee di Shaftesbury
il quale riteneva il sublime la capacità della mente di unire gli opposti.
Arriviamo dunque ad Adorno e alla nozione di Sublime all‟interno della Teoria Estetica.
«Le opere in cui la forma estetica sotto la pressione del contenuto di verità trascende se stessa, occupano il
posto una volta inteso dal concetto di sublime. In esse lo spirito e il materiale si allontanano l'uno dall'altro
nello sforzo di diventare tutt'uno20».
Adorno riscatta così la categoria del sublime (se pensiamo al postaccio dove lo aveva gettato Hegel
relegandolo a mera contemplazione naturale), ascrivendolo alle opere che per lui hanno la più grande
modernità.
La capacità che l'opera d'arte ha di farci prendere una posizione critica nei confronti della realtà è definita da
Adorno come contenuto di verità. La forma estetica in cui si presenta l‟opera d‟arte dunque non si limita alla
pura formalità, ma proprio grazia all‟esigenza di questo contenuto di verità di far emergere una realtà critica,
l‟opera d‟arte trascende sé stessa, cioè va oltre il suo contenuto formale per darci l‟altro del reale. Ed è simile
al concetto che lo stesso Adorno, sulla scorta di Benjamin, definiva auralità dell‟opera, che non è da
intendere solamente come “l’hic et nunc, il qui e ora dell’opera”, ma anche come qualcosa che caratterizza
l‟opera d‟arte al punto che, citando Benjamin, “per quanto vicina sia resti sempre lontana”. Ovvero che per
quanto noi tentiamo di spiegare l‟opera, di comprenderla questa sempre ci sfugge. Quindi comprendiamo che
la comprendiamo ma che non comprendiamo del tutto, che più continuiamo a comprenderla, più quella
continua a sfuggirci, perché non riusciremo mai a comprenderla e spiegarla una volta per tutte.
Questo è per Adorno il sublime. Per Adorno il Sublime sostituisce il bello, dal momento che il bello è come
se avesse fatto il suo tempo. Il bello è proprio dell'arte tradizionale perché il bello è in primo luogo Armonia.
Il sublime invece indica questa dimensione di trascendenza, di eccedenza, qualcosa che la ragione non riesce
a comprendere.
Lo teorizza Adorno, ma molti artisti moderni preferiscono la nozione di sublime alla nozione di bello, per
esempio Barnet Newman che esplicitamente dice basta con la bellezza, che è un portato della cultura europea
e scrive un saggio intitolato "Il sublime, ora".
20
T. Adorno – Teoria Estetica, p.262.
Spingendoci oltre potremmo dire che prima, nella bellezza, poteva esserci trascendenza, e che questo è il
tempo del sublime. Per Adorno questo è un mondo in cui non può più darsi la bellezza, “scrivere una poesia
dopo Auschwitz è un atto di barbarie” dirà. E quindi il sublime è la modernità. Al posto della bellezza, a
questo mondo, appartiene il sublime.
«La dottrina Kantiana del sentimento del sublime descrive assai bene un’arte che in sé trema nel
sospendersi in funzione del contenuto di verità che non appare, senza tuttavia cancellare, in quanto arte, il
proprio carattere d’apparenza21».
Riprendendo il concetto kantiano, Adorno utilizza la nozione di sublime per delineare uno dei cardini della
propria filosofia. Abbiamo già chiarito la natura del “contenuto di verità”. Qui Adorno ci dice che tale
contenuto di verità non è mera apparenza, eppure si dà senza essere esso stesso apparenza.
Sono riflessioni che Adorno riprende da lontano, sono riflessioni che vengono da Nietzsche e che riprenderà
anche la filosofia francese.
Parlare di “contenuto che non appare, senza tuttavia cancellare la propria apparenza” vuol dire che
nell‟Arte questo contenuto appare in quanto sensibile, pur non essendo esso stesso sensibile e quindi, nel
momento in cui appare, cancella conseguentemente la propria apparenza.
Quando si parla di queste due termini non si intende due entità che si contrappongono, ma di un Invisibile
che è l‟altra faccia del Visibile, e allora possiamo parlare dell‟uno solo in quanto ce l‟altro.
La dimensione del sentire è quella che ci permette di cogliere il senso, perché il senso non si offre al logos; il
senso si offre al sentire. La caratteristica del sentire è quella di non tradursi mai in termini logici, c‟è
qualcosa nel sentire e nel senso che non si lascia tradurre in logos. È quello che Nietzsche chiamava rapporto
tra Apollo (il logos, la forma) e Dioniso (l‟invisibile, informe, indicibile). È pero anche vero che i due non
sono contrapposti: c‟è Apollo in quanto c‟è Dioniso e c‟è dicibile in quanto c‟è indicibile e viceversa.
Questa dimensione del pathos, del non dicibile, è, per Adorno, una dimensione indissolubilmente legata alla
dimensione del sublime.
E dunque il fatto di cogliere l‟invisibile nel visibile, e di coglierlo non come un Visibile, ma il coglierlo come
un sentire, l‟accorgersi che all‟interno di questo visibile c‟è qualcosa che non si è rivelato ci dice che
l‟elemento visibile, l‟apparenza serve a far emergere, tramite essa, un qualcosa di altro.
Ed è lo stesso motivo della siepe in Leopardi. Una poesia come l‟Infinito è adatta a descrivere un sublime
che non è quindi legato esclusivamente a oggetti di grandi dimensioni, bensì al domestico, al quotidiano, una
siepe. La siepe che non permette di vedere è proprio il motivo per cui Leopardi immagina interminabili
silenzi. Grazie alla siepe. Quindi l‟elemento che apparentemente impedisce, l‟elemento sensibile, è in realtà
un elemento che occorre.
C‟è poi un punto in cui a mio avviso Burke rivela una grande modernità e che è assolutamente affine al
concetto di sublime nell‟intera estetica di Adorno. In un punto infatti, Burke dice che «l’immaginazione
viene eccitata dalla promessa di qualcosa che ancora non c’è e non si ferma sull’oggetto che si presenta al
senso22».
21
22
Id., p.271
Id., p.100
Burke dedica poco spazio a questo tema, che sarà invece centrale nella filosofia del „900. Inserendo Burke il
non-finito tra le cause del sublime assumiamo di conseguenza che il sublime generi una promessa di
qualcosa che ancora non c‟è e che quindi non si ferma alla pura formalità dell‟oggetto artistico.
È il concetto di cui abbiamo parlato finora. Adorno svilupperà il concetto di promessa in chiave negativa, ma
il concetto di arte come promessa di felicità (dizione ripresa da Stendhal), facendone l‟architrave della
propria utopia negativa.
Se come abbiamo detto prima il contenuto di verità dell'opera è la messa in questione della realtà per far
emergere nella realtà l'altro del reale, Adorno identifica in questa “messa in questione del reale” il compito
dell'opera d'arte. Se ancora possiamo sperare che la realtà possa cambiare, questa speranza la possiamo
depositare soltanto nell‟opera d‟arte. Se non ci fosse l‟arte non avremmo più la dimensione utopica,
speranza di un cambiamento. E questa possibilità è riservata da Adorno al sublime, che trova qui il
fondamento della sua carica utopica. Un‟arte sublime è un‟arte delle possibilità.
La dimensione utopica, aggiunge Adorno, non può essere comunicata dall‟artista in maniera diretta, perché
l'arte non usa il linguaggio del logos, ma agisce sul piano del pathos, giocando quindi sul terreno del
sublime.
Per cui ce lo dice, ci mostra un contenuto attraverso i suoi dati sensibili e immediatamente ce lo nasconde, lo
disdice. E‟ un senso, una verità che non si dà una volta per tutte, ma un secretum, che si apre, un'aleteia. Un
non-dimenticato, non-nascosto, rivelato, ma mai svelato una volta per tutte. Una verità che si schiude, e
dunque uno schiudersi che non è proprio della verità logica, a cui si arriverebbe per deduzione. E‟ la verità
dei presocratici ripresa da Nietzsche in poi e che diventa fondamentale nella filosofia del „900.
E‟ la verità che non si affida agli occhi, per questo non è logos, non è chiarezza. Joyce arriva a dire “chiudi
gli occhi e vedrai” nelle prime pagine dell‟Ulisse. Vuoi raggiungere la verità? Non puoi farlo con il logos,
con il logos sei li a girarci intorno, non cogli mai il punto. Ti allontani anziché avvicinarti.
E anche quella con cui ancora Joyce chiude l‟ultimo racconto di Dubliners, The Dead, in cui i protagonisti
devono scendere al livello dei morti per capire UN senso, per far emergere il momento epifanico.