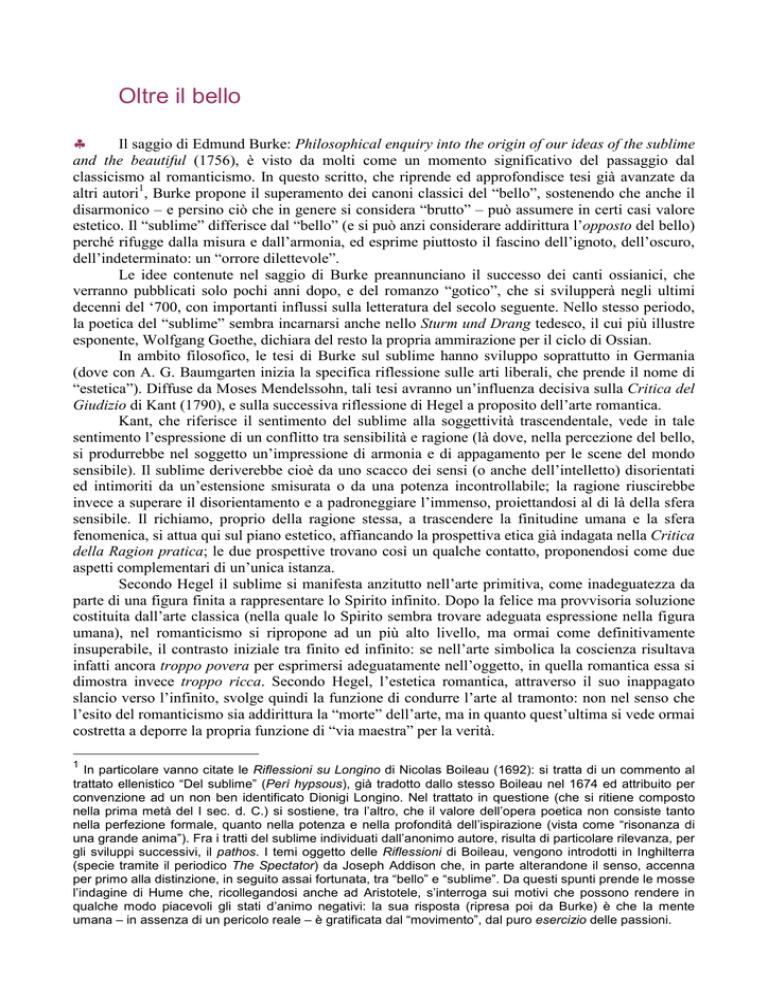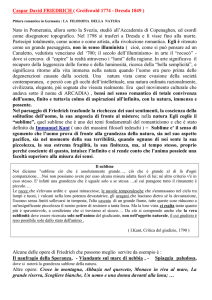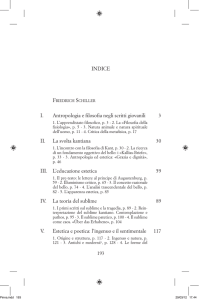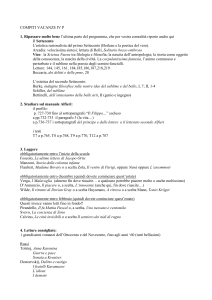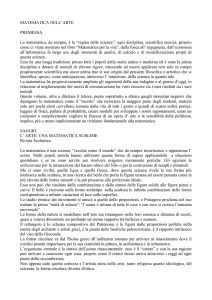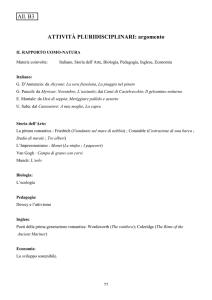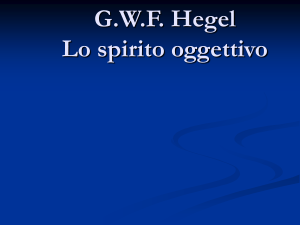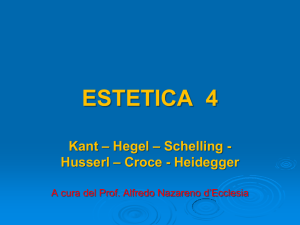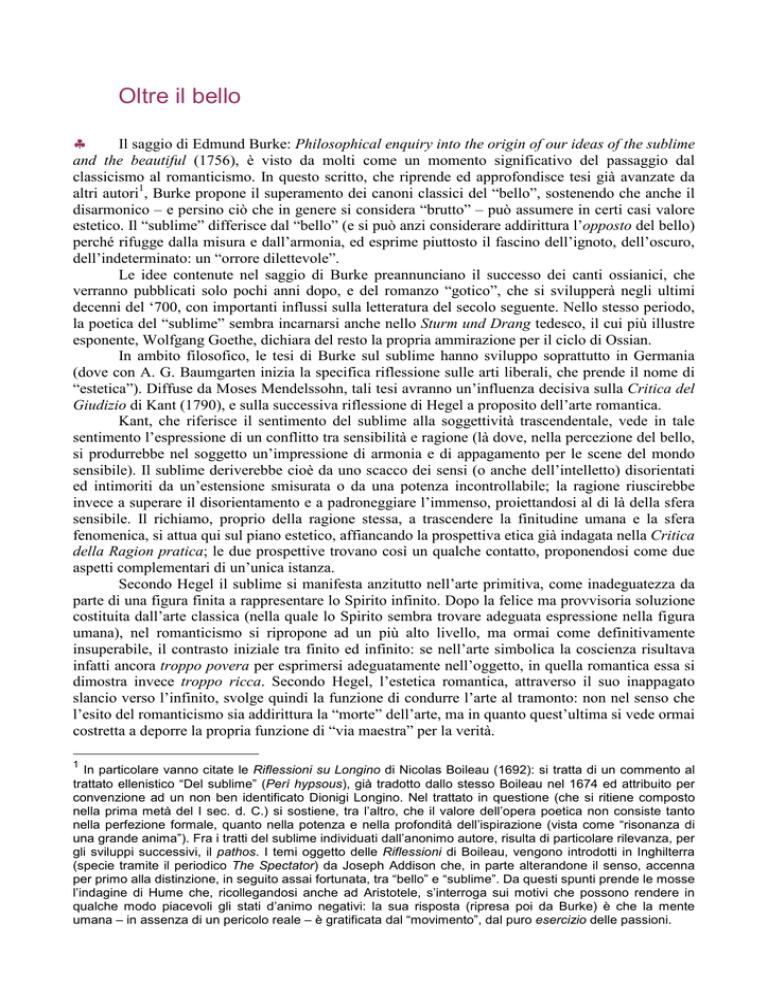
Oltre il bello
♣
Il saggio di Edmund Burke: Philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime
and the beautiful (1756), è visto da molti come un momento significativo del passaggio dal
classicismo al romanticismo. In questo scritto, che riprende ed approfondisce tesi già avanzate da
altri autori1, Burke propone il superamento dei canoni classici del “bello”, sostenendo che anche il
disarmonico – e persino ciò che in genere si considera “brutto” – può assumere in certi casi valore
estetico. Il “sublime” differisce dal “bello” (e si può anzi considerare addirittura l’opposto del bello)
perché rifugge dalla misura e dall’armonia, ed esprime piuttosto il fascino dell’ignoto, dell’oscuro,
dell’indeterminato: un “orrore dilettevole”.
Le idee contenute nel saggio di Burke preannunciano il successo dei canti ossianici, che
verranno pubblicati solo pochi anni dopo, e del romanzo “gotico”, che si svilupperà negli ultimi
decenni del ‘700, con importanti influssi sulla letteratura del secolo seguente. Nello stesso periodo,
la poetica del “sublime” sembra incarnarsi anche nello Sturm und Drang tedesco, il cui più illustre
esponente, Wolfgang Goethe, dichiara del resto la propria ammirazione per il ciclo di Ossian.
In ambito filosofico, le tesi di Burke sul sublime hanno sviluppo soprattutto in Germania
(dove con A. G. Baumgarten inizia la specifica riflessione sulle arti liberali, che prende il nome di
“estetica”). Diffuse da Moses Mendelssohn, tali tesi avranno un’influenza decisiva sulla Critica del
Giudizio di Kant (1790), e sulla successiva riflessione di Hegel a proposito dell’arte romantica.
Kant, che riferisce il sentimento del sublime alla soggettività trascendentale, vede in tale
sentimento l’espressione di un conflitto tra sensibilità e ragione (là dove, nella percezione del bello,
si produrrebbe nel soggetto un’impressione di armonia e di appagamento per le scene del mondo
sensibile). Il sublime deriverebbe cioè da uno scacco dei sensi (o anche dell’intelletto) disorientati
ed intimoriti da un’estensione smisurata o da una potenza incontrollabile; la ragione riuscirebbe
invece a superare il disorientamento e a padroneggiare l’immenso, proiettandosi al di là della sfera
sensibile. Il richiamo, proprio della ragione stessa, a trascendere la finitudine umana e la sfera
fenomenica, si attua qui sul piano estetico, affiancando la prospettiva etica già indagata nella Critica
della Ragion pratica; le due prospettive trovano così un qualche contatto, proponendosi come due
aspetti complementari di un’unica istanza.
Secondo Hegel il sublime si manifesta anzitutto nell’arte primitiva, come inadeguatezza da
parte di una figura finita a rappresentare lo Spirito infinito. Dopo la felice ma provvisoria soluzione
costituita dall’arte classica (nella quale lo Spirito sembra trovare adeguata espressione nella figura
umana), nel romanticismo si ripropone ad un più alto livello, ma ormai come definitivamente
insuperabile, il contrasto iniziale tra finito ed infinito: se nell’arte simbolica la coscienza risultava
infatti ancora troppo povera per esprimersi adeguatamente nell’oggetto, in quella romantica essa si
dimostra invece troppo ricca. Secondo Hegel, l’estetica romantica, attraverso il suo inappagato
slancio verso l’infinito, svolge quindi la funzione di condurre l’arte al tramonto: non nel senso che
l’esito del romanticismo sia addirittura la “morte” dell’arte, ma in quanto quest’ultima si vede ormai
costretta a deporre la propria funzione di “via maestra” per la verità.
1
In particolare vanno citate le Riflessioni su Longino di Nicolas Boileau (1692): si tratta di un commento al
trattato ellenistico “Del sublime” (Perì hypsous), già tradotto dallo stesso Boileau nel 1674 ed attribuito per
convenzione ad un non ben identificato Dionigi Longino. Nel trattato in questione (che si ritiene composto
nella prima metà del I sec. d. C.) si sostiene, tra l’altro, che il valore dell’opera poetica non consiste tanto
nella perfezione formale, quanto nella potenza e nella profondità dell’ispirazione (vista come “risonanza di
una grande anima”). Fra i tratti del sublime individuati dall’anonimo autore, risulta di particolare rilevanza, per
gli sviluppi successivi, il pathos. I temi oggetto delle Riflessioni di Boileau, vengono introdotti in Inghilterra
(specie tramite il periodico The Spectator) da Joseph Addison che, in parte alterandone il senso, accenna
per primo alla distinzione, in seguito assai fortunata, tra “bello” e “sublime”. Da questi spunti prende le mosse
l’indagine di Hume che, ricollegandosi anche ad Aristotele, s’interroga sui motivi che possono rendere in
qualche modo piacevoli gli stati d’animo negativi: la sua risposta (ripresa poi da Burke) è che la mente
umana – in assenza di un pericolo reale – è gratificata dal “movimento”, dal puro esercizio delle passioni.
♣
Sia pure nel prospettato fallimento della dimensione estetica, Hegel coglie nello “squilibrio”
e nel “pathos” propri dell’arte simbolica e romantica, sempre i tratti della potenza e dell’infinità
attribuite tradizionalmente al divino: il compito dell’arte consiste appunto nell’aprire la strada alla
visione religiosa e filosofica, cioè ad una più adeguata ricerca dell’assoluto. Ma si avvicina ormai il
tempo della morte di Dio, il tempo in cui comincia ad apparire anche il fallimento, in tale ricerca,
della religione e della filosofia. Leopardi è il primo a scorgere che, nella cultura contemporanea,
dell’infinito può restare, al più, una nostalgica illusione, e che persino nella vastità degli spazi
celesti l’uomo non può ormai incontrare altro che il deserto.
Il motivo fondamentale della cultura contemporanea – che viene evidenziandosi negli ultimi
centocinquant’anni – è il suo progressivo liberarsi dagli schemi (etici, estetici, logici) del proprio
passato: l’interesse per il sublime che, alle soglie dell’era romantica, si manifesta anche come
vocazione al “disordine”, può forse considerarsi un sintomo rilevante di questo sviluppo. Anche se
tale “disordine” appare, all’inizio, sempre legato a regole non estranee all’ordine precedente: i
canoni estetici del romanticismo (come vede Hegel) sono più dinamici e persino più sfumati di
quelli classici; ma sono pur sempre canoni, punti fermi fissati in una visione “forte” della realtà.
Se nella prospettiva classica il “bello” valeva come visione non problematica della verità,
come inserimento di una certa realtà umana in un ordine assoluto e definitivo, di cui si supponeva di
conoscere o almeno di intravedere i tratti essenziali, l’inquietudine dell’arte romantica esprime un
allontanarsi di quei tratti dalla vista dell’uomo. Il che, tuttavia, non rende priva di senso la loro
ricerca, anzi si traduce nel progetto di collocarla in una prospettiva ancor più vasta, che può aprirsi
proprio a partire dall’insoddisfazione per le mete conseguite in passato.
L’anima profonda della poesia romantica vede il sottrarsi del divino (e la corrispondente
desolazione del mondo) come una fuga, a cui dovrà prima o poi seguire un ritorno: l’artista è colui
che rimane in attesa, in nome dell’intera umanità, cercando nella notte tracce e segnali di un nuovo
albeggiare. “Quello che permane, lo fondano i poeti” recita l’ultimo verso della poesia Andenken di
Hölderlin: in mezzo al continuo fluire del reale, che sembra travolgere nel nulla tutte le cose e
lasciare solo la loro immagine nella memoria, il poeta si mantiene testimone del vero e dell’eterno.
Per questo, Leopardi non può essere, a rigore, annoverato tra i romantici: il suo canto (essenzialmente notturno) non annuncia l’alba di una nuova epoca del divino, ma il suo irreversibile
tramonto, e può apparire “sublime” solo in modo profondamente diverso dalla poesia di Hölderlin o
di Novalis. In questi autori la verità è vista ancora come consolazione del dolore, e la forma artistica
risulta in piena sintonia con il contenuto; nel Leopardi della Ginestra, la forma appare invece in
contrasto con il proprio contenuto (la testimonianza disincantata della verità), nel senso che il dire
poetico avvolge con la sua potenza la visione del deserto, trasfigurandola e rendendola sopportabile.
Deposta l’idea di un bello o di un sublime legati a modelli eterni di tipo platonico, ridotto
ogni valore estetico a convenzione, ad abitudine storicamente consolidata, resta sulla scena la pura e
nuda forza del dire poetico: la poíesis che ha in se stessa il proprio scopo, e si pone perciò al di
sopra di tutte le altre tecniche produttive che hanno invece tale scopo fuori di sé. Si tratta, secondo
Leopardi, dell’ultimo “quasi rifugio” dello spirito, che può recuperare un qualche senso di infinità
ed eternità solo cantando se stesso: il proprio dolore ed il proprio coraggio nell’affrontarlo. La
potenza del genio poetico “raccende l’entusiasmo” e “consola il deserto”, dando forza alla stessa
visione del “solido nulla” in cui consistono tutte le cose del mondo.
O si fa avanti, dopo la morte di Dio, quell’altra forma di potenza (affine nelle premesse ma
divergente negli esiti dalla proposta leopardiana) che è la volontà dell’oltre-uomo: anziché
adeguarsi a canoni metafisici ormai non più praticabili (le eterne strutture ideali di Platone o di
Hegel), l’uomo del futuro deve imporre al reale la forma della propria volontà creatrice. Ogni
aspetto negativo o anche banale, superficiale, della vita, è recuperato nel progetto post-metafisico
che vuol trasformare il non-senso dell’esistere in un senso inaudito. E in questa prospettiva vengono
meno anche i criteri che consentivano di distinguere tra “superficie” e “profondità”: è solo la
volontà di potenza a decidere del valore e dello spessore di qualunque situazione. “…E dove mai
l’uomo non rasenta un abisso? – si chiede Zarathustra – non è già il vedere, un vedere gli abissi?”
2
♣
Proprio alla luce di questi sviluppi, le tesi hegeliane sembrano conservare, dopo tutto, una
certa attualità: sia pure in forma implicita, esse anticipano la svolta che, dalla fine dell’Ottocento,
apre la strada all’arte contemporanea. Non solo oltre l’armonia del “bello”, ma anche oltre la
grandiosità del “sublime”: l’opera d’arte andrà costituendosi sempre più come un messaggio che,
anziché assumere significati universali, già definiti ed organici, persegue semplicemente la potenza
del dire, l’efficacia del puro impatto sul fruitore (non: “io amo questa cosa”, ma piuttosto: “la cosa è
qui davanti” – come suggerisce Rilke, commentando i quadri di Cézanne).
Gli elementi introdotti da tale messaggio presentano spesso un aspetto enigmatico, appaiono
frammentari, casuali; il gusto estetico può comprendere adesso anche quel “brutto” privo di dignità
e grandezza che Kant e Hegel (e poi l’intera tradizione filosofica) escludevano dall’espressione
artistica2. Nel brutto irrisolto, nella “banalità del male” non aperta dialetticamente al bene, nel
dettaglio provocatoriamente, oscenamente privo di significato, si esprimono quella disgregazione,
quella devastazione del mondo e dell’uomo in cui Zarathustra, il “solutore di enigmi e redentore del
caso”, individua la sfida decisiva.
La crisi dei canoni estetici è anche la crisi del soggetto cosciente, della ragione cartesiana
incaricata di recuperare ogni contenuto dell’esperienza umana in un ordine nitido ed unitario. L’Io
cartesiano (o anche kantiano, hegeliano) si fa da parte e lascia emergere i frammentari ed inquietanti
messaggi dell’Es: segnali ambigui, inciampi imprevedibili. Ma, se vogliamo seguire l’indicazione di
Freud, “comunque sia, bisogna andarci”.
Tutto ciò non significa che l’arte contemporanea rinunci, semplicemente, a dire qualcosa:
dopo il tramonto degli Eterni, l’arte può sopravvivere – restando grande – solo se conserva (ed
esprime con potenza) la consapevolezza di tale tramonto; solo se riesce a cogliere e a rappresentare
in modo non frammentario e non precario la frammentazione e la precarietà dell’esistenza. Il resto è
esercizio di maniera e vuota chiacchiera, proliferazione inconsapevole dell’insignificanza del dire e
del fare quotidiani (anche se, come vede appunto Nietzsche, le cose più vuote ed insignificanti
hanno sempre, per chi sa guardare, spessori abissali).
E ciò non significa neanche che non possano proporsi, nella cultura odierna, grandi opere
d’arte che, constatando la disgregazione e la devastazione del mondo, si risolvano ancora nella
speranza – di matrice romantica – che queste possano essere infine redente dal ritorno del divino
(The Waste Land di Eliot costituisce un esempio emblematico di tale prospettiva). Allo stesso
modo, è possibile che importanti pensatori contemporanei (Heidegger e Jaspers sono tra questi)
mantengano aperta la possibilità di un dio post-metafisico. Ma si tratta di – sia pur grandi – residui
del passato: Leopardi e Nietzsche vedono più lontano.
♣
Lo spettacolo della desolazione della Terra, la mancanza di senso e la precarietà assoluta
dell’esistere sono, del resto, il prezzo che l’uomo deve pagare per affermare la propria potenza e la
propria libertà di spingersi oltre ogni limite. Si tratta di un prezzo terribile, tramite il quale la tecnica
umana si libera da ogni – tranquillizzante, ma insieme vincolante – necessità della tradizione e si
apre lo spazio verso un futuro dagli esiti aperti ed imprevedibili.
E’ anche vero che la vocazione dello spirito umano per l’ignoto ed il terribile non costituisce
un’assoluta novità della cultura contemporanea. Il thauma (così sono indicati in greco la meraviglia
e l’orrore) accompagna l’uomo da quando vive sulla terra, e l’ambigua attrazione per ciò che
atterrisce è già ben espressa, ad esempio, dalla figura – decisamente moderna – di Odisseo, che
ripetutamente affronta l’ignoto, per pura curiosità o per mettere alla prova le proprie risorse.
2
Karl Rosenkranz (seguace di Hegel ed autore di una Estetica del brutto) ammette il negativo solo come
male riscattabile, cioè come dipendente dal positivo (il che non significa difendere il negativo “abbellito” che
è invece sofisticazione, “menzogna estetica”). Di conseguenza, egli condanna le opere di Hugo (di cui critica
in particolare il dramma Le roi s’amuse) per la loro mancanza di “giustizia poetica”, ed allo stesso modo
critica Dumas figlio (La Dame aux camélias) e Sue. In generale, restano condannati senza appello il
“naturalismo” ed il “realismo borghese” (Rosenkranz concorda con Baudelaire nel giudizio negativo sulla
fotografia) visti come sintomi di involuzione e di smarrimento del gusto.
3
Nel pensiero greco, tuttavia, l’attrazione per il thauma appare ben presto soverchiata dalla
volontà di superarlo, e soprattutto di comprenderlo, di risolverlo in una visione veritativa delle cose;
è questo uno dei caratteri salienti del grande progetto filosofico, ed è in quest’ottica che Platone ed
Aristotele affermano che la filosofia nasce dal thauma (cioè insieme dalla meraviglia e dall’orrore).
L’Orestea di Eschilo esprime, in termini prettamente filosofici, il trionfo della ragione su ciò che
terrorizza e disorienta: Atena, figlia di Zeus e simbolo della sapienza divina, placa infine le Furie
(simbolo della violenza che si perpetua nel tempo, che affligge e confonde l’uomo fino a travolgerlo
nella follia), ed esse si trasformano infine nelle Eumenidi, le “Benevole”, protettrici sotterranee,
invisibili, della città di Atene – cioè della città che incarna la sapienza filosofica.
Ma il tramonto della filosofia, intesa appunto come sapere assoluto che salva dal negativo,
riconduce l’umanità della nostra epoca verso il primitivo ed ambiguo rapporto con il thauma. “La
medicina è stata peggiore della malattia”, afferma Nietzsche, scorgendo che la “medicina” è stata
anzitutto inefficace. Perché il thauma l’uomo se lo porta da sempre nel cuore e, se molte sono le
cose terribili, nessuna è più terribile dell’uomo (come già ammoniva Sofocle, nell’Antigone).
Lo sguardo di Nietzsche si spinge abbastanza a fondo da scorgere che gli Eterni evocati
come “rimedio” dal pensiero filosofico e religioso, sono in realtà maschere superficiali della stessa
“malattia”: del terrore impotente di fronte al continuo ed imprevedibile mutare delle cose, alla
mancanza di senso e di scopo della vita. Ma tali maschere finiscono addirittura per aggiungere
dolore a dolore, follia a follia, ponendo il vivente in conflitto con la propria “rimossa” soggezione al
divenire. L’oltre-uomo è colui che non cerca più rimedi; non fugge più dalla meraviglia e dallo
sgomento, ma si allea con essi, trasformandoli in contenuti e strumenti del proprio volere.
Nietzsche non può giungere, tuttavia, a vedere che il pensiero ontologico greco costituisce,
prima ancora che una “maschera” (ed una falsa medicina) del terrore per il mutamento delle cose, la
radice stessa di quel terrore e di quel mutamento. Non perché prima della comparsa di tale pensiero
l’uomo sia libero dall’angoscia di fronte al divenire, ma perché solo la filosofia definisce in modo
compiuto il volto di tale angoscia e ne esalta i tratti fino alla potenza estrema; potenza che rimane in
vista anche dopo che la filosofia esce di scena in quanto rimedio. Sicché l’odierna fuga verso la
meraviglia (e verso il terrore che le è connesso) non è un semplice ritorno alla cultura pre-filosofica:
a fare la differenza, estremizzando la portata del meraviglioso e del terribile, è la crescente potenza
che il sapere tecnico-scientifico rende ormai disponibile all’uomo.
La vocazione alla potenza, che ha come controparte la terrificante imprevedibilità del
divenire, rappresenta il filo conduttore della storia dell’Occidente: prima che opporsi, in apparenza,
in superficie, a tale vocazione, l’ontologia greca le spiana addirittura la strada (preparando così il
proprio stesso tramonto). Il corso di questa strada è tracciato fin da quando Platone fissa i limiti
estremi del nascere e del morire, intesi come oscillazione delle cose tra l’essere ed il nulla. La
volontà di potenza – che costituisce l’essenza profonda della poíesis platonica – è destinata ad
affiorare in modo sempre più visibile nella cultura contemporanea, guidandola a travolgere i canoni
ed i valori della tradizione: argini troppo deboli per contenere la forza del fiume di cui inizialmente
sembravano controllare lo scorrere.
4