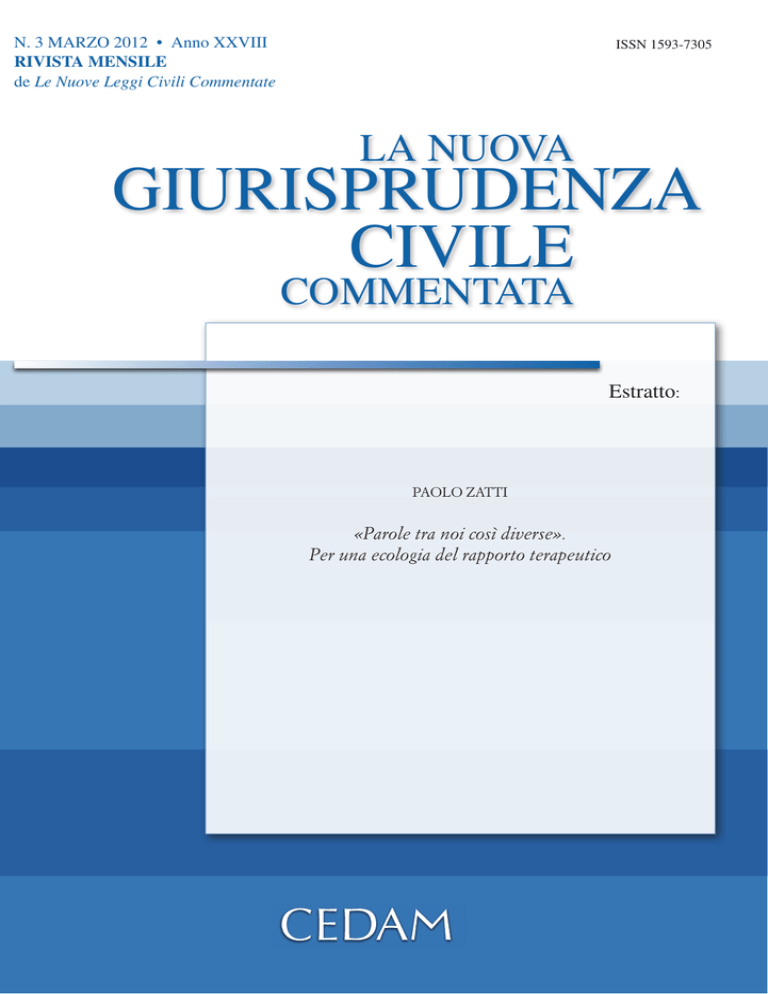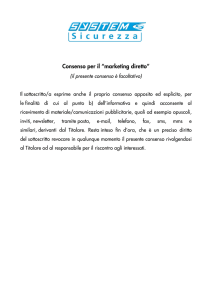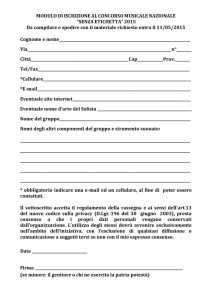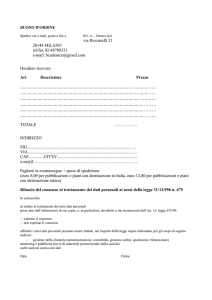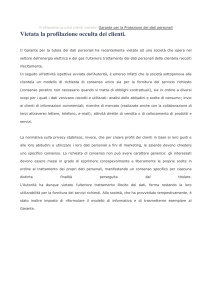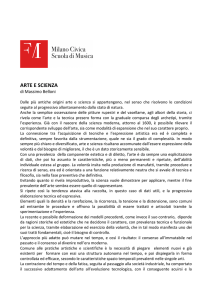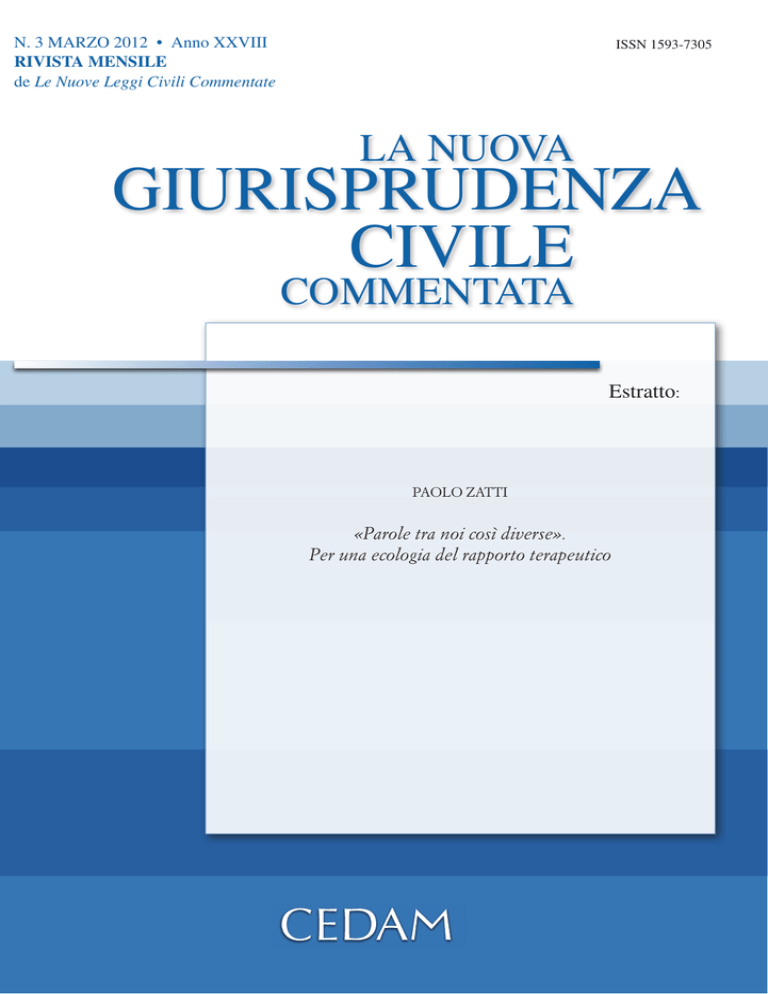
N. 3 MARZO 2012 • Anno XXVIII
RIVISTA MENSILE
de Le Nuove Leggi Civili Commentate
ISSN 1593-7305
LA NUOVA
GIURISPRUDENZA
CIVILE
COMMENTATA
Estratto:
PAOLO ZATTI
«Parole tra noi così diverse».
Per una ecologia del rapporto terapeutico
Letture e Opinioni
«PAROLE TRA NOI COSÌ DIVERSE»
Per una ecologia del rapporto terapeutico
di Paolo Zatti
Sommario: 1. La comunicazione diseguale. – 2. La
dis-eguaglianza nel rapporto di cura. – 3. I ritardi della medicina. – 4. I ritardi del diritto.
1. La comunicazione diseguale. Come si
indovina dal titolo, questa breve riflessione
non si addentra nelle questioni giuridiche del
consenso al trattamento medico, ma intende
proporre sinteticamente un metodo di discussione e soluzione del problema.
«Parole tra noi così diverse». Qualcuno avrà
sentito l’eco di un verso di Montale «parole tra
noi leggere» ... e forse qualcun altro di un romanzo di Lalla Romano, ancora «Parole tra noi
leggere». Ma la risonanza è casuale, o almeno
di secondo grado: si tratta in realtà del titoletto
di una scheda di «Tuttolibri» dedicata a «La
comunicazione diseguale» di Lucia Fontanella ( 1 ): un piccolo libro (132 pagine) quanto mai
lucido e brillante, che svolge un’analisi linguistica (l’autrice insegna Italiano all’Università di
Torino) della relazione tra medici, infermieri e
paziente nel topos dell’ospedale.
Il sottotitolo invece svela qualche piccola
ispirazione «batesoniana» che ha influito sul
mio modo di vedere il problema del consenso
al trattamento medico, dal punto di vista della
inadeguatezza dello stato attuale della disciplina e della necessità di una profonda riconsiderazione dell’approccio normativo ( 2 ).
L’analisi di Lucia Fontanella rivela i connoIl testo riproduce con modifiche la relazione svolta al Convegno di studi su «Consenso al trattamento
medico e tutela della salute: una relazione complessa» (Padova, 14.12.2011).
( 1 ) Il Pensiero scientifico, 2011.
( 2 ) Mi riferisco allo studio dei processi di comunicazione e di apprendimento nelle opere più conoNGCC 2012 - Parte seconda
tati della comunicazione dis-eguale, quella cioè
che si intreccia su un telaio di autorità-subordinazione; in sintesi, relazione tra un parlante
che detta le regole della comunicazione e un altro che ci si deve adattare.
Conviene forse precisare subito una distinzione che non sembra sempre chiara o accetta
ai medici: una comunicazione dis-omogenea
per competenza non è necessariamente diseguale. Se affido a un architetto la progettazione o la ristrutturazione della mia casa, lo investo di un compito che riguarda la sua competenza; la comunicazione sarà efficace tra noi se
io non pretenderò di emulare la sua competenza o di contestarne gli apprezzamenti. Ma mia
competenza – non sua – sarà di indicargli le
mie preferenze e di valutare se il progetto le
soddisfi: sarò io a poter dire (se lo ritengo importante) quale esposizione preferisco, quale
intensità di luce, quale ariosità, quale calore o
frescura; e certamente – se non sono sciocco –
avrò scelto l’architetto più o meno classico o
innovatore a seconda del mio gusto; a meno
che io non sia più a mio agio – è una scelta –
nel delegare alla competenza dell’architetto
ogni scelta, estetica funzionale abitativa, dicendo: faccia lei, come se fosse per se medesimo.
Nel caso che io voglia esercitare la mia competenza, l’elaborazione del progetto esigerà
una comunicazione circolare, simile a un processo che si autoregola verso un risultato che
compone e soddisfa tanto le esigenze tecniche
e valoriali (estetica, qualità) del professionista,
quanto le preferenze personali del committente-destinatario dell’opera: la circolarità assicusciute di Bateson, Verso un’ecologia della mente,
Adelphi, 1977 e Mente e Natura, Adelphi, 1984, rist.
2008.
143
Letture e Opinioni
rerà che la tecnica si pieghi fin dove possibile
alle preferenze, e che queste siano selezionate
escludendo quelle che non possono essere soddisfatte mantenendo ferme le esigenze di professionalità e il valore tecnico del risultato. Se i
criteri che governano le due «competenze»
vengono a confliggere in condizioni di rigidità
– in quanto le preferenze inderogabili del
cliente siano sentite dal tecnico come incompatibili con la sua integrità professionale, o le soluzioni sostenute dal professionista non soddisfino esigenze irrinunciabili per il cliente – il
processo circolare non regge e si rende inevitabile la rottura: il committente cambia architetto o l’architetto lascia l’incarico.
Ho scelto l’esempio dell’architetto perché altri mi parevano poco adeguati o provocatori:
paragonare il medico a chi ripara un’automobile o una caldaia non mi pare rendere giustizia
alla medicina, anche se talvolta è il medico a
proporre la metafora. Ma anche in questi più
ruvidi paragoni, e nella relativa banalità del
contesto della «riparazione», la disomogeneità
della comunicazione indotta dal suo tessuto
tecnico non genera alcuna subordinazione (se
non per fatti psichici che non stiamo a considerare): se porto l’automobile a riparare, non ho
probabilmente un campo di preferenze e valutazioni da far valere, fino a che non si aprono
opzioni diverse con uno spazio valutativo che
mi riguarda, per esempio sulla entità della revisione o sulla scelta tra riparare una vecchia caffettiera o rottamarla; se chiamo l’idraulico per
un problema alla caldaia, il mio spazio e «potere» sarà quello di indicargli la temperatura che
voglio avere in casa, o quello di scegliere tra
una riparazione moderatamente promettente e
un intervento più radicale ma più duraturo.
Anche qui esiste un concorso di «competenze»
e una circolarità della comunicazione che è circolarità del processo di decisione.
Insomma, le regole della comunicazione disomogenea/non diseguale non sono dettate da
una parte «competente», ma reciprocamente
da due parti di diversa competenza, e anzi in
senso più profondo dall’esigenza che la comunicazione sia bilaterale e circolare.
2. La dis-eguaglianza nel rapporto di
cura. La comunicazione osservata da Lucia
Fontanella non realizza queste caratteristiche;
144
essa si svolge sul presupposto che il paziente
(nomen omen!) non abbia una sua «autorità» –
un suo campo di informazioni e valutazioni
utili alla decisione – sul problema della propria
cura, che si vuole esaurire interamente nella
sua rappresentazione tecnica, tale quale nell’intervento del riparatore e anzi in modo meno
aperto ad opzioni, la cui convenienza resta alla
fine valutata dal medico.
Questo connotato di diseguaglianza è pervasivo: investe tutti i momenti e i segnali della comunicazione, e da tutti è asserito e confermato,
parole, espressioni, mimica facciale, gesti, posture.
Scrutando nella diseguaglianza per capirne i
fondamenti, Lucia Fontanella segnala un paradosso in un paradosso. La comunicazione si
svolge su un assunto inespresso ma inequivoco,
che vede l’ospedale come una proprietà – in
senso fattuale – di chi ci lavora, medici e infermieri. Esiste per loro, è la loro casa. Il paziente
è in casa d’altri, «ricoverato», come si dice,
«ospite» (ospitale) a certe condizioni: seguire
le regole, inserirsi nella logica gerarchica, non
protestare, accettare il giudizio e il rimprovero,
non esercitarli.
All’insegna della proprietà si scova un altro
paradosso: in una cultura proprietaria, che circonda di riguardi e difese anche sociali ogni
appartenenza, che guarda con sconcerto scandalizzato a chi metta le mani nella borsetta o
nel cassetto di un’altra persona, l’accesso al
corpo da parte del medico o dell’infermiere si
pratica spesso, di fatto, senza bussare: si può,
come il corpo del «paziente» non avesse un
«proprietario».
Ma se osserviamo il rapporto dal punto di vista della accettazione o del rifiuto della rispettiva «competenza» delle parti, e dunque della
circolarità della comunicazione e del processo
di decisione, allora emerge il presupposto culturale che rende il medico diverso dall’architetto della mia piccola parabola: il medico considera sua competenza decidere, su base di
scienza, di coscienza, come si usa dire, e di
esperienza, il bene della persona curata.
Emerge qui il fondamento antico della diseguaglianza, su cui il libro di L. Fontanella non
si sofferma esplicitamente ma che diffusamente
dimostra: è la resistenza dell’idea di potestà
medica, espunta dal codice deontologico nel
NGCC 2012 - Parte seconda
Per una ecologia del rapporto terapeutico
1998, dunque recentemente, ma tutt’altro che
scomparsa dalla lingua della medicina – basta
una ricerca in Google per dimostrarlo – e dalla
mente dei medici, che sembrano farne un tutt’uno con l’integrità della professione, cosa logicamente non fondata.
Lo schema mentale della potestà vuole che
spetti al medico, in base alla sua conoscenza scientifica e alla coscienziosa applicazione
delle sue conoscenze, di dire (non in senso
descrittivo, ma prescrittivo proprio come in
«iuris-dictio») qual è il bene del malato; non
come chi da competente fa una proposta fondata, ma come chi si assume la responsabilità
e il potere della scelta: fini e mezzi della terapia sono dettati dal medico, e la loro applicazione, in quanto benefica, è in sé giustificata;
al malato resta la possibilità di un espresso
dissenso, che è eccezionale (cfr. del resto in
giurisprudenza Cass. pen., 29.5.2002, n.
26446, caso Volterrani, e Cass. pen., sez un.,
21.1.2009, n. 2437 ( 3 )).
La potestà crea la comunicazione dis-eguale
non solo perché implica il suo contrario, la
soggezione, ma perché eleva la lingua della medicina come sapere a lingua del rapporto: è
questa lingua che detta l’orizzonte dei significati, e che stabilisce una prima “codificazione
del contesto” su cui poggia la codificazione
“potestativa”.
Certo la comunicazione si svolge; anche il
paziente parla, viene richiesto di dire e collaborare; ma il suo orizzonte di significati – e quindi la sua «competenza» – non è incluso nella
lingua dominante della relazione.
Esiste infatti un connotato tipico della scienza: essa è enunciativa, non comunicativa.
Scrive Maria Zambrano: «La Scienza si manifesta in forma enunciativa, impersonale (...)
ciò che la scienza non sa ridurre a sé sono certi stati della vita umana, certe situazioni che
l’uomo vive, e di fronte alle quali la forma
enunciativa della scienza non ha forza né valore» ( 4 ).
( 3 ) La prima decisione è pubblicata in Cass. pen.,
2003, 2659 ss.; la seconda anche in questa Rivista,
2009, I, 926 ss., con commento di Riondato-Palermo, ivi, II, 295 ss.
( 4 ) Zambrano, Verso un sapere dell’anima, Raffaello Cortina ed., 1996, 65.
NGCC 2012 - Parte seconda
Se nella relazione prevalgono non tanto e
non solo le parole, ma i significati della scienza
si crea di necessità una zona di cecità comunicativa.
Le parole essenziali al tema della relazione –
salute, sofferenza, cura, guarigione, vita buona,
vita cattiva, miglioramento, peggioramento, successo, insuccesso, necessità, scelta – sono caricate dei significati propri alla medicina nella sua
forma enunciativa.
Ma questi significati, pur così importanti anche per la persona ammalata, possono «in certe
situazioni che l’uomo vive (...) non avere forza
né valore» ( 5 ) rispetto a ciò, che lo stato della
vita porta la persona a considerare come sua
possibile salute, suo stare bene o stare meglio,
sua necessità o scelta.
Il medico può farsi mediatore tra i due orizzonti, perché è a casa sua nei significati della
scienza; ma per farlo deve accettare che la relazione parli due lingue, non una sola; e che la
sua competenza gli dia, di fronte alla persona
scientificamente incompetente, non la potestà
di scegliere, che non ha, ma il compito di ascoltarla nella lingua dell’esperienza per tradurne i
propositi nella lingua della scienza e riproporli
al malato.
Se la comunicazione è assorbita nell’enunciazione, se la lingua della relazione è quella
della medicina, allora il paziente, anche quando chiede, ascolta, risponde, porta in sé nascosta una condizione di ammutolimento. Ciò che
gli preme, su cui si orienta, l’orizzonte in cui
cerca di conservare la sua serenità e la sua capacità di affrontare il male, infine il suo interiore consenso o dissenso, in una parola la malattia come esperienza, resta in una zona morta alla comunicazione.
Ecco perché «parole tra noi così diverse».
Questa subordinazione, questo ammutolimento, è il dolore aggiunto alla malattia; alla
sofferenza di essere malato si aggiunge quella
di essere «paziente».
Peter Noll, grande amico di Max Frisch,
racconta gli ultimi diciotto mesi della sua vita dopo che ha deciso di rifiutare ogni terapia per un cancro. E a metà dice: «(...) Sono
malato (...) sono mortalmente malato, ma so-
( 5 ) Ibidem.
145
Letture e Opinioni
no riuscito a non diventare un paziente» ( 6 ).
Cosa ha evitato, cosa mai ha guadagnato?
Una cosa sola, restare padrone di sé.
Cito ancora Maria Zambrano: «La cosa più
umiliante per un essere umano è sentirsi portato, trascinato come se gli si concedesse a malapena un’opzione e gli fosse a stento possibile
scegliere, senza poter prendere alcuna decisione perché qualcun altro, che non si prende la
briga di consultarlo, la sta già prendendo al suo
posto» ( 7 ).
Anche nella storia di Peter Noll c’è un paradosso: è riuscito a morire senza diventare un
paziente, perché un medico amico carissimo lo
ha aiutato a vivere da malato.
I medici sanno cosa vive chi è «paziente»? O
piuttosto, quanti medici lo sanno?
Un medico (Sergio Livigni, Primario di terapia intensiva dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino) scrive a commento del libro di
Fontanella: «Noi che pensiamo di sapere ci accorgiamo che in realtà non sappiamo nulla. (...)
Bisogna volere ascoltare (...) Nell’esercizio della professione medica quello che solitamente
manca è l’ascolto» ( 8 ).
Una tipica esperienza di questi decenni conferma questo non sapere: è l’esperienza del medico che si ammala e si ritrova «paziente». Lo
scambio di parti pare essere sempre una sorta di
choc emotivo: il medico scopre come ci si sente
nel luogo del paziente. Forse non scopre interamente la soggezione, perché è trattato da collega,
e partecipa di una circolarità della comunicazione e della decisione altrimenti limitata o preclusa. Ma accade talvolta che la terapia proposta
con scientifica conoscenza e coscienza dai suoi
colleghi lo conduca verso una condizione che
confligge duramente con tutto ciò a cui la sua
concezione di sé e della vita lo prepara, e che richiede. Vedere l’altra metà della relazione è tanto sconvolgente o rivelatore, che il medico ci scrive un libro ( 9 ), o che qualcuno ci fa un film.
Questa esperienza, di vedere finalmente ciò
che non si vedeva quando era sempre davanti
( 6 ) Frisch, Sul morire e la morte, trad. it., Mondadori, 1984.
( 7 ) Zambrano, op. cit., 81.
( 8 ) Fontanella, op. cit., 133.
( 9 ) Uno fra i molti: Bartoccioni-Buonadonna-Sartori, Dall’altra parte, Rizzoli, 2006.
146
agli occhi, si chiama «risveglio». Ma sono illuminazioni che non sembrano avere un effetto
diffusivo, cambiano una persona ma non una
cultura e un costume.
C’è un’altra cosa che i medici sembrano non
sapere: quanto la comunicazione diseguale sia
insidiosa.
Il paziente, nella gran parte dei casi, non è
Peter Noll; accetta di essere paziente e molto
paziente. Acconsente volentieri alla subordinazione, anzi la cerca, la chiede.
Il paziente ammira le enunciazioni della
scienza, come formule sacre. Accetta istintivamente la relazione gerarchica, vi si aggrappa
volentieri. Venera i grandi medici, l’inarrivabile Primario che gli fa visita è accolto come un
tempo il Vescovo. Il paziente medio non chiede che di affidare al medico la propria sorte, e
vive il problema del consenso come una pratica
burocratica. Non vuole essere più che tanto informato, non fa valere più che tanto proprie
convinzioni e preferenze.
I medici spesso prediligono questo paziente
fanciullo, rinfanciullito, che si consegna. Non vedono o sottovalutano l’insidia della dis-eguaglianza: perché quando l’esperienza reale resta
fuori della zona comunicativa, rimane là, non
detta; e se gli esiti non sono fortunati, le stesse
persone che si sono acquietate accettando o cercando l’autorità medica non esiteranno a rovesciare sul medico la loro delusione, anche aggredendolo in giudizio, non solo per errore tecnico,
ma perché «scopriranno» di non essere stati consenzienti. La dis-eguaglianza non è, come certi
medici pensano, un rapporto realmente accettato – l’intera cultura del presente va in altra direzione; né una base sana e sicura di relazione.
L’insidia di questa convivenza ambigua e
sofferta tra rapporto dis-eguale e pratica del
«consenso informato», se esplorata, assume
molteplici aspetti. E di uno, fondamentale,
vorrei fare un cenno, perché non mi è mai capitato di vederlo esplicitato.
Inserire la richiesta e la prassi del «consenso
informato» in un rapporto di comunicazione
dis-eguale non è soltanto una dissonanza comunicativa e psicologica, ma è un errore logico
che produce effetti relazionali e cognitivi distorti e che rende praticamente impossibile
trovare soluzioni adeguate in termini di equilibrio ed efficacia ai problemi di gestione dei
NGCC 2012 - Parte seconda
Per una ecologia del rapporto terapeutico
conflitti. Come ben dimostra l’analisi linguistica di Fontanella, l’insieme dei messaggi nella
lingua della diseguaglianza diviene un potente
metamessaggio sul contesto, che lo qualifica
come un contesto di subordinazione: proporre
e richiedere al «paziente», in un tale contesto,
un atto di consenso è un esempio, credo perfetto, di quel «doppio vincolo» che Bateson
considerava la chiave della schizofrenia, e soprattutto un esempio di quell’errore che attiene alla «confusione di tipi logici» ( 10 ): regolare
isolatamente uno dei messaggi – quello del
consenso – senza incidere sul contesto, senza
ricodificarlo nel suo insieme includendo la
«competenza» del malato e creando le condizioni di una circolarità di comunicazione e decisione, significa perseguire un obiettivo logicamente sfalsato, monco e contraddittorio.
3. I ritardi della medicina. L’idea che il
medico sia investito dell’autorità di dettare il
bene e la via per raggiungerlo ha origine, credo, nella nascita stessa della medicina.
La modellizzazione è l’attitudine dominante
del pensiero greco ( 11 ). È nelle vene della medicina, fin dall’antico, il pensare alla salute come a un modello, che contiene una verità valida anche per il paziente.
Nel grande paradigma ippocratico, che connota la medicina fino alla modernità e oltre, il
bene del malato è cercato in una verità: scopo
comune di medico e paziente è quello di recuperare un ordine del microcosmo vitale iscritto
nell’ordine dato del macrocosmo. Il riferimento a questa verità benefica condivisa da medico
e paziente poteva rendere superfluo, perché in
re ipsa, il consenso del malato.
La medicina di oggi infrange i limiti «naturali» del suo intervento, si apre a scelte non riferibili a un «ripristino» di un ordine dato e necessario, a scelte opinabili, spesso di dubbio
valore vitale: in questo nuovo spazio la scienza
può prevedere, descrivere, offrire, proporre,
non può dettare il bene, non dispone di una
lingua certa rispetto all’esperienza.
( 10 ) Bateson, Mente e Natura, cit., rist. 2008,
155 ss.
( 11 ) Jullien, Pensare l’efficacia in Cina e in Occidente, Laterza, 2008, passim.
NGCC 2012 - Parte seconda
Anzi: la stessa analisi della scienza ci avverte
non solo dei suoi margini di incertezza, ma della inerzia insidiosa di questa macchina potente
che si autoalimenta, che si autoprefigge, per i
suoi stessi meccanismi interni, obiettivi sempre
più avanzati.
L’opinabilità del «bene» enunciato dalla
scienza non si manifesterà nelle situazioni banali o ordinarie, neppure in quelle ardue ma
certamente connotate da necessità e beneficità
attesa. Ma molte, proposte mediche impegnative, in questo nuovo orizzonte, sono più che
mai opinabili alla luce di una concezione di bene che esige l’accordo del paziente. Siamo lontani dalla sintonia ippocratica, e siamo in un
punto in cui è messa a dura prova l’idea troppo
facilmente enunciata della «alleanza terapeutica»: c’è un problema serio di accordo tra l’integrità professionale del medico e la concezione che il paziente ha della propria integrità.
Nel momento in cui non siamo più certi di
trovare il nostro bene nei «beni» conseguibili
dalla medicina, dobbiamo rivedere i passi del
rapporto tra medico e paziente per garantire a
ogni persona malata di dire il suo proprio bene,
garantendo al medico il rispetto della sua identità professionale e della sua coscienza.
Più che mai è necessaria una medicina capace di mediazione tra scienza ed esperienza, che
implica come necessità, oltre che come dovere
etico e giuridico, il rispetto dell’autodeterminazione del malato tanto quanto dell’integrità
professionale del medico.
In realtà, questo modo di vedere non è in
contrasto con la tradizione medica, anzi, ne valorizza la parte migliore. La medicina è una
scienza che ha sempre conservato una attitudine sperimentale nel senso di attenzione alla
concretezza empirica del caso. La medicina cura la malattia nel malato. Il caso clinico non
oscura il modello, ma lo include. In questa attitudine c’è il principio di un ascolto attento
della persona malata, fino a integrare il significato di salute e cura come modello e di salute e
cura come esperienza.
Eppure, i medici si mostrano insofferenti
verso le nuove posizioni dell’etica medica e del
diritto. Criticano aspramente la definizione di
salute dell’OMS, con il suo tentativo di integrazione delle dimensioni interiori della persona. L’accoglienza quasi testuale nei Codici
147
Letture e Opinioni
deontologici viene sentita come un ossequio
formale o ideale, una impraticabile utopia. La
tendenza delle Corti ad affermare che la beneficità «secondo scienza» di una terapia non basta a giustificarla, e che il consenso del paziente
deve essere effettivo e non formale, fondato su
informazione reale, adeguata, verificata, è stata
attivamente e direi accanitamente contrastata.
Le vicende giudiziarie portano i segni di una
guerra di trincea, in cui la lenta avanzata del
principio dell’autodeterminazione, è interrotta
da fiammate di ritorno alla rassicurante idea
che la terapia si autogiustifica: dunque alla potestà eliminata dai codici deontologici.
Nessuno sottovaluta le difficoltà di adeguare
la prassi, e in particolare quella ospedaliera, ai
principi affermati da moralisti e giuristi. Ma
credo che altrettanto realistico sia segnalare il
rischio di ritardo culturale della medicina.
I medici dovrebbero ritrovare, in termini
nuovi, il loro ruolo antico di mediatori tra
scienza ed esperienza: conoscere le parole della
scienza e capire le parole dell’esperienza dette
dall’altro parlante, la persona malata.
Ma questo non è solo un dono attitudinale,
che non a tutti è dato, ma è anche un tema di
preparazione e di apprendistato. Perché si continua, oggi, a sfornare medici che in dieci anni
di preparazione non hanno dedicato due settimane al problema di cosa significhi avvicinare
una persona in difficoltà? Da quale presunzione deriva l’idea che l’investitura scientifica o la
prassi in sé facciano sapere al medico come si
tratta un malato? Farsi le ossa in corsia non significa di per sé sviluppare le ossa giuste. Perché si rimane fermi a quelle massime di falsa
saggezza, che il medico deve farsi il pelo sullo
stomaco per non venire travolto dal contatto
con la sofferenza? Perché non si valutano le attitudini di chi fa il medico anche sul versante
della relazione? Perché un ufficiale degli alpini
deve avere attitudine al comando, e un medico
non deve avere attitudine alla comprensione?
Più oggettivamente, se il tempo in ospedale è
così tiranno, perché non si valutano e non si affrontano le ragioni di questa tirannia, sceverando anzitutto le complicità mediche alla riduzione dei tempi di assistenza pubblica?
4. I ritardi del diritto. Ma è tempo di
guardare anche al diritto e ai suoi ritardi. Si di148
ceva che il medico deve essere mediatore tra
scienza ed esperienza nella singola relazione.
Ma al diritto spetta di propiziare questa mediazione con regole che la preparino e che la garantiscano.
Una volta il diritto rimetteva alla scienza il
criterio di bene e di verità. Lo deve certamente
fare per quanto riguarda alcune definizioni di
stati biologici, di strumenti terapeutici; anche
se per molti aspetti ormai si profila una co-produzione medico-giuridica, ad esempio per la
definizione di morte, o per la validità delle sperimentazioni scientifiche.
Ma quanto alle parole chiave della relazione
terapeutica, salute, terapia, consenso, spetta al
diritto di garantire la mediazione, di regolare e
assicurare l’interazione tra il bene della scienza
e il bene dell’esperienza, tra l’integrità della
professione medica e l’integrità della persona e
della sua libertà.
Il diritto ha il compito di garantire con i propri
significati l’integrazione tra i significati della medicina e i significati dell’esistenza individuale.
Al centro di questo compito sta il problema
del consenso. Ma anche «consenso» è una parola che richiede mediazione, questa volta tra diritto ed esperienza, tra diritto e realtà vitale.
Non possiamo più permetterci di proporre e
imporre alla relazione medico-paziente un’idea
di consenso e dei modelli applicativi assolutamente inadeguati al terreno, gravidi di effetti
perversi. Il diritto che trasferisce in sala operatoria – o nel corridoio – le forme che valgono
per un contratto bancario fa piangere.
Come può, un diritto pensante, accettare che
a una persona ricoverata per peritonite, mentre
entra in sala operatoria in preda a un dolore
che non riesce a sopportare, sia richiesto della
firma di un modulo di consenso? E come può
sostenere che quello sia un atto di autodeterminazione valido ed efficace, e che questo modello sia un accettabile e ragionevole modo di
regolare la questione del consenso?
Davvero pensiamo che i criteri con cui si dà
per acquisita l’informazione di chi acquista una
Sim card siano estensibili alla informazione su
quanto ci sarà fatto nel corpo, e ai relativi rischi e probabilistiche previsioni?
Cosa ci induce a pensare che i vecchi paradigmi siano praticabili, affidabili in un contesto ad essi totalmente estraneo?
NGCC 2012 - Parte seconda
Per una ecologia del rapporto terapeutico
Una raccolta di saggi di Simone Weil, segnati dalla sua severa e particolarissima spiritualità, ma che i giuristi dovrebbero rileggere, si intitola «Il diritto è estraneo al bene. Lo scandaloso pensiero di Simone Weil» ( 12 ): estraneo in ultima analisi perché, secondo S. Weil, inesorabilmente legato alla forza, che traduce in potere, cioè in rapporti di forza giuridicamente
stabiliti. Io non credo a questa condanna, ma
prendo molto sul serio l’ammonimento. Se non
rinnoviamo i nostri strumenti, saremo solo capaci di stabilire fragili rapporti di forza tra medico e persona malata; e avremo tradito il nostro ruolo di giuristi.
Occorre ritrovare il legame tra soluzioni giuridiche ed esigenze etiche e umane specifiche
al rapporto tra medico e paziente. Non si tratta
di adattare, di ritoccare; si tratta di ricostruire i
tessuti vitali dell’esperienza attorno agli schemi
che la tradizione ci consegna.
Il consenso che eticamente è richiesto al medico di costruire con il paziente – non di acquisire
confezionato – è molto di più del consenso giuridico; ma il consenso giuridicamente inteso deve
essere molto di più che l’atto formale, e più dell’atto di manifestazione di una volontà secondo
lo schema del negozio; lo schema dell’atto giuridico va incluso ma trasceso, integrato in una regolazione della costruzione e gestione del consenso.
Io non ho certo in mente qui e ora tutte le linee di un nuovo paradigma; ma penso ad alcuni vettori, che obbediscano a un principio operativo: quello di incidere non sull’aspetto del
consenso in sé considerato, ma sul rapporto terapeutico nel suo insieme; non su uno dei messaggi, ma sul contesto che va ri-codificato. Nelle relazioni esiste un apprendimento del contesto ( 13 ), e l’obiettivo di un insieme di prescrizioni dirette a indirizzare una relazione verso
alcuni criteri fondamentali deve essere quello
di favorire un certo vettore di apprendimento,
che nel nostro caso deve essere quello del riconoscimento reciproco delle «competenze» e
della accentuata circolarità, condizioni e insieme fattori di rispetto delle prerogative giuridiche del medico e della persona curata.
( 12 ) Il libro, di M. Papini, è pubblicato da Cittadella, 2009.
( 13 ) Bateson, Mente e natura, cit., 181.
NGCC 2012 - Parte seconda
Elenco sinteticamente alcuni punti.
1. Consenso deve significare giuridicamente
il risultato di un processo di cui si garantisce
per via normativa l’effettività, che significa le
condizioni reali, l’accadimento lungo il tempo,
che si contorna di garanzie e soluzioni alternative per ogni caso di difficoltà o di impossibilità di formazione.
Informazione deve significare una comprovata acquisizione di conoscenza, che va non solo regolata ma verificata.
Di consenso e informazione, dunque, il diritto deve occuparsi, integrando la relazione bilaterale con la disciplina della gestione dell’organizzazione ospedaliera in modo da consentire la
maturazione del consenso in un contesto adeguato (cfr. la disciplina del consenso alla sperimentazione, secondo le direttive europee, peraltro insufficiente).
2. Là dove lo schema della consensualità diviene comunque impraticabile, si deve valorizzare con propri strumenti il criterio, concorrente
e suppletivo, del rispetto assoluto verso l’identità
della persona, intesa come convinzioni, concezione di vita, preferenze comunque manifestate: è più facile per un paziente fare una dichiarazione di identità, che dice in modo semplice
qual è il suo criterio di bene e di vita, che non
una disposizione anticipata di trattamento.
3. La mediazione tra previsioni e circostanze
reali va assicurata, valorizzando il ruolo del fiduciario anche sulla base di un affidamento spontaneo del malato; e occorre farlo anche al di là degli schemi tradizionali della rappresentanza.
4. Il vincolo del medico al rispetto delle volontà, delle preferenze, della identità del malato, in una parola all’integrità della persona,
non va costruito avendo in mente solo lo schema dell’obbligo di puntuale adempimento, che
è spesso – non sempre – improprio e insensato
nell’ambito delle situazioni terapeutiche, e non
va lasciato alla formula vaga e ipocrita del «tener conto» che crea solo incertezza e discussione. La via è ancora quella della mediazione tra
disposizioni, indicazioni e desideri del paziente e
circostanze concrete, affidata all’intesa tra medico e paziente o medico e protettore (cfr. la disciplina tedesca sulle disposizioni del paziente
nel § 1901 a BGB, Patientenverfügung).
5. Menziono appena altri punti critici che
vanno assolutamente riveduti, come l’infernale
149
Letture e Opinioni
meccanismo che parte dallo stato di necessità,
costruito senza riguardo a un bilancio di costi e
benefici, e arriva alla tagliola della equiparazione, epistemologicamente fallace, tra interruzione delle cure e atto commissivo.
Ci vuole creatività e concretezza, collaborazione ideativa tra competenza sanitaria e diritto; occorre integrare la disciplina civilistica e penalistica con norme di organizzazione. Può essere che
si debba individuare in ogni reparto un responsabile della consensualità a cui il malato o i familiari possano rivolgersi. Può essere che si debbano videoregistrare i colloqui. Quel che conta è
proporsi di realizzare una effettività delle regole,
costruendole in modo praticabile e incisivo.
Occorre fare una rivoluzione che rimetta in
sintonia etica, medicina, diritto per la più piena umanità della relazione terapeutica. Occorre evitare di essere tutti, medici compresi, soggetti a una sola potestà, quella della tecnologia
autoreferenziale: quella che crea trappole, come la sopravvivenza assistita – ma molte altre
se ne potrebbero elencare – di cui sono egualmente prigionieri medico e malato.
La rivoluzione, si è detto ( 14 ), dovrebbe esse-
re fatta d’intesa tra due figure: il malato esperto e il medico ammalato. Ne aggiungo una, di
servizio: il giurista paziente, in tutti i sensi, purché sappia e voglia costruire un diritto che conosce, vede e avvalora la sostanza vitale della
relazione.
Offrire schemi giuridici presi dallo scaffale
della dogmatica per regolare la situazione di
sofferenza è dare sassi come se fossero pane;
significa mantenere il diritto, come sempre
più spesso tristemente avviene, «lontano dal
bene».
( 14 ) L. Guarneri, La cosa più stupefacente al mondo. Avventure di un malato esperto, Anima, 2004.
150
NGCC 2012 - Parte seconda