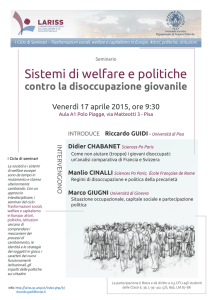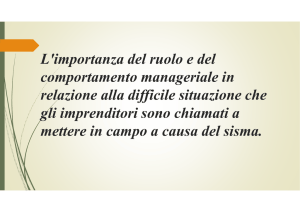Indice
Presentazione (di Vincenzo Cesareo)
9
Introduzione
Modernizzare il welfare state
15
Capitolo primo
La sfida dell’individualizzazione
31
Nella «società a progetto», alla ricerca di nuove connessioni
Biografie autoriflessive tra autodeterminazione e incertezza
Vulnerabilità diffusa, corsi di vita, disuguaglianze
Capitolo secondo
Welfare state attivo, welfare state attivante
53
L’active welfare state
L’imperativo dell’occupazione nel discorso istituzionale europeo
Pluralizzazione, destandardizzazione e personalizzazione delle politiche
Capitolo terzo
Partecipazione, capacità, capitale umano
79
Oltre la visione ortodossa dell’attivazione
Activation policies abilitanti, orientate all’empowerment
Lifelong learning e cittadinanza attiva
Capitolo quarto
Modelli «classici» di welfare attivo
Il volto inclusivo del workfare britannico
L’apertura workfarista del learnfare danese
La convergenza (im)possibile
103
Capitolo quinto
Modelli emergenti?
131
La frattura tra insider e outsider nell’Insertionfare francese
Il paradosso italiano: un modello, nessun modello
I primi passi dell’attivazione
Un sistema di apprendimento in formazione continua
Piste di innovazione e fattori di inerzia
Conclusioni
Un welfare delle capacità e delle eque opportunità
di apprendimento continuo
163
Su potenzialità e limiti del lifelong learning
Ricalibrare il learnfare
Bibliografia
183
Presentazione
9
Presentazione
Nella società e nell’economia della conoscenza — sostiene l’Unione
Europea — lo sviluppo del capitale umano e l’apprendimento permanente
costituiscono presupposto per l’accesso all’occupazione, la realizzazione
personale, l’inclusione sociale e l’esercizio dei propri diritti. Al punto che
le key competences per il lifelong learning identificate proprio in sede europea
(imparare a imparare, capacità di comunicazione nella madrelingua e nelle
lingue straniere, competenza matematica e competenze di base nelle scienze
e nelle tecnologie, competenza digitale, competenze sociali e civiche, spirito
di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale
e interculturale) sono al tempo stesso considerate come competenze di
cittadinanza. Una cittadinanza «attiva», che fa leva sul protagonismo del
soggetto nella costruzione di una società del benessere, coesa e giusta, e
che per questo promuove la partecipazione responsabile e autonoma alla
vita sociale, economica e democratica. Il lavoro è l’ambito per eccellenza
di contribuzione al bene comune, di integrazione e inclusione sociale, di
realizzazione di sé e di protezione contro la povertà, l’emarginazione, la
dipendenza dal welfare.
In questo scenario, l’apprendimento che si compie lungo l’arco della
vita (lifelong), in qualunque contesto esperienziale (lifewide) e secondo
modalità diversamente strutturate e istituzionalizzate (formal, not formal,
informal), viene assunto a pilastro di un nuovo modello di welfare — anch’es­
so attivo — teso a promuovere nei cittadini la capacità di autoprotezione
10
Welfare attivo
dai rischi sociali, un welfare che trova proprio nell’occupazione la migliore
forma di tutela individuale e la leva per l’uscita dalla eventuale condizione
di bisogno.
Formare, riqualificare, aggiornare le competenze divengono i punti
di forza di nuove politiche occupazionali, non per caso definite activations
policies, che intrecciandosi con le politiche sociali mirano ad almeno due
finalità considerate interdipendenti: migliorare l’impiegabilità degli individui
e la loro (ri)collocazione dentro un mercato del lavoro incerto, mobile, in
continua evoluzione; scongiurare il rischio che essi rimangano intrappolati
nella disoccupazione, nell’inattività, nell’assistenzialismo o in lavori instabili,
poco remunerati, mal tutelati, di scarsa qualità. Tali politiche si traducono
anzitutto nei programmi di welfare to work, rivolti a sostenere i soggetti nel
passaggio dalla percezione passiva di una indennità al reinserimento lavorativo
(pur se in un impiego sussidiato o temporaneo), con l’obiettivo di restitui­
re loro la possibilità di guadagnarsi il proprio reddito e di rientrare nella
schiera degli attivi, nel rispetto della «condizionalità»: accettare la proposta
di formazione o lavoro, pena l’esclusione dagli schemi di protezione.
La rilevanza assegnata al capitale umano e all’apprendimento perma­
nente si salda così con la necessità di riforma del welfare state, il quale nella
sua configurazione keynesiano-fordista si è da tempo mostrato incapace di
rispondere ai bisogni di protezione sociale che sorgono nella società contem­
poranea. Flessibilizzazione e femminilizzazione del lavoro, invecchiamento
della popolazione, pluralizzazione dei modelli familiari e indebolimento
dei legami sociali e delle istituzioni, individualizzazione delle carriere di
vita, diffusione di istanze di autorealizzazione da un lato fanno lievitare la
domanda per i servizi di cura (in particolare per bambini, malati e anziani)
e per i servizi di formazione e accompagnamento lungo le transizioni nel
mercato del lavoro, dall’altro lato richiedono soluzioni personalizzate e
flessibili, capacità di adattamento ai corsi di vita, spazi di negoziazione e
autonomia per i beneficiari. A queste nuove esigenze cerca di rispondere il
welfare state attivo per come è stato definito a livello europeo.
Il linguaggio e i principi di fondo di questo modo di intendere le
finalità dello stato sociale, il ruolo dei cittadini e delle formazioni sociali, il
lavoro e la cittadinanza sono penetrati in modo capillare nel dibatto politico
dei Paesi europei, come dimostra emblematicamente anche il caso italiano,
ma sappiamo che l’uniformità concettuale, per quanto condizionante, non
Presentazione
11
produce necessariamente uniformità di risposte. Se è vero che la definizio­
ne della situazione è capace di costruire realtà, è anche vero che proprio il
persistere di uno spazio aperto di definizione (che in materia di welfare gli
stati nazionali conservano, nonostante l’accrescimento dei poteri da parte
degli organismi sovranazionali e dei territori locali) apre a scenari diversificati
nel passaggio dal disegno alle soluzioni istituzionali.
Rosangela Lodigiani con questo libro ci invita a osservare più da vicino
la varietà dei tipi di welfare attivo effettivamente implementati in Europa,
portando allo scoperto quanto gli orientamenti comunitari abbiano sì inne­
scato processi di convergenza e isomorfismo, ma trovino fattori di resilienza
nelle caratteristiche socio-economiche, politico-istituzionali e culturali dei
singoli contesti, rivelando come lo stesso welfare attivo, assunto a idealtipo,
debba poi inscriversi in un quadro di coerenze societarie per concretizzarsi in
modo efficace. Né potrebbe essere diversamente nella misura in cui discutere
di welfare significa riflettere sul tipo di modello di sviluppo a cui si vuole
dare forma; metterne a nudo finalità e presupposti valoriali e normativi;
esplicitare la visione del rapporto tra cittadino e Stato, tra bene individuale
e bene comune, tra responsabilità individuale e responsabilità collettive. Di
qui, l’interesse per l’approfondimento proposto dei casi italiano, francese,
britannico e danese, i quali ci mostrano come, pur a partire da presupposti
condivisi, promuovere il welfare e attivare le persone possano assumere
significati e piste di attuazione diverse.
Rosangela Lodigiani ci conduce però a un passo ulteriore. Ci spinge a
entrare dentro al paradigma dominante dell’attivazione, dell’apprendimento
permanente e della società della conoscenza per evidenziarne i lati nascosti,
i paradossi di cui occorre essere avvertiti al fine di evitare effetti perversi,
imprevisti.
Basti pensare alle ambivalenze legate all’imperativo dell’occupazione
nei programmi di welfare to work, massima espressione del welfare attivo:
la presenza di vincoli più o meno stringenti all’accettazione delle proposte
formative e di lavoro inserite in tali programmi delimita la possibilità di voice
dei beneficiari e la loro possibilità di partecipare fattivamente alla definizione
di percorsi autonomi di reinserimento. Inoltre non tutto il lavoro è buona
occupazione, capace di creare inclusione, riconoscimento sociale, stima di
sé; né del resto tutto il lavoro si esaurisce nell’impiego retribuito: dunque
altre forme di lavoro (da quello domestico a quello volontario di impegno
12
Welfare attivo
civile) potrebbero utilmente essere valorizzate come segno di attivazione,
con elevate valenze di inclusione sociale, dentro quella che diversi autori
definiscono una società pluri-attiva.
Si pensi anche alle contraddizioni che indeboliscono la valenza dell’ap­
prendimento permanente come diritto di cittadinanza, la sua possibilità
di configurarsi come fattore di protezione rispetto alla discontinuità occu­
pazionale, la marginalizzazione, l’intrappolamento in situazioni di disagio
lavorativo e sociale. Un esempio valga per tutti. Quanto più l’accesso alla
conoscenza diventa una risorsa capace di discriminare rispetto al lavoro e
perfino alla partecipazione attiva alla società, tanto più tale accesso divie­
ne un fattore di stratificazione. Esso finisce col penalizzare le fasce della
popolazione più deboli, meno dotate di capitale umano, più difficilmente
intercettate da proposte di recupero e di sviluppo di nuove competenze
lungo l’arco della vita, rischiando proprio di fallire laddove più vorrebbe
incidere: cancellare le disuguaglianze.
Viene in evidenza così che l’apprendimento in età adulta è funzione
di quello in età scolare e perfino pre-scolare; che la garanzia di sistemi equi
di accesso è condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione delle
opportunità di apprendimento; che accanto al sistema dei diritti formali
vanno sviluppate le capacità (capabilities) di sfruttarli a proprio vantaggio.
E la capacità di apprendimento permanente è una di queste. Una capacità
cruciale, ci ricorda l’autrice, se e per quanto consente alle persone di svilup­
pare spirito critico, riflessività, e le sostiene nel comprendere e padroneggiare
la realtà circostante, così che possano mettere in campo scelte libere e al
tempo stesso responsabili, che abbiano significato per la loro realizzazione
personale.
La riflessione di Rosangela Lodigiani non è dunque finalizzata a mi­
sconoscere i potenziali insiti nel lifelong learning rispetto alle finalità di cui
si è detto, piuttosto si concentra sulle contraddizioni che esso possiede per
come si sta configurando (soprattutto in Italia) e suggerisce piste concrete
per una sua «ricalibratura». Ciò alla luce di quanto sta avvenendo nei sistemi
di welfare attivo, nei quali l’esigenza è sia di garantire l’equità delle posizioni
di partenza, sia di offrire opportunità per reintegrare lungo i corsi di vita
le risorse necessarie per proteggersi nelle fasi di vulnerabilità. Da questa
ricalibratura discende non solo la sostenibilità, ma anche la credibilità del
learnfare, immaginato come sistema di protezione integrativo a quello di
Presentazione
13
welfare to work. L’autrice ci aiuta nelle pagine che seguono a dare sostanza
a questa affermazione. È, questo, uno dei tanti meriti che riconosciamo a
questa opera e che si aggiunge alla sua capacità di affrontare in maniera
critica e mai ovvia un tema tanto attuale e complesso.
Vincenzo Cesareo
Professore ordinario di Sociologia
presso l’Università Cattolica di Milano
Partecipazione, capacità, capitale umano
79
Capitolo terzo
Partecipazione, capacità,
capitale umano
Oltre la visione ortodossa dell’attivazione
Di fronte alla diversità e alle disuguaglianze che caratterizzano le persone, assumere la responsabilità individuale a criterio normativo e valoriale
del nuovo welfare attivo appare quantomeno rischioso e ambivalente, determinando un sovraccarico e una ipervalutazione del soggetto sia in positivo
che in negativo: suoi sono i meriti, ma sue sono anche le colpe a fronte di
fallimenti che vengono interamente imputati alle carenze individuali e ai
demeriti personali, introducendo così una dimensione di valutazione morale che oscura le responsabilità collettive. È questo «individuo per difetto»
(Castel, 1995) il beneficiario privilegiato delle politiche di attivazione.
Seguendo tale impostazione, due concetti cardine di tali politiche,
occupabilità ed empowerment, tendono a essere interpretati solo a partire dal
soggetto, e non anche dalle condizioni (istituzionali anzitutto) necessarie per
il loro sviluppo. In entrambi i casi fa premio una lettura monodimensionale,
di impronta economicista ed efficientista, di cui sembra soffrire l’intero
impianto del modello sociale europeo (Crespo e Serrano Pascual, 2005). Il
giudizio ci pare — come afferma Barbier (2005) — eccessivo, e non tiene
conto della diversità dei modelli di attivazione di fatto emergenti nei contesti
nazionali. Quantomeno non appare più del tutto rispondente alla realtà, se
è vero che dopo la svolta neoliberista consumatasi negli ultimi venti anni
del secolo scorso in molti Paesi europei, oggi è in atto una convergenza
80
Welfare attivo
verso il paradigma dell’investimento sociale che — se pure non contraddice
molti dei precetti neoliberisti, a partire da quello della centralità del lavoro
per il mercato — mette in dubbio la capacità del mercato stesso di creare
occupazione sufficiente per tutti (Jenson, 2008). Tuttavia è un giudizio che
rileva il contestuale diffondersi degli assunti del workfare, apparentemente
del tutto in contrasto con il paradigma dell’investimento sociale, almeno
nella sua versione più inclusiva. Proviamo a entrare più nel dettaglio.
Pensiamo anzitutto all’occupabilità. A dispetto della lettura prevalente
che la intende come funzione delle caratteristiche personali e della responsabilità individuale nel migliorare le proprie capacità di inserimento lavorativo,
agendo, oltre che sul piano delle competenze, su quello dell’adattamento e
della flessibilità, essa dipende anche dalle reali opportunità che il mercato del
lavoro offre (Gazier, 2003), nonché dalle risorse che a livello istituzionale lo
Stato riesce a garantire e che non possono ridursi a iniziative che agiscano solo
sul fronte dell’offerta (Ferrera, 1998). Coerentemente con tale impostazione,
la disoccupazione finisce con l’essere interpretata essenzialmente come un
rischio individuale, determinato più dall’obsolescenza delle competenze
possedute, dalla scarsa capacità di adattamento, da una debole motivazione
al lavoro, che non da fattori di tipo strutturale — per esempio l’assenza di
opportunità di impiego di qualità sul piano delle mansioni, della tutela,
della retribuzione, come invece predicato dall’Unione Europea («to create
more and better job» è il motto della strategia di Lisbona).
Lo stesso accade con il concetto di empowerment dal quale dovrebbe
originarsi la capacità di partecipazione attiva. In genere rapportato alle
«mancanze» e alle lacune che andrebbero recuperate unicamente sul piano
personale (formazione, responsabilità, motivazione), ne resta misconosciuta
la natura multidimensionale, relazionale, che lega in modo inscindibile
individuo e struttura. Ne discende che la responsabilizzazione individuale
è interpretata in chiave colpevolizzante e va di pari passo con una sfiducia
di fondo nel soggetto, il quale per meritare l’inclusione nei programmi
di attivazione deve essere continuamente monitorato e incentivato anche
attraverso obblighi stringenti che ne sanzionino i comportamenti giudicati
scorretti. Paradossalmente, infatti, l’imperativo dell’attivazione attraverso
il lavoro e la condizionalità dell’accesso al welfare, mentre presuppongono
un individuo competente e responsabile, inducono a predisporre dispositivi
costrittivi e punitivi. Ne sono un esempio i già citati programmi di workfare,
Partecipazione, capacità, capitale umano
81
dove l’enfasi è posta sui requisiti lavorativi e altri obblighi come precondizioni per ricevere i sussidi, secondo un orientamento che risulta «punitivo e
esplicitamente disciplinante» (Hvinden, 2000, p. 58). Al punto che diversi
osservatori vi hanno intravisto una forma di «neopaternalismo» caricato di
moralismo, laddove si sostiene che le condizionalità siano poste nell’interesse
del soggetto (ibidem; Jepsen e Serrano Pascual, 2005; van Berkel, 2002). Si
definisce così quella che van Berkel (2002) chiama la visione «ortodossa»
dell’attivazione, incentrata su una sorta di «emancipazione forzata», dove è
l’individuo a doversi impegnare nel ricercare la propria autonomia (lavorativa). Lucida e cinica l’analisi di Solow (2001, p. 5):
la discussione si è basata finora sulla tacita convinzione che tutti i problemi
riguardino il mercato del lavoro dal lato dell’offerta; basta che i cani randagi
si comportino come cani da riporto, e la selvaggina comincerà ad abbondare.
Ma questo è un errore panglossiano. La quantità di posti di lavoro non è
una costante, ma non è neppure probabile che possa aumentare quanto
le offerte di lavoro.
La lettura monodimensionale di tali due concetti non è però l’unica possibile.
Questo semmai è l’esito della trasposizione del principio dell’attivazione dal
campo delle politiche sociali e del social work — dove è stato inizialmente
applicato — a quello delle politiche di (re)inserimento lavorativo (Geldof,
1999). Trasposizione che ha dato luogo a una vera e propria distorsione
di significato, al punto che non è più chiaro nemmeno se il lavoro ne è il
fine oppure il mezzo (Borghi, 2005). Infatti, nell’ambito del social work
l’attivazione è chiamata in causa a sostegno dei soggetti maggiormente svantaggiati, traducendosi in programmi nei quali il lavoro per il mercato è solo
una delle leve per la realizzazione di percorsi di emancipazione individuale,
esprimendo così uno stretto legame con la nozione di empowerment. Per
contro, nell’ambito delle politiche occupazionali, il lavoro remunerato (e
le azioni messe in campo per conseguirlo) risulta come criterio pressoché
esclusivo per la valutazione dell’attivazione.
Esistono tuttavia i margini per muoversi su un registro diverso, sia
enfatizzando l’integrazione tra politiche sociali, del lavoro e della formazione,
specie a livello locale, dove meglio si evidenzia la specificità territoriale dei
fenomeni di disagio ed esclusione e si palesa l’esigenza di interventi mirati,
capaci di agire su più fronti contemporaneamente, sia andando più a fondo
82
Welfare attivo
del concetto stesso di attivazione, per esplicitare i suoi diversi significati
e il suo nesso con l’idea di partecipazione e cittadinanza attiva, in sintesi
andando a ragionare su quale sia il suo obiettivo prioritario: l’occupazione
o l’inclusione nel senso più ampio del termine, ricordando che non si può
sostenere una equivalenza funzionale tra i due fenomeni.
Seguendo Bifulco (2005a), possiamo ritenere quello di attivazione un
«concetto ombrello», sotto il quale si ritrovano a coesistere finalità diverse,
pur se tutte accomunate da criteri di intervento finalizzati al supporto
dell’agency dei destinatari:
la partecipazione al lavoro, anche obbligata; la responsabilizzazione individuale rispetto al proprio benessere e a quello dei membri della propria famiglia, che si trovino in condizioni di dipendenza; la libertà di scelta in quanto
consumatori dei servizi di welfare; la partecipazione alle scelte pubbliche e
l’autorganizzazione delle comunità locali. (Bifulco, 2005a, p. 20)
Esso comprende dunque esperienze diverse in relazione agli ambiti
in cui si realizzano e al grado di empowerment che implicano. Proprio la
sua ampiezza semantica consente di evidenziare come anche nel settore
delle politiche del lavoro possa essere valorizzato il nesso originario tra
attivazione ed empowerment appena richiamato in riferimento al social
work. È un nesso che porta alla luce come il lavoro (retribuito) sia uno
dei possibili campi di realizzazione della cittadinanza attiva, forse il più
importante, ma non necessariamente l’unico, poiché tale tipo di cittadinanza — a seconda della fase del corso di vita attraversata — si può
esplicitare in contesti diversificati, senza per questo determinare il venir
meno del dovere (e vorremmo dire anche del diritto) di concorrere in
modo «produttivo» alla costruzione di una società del benessere per tutti,
inclusiva, coesa, capace di esprimere forme di solidarietà allargata. Ne
discende la possibilità di riconoscere la varietà delle «forme di lavoro» e
del tipo di risorse che queste ultime garantiscono in termini di inclusione:
forme ascrivibili alla nozione ampia di «condizione lavorativa» proposta
da Supiot (2003; si veda il capitolo precedente).
Se poi si allarga lo sguardo alle politiche sociali più in generale, l’attivazione può divenire anche sinonimo di partecipazione alla produzione del
welfare e di esercizio dei diritti politici, civili oltre che sociali, in tutti i casi
riconoscendo altre opportunità di inclusione, alternative alla partecipazione
Partecipazione, capacità, capitale umano
83
al mercato del lavoro. Prende forma in questo modo una visione «riflessiva»
dell’attivazione, che oltrepassa quella ortodossa, valorizzandone il carattere
multidimensionale e orientando i servizi a prendere sul serio l’expertise degli
utenti rispetto alla loro situazione (van Berkel, 2002). Ciò implica non solo
predisporre politiche riflessive nel senso classico del termine, cioè supportate
da un monitoraggio continuo e dalla valutazione degli interventi. Richiede
altresì di applicare la riflessività a tutto il processo di costruzione delle politiche stesse, compresa la definizione dei problemi da risolvere o dei mezzi
da sviluppare e mobilitare per risolverli. Presuppone infine di riconoscere
il protagonismo dei destinatari (ibidem; Luciano, 2002).
La propensione per l’una o l’altra visione — ortodossa e riflessiva —
muta a seconda del contesto territoriale, del regime di welfare dominante,
delle forme di regolazione del mercato del lavoro, della concezione del patto
di cittadinanza, delle finalità attribuite alle politiche sociali, del lavoro (attive e passive), formative e di lifelong learning, ecc., configurando modelli
di attivazione diversificati. Assumendo come linea direttrice per l’analisi
di tali modelli la relazione che intercorre tra activation policies, processi di
partecipazione (cittadinanza attiva), inclusione sociale, emancipazione, lo
stesso van Berkel (2002, p. 220, passim) elabora una tipologia di approcci
all’attivazione differenziandoli in base all’orientamento politico-istituzionale
dei policy makers e ai presupposti normativi a cui si ispira la loro azione.
L’autore distingue tra quattro tipi ideali, da intendersi come tipi puri in
senso weberiano, come modelli di riferimento:
1. gli ottimisti dell’indipendenza dal welfare, scettici rispetto all’intervento
dello Stato, giudicato non solo negativo ma da evitare, in quanto finisce
con l’inibire l’iniziativa privata delle persone e la loro cittadinanza attiva,
ponendole in una condizione di assoluta dipendenza dai meccanismi
di protezione passiva del reddito, riproducendo invece che eliminando
i fattori di esclusione: solo il mercato libero da interventi statali può
fornire ai soggetti le opportunità per realizzare al meglio l’inclusione nel
lavoro remunerato e ottenere un reddito sufficiente a soddisfare le proprie
esigenze di vita. Essi mostrano un atteggiamento negativo sia verso le
politiche attive del lavoro, sia verso quelle passive, nella misura in cui il
cittadino «completo» risulta essere solamente colui che riesce a ottenere
l’indipendenza attraverso il mercato (mercificazione) o la famiglia (familizzazione), ritenendo al contrario che i dispositivi di welfare disincentivino
84
Welfare attivo
i soggetti nella realizzazione della piena cittadinanza, al punto che il loro
ritiro si configura come fattore di incentivo per l’emancipazione;
2. gli ottimisti del paternalismo, secondo i quali lo Stato deve prescrivere
e implementare percorsi di integrazione per gli individui all’interno
del mercato del lavoro e della società più in generale, in quanto tali
percorsi promuovono l’emancipazione dei soggetti, limitando le situazioni di rischio e agendo sulla diminuzione della vulnerabilità di quanti
si trovano in difficoltà. Secondo tale approccio, l’insistenza sul tema
dell’attivazione degli individui è da ritenere nel loro stesso interesse,
in quanto prerogativa di emancipazione che lo Stato deve cercare di
favorire, al limite «forzare»: solo coloro che stanno compiendo gli sforzi
per conseguire le mete socialmente prescritte riceveranno sostegno
economico. Come quelli che appartengono alla tipologia precedente,
gli ottimisti del paternalismo definiscono l’inclusione attraverso la
partecipazione al mercato del lavoro, ma prevedono il sostegno dello
Stato laddove essa non si possa realizzare. Ne consegue un atteggiamento positivo sia verso le politiche attive sia verso quelle passive, queste
ultime in particolare viste come un meccanismo di incentivazione e di
ricompensa economica per gli sforzi compiuti dai soggetti nell’ottenere
l’inclusione attraverso il lavoro;
3. gli ottimisti dell’autonomia, che fanno affidamento sulle capacità e sulla
volontà dei soggetti di realizzare opportunità di inclusione e partecipazione
alla società attraverso la propria libera iniziativa. Lo Stato, per mettere
in grado le persone di agire autonomamente, deve «soltanto» fornire agli
individui i mezzi sufficienti per corrispondere alle loro necessità di base
— per esempio un reddito minimo incondizionato — nella convinzione
che, assicurando ai soggetti il soddisfacimento dei bisogni primari, li
si metterà nella condizione di utilizzare al meglio le proprie capacità,
producendo su di essi un effetto di attivazione. In questo modo possono
essere lasciati liberi di decidere come partecipare alla società, non solo
attraverso il lavoro remunerato, ma anche mediante altre tipologie di
lavoro non di mercato. Lo Stato non deve dunque prescrivere percorsi di
integrazione, ma al contrario sostenere i cittadini nelle loro aspirazioni
di inclusione attraverso un insieme di politiche passive, predisposte in
chiave di emancipazione. Scettica, generalmente, è la posizione verso le
politiche attive reputate a rischio di paternalismo;
Partecipazione, capacità, capitale umano
85
4. gli ottimisti dell’attivazione, che enfatizzano il desiderio delle persone di
partecipare e contribuire alla società attraverso diverse forme di lavoro: un
cittadino «completo» è proprio colui che è attivamente coinvolto in qualche genere di attività, anche non di mercato. Diversamente dagli ottimisti
dell’autonomia, con i quali peraltro condividono questa impostazione,
sono consapevoli del fatto che una parte dei soggetti destinatari delle
politiche per l’impiego non sono in possesso delle risorse necessarie per
essere inclusi nel mercato del lavoro, anche quando i loro bisogni economici siano soddisfatti. Da sé sola l’erogazione di un reddito di base
non è dunque sufficiente a garantire l’inclusione. Di qui la necessità di
intervento delle politiche sociali e in particolare delle politiche attive
lette in chiave di empowerment; è massima la rilevanza data alla ricerca
attiva e autonoma del lavoro da parte delle persone disoccupate, ma la
partecipazione non è ridotta alla sfera lavorativa.
I primi due tipi ideali — e segnatamente il secondo, di stampo (neo)
paternalistico — sono con tutta evidenza in linea con la visione ortodossa
all’attivazione, e sono i più diffusi a livello europeo. I secondi due tipi ideali
— e in misura massima il quarto — definiscono lo spazio dell’approccio
«riflessivo» che è nella realtà quasi tutto da costruire. Esso è incentrato su
politiche attive «abilitanti» (enabling) e «potenzianti» (empowering), orientate
a conferire ai soggetti le risorse per soddisfare i propri bisogni, ma anche a
riconoscere la loro autonomia e competenza nell’attivazione. Ciò capovolge
la prospettiva degli interventi e getta una luce nuova sull’operato dei servizi: i
diversi tipi di lavoro e di attività sono presi in considerazione per le risorse a
cui danno accesso in rapporto ai bisogni espressi dai soggetti, alle aspettative,
agli obiettivi sui quali misurano la loro realizzazione personale, senza dare
per scontato che l’occupazione remunerata sia sempre e comunque la mèta
preferibile. Due ne sono i presupposti: i cittadini destinatari delle politiche sono «attori competenti», consapevoli e capaci di autodeterminazione
nei percorsi di attivazione che li riguardano, o lo possono diventare con
gli adeguati strumenti di accompagnamento e sostegno abilitante; le loro
responsabilità sono negoziate in un contesto democratico. Ma entrambi i
presupposti esigono che essi siano anche forniti delle risorse (informazioni,
potere, opportunità di direzione, ma anche conoscenze e capacità autoriflessive) necessarie per partecipare alle pratiche stesse di negoziazione e sulle
reali opportunità che hanno di mobilitarle (ibidem).
86
Welfare attivo
In quest’ultima accezione più ampia possiamo affermare che l’attivazione sia un processo a conclusione aperta, poiché «la partecipazione può
assumere […] varie forme: quella del lavoro retribuito e non retribuito, quella
della partecipazione economica, culturale e/o sociale. Il punto di partenza
è che la persona è titolare di una partecipazione sociale che si conforma
all’identità e alla vita quotidiana della persona disoccupata, contribuisce
all’organizzazione della sua vita e può essere realizzata dall’individuo interessato, in modo realistico» (Valkenburg, 2005, p. 14).
Aprirsi a questa concezione ampia dell’attivazione non significa rigettare l’impostazione dell’active welfare state. Se si prendono alla lettera
i documenti europei si scopre che la partecipazione attiva è il requisito
costitutivo di una cittadinanza attiva, e che la sua declinazione è multisettoriale, non circoscritta al lavoro retribuito (Vandenbroucke, 1999; 2003).
Certo, il primo settore al quale solitamente si dà risalto è proprio quello
della partecipazione lavorativa, che si traduce nell’occupazione (retribuita o
sussidiata). Un secondo settore è quello della partecipazione politica e civile.
Esso riguarda, fra l’altro, la partecipazione alla produzione del welfare, che
può essere più o meno attiva, ed è passibile a sua volta di svilupparsi in più
direzioni. Due, almeno (Paci, 2005): 1. la costruzione della strategia di
emancipazione dalla condizione di bisogno, attraverso l’utilizzo di incentivi,
voucher, budget di spesa e altri dispositivi; essa si realizza per esempio nella
possibilità di co-partecipare all’elaborazione dell’intervento di formazione o
ricollocazione professionale attraverso gli strumenti della negoziazione, della
contrattualizzazione e del coinvolgimento diretto o indiretto nelle decisioni
circa i programmi sociali. Nei termini di Borghi e van Berkel (2007) tale
forma di partecipazione implica un coinvolgimento nel problem solving; 2.
la definizione delle politiche sociali (e del lavoro), nel rapporto sia diretto,
sia — soprattutto — indiretto, mediante le associazioni sociali, con l’attore
pubblico: potremmo dire che la partecipazione arriva a essere mobilitazione
della società civile e, restando ai termini di Borghi e van Berkel, implica un
coinvolgimento nel problem-setting.1 In questo secondo caso è l’intero regime
di welfare, e non solo lo stato sociale che, assumendo l’ottica della parteci Secondo i due autori (ibidem) vi è un altro livello minimale di partecipazione, sostanzialmente
passiva (passive participation), rispetto alla quale i cittadini non hanno potere, ma sono al massimo
coinvolti come informatori, anche se possono vantare la presenza di propri rappresentanti nelle sedi
istituzionali.
1
Partecipazione, capacità, capitale umano
87
pazione attiva, valorizza il ruolo di tutti gli attori in campo: il mercato e le
famiglie, il terzo settore, in un quadro di «welfare societario», «plurale» di cui
si è già detto (si veda il capitolo 2). Nei termini che stiamo qui utilizzando
tale sviluppo può essere visto come espressione di un sistema di welfare
attivo, incentrato sul protagonismo dei cittadini variamente organizzati tra
loro, nella definizione dei bisogni e nella elaborazione di risposte a essi. Non
si tratta certo di immaginare un sistema di delega crescente dallo Stato alla
società civile, anche perché l’azione di quest’ultima esige di essere regolata,
ma di riconoscerne la capacità innovativa e creativa nel tessere legami di
solidarietà allargata e nel trovare modalità efficaci di risposta soprattutto ai
bisogni di tipo relazionale (Magatti, 2005).
Ne discende una concezione di cittadino non limitata al suo essere
destinatario passivo di politiche (spesso coercitive), né al suo essere cliente
di servizi concorrenti sul mercato, bensì al suo giocarsi come partner delle
istituzioni, di varia natura, e attore protagonista nella costruzione della sua
capacità di essere attivo (Newman, 2007) sul triplice piano dell’occupabilità,
della definizione del percorso di uscita dalla condizione di bisogno; della
programmazione dei servizi. Si ristabilisce così il nesso tra attivazione ed
empowerment, partendo dall’assunto che autonomia sociale e partecipazione sono interdipendenti (Chicchi, 2005). Siamo pienamente nell’alveo
dell’active welfare state per come è stato disegnato a livello europeo. Il
problema è lo iato, la distanza che emerge tra le dichiarazioni di principio,
peraltro non prive di ambiguità e paradossi, e la loro attuazione sul piano
delle politiche.
Activation policies abilitanti, orientate all’empowerment
Il riconoscimento della partecipazione come dimensione centrale della
cittadinanza attiva è solo il primo passo perché quest’ultima possa esplicitarsi
in tutte le sue potenzialità. Se ci si ferma a livello teorico, infatti, non può
bastare. Così come indicare l’obiettivo della piena occupazione non può di
per sé assicurare in ordine alla scomparsa della disoccupazione e dell’inattività,
né la definizione di servizi di attivazione dà la certezza di un reinserimento
attivo ai beneficiari. In altri termini, una volta stabilite le mete socialmente
apprezzate, tutti devono poter fruire di mezzi e opportunità adeguate per
Modelli «classici» di welfare attivo
103
Capitolo quarto
Modelli «classici» di welfare attivo
Il volto inclusivo del workfare britannico
L’impianto neo-liberale e la svolta laburista
Emblema dell’approccio individualista e liberale del welfare (EspingAndersen, 1990; 2000), il Regno Unito è stato il Paese europeo sul quale
per primo ha attecchito è si è sviluppata la declinazione workfarista del
welfare to work sulla scorta dell’esempio statunitense. In linea con i principi
normativi che ne informano il sistema di protezione, il mercato è considerato il principale meccanismo di integrazione sociale. Lo Stato ricopre un
ruolo residuale, assumendo pochi rischi come collettivi e concentrandosi
su politiche selettive, prevalentemente di tipo assistenziale, riservate agli
individui fortemente svantaggiati che non raggiungono una soglia di reddito
considerata minima e non trovano nel mercato del lavoro le adeguate risorse
economiche per il proprio benessere, restando destinati così a ricadere in
una situazione di dipendenza dal welfare (superata la verifica dei mezzi).
L’occupazione rappresenta in tale scenario il più efficace sistema di protezione, non perché garanzia di accesso a forme di assicurazione sociale su base
corporativa (come ad esempio in Italia e in Francia; si veda il cap. 5), bensì
in quanto fonte di reddito e dunque garanzia di autonomia nel far fronte
ai propri bisogni e garanzia di capacità di acquisto (sul mercato) dei beni e
dei servizi di cui si necessita. Ne ricaviamo due implicazioni: anzitutto, la
mancata partecipazione al mercato del lavoro si rivela stigmatizzante, mentre
104
Welfare attivo
la disoccupazione non viene considerata come un fenomeno strutturale connesso al funzionamento del sistema economico, bensì esito di una scelta di
opportunità dei singoli che trovano vantaggiosa la condizione di dipendenza
dalle prestazioni assistenziali invece della ricerca di un impiego; in secondo
luogo, la risposta in termini di policy non è la solidarietà collettiva, ma il
condizionamento delle prestazioni sociali all’attivazione del soggetto e al
suo rapido reimpiego (ibidem).
Come sottolinea Ciarini (2008a), al quale ci riferiremo in questa
ricostruzione dell’esperienza britannica, nonostante l’approccio liberale
rimanga costitutivo del modello britannico, è pur vero che l’evoluzione del
sistema di welfare ha conosciuto fasi di rottura e cambiamento grazie alle
quali l’azione regolativa e redistributiva dello Stato si è andata ampliando
a discapito del laissez faire (Ciarini, 2008a).
Il riferimento va anzitutto al periodo di Governo laburista della metà
del secolo scorso, quando il sistema di protezione sociale conobbe una
rimodulazione in direzione dell’estensione dell’intervento dello Stato e
della promozione della copertura di base pubblica garantita alla fascia di
popolazione che si colloca al di sotto di una soglia standard di reddito. Tale
impostazione ha lasciato una traccia importante, anche se i successivi Governi
conservatori, soprattutto nel corso degli anni Ottanta, «ha[nno] riportato
il baricentro della regolazione del welfare e delle politiche del lavoro in
particolare verso un più stringente sistema di condizionalità, finalizzato alla
riduzione della spesa sociale e delle forme di indennizzazione passiva (erogate
cioè attraverso sussidi), che fin lì si erano sviluppate» (ibidem, p. 133). Una
traccia rimasta sotterranea, ma recuperata con il ritorno al Governo del
partito laburista a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, quando al
rafforzamento di alcuni dispositivi di taglio workfarista si affiancano riforme
che rivelano un volto più inclusivo, in specie con riferimento ai soggetti più
deboli, secondo una linea che è insieme di continuità e di discontinuità con
l’impianto neo-liberale dei precedenti Governi conservatori. Questi ultimi,
alle prese con le difficoltà derivanti da alcuni cambiamenti socio-economici
di natura strutturale — terziarizzazione, deindustrializzazione, espansione
dei servizi a bassa qualificazione, flessibilizzazione e segmentazione crescenti
del mercato del lavoro, accentuazione delle disuguaglianze di reddito, ecc.
— si trovano infatti in prima linea a dovere da un lato contenere una spesa
sociale in crescita, in specie per quanto concerne le politiche passive del
Modelli «classici» di welfare attivo
105
lavoro, e dall’altro a sostenere l’ingresso delle fasce più deboli e marginali
della popolazione attiva in un mercato del lavoro che offre opportunità di
impiego sempre più anche al di fuori dei tradizionali segmenti centrali, più
protetti e sicuri, meglio remunerati. Due — seguendo ancora l’autore — le
direttrici di riforma seguite. La prima, che si è tradotta nell’istituzione dei
dispostivi di in work benefit (nello specifico di natura fiscale, come gli sgravi
contributivi e i crediti di imposta), mirava a rendere preferibile il lavorare
rispetto alla fruizione passiva dei sussidi per i soggetti collocati in una posizione marginale del mercato del lavoro, in bilico tra l’inoccupazione e un
impiego a basso salario e bassa qualificazione. In altri termini essa mirava
a invertire il rapporto di convenienza esistente (dal punto di vista finanziario, almeno) tra la condizione di assistito e quella di occupato. La seconda
direttrice di riforma ha invece messo mano al sistema di indennità e tutele
per i lavoratori disoccupati. Nel 1986, a partire dal programma Restart di
riordino delle politiche del lavoro, l’intero impianto delle indennità viene
rivisto all’insegna di criteri di eleggibilità più stringenti, con condizioni più
selettive e vincolanti per l’accesso alle prestazioni.1 L’obiettivo era duplice:
anzitutto ridurre il numero dei claimants e quindi anche contrarre la spesa
pubblica; in secondo luogo esercitare una forma di controllo sociale rispetto
a un fenomeno (la mancata partecipazione al lavoro) socialmente etichettato
e per questo da contrastare con opportuni programmi di attivazione e strumenti di monitoraggio dei disoccupati per evitarne il rifugio opportunistico
in una situazione di passività, «vittime consapevoli» della cosiddetta trappola
dell’inattività. In linea con la visione più «pura» del workfare, le condizioni
poste per la fruizione dei sussidi arrivavano sino a costringere il soggetto in
cerca di impiego ad accettare una qualunque offerta di lavoro anche se al
di sotto delle precedenti qualifica e retribuzione, secondo l’imperativo del
work first, che ha reso famoso il modello. In ciò, facendo scivolare la logica
del welfare to work (sostenere i soggetti in carico al welfare nel passaggio
verso il lavoro) fino a quella del work for welfare (da cui appunto deriva il
termine workfare), che sottende uno «scambio» tra welfare e lavoro, come
avviene nei lavori sussidiati (Lodigiani, 2006). Sottovalutando — come è
Storicamente il Regno Unito è stato il primo Paese dell’Unione Europea ad avere introdotto, nel 1989,
un meccanismo sanzionatorio per il godimento di benefits e indennità e, nel 1991, l’obbligatorietà della
partecipazione dei disoccupati ai programmi di politica attiva del lavoro (Di Domenico, 2005).
1
106
Welfare attivo
stato bene illustrato (Giaccardi, 2001; Solow, 2001) — che la centralità
assegnata in questo modo alla dimensione macroeconomica e dei conti
pubblici porta a trascurare del tutto altre dimensioni rilevanti per la lotta
alla disoccupazione, che attengono al livello micro e sociale e che riguardano
la sfera personale, familiare, esistenziale dei disoccupati stessi.
In questo scenario, i governi del New Labor si sono a loro volta mossi
in due direzioni. La prima, che potremmo definire di carattere universale,
ha riguardato la lotta alla povertà e in specie al fenomeno dei working poors,
i quali — nonostante i dispositivi di in work benefits già in essere — rappresentavano una emergenza sociale, se è vero che l’eredità più importante
del Tatcherismo è il livello di ineguaglianza dei redditi e i suoi effetti in
termini di ridotta coesione sociale, impoverimento e criminalità (Rhodes,
2001). Le strategie messe in campo hanno riguardato diversi ambiti: 1.
l’innalzamento dei minimi salariali al fine di contrastare i rischi di un’altra
trappola, quella della povertà, in cui si trovano confinati i soggetti indotti
ad accettare lavori talmente mal retribuiti da non consentire di raggiungere
un livello di reddito superiore alla soglia di povertà; 2. la crescita degli
investimenti in capitale umano e formazione professionale per favorire e
accompagnare il reinserimento dei soggetti in stato di disoccupazione; 3.
la riorganizzazione dei livelli amministrativi di governo delle politiche del
lavoro e l’innovazione dei soggetti preposti alla gestione degli strumenti
di re-inserimento (come i servizi per l’impiego). Tutti fattori che hanno
contribuito ad attenuare la lettura colpevolizzante dello stato di disoccupazione e a sviluppare misure di carattere più promozionale e meno
stigmatizzante (Ciarini, 2008a). L’elemento caratterizzante di questo nuovo
corso è certamente costituito dal programma New Deal, al quale si può
dare atto di aver cercato di conferire un aspetto maggiormente inclusivo
alle politiche di workfare come insito, almeno in linea di principio, nel
welfare to work.
Le condizioni forti dell’attivazione e i suoi correttivi
Il New Deal, avviato dall’amministrazione Blair tra il 1997 e il 1998,
punta ad agire sui quattro assi di intervento costitutivi del welfare to work:
rendere attrattiva l’occupazione più della percezione dei sussidi; restringere
la fruizione dei benefits, sanzionando il mancato rispetto delle regole di
Modelli «classici» di welfare attivo
107
accesso; migliorare la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata; rendere
la transizione dall’assistenza al lavoro socialmente sostenibile e soggettivamente accettabile (Giaccardi, 2001). Ne è derivato un piano di interventi
di attivazione e reinserimento variegato e diretto in primo luogo ai soggetti
più deboli: disoccupati di lungo periodo, giovani, donne (tra le più attive in
Europa, grazie al diffuso ricorso al part-time, ma anche tra le più penalizzate
sia sul piano della disparità di trattamento economico rispetto agli uomini,
sia sul piano della qualità dell’impiego e delle possibilità di carriera), persone
con disabilità, genitori soli (una categoria particolarmente consistente nel
Paese). Tuttavia, i quattro assi di intervento appena richiamati non sono
stati perseguiti con la stessa intensità, a discapito del secondo e soprattutto
del quarto.
Gli interventi implementati hanno mirato a distinguere in modo netto
tra soggetti ritenuti in grado o meno di integrarsi stabilmente nella società
attraverso la partecipazione al mercato del lavoro. Ai primi vengono offerte
soprattutto opportunità di formazione professionale orientate a svilupparne
l’occupabilità; ai secondi è rivolto un pacchetto integrato di misure di tipo
fiscale (crediti di imposta), monetarie (indennità e sussidi) e occupazionale
(impieghi sussidiati).
La dichiarazione di non abilità al lavoro può dare accesso all’indennità di incapacità (Brookes et al., 2005). In altre parole, il lavoro, anzi la
capacità di lavorare è rimasta una precondizione della cittadinanza, al punto
da divenire obbligatoria l’accettazione delle proposte di impiego formulate
dai servizi competenti, anche se lo stesso New Deal ha introdotto qualche
correttivo con riferimento ai soggetti più vulnerabili.
Il perno attorno a cui ruota il modello di welfare attivo britannico è
rappresentato dai centri per l’impiego, i JobCentre, riformati e trasformati
all’inizio del Duemila nei JobCentrePlus, posti sotto le dipendenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e deputati a gestire in modo
integrato una serie di dispositivi: collocamento, politiche per l’occupazione,
sussidi di disoccupazione e invalidità, sussidi abitativi, contributi previdenziali previsti per le persone in situazione di disoccupazione, contributi per
l’assistenza e la cura diretti alle famiglie povere e ai genitori single; ma anche
iniziative di formazione professionale, azioni di supporto psicologico e sociale.
A qualificarne l’azione è proprio il raccordo che in tali servizi si realizza tra
politiche del lavoro e politiche sociali, benché le seconde siano subordinate
108
Welfare attivo
alle prime nella misura in cui l’obiettivo resta in tutti i casi il reinserimento
lavorativo e la conciliazione vita-lavoro2 (Ciarini, 2008a).
Nello specifico, i programmi di reinserimento gestiti dai JobCentrePlus (i New Deal Programme e Pathway to Work Programme) prevedono
una diversa combinazione delle misure che, come abbiamo visto, fanno
parte del pacchetto delle activation policies e sono diretti a specifici target
di utenti. Nel dettaglio riguardano per esempio: giovani di età compresa tra
i 18 e 24 anni (New Deal for Young People); disoccupati di lungo periodo
con tra i 25 e i 49 anni (New Deal 25 Plus); disoccupati over50 (New Deal
50 Plus); partner di soggetti beneficiari di sussidi (New Deal for Partner);
soggetti portatori di disabilità (New Deal for Disabled People); genitori soli
con figli a carico (New Deal for Lone Parents); musicisti disoccupati (New
Deal for Musicians); tossicodipendenti, homeless, ex carcerati (Progress to
work); soggetti che chiedono o che già godono dell’indennità di incapacità
al lavoro (Pathway to Work).3
A fondamento di questi programmi si ritrova il «patto di servizio»,
che lega in un rapporto contrattuale il beneficiario e il centro per l’impiego,
vincolando i due contraenti a obblighi reciproci: il primo deve ricercare attivamente una occupazione e accettare le proposte che gli vengono formulate
(siano di formazione o di impiego), pena l’incorrere in sanzioni che comprendono la decurtazione (tra il 20 e il 40% dell’ammontare complessivo)
o perfino la revoca dell’irrogazione dei sussidi; i secondi devono garantire le
prestazioni secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa. L’orizzonte
temporale che definisce per quanto il soggetto possa rimanere inattivo o in
carico al welfare ed entro quanto debba ricevere (e accettare) una proposta
Di rilievo sono al riguardo alcuni dispositivi: il Working Family Tax Credit, imposta negativa per fasce
di reddito per chi ha un salario basso, sia genitore o abbia più di 25 anni, e lavori a tempo pieno;
l’integrazione del reddito prevista dalla Child Tax Credit per i genitori che lavorano, sotto retribuiti o
sotto impiegati, o del tutto disoccupati; l’estensione dei benefici previsti per la maternità anche agli
uomini e i nuovi housing benefit che destinano aiuti per la copertura (in taluni casi sino al 100%) delle
spese abitative dei disoccupati che vivono in affitto, e si inseriscono nei programmi di reinserimento
attivo; l’istituzione di un dispositivo dedicato per i partner dei beneficiari dei sussidi (New Deal for
Partner): la loro presa in carico non rientra più nelle misure previste per il fruitore della Jobseeker’s
Allowance, ma avviene in modo diretto con misure di re-inserimento che riguardano soprattutto la
consulenza nella ricerca del lavoro, il sostegno al pagamento dei servizi all’infanzia, e la formazione
(Department of Work and Pensions, 2006).
3
Per i dettagli si possono consultare due siti in particolare: www.newdeal.gov.uk/home_job.asp; www.
jobcentreplus.gov.uk/pdfs/JPS1.pdf.
2
Modelli «classici» di welfare attivo
109
di formazione/impiego dipende dal target di riferimento (Brookes et al.,
2005).
Le condizioni più stringenti sono definite per i giovani tra i 18 e i
25 anni d’età e per i disoccupati di lungo periodo tra i 25 e i 49 anni, per
i quali il programma di attivazione è obbligatorio ed entra in funzione al
massimo entro sei mesi per i più giovani ed entro 18 mesi per gli adulti,
calcolati dal momento dell’acquisizione dello status di disoccupazione. Nel
corso dei primi quattro mesi (periodo Gateway) si prevede l’erogazione di
iniziative brevi di formazione e azioni di consulenza e supporto nella ricerca attiva dell’impiego. Al termine di questa prima fase, le opzioni tra le
quali il soggetto è chiamato a scegliere sono quattro: un lavoro sussidiato;
un’iniziativa di formazione a tempo pieno; un’attività di volontariato, con
una integrazione reddituale pari all’ammontare del sussidio; un’attività di
pubblica utilità nel settore della tutela ambientale. Se il programma di attivazione non ha esito positivo o il risultato è solo temporaneo si procede a una
nuova fase di consulenza e assistenza nella ricerca del lavoro: come ricorda
Freud (2007), la quinta opzione (rimanere in stato di passiva dipendenza
dal welfare) non è contemplata!
Per le altre categorie di destinatari la partecipazione ai programmi
è volontaria e le clausole meno serrate. Per tutti i beneficiari, comunque,
l’eventuale revoca del sussidio è temporanea, reversibile e riprende in modo
automatico trascorso un certo periodo di tempo (in genere tre mesi). È
quest’ultima una norma introdotta a inizio decennio dopo una prima valutazione del New Deal e dà conto della capacità del Governo di confrontarsi
in modo serio con le questioni più critiche. La definizione di criteri severi
per la revoca di benefici e servizi in caso di inadempienza è peraltro molto
contrastata, e c’è chi ha rilevato quanto essa possa produrre effetti perversi,
come l’innalzamento del numero dei soggetti che fanno richiesta delle
indennità di incapacità (Brookes et al., 2005). Del resto, pur a fronte di
una valutazione a una prima lettura complessivamente positiva, rispetto ai
risultati attesi sul fronte occupazionale e dei soggetti dipendenti dal welfare
(misurabile nella drastica riduzione del numero dei percettori di indennità),
emerge una diversa efficacia dei programmi in base ai target di riferimento
e alla tipologia di condizionalità che prevedono. Per esempio, i giovani
tra i 18 e i 25 anni e i disoccupati di lungo periodo tra i 25 e i 49 anni, e
altre categorie più deboli come i genitori soli o i percettori dell’incapacity
110
Welfare attivo
benefit mostrano tempi di dipendenza più lunghi (Freud, 2007). Al di là di
questa notazione, non meno importante è sottolineare come, in molti casi,
il passaggio dal welfare al lavoro è temporaneo, e dunque, pur orientati a
rompere la dipendenza del disoccupato dal sistema di protezione pubblico,
questi stessi programmi innescano una spirale di dipendenza nella quale
il soggetto sperimenta la reversibilità nel tempo di tale passaggio, avendo
difficoltà a trovare tramite i percorsi di attivazione una collocazione occupazionale stabile e sufficientemente remunerata. Su questo pesa certamente
la bassa dotazione di competenze e qualificazione che per lo più i soggetti
attivati (che appartengono in maggioranza a categorie svantaggiate e deboli)
portano in dote, ma incidono anche le difficoltà delle imprese a investire
in essi, appiattendo spesso le proprie aspettative solo sulle opportunità di
risparmio sul costo del lavoro che deviano dalla loro assunzione (ibidem).
L’individualizzazione, anzi, la personalizzazione è l’anima dell’azione
dei JobCentrePlus, che si concretizza nell’assegnazione a ciascun utente in
cerca di impiego di un Personal Advisor. Quest’ultimo segue passo passo
(attraverso colloqui con cadenza al massimo quindicinale) il percorso di
reinserimento, offrendo azioni di tipo consulenziale ma anche, di fatto,
esercitando una funzione di controllo e valutazione a partire dal patto di
servizio stipulato. Inoltre, in virtù della possibilità che gli viene conferita di
gestire in modo autonomo politiche diverse, egli di fatto possiede margini di
potere e discrezionalità. Margini che certo rendono flessibile il suo operato e
gli consentono di ritagliare su misura percorsi adatti alle necessità individuali
(Brookes et al., 2005), ma che rendono nel contempo asimmetrico il rapporto
con l’utente. Il Personal Advisor resta così vincolato al raggiungimento di
obiettivi quantitativi (misurabili nel numero di soggetti ricollocati in un dato
arco di tempo) che o inducono a interferire sulle preferenze del beneficiario
senza tenere conto delle sue effettive esigenze, oppure portano a selezionare
tra i potenziali beneficiari quelli più occupabili (Bonvin e Farvaque, 2005).
Non per caso, diverse indagini di valutazione hanno evidenziato come i
partecipanti ai programmi ne denuncino i risvolti coercitivi e paternalistici
(Cantalupi, 2003; Fergusson, 2004).
Come nota Ciarini (2008a), il tratto comune ai diversi programmi
di attivazione (in continuità quindi con la tradizionale impostazione
workfarista) è il generale orientamento all’offerta di queste politiche, con
l’enfasi data ai dispositivi di potenziamento dell’occupabilità e di accesso
Modelli «classici» di welfare attivo
111
immediato al lavoro. In tale scenario, la presenza del volontariato nel
pacchetto dei percorsi di reinserimento è di particolare interesse. Tale
opportunità infatti estende l’idea di lavoro al di fuori dai confini dell’impiego salariato per il mercato, per ricomprendere attività che comunque
possono contribuire a formare delle skills utili nel percorso di rientro nel
mercato. Nel modello di welfare to work che emerge negli ultimi anni,
dunque, il «rapporto tra utente e amministrazione non appare più solo
sanzionatorio o stigmatizzante (così come emergeva nell’indirizzo di riforma dei governi conservatori), ma anche calibrato sull’ampliamento dei
canali di accesso alla attività lavorativa e delle opportunità di sviluppare
occupabilità» (Ciarini, 2008a, p. 144).
L’approccio funzionalistico alla formazione
Nell’ottica dell’occupabilità e dell’occupazione si declinano anche le
politiche formative e di sviluppo del capitale umano inscritte nei programmi
di attivazione. Questa finalizzazione è resa evidente dalla ripartizione dell’investimento pubblico in politiche per il mercato del lavoro, di cui tre quarti
confluiscono nella formazione per l’occupabilità erogata da enti e agenzie
formative, contro il 12,1% dedicato agli incentivi per l’impiego, il 7,8%
alle misure di integrazione per i soggetti portatori di disabilità e il 4,3%
alla creazione di nuovi posti di lavoro (dati Eurostat riferiti al 2005; Riva,
2008). L’elevata percentuale di spesa in formazione sul totale di quella in
politiche attive nasconde peraltro il basso investimento effettivo, fermo allo
0,08% del Pil, sempre nel 2005, contro una media europea dello 0,21%. Per
questa via vengono finanziate iniziative di aggiornamento e riqualificazione
con finalità strettamente occupazionali, decisamente funzionali all’impiego.
Esse risultano improntate sul breve periodo, in vista di un rapido reinserimento lavorativo.
Alla formazione è affidato il compito di migliorare la corrispondenza
tra le competenze domandate e offerte sul mercato del lavoro, laddove da
più parti si denunciano le conseguenze negative dello skills shortage e dello
skills mismatch sia per le imprese, che non trovano risposta ai propri fabbisogni né in termini quantitativi né soprattutto sotto il profilo qualitativo
(fenomeno evidente se si considera l’elevata incidenza di soggetti a bassa
qualificazione tra gli occupati), sia per i lavoratori, che soffrono difficoltà