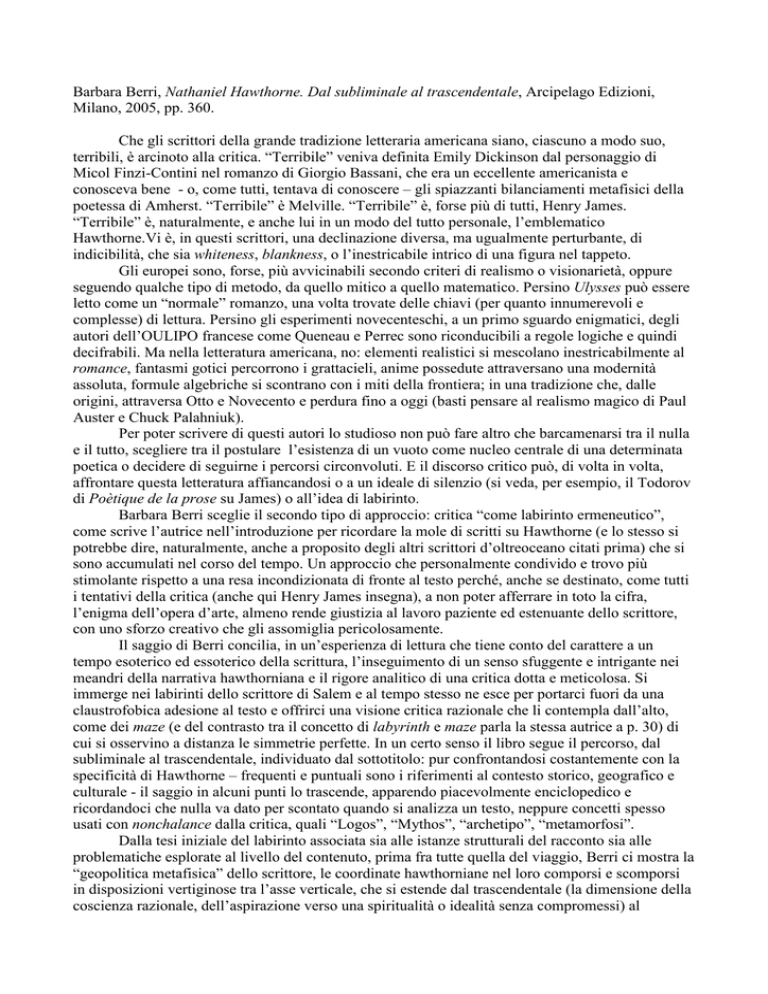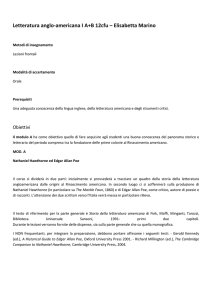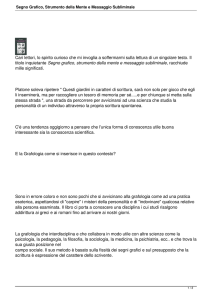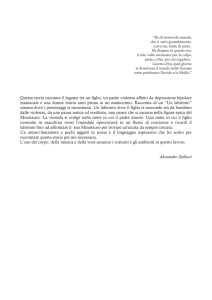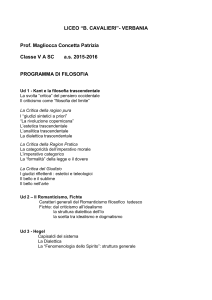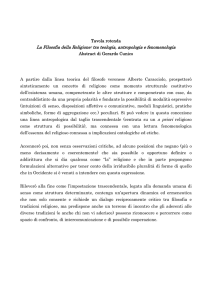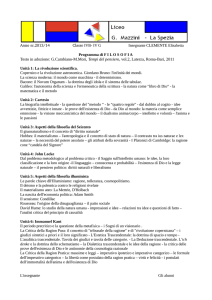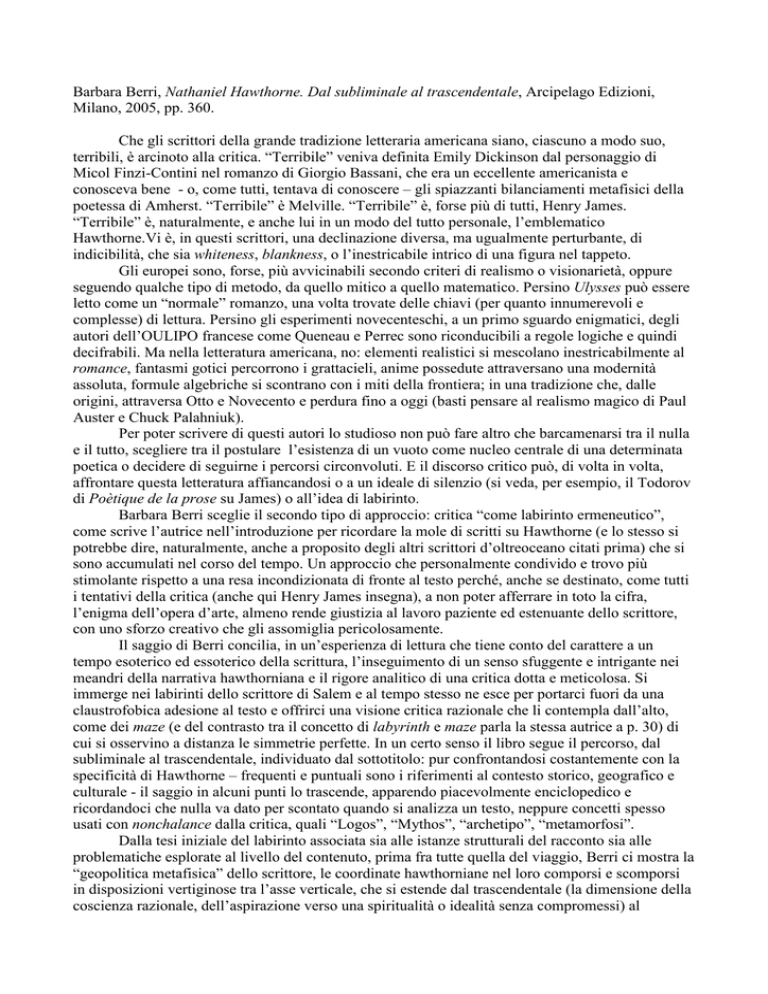
Barbara Berri, Nathaniel Hawthorne. Dal subliminale al trascendentale, Arcipelago Edizioni,
Milano, 2005, pp. 360.
Che gli scrittori della grande tradizione letteraria americana siano, ciascuno a modo suo,
terribili, è arcinoto alla critica. “Terribile” veniva definita Emily Dickinson dal personaggio di
Micol Finzi-Contini nel romanzo di Giorgio Bassani, che era un eccellente americanista e
conosceva bene - o, come tutti, tentava di conoscere – gli spiazzanti bilanciamenti metafisici della
poetessa di Amherst. “Terribile” è Melville. “Terribile” è, forse più di tutti, Henry James.
“Terribile” è, naturalmente, e anche lui in un modo del tutto personale, l’emblematico
Hawthorne.Vi è, in questi scrittori, una declinazione diversa, ma ugualmente perturbante, di
indicibilità, che sia whiteness, blankness, o l’inestricabile intrico di una figura nel tappeto.
Gli europei sono, forse, più avvicinabili secondo criteri di realismo o visionarietà, oppure
seguendo qualche tipo di metodo, da quello mitico a quello matematico. Persino Ulysses può essere
letto come un “normale” romanzo, una volta trovate delle chiavi (per quanto innumerevoli e
complesse) di lettura. Persino gli esperimenti novecenteschi, a un primo sguardo enigmatici, degli
autori dell’OULIPO francese come Queneau e Perrec sono riconducibili a regole logiche e quindi
decifrabili. Ma nella letteratura americana, no: elementi realistici si mescolano inestricabilmente al
romance, fantasmi gotici percorrono i grattacieli, anime possedute attraversano una modernità
assoluta, formule algebriche si scontrano con i miti della frontiera; in una tradizione che, dalle
origini, attraversa Otto e Novecento e perdura fino a oggi (basti pensare al realismo magico di Paul
Auster e Chuck Palahniuk).
Per poter scrivere di questi autori lo studioso non può fare altro che barcamenarsi tra il nulla
e il tutto, scegliere tra il postulare l’esistenza di un vuoto come nucleo centrale di una determinata
poetica o decidere di seguirne i percorsi circonvoluti. E il discorso critico può, di volta in volta,
affrontare questa letteratura affiancandosi o a un ideale di silenzio (si veda, per esempio, il Todorov
di Poètique de la prose su James) o all’idea di labirinto.
Barbara Berri sceglie il secondo tipo di approccio: critica “come labirinto ermeneutico”,
come scrive l’autrice nell’introduzione per ricordare la mole di scritti su Hawthorne (e lo stesso si
potrebbe dire, naturalmente, anche a proposito degli altri scrittori d’oltreoceano citati prima) che si
sono accumulati nel corso del tempo. Un approccio che personalmente condivido e trovo più
stimolante rispetto a una resa incondizionata di fronte al testo perché, anche se destinato, come tutti
i tentativi della critica (anche qui Henry James insegna), a non poter afferrare in toto la cifra,
l’enigma dell’opera d’arte, almeno rende giustizia al lavoro paziente ed estenuante dello scrittore,
con uno sforzo creativo che gli assomiglia pericolosamente.
Il saggio di Berri concilia, in un’esperienza di lettura che tiene conto del carattere a un
tempo esoterico ed essoterico della scrittura, l’inseguimento di un senso sfuggente e intrigante nei
meandri della narrativa hawthorniana e il rigore analitico di una critica dotta e meticolosa. Si
immerge nei labirinti dello scrittore di Salem e al tempo stesso ne esce per portarci fuori da una
claustrofobica adesione al testo e offrirci una visione critica razionale che li contempla dall’alto,
come dei maze (e del contrasto tra il concetto di labyrinth e maze parla la stessa autrice a p. 30) di
cui si osservino a distanza le simmetrie perfette. In un certo senso il libro segue il percorso, dal
subliminale al trascendentale, individuato dal sottotitolo: pur confrontandosi costantemente con la
specificità di Hawthorne – frequenti e puntuali sono i riferimenti al contesto storico, geografico e
culturale - il saggio in alcuni punti lo trascende, apparendo piacevolmente enciclopedico e
ricordandoci che nulla va dato per scontato quando si analizza un testo, neppure concetti spesso
usati con nonchalance dalla critica, quali “Logos”, “Mythos”, “archetipo”, “metamorfosi”.
Dalla tesi iniziale del labirinto associata sia alle istanze strutturali del racconto sia alle
problematiche esplorate al livello del contenuto, prima fra tutte quella del viaggio, Berri ci mostra la
“geopolitica metafisica” dello scrittore, le coordinate hawthorniane nel loro comporsi e scomporsi
in disposizioni vertiginose tra l’asse verticale, che si estende dal trascendentale (la dimensione della
coscienza razionale, dell’aspirazione verso una spiritualità o idealità senza compromessi) al
subliminale (lo spazio inquietante del sotterraneo, dello ctonio, di un inconscio scoperto o intuito
molto prima delle sperimentazioni-teorizzazioni freudiane e poi junghiane), e quello orizzontale
delle trasformazioni del personaggio, delle sue peregrinazioni dentro e fuori di sé, dei suoi
spostamenti tra luoghi a un tempo concreti e allegorici, tra le colonie e la wilderness, tra arcadie
perdute e foreste, tra ombre, silenzi, prigioni e giardini che diventano caverne del cuore. Tutto
questo analizzando gli insolvibili rapporti (anche qui tipicamente americani e puritani) tra religione
e scienza e tra innocenza e colpa. Inoltre, Berri illustra le affinità tra le figure della narrazione e le
figure del mito – minotauri e fauni, grandi madri e silfidi - ma senza facili identificazioni, anzi,
mantenendo aperte dicotomie e ambiguità, come è proprio della natura metamorfica di questi
racconti e dei personaggi che li abitano.
Particolarmente interessante è il capitolo sul corpo, inteso come mappa su cui l’esperienza
fisica e le risonanze dell’anima tracciano, come su un testo, tracce e segni; in questa prospettiva
anche gli abiti e gli altri orpelli che lo ricoprono, per scelta o per imposizione della comunità, dal
velo del minister nel racconto omonimo alla A ricamata sul petto di Esther Prynne in The Scarlet
Letter, non sono che l’esternazione di un dramma interiore, seppure così tortuoso da risultare
emblematico, una materializzazione della colpa secondo i principi di una vera e propria ”araldica
del peccato”.
Degna di nota anche la parte sul linguaggio, in cui vengono presi in esame l’intertestualità e
gli aspetti allegorici, metaletterari (autoriflessività, ironia, parodia) della scrittura di Hawthorne
accanto, come è inevitabile, alle figure del discorso, in primo luogo metafore, simboli e binomi.
La ricchezza del libro è dovuta soprattutto alla sua apertura, al fatto che Barbara Berri
ricorre, con un atteggiamento autenticamente pluridisciplinare, a tutte le fonti del sapere, dalla
teoria della critica alla filosofia, dall’antropologia alla psicologia (sottolineando, come abbiamo già
accennato, le intuizioni ante litteram di Hawthorne sui labirinti della psiche) alla linguistica. Ma è
anche il risultato di qualche preziosa citazione che rivela una grande passione per la letteratura e
l’arte (da Goya a Borges) e non solo la volontà di “dissezionare” i testi.
Così si perdona volentieri qualche eccesso tassonomico che si perde – e diversamente non
potrebbe accadere – di fronte alla difficoltà ontologica dell’impresa di cui si diceva all’inizio.
Perché anche le monografie critiche devono in qualche modo concludersi. Come mi disse una volta
Leonardo Terzo, autore, tra l’altro, della bella prefazione a questo saggio, a un certo punto “bisogna
imporsi di terminare il proprio lavoro altrimenti, di approfondimento in approfondimento, si
andrebbe avanti all’infinito.”
Mara Logaldo