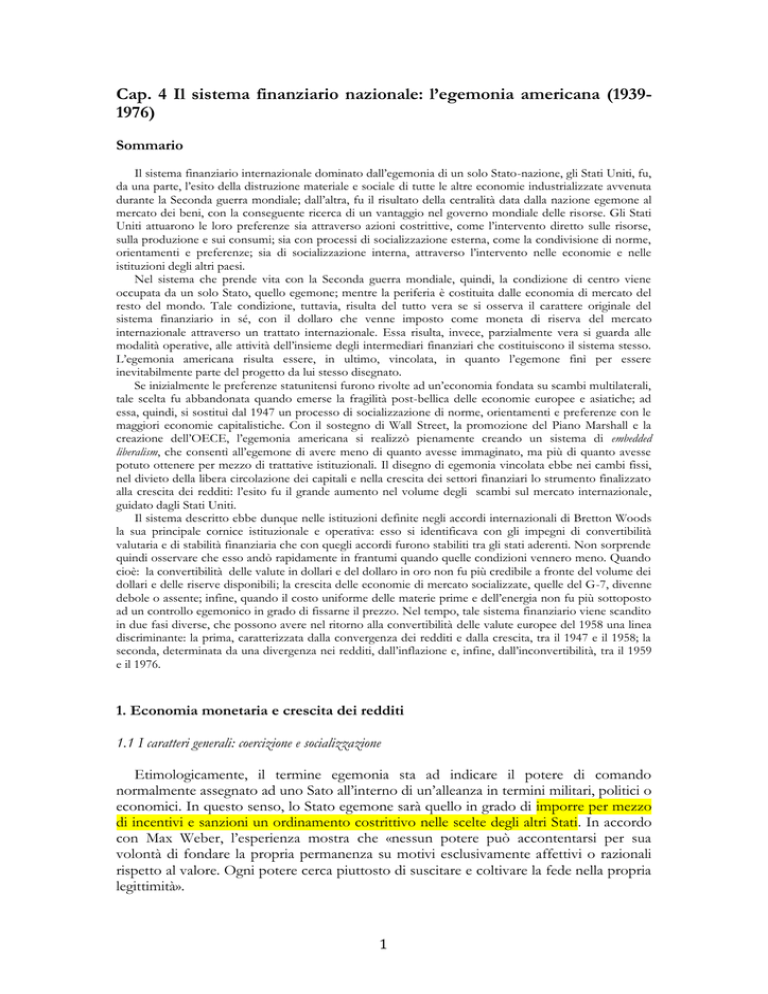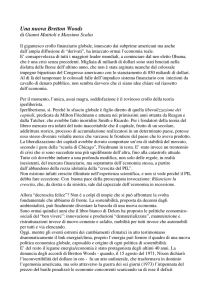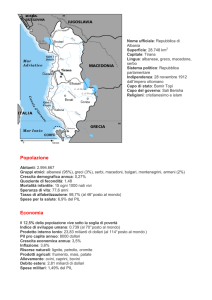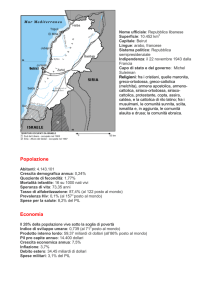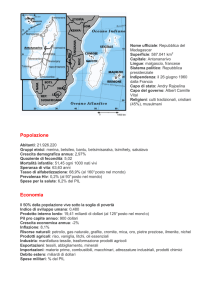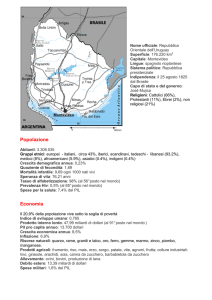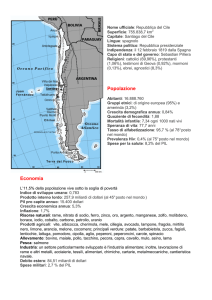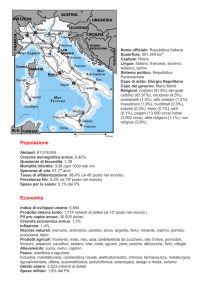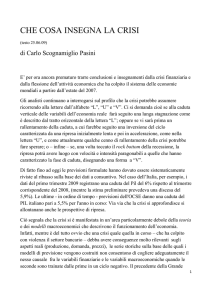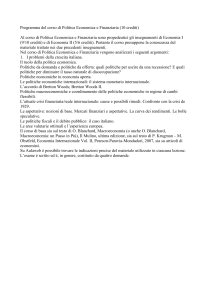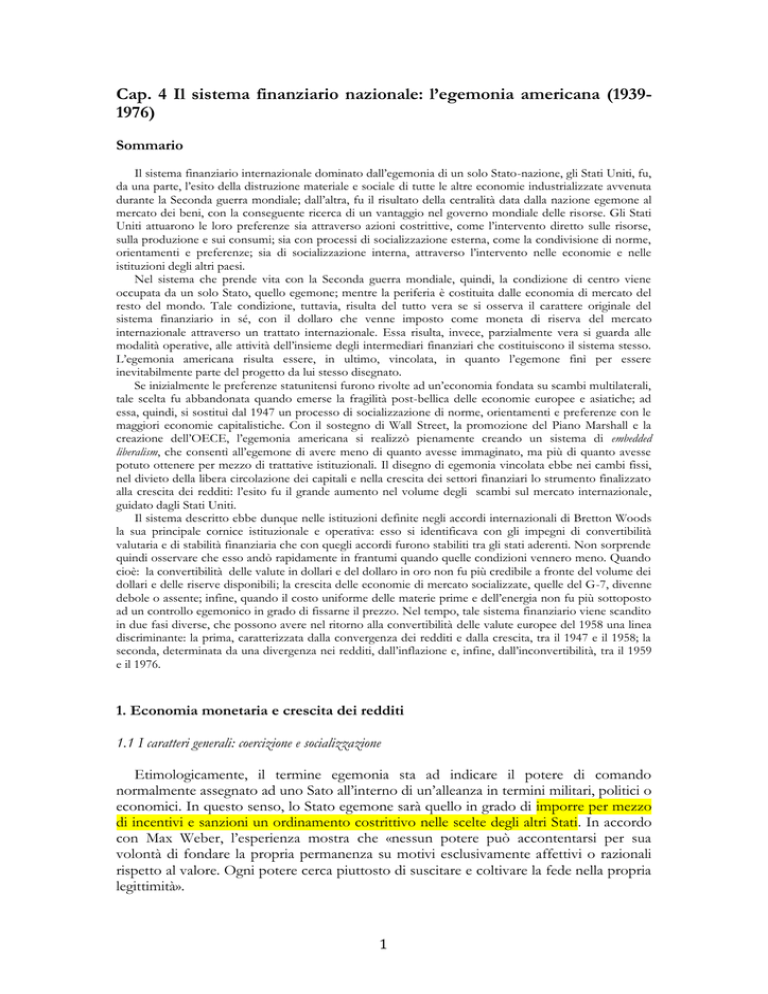
Cap. 4 Il sistema finanziario nazionale: l’egemonia americana (19391976)
Sommario
Il sistema finanziario internazionale dominato dall’egemonia di un solo Stato-nazione, gli Stati Uniti, fu,
da una parte, l’esito della distruzione materiale e sociale di tutte le altre economie industrializzate avvenuta
durante la Seconda guerra mondiale; dall’altra, fu il risultato della centralità data dalla nazione egemone al
mercato dei beni, con la conseguente ricerca di un vantaggio nel governo mondiale delle risorse. Gli Stati
Uniti attuarono le loro preferenze sia attraverso azioni costrittive, come l’intervento diretto sulle risorse,
sulla produzione e sui consumi; sia con processi di socializzazione esterna, come la condivisione di norme,
orientamenti e preferenze; sia di socializzazione interna, attraverso l’intervento nelle economie e nelle
istituzioni degli altri paesi.
Nel sistema che prende vita con la Seconda guerra mondiale, quindi, la condizione di centro viene
occupata da un solo Stato, quello egemone; mentre la periferia è costituita dalle economia di mercato del
resto del mondo. Tale condizione, tuttavia, risulta del tutto vera se si osserva il carattere originale del
sistema finanziario in sé, con il dollaro che venne imposto come moneta di riserva del mercato
internazionale attraverso un trattato internazionale. Essa risulta, invece, parzialmente vera si guarda alle
modalità operative, alle attività dell’insieme degli intermediari finanziari che costituiscono il sistema stesso.
L’egemonia americana risulta essere, in ultimo, vincolata, in quanto l’egemone finì per essere
inevitabilmente parte del progetto da lui stesso disegnato.
Se inizialmente le preferenze statunitensi furono rivolte ad un’economia fondata su scambi multilaterali,
tale scelta fu abbandonata quando emerse la fragilità post-bellica delle economie europee e asiatiche; ad
essa, quindi, si sostituì dal 1947 un processo di socializzazione di norme, orientamenti e preferenze con le
maggiori economie capitalistiche. Con il sostegno di Wall Street, la promozione del Piano Marshall e la
creazione dell’OECE, l’egemonia americana si realizzò pienamente creando un sistema di embedded
liberalism, che consentì all’egemone di avere meno di quanto avesse immaginato, ma più di quanto avesse
potuto ottenere per mezzo di trattative istituzionali. Il disegno di egemonia vincolata ebbe nei cambi fissi,
nel divieto della libera circolazione dei capitali e nella crescita dei settori finanziari lo strumento finalizzato
alla crescita dei redditi: l’esito fu il grande aumento nel volume degli scambi sul mercato internazionale,
guidato dagli Stati Uniti.
Il sistema descritto ebbe dunque nelle istituzioni definite negli accordi internazionali di Bretton Woods
la sua principale cornice istituzionale e operativa: esso si identificava con gli impegni di convertibilità
valutaria e di stabilità finanziaria che con quegli accordi furono stabiliti tra gli stati aderenti. Non sorprende
quindi osservare che esso andò rapidamente in frantumi quando quelle condizioni vennero meno. Quando
cioè: la convertibilità delle valute in dollari e del dollaro in oro non fu più credibile a fronte del volume dei
dollari e delle riserve disponibili; la crescita delle economie di mercato socializzate, quelle del G-7, divenne
debole o assente; infine, quando il costo uniforme delle materie prime e dell’energia non fu più sottoposto
ad un controllo egemonico in grado di fissarne il prezzo. Nel tempo, tale sistema finanziario viene scandito
in due fasi diverse, che possono avere nel ritorno alla convertibilità delle valute europee del 1958 una linea
discriminante: la prima, caratterizzata dalla convergenza dei redditi e dalla crescita, tra il 1947 e il 1958; la
seconda, determinata da una divergenza nei redditi, dall’inflazione e, infine, dall’inconvertibilità, tra il 1959
e il 1976.
1. Economia monetaria e crescita dei redditi
1.1 I caratteri generali: coercizione e socializzazione
Etimologicamente, il termine egemonia sta ad indicare il potere di comando
normalmente assegnato ad uno Sato all’interno di un’alleanza in termini militari, politici o
economici. In questo senso, lo Stato egemone sarà quello in grado di imporre per mezzo
di incentivi e sanzioni un ordinamento costrittivo nelle scelte degli altri Stati. In accordo
con Max Weber, l’esperienza mostra che «nessun potere può accontentarsi per sua
volontà di fondare la propria permanenza su motivi esclusivamente affettivi o razionali
rispetto al valore. Ogni potere cerca piuttosto di suscitare e coltivare la fede nella propria
legittimità».
1
In riferimento al sistema finanziario internazionale successivo alla Seconda guerra
mondiale, è immediato notare che l’azione egemone è stata esercitata dagli Stati Uniti:
essi hanno, in primo luogo, attuato incentivi e sanzioni istituzionali con l’obiettivo di
modificare le preferenze della classe dirigente dei paesi Alleati, durante il primo
periodo post-bellico; successivamente, nel ventennio successivo, essi si sono incaricati di
guidare quel processo di persuasione normativa che consentì agli stessi Stati Uniti,
attraverso contatti culturali, incentivi materiali e minacce di sanzione, di ottenere
legittimità nel comando. Questo processo di promozione e trasferimento della
gerarchia dei valori propri dello Stato-nazione egemone viene definito dalla letteratura
politica come socializzazione.
Le condizioni che permettono la realizzazione del processo di socializzazione sono
essenzialmente tre. In primo luogo, esso è favorito da una precedente situazione di
guerre e crisi politiche che portano ad avere una coincidenza tra instabilità
internazionale e crisi di legittimità della classe dirigente nazionale. In secondo luogo,
trattandosi di processo di trasferimento di valori, esso richiede una recettività delle
élite politico-amministrative. In terzo luogo, infine, lo sviluppo della socializzazione
tende a manifestarsi in seguito al momento di esercizio coercitivo del potere.
Coercizione e socializzazione portano agli stessi obiettivi e sono in molti casi
difficilmente distinguibili su un piano politico, mentre lo sono sempre sul piano
economico. La coercizione è identificabile con la manipolazione degli incentivi e delle
sanzioni materiali applicate dallo Stato egemone; la socializzazione, invece, si materializza
nella condivisione delle modalità di azione, nonché nella promozione dell’attività
produttiva, dei consumi, delle tutele sociali dei diritti all’istruzione, alla salute e alla
giustizia.
Concretamente, gli Stati Uniti hanno gettato le basi della propria egemonia attraverso i
due mezzi della coercizione e della socializzazione nell’immediato secondo dopoguerra.
Le modalità con cui fu gestita la prassi affitti e prestiti tra gli Stati Uniti e i paesi Alleati
dopo la fine del conflitto – si pensi in particolar modo al rapporto con la Gran Bretagna
– , così come l’intervento di riorganizzazione delle strutture produttive e nelle modalità
della rappresentanza politica dei paesi sconfitti – come la riorganizzazione economica e
sociale della Germania e del Giappone – rappresentano il momento coercitivo. Nello
stesso periodo, è possibile riscontrare il centro dell’azione di socializzazione nel disegno
dell’economia internazionale di beni e capitali che si realizzò con gli accordi Bretton
Woods. L’esito di queste azioni fu la creazione di un sistema finanziario nazionale
dominato dall’egemonia finanziaria americana.
Quest’egemonia si realizza in primo luogo attraverso le condizioni di economia
monetaria con cui gli agenti finanziari vengono portati ad operare. Si intende qui per
economia monetaria quella di un sistema economico in cui la moneta è investita di un
ruolo proprio che influisce sulle motivazioni e sulle decisioni degli agenti, diventando, in
sintesi, uno dei fattori operativi; tanto che la conoscenza del comportamento della
moneta risulta strumentale alla comprensione degli eventi. scelte di medio periodo degli
agenti.
Un’economia monetaria si realizza attraverso le seguenti condizioni. La prima è
l’esistenza di un settore economico che ha un proprio ruolo, quello di intermediazione
finanziaria, che consente la dissociazione tra risparmi e investimenti al fine di ottimizzare
2
i due comportamenti. La seconda condizione è l’instabilità nel processo di
accumulazione, in quanto non vi è sicurezza nella capacità di realizzare utili attraverso la
propria attività produttiva in maniera continuativa. La terza è il condizionamento operato
dal credito, ovvero dal costo e dal volume dell’offerta, sul processo di accumulazione di
cui prima. La quarta condizione è costituita dalla relazione cumulata tra reddito e
ricchezza.
Occorre sottolineare con forza che queste condizioni di “economia monetaria” si
applicano in modo pieno per la prima volta solo dopo gli accordi di Bretton Woods che
possono ritenersi l’atto di nascita del fiat standard, ovvero della moneta legale, e con essa
del nazionalismo monetario e del primato dato dalle autorità di governo agli equilibri sul
mercato interno.
Fu infatti solo in seguito all’esperienza acquisita negli anni tra le due guerre che la
pratica di una politica monetaria rivolta al controllo dei prezzi, alla tutela della legge della
parità del potere di acquisto a livello internazionale fu abbandonata. In specie l’esperienza
degli anni Trenta aveva portato alla condivisione di tre insegnamenti: a) il sistema dei
pagamenti organizzato in gold standard comportava rigidità deflattive che accentuavano la
condizione ciclica e comportavano danni rilevanti nei livelli di produzione e occupazione;
b) la scelta dei cambi flessibili non era sostenibile in quanto comportava una volatilità
così marcata nei rendimenti e una incertezza così diffusa da determinare un freno agli
investimenti; c) la crescita del livello tecnologico la politica economica dei governi ne
comportava una necessario coinvolgimento nelle scelte di politica industriale e interventi
nella attività produttiva.
Ne seguiva che in un sistema di cambi fissi, quale quello su cui ci si orienta nel
secondo dopoguerra, i surplus, o deficit, che si determinano nel breve periodo negli
scambi internazionali devono essere resi compatibili con gli equilibri interni dei mercati
reali per mezzo di operazioni di sterilizzazione svolte dalle banche centrali. Se questo non
si verifica gli squilibri esterni si protraggono e inducono a processi di redistribuzione
della ricchezza finanziaria netta verso i paesi in surplus, con conseguenti spinte inflattive
verso i paesi in deficit strutturale, con l’accentuarsi della mobilità dei capitali e, in ultimo,
con una generale crisi della stabilità del sistema stesso.
È questa la ragione per cui il sistema previde la creazione di uno specifico
intermediario internazionale, il Fondo monetario, cui si attribuì un patrimonio di riserve
composto da quote assegnate ai paesi aderenti attraverso trattative dominate dallo Statonazione egemone. Inoltre, al Fondo veniva demandata la possibilità di intervenire nelle
politiche monetarie fiscali nazionali attraverso l’azione di prestiti, cioè contratti,
internazionali, che come tali erano trasferimenti specifici di risorse a fronte di una
cessione della sovranità nazionale per un determinato periodo di tempo.
Gli Stati Uniti, avendo la maggioranza delle quote del Fondo, avevano anche il
maggior numero di delegati e riuscirono pertanto a utilizzare il fondo come una propria
agenzia, uno strumento di socializzazione esterno attraverso l’accettazione delle norme. Il
disegno delle regole – norme, orientamenti e preferenze – aveva quindi come obiettivo di
fondo l’attuazione di un disegno di potenza nazionale e commercio estero degli Stati
Uniti. In questo contesto, le norme costituiscono i principi generali su cui si basa una
visione dell’ordine internazionale; gli orientamenti sono le scelte di comportamento che
da quelle norme sono derivate; infine, le preferenze, in termini di prosperità, sicurezza o
conoscenza, generano le sequenze di scelte che hanno fatto si che e le economie di
3
mercato organizzate nel contesto di regole attuato dopo la secondo guerra mondiale
siano state vincolate dalla condizione della potenza nazionale di un solo Stato.
Non vi era di fatto nessuna effettiva difficoltà tecnica nell’operare scelte cooperative –
il piano Keynes prevendo una moneta internazionale come unità di conto, il bancor, fu
un esempio chiaro di questo – ma esse furono respinte per costruire un sistema di
incentivi e sanzioni che consentisse alla nazione Stati Uniti di avere una efficace politica
di potenza nazionale per mezzo della gestione delle modalità di esercizio del commercio
estero e del sistema dei pagamenti. Il piano White nel disegno di Bretton Woods e del
FMI ebbero nel piano Marshall il suo naturale punto di contatto per una
compenetrazione tra economia finanziaria e economia reale.
La rapidità di crescita delle economie nazionali dei paesi industriali aderenti
all’accordo, tuttavia, diede luogo già dai primi anni Cinquanta ad una condizione di
egemonia vincolata. Formalmente, il vincolo si esplicitava nell’obbligo statunitense di
convertire in oro all’equivalenza di 35 dollari all’oncia, le quote in dollari detenute dalle
banche centrali nazionale come base per la loro offerta di moneta. Quindi, questa
condizione di riserva internazionale attribuita alla valuta di un solo paese andava a creare
un sistema asimmetrico che dipendeva, quindi, dalla fiducia data al dollaro.
Essendo il dollaro e gli Stati Uniti al centro del sistema, essi erano l’unico paese che
potevano utilizzare in modo autonomo la leva della politica monetaria. Tuttavia, questo
privilegio era al tempo stesso un vincolo: gli Stati Uniti, infatti, perseguendo l’obiettivo di
una sostenuta domanda internazionale di beni, furono costretti ad utilizzare la politica
monetaria in funzione espansiva.
I due vincoli della parità di cambio e della politica monetaria espansiva garantivano un
ordine economico internazionale che aveva come scopo principale quello di sostenere
una continua crescita del volume di scambio internazionale dei beni reali, di cui gli Stati
Uniti possedevano la quota maggioritaria.
Come mostra la figura 4.1, se la condizione economica del sistema si trova ad essere
nel punto 2, a meno che non vi sia svalutazione e aumento del livello di spesa nazionale,
l’equilibrio interno ed esterno non può essere raggiunto. La sola politica fiscale può
raggiungere il punto 3; la sola svalutazione può raggiungere il punto 4.
FIGURA 4.1
4
La possibilità di creare condizioni di espansione produttiva, promuovendo una
modifica coordinata delle condizioni di equilibrio sia sul mercato estero che su quello
interno, così come indicato dalla figura 4.2, è resa possibile solo da un effetto espansivo
di offerta di moneta consentito, di fatto, nel sistema di cambi fissi quale quello di Bretton
Woods, al solo Stato-nazione che disponesse di una moneta avente ruolo sia di valuta
domestica sia di riserva internazionale, ovvero gli Stati Uniti.
FIGURA 4.2
5
Sarà quindi la sola economia egemone a poter muovere in cambi fissi DD in funzione
espansiva; normalmente una politica espansiva, come indica la figura 4.3, porterebbe ad
una azione deflattiva e ad una sotto occupazione.
FIGURA 4.3
Sono queste le ragioni per cui si sono avute in tutto il periodo del sistema di Bretton
Woods una m olteplicità di svalutazioni e rivalutazioni da parte degli stati che non
potevano contare su una politica monetaria autonoma.
FIGURA 4.4
E’ questa stessa ragione che ha poi portato ad un a condizione di vantaggi ripetuti nella
svalutazione delle valute nazionali e nel permanere del dollaro ad una condizione centrale
6
anche quando non ne aveva più la possibilità in termini di vantaggio nella produzione sul
mercati reali dalla metà degli anni ’60.
Il vantaggio – necessariamente di breve periodo, se non si ricorre a svalutazioni, è
evidenziato nella figura 4.5 e nella sua coordinata 4.5.1.
FIGURA 4.5
FIGURA 4.5.1
L’accumulazione repressa di svalutazioni e moneta chiave ha creato gli attacchi
speculativi degli anni Sessanta e in ultimo le spinte dirompenti degli anni 70 che hanno
portato alla fine del sistema.
1.2 – Le modalità operative
Dopo la Seconda guerra mondiale, il processo di costruzione dell’egemonia finanziaria
statunitense passa attraverso l’imposizione di una cultura industriale e finanziaria in tutti i
paesi che aderiscono al Piano Marshall. Questa cultura comportava una riorganizzazione
dell’economia in unità istituzionali, classificate in settori secondo uno schema di
7
contabilità nazionale uniformata agli standard statunitensi. In questo modo, veniva
costruito, in ogni paese, un sistema di conti pubblici che consentiva una distribuzione
delle risorse finalizzata a un percorso di crescita.
La teoria economica non consente di poter affermare in maniera certa che esista una
relazione tra la dimensione del settore finanziario e una crescita dell’economia reale:
l’evidenza empirica, invece, mostra l’esistenza di tale relazione. Quello che possiamo
desumere dallo studio della contabilità nazionale, infatti, è che la moderna crescita
economica è stata accompagnata, nelle prime fasi, da una più che proporzionale
espansione della sovrastruttura finanziaria. Ciò suggerisce che questa espansione è una
fase necessaria dello sviluppo di un Paese fino alla sua maturità, che si riflette in un indice
di interrelazione finanziaria molto vicino ad 1:1.
La rilevanza di ogni specifico settore finanziario è data dalla diversa natura delle sue
specifiche componenti, ovvero principalmente banche, assicurazione, borse valori e altri
intermediari finanziari. Un indicatore di tale incidenza è dato dalla loro quota nelle
attività finanziarie totali. Tale quota è cresciuta costantemente in tutte le economie di
mercato. Uno studio dei cambiamenti dei bilanci nazionali mostra che la composizione e
il peso delle voci di bilancio ha subito variazioni, tuttavia non in maniera sostanziale.
La crescita del settore finanziario in ogni singolo paese è stata strumentale, da una
parte, alla crescita del Pil dei diversi paesi; dall’altra, alla diffusione dell’egemonia
statunitense nel periodo successivo alla guerra: attraverso il settore finanziario, infatti,
l’attività produttiva nazionale veniva promossa in equilibrio con il cambio internazionale.
Questo equilibrio è dato dall’equivalente tra la base monetaria e il valore di cambio,
ottenendo come risultato finale che il mercato internazionale cresca molto di più dei
singoli mercati nazionali.
8
9
2. Guerra ed egemonia
La guerra ebbe ripercussioni, diverse per modalità, caratteristiche ed intensità, su tutte
le aree del mondo. Come già nella Prima guerra mondiale, ma con maggiore forza, gli
Stati Uniti videro accrescere enormemente il proprio potere economico, sia a livello
assoluto che in relazione agli altri paesi. Già prima dell’entrata in guerra nel dicembre del
1941, l’occupazione e il reddito statunitensi aumentarono in conseguenza delle necessità
di approvvigionamento degli eserciti e della popolazione europei. In generale,
considerando il periodo che va dal 1939 al 1944, il prodotto interno lordo americano
crebbe del 150% mentre la produzione industriale aumentò del 300%. La guerra giocò
ovviamente un ruolo chiave in questo processo di crescita, facendo aumentare la
produzione a fini bellici dal 2% del totale nel 1939 fino al 40% registrato nel 1943. Per
avere un quadro generale della netta superiorità della produzione industriale statunitense,
soprattutto di materiale bellico, basti pensare che, nel 1944, essa costituiva il 40% della
produzione mondiale di armamenti, mentre già nel 1942 gli Stati Uniti da soli
producevano più armi di tutti i paesi dell’Asse.
La crescita della produzione americana ebbe effetti anche sull’occupazione, che fece
registrare un aumento di 19 milioni di posti di lavoro nel periodo 1941-1944, nonché dei
consumi, che crebbero, nello stesso periodo, del 12%. Tutti i settori dell’industria
americana trassero qualche vantaggio dallo stato di guerra anche se le industrie degli
armamenti furono, ovviamente, quelle maggiormente avvantaggiate. In questi settori si
registrarono anche i maggiori avanzamenti di sviluppo tecnologico, che sarebbero stati
poi alla base delle produzioni post-belliche di automobili, aerei, lavorazione dei metalli,
nonché delle industrie del settore metallurgico, chimico e elettrotecnico. In generale,
l’industria americana sperimentò un’espansione tecnologica e produttiva senza
precedenti, raggiungendo, da una parte, un’altissima efficienza – efficienza, tra l’altro, che
si accompagnò ad una concentrazione nelle grandi industrie, provocando parallelamente
la crisi della piccola e media impresa – e, dall’altra, diffondendosi anche nelle aree in
precedenza quasi interamente rurali, come quelle dei vasti stati dell’ovest e del sud degli
Stati Uniti.
10
La guerra generò inoltre cambiamenti in altre zone del mondo. Uno dei più
macroscopici dal punto di vista economico avvenne in conseguenza dell’invasione
tedesca della Francia, che si concluse con l’ingresso a Parigi delle truppe della Wehrmacht
nel giugno del 1940. L’occupazione ebbe costi altissimi per i francesi. La politica del
Terzo Reich, infatti, fu quella di impiegare massicciamente le risorse dei territori occupati
per finanziarie sia le truppe sul territorio, sia l’espansione produttiva in patria.
È stato calcolato che durante il periodo bellico i trasferimenti finanziari che la
Germania nazista estorceva ai paesi conquistati ammontavano all’incirca al 40% del totale
del gettito fiscale tedesco. In questo senso la Francia fu il paese maggiormente colpito,
dovendo versare una somma pari a circa di 20 milioni di Reichsmark al giorno per un
totale, tra il 1940 e il 1944, di oltre 600 miliardi di franchi ad una parità, fortemente
sopravvalutata, di 20 franchi per marco. Per rendere l’idea dell’enorme ammontare dei
pagamenti francesi nel periodo di occupazione tedesca, si calcola che il totale dei costi
sostenuti nel solo 1943 fosse pari a circa il 9% del prodotto interno lordo tedesco.
Questa percentuale, tra l’altro, era addirittura minore della media calcolata dei prelievi di
tutti i territori occupati nel periodo 1940-1944, che ammontava al 14% del prodotto
interno lordo della Germania nazista di quegli anni. Tali cifre escludono i vantaggi che le
aziende tedesche si garantivano mediante le confische di macchinari, territori e intere
aziende, nonché attraverso l’impiego, a condizioni quasi di schiavismo, di lavoratori dei
paesi occupati. A tal proposito, è noto l’esempio della I.G. Farben, un’industria chimica
tedesca che, impiegando manodopera dei territori conquistati in condizione di schiavitù –
è stato calcolato che l’aspettativa di vita in un campo di lavoro della I.G. Farben era
all’incirca di tre mesi –, riuscì ad aumentare la sua produttività in un ambito
multinazionale.
Deve essere in ogni caso segnalato che le esperienze sotto l’occupazione nazista
furono diverse a seconda dei paesi presi in esame: ad esempio, la Norvegia fu destinataria
di investimenti nel settore petrolifero e idroelettrico – due centrali idroelettriche vennero
completate in questi anni con denaro tedesco – , anche se il prodotto nazionale
norvegese decrebbe con il passare degli anni in quanto il paese venne coinvolto con
intensità crescente negli sforzi per sostenere lo sforzo bellico tedesco. D’altronde, era
questo un destino comune a tutti i paesi alleati della Germania – come ad esempio
Finlandia, Ungheria, Romania e Bulgaria – che, a mano a mano che la guerra procedeva,
venivano sempre più sfruttati per finanziare la macchina bellica nazista. Il Belgio e
l’Olanda subirono, anche se con minor intensità, lo stesso destino della Francia, essendo
costretti a pagare quotidiani pagamenti verso la Germania, mentre i paesi che soffrirono
le conseguenze più drastiche dell’occupazione furono certamente quelli orientali, come la
Cecoslovacchia e la Polonia, le cui risorse – in primis umane, ma anche industriali e delle
materie prime – vennero sfruttate indiscriminatamente, facendo crollare la propria
capacità produttiva.
Anche l’espansione in oriente del Giappone aveva radici economiche, che possono
essere individuate nell’esclusione del paese nipponico dai grandi blocchi commerciali
degli anni Trenta, ed ebbe, nel periodo post-bellico, notevoli conseguenze sul piano
dell’organizzazione internazionale dei commerci. La principale preoccupazione delle
autorità giapponesi, decisiva nel trascinare il paese in guerra, fu la necessità di conquistare
approvvigionamenti di materie prime e combustibili, nonché di creare mercati protetti
per le merci giapponesi. La guerra si risolse, però, in un disastro per il Giappone,
soprattutto in relazione alle infrastrutture, alla capacità industriale e alla flotta mercantile:
11
si calcola, infatti, che alla fine del conflitto la marina americana aveva distrutto l’88% dei
6,5 milioni di tonnellate del naviglio mercantile nipponico.
Il conflitto ebbe conseguenze economiche anche nei paesi non direttamente
interessati dai combattimenti. L’india, ad esempio, riuscì a ricavare qualche piccolo
vantaggio, anche se dato lo scarso livello tecnologico di partenza questi non poterono
essere rimarchevoli. Tuttavia, qualche effetto industrializzante si ebbe nei settori delle
munizioni, delle costruzioni navali e della meccanica, soprattutto in relazione alle
commesse britanniche. Anche nei paesi latino-americani il secondo conflitto mondiale
portò alcune conseguenti di una certa importanza. Questi paesi divennero dei grandi
fornitori di materie prime per gli Stati Uniti, accumulando riserve di dollari e aumentando
la propria quota di esportazioni mondiali, che passò dal 7,8% del 1938 al 13,4% registrato
nel 1946. In conseguenza della mancanza di rifornimenti da parte dei tradizionali partner
europei, aumentò anche l’interscambio commerciale tra gli stessi paesi del Sud America.
Tra i paesi europei impegnati nel conflitto, dopo la caduta della Francia nell’estate del
1940, la Gran Bretagna si ritrovò da sola a fronteggiare l’offensiva tedesca. Tuttavia, per
quanto la produttività inglese crebbe durante il conflitto, essa non riuscì né a sostenere i
ritmi delle necessità belliche, né a raggiungere i livelli degli Stati Uniti, i quali, grazie al
progresso tecnologico fatto registrare, riuscivano ad occupare una quota minore di
manodopera nel settore delle industrie di materiale bellico e nelle stesse forze armate. Gli
Stati Uniti, come nella Prima guerra mondiale, accorsero così in aiuto dei paesi alleati.
Tuttavia la novità delle modalità di finanziamento delle spese belliche dei paesi europei, e
della Gran Bretagna in particolar modo, fu che questi non furono erogati come prestiti o
anticipazioni ma presero la forma di forniture di materiali e beni alimentari, come ad
esempio munizioni e alimenti conservati, ai paesi che erano in guerra contro l’Asse.
L’accordo cosiddetto Leand-Lease – affitti e prestiti – trasferì all’Impero britannico un
totale di beni e servizi che ammontava all’incirca al 5% del reddito nazionale statunitense,
mentre all’inizio del 1945 il totale dei rifornimenti di ogni genere ai paesi europei in
guerra contro il nazi-fascismo, inclusa, dopo il 1941, anche la Russia sovietica,
ammontava a 5.000 milioni di dollari. In cambio delle forniture americane ad un prezzo
vantaggioso, che sarebbe stato possibile saldare al termine del conflitto, i riceventi degli
aiuti accettavano, come specificato dall’articolo VII del Lend-Lease Agreements, di
partecipare insieme agli Stati Uniti alla ricostruzione di un sistema commerciale aperto e
multilaterale, rinunciando agli accordi commerciali bilaterali e accettando di rimuovere
barriere doganale e quote discriminanti.
La guerra determinò una generale sofferenza delle borse mondiali, provocando un
generalizzato declino degli affari e una mobilitazione delle risorse che, come abbiamo
visto, veniva gestita quasi totalmente dagli Stati. Da questo punto di vista, in realtà, la
situazione si presentava in forma diversa rispetto a quella della Prima guerra mondiale, in
quanto il controllo statale sulle attività finanziarie e sui trasferimenti di risorse a fini
bellici era decisamente più forte, riducendo così le opportunità per banchieri e finanzieri
di ricavare guadagni dalle diverse transazioni.
Sulla piazza di Wall Street, come tra l’altro nella City di Londra, vi fu un
ridimensionamento, come detto, delle attività finanziarie internazionali. Soprattutto nel
primo periodo del conflitto vi fu una forte decrescita del numero delle imprese quotate
sulla piazza newyorchese, il cui valore era fortemente influenzato dagli eventi bellici e
dalle notizie che circolavano. Ad esempio, i prezzi medi delle azioni aumentarono del
10% nel settembre del 1939, in quanto ci si aspettava molti profitti da parte delle aziende
12
americane in seguito alle commesse di guerra di Gran Bretagna e Francia, poi caddero del
20% nel maggio-giugno del 1940 in seguito all’invasione tedesca della Francia e poi
continuarono a decrescere costantemente fino all’aprile del 1942, quando raggiunsero un
livello che era del 40% inferiore di quello registrato prima dell’inizio della guerra. La
svolta si ebbe il 28 aprile del 1942, quando Roosvelt annunciò misure di razionamento e
prezzi amministrati, allontanando in tal modo le paure dell’inflazione e permettendo una
ripresa degli investimenti in borsa, tanto che nel settembre del 1945 i prezzi medi a Wall
Street erano già raddoppiati.
Tra le conseguenze del conflitto vi fu la crescita dell’importanza del Federal Reserve
Board di Washington, a scapito di quello di New York che, come visto, era invece stato
l’attore principale della politica finanziaria americana negli anni Trenta. In questo nuovo
contesto il tasso di sconto fissato all’1% nel 1937 fu mantenuto per tutta la durata della
guerra, favorendo il finanziamento di un debito pubblico statale che passò, nel periodo
1941-1945, da 48 milioni di dollari a 260 per affrontare le spese di guerra. Le banche
d’investimento furono largamente coinvolte nel collocamento dei titoli del Tesoro, che
emise sette prestiti di guerra negli anni considerati, ma ricavarono pochissimi guadagni da
tale coinvolgimento, mentre i titoli emessi dalle imprese private si dimezzarono tra il
1941 e il 1943 per poi aumentare nuovamente solamente negli ultimi due anni del
conflitto.
Seguendo un trend che sarebbe stato poi istituzionalizzato largamente nel secondo
dopoguerra, in Gran Bretagna la geometria decisionale in materia finanziaria e monetaria
si spostò, durante la guerra, nettamente in favore della politica e quindi del Tesoro, con
una riduzione dell’incidenza delle decisioni della Banca d’Inghilterra, che divenne il
braccio esecutivo del governo in materia monetaria, svolgendo anche funzioni di
intermediario con la City e con le banche commerciali. Queste ultime furono tra le
banche che superarono con più facilità il periodo di guerra proprio grazie all’intervento
dello Stato che, da una parte, era diventato il loro maggior cliente – nell’agosto del 1945 i
depositi della Midland Bank, ad esempio, erano costituiti per l’82% da titoli governativi –;
e dall’altra ne indirizzava le attività con istruzioni precise su come impiegare le proprie
risorse.
Come negli Stati Uniti, tuttavia, il volume d’affari della borsa di Londra si ridusse
enormemente, contraendosi circa dell’80% tra il 1939 e il 1941, per poi riprendersi, in
parallelo con Wall Street, dal 1942 in poi. I corsi azionari infatti seguirono le vicende
belliche, toccando il punto più basso nel 1940 quando la città era sotto i bombardamenti
tedeschi e circa un terzo della City era in rovina. Con il lento volgere della guerra a favore
degli Alleati, anche i titoli azionari recuperarono il proprio valore, con l’indice industriale
che passò da 79,7 alla fine del 1941, a 93,7 nel 1942 ed infine a 103,1 registrato il 31
dicembre 1943, con un guadagno sul prezzo minimo toccato nel 1940 pari al 60%.
Tra le grandi piazze finanziarie mondiali la situazione più drammatica era, per le
ripercussioni delle vicende belliche e l’invasione tedesca, sicuramente quella di Parigi.
Dopo l’occupazione delle truppe naziste, i pagamenti a cui la Francia era stata imposta
venivano gestiti dalla Banca di Francia e dal suo governatore Yves de Boisanger, che aprì
un conto presso la Reichskreditkasse sul quale il Tesoro era costretto a versare ogni dieci
giorni una rata di 4 miliardi di franchi. Fino all’aprile del 1942 timide trattative vennero
portate avanti per tentare di ridurre tale cifra: questi tentativi, però, cessarono del tutto
quando Pierre Laval ridivenne Primo ministro di Vichy, appunto nell’aprile del 1942,
inaugurando una politica pienamente collaborativa con gli occupanti, senza nessuna
13
preoccupazione per le possibili tendenze inflazionistiche, che portò ad un aumento dei
prezzi pari all’88% di quelli registrati prima del conflitto. L’inflazione, però, contribuì
d’altro canto a sostenere le attività della borsa di Parigi che, grazie all’abbondanza di
liquidità, vide crescere le operazioni in maniera vertiginosa a partire dal 1941, quando si
registrò un aumento dei prezzi medi delle azioni del 300%.
Le grandi banche attraversarono, come del resto in tutti gli altri paesi, un periodo di
grande difficoltà, a causa della diminuzione delle operazioni di cambio e del
finanziamento del commercio internazionale, che si fece decisamente scarso. In questo
contesto, in Francia, cominciò a diffondersi l’abitudine di saldare le diverse transazioni in
contanti, colpendo in tal modo le operazioni di sconto. Come altrove, crebbe il volume
delle obbligazioni del Tesoro – che in Francia doveva, come ricordato, anche sostenere
l’onere degli enormi pagamenti verso la Germania – , crescendo parallelamente anche la
percentuale delle obbligazioni possedute dalle grandi banche: ad esempio, nel 1945, il
Crédit Lyonnais aveva un portafogli costituito per il 90% da obbligazioni del Tesoro. Tra
le banche private, seguendo una politica inaugurata nella Germania nazista, quelle di
proprietà ebraica furono quelle che subirono maggiormente dell’occupazione tedesca e,
in particolar modo, delle politiche anti-semite che il governo di Vichy perseguiva. Il
Comité d’Organisation des Banques, nel 1940, identificò 30 case bancarie come ebraiche,
chiudendole, come nel caso della Lazard Frères, arianizzandole oppure, come accadde
alle proprietà dei Rotschild, confiscandole.
La situazione delle istituzioni finanziarie italiane durante la guerra è una delle più
peculiari nell’intero panorama mondiale, soprattutto per via delle vicende belliche. Nella
prima fase della guerra, ovvero tra il 1939 e il 1942, la politica monetaria e finanziaria
condotta dal governo e dalla Banca d’Italia ricalca sostanzialmente quelle degli altri paesi,
orientandosi verso il finanziamento della guerra e mettendo in campo strumenti
finanziari per tentare di mantenere quanto più possibile una stabilità dei prezzi, che
crebbero del 52%, cioè in media con gli altri paesi europei tranne, come s’è visto, la
Francia, e in realtà la Germania, dove un ferreo controllo dell’economia e lo sfruttamento
dei territori occupati aveva permesso un’inflazione pari solamente al 6,4%.
Il drastico andamento della guerra italiana e i bombardamenti alleati dell’autunno del
1942 fecero però sì che il paese entrò in una vera e propria crisi, inaugurando una
situazione che divenne drammatica quando, con l’armistizio dell’8 settembre del 1943, il
paese si spezzò in due, perdendo praticamente la propria autorità monetaria sul territorio.
Sia nei territori sotto il governo alleato al sud, che in quelli sotto il controllo tedesco al
nord, si sperimentarono forme inflazionistiche: da una parte, al sud, esse erano dovute
all’emissione delle cosiddette «am-lire» e alla totale assenza di qualsiasi controllo
monetario su gran parte del territorio, dove i combattimenti distruggevano anche gran
parte delle attività produttive e delle infrastrutture; al nord, invece, la Banca d’Italia,
ancora formalmente autonoma sotto il governatorato di Vincenzo Azzolini, era costretta
a stampare moneta per pagare le forze di occupazione tedesche. Come conseguenza, tra il
1942 e il 1945, la circolazione monetaria complessiva, sia al nord che al sud, aumentò di
4,9 volte, mentre i prezzi all’ingrosso furono maggiori di 13,5 volte e il costo della vita
aumentò di 14,7 volte. Tra il settembre del 1943 e la liberazione di Roma del giugno
1944, ma in realtà fino alla conclusione del conflitto e la caduta di Hitler, la situazione
italiana rimase molto difficile e caratterizzata da una enorme inflazione.
Tra le piazze finanziarie che videro accrescere la propria importanza nel corso del
conflitto ci fu certamente la Svizzera, soprattutto in virtù del fatto che la sua valuta, il
14
franco svizzero, fu l’unica tra quelle europee che rimase convertibile in oro per tutta la
durata della guerra, facendone una moneta molto ricercata. La Germania nazista, ad
esempio, usava la piazza finanziaria svizzera per vendere oro contro franchi, impiegando
poi questi ultimi per rifornirsi di materie prime di primaria importanza per la conduzione
delle operazioni militari, come il petrolio e il tungsteno, dai paesi neutrali quali la Spagna,
il Portogallo o la Turchia. L’accresciuto controllo politico delle attività finanziarie
determinò, anche in Svizzera, una diminuzione delle attività e quindi dei profitti delle
banche. Tuttavia, le banche svizzere continuarono a fornire servizi creditizi a molte
aziende e banche tedesche: importante erano infatti i rapporti tra la Crédit Suisse e la
Deutsche Banke e tra la Société de Banque Suisse e la Dresdner Bank, ma non possono
essere trascurate anche le quote di investimenti svizzeri in grandi imprese come la già
citata I.G. Farben. 2
3. Regolamentazione e crescita
Il sistema monetario post-bellico cominciò a nascere dalla stessa esperienza del
conflitto, tanto che già durante il medesimo Stati Uniti e Gran Bretagna iniziarono a
porre i primi mattoni di quell’edificio finanziario internazionale che sarebbe stato
formalizzato a Bretton Woods nel luglio del 1944. Con la firma della Carta Atlantica
nell’agosto del 1941 e il Mutual Aid Agreement del febbraio del 1942, le autorità inglesi e
americane si accordavano infatti su alcuni principi di base che avrebbero poi costituito le
basi su cui costruire i futuri accordi: se, da una parte, gli inglesi accettarono di ripristinare
la convertibilità della sterlina e di rinunciare alle preferenze tariffarie imperiali fissate dalla
conferenza di Ottawa del 1932; dall’altra gli americani promisero di continuare gli aiuti
finanziari da destinare alla ricostruzione anche dopo la cessazione delle ostilità, nonché a
rispettare la priorità che le autorità britanniche, nella ormai piena accettazione delle teorie
keynesiane, davano alle politiche del pieno impiego.
Risulta essenziale sottolineare, però, come vedremo a breve, che il quadro di accordi
che prese vita a Bretton Woods non funzionò, in realtà, secondo le modalità decise nel
luglio del 1944, ma fu orientato in maniera progressiva dagli Stati Uniti a favorire un
processo di socializzazione, orientato in due modalità: nella forma esterna di
cooperazione istituzionale internazionale e in vincoli normativi scaturiti da questi
incontri; e nella forma interna di omogeneizzazione dei diversi settori dei sistemi
economici raccordati in schemi di contabilità nazionale. Il sistema dell’egemonia
statunitense entrò progressivamente in vigore negli anni Cinquanta, culminando con la
fissazione delle parità tra le valute aderenti al sistema decisa nel 1958, ed iniziando la sua
crisi dagli inizi degli anni Sessanta in seguito ai mutati equilibri produttivi e commerciali
tra i maggiori paesi industrializzati.
La cultura economica e finanziaria delle autorità americane e inglesi che gestirono i
negoziati e determinarono le specifiche del sistema monetario internazionale del secondo
dopoguerra – guidate da un lato da Harry D. White e dall’altro da John M. Keynes, che
furono anche gli estensori dei due piani su cui si fondarono le trattative – era
profondamente influenzata dalle vicende che avevano caratterizzato gli anni tra le due
guerre mondiali, con particolare riferimento all’esperienza degli anni Trenta. La
percezione degli errori commessi nel periodo precedente al 1939 portò alla
consapevolezza di dover costruire un edificio internazionale che garantisse stabilità nei
tassi di cambio, pieno impiego all’interno delle economie nazionali e cooperazione
internazionale. Gli errori commessi nel periodo tra le due guerre, che avevano impedito
15
la crescita economica internazionale, erano riconducibili ad una triade di elementi: il gold
exchange standard; i tassi di cambio variabili e le svalutazioni competitive; infine, il ruolo
dello Stato nell’economia.
Il gold standard, nella nuova forma che esso aveva preso a partire dalla conferenza di
Genova, era durato, di fatto, solamente sei anni, a partire dal ritorno alla parità aurea
della sterlina nel 1925 fino alla sospensione della medesima nel 1931. Esso era giudicato
adesso come un sistema obsoleto: un meccanismo farraginoso perché troppo rigido e
non adatto a sostenere la nuova organizzazione economica e produttiva mondiale.
Soprattutto, come si è visto, il gold exchange standard permetteva un’allocazione
asimmetrica delle riserve auree: gli Stati Uniti e la Francia, da soli, avevano accumulato
nel 1924 il 53% dell’oro mondiale, mentre la continua fuoriuscita di oro dalla Gran
Bretagna aveva costretto quest’ultima, per poter rimanere in regime di parità, a contrarre
la propria offerta monetaria. La libera fluttuazione dei cambi secondo le forze di offerta e
domanda si era dimostrata altrettanto decisiva nell’instabilità economica mondiale degli
anni Trenta, permettendo il perseguimento di politiche monetarie definite di beggar-thyneighbour, mirate quindi ad ottenere un vantaggio competitivo mediante svalutazioni
competitive, come ad esempio quella serie inaugurata dalla svalutazione della sterlina nel
1931. I cambi fluttuanti, inoltre, lasciavano un ampio spazio ai flussi di capitali
speculativi, che si muovevano tra le valute al solo scopo di trarne un vantaggio, appunto,
speculativo, come insegnava la vicenda del franco nel periodo 1922-1926.
L’ultimo elemento, la concezione del ruolo dello Stato, dipendeva molto dalle teorie
keynesiane, ora in fase di piena affermazione, e dall’esperienza bellica, che nuovamente,
come nella Prima guerra mondiale, funzionò quasi come esempio virtuoso di gestione
finanziaria. Si postulava così, a Bretton Woods, il passaggio dell’intervento statale da un
piano microeconomico ad un piano macroeconomico, con notevoli conseguenze sulla
politica monetaria e soprattutto sul ruolo delle banche centrali all’interno di un
complesso sistema politico di gestione dell’attività economica. Se in precedenza, in
funzione del gold standard e poi nella speranza di un suo ripristino, la banca centrale aveva
svolto il ruolo centrale di operatore di una politica monetaria che doveva essere
indipendente al potere politico centrale, ora, dato che la stessa politica monetaria si
inseriva in un quadro più ampio di iniziative nel quale, ad esempio, la parte maggiore
veniva svolta dalla politica fiscale, anche la banca centrale si trovava in una posizione di
comprimaria, subordinata al resto delle scelte di politica economica del governo.
In questo modo, seguendo un trend in corso fin dagli anni Trenta e che prosegue
negli anni post-bellici, si va incontro ad un’ampia nazionalizzazione degli istituti bancari
centrali: tra il 1936 e il 1945 vengono nazionalizzate le banche centrali di Danimarca,
Canada e Nuova Zelanda; dopo la conclusione della guerra, è il turno dei maggiori paesi
industrializzati, come la Francia, la Germania, il Regno Unito e i Paesi Bassi. Le uniche
banche a non essere nazionalizzate tra i paesi più importanti furono la Fed americana e la
Banca d’Italia, anche se entrambe nei loro statuti, incorporavano già forti elementi di
indirizzo nel perseguimento del benessere collettivo: la Fed aveva ricevuto questo
indirizzo fin dalla sua fondazione nel 1913, mentre la Banca d’Italia si era vista rafforzare
le caratteristiche di istituto con finalità di interesse pubblico con la legge bancaria del
1936, che, senza alterare l’assetto proprietario, aveva trasformato l’istituto in un ente di
diritto pubblico con divieto di avere rapporti creditizi con una clientela non bancaria.
Questo processo di nazionalizzazione delle banche si inseriva in un contesto di cultura
economica sorretto da una idea, largamente condivisa, secondo la quale la politica del
16
tasso di sconto, che era stata il principale strumento di politica monetaria della banche
centrali fino a tutta la Prima guerra mondiale, dispiegasse i propri effetti sulla domanda
aggregata con troppo ritardo. Assumendo un ruolo ancillare, quindi, gli istituti centrali
avevano il compito di mantenere i tassi ai livelli minimi in compatibilità con l’equilibrio
esterno, mentre sarebbe stata la politica fiscale a controllare l’andamento della domanda.
In questo contesto, anche gli strumenti a disposizione delle diverse banche centrali
stavano cambiando, seguendo un processo già in corso fin dagli anni Trenta che si
dispiegò poi pienamente nel secondo dopoguerra. Un breve salto indietro nel tempo
aiuta a comprender lo sviluppo dell’utilizzo dei banchieri centrali delle operazioni di
mercato aperto e, in seguito, della regolamentazione della riserva obbligatoria quali
strumenti volti al controllo della base monetaria.
Fin dall’inizio del Novecento le operazioni di sconto presso le banche centrali erano
andate esaurendosi, soprattutto in conseguenza del processo di concentrazioni bancaria
che aveva dato vita a grandi istituti strutturalmente liquidi, in grado di soddisfare le
esigenze della clientela senza ricorrere allo sconto delle cambiali presso la banca centrale.
Con la Prima guerra mondiale si affermò, poi, un nuovo strumento finanziario,
ampiamente utilizzato proprio per finanziare, come visto nel capitolo precedente, le
necessità belliche: il buono del Tesoro. L’abbondanza di questi titoli di Stato, che le
banche centrali erano state costrette ad acquistare per finanziare il conflitto, fecero si che
nel primo dopoguerra ci fu una certa sfiducia in operazioni di mercato aperto, nelle quali
gli istituti centrali vendevano e compravano titoli direttamente sul mercato, portando
all’inserimento negli statuti ad esempio della Reichsbank e della Banca di Francia del
divieto di effettuare tali operazioni.
Tuttavia, operazioni di mercato aperto furono sperimentate con successo dalla Fed
all’inizio degli anni Trenta con lo scopo primario di accrescere la liquidità di un sistema
bancario in grande difficoltà. Queste pratiche vennero adottate, nello stesso periodo,
anche dalla Banca d’Inghilterra e, su questi esempio, si verificò un’inversione di tendenza:
in questo senso i divieti ad intraprendere questo tipo di operazioni furono rimossi dai
regolamenti della Reichsbank nel 1933 e della Banca di Francia nel 1938, portando gli
acquisti e le vendite sul mercato aperto a diventare, già alla fine della Seconda guerra
mondiale, uno dei principali strumenti per controllare la liquidità dei sistemi bancari. Il
livello di riferimento adottato per calcolare la base monetaria, e quindi per regolare le
varie operazioni di compravendita sul mercato aperto da parte delle banche centrali, era il
livello delle riserve delle banche. Regolamentando con un’apposita normativa, inaugurata
nel 1933-1935 negli Stati Uniti e poi applicata anche in altri paesi, la riserva obbligatoria
delle banche, che doveva essere versata dalle medesime nelle casse della banca centrale,
questa diventava uno strumento di politica monetaria. Negli anni subito precedenti e
immediatamente successivi alla Seconda guerra mondiale, tali principi vennero recepiti
dalle normative bancarie di un gran numero di paesi: prima della guerra si affermarono in
Messico, Svezia, Austrialia, Nuova Zelanda, Ecuador e Costa Rica; in Italia essa venne
introdotta da Luigi Einaudi nel 1947, mentre nel Regno Unito, tradizionalmente
refrattario ad una regolamentazione scritto, il nuovo strumento fu applicato con un tipico
comunicato della Banca d’Inghilterra che annunciava un accordo interbancario in
materia.
In questo modo le banche centrale nazionalizzate venivano inserite, con nuovi
meccanismi d’intervento, all’interno di una pletora di strumenti economici e monetari
nelle mani delle autorità politiche. Veniva istituzionalizzato, nel secondo dopoguerra, uno
dei concetti chiave del nascente sistema di Bretton Woods: l’indipendenza della
17
conduzione della politica economica nazionale, con il fine ultime di perseguire la crescita
economica e il pieno impiego, in un quadro di cooperazione monetaria basato su una
regolamentazione internazionale. Questa regolamentazione fu il frutto, come accennato,
di un negoziato tra i due principali paesi usciti vincitori dalla guerra: gli Stati Uniti, ormai
esplicitamente la maggiore potenza industriale del mondo, e il Regno Unito.
Una asimmetrica mediazione tra i due progetti presentati da Keynes, in
rappresentanza britannica, e da White per gli americani, che tendeva comunque a favorire
la visione degli Stati Uniti, presero una prima forma nel Joint Statement by Experts on the
Establishment of an International Monetary Fund, che divenne la bozza di lavoro principale per
la stesura degli Articles of Agreement of the International Monetary Fund siglati il 22 luglio del
1944. Due erano le nuove istituzioni che venivano fondate: il Fondo Monetario
Internazionale e la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, nota in
seguito come Banca Mondiale. Gli obiettivi principali del Fondo, come dichiarato
dall’Articolo I (Purposes), dovevano essere: la promozione della cooperazione monetaria
internazionale; la facilitazione della crescita economica e del raggiungimento del pieno
impiego, nel rispetto dell’autonomia macroeconomica dei paesi aderenti; il mantenimento
di tassi di cambio stabili al fine di evitare svalutazioni competitive, che avrebbero
depresso il commercio internazionale; la creazione di un sistema di pagamenti
multilaterali e la rimozione di barriere doganali o flussi di commercio discrezionali.
Se i piani di Keynes e White prevedevano, da una parte, il ripristino di un sistema di
cambi variabili e, dall’altra, la costruzione di una struttura a cambi fissi, l’accordo che
venne raggiunto fu quello di un sistema di cambi fissi all’interno del quale venivano però
previsti degli aggiustamenti anche sostanziali. Il riferimento monetario internazionale
diveniva il dollaro, la moneta del paese vincitore e della maggiore economia mondiale,
unica valuta convertibile in oro alla parità in vigore il 1 luglio del 1944, ovvero di 35
dollari per oncia, il valore, cioè, a cui era stato ancorato il dollaro nel 1934. L’articolo IV
degli accordi di Bretton Woods (Obligations Regarding Exchange Arrangements) prevedeva
che, su questa base di riferimento, le altre valute avrebbero dovuto dichiarare il proprio
tasso di cambio con il dollaro e mantenerlo nel corso del tempo con un margine di
variazione dell’1% al di sopra o al di sotto del livello stabilito.
Tuttavia, gli accordi prevedevano un ampio margine di manovra per le autorità
monetarie dei vari paesi aderenti, in quanto si concedeva, come dettato dall’Articolo XX
(Final Provisions), la facoltà di cambiare la parità stabilita fino al 10% del valore originale in
caso di squilibrio fondamentale della bilancia dei pagamenti. Tale modifica poteva essere
applicata senza ricorrere all’approvazione diretta da parte del Fondo, che sarebbe stata
invece decisiva nell’approvare modifiche maggiori del 10%. Se, quindi, all’apparenza
Bretton Woods sembra essere un sistema di cambi fissi tra le valute aderenti, esso
nasconde invece degli accordi secondo i quali le valute potevano, come detto, fluttuare,
portando l’architettura monetaria decisa nel 1944 ad assomigliare più ad una griglia di
cambi fissi aggiustabili pensati per divenire un momento di coordinamento delle future
fluttuazioni valutarie. Inoltre, è interessante sottolineare come in tutti i trentuno articoli
che componevano gli accordi d’istituzione del Fondo Monetario Internazionale non vi
era mai specificato cosa gli estensori del piano intendessero per «squilibrio
fondamentale»; anzi, come ricordato in seguito dallo stesso White, vi fu un generale
accordo circa l’impossibilità di enunciare una definizione soddisfacente di tale dicitura. La
mancata definizione dei parametri che avrebbero consentito una svalutazione valutaria
rispondeva alla necessità di non fissare delle rigidità che avrebbero poi ristretto i margini
18
di manovra delle autorità monetarie nazionali in caso di necessità di modifiche delle
parità valutarie pattuite.
Un altro tassello, quindi, andava a costruire l’edificio di Bretton Woods come struttura
di regolamentazione sovranazionale di autonomie nazionali. Contemporaneamente, un
ulteriore elemento veniva introdotto al fine di segmentare maggiormente le economie
nazionali: partendo dal presupposto che le autonomie politiche dei paesi membri non
sarebbero potute risultare efficaci se si fosse lasciato libero corso alla mobilità
internazionale dei capitali e alle conseguenti azioni speculative destabilizzanti, vennero
attribuiti controlli sulle transazioni valutarie, come prescritto dall’Articolo IV.3
(Surveillance Over Exchange Arrangements). Vale la pena ricordare che se prima della crisi del
1929 e della conseguente Grande depressione tali controlli sarebbero stati considerati una
violazione delle regole fondamentali del gioco economico, sull’esperienza degli anni
Trenti tali controlli diventarono la regola, formalizzata, appunto, dalla conferenza di
Bretton Woods.
Quello che venne disegnato fu quindi un assetto monetario in cui l’ammontare del
circolante delle diverse valute, ad eccezione del dollaro, non avrebbe più dovuto essere
determinato dalla quantità di oro posseduta. Per quanto il secondo dopoguerra sia stato il
periodo di maggior sviluppo e benessere economico mai registrato dalle economie
occidentali, va sottolineato che tale successo non può essere attribuito all’ordine
monetario deciso a Bretton Woods per il semplice motivo che il sistema che prese forma
nel periodo successivo fu ben diverso da quello immaginato dagli architetti inglesi e
americani nel luglio del 1944.
Il sistema di Bretton Woods era stato originariamente costruito per essere la cornice
normativa sovranazionale all’interno della quale si sarebbe sviluppato un nuovo sistema
di commercio internazionale multilaterale. Al termine del conflitto, tuttavia, il ripristino
dei flussi commerciali era fortemente limitato dalle drammatiche condizioni in cui
versava gran parte del continente europeo e dell’Asia: intere regioni furono spopolate e
devastate; oltre diciassettemila città e settantamila villaggi furono distrutto, del tutto o
parzialmente, insieme a ponti, strade, linee ferroviarie, ospedali, biblioteche, scuole e
ovviamente fabbriche e aziende agricole. La stessa spina dorsale produttiva di molti paesi
era quindi in ginocchio. Questa situazione, insieme alla quasi completa autosufficienza
statunitense, portava all’impossibilità di ripristinare nell’immediato quel commercio
internazionale che si reputava vitale per la crescita economica mondiale: impossibilitati a
produrre merci competitive sul mercato internazionale e bisognosi di ogni genere di
prodotto, i paesi europei sperimentavano un deficit in quel momento strutturale della
bilancia commerciale che non permetteva un rapido ripristino delle parità tra le valute o
la sospensione dei controlli sul commercio: queste restrizioni, infatti, sarebbero potute
essere abolite senza creare ulteriore deficit, o senza portare ad una svalutazione
monetaria, solamente se fosse stata ridotta la spesa interna dei paesi. Politicamente,
questo sarebbe stato un peso non facilmente sostenibile.
L’immediata fornitura di aiuti alle popolazioni e ai governi degli stati europei venne
gestita dall’Ambasciata americana di Londra in cooperazione con i dipartimenti
governativi britannici. Nella visione americana, che permeò poi l’azione delle Nazioni
Unite, si doveva seguire un percorso per tappe, che avrebbe portato prima al
soddisfacimento dei bisogni primari delle popolazioni, con cibo e vestiario; poi alla
riabilitazione di medio periodo, con la ricostituzione degli stock prodotti primari; infine
alla ricostruzione industriale vera e propria. Con queste idee era stata fondata il 9
19
novembre del 1943 la United Nations Relief and Rehabilitation Administration, che aveva
precisamente il compito di gestire i primi aiuti ai territori liberati. La prima tranche
consisteva in beni del valore complessivo di 2,6 miliardi di dollari. Di tale cifra, il 72% era
fornito dagli Stati Uniti, il 12% dal Regno Unito, il 6% dal Canada, il 2% dall’Unione
Sovietica e il resto da altri paesi. Nell’agosto del 1945 venne concordata una seconda
tranche di aiuti. Il Canada si ritirò e la sua quota, pari al 6%, venne assunta dagli Stati
Uniti, che stipularono un patto unico con tutti i paesi europei, sperimentando per la
prima volta un sistema che sarebbe stato poi ripetuto e implementato con il Piano
Marshall.
Gli sviluppi e le dinamiche che presero vita tra il 1946 e il 1947 resero evidente come
il sistema immaginato un paio di anni prima a Bretton Woods avrebbe avuto una lenta
applicazione, e soprattutto sarebbe stato attuato con deviazioni sostanziali da quanto
stabilito nel luglio del 1944. A questo processo contribuirono alcuni problemi
strettamente connessi tra loro: la permanenza di accordi commerciali bilaterali e il lento e
sostanzialmente deludente progresso di accordi commerciali multilaterali; la permanenza
dei controlli sul commercio e sui cambi, ai quali i paesi europei erano praticamente
obbligati dalla disastrosa condizione post-bellica; infine, la scarsità di dollari in Europa.
Alla fine della Seconda guerra mondiale gli Stati Uniti erano il paese con la produzione
industriale maggiore al mondo. Alla fine degli anni Quaranta, ad esempio, le aziende
statunitensi producevano quasi il 50% dei beni manifatturieri mondiali e la produzione
industriale registrata nel 1947 era superiore a quella di dieci anni prima del 42%. D’altro
canto i paesi dell’Europa continentale e dell’Asia, che avevano subito enormi distruzioni
durante la guerra, non erano in grado di pagare le importazioni necessarie di beni, né
quelli di prima necessità, né quelli necessari alla ripresa industriale. Nel 1947, i paesi
europei nei quali si concentravano le aree distrutte dal conflitto, importarono merci per
un ammontare di 20,2 miliardi di dollari, mentre le esportazioni e le altre entrate correnti
furono pari a 13,1 miliardi di dollari, determinando un deficit della bilancia dei pagamenti
di 7,1 miliardi di dollari e portando alla scarsità di dollari.
In questo contesto caotico vennero inaugurati i progetti tendenti alla liberalizzazione
commerciale proprio con l’idea di risolvere le strozzature esistenti mediante un
coordinamento della riduzione delle tariffe. Questi progetti andarono incontro ad un
sostanziale fallimento ma, sorprendentemente, finirono per dar vita ad un accordo, il
GATT, che, sebbene lontana da quella immaginata e con regole a volte anche
macroscopicamente violate dai partecipanti, ebbe un notevole successo sul lungo
periodo. Già nel dicembre del 1945, gli Stati Uniti resero noto un piano per istituire
un’organizzazione internazionale del commercio, la International Trade Organization
(ITO), invitando gli altri paesi, compresa l’Unione Sovietica, a unirsi ai negoziati che
sarebbero iniziati con un primo incontro nell’ottobre del 1946 a Londra, per discutere la
stesura di una carta del commercio internazionale sulla base di un lavoro preparatorio di
un comitato internazionale sorto nel febbraio dello stesso anno. I negoziati proseguirono
per tutto il 1947 ed infine, a marzo del 1948 durante la conferenza dell’Avana, venne
stilata la cosiddetta Carta dell’Avana, ovvero il Final Act of the United Nations Conference on
Trade and Employment.
L’ITO, però, non entrò mai in funzione in quanto non venne mai ratificato dal
Congresso americano, anche per via delle forti pressioni britanniche che riuscirono a far
inserire nel trattato l’adozione in una molteplicità di circostanze di discriminazioni
commerciali e restrizioni quantitativa. Il fallimento dell’ITO è anche legato al successo
20
ottenuto dalla prima sessione del General Agreement on Tariffs and Trade, che si era tenuta a
Ginevra nell’aprile del 1947. Fondato su due principi fondamentali – un approccio
multilaterale e non discriminatorio e la condanna di restrizioni quantitative al commercio,
il GATT venne ratificato da 23 paesi nell’ottobre del 1947, che diedero vita, dopo il
primo round di negoziati, a 123 accordi su 45.000 voci daziarie, che rappresentavano
all’incirca la metà del commercio mondiale. Nonostante persistessero differenze di
prospettive tra americani e britannici, che si ripeterono durante i successivi round, il
sistema proseguì, come proseguirono le preferenze commerciali del Commonwealth
perseguite dal Regno Unito.
Nello stesso periodo di tempo, un altro evento si accompagnò alle vicende dei trattati
commerciali del GATT, finendo per dare linfa vitale all’inaugurazione del Piano Marshall,
senza il quale la ripresa della produttività industriale europea, e quindi i relativi flussi
commerciali internazionali, sarebbe stata difficile. Fu, infatti, il ritorno alla convertibilità
della sterlina nell’estate del 1947 – convertibilità subito sospesa dopo poco più di un
mese – che rese evidente le reali difficoltà della ripresa industriale europea e le necessarie
azioni da intraprendere.
All’interno dell’accordo anglo-americano American Loan Agreement, siglato il 15 luglio
1946 per rimpiazzare il Lend-Lease, conclusosi il 2 settembre del 1945, il Regno Unito
aveva accettato, in cambio di prestito americano pari a 3,85 miliardi di dollari, di tornare
alla convertibilità della sterlina entro un anno. Questo percorso era coerente con quanto
stabilito a Bretton Woods nell’ottica di un rapido ripristino di un sistema commerciale
internazionale funzionale all’egemonia americana, che prevedeva, oltre il ritorno alla
convertibilità, la fine delle preferenze commerciali imperiali del Regno Unito con i paesi
del Commonwealth. La convertibilità della sterlina, scambiata con 4,03 dollari, fu così
ripristinata precisamente il 15 luglio del 1947. Le settimane di convertibilità furono un
vero e proprio disastro finanziario: la Banca d’Inghilterra vide diminuire molto
rapidamente le proprie riserve – si calcola che perse un miliardo di dollari nel giro di
appena un mese – e fu costretta a sospendere la convertibilità già il 20 agosto.
Gli Stati Uniti ottennero così, da una parte, l’indebolimento dell’uso della sterlina
quale valuta di riserva internazionale, il cui prestigio minava i progetti dell’egemonia del
dollaro; e dall’altra, una minor pressione sulla domanda internazionale di valuta
statunitense. Quest’ultima condizione, favorendo, insieme al contemporaneo Piano
Marshall, un rilancio dell’attività produttiva europea, gettò le basi per la creazione di
quella domanda di beni che sarebbe poi stata soddisfatta dal settore industriale americano
negli anni successivi.
Il problema della scarsità di dollari si manifestò nel biennio immediatamente
successivo alla conclusione della guerra. Già agli inizi del 1947 un Comitato di
coordinamento inter-ministeriale di alti funzionari statunitensi degli Esteri, della Marina e
della Guerra avvisarono il governo che le esportazioni statunitensi del biennio 1946-1947
sarebbero potuto essere assorbite dal resto del mondo solamente per altri 12 o 18 mesi. Il
credito internazionale era infatti molto limitato, il programma di aiuti dell’UNRRA stava
per concludersi e le riserve di valuta estera dei paesi importatori si stavano per esaurire.
Conseguenza di tale situazione internazionale, avvisava il medesimo comitato, avrebbe
portato ad un declino delle esportazioni americane con conseguenze decisamente
negative in termini di attività industriale e occupazione interna. La soluzione che veniva
immaginata dai funzionari americani era l’embrione di quello che sarebbe diventato il
21
Piano Marshall, cioè un massiccio programma di aiuti diretti a finanziarie la crescita
europea e, di conseguenza, il flusso delle esportazioni.
Su queste linee programmatiche si basava il discorso tenuto da George Marshall,
segretario di Stato statunitense, il 15 giugno del 1947 all’università di Harvard. Occorre
sottolineare come le raccomandazioni del comitato inter-ministeriale e lo stesso discorso
di Harvard precedono la crisi della sterlina dell’estate di quello stesso 1947. Eppure, va
parimenti evidenziato come l’iter dei negoziati internazionali con i partner europei che
portarono all’approvazione del Piano Marshall iniziò solamente dopo quella disastrosa
esperienza, che suggerì alle autorità statunitensi che era impossibile immaginare un
mondo di commerci liberalizzati senza prima offrire un programma di aiuti finanziari
indirizzato a far riprendere l’attività industriale europea.
Dopo la proposta statunitense, i partner europei – ad esclusione del blocco dell’est
che venne ancorato all’Unione Sovietica, che aveva rifiutato gli aiuti statunitensi – si
riunirono così in due conferenze per delineare la futura cooperazione economica europea
nella gestione dei fondi americani: una prima bozza di lavoro venne stilata nel corso della
prima di tali conferenze, tenutasi a Parigi nel luglio del 1947. Preparato dalla
formulazione della cosiddetta dottrina Truman in funzione anti-sovietica, in un nascente
clima di guerra fredda, l’Economic Cooperation Act fu approvato dal Congresso
americano il 17 marzo del 1948, dando il via allo European Recovery Plan (ERP).
Contestualmente dall’altra parte dell’Atlantico, al termine della seconda riunione dei
partner europei nasceva, il 16 aprile del 1948, l’Organizzazione Europea di Cooperazione
Economica (OECE), incaricata di gestire i 13.159 milioni di dollari che l’ERP mise a
disposizione dell’Europa tra il 1948 e il 1952.
Questa somma venne suddivisa tra i vari paesi europei in modo diseguale: il Regno
Unito fu il paese maggiormente finanziato, ricevendo 3,176 milioni di dollari, seguito
dalla Francia con 2.706, l’Italia con 1.474 e la Germania occidentale, che ricevette 1.389
milioni di dollari. L’allocazione dei fondi dimostra come la paura anti-comunista, se fu
essenziale per la ratifica del piano di aiuti dal Congresso, non lo fu nello stesso modo
nell’ispirare le forme della messa in atto del Piano Marshall: il Regno Unito, ad esempio,
il paese più finanziato, non correva alcun pericolo di vedere arrivare un partito comunista
al potere. La logica che guidava i finanziamenti sembrava, più che altro, corrispondere al
volume del commercio estero nazionale, andando a finanziarie maggiormente quei paesi
che importavano una quota maggiore delle esportazioni statunitensi.
L’efficacia del Piano Marshall fu principalmente quella di risolvere l’impossibilità di
importare delle economia europee che, una volta rimosso tale ostacolo, furono in grado
di riequilibrare il rapporto tra domande potenziali e offerta aggregata, portando ad una
rapida crescita. È stato calcolato che, al 1952, la produzione industriale dei paesi
dell’OECE era stata del 39%, mentre le esportazioni erano cresciute del 200% e le
importazioni di più del 30%.
La carenza di dollari non fu eliminata ma venne significativamente moderata. Tuttavia,
nell’immediato, le speranze in una rapida ripresa del commercio internazionale vennero
frenate dalla breve recessione economica statunitense del biennio 1948-1949, che
provocò una diminuzione delle importazioni americane dall’Europa, portando ad
aumentare la carenza di dollari nel vecchio continente. I paesi più colpiti furono quelli
dell’area del Commonwealth, ma non il Regno Unito, in quanto tra quei paesi vi erano i
maggiori produttori delle materie prime necessarie all’industria americana: le importazioni
22
statunitensi calarono del 50% nel primo e nel terzo trimestre del 1949, mettendo in crisi
le economie di quei paesi e, di concerto, anche il Regno Unito. Il deflusso di oro inglese
fu molto rapido, tanto che tra luglio e settembre 1949 vennero persi 300 milioni di dollari
in oro, finché la Banca d’Inghilterra fu costretta, il 18 settembre, a svalutare la sterlina.
Entro una settimana altri 23 paesi svalutarono le proprie valute e altri sette nel periodo
successivo, mentre le sole valute che rimasero ancorate alle proprie parità furono il
dollaro statunitense, il franco svizzero, lo yen giapponese e qualche moneta dei paesi
latino-americani e dell’Europa dell’Est.
Le svalutazioni, insieme all’esaurirsi della crisi americana alla fine del 1949 e lo
scoppio della guerra di Corea nel 1950, ebbero gli effetti desiderati dalle autorità
monetarie, tanto che le riserve auree del Regno Unito triplicarono nei due anni
successivi, portando ad un miglioramento della posizione anche di numerosi altri paesi.
Tuttavia queste esperienze facevano crescere la necessità di immaginare qualche
istituzione monetaria regionale europea, che affiancasse il Fondo Monetario
Internazionale nella gestione dei pagamenti intra-europei. Dalla dichiarazione della parità
ufficiale del dicembre del 1946 furono infatti necessari dodici anni per costruire un
sistema finanziario, in cui lo scambio di flussi e stock avvenisse in modo efficace: l’esito
fu la convertibilità tra le valute europee del 1958.
L’obiettivo di addivenire a tale scenario era condiviso anche dall’amministrazione
americana dell’ERP, soprattutto per via degli effetti positivi che l’integrazione finanziaria
e la conseguente crescita europea avrebbero avuto per le esportazioni statunitensi. Vi fu,
quindi, un impegno positivo nello stimolare una progressiva cooperazione tra le
economie dei paesi europei, marcando un decisivo cambiamento di atteggiamento
rispetto al primo dopoguerra.
Lo strumento principale per formalizzare di questo disegno fu l’Unione Europea dei
Pagamenti (UEP), istituita il 19 settembre del 1950 dai paesi dell’OECE con sede a
Basilea, con un iniziale programma di funzionamento della durata di due anni,
rinnovabile annualmente, che venne esteso fino alla fine del 1958. Gli Stati Uniti
giocarono un ruolo essenziale nella costruzione di questo strumento, versando il capitale
iniziale per una cifra pari a 350 milioni di dollari. Il funzionamento della UEP era
abbastanza semplice, funzionando come una sorta di stanza di compensazione
continentale: alla fine di ogni mese ogni paese membro avrebbe sistema la sua posizione
circa i debiti e crediti con l’Unione nel suo complesso, che sarebbero poi stati saldati in
dollari, oro o ulteriori aperture creditizie.
Contestualmente, i paesi dell’OECE approvarono anche, nel giugno del 1950, un
Codice di liberalizzazioni che all’Articolo II prevedeva la riduzione delle barriere tariffarie
del 60% entro ottobre del 1950 e del 75% entro febbraio del 1951. Seppur con risultati
diversi a seconda dei paesi, non si può negare che il successo della UEP e del connesso
Codice di liberalizzazioni fu importante. In media, infatti, i paesi dell’OECE
liberalizzarono il commercio per il 67% delle merci, con i seguenti dati riferiti ai singoli
paesi più importanti: il Regno Unito faceva registrare la percentuale più alta, con l’86%
della liberalizzazione; seguiva l’Italia con il 76%, la Francia e i Paesi Bassi con il 66%, il
Belgio e il Lussemburgo con il 64% ed infine la Germania con il 63%.
È interessante osservare come l’Unione Europea dei Pagamenti e il Codice di
liberalizzazioni del 1950, se da una parte rappresentano un’applicazione regionale dei
principi espressi da Bretton Woods, dall’altra raffigurano anche la sostanziale distanza
23
che lo scenario internazionale prese giù a partire dalla fine degli anni Quaranta dal
modello disegnato dagli anglo-americani nel luglio del 1944. La liberalizzazione dei
commerci con l’eliminazione delle barriere tariffarie, insieme alla creazione di un sistema
di pagamenti multilaterale, costituivano infatti il cuore degli Articles of Agreements di
Bretton Woods e, paradossalmente, trovarono la propria piena attuazione in un sistema
integrato a livello macro-regionale europeo, che dal 1950 in poi rimosse
progressivamente gran parte degli ostacoli al commercio intra-europeo. Tali accordi nati
in seno all’UEP con il decisivo sostegno iniziale degli Stati Uniti apparivano però in
pieno contrasto con lo stesso Bretton Woods, segnando un sostanziale allontanamento
dallo stesso. Ammettendo la nascita di un mercato integrato europeo, e quindi
implicitamente di pratiche commerciali discriminatorie in antitesi sia con Bretton Woods
che con il GATT, gli Stati Uniti abbandonavano la propria idea di creazione di un
sistema di scambi liberalizzati su scala mondiale al fine di sostenere la crescita economica
dei paesi che avevano la quota maggiore di assorbimento delle esportazioni americane,
ovvero i paesi dell’OECE.
Anche la formazione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), nata
nel 1951 in seguito ad un percorso che iniziò con un discorso del ministro degli esteri
francese Robert Schuman del maggio del 1950, veniva alla luce sotto l’egida degli Stati
Uniti ma in palese violazione dei principi di non discriminazione e delle norme del
GATT. La CECA aveva come obiettivo principale l’integrazione dell’intera produzione
franco-tedesca del carbone e dell’acciaio, ponendola sotto l’autorità di un’organizzazione
alla quale partecipavano anche gli altri paesi europei, includendo così anche i paesi del
Benelux e l’Italia.
Il mutamento negli indirizzi di politica economica internazionale degli Stati Uniti e dei
paesi dell’Europa occidentale sembra, quindi, essere stato decisamente influenzato dalle
crisi del periodo 1947-1949, che fecero emergere chiaramente l’impossibilità di affrontare
le difficoltà della ricostruzione e della crescita economica europea in un mondo
completamente liberalizzato. Nello stesso periodo, con il rifiuto del Piano Marshall da
parte dell’Unione Sovietica e l’inizio della Guerra fredda, anche motivi politici
intervennero nel cementare quell’interesse statunitense a guardare con interesse maggiore
alla crescita europea che al modello monetario e commerciale internazionale immaginato
a Bretton Woods: la discriminazione commerciale diventava così strumentale, sia da un
punto di vista economico che da un punto di vista politico, per il conseguimento
dell’egemonia statunitense.
L’organizzazione internazionale della finanza e del commercio che cominciò ad
emergere agli inizi degli anni Cinquanta fu, comunque, essenziale nel fornire una struttura
di sostegno alla ripresa della crescita economica mondiale, dando sostanzialmente luogo
ad un mondo che, alla metà degli anni Cinquanta, quando i presupposti per il ritorno alla
convertibilità tra le valute erano stati raggiunti, era diviso in due aree separati da controlli
sui cambi: un’area che si fondava sull’Unione Europea dei Pagamenti, che includeva
anche l’area della sterlina; e un’altra area basata sul dollaro. Gli Stati Uniti, dal canto loro,
ammisero uno strutturale deficit della propria bilancia dei pagamenti, attraverso il quale
venne alimentata la crescita della liquidità internazionale e la crescita delle economie
europee.
Le aree non industrializzate del mondo beneficiarono, per tutto il periodo, di aiuti
statali di altri paesi che divennero, alla fine degli anni Quaranta, una fonte di
approvvigionamento di capitali necessaria per far fronte ai pagamenti internazionali. Tra
24
il 1953 e il 1957 i paesi meno sviluppati ricevettero 2.000 milioni di dollari all’anno di
prestiti ufficiali, elargiti sia dai vari Stati che dalla Banca mondiale. Quest’ultima era restia
al finanziamento di strutture per l’istruzione e la sanità, in quanto esse fornivano un
apporto all’aumento della produzione difficilmente quantificabile, e si concentrava invece
sul finanziamento di impianti elettrici, ferrovie e reti stradali. I paesi non industrializzati,
dipendenti dai paesi avanzati per l’importazione di capitali, lo furono anche per le loro
esportazioni: in più, venendo a mancare l’applicazione pratica dei principi di non
discriminazione che erano stati affermati a Bretton Woods e con il GATT, sia la finanza
che il commercio si distribuirono fortemente tra i paesi in base alle aree alle quali essi si
legavano: i paesi che facevano parte, ad esempio, dell’area della sterlina e ai territori
dell’Europa occidentale, insieme a Cuba, videro un aumento delle proprie esportazioni
del 227% nel periodo 1928-1955, mentre i paesi che non avevano tali legami
internazionali videro aumentare, negli stessi anni, le loro esportazioni solo della metà di
quella percentuale.
Il sistema di Bretton Woods, diverso in numerosi aspetti da quello ideato dai suoi
architetti, entrò infine pienamente in vigore il 31 dicembre del 1958, quando tredici paesi
dell’Europa occidentale ripristinarono la convertibilità delle proprie valute, grazie
soprattutto al costante disavanzo nella bilancia dei pagamenti statunitense che aveva
permesso una redistribuzione delle risorse verso il resto del mondo. Se, infatti, nel 1948
gli Stati Uniti possedevano più del 60% delle risorse monetarie globali, nel 1958 questa
percentuale era calata a meno del 50%. L’FMI ufficializzò poi, nel 1961, la nuova
situazione di convertibilità monetaria aggiornando l’elenco delle nazioni che
soddisfacevano i criteri dell’articolo VIII degli accordi.
4. Apogeo e crisi dell’egemonia americana
Nel periodo che va dalla fine della guerra di Corea alle crisi petrolifere degli anni
Settanta, che come perno centrale nella storia finanziaria mondiale il ripristino delle parità
valutarie del 1958, si verificò una fase di espansione economica su scala mondiale, che
coinvolse, contemporaneamente, un gran numero di paesi. Se da una parte i governi
applicavano politiche economiche miranti a sostenere la domanda aggregata, dall’altra il
GATT divenne centrale nel processo di abbassamento delle barriere doganali che
liberalizzarono lo scambio di manufatti tra i paesi industrializzati e anche quello delle
materie prime. I flussi commerciali e finanziari subirono gli effetti delle scelte di politica
economica sia dei paesi industrializzati, che diventarono il centro del sistema grazie alla
loro capacità di innovazione tecnologica e di esportazione dei capitali, e i paesi in via di
sviluppo, che si costituirono come periferia del sistema, esportatrice di materie prime e
importatrice di capitali. In questo modo, l’offerta si compone attraverso i fattori delle
materie prima, da parte dei paesi in via di sviluppo, e del fattore dell’innovazione
tecnologica, sviluppato dai paesi industriale; la domanda, invece, è sostenuta dalla crescita
del reddito disponibile nei paesi industrializzati promosso attraverso politiche monetarie.
4.1. Il centro del sistema: i paesi industrializzati
Gli investimenti tecnologici che avevano come obiettivo l’innovazione di prodotto e
di lavorazione furono uno dei tratti distintivi dei paesi industrializzati in questo periodo.
Non c’è da stupirsi se i paesi più ricchi erano anche i paesi con il più alto livello di
progresso tecnico del periodo. Tra questi, gli Stati Uniti primeggiavano senza rivali,
25
fondando questa leadership su un più alto rapporto tra Pil e spese per ricerca e sviluppo;
al secondo posto, gli americani erano seguiti dalla Gran Bretagna e, poi, dalla Germania
dell’ovest. È stato rilevato che su cento delle maggiori innovazioni tecnologiche
introdotte nel periodo 1945-1970, infatti, sessanta furono sviluppate da aziende
americane, quattordici dai britannici e undici da imprese tedesche.
Più della metà degli investimenti in ricerca dei paesi dell’OCSE e degli Stati Uniti
erano destinati a finanziari gli sviluppi tecnologici del settore industriale, mentre quasi i
tre quarti degli investimenti privati si concentravano nei settori dell’elettronica, della
chimica, dell’elettricità e dei mezzi di trasporto. I medesimi settori erano anche le aree in
cui si concentrava la spesa pubblica, con l’aggiunta del settore aereospaziale.
I settori industriali nei quali si concentrarono maggiormente gli investimenti, pubblici
o privati che fossero, furono anche i settori che registrarono la maggiore crescita
economica. Tuttavia, ne furono avvantaggiati anche i settori che dipendevano, per le
materie prima e i macchinari utilizzati, dalle aree produttive che si stavano sviluppando
con più rapidità. L’industria tessile, ad esempio, si trasformò nel corso degli anni Sessanta
in un settore ad alta intensità di capitale, in quanto la produzione dei nuovi macchinari
finiva per impiegare i progressi tecnologici raggiunti in altri settori produttivi, mettendo a
frutto gli studi sui materiali, la tecnologia delle fibre, l’idrodinamica, l’aerodinamica e, in
seguito, l’elettronica, che fece si che dal 1970 in poi le tecniche con controllo numerico
furono applicate nella produzione dei macchinari.
Lo sviluppo di nuove tecnologie applicate ai vari settori industriali, seppur con
epicentri nazionali caratterizzati dall’asimmetria segnalata in precedenza, si diffuse al di
fuori dei paesi innovatori molto rapidamente e in vari modi diversi. Un ruolo chiave in
questo senso venne giocato dalle grandi imprese multinazionali, che diffondevano gli
sviluppi tecnologici attraverso i rapporti tra le imprese principali e le loro filiali sparse in
diversi paesi del mondo. Un altro canale di trasferimento tecnologico tra paesi era
costituito dagli aiuti internazionali che i paesi sviluppati fornivano ai paesi meno
industrializzati, anche se l’adeguatezza della tecnologia in questi contesti era spesso
dubbia visti i costi, a volte eccessivi, per adeguare gli impianti e il sistema economico – si
pensi ad esempio all’abbondanza di manodopera o alla scarsità di capitali – dei paesi più
poveri. Ad esempio, in America latina, nel periodo compreso tra il 1939 e il 1973
l’utilizzo di tecnologie che utilizzavano il petrolio, in sostituzioni di tecniche che
comportavano un minor uso di energia o che erano basate su altre risorse d’energia
localmente disponibili, portò ad un aumento del 500% della domanda di petrolio: in
Brasile ed Argentina, durante gli anni Settanta, ad esempio, il 25% della valuta estera a
disposizione veniva utilizzato per l’acquisto di petrolio.
L’architettura mondiale degli scambi fu profondamente influenzata dal progresso
tecnologico post-bellico, che ebbe un notevole impatto nel modulare i flussi commerciali
sia con innovazioni di processo, che con innovazioni di prodotto: la prima derivante
dall’asimmetria nello sviluppo tecnologico tra paesi, che produceva vantaggi comparati
nello scambio di manufatti; la seconda derivante, invece, dalla crescente varietà di nuovi
prodotti.
In seguito alla guerra di Corea, per tre decadi l’area che registrò il maggior aumento
negli scambi commerciali fu quella dei paesi industrializzati, che scambiavano tra loro
principalmente prodotti di scala e meccanici, mentre importavano dai paesi in via di
sviluppo una grande percentuale di prodotti tessili standardizzati. In generale, la maggior
26
parte del commercio di manufatti tra paesi industrializzati si svolgeva nell’ambito di
settori industriali simili: più del 60% degli scambi nei dieci paesi che, da soli, fornivano il
58% delle esportazioni a livello mondiale, si svolgevano in ambito intra-settoriale. Questi
si dividevano in prodotti tra loro diversi ma perfettamente sostituibili, oppure nello
scambio di semilavorati e componenti tra varie filiali tra loro verticalmente integrate e
proprietà di una stessa società multinazionale. I paesi in via di sviluppo fornivano invece
quote importanti di esportazioni di prodotti standardizzati, in particolar modo nel campo
dell’abbigliamento.
Gli Stati Uniti, che nel periodo post-bellico avevano incrementato il loro vantaggio
tecnologico e, quindi, le capacità di innovazione, fondavano la propria industria su una
manodopera qualificata e sull’esportazione di prodotti che necessitavano di un alto livello
di ricerca e sviluppo, che erano anche meno soggetti alla sostituzione di beni
d’importazione. Il Giappone fu uno di quei paesi cosiddetti inseguitori, insieme alla
Germania, durante gli anni Cinquanta e Sessanta. Le spese per l’acquisto di brevetti e
licenze straniere, che toccarono quota 250 milioni di dollari nel 1969 a partire dai 20
milioni registrati nel 1955, consentirono al paese di ridurre gradualmente il gap
tecnologico con gli Stati Uniti. In questi decenni, la Germania raggiunse la Gran Bretagna
sul terreno delle esportazioni, essendo la competitività inglese decisamente in declino,
nonostante la svalutazione della sterlina nel 1967 ridiede un piccolo slancio alle industrie
inglesi, mentre l’Italia divenne uno tra i maggiori esportatori al mondo grazie al
miglioramento della competitività dell’industria nazionale.
Questa nuova struttura dei flussi commerciali fondò molto del suo successo sul
GATT, sebbene quest’ultimo venne sviluppato secondo direttive in parte diverse da
quelle con cui era sorto, permettendo ai paesi partecipanti di scegliere i prodotti e le voci
dove erano più disponibili a fare concessioni tariffarie. L’esempio più macroscopico fu
quello europeo. I sei paesi che avevano dato vita alla CECA, infatti, siglarono nel 1957 il
Trattato di Roma con il quale venne costituita la Comunità Economica Europea (CEE),
stabilendo le regole del mercato comune, tra le quali vi era l’adozione di una tariffa
comune da applicare negli scambi commerciali con gli altri paesi del mondo. Lasciata
fuori da questa iniziativa, la Gran Bretagna promosse come misura temporanea
l’Associazione Europea per il Libero Scambio (EFTA), che coinvolse i paesi rimasti fuori
dalla CEE.
Nel 1962, inoltre, l’amministrazione Kennedy promosse il Trade Expansion Act,
pensato per includere la Gran Bretagna nel mercato europeo attraverso importanti
riduzioni tariffarie unite alla completa eliminazione dei dazi in quei prodotti in cui Stati
Uniti e CEE detenevano più dell’80% delle esportazioni a livello mondiale. Anche se Da
Gaulle, attraverso il veto posto nel 1963, bloccò la richiesta di adesione della Gran
Bretagna, il successo dell’allargamento del libero mercato fu evidente: durante il
cosiddetto Kennedy Round, i dazi vennero ridotti dai paesi industrializzati del 70% sulle
rispettive importazioni, esclusi i cereali, la carne e i prodotti caseari.
Il generale abbassamento delle barriere doganali e l’aumento vertiginoso degli scambi
commerciali diedero il via anche ad un aumento dei flussi di capitali che, ricominciando a
crescere tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, provocarono un
rimescolamento nelle gerarchie internazionali, rappresentando un punto di svolta nelle
relazioni finanziarie internazionali e riportando in auge la City londinese. La rinascita di
Londra si fondò sull’uso di due nuovi elementi che, alla fine degli anni Cinquanta,
comparvero sui mercati mondiali: gli eurodollari e le eurobbligazioni.
27
È possibile rintracciare la genesi dei cosiddetti eurodollari agli inizi degli anni
Cinquanta quando crescenti quantità di dollari cominciarono a venire depositate presso
numerose banche europee, la maggior parte delle quali a Londra. L’origine di tali depositi
era varia. Da una parte essi provenivano dagli investimenti statunitensi, in particolar
modo quelli delle grandi multinazionali, dagli aiuti alle popolazioni civili e dalle spese per
il mantenimento delle truppe all’estero, a cui si aggiungeva però, con intensità crescente
con il passare degli anni, il deficit della bilancia di pagamento statunitense. Un’altra
ragione che stimolò la nascita degli eurodollari fu certamente la Guerra fredda, che portò
l’Unione Sovietica e i paesi dell’est Europa a depositare i propri attivi in dollari nelle
banche europee, in quanto temevano che un peggioramento nelle relazioni internazionali
con gli Stati Uniti, sempre possibile, avesse potuto comportare un congelamento di quei
fondi se depositati in banche americane.
Un ruolo importante nella crescente disponibilità di dollari delle banche europee e
inglesi si deve anche alla cosiddetta Regulation Q americana, che stabiliva un massimale per
gli interessi pagati sui depositi bancari statunitensi, e alle sue conseguenze in ambito
internazionale. Il massimale, infatti, poteva, e così avvenne, essere superato dalle banche
inglesi, che offrendo tassi d’interesse maggiori attiravano flussi in dollari. Questa pratica
finanziaria fu inaugurata dalla Midland Bank, che nel giugno 1955 offrì un tasso pari
all’1,8% su depositi a trenta giorni in dollari, mentre la regolazione statunitense fissava il
massimo all’1%: attirando dollari, la banca inglese li rivendeva poi sul mercato interno in
cambio di sterline, ricomprando poi a termine i dollari e guadagnando attraverso
l’arbitraggio sui tassi di interessi. Il divieto introdotto in Gran Bretagna di denominare in
sterline i finanziamenti agli scambi con paesi terzi, per interrompere il ribasso della
sterlina, rese ancora più vantaggioso sostituire la valuta inglese con il dollaro nelle
transazioni internazionali, specialmente da parte delle banche che operavano oltremare,
come la Kleinwort e la Bank of London and South America.
Quando nel dicembre del 1958 le valute europee tornarono alla convertibilità
reciproca, vi fu un graduale abbassamento dei controlli sui flussi di capitale e una crescita
rapida del mercato degli eurodollari, i quali costituivano una fonte di credito di enorme
quantità. Usando i fondi che provenivano in massima parte dalle multinazionali
americane, infatti, le banche inglesi finanziavano il commercio internazionale e i prestiti a
breve: se nel 1958 questo mercato contava un giro d’affari di 1,5 miliardi, nel 1973 si
arrivò a toccare quota 130 miliardi di dollari.
Velocemente, sull’onda dell’aumento dei prestiti bancari denominati in dollari, i
banchieri della City londinesi cominciarono ad emettere obbligazioni, denominate
sempre in dollari ma emesse su Londra anziché su New York, alle quali la Banca
d’Inghilterra diede il suo nulla osta nel luglio del 1962. La prima emissione di
eurobbligazioni può essere rintracciata in un’operazione del maggio del 1963, condotta
dalla merchant bank Samuel Montague che aveva collocato, per conto del governo del
Belgio, un prestito di 20 milioni di dollari. Poche settimane dopo fu la volta della prima
eurobbligazione destinata ad un’impresa privata: Sigmund Warburg, infati, nel gennaio
1963 siglò un accordo con Autostrade Italiane, al tempo una controllata dell’IRI, alla
quale venne accordato un prestito di 15 milioni di dollari, ad un tasso d’interesse del
5,5% e per una durata di sei anni, che venne effettivamente emesso il primo luglio dello
stesso anno.
28
L’emissione delle eurobbligazioni divenne ancora più vantaggiosa all’indomani
dell’introduzione negli Stati Uniti della Interest Equalization Tax, il 18 luglio 1963: questa
imposta sul rendimento dei prestiti esteri emessi negli Stati Uniti determinò, infatti, un
aumento dei costi d’emissione delle obbligazioni estere. Questo portò, in appena cinque
anni dal loro primo apparire, le eurobbligazioni a raggiungere i 4 miliardi di dollari
all’anno, con vantaggi per tutte le parti coinvolte, data la mancanza di un obbligo a
presentare documentazione particolare da parte dei debitori – visto che i prestiti non
erano soggetti alla legislazione di alcun paese – , nonché dato l’anonimato e l’esenzione
da imposte alla fonte, che avvantaggiava gli investitori.
Un’ultima tipologia creditizia cominciò a nascere in Europa alla metà degli anni
Sessanta, coprendo il settore dei prestiti a medo termine, con scadenze a 10-15 anni. Gli
eurocrediti furono prestiti interbancari a tasso variabile, finanziati in eurodollari, più
flessibili rispetto alle obbligazioni e per questo appetibili da un vasto mercato. La prima a
emettere questo tipo di forma di credito fu la First National City Bank nel maggio del
1966. Successivamente, il successo riportato dagli eurocrediti portò all’organizzazione di
consorzi di credito che riunivano più istituti bancari, come ad esempio quello, che
ammontava a 15 milioni di dollari, organizzato nel giugno del 1966 dalla Bank of London
and South America, e quello, pari a 100 milioni, gestito dalla Lehman Brothers e dal
Bankers Trust International per l’Austria. In generale, gli eurocrediti crebbero dai 2
miliardi di dollari del 1968, fino ai 20 miliardi registrati nel 1973.
Come visto, il processo di accumulazione di dollari nei paesi europei, in primo luogo
in Gran Bretagna, occupò tutto il decennio degli anni Sessanta, fin dai primissimi anni
successivi al ripristino della convertibilità delle divise monetarie dei principali paesi
europei. Il dollaro, quindi, si stava imponendo sempre più come moneta chiave
dell’economia internazionale, in quanto, oltre ad essere l’unità di conto delle importazioni
e delle esportazioni, veniva utilizzato anche come mezzo di scambio delle transazioni
interbancarie e come moneta di riserva di Stati e privati. Questa dipendenza dal dollaro si
rivelò come uno degli elementi decisivi nell’incrinare il funzionamento dell’intero sistema:
paradossalmente, proprio nel momento in cui Bretton Woods entrò pienamente in
vigore, nel 1959, i suoi meccanismi mostrarono i segni di una debolezza che si
manifesterà esplicitamente solo un decennio più tardi.
Il sistema si evolveva, infatti, in modo squilibrato: come notato fin dal 1947 da Robert
Triffin, economista belga a Yale, l’instabilità del sistema di Bretton Woods era dovuta
proprio all’aumento dei saldi esteri denominati in dollari, che portava ad un parallelo
aumento delle riserve internazionali, sempre in dollari. Proprio l’accumulo di dollari era il
nodo centrale della questione: infatti, detenere dollari era conveniente fin quando non
sussistevano dubbi sulla capacità degli Stati Uniti di onorare la convertibilità in oro. Ma la
fiducia nelle possibilità statunitensi cominciò a vacillare fin dall’inizio degli anni Sessanta,
quando i conti in dollari del resto del mondo incombevano sulle riserve auree americane:
nel 1960, per la prima volta, le passività monetarie in divisa estera superarono
l’ammontare delle riserve auree americane; nel 1963, invece, i debiti americani verso
l’estero superarono il debito interno. Se un paese estero avrebbe richiesto di convertire in
oro i proprio saldi in dollari avrebbe scatenato una corsa internazionale alle riserve auree
statunitensi, costringendo gli Stati Uniti alla svalutazione.
Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, il problema che si
poneva alle autorità monetarie e finanziarie mondiali era duplice: da una parte accrescere
le liquidità internazionali necessarie a sostenere la crescita economica; dall’altra trovare
29
uno strumento di liquidità da sostituire al dollaro, che, come visto, mostrava i primi segni
di sofferenza nelle pressioni a cui veniva sottoposto dalla sua convertibilità aurea. Già nel
1959, infatti, era stato preso atto che l’economia mondiale era cresciuta enormemente
rispetto al 1944, portando così ad un aumento delle quote dell’FMI pari al 50%;
quest’aumento, tuttavia, dato che il valore del dollaro nello stesso periodo era più che
raddoppiato, non variava quasi per nulla le risorse effettive a disposizione del Fondo.
Nel momento in cui, nella prima metà degli anni Sessanta, la debolezza del dollaro
divenne evidente, cominciò ad apparire altrettanto evidente che gli Stati Uniti non
intendevano sacrificare i propri obiettivi politici e sociali, come, ad esempio, l’impegno
militare in Vietnam, che divenne sempre maggiore a partire dal 1965, e le spese sociali:
nel 1960, ad esempio, Kennedy incentrò tutta la propria campagna elettorale con una
promessa di portare la crescita annua al 5%, escludendo dal novero delle possibilità per
riequilibrare il sistema monetario internazionale manovre sui tassi d’interesse o misure
fiscali restrittive. Anche l’arma della svalutazione, che avrebbe posto fine alla supremazia
del dollaro come valuta di riferimento mondiale, non era praticabile, in quanto sarebbe
stata interpretata come una chiara dichiarazione di fallimento.
Tuttavia, proprio la campagna elettorale di Kennedy con lo slogan «to get America
moving again», venne interpretata come anticipatrice di possibile politiche
inflazionistiche, che provocarono la prima crisi sul mercato dell’oro di Londra fin dalla
sua riapertura nel 1954: gli speculatori, infatti, per timore di una svalutazione, portarono
il prezzo dell’oro sul mercato privato londinese dai 35,20 dollari all’oncia, prezzo a cui
l’oro veniva comprato dal Tesoro statunitense, fino a 40 dollari all’oncia. La soluzione,
temporanea, venne trovata in un accordo tra banche centrali con la nascita, come
vedremo a breve, del cosiddetto Gold Pool nel novembre del 1961.
In queste condizioni, il sistema di Bretton Woods riuscì a sopravvivere durante gli
anni Sessanta e fino al 1971 grazie, principalmente, ad iniziative di cooperazione a livello
internazionale tra Stati e banche centrali, che tornò in auge dopo quasi trent’anni di
interruzione: un esempio di tale cooperazione è fornito dalla decisione, simbolica oltre
che pragmatica, presa dai governatori delle varie banche centrali di incontrarsi presso la
Banca dei Pagamenti Internazionali a Basilea con cadenza mensile, per scambiarsi
informazioni, suggerimenti e decidere le mosse da applicare.
Dopo la rivalutazione del marco del 4 marzo 1961, ad esempio, le pressioni sulla
sterlina si intensificarono, portando alla stipula di alcuni accordi di scambio tra le banche
centrali, che prevedevano l’impegno a mantenere i loro saldi in valuta anziché convertirli
in oro, fornendo anche un miliardo di dollari alla Gran Bretagna. Un ulteriore prestito
agli inglesi fu fornito, nel 1964, dalla Fed di New York, in quanto gli americani, dato che
la sterlina era la seconda valuta di riserva internazionale e, una sua svalutazione, avrebbe
comportato forti pressioni sul dollaro, si impegnarono a far sì che il valore della divisa
inglese non cadesse aprendo una linea di credito di tre miliardi di dollari verso la Gran
Bretagna.
Altre due iniziative devono essere prese in considerazione in questo quadro di eventi:
il Gold Pool, che funzionò nel periodo 1961-1967, e i diritti speciali di prelievo presso
l’FMI, le cui trattative, iniziate nel 1963, si conclusero nel 1967 con disposizioni che
entrarono effettivamente in regime nel 1969. I negoziati per creare nuove riserve,
alternative al dollaro, furono inaugurati dal Gruppo dei Dieci, ovvero il G-10. Nel 1961,
quindi, le nazioni industrializzate decisero, attraverso gli Accordi Generali di Prestito, di
30
aumentare la proprio quota, denominata nelle varie valute nazionali, per un totale di sei
miliardi di dollari, legando l’accesso a queste risorse all’approvazione dei ministri delle
finanze dei paesi industrializzati. Nel 1963 venne inoltre creato un gruppo composto da
alti delegati finanziari, che propose un altro aumento delle quote dei paesi, pari al 25%,
che venne eseguito nel 1966.
Contestualmente, le crescenti passività verso l’estero degli Stati Uniti, che avevano già
da tempo superato le riserve auree del paese, avevano portato ad un aumento del prezzo
del dollaro al di fuori dei confini americani oltre il limite desiderato dei 35 dollari
all’oncia. Visto che il dollaro sembrava percorrere un trend discendente, al fine di
disincentivare la vendita dei dollari detenuti come riserva internazionale, venne creato un
consorzio di banche centrale, appunto il Gold Pool, che si accordarono per non
convertire i dollari in loro possesso e vendere invece il proprio oro, per allentare così le
pressioni sugli Stati Uniti.
Tuttavia, questo consorzio perse con gli anni la propria efficienza, soprattutto in
relazione al fatto che gli Stati Uniti non sembravano propensi a sacrificare i propri
obiettivi militari all’estero e di politica interna per sostenere la propria valuta. Questo
portò ad un graduale aumento dello scetticismo degli altri paesi ad intervenire in favore
del dollaro: la Francia, infatti, nel 1967 si ritirò dal Gold Pool, costringendo di fatto gli
Stati Uniti ad aumentare il loro contributo in questo senso; dopo un’ultima ulteriore
vendita d’oro per un valore di 800 milioni di dollari, l’accordo venne concluso nella
primavera del 1968.
Negli stessi anni giungevano a termine le trattative per l’istituzione, all’interno
dell’FMI, dei Diritti Speciali di Prelievo (DSP). Dopo una prima proposta da parte del G10 risalente al 1961, l’accordo per l’istituzione dei Diritti Speciali di Prelievo venne
approvata il 26 agosto del 1967, accogliendo le proposte della commissione presieduta
dall’italiano Rinaldo Ossola. Si arrivò così al primo emendamento agli Accordi dell’FMI,
ratificato il 28 settembre 1967 dall’Assemblea del Fondo a Rio de Janeiro. Dopo alcune
modifiche introdotte nel giugno del 1968, il nuovo accordo entrò definitivamente in
vigore nel luglio del 1969, prevedendo le prime assegnazioni di DSP dal 1 gennaio 1970.
I DSP andavano a costituire una forma di liquidità internazionale a piena
convertibilità valutaria del Fondo allocati ai paesi membri in proporzione alle quote di
partecipazione degli stessi al Fondo. I DSP non costituiscono una vera e propria valuta,
ma piuttosto un diritto, appunto, di acquistare una o più valute liberamente utilizzabili
detenute nelle riserve dei paesi membri. Nel periodo 1970-1974, il valore di 1 DSP era
fissato, pur non essendo convertibile in oro, allo stesso valore in oro del dollaro, quindi
35 DSP all’oncia. Il valore sarebbe poi cambiato dopo il 1974 in seguito alle due
svalutazioni del dollaro del 1971 e del 1973, e sarebbe stato calcolato riferendosi alla
media del valore di un paniere delle più importanti monete a livello internazionale.
La ratio dietro alla creazione dei DSP, quindi, consisteva nell’accrescere le liquidità
internazionali senza dover ricorrere ad un aumento della circolazione mondiale del
dollaro: all’occorrenza di un deficit nella bilancia dei pagamenti, i paesi in difficoltà
potevano utilizzare, infatti, i DSP a loro disposizione per dimostrare la loro capacità di
accedere alla liquidità necessaria. È stato calcolato che, dal gennaio 1970 fino alla ratifica
del secondo emendamento agli Accordi del Fondo dell’aprile del 1976, sono stati
concessi crediti in DSP per un totale di 8,9 miliardi: 3,1 miliardi concessi nel 1970, e 2,8
miliardi per il 1971 e per il 1972. Al 30 aprile 1976 solamente otto paesi – Etiopia,
31
Kuwait, Libano, Libia, Arabia Saudita, Singapore e Emirati Arabi Uniti – non avevano
fatto richiesta per utilizzare i DSP.
4.2. La periferia del sistema: i paesi in via di sviluppo
Durante le tre decadi successivi alla Seconda guerra mondiale, i paesi non
industrializzati avevano poche caratteristiche in comune: prevalevano, invece, notevoli
differenze sul piano culturale, storico ed economico. Tuttavia, spesso in questi paesi
prevalsero analisi economiche e proposte tra loro molto simili: la diagnosi dominante era
infatti che la sola produzione di materie prime, agricole e minerarie, e di prodotti
alimentari non fosse sufficiente ad innescare un processo di arricchimento nazionale.
Pertanto, l’instabilità delle esportazioni venne constatata mediamente con politiche di
sostituzione delle importazioni, tese a finalizzare una crescita dell’industria manifatturiera
locale, accrescendo contestualmente anche il mercato locale.
Le risorse finanziarie per raggiungere tale scopo vennero recuperate in particolar
modo attraverso una massiccia tassazione sulle esportazioni delle materie prime,
utilizzando poi i ricavi di tali prelievi fiscali per elargire sussidi alle industrie locali. Per lo
stesso obiettivo vennero imposti dazi doganali e contingentamenti sulle importazioni di
manufatti dall’estero, provocando un mutamento dei prezzi sul mercato interno per
stimolarne la crescita. Il tasso di protezione effettiva del Brasile era in media del 118%,
con il 41% sui macchinari e picchi dell’8.480% sui profumi e i saponi.
Il settore maggiormente colpito era, in questo senso, l’agricoltura, in quanto i
contadini si trovavano a poter vendere i propri prodotti ad un prezzo più basso, mentre
erano costretti a pagare un prezzo maggiore per acquistare i manufatti industriali. In
Pakistan, ad esempio, nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta il rapporto tra i prezzi dei
manufatti e quelli dei prodotti agricoli era mediamente il doppio rispetto a quello
esistente sul mercato mondiale. In general, nei paesi in via di sviluppo, queste politiche
provocarono, oltre che una generalizzata tendenza alla migrazione verso le aree urbane, la
crescita delle importazioni di prodotti alimentari ad un tasso doppio rispetto alle
esportazioni.
Gli anni del secondo dopoguerra furono anche gli anni in cui si assistette ad un
cospicui afflusso di aiuti allo sviluppo da parte dei paesi occidentali nei paesi in via di
sviluppo. Gli investimenti internazionali interessarono in particolar modo le regioni
dell’America Latina e, in generale, quelle zone a colonizzazione europea: l’India, ad
esempio, dopo l’indipendenza raggiunta nel 1947 e l’adozione negli anni successivi di
politiche di nazionalizzazione, protezione e controllo statale delle industrie, smise di
essere un paese attrattivo per il capitale straniero. In altri paesi in via di sviluppo, invece,
le conseguenze economiche degli investimenti stranieri potevano variare enormemente:
in alcuni casi cambiamenti radicali della politica nazionale potevano entrare in conflitto
con gli interessi economici delle multinazionali straniere, provocando anche l’intervento
diretto dei paesi occidentali, come nel caso dell’Iran nel 1953 e del Guatemala nel 1954;
in altri contesti, invece, si realizzarono forme di investimento estero virtuose, come
l’esempio della Fondazione Rockfeller che fondò in Messico, nel 1946, un centro
internazionale per il mais e per il frumento, esperienza poi replicata nel 1959 quando,
insieme alla Fondazione Ford, la Fondazione Rockfeller fondò un istituto internazionale
di ricerca sul riso nelle Filippine.
32
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, i capitali in entrata nei paesi in via di sviluppo
avevano ripercussioni economiche e politiche sfavorevoli alle nazioni ospitanti. Gran
parte degli investimenti erano infatti concentrati nel settore minerario ed estrattivo,
privando i paesi di risorsi non rinnovabili a un ritmo che non giovava al paese, portando
minimi benefici al sistema economico. La manodopera, infatti, impiegata in mansioni a
bassa specializzazione, non acquisiva nuove competenze, rendendo quindi impossibile la
nascita di nuove iniziative private locali.
In generale, gli aiuti internazionali vennero distribuiti in maniera diseguale tra i vari
paesi in via di sviluppo: nel 1970, ad esempio, i paesi in via di sviluppo più prosperi
ricevettero maggiori aiuti rispetto agli altri e tendenzialmente i paesi più piccoli
ricevevano aiuto pro capite maggiori rispetto a quelli di maggiori dimensioni. Inoltre, vi
fu una trend decrescente degli aiuti frutto di accordi bilaterali allo sviluppo nel periodo
1960-1970, tanto che è stato calcolato che tali aiuti, in rapporto al Pil dei paesi sviluppati,
passarono dallo 0,52% del 1960 al 0,34%. A tal proposito, nel 1969, il presidente della
Banca Mondiale Robert McNamara istituì la commissione Pearson che richiese l’impegno
dei paesi industrializzati a portare il rapporto tra aiuti e Pil almeno al 0,7%, senza tuttavia
sortire alcune effetto.
Anche gli aiuti allo sviluppo gestiti dalla Banca Mondiale non furono molto incisivi nel
modificare le tendenze di fondo di questi flussi di capitali, anche perché il contribuito dei
finanziamenti della Banca Mondiale fu pari ad appena il 10% del totale. Inoltre, anche
questi aiuti avevano implicazioni politiche ed economiche simili a quelle provocate dagli
aiuti bilaterali, dato che i capitali andavano a finanziari quei progetti e quei settori reputati
utili dalle autorità della Banca Mondiale. Ad esempio, l’India fu vincolata a ridurre i
controlli sull’economia e a modificare le proprie politiche circa la bilancia dei pagamenti
per poter accedere ad alcuni prestiti dall’estero verso la metà degli anni Sessanta.
Il drenaggio di risorse dal settore agricolo verso quello industriale non fece solamente
aumentare l’importazione di prodotti alimentari, ma generò anche una riduzione delle
esportazioni di materie prime non petrolifere. Negli anni Cinquanta e Sessanta, infatti, i
paesi in via di sviluppo persero mediamente il 75% delle quote di mercato delle materie
prime che esportavano, in gran parte perché i paesi industrializzati producevano prodotti
altamente competitivi, se non perfettamente sostituibili. Tuttavia, nello stesso arco
temporale, alcuni paesi in via di sviluppo che non avevano risorse petrolifere da
esportare, riuscirono comunque a registrare alti tassi di crescita delle esportazioni, in
media superiori al 6% annuo. La maggior parte di essi erano paesi di piccole dimensioni, i
quali, con meno problemi di approvvigionamento di una grande massa di popolazione,
fecero registrare tassi di crescita delle esportazioni anche maggiori rispetto ai paesi
industrializzati, riuscendo anche a far crescere i redditi medie interni.
La composizione in termini di prodotti degli scambi commerciali dei paesi in via di
sviluppo va distinta, nella seconda metà del Novecento, in due sotto-insieme con
caratteristiche specifiche: i paesi produttori di petrolio e i paesi che ne erano invece
importatori.
Nel caso dei produttori di petrolio la questione che fu maggiormente rilevante fu la
maggiore o minore stabilità politica e, più in generale, il loro rapporto con le grandi
multinazionali. Questi temi sono discussi con più precisione nel capitolo successivo,
quando l’impatto dei paesi produttori di materie prime petrolifere sull’economia
mondiale fu decisivo. Tuttavia, basti qui osservare come nel primo trentennio post-
33
bellico le condizioni di questo gruppo di paesi furono in realtà molto penalizzanti, con un
grande vantaggio invece per le compagnie petrolifere multinazionali e per i paesi
industrializzati. A tale periodo seguirono, invece, anni di rivolte sociali che portarono a
guerre o a condizioni monopolistiche per i paesi in questione, che determinarono
l’aumento dei prezzi e la rigidità di mercato negli scambi con le economie industrializzate:
proprio questi elementi determinarono, infine, un enorme impatto sulla crisi generale del
sistema egemonico americano.
Il secondo gruppo di paesi, quello composto da paesi esportatori di materie prime
non petrolifere, risulta essere, nel periodo in esame, molto più rilevante del precedente.
La composizione in termini di prodotti di questi paesi mostra come lo scambio non sia
scomponibile in prodotti manufatti verso materie prime.
Nel corso degli anni Sessanta, ad esempio, la quota delle materie prime sul totale delle
importazioni è stata simile nei due gruppi di paesi. Verosimilmente, ciò fu dovuto alle
diverse tecnologie produttive applicate nelle due aree, delineando quindi un vantaggio
comparato dovuto al gap tecnologico. Come conseguenza, si verificarono frequenti
scambi intersettoriali di prodotti semilavorati in ragione di innovazioni di processo e,
quindi, una frequente instabilità nei volumi delle esportazioni dei paesi in via di sviluppo.
I paesi in via di sviluppo tentarono di contrastare questa posizione di svantaggio
mediante politiche nazionali piuttosto che attraverso accordi cooperati e processi di
socializzazione. Tra i vari strumenti di politica monetaria a disposizione, quello più
utilizzato fu il ricorso alle svalutazioni per stabilizzare eventuali squilibri fondamentali
nella bilancia dei pagamenti. Tra il 1954 e il 1971 si sono infatti verificati 48 casi di crisi
nella bilancia dei pagamenti con successiva svalutazione da parte dei paesi in via di
sviluppo. L’Argentina, ad esempio, svalutò ben quattro volte: nell’ottobre del 1955, nel
dicembre del 1958, poi nel 1962 e nel 1970; il Brasile, invece, svalutò nel febbraio del
1967; l’India nel 1966; la Colombia per quattro volte, dal 1957 al 1967; le Filippine nel
1962 e nel 1970. All’interno di quest’ampia casistica – nella successiva tabella sono
inseriti tutti i casi di svalutazione di quegli anni – tuttavia, è bene operare una distinzione
cruciale: alcuni paesi, infatti, svalutarono la propria valuta attraverso iniziative concordate
con il Fondo Monetario Internazionale; altri paesi, invece, attuarono politiche
economiche di svalutazione senza l’appoggio del Fondo.
34
È interessante ora osservare come le svalutazione operate senza il sostegno del
Fondo, durante il periodo di Bretton Woods, abbiano avuto mediamente un esito più
fallimentare, nel medio periodo, rispetto a quei paesi che invece ricorsero al Fondo per
35
orchestrare le necessarie manovre di politica economica. Nei paesi assistiti dal Fondo,
infatti, si nota come il tasso reale di cambio viene riallineato nei quattro anni successivi
alla svalutazione e la bilancia dei pagamenti viene riequilibrata. Un fattore essenziale, in
queste svalutazioni di successo, venne giocato, più che dalle manovre monetarie in sé,
dalle politiche fiscali e macroeconomiche che il Fondo imponeva. Non sembra essere
lontana dalla realtà, quindi, l’ipotesi che queste svalutazioni concordate con il Fondo
avevano mediamente più successo delle altre in quanto sottoposte a misure costrittive
dettate da un organismo internazionale, com’era appunto il Fondo, in larga misura
controllato dalla nazione egemone, ovvero dagli Stati Uniti.
4.3. La fine dell’egemonia americana
La fine del Gold Pool e la mancata realizzazione di una riforma strutturale
dell’architettura monetaria internazionale, con il dollaro che continuava a perdere valore a
fronte di una sua difesa istituzionale che, alla fine degli anni Sessanta, si faceva sempre
più costosa, portarono al crollo del sistema di Bretton Woods. Le tappe che scandirono
tale crollo furono la crisi delle due valute principali dell’economia internazionale: prima
quella della sterlina, che venne svalutata del 17% nel novembre del 1967; e poi quella del
dollaro, la cui convertibilità aurea fu sospesa unilateralmente nell’agosto del 1971: la
valuta statunitense venne poi svalutata dell’8%, sempre nel 1971, e di un ulteriore 10%
nel 1973. Questo percorso portò, poi, all’approvazione del secondo emendamento agli
Accordi del Fondo, nella prima metà del 1976, che prevedeva l’abolizione del prezzo
ufficiale dell’oro traghettando il mondo verso un sistema di cambi flessibili.
La crisi della sterlina, che culminò nella svalutazione del 1967, aveva le sue origini
negli anni precedenti ed era sostanzialmente legata alla dimensione di seconda valuta di
riserva internazionale, di cui gli Stati Uniti non voleva privarsi per timore di ripercussioni
sul dollaro, accoppiata però ad un’economia che faceva registrare una crescita
decisamente più lenta rispetto agli altri paesi dell’Europa occidentale e al Giappone.
Mantenere il cambio della sterlina al valore di 2,8 dollari fu la battaglia che venne
combattuta dai governi inglesi post-bellici e che fu, alla fine, destinata alla sconfitta. Nel
corso degli anni Sessanta l’unico elemento positivo all’interno del quadro inglese era la
capacità di attirare, come abbiamo visto, capitali a breve termine grazie all’elevato tasso
d’interesse praticato, pur con alcune oscillazioni, dalla Banca d’Inghilterra lungo tutto il
periodo: nel gennaio 1961 il tasso fu innalzato al 5%, per arrivare al 7% nel luglio del
1962. Tra il 1962 e il 1964 si registrò una manovra di tagli alla spesa pubblica e un
incremento della pressione fiscale, che fecero aumentare la disoccupazione di un punto
percentuale tra il 1961 e il 1962, ma permisero di calmare i mercati, grazie anche
all’intervento delle banche centrali europee e del Fondo Monetario Internazionale, che
sostennero il valore della sterlina.
Nel 1964, dopo che De Gaulle pose il veto all’ingresso della Gran Bretagna nella
CEE, il Partito laburista tornò al governo dopo tredici anni: il nuovo gabinetto, guidato
da Harold Wilson, rimaneva tuttavia contrario all’ipotesi della svalutazione, temendo
possibili spirali inflazionistiche. Un nuovo flusso di capitali fu fornito dal Fondo, che aprì
verso la Gran Bretagna un credito d’emergenza di un miliardo di dollari, e dagli Stati
Uniti che guidarono in prima linea un sindacato di undici paesi per fornire ulteriori tre
miliardi di dollari di prestiti agli inglesi. Queste continue iniezioni di liquidità non
facevano, però, che ritardare un’inevitabile conclusione: la chiusura del canale di Suez
durante la Guerra dei sei giorni del 1967 fece nuovamente incrinare la fiducia nella
36
stabilità dei commerci inglesi. Un’ennesima fuga di capitali, inoltre, fu innescata dalle
dichiarazioni del ministro degli esteri francese Maurice Couve de Murville, che espresse i
suoi dubbi sulla stabilità della sterlina e sulla capacità del governo inglese di ricevere
ulteriori prestiti. Il 18 novembre 1967 il governo inglese fu costretto a svalutare, come
detto, del 17% la valuta inglese.
Il fallimento del pool dell’oro e la crisi della sterlina, con conseguente svalutazione,
erano, a posteriori, gli indizi del crollo imminente: i crescenti disavanzi della bilancia dei
pagamenti americani e lo sviluppo degli euromercati furono determinanti in questo
senso, ma non furono gli unici elementi che determinarono la fine di Bretton Woods.
Come dimostra l’esperienza inglese del 1967, il nodo della questione era legato in maniera
significativa ad una ripresa delle economie occidentali che si basava su un modello di
sviluppo che prevedeva, in primo luogo, la completa trasformazione delle stesse da
economie agricole e trasformatrici in sistemi produttori principalmente di servizi; in
secondo luogo, questo sviluppo era incardinato su un patto sociale che aveva inglobato le
masse dei lavoratori grazie ad un’alta e crescente spesa sociale statale. Si poneva, quindi,
alle autorità dei vari governi nazionali un dilemma squisitamente politico: il rallentamento
produttivo e la conseguente crescita del deficit nella bilancia dei pagamenti poteva essere
coniugato con la difesa di cambi fissi immaginata a Bretton Woods solamente abiurando
al patto sociale che aveva garantito, per più di vent’anni, sviluppo e prosperità. La fissità
del cambio, come dimostra il caso inglese del 1967, doveva quindi essere sacrificata
sull’altare della stabilità e della spesa sociale.
L’ultimo atto andò in scena tra il 1971 e il 1976. L’inflazione statunitense era sempre
stata sotto controllo: nel periodo della convertibilità di Bretton Woods, tra il 1959 e il
1970, si era attestata ad una media del 2,6% annuo, più passa dei paesi del G-7. Tuttavia,
la crescita della base monetaria statunitense era andata accelerando in particolar modo a
partire dal 1964, in concomitanza con il maggior impegno militare nel Vietnam
dell’amministrazione Johnson e con le spese per i programmi sociali: le autorità
monetarie statunitensi, quindi, decisero di sacrificare la stabilità dei prezzi agli obiettivi di
politica estera e di politica sociale.
Data la centralità del dollaro e dell’economia americana nel contesto globale,
l’inflazione statunitense non tardò a trasmettersi agli altri paesi. Tuttavia, per tutto il
periodo, data una crescita molto più rapida rispetto a quella degli Stati Uniti delle
economie dell’Europa occidentale e del Giappone, questi paesi furono in grado di
importare e sostenere un’alta inflazione e un aumento dei prezzi. Tale processo non
poteva, però, durare in eterno. Già nel biennio 1968-1969 si verificarono in Francia e
Germania importanti riaggiustamenti del cambio: il primo in relazione agli eventi del
maggio francese del 1968, a cui il governo rispose con una politica monetaria espansiva
che produsse una fuga dal franco e un severo ridimensionamento delle riserve auree
francese, la cui pressione fu alleviata da un pacchetto di aiuti coordinato proprio dagli
Stati Uniti. La fuga dal franco generò un flusso di capitali in Germania, provocando un
apprezzamento del marco. Le due condizioni, provocarono, nel corso del del 1969, un
ridimensionamento di entrambe le valute: il franco venne svalutato dell’11,1% nell’agosto
del 1969, mentre il marco fu rivalutato del 9,3% nel settembre dello stesso anno.
Una nuova crisi del sistema monetario internazionale fu scatenata dalla bilancia dei
pagamenti statunitense che, dopo una chiusura in surplus nel biennio 1968-1969, crebbe
enormemente nel biennio successivo, raggiungendo un negativo di 30 miliardi di dollari
nell’agosto del 1971. Un flusso di dollari raggiunse quindi i paesi in surplus commerciale,
37
in primo luogo il Giappone e la Germania: la Deutsche Bundesbank sospese, il 5 maggio
1971, le operazioni sui mercati valutari, seguita dalle banche centrali di Giappone,
Austria, Belgio, Olanda e Svizzera.
Le intenzioni mostrate dalle autorità francesi e inglesi di convertire in oro i dollari
presenti nelle proprie riserve aumentarono la pressione sugli Stati Uniti. Il 15 agosto
Nixon annunciò di aver incaricato il Segretario del Tesoro John Connally di sospendere
temporaneamente la convertibilità in oro del dollaro, imponendo contestualmente una
sovrattassa del 10% sulle importazioni: il tutto venne fatto senza neanche consultare il
Fondo Monetario Internazionale. Privi di un sistema monetario internazionale, i paesi
industrializzati si riunirono, nel dicembre del 1971, a Washington, decidendo con la firma
dello Smithsonian Agreement la svalutazione del dollaro del 7,9%, portando il suo valore
a 38 dollari all’oncia, senza però ripristinare l’obbligo di convertibilità per la valuta
statunitense; vennero, inoltre, durante l’estate-inverno del 1971, decise le rivalutazioni
delle maggiori valute mondiali nei confronti del dollaro: lo yen si apprezzò del 16,9%, il
marco tedesco del 13,6%, il franco e la sterlina del 8,6%; la lira italiana del 7,5%.
Tuttavia, il nodo gordiano della situazione monetaria internazionale non era stato
sciolto. La rivalutazione delle divise europee comportò un aumento delle esportazioni
americane, sospinte da una politica monetaria statunitense espansiva: l’offerta monetaria,
nel novembre del 1972, cresceva infatti ad un tasso del 6% annuo. All’inizio del 1973
l’elevato tasso d’inflazione statunitense provocò un’altra fuga dal dollaro, che portò a
variazioni nel tasso di cambio con il dollaro da parte delle maggiori economie europee, ed
infine ad una nuova svalutazione decisa dalle autorità americane nel febbraio del 1973,
stavolta pari al 10%. La CEE decise di far fluttuare le proprie valute, con una banda di
oscillazione del 2,25%, e così fece anche la Banca del Giappone. Il problema legale,
connesso agli Accordi dell’FMI, si concretizzava nel fatto che i paesi erano costretti a
mantenere fissi i tassi di cambio: nel gennaio del 1976, così, nella riunione dei direttori
esecutivi tenutasi a Kingston in Giamaica propose il secondo emendamento agli Accordi,
che sarebbe stato poi approvato dal Consiglio nel maggio dello stesso anno, legalizzando
di fatto il sistema dei cambi flessibili.
5. Gli intermediari del sistema
5.1. Il Fondo Monetario Internazionale
L’istituzione del Fondo Monetario Internazionale fu certamente una delle risultanti
più innovative che scaturirono dagli accordi di Bretton Woods del 1944. Per un verso il
nuovo organismo aveva, almeno in nuce, alcune caratteristiche che sembrano avvalorale
l’interpretazione che lo vede come un primo abbozzo di banca centrale sovranazionale: si
veda, a tal proposito, in particolar modo l’articolo I degli Articles of Agreement, dove il
Fondo viene indicato come fornitore di risorse con adeguate salvaguardie ai paesi
membri in temporanea situazione di squilibrio delle bilance dei pagamenti.
Se, nella teoria, questo rimaneva, a prescindere dalle differenze tra le proposte di
Keynes e di White, un punto fermo delle politiche del Fondo, insieme al tentativo di
mettere in campo tutti gli strumenti necessari per scoraggiare i movimenti di capitali
speculativi; la concreta messa in pratica degli accordi si scontrò, prima e dopo la
conferenza di Bretton Woods, con una forte opposizione portata strenuamente avanti dal
settore finanziario americano.
38
Le preoccupazioni del mondo finanziario statunitense nei confronti del nascente
sistema di Bretton Woods possono essere racchiuse in tre elementi fondamentali. Il
primo di questi era legato alla posizione dominante che gli Stati Uniti avevano ottenuto
dopo la Seconda guerra mondiale e che tutti si attendevano continuassero ad occupare
anche negli anni seguenti: tale posizione di forza, si temeva avrebbe generato una quota
eccessiva di oneri finanziari e macroeconomici su un solo paese, appunto gli Stati Uniti.
In secondo luogo, una parte della finanza americana, quella più legata all’attività
produttiva, era preoccupata dalla cosiddetta possibilità di moral hazard che il sistema
avrebbe potuto generare mercati finanziari che avrebbero catturato risorse invece di
destinarle alla produzione e, per l’altro verso, avrebbero potuto creare squilibri inflattivi
che si sarebbero ripercossi sulla stabilità del sistema. Queste preoccupazioni suscitarono
interventi istituzionali per aumentare i controlli valutari, per questa via scoraggiando gli
afflussi e i deflussi di capitale su Wall Street, che avrebbe visto in tal modo tarpate le
proprie ambizioni di diventare la piazza finanziaria del mondo, scalzando in questo modo
Londra.
Sull’onda di questi timori, dietro le quinte dei negoziati ufficiali tra i delegati di Stati
Uniti e Gran Bretagna, che portarono agli accordi di Bretton Woods, si svolsero intense
manovre e attività lobbistiche tutte all’interno del mondo finanziario e politico
statunitense, che ebbe l’effetto di portare ad un notevole ridimensionamento del peso del
Fondo rispetto ai piani originari. Più che nell’assetto generale e nei principi di fondo, le
spie di questo ridimensionamento sono da ricercare nei dettagli, in alcuni espedienti
tecnici che avevano lo scopo di andare incontro alle necessità e alle preoccupazioni del
settore finanziario americano appena richiamate. In conclusione, più che una banca
centrale sovranazionale, il Fondo nacque più che altro come un’agenzia dei governi senza
alcun potere proprio di creazione di liquidità internazionale.
Gli stratagemmi inseriti tra le maglie degli articoli del Fondo riguardavano alcuni dei
temi più scottanti, quali i movimenti di capitale, la vigilanza internazionale e la struttura di
governo del nuovo organismo. Il principale accorgimento per tutelare il mondo
finanziario americano si trova all’articolo VI dello Statuto, dove viene fatto divieto al
Fondo di prestare risorse per contrastare i deflussi di capitale, quale che ne fosse la causa.
Inoltre, il settore privato statunitense riuscì nel suo intento lobbistico anche sulla
questione dei controlli sui movimenti di capitali, un tema essenziale nella geometria del
potere finanziario internazionale. Sempre nell’articolo VI degli accordi si trova, infatti,
soltanto la facoltà dei governi, e non più l’obbligo, a cooperare per contenere i
movimenti internazionali di capitale. Cadeva contestualmente anche l’ipotesi di
concedere al Fondo il potere di imporre ai paesi membri il controllo sui flussi di capitale.
In secondo luogo, il linguaggio utilizzato nell’intero accordo era un linguaggio
estremamente tecnico e complesso, con lo scopo di rendere il meno agevole possibile la
comprensione dei meccanismi profondi del Fondo, allontanando l’idea che potesse
essere assimilato ad una banca sovranazionale. In tal senso, scomparvero anche nel
disegno finale tutti i riferimenti a strumenti di vigilanza e regolamentazione
internazionale a scopo prudenziale.
Anche la struttura di governo del Fondo rifletté l’avversione del mondo finanziario
americano alla nascita di una struttura finanziaria sovranazionale. Se, infatti, il piano di
Keynes e del Tesoro britannico desiderava istituire un governo indipendente di esperti,
39
gli americani fecero pressioni, coronate infine da successo, per la creazione di un
consiglio di amministrazione, il Board of Directors, formato da funzionari a nomina
governativa, che avrebbero dovuto lavorare nella sede di Washington a tempo pieno. È
facilmente intuibile come questa scelta poneva dei limiti alla discrezionalità delle scelte
del Fondo, in quanto la nomina governativa dei suoi direttori prestava il fianco al
controllo politico dell’organismo da parte dei diversi governi nazionali, facendo
tramontare definitivamente l’idea di avere un’istituzione forte di un’irreprensibile
autorevolezza tecnica.
Nonostante gli scarti tra i piani e le realizzazioni concrete, il Fondo Monetario
Internazionale fu comunque un’innovazione che non aveva precedenti nella storia, che
andò ad occupare un posto di rilievo all’interno del panorama finanziario internazionale.
Tuttavia, nei primi quindici anni di attività la domanda di finanziamenti fu piuttosto
scarsa, portando il Fondo a non avere un ruolo ben definito, anche per la concomitanza
del Piano Marshall che forniva ai paesi europei tutti i fondi di cui essi avevano bisogno
per la ricostruzione post-bellica.
L’anno chiave per il Fondo, che gli conferì un ruolo davvero cruciale, fu il 1958, con il
ripristino della convertibilità valutaria dei maggiori paesi europei, i quali, contestualmente,
furono obbligati al rispetto delle prescrizioni dell’articolo VIII dello Statuto. Da quel
momento, il sistema si trasformò in un insieme interagente di Stati-nazione, regole e
mercati valutari e dei capitali in crescente espansione. Proprio il ripristino della
convertibilità dei paesi europei era, d’altronde, stato possibile in seguito ad un costante
disavanzo della bilancia dei pagamenti americana: se nel biennio 1956-1957 il saldo era
ancora in sostanziale equilibrio, il deficit cominciò a crescere dal 1958, arrivando a 4
miliardi e crescendo poi a 6 miliardi nel 1959. Proprio nel 1959 le passività esterne degli
Stati Uniti eguagliarono, per la prima volta, le riserve in oro, per poi superarle
costantemente nel corso degli anni successivi a fronte di persistente deficit annuale della
bilancia dei pagamenti.
Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, quindi, il Fondo
Monetario Internazionale si trovò al centro di un sistema internazionale, dopo la
ripristinata convertibilità del 1958, in cui però due nuovi elementi – gli squilibri prodotti
dal disavanzo statunitense e l’aumento della mobilità di capitali – contribuivano a creare
un effetto potenzialmente destabilizzante.
Il centro dei problemi, che si riflette anche in un aumento delle discussioni in merito a
partire proprio dall’inizio degli anni Sessanta, era certamente la questione della liquidità
internazionale. Tuttavia, tale questione nascondeva in realtà al suo interno almeno tre
diverse problematiche, che intrecciavano tra loro i propri effetti, riguardando la quantità
e la qualità delle risorse del Fondo e, soprattutto, il ruolo che il dollaro era andato
assumendo all’interno del panorama finanziario internazionale.
Il primo problema riguardava, appunto, le risorse del Fondo, che non erano più
adeguate a sostenere l’aumentato volume dei commerci internazionali. Questa difficoltà
ebbe una soluzione relativamente facile, che venne raggiunta grazie all’aumento delle
quote dei rispettivi paesi alle risorse ordinarie del Fondo, attraverso un aumento del 50%
nel 1959 e del 25% nel 1966. Questi aumenti, però, rivelavano anche il secondo
problema circa le riserve del Fondo. Quest’ultimo, infatti, non avevano una proprio
capacità di creazione monetaria e dipendeva esclusivamente di risorse conferite dai paesi
membri in valuta nazionale. In caso di emergenza, quindi, difficilmente il Fondo avrebbe
40
avuto le disponibilità necessarie a risolvere i possibili problemi dei paesi più grandi, come
ad esempio gli Stati Uniti e la Gran Bretagna.
Una risposta parziale a quest’ultima problematica venne dalla creazione del cosiddetto
G-10: i dieci paesi più industrializzati siglarono, nel 1962, i General Arrangements to Borrow
(Gab), un accordo parallelo al Fondo, al fine di costituire una scorta di risorse utilizzabili
aggirando i macchinosi procedimenti del Fondo. In particolar modo il controllo politico
di queste risorse pose alcune questioni di non secondaria importanza circa l’autorità a cui
dovesse essere demandata la decisione finale: si arrivò, infine, ad un accordo che
prevedeva un meccanismo cosiddetto «a doppia chiave»: l’accesso ai fondi del Gab
doveva essere quindi accordato dal Board dell’Fmi, dalla maggioranza dei paesi aderenti,
nonché dai tutti i paesi la cui valuta fosse inserita nel prestito.
Il terzo problema inerente la questione della liquidità internazionale, certamente il più
difficile da risolvere e che, a ben vedere, fu una delle cause principali del crollo di Bretton
Woods, riguardava il dollaro, ed in particolare il suo utilizzo come principale fonte di
liquidità internazionale conseguentemente ai persistenti disavanzi nella bilancia dei
pagamenti statunitense verificatesi dalla fine degli anni Cinquanta in poi.
In questo senso, il sistema monetario internazionale si era evoluto in una particolare
tipologia egemonica: il cosiddetto dollar standard. Il difetto centrale del sistema era che la
disponibilità di liquidità a livello mondiale, posto il dollaro come valuta di riserva
internazionale e strumento di pagamento nei flussi commerciali, finiva per dipendere
dalle scelte di un paese in cui vigeva un regime di fiat standard, ponendo così enorme
pressione sulle scelte di politica monetaria del paese perno del sistema, dalle quali
derivava, in sostanza, la fiducia generale.
Ci si trovava di fronte, quindi, al già richiamato dilemma Triffin. Gli Stati Uniti
potevano, da una parte, correggere gli squilibri della propria bilancia dei pagamenti,
costringendo però il resto del mondo a subire gli effetti deflazionistici di tali politiche e
rinunciando contestualmente al ruolo egemonico che gli veniva conferito dall’emettere la
valuta di riferimento a livello internazionale. Oppure, le autorità americane avrebbero
potuto, come fecero, alimentare la domanda mondiale di liquidità in dollari fino al punto
che un evento di qualsiasi natura sopraggiungesse a far crollare la fiducia nel dollaro,
scatenando una nuova corsa alla convertibilità come accadde nel 1931.
Se la soluzione più immediata e logica al problema sarebbe stata la creazione di una
qualche forma di moneta sovranazionale, l’effettiva messa in pratica di questa soluzione
andava incontro a problemi difficilmente sormontabili: da una parte, infatti, gli Stati Uniti
si schierarono contro il progetto per tema di perdere la posizione egemonica derivante
dalla posizione del dollaro; dall’altra parte, garantire la fiducia di una moneta
sovranazionale senza nessuna autorità preposta a questo compito sarebbe stato un
compito decisamente difficile da portare a termine.
Nel corso degli anni Sessanta, per le motivazioni già richiamate, le posizioni
cominciarono a cambiare, anche in conseguenza, da un lato, delle ventilate minacce
portate avanti dal governo francese di dare istruzione alla Banca di Francia di convertire
in oro i dollari detenuti in eccesso; dall’altro, dell’aumento del prezzo dell’oro sul mercato
libero, che superò il prezzo di 35 dollari all’oncia, segnalando una crescente sfiducia dei
mercati nella forza del dollaro.
41
Da questa problematica scaturirono, a ben vedere, le novità introdotte tra la seconda
metà degli anni Sessanta e la metà degli anni Settanta. Se i già citati Gab costituivano il
riconoscimento del ruolo dell’Fmi, ma rimanevano strumenti molto limitati,
l’introduzione, nel 1969, dei Diritti Speciali di Prelievo (Dsp) costituiva la prima
istituzione di una forma di moneta sovranazionale: la loro attuazione, però, era stata
inserita in un quadro così dettagliato di disposizioni limitative che ne rese l’impatto
concreto piuttosto limitato. Dopo la sospensione della convertibilità del dollaro
nell’agosto del 1971, infine, venne approvata nel 1976 quando venne sospeso l’obbligo
del mantenimento dei cambi fissi.
5.2. I grandi centri finanziari mondiali
Lo sviluppo dei grandi centri finanziari mondiali, nel periodo che va dal 1945 al 1976,
non deve essere confuso con la storia del sistema monetario internazionale, anche se i
meccanismi di funzionamento di quest’ultimo ebbero certamente un’influenza notevole
nell’orientare scelte e decisioni. Inoltre, le piazze più importanti ebbero un’evoluzione
che fu solo in parte uguale a quella del progresso economico e politico delle rispettive
nazioni. Wall Street, ad esempio, pur in posizione di indiscussa forza, non lo fu mai in
maniera così predominante come lo fu, invece, il peso dell’economia americana a livello
mondiale; di converso, la City di Londra, la cui storia post-bellica fu certamente
caratterizzata da un evidente declino, non perse mai del tutto la propria influenza, ed anzi
recuperò molta della strada perduta a partire dagli anni Sessanta, quando divenne il
centro del mercato degli eurodollari e delle eurobbligazioni, andando ad occupare un
posto nella finanza mondiale neanche lontanamente paragonabile al peso specifico
dell’economia britannica.
a. Wall Street e il sistema bancario statunitense
Alla conclusione della Seconda guerra mondiale New York era certamente emersa
quale centro finanziario più importante a livello globale, anche in conseguenza del ruolo
degli aiuti finanziari statunitensi alla ricostruzione europea. Numerosi fattori
contribuirono a rinsaldare, con gli anni Cinquanta, la posizione di Wall Street come
centro finanziario del pianeta. In primo luogo, il ruolo del dollaro era fondamentale, in
quanto la valuta americana rappresentava il mezzo di pagamento e la valuta di riserva a
livello internazionale, senza alcun rivale all’orizzonte, essendo anche l’unica moneta
convertibile in oro; inoltre, gli Stati Uniti potevano avvalersi, da una parte, di un’enorme
quantità di riserve auree, accumulate durante la guerra, dall’altra di un’istituzione, la
Federal Reserve Bank of New York, che ricopriva un ruolo decisivo nelle questioni
monetarie sia sul mercato interno che a livello internazionale.
Tra la fine degli anni Quaranta e negli anni Cinquanta, New York sviluppò un vivace
ambiente bancario e finanziario. Le banche commerciali newyorchesi erano diventate le
più grandi del mondo, superando di gran lunga le corrispettive londinesi con risorse
complessive che ammontavano nel 1954 a 32,3 miliardi di dollari, contro i 19,8 miliardi
degli inglesi. Gli affari internazionali venivano molto curati, con uffici dedicati ad attività
come la compravendita di valute estere, il finanziamento dei commerci e i prestiti ad
istituti bancari stranieri. Inoltre, nel 1955, sette banche statunitense possedevano filiali
all’estero, mentre, di converso, erano ventuno le banche straniere, appartenenti a dodici
diverse nazioni, che avevano delle filiali sulla piazza di New York, svolgendo per la
42
maggior parte attività di compravendita valutaria, specialmente in relazione alla valuta del
paese di provenienza.
Le banche di investimento, insieme a broker e mediatori in cambi esteri, società di
gestione dei conti connessi al commercio estero, spedizionieri doganali, rappresentanti di
import-export, case d’accettazione e di sconto – anche se non sviluppate ed efficienti
come a Londra – ; tutte aziende specializzate erano presenti contemporaneamente sul
mercato newyorchese, fornendo una vasta e completa gamma di servizi finanziari.
Contestualmente, il New York Stock Exchange riprese a crescere fin dai primi anni
Cinquanta, in parallelo con la fase espansiva dell’economia statunitense: il volume delle
transazioni aumentò vertiginosamente, passando da una media di 312 milioni annui
investiti in titoli della fine degli anni Quaranta, fino ai 667 milioni del 1959 e portando
anche alla crescita del numero degli investitori individuali, segno di una crescente
democratizzazione della borsa americana. Più o meno nello stesso arco di tempo, l’indice
Dow Jones sperimentò una notevole crescita complessiva, corrispondente al 240% per il
periodo 1953-1960: pari a 260 punti nel dicembre del 1953, il Dow Jones raggiunse quota
386 nel dicembre dell’anno successivo, oltrepassando per la prima volta il picco più alto
toccato nell’agosto del 1929, e raggiungendo 650 al termine del 1960.
Alcune problematiche, tuttavia, permanevano, facendo di New York un centro
certamente egemone a livello mondiale che, tuttavia, non poteva dirsi né unico, né
completo ed efficiente in ogni settore finanziario. I titoli negoziati sul mercato
newyorchese, ad esempio, erano ancora titoli quasi esclusivamente statunitensi: gli anni
Cinquanta testimoniarono, a tal proposito, una nuova fase di espansione delle
multinazionali americane, come ad esempio la General Electric, la Standard Oil Co. of
New Jersey, o l’IBM. Sebbene alla contrattazione dei titoli delle imprese americane
partecipassero mediatori provenienti da tutto il mondo, rendendo giustizia quindi al
ruolo internazionale di Wall Street, l’emissione di titoli esteri era ancora troppo costosa,
limitando così i prestiti internazionali, con qualche significativa eccezione, come quella
del finanziamento della CECA.
Anche la legislazione vigente negli Stati Uniti per il settore bancario e finanziario
poneva non pochi ostacoli al pieno sviluppo delle potenzialità degli istituti americani. In
particolare, le banche commerciali ebbero diverse difficoltà nel reperire i fondi necessari
per soddisfare le necessità di credito che un’economia in grande fase espansiva offriva.
Se, durante gli anni Cinquanta, la domanda dei prestiti raddoppiò, la raccolta dei depositi
bancari aumentò solamente del 50%. Principale indiziato di questa situazione era,
nuovamente, la Regulation Q, la quale, impedendo alle banche di offrire alti interessi sui
depositi, limitava di fatto l’appetibilità dei depositi stessi. Escluso, quindi, lo strumento
del tasso di interesse come metodo per attrarre fondi, le banche newyorchesi
cominciarono un’intensa attività di fusioni che servivano ad incrementare le risorse da
mettere a disposizione della crescente domanda creditizia proveniente dal settore
dell’economia reale. Fu, in questo modo, che si realizzò la fusione nel 1955, tra la
Manhattan Bank, la National City Bank e la First National Bank; quella tra la J.P. Morgan
e il Guarantee Trust, nel 1959; infine, quella, del 1961, tra la Central Hanover Bank e il
Manufacturers Trust.
Tuttavia, sebbene le banche commerciali diventarono, in questo modo, le più grandi al
mondo, la loro possibilità di crescita era tutt’altro che illimitata, soprattutto per via della
legislazione vigente che impediva l’apertura di filiali in altri Stati. Fu così che sorsero
nuovi strumenti finanziari pensati proprio per accrescere le risorse delle varie banche. Il
43
principale di essi fu il certificato di deposito che, lanciato nel 1961, per la prima volta,
dalla First National Bank, poteva essere scambiato anche su un mercato secondario
appositamente creato in precedenza.
Anche se le banche newyorchesi dovettero superare gli ostacoli posti dalla legislazione
americana e da diverse misure prese dal governo federale per limitare l’esportazione di
capitale statunitense, nonché una rinascita della City legata al mercato delle
eurobbligazioni, esse rimasero comunque in una posizione di dominio circa la finanza
internazionale, anche se la piazza in cui operavano poteva non sempre essere quella di
New York.
Proprio gli anni Sessanta determinarono il momento in cui vi fu la prima grande
espansione multinazionale degli istituti bancari americani. Segno più evidente di tale
sviluppo fu la crescita del numero delle filiali delle banche statunitensi all’estero, le quali
passarono dalle 131 del 1950, a 899 nel 1986, concentrata in larghissima parte nei paesi
industrializzati e nelle piazze finanziarie più importanti. Il luogo preferito era,
ovviamente, l’Europa, dove si contavano, nel 1975, 113 filiali – di cui 58 solo a Londra –
e 29 uffici di rappresentanza delle otto maggiori banche americane.
Nel corso degli anni Sessanta, inoltre, con sempre maggiore intensità le banche
statunitensi spostarono le loro attività in Europa, con il fine ultimo di aggirare una
legislazione bancaria che negli Stati Uniti si era fatta sempre più restrittiva, con le
restrizioni agli investimenti diretti delle multinazionali del 1965 e l’aumento dei tassi
ufficiali di interesse nel 1966 e poi nel 1969, che tuttavia non eliminarono il massimale
previsto dalla Regulation Q. A tal fine, ad esempio, per prima la First National Bank, nel
novembre del 1959, utilizzò la propria filiale di Londra per raccogliere depositi in dollari
per poi trasferirli sulla piazza di New York e finanziarie prestiti negli Stati Uniti.
In generale, nel corso del decennio, le banche statunitensi aumentarono molto la
propria quota nel mercato degli eurodollari, soprattutto per mezzo della piazza londinese,
passando dal 17% del 1958 al 54%, registrato nel 1969. Le medesime filiali della City
furono utilizzate anche, dopo la legislazione del 1963 e del 1965 – ovvero,
rispettivamente, la Intereste Equalization Tax e la Voluntary Foreign Credit Restraint
Programme, che chiusero il mercato dei capitali alle emissioni straniere – per effettuare
operazioni di emissioni di prestiti internazionali, andando ad occupare un ruolo
importante nel mercato delle eurobbligazioni, in particolar modo tra il 1963 e il 1972,
quando otto filiali di banche statunitensi apparivano tra i venti più grandi intermediari su
questo tipo di mercato. Le banche americane, quindi, attraverso le proprie filiali
londinesi, riuscirono ad aggirare le varie misure restrittive vigenti negli Stati Uniti,
partecipando con notevoli guadagni al mercato delle eurobbligazioni e degli eurocrediti,
che fecero parte da quel momento di una strategia globale.
b. La City di Londra
Alla conclusione della guerra le istituzioni secolari, gli strumenti e le competenze che
caratterizzavano la piazza finanziaria di Londra erano intatte e immutate nel loro
prestigio e nelle loro capacità. Nonostante l’avanzata decisa di Wall Street, le ambizioni
internazionali della City non era scemate, né tanto meno si era, apparentemente,
indebolito il suo comparto bancario: la Midland Bank, ad esempio, era al 1945 ancora la
più grande banca del mondo, seguita dalla Bank of America.
44
Alcuni elementi di carattere economico, però, fecero si che il declino della City fosse
evidente almeno per tutta la durata degli anni Cinquanta e, pur recuperando nel decennio
successivo, non tornò mai ai livelli né degli anni Venti né, tanto meno, del periodo pre1914. Non era solo l’ascesa dell’egemonia americana a minare il primato finanziario
inglese. La cornice economica generale dell’economia britannica, infatti, era, nel secondo
dopoguerra, caratterizzata da una crescente debolezza: la scarsa solidità delle industrie
inglesi faceva sì che mancassero, alla City, i costanti flussi di capitale in uscita per
finanziare il commercio e gli investimenti internazionali, togliendo uno dei tasselli
essenziali su cui si era basata la complessa struttura finanziaria inglese nei decenni del suo
splendore. Il corollario di questa sofferenza sul piano industriale era rappresentato dalla
debolezza della moneta nazionale, la sterlina, che non veniva più usata come strumento
di pagamento e valuta di riserva internazionale, superata in questo dal dollaro, eliminando
un altro degli elementi essenziali al successo della finanza inglese. Le due importanti
svalutazioni della sterlina, inoltre, nel 1949 e nel 1967, non andarono certo nella direzione
di un ripristino della sua stabilità e credibilità a livello internazionale. In ultimo, le
politiche governative sembravano orientate, nel primo quindicennio successivo al 1945,
ad un mantenimento del controllo sui cambi e a restringere la libertà di movimento di
capitali. Sopravviveva, inoltre, uno spiccato dirigismo nell’allocazione del credito grazie
ad un’attiva politica del Tesoro che agiva attraverso le direttive della Banca d’Inghilterra.
Come, si dice, sosteneva lo stesso Keynes, la nazionalizzazione delle banche non era
necessaria, perché esse erano, di fatto, già nazionalizzate nella pratica quotidiana.
Il declino della City non fu, tuttavia, una débâcle. Se in alcuni settori essa,
effettivamente, perse terreno, in altri la finanza inglese mantenne tutto il suo potere. La
rete internazionale degli istituti bancari inglesi era, infatti, ancora la più estesa, con un
numero di filiali oltremare che continuò a crescere per tutto il periodo, passando dalle
2.315 del 1938, alle 3.612 del 1955. La più grande banca multinazionale britannica, la
Barclays Bank Dco, contava, sempre nel 1955, ben 997 filiali estere, contro le 55 della
National City Bank americana. La stessa Londra era la sede di 69 filiali e uffici di
rappresentanza di istituti bancari stranieri, che diventarono 80 nel 1960. Le merchant bank
continuavano a investire nel commercio internazionale – che rappresentava, ad esempio,
per la Schroder il 30% dei guadagni nel periodo 1946-1953 e il 25% nel 1954-1958 – ,
anche se l’attività di accettazione e di sconto legata al finanziamento del commercio
estero britannico salì in maniera vistosa: se, infatti, alla fine degli anni Venti il 70% dei
titoli era emesso all’estero, negli anni Cinquanta quella percentuale era scesa al 37%.
Ciononostante, le competenze e le connessioni di lungo periodo della finanza
britannica, mantennero la City quale luogo principale del finanziamento del commercio
internazionale, in quanto, nonostante la supremazia del dollaro, metà dei flussi
commerciali internazionali continuarono ad essere denominati in sterline. Nel corso degli
anni Quaranta e Cinquanta, inoltre, riaprirono molti mercati che avevano
tradizionalmente la propria sede a Londra, come il mercato della gomma nel 1946, dello
stagno nel 1949, del cacao nel 1951, del piombo nel 1952; dello zinco, del rame e della
lana nel 1953, ed infine quello del caffè, riaperto nel 1957. Il destino di questi mercati di
materie prime fu diverso da prodotto a prodotto: se, ad esempio, il London Metal
Exchange riuscì a reggere la competizione di New York, il mercato della lana si spostò a
Sidney mentre quello della gomma in estremo Oriente. Di contro, il mercato dell’oro,
riaperto nel 1954 a Londra, riguadagnò la sua centralità nella piazza di Londra a scapito
sia di New York che di Zurigo. Un altro dei settori in cui le competenze finanziarie
inglesi erano ancora predominanti e dove Londra mantenne il suo primato era quello
45
assicurativo: la Lloyd’s rimase, infatti, un gigante, soprattutto nei rami dell’assicurazione
contro gli incendi, infortuni e in quello delle assicurazioni marittime
L’emissione di titoli esteri, invece, fu il settore in cui la City perse più terreno,
soprattutto nei confronti di New York, ma anche rispetto a Zurigo e Parigi, con un trend
discendente osservabile anche sul lungo periodo. È stato infatti calcolato che, se la media
precedente alla Prima guerra mondiale era di 200 milioni di sterline di emissioni di prestiti
esteri all’anno, questa scese a 150 milioni alla fine degli anni Venti per poi precipitare
durante la depressione economica degli anni Trenta, raggiungendo la media annua di 31
milioni di sterline nel periodo 1931-1938. Nonostante dopo il 1945 vi fu, rispetto almeno
agli anni Trenta, una piccola ripresa, la media annua per il periodo tra il 1950 e il 1958 si
stabilizzò sui 61 milioni annui, andando a rappresentare il 6% del totale delle emissioni
lanciate nel paese nel 1961.
Quest’ultimo dato, se osservato congiuntamente al fatto che la maggior parte delle
filiali estere delle banche era nei paesi dell’area della sterlina – il 75% si trovavano infatti
in Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica – e all’aumento della percentuale del
finanziamento dei commerci britannici, dà la misura di un ripiegamento della finanza
inglese sul Commonwealth e, in generale, sull’area della sterlina. È interessante notare
come gli inglesi strutturarono su questo gruppo di paesi – che comprendeva le colonie
più dodici Stati indipendenti – un sistema finanziario che ricordava molto quello
mondiale ottocentesco del quale la Gran Bretagna era stato il centro indiscusso. Infatti, la
City era ora il perno intorno al quale funzionava l’area finanziaria della sterlina: venivano
forniti capitali a lungo termine ai paesi dell’area, garantendo l’assorbimento, senza dazi,
delle loro esportazioni. I meccanismi che guidavano questi flussi di capitale e manufatti
erano basati su principi antichi: le monete di quest’area venivano scambiate a tassi fissi; si
operavano controlli uniformi sui cambi rispetto ai paesi al di fuori dell’area; vi era una
libera circolazione di capitali; infine, si aveva una condivisione delle riserve. In questo
contesto la sterlina rivisse, seppur in modo limitate e geograficamente ristretto, il suo
ruolo ottocentesco, funzionando da strumento di pagamento e da valuta di riserva.
Tuttavia, dall’inizio degli anni Sessanta, la congiuntura economica che portò
all’accumulazione di dollari in Europa e alla nascita, come visto in precedenza, degli
euromercati, permise a Londra di recuperare il terreno perduto e tornare ad essere uno
dei maggiori centri finanziari internazionali con rilevanza mondiale, e non più solo
regionale: in questo decennio, infatti, la City assunse il controllo della parte maggioritaria
del mercato degli eurodollari e delle eurobbligazioni ponendosi al centro delle nuove
tipologie di transazioni bancarie internazionali.
Alcune condizioni contribuirono alla rinascita della City. Tra gli elementi principali vi
erano le tradizionali competenze in campo finanziario della piazza londinese, accumulate
grazie ad una storia plurisecolare e che erano solamente in attesa di poter ricominciare a
svolgere le funzioni che meglio conoscevano. Il secondo fattore era costituito dalla
tendenza delle istituzioni britanniche ad incoraggiare e stimolare questo tipo di attività: il
Tesoro e la Banca d’Inghilterra esprimevano una chiara volontà di sorreggere le
aspirazioni internazionali della finanza inglese: di importanza centrale, in questo senso, fu
l’esenzione dei depositi denominati in valuta straniera dalle varie restrizioni che si
applicavano invece ai depositi in sterline, conducendo nella pratica alla nascita di due
attività finanziarie nettamente separate tra loro: una interna, strettamente regolata e
denominata in sterline; una seconda verso l’estero, con ampie libertà e denominata in
valuta straniera. Infine, deve essere citata la legislazione bancaria degli altri maggiori
46
paesi, che facevano in modo di far confluire i dollari verso Londra, vista le specifiche
misure statunitensi della Regulation Q, o quelle di paesi come Francia, Svizzera, Italia e
Germania, che tendevano a scoraggiare i depositi esteri.
Sfruttando le possibilità offerte dal nuovo mercato degli eurodollari, la finanza inglese
rinacque: per dare una misura di questa rinascita, e del dominio londinese degli
euromercati, si calcola che, alla fine degli anni Sessanta, i prestiti con fondi in eurodollari
venivano negoziati a Londra per una cifra pari all’80% del totale. Un altro dato che
permettere di cogliere la nuova posizione della City nel panorama mondiale è il numero
delle filiali delle banche estere, per conto delle quali venivano svolte molte delle
transazioni che avevano luogo nella City; numero che crebbe notevolmente, passando da
69 nel 1955, a 159 nel 1970, e arrivando a 243 nel 1975, il doppio rispetto alle filiali estere
presenti a New York nello stesso anno.
Per far fronte alla nuova mole di affari, nonché accrescendone anche il peso a livello
internazionale, venne inaugurata nella City una nuova tipologia di istituto finanziario: i
consorzi bancari. Questi ultimi – veri istituti e non semplici sindacati – erano costituiti da
diversi gruppi di banche di varia nazionalità, che si univano per perseguire una strategia
finanziaria condivisa, per lo più costituiti da banche che non avevano le risorse necessarie
per lanciarsi da sole in operazioni finanziarie sui nuovi euromercati, che venivano
considerati incerti e quanto mai rischiosi. Il primo di questi consorzi bancari, la Midland
and International Bank Limited, venne fondato nel 1964 e andava a riunire la Midland
Bank, la Toronto Dominion Bank, la Standard Bank e la Commonwealth Bank of
Australia; molti altri ne vennero fondati negli anni successivi, tra cui il maggiore tra essi,
che nacque nel 1970 con il nome di Orion Bank.
Gli euromercati ebbero un duplice effetto sulla finanza inglese e sulla City. Se, da una
parte, le nuove possibilità finanziarie determinarono certamente una rinascita
dell’importanza di Londra come centro internazionale, queste determinarono anche una
maggiore esposizione alla concorrenza degli istituti inglesi. I segni di tale concorrenza
sono perfettamente rintracciabili nelle statistiche: se, nel 1958, più del 60% del mercato
degli eurodollari era controllato dalle banche britanniche, nel 1968 questa quota era scesa
al 30%, con un crollo particolare sperimentato dalla quota di mercato delle clearing bank,
che passò dal 22% al 2% in appena una decade. Tale situazione si riflettevano anche nel
mercato delle eurobbligazioni, dove solamente tre case britanniche – Warburg,
Rothschild e Hambro – si posizionavano nella lista delle venti banche che guidarono le
emissioni nel periodo 1963-1972. L’elemento che appare più importante sottolineare,
tuttavia, è che la rinascita di Londra fondata sulle possibilità concesse dagli eurodollari
gettò le basi per quella separazione, richiamata in precedenza, dei destini della City, della
finanza inglese, da quelli dell’economia e dell’industria britannica, così come dai destini
della sua moneta, la sterlina, che rimase marginale in tutte le nuove operazioni condotte
in quegli anni.
47