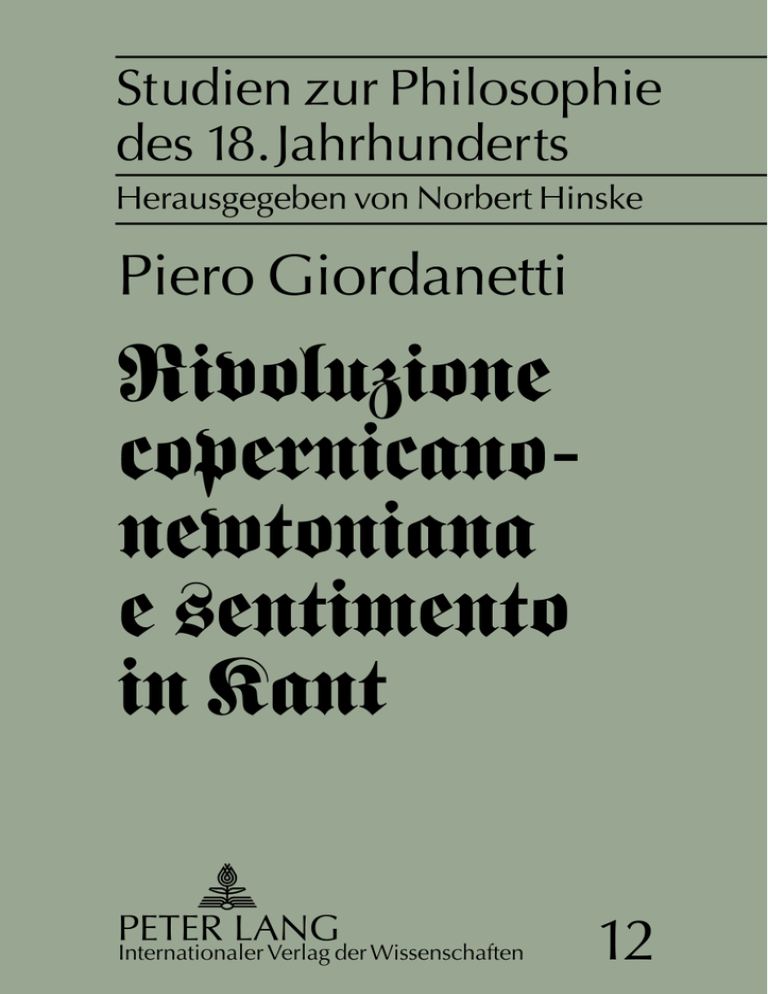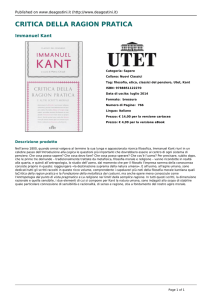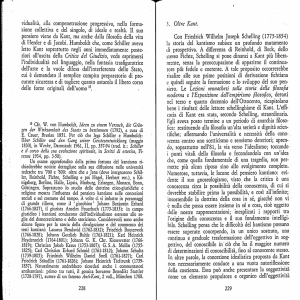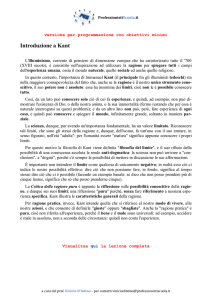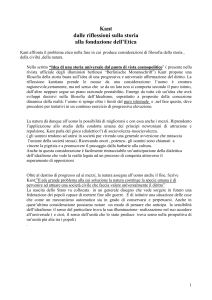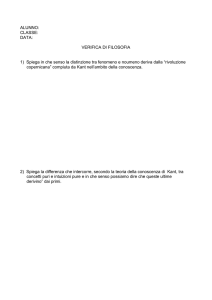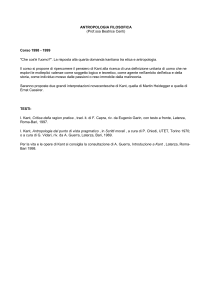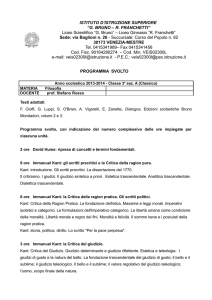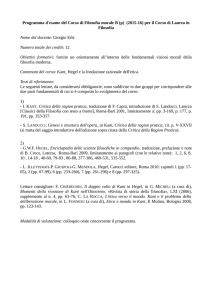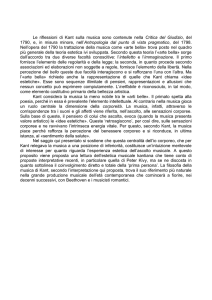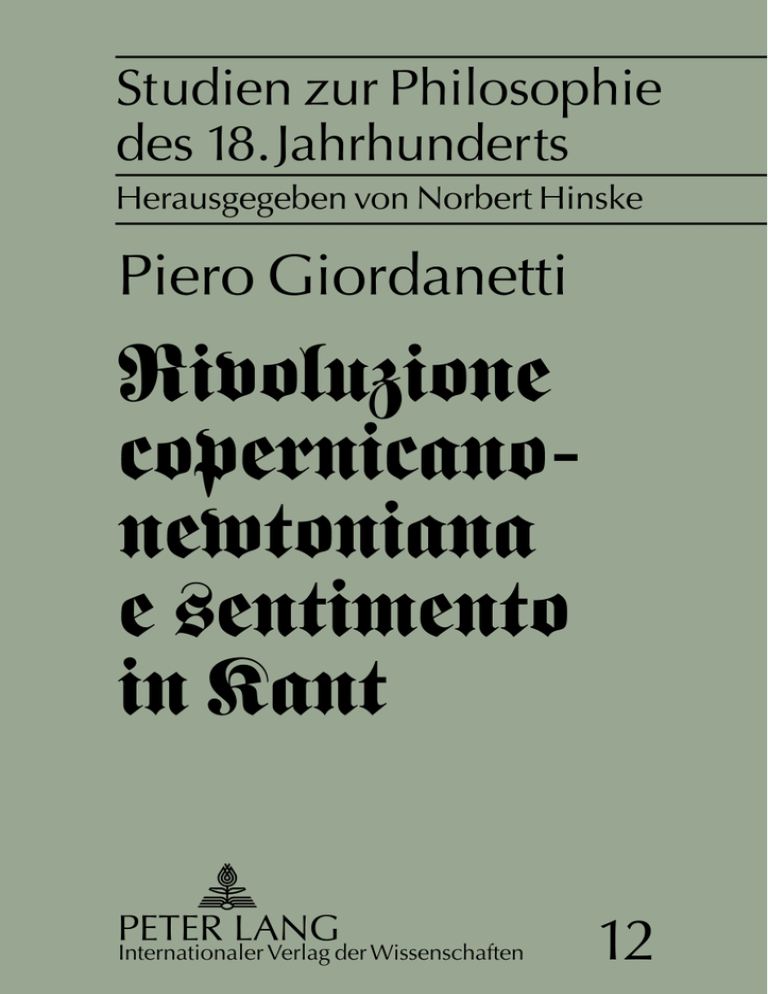
Introduzione
Fra le interpretazioni della svolta copernicana si possono, in modo del tutto generale, distinguere letture orientate a cogliere in Kant il distruttore della metafisica ed esegesi volte a vedere nella sua filosofia la fondazione di una nuova metafisica. Nella prima corrente rientra, ad esempio, Per la storia della religione e
della filosofia in Germania di Heinrich Heine, che presenta Kant come il Robespierre della filosofia, il cui pensiero è dotato di una forza micidiale e annientatrice; la Critica della ragion pura è la lama che ha tagliato la testa al deismo.
Carducci riprende nel 1870 questa immagine in Versaglia:
E il giorno venne: e ignoti, in un desio / Di veritade, con opposta fé, / Decapitaro,
Emmanuel Kant, Iddio, / Massimiliano Robespierre, / il re. / Oggi i due morti sovra
il monumento / Co ‘l teschio in mano chiamano pietà, / Pregando, in nome l’un del
sentimento,/ l’altro nel nome de l’autorità. / E Versaglia a le due carogne infiora /
L’ara ed il soglio de gli antichi dì.../ Oh date pietre a sotterrarli ancora, / Nere macerie de le Tuglierì (21 settembre 1871)1.
L’interpretazione della filosofia kantiana come pensiero distruttivo è presente
anche in Victor Cousin (1792-1867). Nelle lezioni che compaiono come parte
del Cours de l’histoire de la philosophie moderne del 1842 egli paragona la filosofia di Kant alla rivoluzione francese; essa, sottolinea, prende le mosse dalle
leggi pure della ragione umana, prescindendo da ogni esperienza e propugnando
il disprezzo nei confronti del passato; la rivoluzione inizia con la dichiarazione
dei diritti originari ed eterni dell’essere umano, indipendentemente dalla considerazione di qualsiasi società empirica e di qualsiasi storia. Per Cousin, Kant è
scettico; al suo scetticismo si deve contrapporre il metodo psicologico, come
teoria della coscienza rivolta tanto agli oggetti esterni quanto agli stati interni2.
Ancora secondo Max Scheler, lo stoicismo e la morale kantiana negano
l’umiltà e la soppiantano con l’orgoglio. Il superbo non vuole farsi regalare nulla, non vuole accogliere nulla né sentire né comprendere il senso del mondo
quando conosce; non vuole sapere nulla di essenziale del mondo poiché lascia
1
2
G. CARDUCCI, Giambi ed Epodi, in Poesie di Giosuè Carducci 1850-1900, Bologna 1924,
pp. 68-70, qui p. 70. Cfr. B. CROCE, La preistoria di un paragone, in Conversazioni
critiche, Serie seconda, Bari 1950, pp. 292-294 e D. CANTIMORI, Studi di storia, Torino
1959, pp. 655-664. Sul dibattito filosofico e scientifico in Germania dal primo diffondersi della filosofia kantiana al ritorno a Kant della seconda metà dell’Ottocento si veda
S. POGGI, I sistemi dell’esperienza. Psicologia, logica e teoria della scienza da Kant a
Wundt, Bologna 1977.
Sono tradotte in italiano da F. TRINCHERA, con note di P. GALLUPPI (Napoli 1843) con il
titolo Lezioni sulla filosofia di Kant. Si veda anche Philosophie de Kant, Paris 1857.
16
Rivoluzione copernicano-newtoniana e sentimento in Kant
entrare in sé solo ciò «che ha pagato il tributo alle sue cosiddette 12 categorie
dell’intelletto: meglio ai suoi 12 ghiribizzi comuni e idee coatte generali»; un
essere che crede che il suo intelletto prescriva alla natura le sue leggi e che non
ci sia nessun altro giudice al di sopra di lui non può sapere nulla del mondo3. Il
riferimento è alla «Prefazione» alla seconda edizione della Critica della ragion
pura.
Anche Simmel coglie un aspetto soggettivistico nella teoria della conoscenza kantiana. Egli taccia Kant di ingenuità, in quanto avrebbe accettato la conoscenza matematica ed empirica esistente come fondamento di ogni ricerca
sull’essenza del conoscere. «L’analisi del conoscere ha per lui esaurito il proprio
compito, quando abbia dimostrato a sufficienza le condizioni della scienza esistente»4. A questa impostazione Simmel contrappone la tesi che ogni scienza
deve essere fondata in un punto ultimo su cui non si può ulteriormente indagare,
ma la cui saldezza necessaria sostiene l’intero edificio; a suo avviso, la giustificazione dei principi primi dell’ambito conoscitivo risiede in una dimensione forse pratica, forse biologica o anche religiosa. Kant, dunque, commette l’errore di
escludere questo punto ultimo e di ricercare il fondamento del conoscere
all’interno del conoscere stesso; le sue dimostrazioni si muovono in circolo poiché non hanno alcun punto d’appoggio al di fuori della propria cerchia.
Diversa dalle precedenti è la lettura di Ernst Cassirer, secondo il quale la rotazione dell’osservatore nella svolta copernicana consiste nel fatto che «facciamo sfilare dinanzi a noi il tutto delle funzioni conoscitive di cui la ‘ragione’ dispone in generale, e ci presentifichiamo ogni singola funzione nella sua specie di
validità [Geltungsart] necessaria ma anche definita e delimitata in modo caratteristico»5. Rotazione è qui percorrere in successione l’intera serie delle posizioni
che possiamo assumere nei confronti della verità e dell’oggetto. Esiste, in primo
luogo, una forma di oggettività che chiamiamo ordinamento spaziale delle cose:
il nostro compito sarà comprenderla non in virtù di uno spazio cosmico assoluto,
ma fondandoci sulle leggi della costruzione geometrica. Analogamente, esistono
relazioni tra costrutti numerici: il nostro compito consisterà nel cogliere questo
nesso come necessario muovendo dal procedimento della costruzione dell’intero
ambito dei numeri a partire dal numero uno. Infine, esistono corpi fisici e forze
fisiche che costituiscono il mondo della natura per intendere i quali non dobbiamo muovere dall’esistenza empirica degli oggetti ma dalla natura della funzione
3
4
5
Cfr. M. SCHELER, Il valore della vita emotiva, a cura di L. BOELLA, Milano 1999, p.
166.
G. SIMMEL, Kant. Sedici lezioni berlinesi, a cura di A. MARINI e A. VIGORELLI, Milano
1986, p. 98.
E. CASSIRER, Vita e dottrina di Kant, Firenze 1984, p. 178.
Introduzione
17
conoscitiva empirica, dalla ragione che opera nell’esperienza e nei suoi giudizi.
La rivoluzione nel modo di pensare consiste nel fatto che si inizia dalla riflessione della ragione su se stessa, sui suoi presupposti e principi fondamentali, sui
suoi problemi e compiti; la riflessione sugli oggetti seguirà in un secondo tempo.
La metafisica, se mai in generale vuole avere per sé un determinato contenuto, deve
per forza essere metafisica delle scienze, dottrina dei principi [Prinzipienlehre] della
matematica e della conoscenza della natura, oppure anche metafisica dei costumi,
del diritto, della religione, della storia [...]. A questo punto la filosofia non ha più un
proprio campo, un ambito particolare di contenuti e di oggetti che le spetti unicamente ed esclusivamente, differenziandola dalle altre scienze; ma è la sola a cogliere
la relazione delle funzioni spirituali fondamentali nella sua vera universalità e profondità: a un livello non accessibile ad alcuna di quelle scienze nella sua singolarità6.
Questa pare a Cassirer l’idea di fondo sottesa alla «Prefazione» alla seconda
edizione e al concetto della svolta copernicana; egli la illustra poi relativamente
alla matematica e alla scienza sperimentale, che gli paiono gli unici due ambiti
del sapere cui essa è applicata e che saranno oggetto il primo dell’«Estetica trascendentale», il secondo dell’«Analitica trascendentale».
Per Heidegger, con la rivoluzione di Kant assume invece posizione centrale
il problema dell’ontologia poiché alla problematica concernente la possibilità
della verità ontologica originaria non può essere presupposto non solo il fatto
della verità delle scienze positive, ma in generale nulla. La fondazione è compiuta sulle tracce della sintesi a priori considerata in se stessa e nei suoi germi
più profondi. L’intento della Critica della ragion pura non può essere se non
travisato dalla sua definizione nei termini di una teoria dell’esperienza, o delle
scienze positive, insomma come teoria della conoscenza. La Critica della ragion
pura è però non un sistema della filosofia trascendentale ma un trattato del metodo in cui si compie la determinazione completa di tutto il contorno e la struttura interna dell’ontologia nella quale è delineato l’intero disegno per un sistema
della metafisica7.
Nel Dibattito di Davos tra Ernst Cassirer e Martin Heidegger8 Cassirer
condivide che Kant si sia riallacciato al problema fondamentale della metafisica
di Heidegger consistente nella domanda «che cos’è l’ente?» e che esso sia stato
determinante per Platone e Aristotele come problema decisivo di ogni metafisica. Tuttavia, Cassirer ritiene che la rivoluzione copernicana di Kant presenti tratti irriducibili: essa non accantona il problema dell’essere, ma vi conferisce una
6
7
8
Ivi, pp. 185-186.
Cfr. M. HEIDEGGER, Kant e il problema della metafisica, Roma-Bari 1981, pp. 24-25.
Cfr. Appendice II, in M. HEIDEGGER, Kant e il problema della metafisica, cit., pp. 234235.
18
Rivoluzione copernicano-newtoniana e sentimento in Kant
configurazione assai più complessa. Ora il problema della determinatezza degli
oggetti è preceduto dal problema della costituzione dell’essere di un’oggettività
in generale e ciò che vale per l’oggettività in generale deve valere anche per
ogni oggetto che rientra in questa struttura dell’essere. Espresso in altri termini,
la svolta implica che la struttura unitaria dell’essere sia sostituita da strutture
dell’essere interamente diverse, ognuna delle quali è dotata di premesse a priori
sue proprie: l’oggetto estetico non è legato all’oggetto empirico ma ha le sue
categorie a priori e anche l’arte costruisce un mondo le cui leggi sono diverse
dalle leggi del mondo fisico. All’essere come sostanza, come fondamento unico,
subentra l’essere che deriva da una molteplicità di significati e di determinazioni
funzionali. Tuttavia, Cassirer intende differenziare la propria posizione da quella
di Heidegger poiché si considera fedele alla problematizzazione kantiana del
trascendentale come è stata formulata da Cohen; per quest’ultimo il metodo trascendentale prende le mosse da un fatto per porre il problema della sua possibilità, laddove il fatto è rappresentato dalla scienza matematica della natura. Kant,
invece, non è, secondo Cassirer, prigioniero di questa limitazione; Cassirer stesso, poi, vuole porre il problema della possibilità del linguaggio e pensa che in tal
modo soltanto si possa accedere alla problematica impostata da Heidegger9.
Una fra le letture più note del concetto della rivoluzione copernicana è, senza dubbio, quella di Hans Blumenberg. A suo avviso, Kant usa l’espressione
‘ipotesi’ in un senso analogo a quello in cui essa compare nella «Prefazione» di
Osiander all’opera di Copernico, De revolutionibus orbium coelestium10. Kant
nulla sapeva della paternità autentica della «Prefazione» e credeva di seguire
l’esempio dato da Copernico. La differenza tra matematica e filosofia risiede per
Blumenberg nel concetto stesso di ‘illuminazione’ cui Kant ricorre per mostrare
che, mentre nella matematica la rivoluzione riguarda il singolo uomo, nella
scienza della natura si ha invece a che fare con l’illuminazione di tutti gli scienziati, data dalla precedenza della forma che fece comprendere che la ragione vede solo ciò che essa stessa produce in base a un progetto. Se comparato con gli
oggetti sinora citati, quello della metafisica si presenta come l’oggetto del più
antico interesse teoretico, il quale rimarrebbe ancora, se gli altri dovessero essere assorbiti nel vortice di una barbarie che tutto distrugge.
Dapprima, interpreta Blumenberg, il passo cui si riferisce la seconda citazione di Copernico nella nota causa irritazione: autore e lettore hanno già forse
dimenticato quale fosse il ruolo precedentemente assegnato a Copernico. Si deve
9
10
Cfr. ibidem.
Cfr. A. DE PACE, Copernico filosofo, Milano 2008; A. DE PACE, Niccolò Copernico e la
fondazione del cosmo eliocentrico. Con testo, traduzione e commentario del Libro I de
Le rivoluzioni celesti, Milano 2009.
Introduzione
19
quindi chiarire in quale contesto si collochi questa nota. Se si considerano più da
vicino le cose, si comprende che Kant non propone solo una verifica del tentativo trascendentale, quella della «Dialettica», ma oltre a essa anche
l’adempimento del desiderio di ogni metafisica di oltrepassare i limiti di ogni
esperienza solo dal punto di vista pratico. Relativamente alla sua evidenza,
l’intera Critica della ragion pura muta la sua funzione e la sua modalità: essa
crea certo il posto per l’estensione, ma lo deve lasciare vuoto. Non appena Kant
ha compiuto questa aggiunta alla sua assicurazione che la metafisica assumerà il
cammino sicuro di una scienza grazie al tentativo trascendentale, egli ricorre in
nota nuovamente a Copernico. L’analogia tra Copernico e Newton non corrisponde quindi più al rapporto tra ipotesi e verifica, come relazione tra «Analitica» e «Dialettica» della «Logica trascendentale», ma al nesso tra ragione teoretica e ragione pratica. Se prima si era detto che gli elementi di una metafisica dovevano essere cercati solo in ciò che si può confermare oppure confutare grazie
a un esperimento, ora il parallelismo con Copernico e Newton mostra che anche
la teoria della ragione pratica si trova nei confronti della teoria della ragione teoretica in un rapporto di conferma sperimentale11. Blumenberg pone quindi
l’accento sul significato pratico della rivoluzione copernicana di Kant.
Secondo Höffe, la svolta nel modo di pensare costituisce il motivo principale della nuova «Prefazione». La rivoluzione pone il soggetto conoscente in un
rapporto creativo con l’oggetto ed è considerata un’ipotesi, un esperimento della
ragione la cui giustificazione risiede nel proprio successo. Per Höffe,
la sua filosofia trascendentale non pretende affatto, come spesso viene obiettato, di
essere infallibile, la qual cosa contraddirebbe la condizione minimale della attuale filosofia della scienza, vale a dire la falsificabilità. La confutazione di schemi di pensiero trascendentali non ha luogo però con i mezzi delle scienze empiriche. Poiché si
tratta di esperimenti di pensiero da parte della ragione, essi possono confermarsi o
naufragare solo in rapporto alla ragione stessa12.
Questo esperimento della ragione avviene, secondo Höffe, in due fasi: nella
fondazione dell’oggettività della matematica e della scienza della natura attraverso l’«Estetica» e l’«Analitica» e nella fondazione dell’oggetto della metafisica nella «Dialettica trascendentale». Höffe si contrappone alla tendenza del
neokantismo a ridurre la Critica della ragion pura a una teoria dell’esperienza;
mentre, secondo il modo tradizionale di pensare, l’incondizionato come oggetto
della metafisica non può essere pensato senza contraddizione, grazie al nuovo
modo di pensare le contraddizioni trovano una soluzione. Ciò rappresenterebbe
una controprova dell’ipotesi della rivoluzione nel modo di pensare, la quale
11
12
Cfr. H. BLUMENBERG, Die kopernikanische Wende, Frankfurt 1965.
O. HÖFFE, Immanuel Kant, Bologna 1986, p. 40.
20
Rivoluzione copernicano-newtoniana e sentimento in Kant
quindi non rimane allo stato di proposta: «la ragione si concilia con se stessa in
modo tale che l’esperimento può esser considerato riuscito, la proposta come
vera e fondata. Esso si eleva quindi al rango di una teoria valida»13.
Per Friedrich Kaulbach14, Kant trova interessante in Copernico il fatto che
egli non confuti in primo luogo una teoria astronomica, ma che in modo molto
più fondamentale abbia conferito al soggetto conoscente una posizione rispetto
all’oggetto diversa da quella che si era affermata nella tradizione scientifica. Si
può dire: in Copernico sono rilevanti non solo le rivoluzioni, le trasformazioni
dei corpi celesti come oggetti, ma anche la svolta della coscienza, che compie il
tentativo di non comprendere il suo punto di vista terreno come punto che non
rimane fisso nei rivolgimenti, ma si muove con la terra e ruota intorno al sole.
Determinante, nel passaggio realizzato da Copernico, è una svolta nel modo di
pensare, una trasformazione della posizione della coscienza [Bewußtseinsstellung], che il soggetto che vuol conoscere assume rispetto al suo oggetto. Decisiva è, per la filosofia, la rivoluzione nel modo di pensare consistente nel fatto che
non ci lasciamo imporre il punto di vista dal quale ci si mostrano le cose del
mondo dalla condizione naturale dell’essere posti sulla terra, ma lo scegliamo in
completa libertà, pensando noi stessi al di là del limitato orizzonte della nostra
percezione corporea e terrena e ponendoci nel pensiero in una posizione dalla
quale possiamo comprendere gli oggetti mondani in base a un piano da noi stessi
concepito. Contro Blumenberg, Kaulbach puntualizza che la rivoluzione di Kant
non solo non è, come correttamente del resto nota Blumenberg stesso, un procedimento meramente teoretico, ma piuttosto si configura come un passaggio pratico-teoretico paradigmatico che include un metodo, la figura di un percorso
concettuale, a proposito della quale Kant si è posto in analogia con Copernico.
Essa non è, dunque, solo metafora, indizio di un mutamento di posizione
dell’essere umano nel cosmo, come vorrebbe Blumenberg. Kaulbach, però, non
si sofferma poi sull’aspetto pratico effettivamente discusso nella «Prefazione»,
ma anzi lo introduce direttamente nell’aspetto teoretico, fondendo l’uno
nell’altro in base all’idea della libera scelta del punto di vista.
Per Karen Gloy, quando, nella «Prefazione» alla seconda edizione, introduce
l’esperimento, Kant non intende avvalersene dal punto di vista oggettivo né per
la dimostrazione né per la confutazione, ma esclusivamente in funzione di una
polemica soggettiva contro pretese dogmatiche, come quella dell’esistenza unilaterale del mondo fenomenico e di un’assolutizzazione della conoscenza scientifica. Si potrebbe mostrare che l’uso dogmatico della ragione nelle idee cosmo13
14
Ibidem.
Cfr. F. KAULBACH, Die Copernicanische Denkfigur bei Kant, in «Kant-Studien», 64
(1973), pp. 30-47.
Introduzione
21
logiche conduce a contraddizioni, al problema se il mondo sia infinito o finito,
se abbia o non abbia un inizio, se sia o non sia riconducibile a elementi irriducibili, indivisibili e ultimi, se sia necessario o puramente contingente. Quando
Kant formula la tesi dell’unità tra mondo fenomenico e noumenico, tra filosofia
teoretica e filosofia pratica, tra scienza e fede, e ne asserisce con tono sempre
più dogmatico l’esattezza con espressioni come «ausgemachte Gewißheit»,
«nicht hypothetisch, sondern apodiktisch bewiesen», «Gegenprobe der Wahrheit
des Resultats», queste espressioni non significano in realtà mai l’esclusione definitiva e apagogica della tesi contraria, ma possono essere considerate legittime
solo grazie a una teoria dell’interesse. Se si ritorna al problema dell’esistenza,
dell’estensione e dello status della scienza, l’analisi dimostra che sia l’ipotesi di
un’esistenza unica e completa della scienza sia la tesi opposta dell’esistenza della morale accanto alla scienza rimangono problematiche e possono essere risolte
solo in base all’interesse. Da ciò scaturisce per la scienza il risultato paradossale
che il sistema delle leggi necessarie non è a sua volta necessario, ma contingente. Pensare per intero e condurre alla loro conclusione le premesse è un processo
che può confermare che la concezione filosofica di Kant è comunque solo un
progetto possibile sia che si assuma la prima sia che si assuma la seconda prospettiva, e non pretende in nessun modo validità né verità uniche e assolute. Se
si concede a Kant di aver giudicato il suo sistema in conformità a questa riserva
critica, emerge come, nonostante alcune sue affermazioni che hanno tono dogmatico, egli costituisca uno dei pochi filosofi che non considerano il proprio sistema assolutamente conclusivo e insuperabile, ma adottano un atteggiamento di
umiltà critica e consapevole della finitezza15.
Wolfgang Kuhlmann ritiene che Kant abbia connesso la cosiddetta seconda
rivoluzione copernicana con la critica della ragione, ottenendo il risultato che la
ragione occupa un posto assolutamente centrale e importante poiché è principio
del mondo dell’esperienza e al tempo stesso il nucleo più intimo e prezioso del
soggetto. La soggettività razionale è il centro del mondo oggettivo e soggettivo,
il punto di partenza ideale, il principio di una filosofia che avrà come oggetto
l’intero, la totalità. La ragione soggettiva, la soggettività razionale vale come
veridica in un duplice senso, in quanto soggetto della critica filosofica e
dell’illuminismo nonché come oggetto di essa. La ragione soggettiva è, al tempo
stesso, libera e autonoma, ed entrambe le caratteristiche si condizionano a vicenda poiché chi non è veridico non può essere libero e la ragione non libera
non può essere veridica. In questa immagine non sono previste significative limitazioni dell’autonomia del soggetto razionale e neppure possibilità di autoillu15
Cfr. K. GLOY, Kants Philosophie und das Experiment, in G. SCHÖNRICH, Y. KATO
(cur.), Kant in der Diskussion der Moderne, Frankfurt a.M. 1996, pp. 64-91.