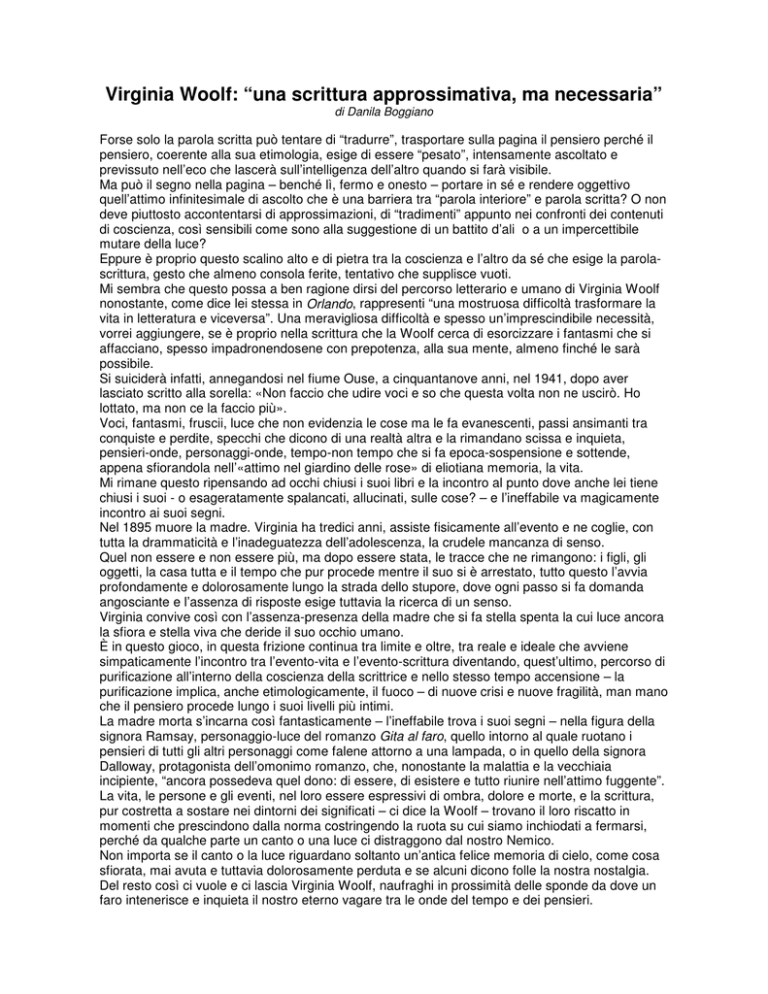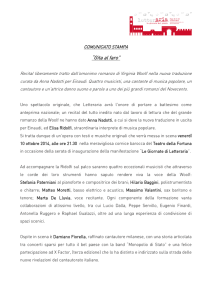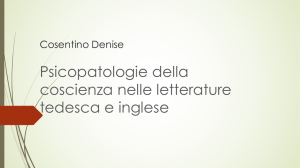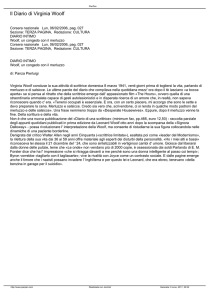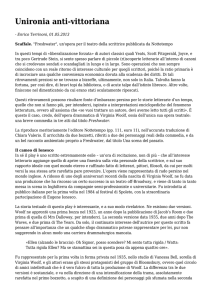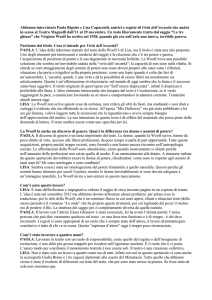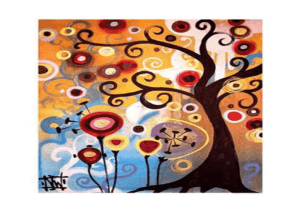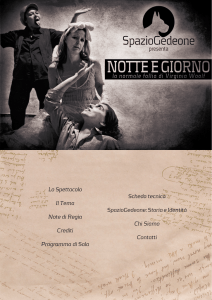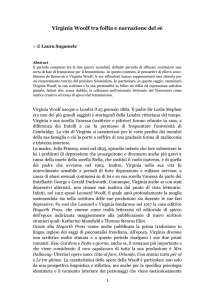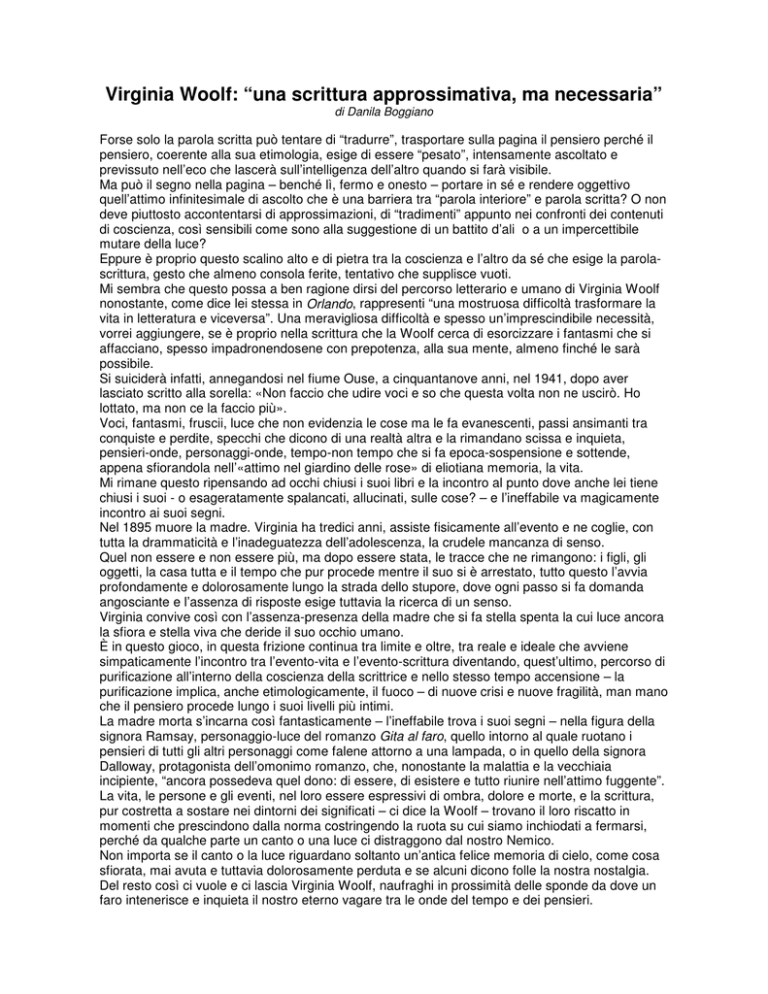
Virginia Woolf: “una scrittura approssimativa, ma necessaria”
di Danila Boggiano
Forse solo la parola scritta può tentare di “tradurre”, trasportare sulla pagina il pensiero perché il
pensiero, coerente alla sua etimologia, esige di essere “pesato”, intensamente ascoltato e
previssuto nell’eco che lascerà sull’intelligenza dell’altro quando si farà visibile.
Ma può il segno nella pagina – benché lì, fermo e onesto – portare in sé e rendere oggettivo
quell’attimo infinitesimale di ascolto che è una barriera tra “parola interiore” e parola scritta? O non
deve piuttosto accontentarsi di approssimazioni, di “tradimenti” appunto nei confronti dei contenuti
di coscienza, così sensibili come sono alla suggestione di un battito d’ali o a un impercettibile
mutare della luce?
Eppure è proprio questo scalino alto e di pietra tra la coscienza e l’altro da sé che esige la parolascrittura, gesto che almeno consola ferite, tentativo che supplisce vuoti.
Mi sembra che questo possa a ben ragione dirsi del percorso letterario e umano di Virginia Woolf
nonostante, come dice lei stessa in Orlando, rappresenti “una mostruosa difficoltà trasformare la
vita in letteratura e viceversa”. Una meravigliosa difficoltà e spesso un’imprescindibile necessità,
vorrei aggiungere, se è proprio nella scrittura che la Woolf cerca di esorcizzare i fantasmi che si
affacciano, spesso impadronendosene con prepotenza, alla sua mente, almeno finché le sarà
possibile.
Si suiciderà infatti, annegandosi nel fiume Ouse, a cinquantanove anni, nel 1941, dopo aver
lasciato scritto alla sorella: «Non faccio che udire voci e so che questa volta non ne uscirò. Ho
lottato, ma non ce la faccio più».
Voci, fantasmi, fruscii, luce che non evidenzia le cose ma le fa evanescenti, passi ansimanti tra
conquiste e perdite, specchi che dicono di una realtà altra e la rimandano scissa e inquieta,
pensieri-onde, personaggi-onde, tempo-non tempo che si fa epoca-sospensione e sottende,
appena sfiorandola nell’«attimo nel giardino delle rose» di eliotiana memoria, la vita.
Mi rimane questo ripensando ad occhi chiusi i suoi libri e la incontro al punto dove anche lei tiene
chiusi i suoi - o esageratamente spalancati, allucinati, sulle cose? – e l’ineffabile va magicamente
incontro ai suoi segni.
Nel 1895 muore la madre. Virginia ha tredici anni, assiste fisicamente all’evento e ne coglie, con
tutta la drammaticità e l’inadeguatezza dell’adolescenza, la crudele mancanza di senso.
Quel non essere e non essere più, ma dopo essere stata, le tracce che ne rimangono: i figli, gli
oggetti, la casa tutta e il tempo che pur procede mentre il suo si è arrestato, tutto questo l’avvia
profondamente e dolorosamente lungo la strada dello stupore, dove ogni passo si fa domanda
angosciante e l’assenza di risposte esige tuttavia la ricerca di un senso.
Virginia convive così con l’assenza-presenza della madre che si fa stella spenta la cui luce ancora
la sfiora e stella viva che deride il suo occhio umano.
È in questo gioco, in questa frizione continua tra limite e oltre, tra reale e ideale che avviene
simpaticamente l’incontro tra l’evento-vita e l’evento-scrittura diventando, quest’ultimo, percorso di
purificazione all’interno della coscienza della scrittrice e nello stesso tempo accensione – la
purificazione implica, anche etimologicamente, il fuoco – di nuove crisi e nuove fragilità, man mano
che il pensiero procede lungo i suoi livelli più intimi.
La madre morta s’incarna così fantasticamente – l’ineffabile trova i suoi segni – nella figura della
signora Ramsay, personaggio-luce del romanzo Gita al faro, quello intorno al quale ruotano i
pensieri di tutti gli altri personaggi come falene attorno a una lampada, o in quello della signora
Dalloway, protagonista dell’omonimo romanzo, che, nonostante la malattia e la vecchiaia
incipiente, “ancora possedeva quel dono: di essere, di esistere e tutto riunire nell’attimo fuggente”.
La vita, le persone e gli eventi, nel loro essere espressivi di ombra, dolore e morte, e la scrittura,
pur costretta a sostare nei dintorni dei significati – ci dice la Woolf – trovano il loro riscatto in
momenti che prescindono dalla norma costringendo la ruota su cui siamo inchiodati a fermarsi,
perché da qualche parte un canto o una luce ci distraggono dal nostro Nemico.
Non importa se il canto o la luce riguardano soltanto un’antica felice memoria di cielo, come cosa
sfiorata, mai avuta e tuttavia dolorosamente perduta e se alcuni dicono folle la nostra nostalgia.
Del resto così ci vuole e ci lascia Virginia Woolf, naufraghi in prossimità delle sponde da dove un
faro intenerisce e inquieta il nostro eterno vagare tra le onde del tempo e dei pensieri.