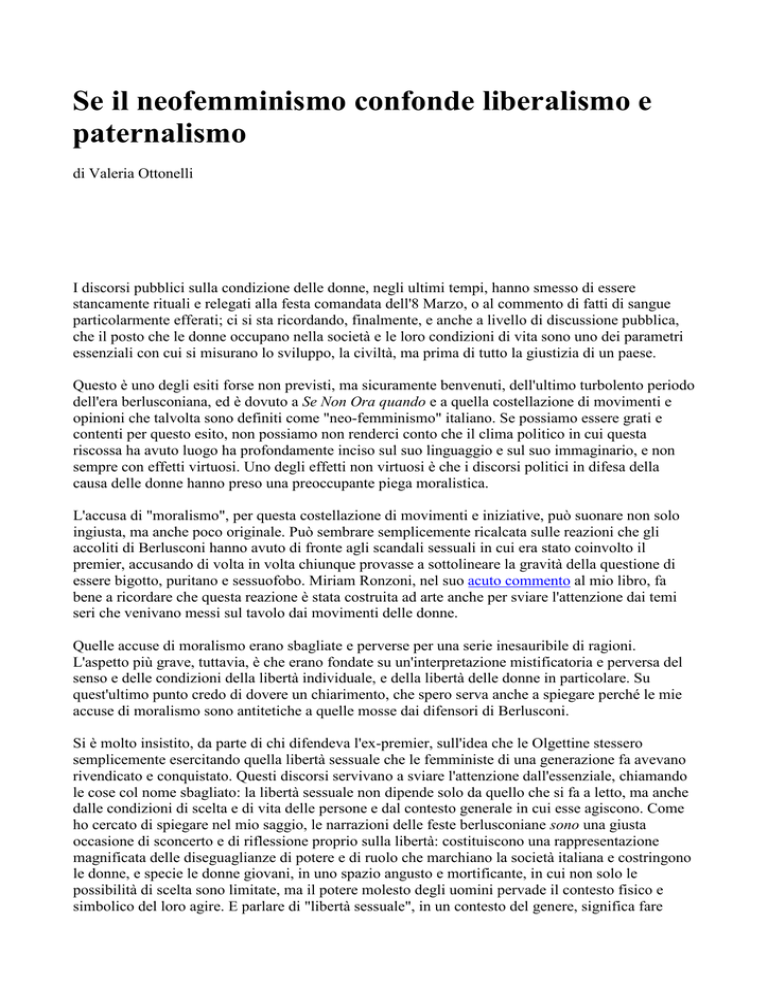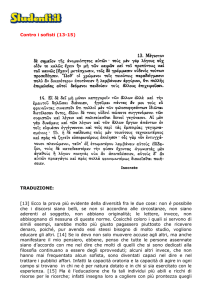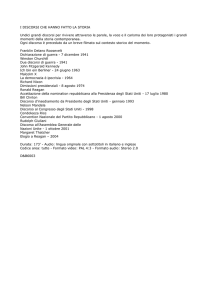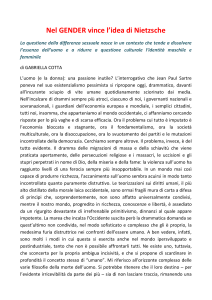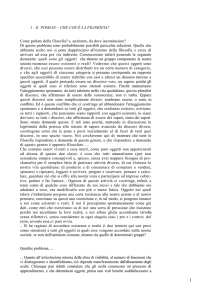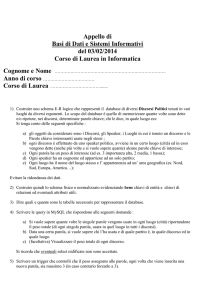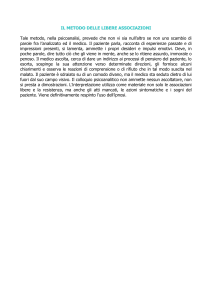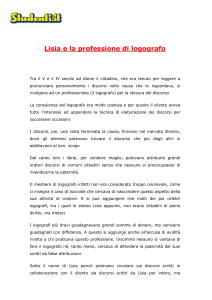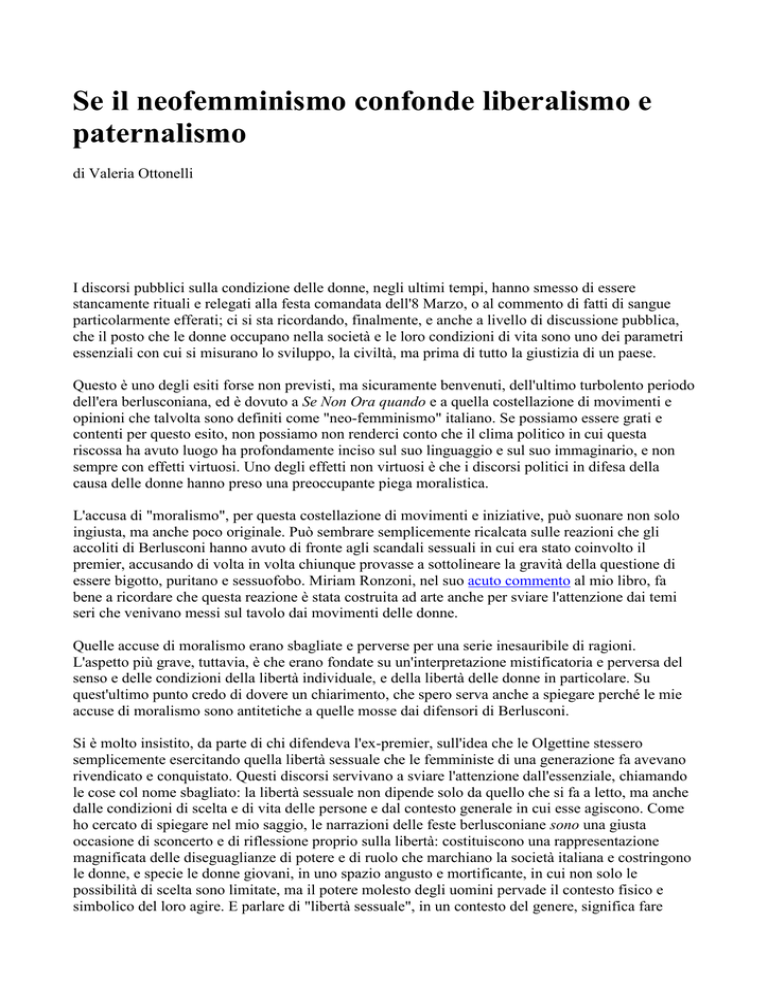
Se il neofemminismo confonde liberalismo e
paternalismo
di Valeria Ottonelli
I discorsi pubblici sulla condizione delle donne, negli ultimi tempi, hanno smesso di essere
stancamente rituali e relegati alla festa comandata dell'8 Marzo, o al commento di fatti di sangue
particolarmente efferati; ci si sta ricordando, finalmente, e anche a livello di discussione pubblica,
che il posto che le donne occupano nella società e le loro condizioni di vita sono uno dei parametri
essenziali con cui si misurano lo sviluppo, la civiltà, ma prima di tutto la giustizia di un paese.
Questo è uno degli esiti forse non previsti, ma sicuramente benvenuti, dell'ultimo turbolento periodo
dell'era berlusconiana, ed è dovuto a Se Non Ora quando e a quella costellazione di movimenti e
opinioni che talvolta sono definiti come "neo-femminismo" italiano. Se possiamo essere grati e
contenti per questo esito, non possiamo non renderci conto che il clima politico in cui questa
riscossa ha avuto luogo ha profondamente inciso sul suo linguaggio e sul suo immaginario, e non
sempre con effetti virtuosi. Uno degli effetti non virtuosi è che i discorsi politici in difesa della
causa delle donne hanno preso una preoccupante piega moralistica.
L'accusa di "moralismo", per questa costellazione di movimenti e iniziative, può suonare non solo
ingiusta, ma anche poco originale. Può sembrare semplicemente ricalcata sulle reazioni che gli
accoliti di Berlusconi hanno avuto di fronte agli scandali sessuali in cui era stato coinvolto il
premier, accusando di volta in volta chiunque provasse a sottolineare la gravità della questione di
essere bigotto, puritano e sessuofobo. Miriam Ronzoni, nel suo acuto commento al mio libro, fa
bene a ricordare che questa reazione è stata costruita ad arte anche per sviare l'attenzione dai temi
seri che venivano messi sul tavolo dai movimenti delle donne.
Quelle accuse di moralismo erano sbagliate e perverse per una serie inesauribile di ragioni.
L'aspetto più grave, tuttavia, è che erano fondate su un'interpretazione mistificatoria e perversa del
senso e delle condizioni della libertà individuale, e della libertà delle donne in particolare. Su
quest'ultimo punto credo di dovere un chiarimento, che spero serva anche a spiegare perché le mie
accuse di moralismo sono antitetiche a quelle mosse dai difensori di Berlusconi.
Si è molto insistito, da parte di chi difendeva l'ex-premier, sull'idea che le Olgettine stessero
semplicemente esercitando quella libertà sessuale che le femministe di una generazione fa avevano
rivendicato e conquistato. Questi discorsi servivano a sviare l'attenzione dall'essenziale, chiamando
le cose col nome sbagliato: la libertà sessuale non dipende solo da quello che si fa a letto, ma anche
dalle condizioni di scelta e di vita delle persone e dal contesto generale in cui esse agiscono. Come
ho cercato di spiegare nel mio saggio, le narrazioni delle feste berlusconiane sono una giusta
occasione di sconcerto e di riflessione proprio sulla libertà: costituiscono una rappresentazione
magnificata delle diseguaglianze di potere e di ruolo che marchiano la società italiana e costringono
le donne, e specie le donne giovani, in uno spazio angusto e mortificante, in cui non solo le
possibilità di scelta sono limitate, ma il potere molesto degli uomini pervade il contesto fisico e
simbolico del loro agire. E parlare di "libertà sessuale", in un contesto del genere, significa fare
della pessima metafisica, come se a rendere libere o non libere le persone fosse una qualche qualità
ontologica intrinseca delle loro azioni, oppure la loro consapevolezza, la loro cultura o la loro
moralità, anziché il contesto in cui agiscono; oppure significa semplicemente cambiare discorso,
cioè parlare di quello che succede nelle camere da letto per non parlare di quello che non succede al
di fuori. Questi discorsi, dunque, concentrando l'attenzione sulle singole azioni e scelte individuali
operano una grave mistificazione della realtà, facendo perdere di vista il quadro generale e le
strutture politiche e sociali all'interno delle quali le persone trovano le condizioni del loro agire.
Ma questo è anche, purtroppo, il difetto fondamentale dell'atteggiamento, delle parole d'ordine e
degli slogan del neo-femminismo che ho classificato come "moralisti". Non ho usato questa
etichetta nello stesso senso in cui l'hanno usata – a torto – i difensori di Berlusconi, ossia come
sinonimo di "sessuofobico" o "bigotto"; l'ho usata invece per riferirmi a un atteggiamento che,
specularmente ai discorsi mistificatori dei berlusconiani, riporta le grandi questioni politiche e
sociali che riguardano le donne a fatti che pertengono alle coscienze o alle psicologie dei singoli, e
alla loro morale privata. A questo universo sviante di discorso appartengono le contrapposizioni fra
il sesso "veramente" liberato delle donne consapevoli e il sesso falsamente liberato delle Olgettine,
le accuse contro le donne "finte" che appartengono al mondo dei media e quelle "vere" che
popolano la realtà, quelle che hanno scelto di "fare sacrifici" e optato per una morale più alta e
quelle che hanno preso scorciatoie e si sono vendute. Se ho ragione su quello che ho appena
ricordato a proposito della libertà, in un mondo in cui le strutture politiche e sociali giocano
sistematicamente a nostro sfavore, riducendo le nostre opportunità, siamo tutte non libere o meno
libere di come potremmo essere.
Non credo che questo sviamento del discorso sia stato solo colpa di Ferrara e degli altri
"antimoralisti"; il fatto che anche molte donne abbiano giocato a questo tavolo può essere stato
dettato da considerazioni di strategia politica. Questo modo di porre le questioni, infatti, può
risultare efficace, almeno sul breve periodo, e puntando sull'indignazione è riuscito a creare
mobilitazioni di piazza, a suscitare dibattiti e occasioni di confronto. Ma dimostrerà di avere il fiato
corto se non riuscirà a far capire perché questa mobilitazione dovrebbe essere messa al servizio non
di esami di coscienza e percorsi di "liberazione" e illuminazione individuale, ma di riforme
profonde della società, del lavoro, del welfare e della politica, in modo da dare alle donne quelle
opportunità che non hanno adesso.
Uno degli esiti più odiosi di questo atteggiamento, inoltre, è che tende a dare sfogo ai nostri
peggiori istinti pedagogici e paternalisti. Se si trasformano questioni politiche che pertengono alla
sfera delle opportunità aperte alle donne in questioni morali che riguardano le coscienze dei singoli,
si arriva necessariamente a pensare di fare politica "convertendo" le anime ai modelli virtuosi.
Miriam Ronzoni ha ragione sul fatto che i fatti culturali e le regole sociali non istituzionalizzate
possono essere oppressivi tanto quanto le leggi dello stato. Ed è vero che il confine fra le regole
sociali che vanno cambiate e quelle che devono essere lasciate al privato di ognuno è ambiguo e
problematico. Se ho dato l'impressione di credere di avere risposte certe e chiare a questi problemi,
in ogni ambito, ho dato un'impressione sbagliata.
Tuttavia, penso di essere abbastanza certa di due cose. La prima è che, anche una volta riconosciuto
che a rendere le persone libere o non libere, a dare loro più o meno opportunità, non ci sono solo le
strutture materiali ma anche le regole sociali e culturali, occorre fare un'attenta distinzione fra due
modi di intendere la cosa. Il primo consiste nell'idea che le regole culturali oppressive agiscano
attraverso "modelli" che le persone introiettano senza rendersene conto, in maniera irriflessiva, e
che questo di fatto renda tutto ciò che fanno, e la loro stessa esistenza, inautentica e non autonoma.
A questo punto l'unica via verso la loro "liberazione" è l'intervento esterno di qualcuno che offra
loro modelli migliori, insegni loro che cosa vuol dire veramente essere se stesse, mostri loro la via,
e lo faccia instillando in loro – e in chiunque altro – un genuino orrore per i modelli "sbagliati" e
tutti i significati sociali ad essi associati. Un secondo modo di prendere in conto le regole sociali e
culturali come fonte di oppressione e di mancanza di libertà è chiedersi seriamente due cose: in che
misura e quanto, caso per caso, essi possano dare luogo a forme di ostracismo sociale che possono
minare concretamente le opportunità delle persone; e in secondo luogo, indipendentemente dalla
diminuzione delle opportunità che essi possono comportare, occorre chiedersi se siano penalizzanti
dal punto di vista del riconoscimento pubblico delle persone, escludendone alcune dalla piena
cittadinanza. Porsi queste domande non implica in nessun modo considerare i soggetti in questione
come meno autonomi e consapevoli di noi, non passa attraverso le loro coscienze e la loro
psicologia, e non richiede che vengano "educati" o rieducati. Implica piuttosto che ci si mobiliti, nel
caso in cui la risposta fosse positiva, per modificare gli equilibri di potere che continuano a
perpetuare queste forme pubbliche di diminuzione sistematica di alcuni soggetti a vantaggio di altri.
La seconda cosa di cui credo di essere abbastanza sicura è che, almeno nelle intenzioni, le mie
osservazioni sulla mole eccezionale di lavoro domestico che ancora viene svolto nelle famiglie
italiane non erano volte a iniziare una campagna contro quegli stili di vita. Questo significa che,
anche se pensassi (e non lo penso) che esista una forte analogia fra i "modelli" che portano alcune
donne italiane a conformarsi agli ideali estetici esecrati dal neo-femminismo e i modelli che le
portano a conformarsi a regole di economia domestica particolarmente gravose e dispendiose in
termini di tempo, comunque non ne trarrei la conclusione che sia opportuno fare campagne
politiche e culturali né contro gli uni né contro gli altri.
Ciò che intendevo fare richiamando l'attenzione sulla nostra economia domestica erano
essenzialmente due cose. La prima era cercare di illustrare con un esempio concreto, e molto
prosaico, una cosa che era già stata detta da molte, ossia che le battaglie che vengono fatte nel nome
delle "donne", in questi ultimi tempi, sono spesso fatte avendo in mente un particolare tipo di
donna, che è profondamente situata, a livello valoriale e culturale, all'interno dell'etica e dell'estetica
conservatrice: la donna che, come recitava il primo appello di SNOQ, "crea ricchezza", "si sacrifica
per affermarsi nella professione che si è scelta", e "si prende cura delle relazioni affettive e
familiari, occupandosi di figli, mariti, genitori anziani". A margine, volevo anche cercare di
ridimensionare le pretese e la retorica associate a questo tipo di rivendicazioni, in cui le donne
(quelle donne) vengono rappresentate come la vera spina dorsale dell'economia del paese, al tempo
stesso martiri e vestali del nostro sistema di produzione e di riproduzione. Si tratta di una retorica di
per sé poco raccomandabile, perché strizza l'occhio all'etica efficientista che sta pervadendo ogni
settore della nostra società. Ma oltre a questo è fuori luogo: se si preoccupano di "mandare avanti" il
paese, quelle vestali dovrebbero allora smettere di stirare le camicie o di cucinare due volte al
giorno, perché dal punto di vista dell'efficienza produttiva (e riproduttiva) si tratta di attività inutili.
Se vogliamo trovare posto per esse, non può essere perché vengono spacciate come "lavoro di
riproduzione necessario".
Il mio secondo proposito era mettere in guardia contro queste rivendicazioni nella misura in cui
sono volte a incidere in maniera pesante e per legge sull'organizzazione del welfare e del lavoro di
donne e uomini, favorendo e consolidando a livello simbolico e materiale alcuni stili di vita, a
scapito delle opportunità di scegliere stili e valori alternativi.
Tuttavia, sebbene ritenga che dovrei mobilitarmi per fare in modo che sia effettivamente garantito a
tutte di scegliere modelli diversi, o che i costi di quelle scelte non gravino eccessivamente su coloro
che optano per vie alternative, non credo di dover fare nessuna battaglia contro la famiglia
tradizionale italiana, né contro i suoi valori etici ed estetici. Questo perché, anche se relegata ai
discorsi fatti nella sfera pubblica, e non imposta per legge, una reprimenda di quei modi di vita mi
sembrerebbe irrispettosa per le persone che li coltivano, sui cui percorsi personali non posso e non
voglio sindacare, e che devo trattare comunque come autonome e consapevoli. E anche perché,
onestamente, anche se possiamo vedere distintamente, alla luce fredda della nostra ragione
sociologica, che ci sono schemi di comportamento che sono funzionali a un particolare ordine
economico e sociale, tuttavia ci sono troppe variabili in gioco perché possiamo arrogarci il diritto di
sindacare non solo sulla vita e le motivazioni degli altri, ma anche sul significato sociale delle loro
scelte; per quello che ne so, ad esempio, non posso escludere che coltivare certi stili domestici possa
valere come forma di resistenza contro la pressione dei sistemi e ritmi di produzione sempre più
affaticanti e parcellizzanti del mondo del lavoro extradomestico.
Miriam Ronzoni ha completamente ragione sul fatto che solo una linea molto sottile corre fra i
discorsi che servono a chiedere cambiamenti delle istituzioni e delle regole sociali repressive, in
modo da offrire effettive opportunità di scelta a tutti, e i discorsi che servono invece a indottrinare e
a proporre un unico modello di vita come virtuoso e degno di essere vissuto. Ma è la linea che
separa una concezione liberale della società, che ha posto per il pluralismo dei valori e le differenze
negli stili di vita – compresi quelli tradizionali – e una concezione paternalista e perfezionista che
tratta le persone come minori da educare. Per questo è della estrema importanza che, con tutte le
difficoltà del caso, continuiamo a discutere su dove esattamente debba cadere quella linea.
Micromedia On Line (18 giugno 2012)
Valeria Ottonelli, docente di Filosofia Politica ed Etica Pubblica presso l'Università di Genova,
autrice di “La Libertà delle donne”