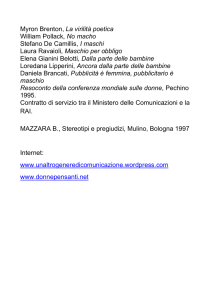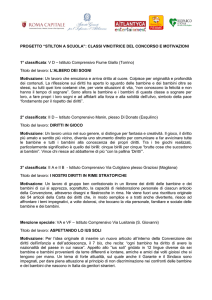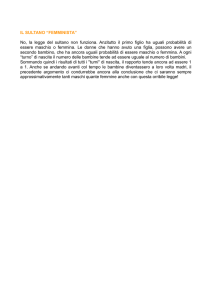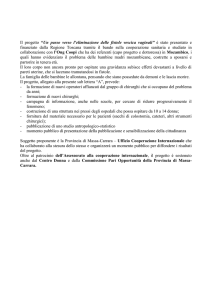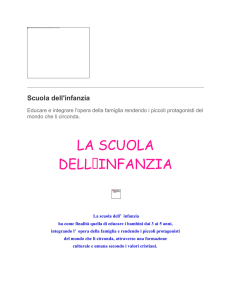Anna De Biasio
Recensione del libro Ancora dalla parte delle bambine di Loredana Lipperini, Milano:
Feltrinelli, 2007
La presa sul mondo della donna è meno vasta di quella dell’uomo.
Perché la donna è da sempre più strettamente asservita alla specie,
agli eterni compiti della riproduzione, incatenata alle leggi della
biologia che l’hanno condannata ad una perpetua immanenza,
impedendole di proiettarsi in quanto individuo nell’avvenire, di
forgiarsi per sé un destino, di testare il suo potere per raggiungere
degli scopi, di aspirare a trasformare il mondo superandosi,
trascendendosi. Da sempre definite da miti creati dagli uomini –
tesoro, preda, gioco e rischio, musa, guida, giudice, mediatrice,
specchio; fata, megera, ninfa, sirena, rosa, stella del mattino, angelo
e demonio – impotenti a porsi come soggetto, le donne non hanno a
loro volta elaborato un mito virile in cui riflettere i loro sogni e i loro
disegni, non hanno generato valori in proprio, né un’arte o una
religione; sognano attraverso i sogni degli uomini, adorano gli idoli
fabbricati dai maschi. Tuttavia, le donne e gli uomini, forse, si
riconosceranno un giorno come simili. Lo auspicava Simone de Beauvoir nel Secondo sesso, il
grande saggio del 1949 che dovrebbe stare sullo scaffale di ogni umanista, bene a portata di
mano.
È più vicino oggi quel giorno? La risposta di Loredana Lipperini in Ancora dalla parte
delle bambine (Feltrinelli 2007) è decisamente negativa. Attraverso una varietà di testi e
fenomeni della cultura popolare contemporanea, dai telefilm ai fumetti, dai giocattoli ai siti e ai
blog della rete, dalla pubblicità ai cartoni animati, Lipperini argomenta con forza la tesi centrale
del suo allarmato saggio: dopo gli anni delle battaglie per i diritti, la parità, il
ridimensionamento delle differenze, siamo nel pieno di una re-genderization, di un ritorno dei
generi, la cui spia sono le onnipresenti immagini di femmine ipersessuate, munite di seni e
labbra rigonfi, a cui si oppongono supermaschi muscolosi e predatori; una tendenza
restauratrice nell’universo delle rappresentazioni della cultura di massa – ma non limitata ad
esso – che viene fatta risalire almeno alla metà degli anni Novanta.
È questo il pane simbolico della nostra quotidianità (l’osservatorio privilegiato è l’Italia,
ma le ramificazioni sono più globali). Le casalinghe che si spogliano per i calendari, l’esercito
trionfante delle veline che affiancano mute e svestite paternalistici presentatori accuratamente
abbigliati, le celebrity non-entities alla Paris Hilton assurte alla fama mediatica grazie ai video
hard, le fatine Winx e le bambole Bratz, le eroine delle bambine di oggi, che paiono tante
miniature delle sensuali ballerine di Mtv, i bulli che fissano le prestazioni sessuali delle pupe
sui videotelefonini; immagini e pratiche che raccontano un’unica storia: è il corpo ad essere il
centro dell’attenzione, in particolare come oggetto e stimolo del desiderio erotico. Per
paradosso, la centralità del corpo e del sesso viene da più parti orgogliosamente, gioiosamente
rivendicata come potere e scelta di libertà, o come veicolo dell’espressione di sé, oppure ancora
come divertito e divertente gioco con ruoli e vecchi stereotipi, resi innocenti dalla presunta
consapevolezza con cui verrebbero manipolati. Non solo si respira ovunque un’aria di
tolleranza, di giocosità, di pacificazione circa la dilagante esibizione dei corpi come oggetti
sessuali, ma questa stessa esibizione diventa sinonimo di una nuova emancipazione: siamo
esattamente agli antipodi rispetto ai toni rabbiosi con cui le femministe degli anni Settanta
denunciavano lo sfruttamento del corpo femminile attraverso le immagini e non (arrivando in
casi estremi a identificare la penetrazione con lo stupro), ma anche rispetto ai toni cupi e
sofferti che dominano in Vogliamo anche le rose (2007), il documentario in cui Alina Marazzi
1
ripercorre mirabilmente alcune tappe del movimento per i Diritti Civili attraverso i diari di tre
donne, che portano incisi nel corpo e nell’anima i conflitti impliciti nelle conquiste di quegli
anni cruciali: l’introduzione del divorzio, la legalizzazione della pillola, la legge 194
sull’aborto, il nuovo diritto di famiglia, la condanna della violenza sessuale come crimine non
più contro la morale, ma contro la persona.
Che senso ha allora, una volta che questi e altri diritti sono stati acquisiti (ma attenzione:
come testimoniano le recenti polemiche sulla 194, le spinte della reazione hanno già aggredito
l’area legale), tornare a parlare di subordinazione femminile? Non dimentichiamo (e questo è
un punto che Lipperini avrebbe potuto esplorare di più) che la mercificazione e la
“pornografizzazione” dell’immagine del corpo, il culto della bellezza, l’ossessione per la
giovinezza e l’infinita stimolazione del desiderio sono tipiche manifestazioni del consumismo
neoliberale che non riguardano certo solo le donne ma investono anche l’universo maschile,
con effetti potenzialmente destabilizzanti proprio sul piano delle identità di genere (al punto da
far parlare un osservatore acuto e provocatorio come Water Siti di “gayzzazione” della società).
Eppure, sostiene Lipperini, se il consumismo riguarda tutti, a ben guardare i suoi modelli sono
molto meno ibridi e trasversali di quanto può apparire in superficie, così come il dibattito sulle
identità rimane un fenomeno marginale, confinato in comparti privilegiati della cultura (si pensi
al campo dei gender studies nell’accademia anglo-americana). Anzi, è proprio nello spazio dei
consumi, che accompagnano sempre più aggressivamente la crescita e la formazione delle
giovani generazioni, che emerge una netta differenziazione tra ruoli maschili e femminili,
secondo una logica gerarchica che penalizza la donna dall’infanzia e si estende fino all’età
adulta. Mentre nelle università si discute di cyberpunks e queerness (ma in Italia pochissimo,
vedi l’assenza di corrispettivi italiani per questi termini), il mondo reale va insomma tutto da
un'altra parte, per citare l’epifanica battuta dell’aspirante velina in Ricordati di me (2003) di
Gabriele Muccino.
La forza dell’argomentazione di Lipperini si basa da un lato sul richiamo a preoccupanti
dati statistici forse noti, ma che qui assumono il sapore dell’inchiesta restituendoci l’immagine
di una società bloccata. Quasi la metà delle donne in età lavorativa non partecipa alla vita
economica (quasi 10 milioni, contro meno di 5 milioni di uomini). Tra i 25 paesi dell’Unione
Europea, l’Italia ha il più basso livello di partecipazione femminile al mercato del lavoro, oltre
che una delle percentuali più esigue di rappresentanza femminile in parlamento (10% circa). Le
donne che lavorano part-time sono il 26%, contro il 4,6% degli uomini. Le lavoratrici, del resto,
occupano il mercato secondo le regole non scritte del sex-typing orizzontale, tendono cioè a
svolgere professioni “femminili” (sono la maggioranza delle insegnanti, segretarie, assistenti
sociali, collaboratrici domestiche), e della segregazione verticale, ovvero costituiscono una
ristrettissima minoranza nei vertici gerarchici in tutti gli ambiti professionali. Se le ragazze
studiano ovunque di più e meglio dei maschi, laureandosi prima e con voti migliori, continuano
in prevalenza a scegliere percorsi di laurea cosiddetti deboli, che comportano un inserimento
lavorativo più difficile, precario e peggio retribuito. Ciò che è ancora più rilevante, una volta al
lavoro si trovano a lottare con la necessità di conciliare – una necessità considerata tuttora
esclusivamente femminile – l’impegno fuori casa con il lavoro domestico: dedicano alla
famiglia mediamente 3 ore al giorno in più rispetto ai compagni, sobbarcandosi il 90% delle ore
consacrate alla cura della casa. Ma quali sono le cause prime di questa condizione di svantaggio
tanto generalizzata quanto accettata, che abbraccia il campo economico, politico, intellettuale e
sociale?
La risposta è semplice: all’origine delle disuguaglianze de facto (non più de jure) vi
sono le strutture psicologiche profonde – le disposizioni interiorizzate, direbbe Pierre Bourdieu
– che come si sa sono molto più lente e resistenti al cambiamento rispetto alle leggi e agli stessi
atti di volontà cosciente. La capacità persuasiva dell’indagine di Lipperini consiste non solo nel
mostrare la persistenza di miti, ruoli e modelli tradizionali che influenzano la psiche
determinando scelte e comportamenti, ma nel riflettere sui luoghi e sui modi della loro
2
formazione; soprattutto, scegliendo di dare ampio spazio ai prodotti reali e immaginari destinati
alle bambine, l’autrice va diretta alle radici dell’apprendistato femminile alla minorità. Il titolo
del libro si ricollega così idealmente – ma anche polemicamente – ad un testo pubblicato da
Elena Gianini Belotti, più di trent’anni fa, sullo stesso argomento e con medesimi intenti (Dalla
parte delle bambine, Feltrinelli 1973). Come a dire, non è cambiato poi molto da allora.
La pubblicità. Le bambine sono prevalentemente ritratte in spazi chiusi, in atteggiamenti
di attesa, in pose che esaltano la bellezza fisica e le precoci capacità seduttive (si osserva da
tempo, nel campo della moda femminile, un progressivo accorciamento delle distanze tra
abbigliamento infantile e adulto); i maschi, al contrario, sono tendenzialmente attivi in spazi
esterni, impegnati in giochi avventurosi e competitivi. Nella pubblicità di prodotti unisex –
pochissimi dopo i 5 anni – tre protagonisti su quattro sono maschi (l’universale continua ad
essere declinato al maschile), mentre in quella dei prodotti femminili domina l’idea che le
bambine desiderino dare e ricevere amore (a loro sono associati i peluche, i colori pastello, le
musichette soavi). Ma se la pubblicità è per vocazione conformista, i giocattoli non si rivelano
meno conservatori. Dopo i giochi neutri dell’età prescolare, oggi come negli anni Sessanta alle
bambine sono invariabilmente destinati bambolotti, oggetti per la cura degli spazi domestici,
oggetti per la cura del corpo e della bellezza, Sapientine con relative domande “da bambine”
(sul fantastico mondo di Barbie e di altre bambole); ai maschi mezzi di trasporto in miniatura,
l’antico arsenale bellico, giochi di abilità che stimolano le facoltà logiche e matematiche.
L’educazione precoce alla diversità, all’appartenenza a due mondi con competenze distinte
s’insinua perfino in un territorio potenzialmente franco come quello della tecnologia
informatica, peraltro segnata da un precoce gender digital divide: i videogiochi destinati alle
ragazzine (molti meno) puntano su interazioni sociali e linguistiche complesse, ambientazioni
familiari e personaggi realistici, quelli per i maschi su personaggi eroici e fantastici dotati di
superpoteri, su abilità quali azione e velocità, su obiettivi come vincere e distruggere
l’avversario. E ancora, nel deplorevole immobilismo dei libri scolastici, il genere maschile
continua ad essere rappresentato in misura molto più considerevole rispetto a quello femminile:
i protagonisti maschi sono di più e a loro spettano più ruoli, attivi, in contesti pubblici, mentre
ai personaggi femminili sono assegnati meno ruoli, passivi, e spazi privati (il papà guida la
macchina e la mamma prepara la merenda).
È approssimativamente lungo queste linee che Lipperini ricostruisce il mondo simbolico
delle “nuove” bambine, a partire dal quale fin da piccolissime esse sono indotte a sognare di
diventare belle, di essere mogli e madri (in base ad un nuovo consenso praticamente unanime
che identifica la maternità con una tappa necessaria alla realizzazione della donna, complice
certo femminismo della differenza), di apparire, piacere e sedurre, convinte che a loro spetterà
il compito di impegnarsi di più nelle attività domestiche e nella cura degli altri. Per la
stragrande maggioranza, in quest’ultimo caso il modello trova piena conferma nella vita di tutti
i giorni. La storia si ripete: ripetere vs. creare. Il pregio di Ancora dalla parte delle bambine è
allora quello di mettere a fuoco con urgenza ciò che continua ad essere sotto i nostri occhi,
magari distratti, magari assuefatti, quando accendiamo il computer o la televisione, o sfogliamo
le pagine di un giornale. Dietro l’indubbio spazio conquistato dai soggetti femminili nella
pubblicità, nei film, programmi televisivi e fumetti, dietro le streghette Winx, le sexy bambole
Bratz, le eroine “attive” alla Lara Croft e tutte le loro emule o prototipi in carne e ossa, non
smettono di dominare i modelli antichi della femminilità con le loro prerogative. Nutrici,
sirene, ninfe e fate, libere e trasgressive soprattutto nel gioco della seduzione (ciò che de
Beauvoir definiva licenza, ovvero libertà negativa), così modellate le donne continuano ad
alimentare il mito dell’Alterità, sognano sogni costruiti da altri. Persuase, forse, di averli
fabbricati da sé.
3