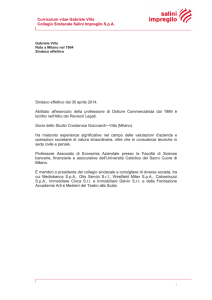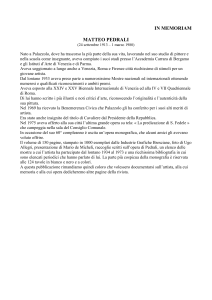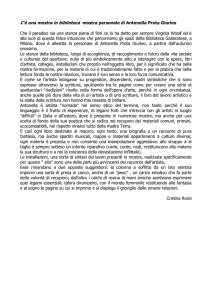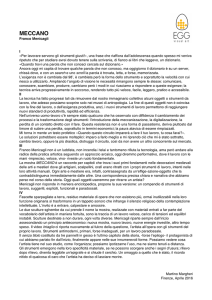n° 318 - gennaio 2005
© Tutti i diritti sono riservati Fondazione Internazionale Menarini - è vietata la riproduzione anche parziale dei testi e delle fotografie
Direttore Responsabile Lucia Aleotti - Redazione, corrispondenza: «Minuti» Via Sette Santi n.1 - 50131 Firenze - www.fondazione-menarini.it
Gli autoritratti nell’arte
“Non sono ancora morto io,
non sono.
Mi credevano un pazzo,
allora D’Annunzio persino
mi vedeva in un manicomio
a dipingere i crani degli
altri pazzi”.
Giacomo Balla
(da un’intervista di Giuseppe
Bocconetti , in “Corriere
Lombardo”.
Milano, 12 novembre 1951
Prestigio, memoria, riconoscimento, vanità e studio di sé. Gli artisti si mostrano e nel contempo si
osservano attraverso lo
specchio, strumento-obiettivo utilizzato per fissare
la propria immagine: oggetto di conoscenza e di
meditazione tra l’io e l’universo.
“L’autoritratto è il sublime
ricordo del mito di Narciso (l’io e la metamorfosi), è la proiezione del
passato della storia. E’ allegoria e emblema, racconto e menzogna. Può
essere verità assoluta o verità inconscia”, scrive Maurizio Fagiolo dell’Arco.
Certo un mezzo per comunicare l’anima attraverso il corpo.
Complesso e affascinante
il tema dell’autoritratto,
per la molteplicità dei significati che può racchiudere, non tutti e non sempre di facile interpretazione.
La sua storia riconduce a
qualche raro aneddoto narrato dalle fonti antiche
quali Fidia o Apelle e a
qualche ugualmente raro
episodio risalente all’età
medievale come quelli
della monaca Guda, di
Maestro Mathiu, Giotto
(almeno secondo quanto
ci tramanda il Vasari ) e
Andrea Orcagna.
Sino all’età umanistica
nella quale l’artista comincia a fare ritratti di sé
con regolarità. Ma si mostra celandosi: Masaccio
si nasconde nella folla che
circonda San Pietro in cattedra; così come Filippino
Lippi è presente alla Crocefissione di San Pietro;
Sandro Botticelli guarda
lo spettatore che sta guardando i Magi in adorazione della Vergine. Michelangelo nasconde il suo
tormentato volto nella
pelle scuoiata di San Bartolomeo, mentre Raffaello testimonia la sua presenza all’interno della
Scuola di Atene.
La prima collezione di autoritratti d’artista nasce a
Firenze alla corte medicea per felice intuizione
(“forse una magica cerimonia quella di appropriarsi del volto dell’artista” scrive a tal proposito
sempre Fagiolo dell’Arco)
del cardinale Leopoldo de’
Medici che cominciò a collezionare questa tipologia
di ritratto che oggi, raccolta nel Corridoio Vasariano, conta ben 1320
esemplari.
Gli studi sull’evoluzione
della figura e del ruolo sociale dell’artista e gli sviluppi di questo genere pittorico sono stati ampiamente documentati e sempre di più oggi suscitano
interesse e vivacità critica,
soprattutto in riferimento
all’arte italiana del Novecento: analisi di problematiche che legano la storia con la sociologia, le indagini psicanalitiche con
Masaccio: Autoritratto da La Resurrezione del figlio di Teofilo - Firenze, Cappella
Brancacci
le inquietudini e gli interrogativi che hanno attraversato il ventesimo secolo.
Giorgio de Chirico si è travestito cento volte e si è
anche abbinato a statue
classiche o a personaggi
mitici per cercare un’identificazione. Ci sono invece
artisti come Carlo Carrà
o Giorgio Morandi che si
sono ritratti solo una o due
volte e altri ancora che si
sono costantemente scrutati e ritratti nel corso della
loro vita: è il caso di Giacomo Balla o di Gino Severini.
A Firenze ulteriori testimonianze sull’autoritratto
sono raccolte nella mostra
“Moi! Autoritratti del XX
secolo” (il pronome interprete-simbolo dell’internazionalità nell’iconogra-
Filippino Lippi: Autoritratto da Disputa con Simon
Mago e Crocefissione di San Pietro - Firenze,
Cappella Brancacci
pag. 2
Giorgio De Chirico: Autoritratto a mezzo busto - Locarno, Collezione
Raimondo Rezzonico
fia autoriflessa), alla Galleria degli Uffizi, che offre una panoramica vasta
e originale della produzione di artisti, a raggio
internazionale, che hanno
segnato le più diverse
espressività del Novecento
lasciando nello studio di
sé tracce vive e pulsanti
del loro modo di essere,
di pensare, di intendere
l’arte oltre che loro stessi.
Una inedita visualizzazione che consente di delineare attraverso il percorso della mostra le principali linee di tendenza
dell’evoluzione dell’autoritratto nella pittura del
XX secolo.
In questo secolo diverso è
il porsi in effige dell’artista. E così il percorso della
mostra citata si snoda tra
autoritratti osservati dall’esterno e indagati nella
loro genesi, contrapposti
o a confronto, per sottolinearne la somiglianza o
meno, l’apposizione della
maschera e il variare dell’espressione, il segno della
storia, oppure l’uso della
metamorfosi. La firma dell’artista, il suo sguardo,
tutto racconta di lui: il
suo corpo può diventare
anche luogo di vanità riflessa in uno specchio. E
ciò vale per Magritte,
Brancusi, Duchamp, Fontana, Chagall, Warhol, e
Suzanne Valadon o Kathe
Kollwitz, per citare due
autoritratti al femminile.
Opere che ricordano, come
sottolinea Pascal Bonafoux, curatore della mostra già presentata a Parigi, che mentre un tempo
il comune denominatore
della collezione era l’ “olio
su tela”, oggi sono le tecniche, ingegnose, provocatorie, diverse, docu-
Giacomo Balla: Autocaffè - Firenze, Galleria degli Uffizi
mento oltre che dell’autore che vi si ritrae, della
disomogeneità dell’autoritratto, pur nella medesima finalità. Ora confessione del modo in cui l’artista vede se stesso, ora
immagine idealizzata corrispondente a ciò che vorrebbe essere o far credere
di essere.
maria siponta de salvia
René Magritte: Il donatore felice - Bruxelles,
Musée d’Ixelles
n° 318 - gennaio 2005
© Tutti i diritti sono riservati Fondazione Internazionale Menarini - è vietata la riproduzione anche parziale dei testi e delle fotografie
Direttore Responsabile Lucia Aleotti - Redazione, corrispondenza: «Minuti» Via Sette Santi n.1 - 50131 Firenze - www.fondazione-menarini.it
Una nuova Opera per Santa Croce
Visto dal Piazzale Michelangelo il complesso monumentale di Santa Croce
colpisce per la sua imponenza. E’ indubbio che
dalla posa della prima pietra, avvenuta nel lontano
1294 su progetto dell’architetto Arnolfo di Cambio, la Chiesa francescana
abbia avuto uno sviluppo
tale da trasformarla in uno
dei massimi capolavori del
gotico italiano, nonché
contenitore di memorie
storiche e opere di grande
valore dal ‘300 in poi.
I lavori, inizialmente avviati a ritmo serrato, consentono di avere la chiesa
già funzionante nel 1320,
poi per svariati motivi, tra
i quali la crisi economica
di Firenze, la peste, la
grande alluvione del 1333
e le discordie interne, rallentano fino alla consacrazione avvenuta finalmente
nel 1443.
I costi rilevanti delle numerose opere che la municipalità fiorentina aveva
simultaneamente avviato
dalla fine del XIII secolo,
imposero l’istituzione da
parte del Comune di Firenze di organismi in grado
di seguire e gestire la complessità dei lavori. L’Opera
di Santa Croce vide la luce
nel 1371 per la necessità
di nominare Operai, intesi
come amministratori e controllori di questa grande
Fabbrica in continua evoluzione, come del resto avveniva per tutti i cantieri
più importanti.
L’attività di ampliamento,
ammodernamento e rifinitura continua infatti nel
corso dei secoli seguenti,
fino all’esecuzione del cam-
panile ad opera del Baccani nel 1847 e della facciata da parte del Matas
dal 1857 al 1863. Nel frattempo, l’intero complesso
si arricchisce di sculture,
dipinti e realizzazioni architettoniche, grazie anche all’intervento dei maggiori committenti rappresentati dalle grandi famiglie fiorentine, che in Santa
Croce avevano iniziato a
finanziare i lavori per le
proprie cappelle, spesso
con Santi protettori appartenenti alle famiglie stesse,
allo scopo di ottenere un
posto ‘privilegiato’ all’interno di quello che ormai
era diventato non solo un
centro spirituale di grande
valore, ma anche un punto
di riferimento, di formazione culturale e d’incontro per tutta la città. All’interno di Santa Croce si
possono ammirare gli affreschi di Giotto e dei suoi
seguaci, il Crocifisso di Cimabue, opere di Donatello,
il pulpito di Benedetto da
Maiano, le numerose vetrate policrome, eseguite
su cartoni di maestri del
XIV e XV secolo, e l’adiacente Cappella Pazzi del
Brunelleschi con le opere
di Luca della Robbia. Inoltre, i numerosi monumenti
funebri e lastre tombali accolti all’interno del complesso dal XIV secolo in
poi, con i ricordi dei grandi
italiani, concorrono a formare di S. Croce un monumento unico per importanza storico-artistica.
Questo patrimonio necessita inevitabilmente di una
costante ed onerosa attività di tutela, manutenzione e controllo, che an-
Il Complesso di Santa Croce a Firenze come appare dal Piazzale Michelangelo
cora oggi continua ad essere condotta dall’Opera
di Santa Croce, di recente
riconfigurata sulla base del
Nuovo Concordato tra lo
Stato Italiano e la Santa
Sede, siglato nel 1984. Fino
a poco tempo fa l’Opera
era indirizzata dall’attività
di volontari collegati in
misura diversa al mondo
dell’arte e alla municipalità fiorentina, e veniva
rappresentata da un Presidente affiancato da un
Consiglio, che agiva sulla
base delle indicazioni fornite dalle Soprintendenze
competenti. Questa struttura organizzativa rodata
nel tempo era in grado di
far fronte alle operazioni
di ordinaria e straordinaria manutenzione, seppur
con limitate risorse sia di
tipo economico che umano.
L’unificazione del percorso
di visita (Luglio 2002) ha
portato i visitatori paganti
da poco meno di 100.000
per il solo Museo dell’Opera, a quasi un milione
F. Brunelleschi: Cappella Pazzi - Firenze, Complesso
di S. Croce
pag. 2
nel 2003 per la visita all’intero complesso monumentale. Questa nuova situazione ha sollevato il problema dell’autonomia operativa della struttura: è risultato indispensabile ridefinire l’assetto dell’Opera
in un sistema organizzativo dotato del necessario dinamismo per soddisfare le esigenze di conservazione e valorizzazione di
un patrimonio così complesso.
Il processo di rinnovamento
che ha interessato diversi
settori, ha attivato un autentico restauro della figura dell’Opera stessa, sia
dal punto di vista istituzionale che giuridico, nonché la necessità di definire
con precisione le proprietà
e le competenze, anche in
funzione della responsabilità diretta sulle opere e
sulla loro conservazione.
Alla conclusione di questo processo, Santa Croce
costituirà una figura inedita molto particolare e
l’Opera potrà sviluppate
pienamente il programma
di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio.
Tra gli obiettivi primari
spicca la programmazione
degli interventi più urgenti, a cominciare dal restauro dei tetti, dai quali
per diverso tempo è percolata acqua piovana sulle
pareti della chiesa e in alcuni casi anche sulle opere
stesse; è in programma anche il recupero di tutte le
grandi pale d’altare del periodo della Controriforma,
di recente avviato con l’entrata in restauro della Resurrezione di Santi di Tito,
che potrebbe essere eletta
a simbolo di questo nuovo
ciclo.
Contemporaneamente, è
indispensabile provvedere
pianificare gli interventi
futuri anche a lungo termine, secondo un programma di valorizzazione
e recupero dell’intero complesso.
Nel 2006 ricorrerà il quarantesimo anniversario
della disastrosa alluvione
di Firenze del 1966, nella
quale la basilica di Santa
Croce pagò un contributo
altissimo ancora oggi in
sospeso, dal momento che
molte opere sono ancora
in restauro o addirittura
da restaurare e molte sono
da allora fuori sede, soprattutto a causa della mancanza di sicurezza dal punto
di vista alluvionale. In occasione delle celebrazioni
previste verranno esposti
temporaneamente alcuni
grandi dipinti restaurati,
in attesa di spazi adeguati
e del riallestimento del
Museo dell’Opera, che prevede la messa in sicurezza
delle opere a rischio e il reperimento di nuovi ambienti. Per questa operazione verrà in futuro formata una commissione di
esperti di livello internazionale per ‘ripensare’ Santa
Croce e dotarla di strumenti all’avanguardia per
conservare nel migliore dei
modi e in sicurezza il patrimonio artistico che vi è
contenuto: tra l’altro, all’interno della chiesa dovrà essere studiato un itinerario per preservare le
numerose lastre tombali
presenti sul pavimento,
soggette ad un irreversibile processo di usura a
causa del calpestio da parte
dei turisti. In questa ottica, è indispensabile proseguire l’ opera di valorizzazione dell’archivio di
Santa Croce avviata negli
ultimi anni, attraverso il
riordino e lo studio dei documenti conservati all’interno dell’archivio stesso
e l’individuazione e l’acquisizione del materiale
documentario e fotografico disseminato in vari archivi all’esterno del complesso monumentale. In
tal modo, sarà possibile
creare un unico archivio
che potrà diventare un
punto di riferimento per
gli studiosi e costituire
la base per la valorizzazione
e divulgazione di questo
complesso. E’ prevista fra
breve l’apertura del sito
internet e saranno avviate
prossimamente importanti
campagne di restauro, con
l’intervento sui dipinti murali di Agnolo Gaddi nella
Cappella Maggiore e di
Taddeo Gaddi nella Cappella Baroncelli.
Il percorso di rinnovamento
avviato dall’Opera ha come
obiettivo finale quello di
arrivare a far percepire il
complesso della basilica
come polo culturale e punto
di riferimento all’interno
del quartiere storico di
Santa Croce - tra i più integri di Firenze - sia per i
cittadini che per le centinaia di migliaia di visitatori che ogni anno varcano
il portone della chiesa per
immergersi in un pezzo di
storia fiorentina.
L’opportunità di creare,
possibilmente anche con
la confinante Biblioteca
Nazionale, un centro culturale e un punto di ingresso nella città di Firenze,
costituisce sicuramente
una scommessa impegnativa, che speriamo possa
presto far parlare di sé.
Cimabue:
Crocifisso
Donatello: Crocifisso (part.)
cristiana massari
Lorenzo Ghiberti?: Lastra tombale - Tomba di
Jacopo de’ Sacchetti (XV sec)
n° 318 - gennaio 2005
© Tutti i diritti sono riservati Fondazione Internazionale Menarini - è vietata la riproduzione anche parziale dei testi e delle fotografie
Direttore Responsabile Lucia Aleotti - Redazione, corrispondenza: «Minuti» Via Sette Santi n.1 - 50131 Firenze - www.fondazione-menarini.it
L’arte dell’affresco
L’antica procedura dell’affresco è una tecnica di pittura murale nella quale il
colore viene steso su uno
strato di intonaco fresco.
È necessaria una particolare preparazione della
superficie: il muro deve
essere coperto da uno strato
di calce spenta e sabbia,
impastate con acqua (detto
arriccio) e successivamente
ricoperto da uno strato liscio di calce spenta, sabbia fine e polvere di marmo
(detto intonaco o tonachino), destinato ad assorbire il colore mantenendolo inalterato per molto
tempo. La descrizione che
nel 1550 Giorgio Vasari
dedicò a questa nobile arte,
riassume meglio di qualunque altra citazione, l’alchimia tecnica e stilistica
dell’affresco; così narrava:
«Di tutti gli altri modi che
i pittori faccino, il dipignere
in muro è più maestrevole e
bello, perché consiste nel fare
in un giorno solo, quello che
nelli altri modi si può in molti
ritoccare sopra il lavorato.
Era dagli antichi molto usato
il fresco, et i vecchi moderni
ancora l’hanno poi seguitato.
Questo si lavora sulla calce
che sia fresca, né la si lascia
mai sino a che sia finito
quanto per quel giorno si vuol
lavorare. Perché allungando
punto il dipignerla, fa la
calce una certa crosterella pel
caldo, pel freddo, pel vento e
pe’ ghiacci, che muffa e macchia tutto il lavoro. E per
questo vuole essere continovamente bagnato il muro che
si dipigne, et i colori che vi
si adoperano, tutti di terre e
non di miniere, et il bianco
di trevertino, cotto. Vuole ancora una mano destra reso-
luta e veloce, ma sopra tutto
un giudizio saldo et intero;
perché i colori, mentre che il
muro è molle, mostrano una
cosa in un modo, che poi in
secco non è più quella. E però
bisogna che in questi egli abbia per guida sua una pratica più che grandissima, essendo sommamente difficile
il condurlo a perfezione. Molti
de’ nostri artefici vagliono
assai negl’altri lavori, cioè
a olio o a tempera, e in questo poi non riescono, per essere egli veramente il più virile, più sicuro, più resoluto
e durabile di tutti gli altri
modi, e quello che, nello stare
fatto, di continuo acquista
di bellezza e di unione più
degli altri infinitamente.
Questo all’aria si purga, e
dall’acqua si difende, e regge
di continuo ad ogni percossa.
Ma bisogna guardarsi di non
avere a ritoccarlo co’ colori
che abbiano colla di carnicci,
o rosso d’uovo, o gomma, o
draganti, come fanno molti
pittori; perché, oltra che il
muro non fa il suo corso di
mostrare la chiarezza, vengono i colori apannati da
quello ritoccar di sopra, e con
poco spazio di tempo diventano neri. Però quegli che cercano lavorar in muro, lavorino virilmente a fresco, e non
ritocchino a secco; perché, oltre l’esser cosa vilissima, rende
più corta la vita alle pitture,
come in ogni altro luogo s’è
detto.»
Una metodologia che nasce già perfetta nella sua
semplicità esecutiva e nella
quale le possibili “rivisitazioni” si sono dimostrate
dei tentativi fallimentari
anche se condotte da
grandi maestri. L’aggregazione infatti della tec-
Giotto: Fuga in Egitto - Padova, Cappella degli Scrovegni
nica di base con esperimenti che proponevano,
ad esempio, la stesura sopra il manto di calce di
materiali organici eterogenei (come pigmenti legati tra loro da rosso
d’uovo, olio ecc,) oppure
altri tipi di varianti, furono eventi funesti che
compromisero la vita di
celeberrime opere d’arte.
In questo senso emblematica è la storia del grande
affresco della Battaglia di
Anghiari, commissionato
a Leonardo da Vinci nel
1504 per una Sala del Palazzo Vecchio a Firenze,
secondo la quale, dopo numerosi studi preparatori,
l’autore aveva deciso di
realizzare l’opera seguendo
una nuova tecnica di pittura murale che prevedeva
l’uso di un impasto di materiali. Accorgendosi che
i colori non facevano presa,
Masaccio: La Cacciata, la frattura tra le due figure
evidenzia le “giornate”
pag. 2
Leonardo trascorse l’intera notte insieme ai suoi
servitori, cercando con
delle fiaccole di far asciugare il colore. Ma i risultati furono disastrosi e all’alba, ormai esausto, dovette riconoscere il fallimento dei suoi disperati
tentativi vedendo l’affresco sciogliersi davanti agli
occhi.
Fino al XIII secolo per
la realizzazione dell’affresco, si procedeva a “pontate”: le zone da dipingere
venivano definite dall’impalcatura. Si deve a Giotto
e alla sua cerchia l’introduzione della divisione in
“giornate”, con cui il pittore può scegliere ogni
giorno la parte da eseguire,
seguendo le linee di contorno dell’immagine. L’artista doveva possedere una
tecnica molto rapida e sicura, tale da lasciargli prevedere il risultato finale
dell’insieme e l’esatta tonalità che avrebbe assunto
il colore una volta seccato,
non essendo possibili pentimenti, ripassi, correzioni, a meno di non disfare l’intonaco della giornata. Le correzioni e le rifiniture avvenivano a secco,
ma normalmente queste
aggiunte sbiadivano più
rapidamente.
Un altro aspetto strettamente legato alla procedura tecnica dell’affresco
è la sinopia, ovvero il disegno preparatorio, la traccia che il pittore definisce prima di procedere alla
realizzazione del proprio
percorso iconografico. Si
eseguiva sul primo strato
di intonaco con carboncino o polvere rossa e spesso
veniva a rappresentare
l’unica e preziosa testimonianza grafica degli artisti più antichi, essendo,
come è noto, pochissimi
i disegni su carta o pergamena che si conservano
fino a tutto il Trecento e
scarsi quelli di primo
Quattrocento. In questi
lontani secoli la preparazione di un’opera d’arte
murale non avveniva, come
poi sarà in seguito, nelle
botteghe, ma sui ponteggi,
davanti alle stesse pareti
da affrescare. Qui il maestro studiava a mano libera le composizioni e le
figure in maniera talmente
compiuta da poter consentire ai collaboratori di
affrescarne alcune parti in
autonomia. L’uso delle sinopie scompare verso la
fine del XV secolo, sostituite con la tecnica dello
spolvero, dei cartoni e della
quadrettatura.
Tanto antiche le origini
dell’affresco, con esempi
ritrovati fin dalla civiltà
etrusca che greco-romana,
così tanto duratura la sua
fortuna quale mezzo
espressivo di artisti appartenenti anche a periodi
storici a noi più vicini.
Pur diradandosi l’utilizzo
di questa tecnica con la
grande diffusione della
pittura ad olio su tela, e
conseguentemente del collezionismo di quadri da
possedere, ma soprattutto
esibire e spostare nei vari
ambienti delle dimore
principesche, ancora in
tempi moderni celebri pittori si sono cimentati nell’affresco, recuperandone
non tanto l’essenziale ascetismo tecnico-procedurale, quanto la resa di una
suggestiva trasposizione
dell’idea sulla materia.
Come non ricordare a tale
proposito gli affreschi di
Mario Sironi, protagonista del Novecento italiano,
che seguendo l’inclinazione verso un’arte monumentale trovò in questa
tecnica il modo di esprimere e divulgare i programmi estetico-ideologici del Fascismo, attribuendo alla pittura murale un valore altamente
educativo e didattico. Nel
corso del Novecento si
hanno anche alcuni rari
esempi di affreschi per dimore private, come nel
caso della sala del Castello
di Montegufoni, in Toscana, affrescata da Gino
Severini negli anni 192122 con personaggi della
Commedia dell’Arte.
Nella storia dell’arte manuale, l’affresco ha quindi
occupato un posto di primaria importanza soprattutto se consideriamo la
valenza documentaria che
le sue rappresentazioni
hanno costituito nel panorama della tradizione
storica, religiosa e letteraria. La ricchezza iconografica che gli artisti riversarono nelle strutture
narrative dei cicli pittorici, oggi si offrono come
un atlante visivo in grado
di evocare le inclinazioni
politiche o più sottilmente
culturali della società di
ogni tempo.
miriam fileti mazza
Leonardo da Vinci: Disegno per La Battaglia di
Anghiari
G. Severini: Arlecchini - Castello di Montegufoni
(Firenze)
M. Sironi: L’Italia e le Arti, cartone preparatorio per l’affresco - Roma, Università La Sapienza
n° 318 - gennaio 2005
© Tutti i diritti sono riservati Fondazione Internazionale Menarini - è vietata la riproduzione anche parziale dei testi e delle fotografie
Direttore Responsabile Lucia Aleotti - Redazione, corrispondenza: «Minuti» Via Sette Santi n.1 - 50131 Firenze - www.fondazione-menarini.it
L’Adorazione dei Magi
di Gentile da Fabriano
“Non sono ancora morto io,
non sono. Mi credevano un
pazzo, allora
D’Annunzio persino mi vedeva
in un manicomio a dipingere i crani degli altri
pazzi”.
Giacomo Balla
(da un’intervista di Giuseppe
Bocconetti , in “Corriere
Lombardo”.
Milano, 12 novembre 1951
Prestigio, memoria, riconoscimento, vanità e studio di sé. Gli artisti si mostrano e nel contempo si
osservano attraverso lo
specchio, strumento-obiettivo utilizzato per fissare
la propria immagine: oggetto di conoscenza e di
meditazione tra l’io e l’universo.
“L’autoritratto è il sublime
ricordo del mito di Narciso (l’io e la metamorfosi),
è la proiezione del passato
della storia. E’ allegoria e
emblema, racconto e menzogna. Può essere verità
assoluta o verità inconscia”, scrive Maurizio Fagiolo dell’Arco.
Certo un mezzo per comunicare l’anima attraverso
il corpo.
Complesso e affascinante
il tema dell’autoritratto,
per la molteplicità dei significati che può racchiudere, non tutti e non sempre di facile interpretazione.
La sua storia riconduce a
qualche raro aneddoto narrato dalle fonti antiche
quali Fidia o Apelle e a
qualche ugualmente raro
episodio risalente all’età
medievale come quelli
della monaca Guda, di
Maestro Mathiu, Giotto
(almeno secondo quanto
ci tramanda il Vasari ) e
Andrea Orcagna.
Sino all’età umanistica
nella quale l’artista comincia a fare ritratti di sé con
regolarità. Ma si mostra
celandosi: Masaccio si nasconde nella folla che circonda San Pietro in cattedra; così come Filippino
Lippi è presente alla Crocefissione di San Pietro;
Sandro Botticelli guarda
lo spettatore che sta guardando i Magi in adorazione
della Vergine. Michelangelo nasconde il suo tormentato volto nella pelle
scuoiata di San Bartolomeo, mentre Raffaello testimonia la sua presenza
all’interno della Scuola di
Atene.
La prima collezione di autoritratti d’artista nasce a
Firenze alla corte medicea
per felice intuizione (“forse
una magica cerimonia
quella di appropriarsi del
volto dell’artista” scrive a
tal proposito sempre Fagiolo dell’Arco) del cardinale Leopoldo de’ Medici
che cominciò a collezionare questa tipologia di
ritratto che oggi, raccolta
nel Corridoio Vasariano,
conta ben 1320 esemplari.
Gli studi sull’evoluzione
della figura e del ruolo sociale dell’artista e gli sviluppi di questo genere pittorico sono stati ampiamente documentati e sempre di più oggi suscitano
interesse e vivacità critica,
soprattutto in riferimento
all’arte italiana del Nove-
Gentile da Fabriano: Adorazione dei Magi (part. della predella con la Fuga in Egitto)
Firenze, Uffizi
cento: analisi di problematiche che legano la storia con la sociologia, le indagini psicanalitiche con
le inquietudini e gli interrogativi che hanno attraversato il ventesimo secolo.
Giorgio de Chirico si è travestito cento volte e si è
anche abbinato a statue
classiche o a personaggi
mitici per cercare un’identificazione. Ci sono invece
artisti come Carlo Carrà o
Giorgio Morandi che si
sono ritratti solo una o due
volte e altri ancora che si
sono costantemente scrutati e ritratti nel corso della
loro vita: è il caso di Giacomo Balla o di Gino Severini.
A Firenze ulteriori testimonianze sull’autoritratto
sono raccolte nella mostra
“Moi! Autoritratti del XX
secolo” (il pronome interprete-simbolo dell’internazionalità nell’iconografia autoriflessa), alla Galleria degli Uffizi, che offre una panoramica vasta
e originale della produzione di artisti, a raggio
pag. 2
internazionale, che hanno
segnato le più diverse
espressività del Novecento
lasciando nello studio di
sé tracce vive e pulsanti
del loro modo di essere, di
pensare, di intendere l’arte
oltre che loro stessi.
Una inedita visualizzazione che consente di delineare attraverso il percorso della mostra le principali linee di tendenza
dell’evoluzione dell’autoritratto nella pittura del
XX secolo.
In questo secolo diverso è
il porsi in effige dell’artista. E così il percorso della
mostra citata si snoda tra
autoritratti osservati dall’esterno e indagati nella
loro genesi, contrapposti
o a confronto, per sottolinearne la somiglianza o
meno, l’apposizione della
maschera e il variare dell’espressione, il segno della
storia, oppure l’uso della
metamorfosi. La firma dell’artista, il suo sguardo,
tutto racconta di lui: il suo
corpo può diventare anche luogo di vanità riflessa
in uno specchio. E ciò vale
per Magritte, Brancusi,
Duchamp, Fontana, Chagall, Warhol, e Suzanne
Valadon o Kathe Kollwitz,
per citare due autoritratti
al femminile.
Opere che ricordano, come
sottolinea Pascal Bonafoux, curatore della mostra già presentata a Parigi, che mentre un tempo
il comune denominatore
Gentile da Fabriano: Adorazione dei Magi - Firenze, Uffizi
della collezione era l’ “olio
su tela”, oggi sono le tecniche, ingegnose, provocatorie, diverse, documento
oltre che dell’autore che
vi si ritrae, della disomogeneità dell’autoritratto,
pur nella medesima fina-
lità. Ora confessione del
modo in cui l’artista vede
se stesso, ora immagine
idealizzata corrispondente
a ciò che vorrebbe essere
o far credere di essere.
maria siponta de salvia
n° 318 - gennaio 2005
© Tutti i diritti sono riservati Fondazione Internazionale Menarini - è vietata la riproduzione anche parziale dei testi e delle fotografie
Direttore Responsabile Lucia Aleotti - Redazione, corrispondenza: «Minuti» Via Sette Santi n.1 - 50131 Firenze - www.fondazione-menarini.it
Architettura e arte astratta a Mantova
L’interazione tra le arti (architettura, pittura e scultura) è una tematica portante nella storia dell’arte,
un’esigenza rivendicata da
molte correnti artistiche:
una prospettiva che si rivela quanto mai attuale
e interessante. In tale direzione si muove Massimo
Ghisi, architetto e fondatore della Galleria Disegno, che da anni sviluppa
progetti di recupero architettonico in cui possono convivere sia le esigenze di tipo funzionale e
conservativo, sia nuove
modalità di percepire e vivere la dimensione estetica. Questa “filosofia” è
stata applicata, ad esempio, nel progetto di ristrutturazione e arredamento
dell’Hotel Rechigi di Mantova che ha previsto al
piano terreno una collezione permanente d’arte
contemporanea, aperta al
pubblico e fruibile quotidianamente dagli ospiti
dell’albergo. La Collezione
Rechigi e gli ambienti dell’Hotel dove essa è collocata esprimono una concezione dell’abitare rappresentativa di un modus
vivendi che intende superare la tradizionale distinzione tra spazio museale e
spazio vissuto per arrivare
ad un risultato di completa
integrazione in cui l’arte
diventa una presenza inscindibile nel quotidiano.
Come afferma l’architetto
e collezionista Massimo
Ghisi «Tutto ciò è indicativo di una nuova sensibilità che si propone di formare un contesto vitale
intorno all’opera d’arte, in
cui essa possa abitare e re-
spirare, in armonia con la
quotidianità, senza nulla
togliere alla potenzialità
iconica e simbolica derivante dalla sua essenza artistica».
Le opere inserite nei diversi ambienti dell’Hotel
se da un lato diventano
parte integrante dell’arredamento, dall’altro lo caratterizzano con la loro
presenza, segnando le differenze tra le varie aree
pubbliche: hall e reception, la zona bar & relax e
l’area riservata alla colazione. Così l’ingresso è
suggellato in modo scenografico da un’installazione di Eduard Habicher,
le cui opere nascono quasi
sempre nei luoghi destinati ad accoglierle e vi si
rapportano creando sorprendenti e stimolanti situazioni visive e ambientali. Le sculture di Habicher combinano materiali
solo apparentemente contrastanti (acciaio con elementi in marmo, vetro,
ardesia o porfido), strutture che sembrano segni
tracciati nell’aria e liberi
di fluttuare, ma che riconducono, attraverso il connubio dei materiali utilizzati, ad una dimensione
poetica della natura. Sempre l’ingresso ospita un’altra scultura di Pietro Coletta, artista che dagli anni
Settanta è protagonista
della ricerca scultorea con
interventi in cui l'artista
rimette in discussione le
valenze dei materiali, attraverso un sapiente gioco
di illusioni ottiche e spaziali. Il bancone della reception, è stato personalizzato dall’architetto, sia
Paolo Serra: Senza titolo, 1996,
lacca e oro su tavola
Coll. Hotel Rechigi
attraverso la scelta inusuale del marmo, sia in
quanto letteralmente sovrastato dall’arte di Marco
Gastini. Analogamente la
zona bar & relax è connotata da opere totalmente
aniconiche tra cui spiccano i nomi di Paolo Iachetti e Paolo Serra, che è
qui presente con i suoi preziosi monocromi in oro e
blu. E’ stata inoltre prevista un’ampia sala conferenze, destinata ad accogliere eventi espositivi di
artisti che poi confluiranno
nella collezione permanente. Attualmente la sala
ospita una personale di
Marco Giovani, artista modenese che fin dagli esordi
ha privilegiato un’indagine sugli aspetti più na-
Pietro Coletta: Autoritratto, 1996, ferro e rame
Coll. Hotel Rechigi
Ingresso dell’Hotel Rechigi con installazioni di Eduard Habicher e Marco Gastini
pag. 2
scosti e impercettibili del
reale. In questi ultimi anni
Giovani ha investigato
l’oggetto e il tentativo
di catturarne l’ombra, ingaggiando una lotta incessante tra essere e apparire, svelando progressivamente i diversi modi di
percepire una medesima
realtà. Le ultime opere dall’emblematico titolo “Doppiogioco” costringono l’osservatore a porsi domande
sulla natura delle cose, mostrando inaspettate visioni
su cui varrebbe la pena soffermarsi: immagini opache e fuori fuoco ma potenzialmente riconoscibili, forme sul punto di
scomparire, di scivolare
via, proiezioni di oggetti
a noi familiari ma che ci
appaiono alieni. Si tratta,
in effetti, di frammenti di
realtà, reliquie del quotidiano che adesso stentiamo
a ri-conoscere, immagini
svelate dalla luce e destinate a restare sospese in
dimensioni dualistiche tra
realtà e finzione, presenza
e assenza. Proprio l’elemento luce è la chiave per
comprendere il modus operandi dell’artista, che la
utilizza per “svelare” gli
oggetti da diversi punti
di vista: cambiando la direzione della luce e con
sottili variazioni si creano,
infatti, altre visioni/interpretazioni possibili di una
stessa realtà. Da ciò si può
intendere come l’opera e
la sua organizzazione visiva - prima di procedere
con i diversi tipi di grafite
- sia studiata con grande
cura. La fase progettuale
del lavoro prevede una piccola scenografia di oggetti
sui quali è proiettata la
luce e il cui effetto sulla
tela deve sorprendere innanzi tutto lo stesso artista. Attraverso questo gioco
di reale-irreale, Giovani
riesce a catturare ciò che
sta dietro gli oggetti, a restituire quelle potenzialità latenti insite nelle cose
che accompagnano la vita
di tutti i giorni.
Nella medesima concezione di arte contestualizzata nella vita quotidiana,
in un continuum tra spazio
privato e pubblico, è l’ambizioso progetto che ha
portato alla ristrutturazione completa di Palazzo
Ottavio Cavriani, edificio in cui si amalgamano
le funzioni di ufficio, abitazione, atelier e galleria.
Si tratta di un palazzo nobiliare della metà del Cinquecento, che prima dell’attuale recupero aveva
perso buona parte del suo
aspetto originario subendo
diverse modificazioni. Circostanze contingenti avevano costretto a tamponare gli archi sulla corte,
ad aggiungere muri per
sostenere le volte con il
conseguente sbilanciamento della simmetria
strutturale. L'intervento,
effettuato dall'archietto
Massimo Ghisi, ha rispettato la storia del palazzo
esaltando al massimo le
qualità degli spazi e con
perfetta integrazione tra
arredi e strutture. Filo conduttore è sempre l’arte aniconica che “abita” e contraddistingue tutti gli
spazi, sia pubblici sia privati. Così il lungo corridoio di ingresso che conduce al cortile è animato
da una struttura dinamica
di Gastini: un’opera che
riesce a dare corpo agli
spazi già carichi di tensioni come le volte, superando i confini di pittura
e scultura informale. L’ampio cortile, su cui si affaccia l’ingresso dell’abitazione e che costeggia le ali
dell’edificio riservate alla
galleria, è interamente oc-
cupato da un’installazione
di Habicher. Nella galleria, che adesso ospita una
personale dello stesso Marco
Gastini, arte e natura convivono in perfetta sintonia, dato che la storia del
palazzo comprendeva il
grande glicine che adesso
fa mostra di sé dietro, dentro e sopra gli spazi della
galleria. I segni dell’arte
si ritrovano un po’ ovunque in tutte le aree dell’abitazione-atelier, in salotto, nella sala da pranzo,
nel giardino, fino a spingersi nei suggestivi spazi
delle cantine in mattoni e
con i soffitti a volte. Spazi
per l’arte e per la vita in
costante dialogo, un’occasione per mettere alla prova
la creatività, ma soprattutto una straordinaria opportunità culturale per la
città di Mantova.
federico poletti
Marco Giovani: Doppiogioco, 2004, Ombre di
oggetti, grafite su carta intelaiata, poliestere
Paolo Iacchetti: A squarciagola, 1992,
olio su tela - Coll. M. Ghisi
Eduard Habicher: En-tra, 2004, acciaio inox verniciato Cortile palazzo Cavriani
n° 318 - gennaio 2005
© Tutti i diritti sono riservati Fondazione Internazionale Menarini - è vietata la riproduzione anche parziale dei testi e delle fotografie
Direttore Responsabile Lucia Aleotti - Redazione, corrispondenza: «Minuti» Via Sette Santi n.1 - 50131 Firenze - www.fondazione-menarini.it
Andrea Palladio
e la civiltà della villa veneta
La mostra che si terrà a Vicenza dal 5 marzo al 3 luglio presso il palazzo Barbaran da Porto, sede del
Centro Internazionale di
Studi di Architettura “Andrea Palladio”, rappresenterà un viaggio affascinante
attraverso trecento opere
provenienti da tutto il
mondo, fra le quali spiccheranno dipinti di Veronese, Tiziano, Tiepolo,
Guercino, Jacopo Bassano,
e disegni di Raffaello, Giulio Romano, Baldassarre
Peruzzi, Palladio, Tiepolo
e Canaletto. Accanto a dipinti e disegni, mappe,
modelli architettonici antichi o realizzati appositamente, costituiranno un’introduzione a quello che fu
un mondo complesso e articolato, fornendo gli elementi per meglio comprenderlo e valutarne non
solo l’importanza dal punto
di vista architettonico ed
artistico, ma anche il ruolo
socio-politico nell’assetto
globale del territorio della
Serenissima.
Se il concetto della “vita
in villa” sul modello della
civiltà romana antica, rinato con Francesco Petrarca
come ideale letterario, si
sviluppò nella Firenze quattrocentesca del Magnifico
e portò a diverse realizzazioni innovative nella Roma
di Raffaello e Bramante,
la civiltà delle ville venete
rappresentò qualcosa di
molto più complesso, un
fenomeno prima di tutto
sociale, oltre che artistico,
iniziato nel Cinquecento
e destinato ad avere profonda influenza per più di
due secoli nel tessuto del
territorio in cui si sviluppò.
Per valutarne la portata,
basti ricordare che le ville
censite in Veneto e Friuli
sono ancora oggi oltre
4.000, e che il 90% dei comuni del Veneto ne ospita
almeno una: la villa - intesa non solo come dimora,
ma nel senso più ampio di
complesso comprendente
anche tutti gli annessi agricoli - costituì un elemento
chiave nella organizzazione
politica ed economica della
Repubblica veneziana, svolgendo un ruolo essenziale
nella storia del territorio
come struttura fondiaria,
proprietaria e produttiva.
L’attività di Andrea di Pietro detto il Palladio, nato
a Padova nel 1508, si identifica con il periodo aureo
della civiltà delle ville, che
si affermava e rafforzava in
virtù delle capacità produttive di una terra adatta
alla coltivazione di cereali
e vite e alla produzione
della seta; la vita in campagna era anche considerata dall’aristocrazia veneziana più salubre di quella
cittadina, specie nei mesi
caldi, quando il centro di
Venezia era colpito da frequenti epidemie e assediato dalle zanzare.
Il giovane Andrea, che
aveva iniziato l’attività con
un periodo di apprendistato a Padova, seguito dalla
collaborazione presso la
bottega vicentina degli
scalpellini Girolamo Pittoni e Giovanni da Porlezza, fu notato e apprezzato per le sue capacità tecniche da Gian Giorgio Tris-
A. Palladio: Villa Barbaro - Maser (Treviso)
sino, personaggio fra i più
eminenti di Vicenza, umanista letterato e diplomatico. Grazie al Trissino, al
quale dovette il soprannome di Palladio, Andrea
riceveva dal 1540 le prime
commissioni come progettista e costruttore; contemporaneamente, accanto all’attività pratica, coltivava
lo studio degli esempi antichi in una serie di viaggi
a Roma, Verona, Pola, Nimes.
Oltre all’intensa attività
per l’aristocrazia vicentina
e veneziana, Palladio riceveva nel 1549 l’incarico di
realizzare il più importante
edificio del suo tempo per
la città di Vicenza, le logge
attorno al gotico Palazzo
della Ragione, commissione che segnava la definitiva consacrazione della
sua fama.
L’ultimo viaggio a Roma,
dove nel 1554 diede alle
stampe la guida Le antichità di Roma, lo intraprese
in compagnia di Daniele
Barbaro, patriarca di Aquileia che si era dedicato alla
traduzione in volgare del
trattato di architettura di
Vitruvio e che trovava in
Palladio il supporto delle
competenze tecniche per
Paolo Veronese: Sala dell’Olimpo e crociera
(particolari degli affreschi)
Villa Barbaro, Maser (Treviso)
pag. 2
verificare e chiarire i passi
più difficili del testo latino. Fu proprio per i due
fratelli Barbaro, il patriarca
Daniele e Marco Antonio,
ambasciatore della Serenissima, che poco più tardi
Palladio progettava la villa
di Maser. Nel secondo dei
Quattro libri dell’architettura, pubblicato a Venezia
nel 1570, Palladio inserisce la pianta e un’incisione
della facciata principale
della villa, descrivendo con
dovizia di particolari l’edificio e le sue pertinenze,
seguendo il percorso dell’acqua che scende giù dalla
collina retrostante, forma
un laghetto usato come peschiera, scorre nella cucina,
irriga i giardini e riempie
gli abbeveratoi per il bestiame, finendo poi con
l’irrigare il frutteto. Appare qui evidente come il
rapporto dell’edificio padronale con le attività proprie della fattoria fosse strettissimo, un legame indissolubile sottolineato dal
fatto che l’architetto progettava tutto il complesso,
e non solo l’abitazione del
proprietario: nella villa
Barbaro il corpo centrale
- residenziale - si unisce
senza soluzione di continuità alle barchesse laterali, destinate a contenere
gli attrezzi agricoli e il raccolto di granaglie (il termine viene da barco, unità
di misura dei carichi di cereali), adottando una soluzione comune a molti altri analoghi complessi dell’epoca. La villa vera e propria, cuore dell’azienda
agricola, costituiva il simbolo del potere della famiglia del proprietario ed era
destinata a funzioni di rappresentanza, essendo un
punto di riferimento per
conoscenti e personaggi
eminenti che viaggiavano
nella regione.
Nella sua pur accurata descrizione di villa Barbaro,
Palladio omette di citare
Paolo Veronese, autore degli affreschi che ornano le
sale della residenza, tanto
da far ipotizzare agli studiosi che l’intervento del
pittore abbia travalicato il
compito della pura decorazione degli ambienti interni e si sia spinto ad interferire con il progetto
palladiano, forse fino a modificare l’assetto originario della facciata, alzando
la finestra centrale del piano
superiore tanto spezzare la
base del timpano di coronamento: una soluzione
“anticlassica” del tutto originale, che non ha riscontro nelle altre realizzazioni
palladiane. Il gioco-contrasto tra razionale circoscrizione degli spazi secondo principi ispirati alla
classicità e illusionismo
manieristico nella decorazione delle superfici connota tutto il ciclo di affreschi, uno dei più alti esempi
della pittura di Veronese.
Le architetture dipinte si
fanno negazione di quelle
reali, “sfondate” in ampie
visioni paesaggistiche del
territorio circostante, in
cui è raffigurata anche la
stessa villa all’interno della
quale si trova l’osservatore.
Le “illusioni” pittoriche
costituiscono il filo conduttore di tutto l’apparato
decorativo, nel quale compaiono personaggi a grandezza naturale in atto di
uscire da porte trompe-l’oeil
o affacciati da balaustre e
balconi affrescati. Ciò che
l’architetto ha delimitato
e circoscritto nettamente,
il pittore espande al di là
della barriera delle pareti,
in una dimensione fantastica libera dai vincoli della
“misura” palladiana, così
come il finestrone sulla facciata che deborda incon-
A. Palladio: Villa Emo - Fanzolo (Treviso)
tenibile oltre il limite prescritto dal timpano appare
spalancarsi verso sfrenate
fantasie manieristiche.
Uno degli esempi più significativi della progettazione palladiana di villafattoria, interamente realizzato sotto la guida dell’architetto, è rappresentato da villa Emo a Fanzolo, costruita intorno al
1560. Il complesso, giunto
fino a noi nella sua integrità, dispiega ai lati dell’edificio padronale - preceduto da un pronao a quattro colonne doriche che
sorreggono il timpano con
lo stemma degli Emo - due
lunghe barchesse, aperte
in undici archi ciascuna e
concluse dalle torricelle
delle colombare. La decorazione delle sale all’interno, opera del veneziano
Giovan Battista Zelotti,
fu eseguita intorno al 1565
e viene ricordata da Palladio nella descrizione della
villa contenuta nei Quattro libri. Nella realizzazione di Villa Emo, Palla-
pag. 3
dio raggiunge una mirabile sintesi di forma e funzione, associando l’ideale
petrarchesco della vita in
villa e le forme di derivazione classica con le necessità della produzione agricola.
La più celebre fra le ville
palladiane, Villa Almerico
Capra Valmarana, detta la
Rotonda, si distacca dalla
tipologia della villa-fattoria di campagna per assumere l’aspetto monumentale di un fabbricato
suburbano destinato a funzioni di rappresentanza;
già altre ville edificate in
anni precedenti rispondevano ad esigenze di questo genere, in virtù delle
quali Palladio aveva ad
esempio allontanato le barchesse dall’edificio padronale, ponendole a debita
distanza. Questo mutamento funzionale e concettuale avrebbe determinato l’evoluzione della villa
verso soluzioni sempre più
monumentali e scenografiche fino alla costruzione
di vere e proprie regge,
la più famosa delle quali,
Villa Pisani a Strà, verrà
edificata nel Settecento.
L’impianto della Rotonda
è però unico non solo nel
percorso creativo di Palladio ma in assoluto, dotata
com’è di quattro facciate
uguali, ciascuna delle quali
si protende con un pronao
a sei colonne verso il paesaggio circostante; l’architetto stesso offre nei Quattro libri una descrizione
dell’edificio che rende ragione della sua originale
struttura: «Onde perché
gode da ogni parte di bellissime viste, delle quali
alcune sono terminate, alcune più lontane, & altre
che terminano con l’Orizzonte; vi sono state fatte le
loggie in tutte quattro le
faccie». Tutto l’edificio
ruota in torno alla sala centrale, circolare, dalla quale
si dipartono quattro corridoi che si concludono
nelle logge, così che dal
centro della sala è possibile avere la contemporanea visione del paesaggio
da ogni lato, resa più ariosa
dalla posizione soprelevata
della costruzione rispetto
alla campagna circostante.
Commissionato nel 1566
da Paolo Almerico, un alto
prelato che dopo una brillante carriera alla corte papale si era ritirato nella
città di origine, l’edificio
ha una pianta perfettamente simmetrica in tutti
i suoi lati ed è dominato
dalla cupola che sovrasta
la sala circolare centrale e
che è all’origine del nome
popolare di Rotonda, che
condivide con il Pantheon
di Roma. L’architettura dei
templi dell’antichità appare qui aver fornito il principio ispiratore più che in
ogni altra costruzione civile di Palladio, e questo
risulta ancora più evidente
nel progetto pubblicato
nei Quattro libri, dove la
sala centrale è coronata da
una cupola semisferica che
non fu poi realizzata. Intorno al 1571 la costruzione della villa era compiuta, mentre la decorazione con affreschi e stucchi fu condotta in epoca
successiva, dopo la morte
di Palladio avvenuta nel
1580, e niente aggiunse al
mirabile dialogo fra la costruzione - splendida, nella
sua ambigua identità fra
sacro e profano - e il paesaggio circostante, che tanto
ha colpito e continua a incantare i visitatori. Scrisse
Goethe nel suo Viaggio in
Italia : «L’architetto forse
non ha mai creato nulla di
più lussuoso. Lo spazio oc-
A. Palladio: Villa Capra - Vicenza; Veduta di una facciata e prospetti dai Quattro libri
cupato dalle scalinate e dai
vestiboli è molto maggiore
di quello della casa stessa;
ciascuno dei lati, infatti,
potrebbe figurare come il
prospetto di un tempio [...]
E così come l’edificio si offre in tutta la sua magnificenza da qualunque punto
lo si guardi, altrettanto incantevole è il panorama
che si gode da esso».
La villa-fattoria è una realtà molto lontana dal molteplice aspetto di questa
dimora-tempio-monumento, eretta a glorificazione di colui che l’aveva
commissionata e del geniale artefice che l’aveva
concepita; la Rotonda sarebbe divenuto il punto di
partenza del palladianesimo, destinato a percorrere una lunga strada e a
dare notevoli frutti nell’Inghilterra del Seicento
- con il classicismo palladiano rappresentato dall’architetto Inigo Jones e del Settecento, con la pubblicazione dei tre volumi
del Vitruvius Britannicus ad
opera dell’architetto Colen Campbell, per il quale
la Rotonda continuava a costituire l’inimitabile modello di riferimento.
donata brugioni