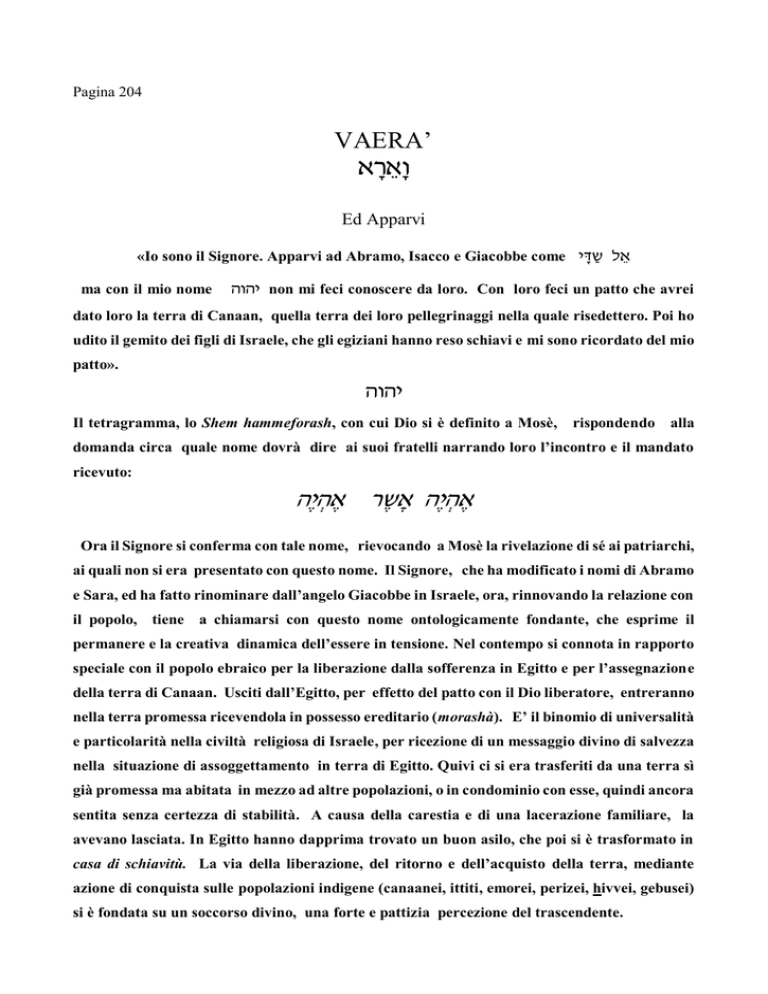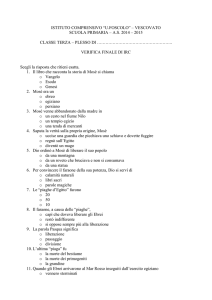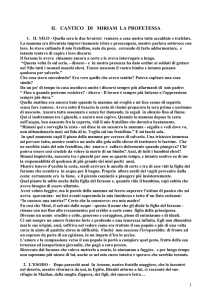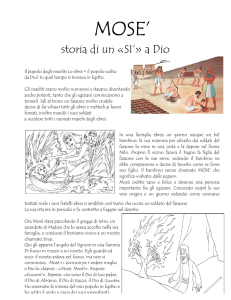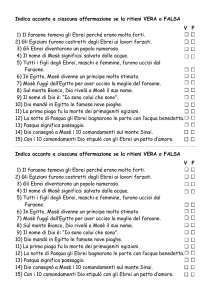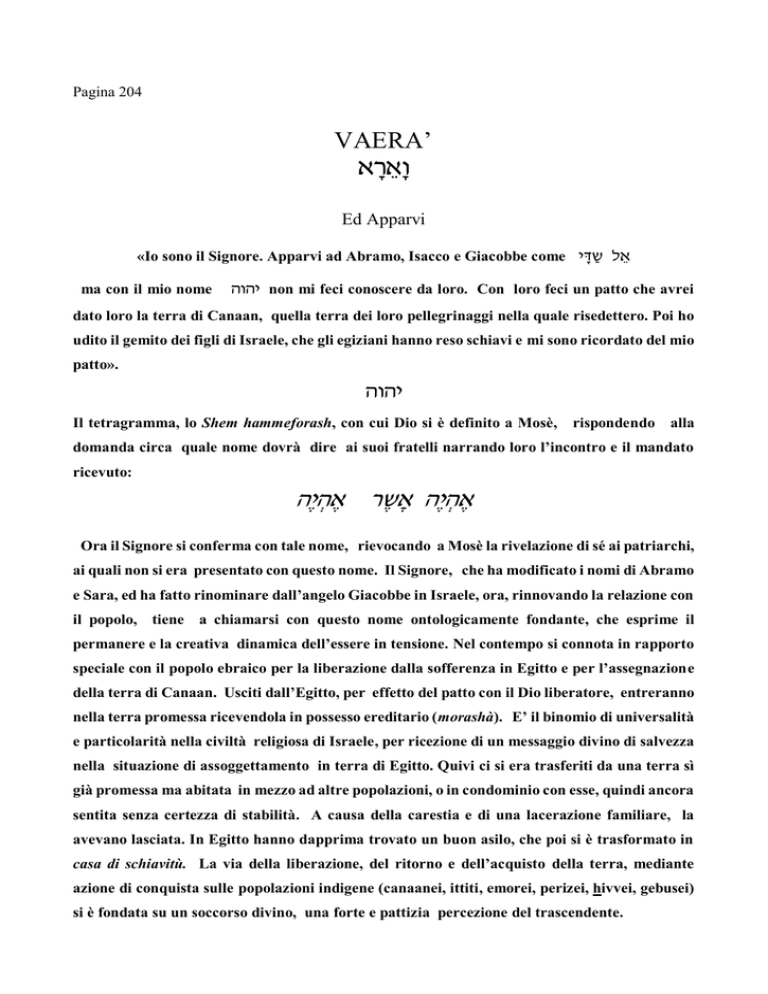
Pagina 204
VAERA’
Ed Apparvi
«Io sono il Signore. Apparvi ad Abramo, Isacco e Giacobbe come
ma con il mio nome non mi feci conoscere da loro. Con loro feci un patto che avrei
dato loro la terra di Canaan, quella terra dei loro pellegrinaggi nella quale risedettero. Poi ho
udito il gemito dei figli di Israele, che gli egiziani hanno reso schiavi e mi sono ricordato del mio
patto».
Il tetragramma, lo Shem hammeforash, con cui Dio si è definito a Mosè,
rispondendo alla
domanda circa quale nome dovrà dire ai suoi fratelli narrando loro l’incontro e il mandato
ricevuto:
Ora il Signore si conferma con tale nome, rievocando a Mosè la rivelazione di sé ai patriarchi,
ai quali non si era presentato con questo nome. Il Signore, che ha modificato i nomi di Abramo
e Sara, ed ha fatto rinominare dall’angelo Giacobbe in Israele, ora, rinnovando la relazione con
il popolo, tiene a chiamarsi con questo nome ontologicamente fondante, che esprime il
permanere e la creativa dinamica dell’essere in tensione. Nel contempo si connota in rapporto
speciale con il popolo ebraico per la liberazione dalla sofferenza in Egitto e per l’assegnazione
della terra di Canaan. Usciti dall’Egitto, per effetto del patto con il Dio liberatore, entreranno
nella terra promessa ricevendola in possesso ereditario (morashà). E’ il binomio di universalità
e particolarità nella civiltà religiosa di Israele, per ricezione di un messaggio divino di salvezza
nella situazione di assoggettamento in terra di Egitto. Quivi ci si era trasferiti da una terra sì
già promessa ma abitata in mezzo ad altre popolazioni, o in condominio con esse, quindi ancora
sentita senza certezza di stabilità. A causa della carestia e di una lacerazione familiare, la
avevano lasciata. In Egitto hanno dapprima trovato un buon asilo, che poi si è trasformato in
casa di schiavitù. La via della liberazione, del ritorno e dell’acquisto della terra, mediante
azione di conquista sulle popolazioni indigene (canaanei, ittiti, emorei, perizei, hivvei, gebusei)
si è fondata su un soccorso divino, una forte e pattizia percezione del trascendente.
Pagina 205
LA QUESTIONE ESEGETICA DEI NOMI DIVINI
La questione esegetica è che il nome fondato sul concetto di Essere ed
tetragramma
indicato con il
compare nella Torà già all’inizio del secondo racconto della creazione,
quando la relazione tra dio e l’uomo si fa più stretta e personale, alternandosi col nome Elohim.
E’ frequente nel rapporto con Abramo, che si rivolge lui stesso al Signore col nome dell’essenza
preceduto da Adonai (Genesi, capitolo 15, v. 8). Perché allora il Signore dice a Mosè che ai
patriarchi non si era fatto conoscerecon il nome ispirato al concetto dell’Essere ed indicato
col tetragramma? La differenza dei nomi, marcata in questo inizio del capitolo 6 di Esodo, ha
indotto una corrente di biblisti a ritenere che nella formazione del Pentateuco siano confluite
diverse scuole redazionali. L’ipotesi o teoria, detta documentale, è partita dall’esistenza di due
principali autori, o fonti, uno ispirato al nome del tetragramma e indicato con la sigla J (JHWH)
e l’altro ispirato al nome Elohim, indicato con la sigla E, che avrebbero composto due
documenti o testi, poi intrecciati tra loro. La teoria, scaturita da precedenti più lontani, si è
affermata nell’Ottocento ed ha avuto largo seguito nella prima metà del Novecento, ma non è
più in auge. Nello sviluppo della teoria si sono individuate almeno altre due fonti: una fonte
sacerdotale, detta P dall’inglese Priestly ed una deuteronomica, detta D. Il Deuteronomio è
peraltro individuato, dalla critica biblica, in quel libro che è stato trovato dal sommo
sacerdote Hilkiahu, in locali del Tempio, al tempo del re Giosia: si veda il Secondo libro dei
Re, cap. 22, v. 8.
Il rabbino e semitista Umberto Moshè David Cassuto (1883 – 1951) ha ammesso l’esistenza di
fonti diverse, che sarebbero pervenute nella Torà da tempi precedenti ed in essa sono state fuse
ed elaborate, in composizione unitaria, a suo avviso di un solo redattore nell’età di David.
Quanto alla diversità dei nomi, Cassuto la ha riscontrata per le altre divinità dell’area semitica.
Anche nelle religioni greco – romane, le divinità erano chiamate con più nomi, da luogo a luogo,
e per epiteti e funzioni diverse: Giove è Zeus, è Jupiter; Apollo è anche Febo, Diana è Artemide,
Venere è Afrodite, Mercurio è Hermes, e così via. Ebbene, nella Torà,
abbiamo visto,
all’inizio, parlando della creazione, che il nome Elohim denota l’universale Dio cosmico. Nel
rapporto con Mosè, per la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù in Egitto, il Signore si
è qualificato con il nome che esprime la sostanza e la durata dell’Essere. Ma questo nome è
comparso già in precedenza e l’alternanza dei nomi non deve stupire. Un nome di Dio, che
tuttora rifulge nella fede di Israele, è Shaddai, El Shaddai.
Pagina 206
Proprio all’inizio di questa parashà il redattore del testo introduce il discorso divino vertente
sull’opzione del tetragramma chiamando «Elohim» il soggetto che si rivolge a Mosè. Lo ha
dovuto d’altronde fare perché un soggetto nella frase ci voleva:
ֹלהים אֶ ל מ ֶֹשה וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו אֲ נִי יְ ה ָ ֹוה
ִ ֱוַיְדבֵּ ר א
ַ
Sarebbe la redazione della Torà così impertinente da presentare il Signore Iddio con il nome
Elohim proprio annunciando che egli ha deciso di chiamarsi con il nome tetragrammato? O è
stato un dispetto del redattore E al redattore sacerdotale J che si distingue col chiamare il
Signore col nome tetragrammato? Il problema non si porrebbe se non si fosse fatta distinzione
tra una scuola che ha chiamato Dio in un modo e un’altra che lo ha chiamato in altro modo. Vi
è nella liturgia ebraica una espressione che risolve la dualità, facendo da equazione tra i due
nomi: «Adonai Hu Ha Elohim». Come a dire, l’Essere (supremo) è Dio
יהוה הוא האֹלהים
**
Il Signore Iddio, ribadita la nuova rivelazione del nome, assicura a Mosè il sostegno per la
liberazione del popolo dalla schiavitù egiziana e il futuro possesso della terra promessa. Ma,
fidente nel divino sostegno, deve essere l’uomo Mosè ad andare a chiedere al faraone di lasciare
uscire dal suo regno i figli di Israele. Mosè gli obietta di non avere avuto successo con i figli di
Israele, così avviliti e scoraggiati, nell’annunciar loro la liberazione, chiedendogli come potrà
averlo nell’affrontare il potente sovrano con la sua mancanza di eloquio o difetto di pronuncia.
Il Signore provvede ad affiancargli Aronne, andranno insieme. Il Signore, per stimolare in
Mosè l’autostima e farlo sentire decisamente importante, ricorre ad una sorprendente
promozione, adoperando per la straordinaria carica il termine, sempre vigente, Elohim: « ti
costituisco Dio davanti al Faraone e tuo fratello Aronne sarà il tuo profeta».
Netatikha Elohim le farò veaharon ahikha ihiyé neviekha
Elohim ha anche un significato di giudice, essendo Dio modello di funzione giudicante, e Rashì
ha inteso questo passo nel senso che Dio costituisce Mosè giudice del faraone. Possiamo
Pagina 207
tranquillamente lasciare alla parola Elohim il significato di Dio, o magari di un messo divino,
come una incoraggiante esagerazione proferita da Dio stesso per rendere ardito Mosè.
*
GENEALOGIA
Il racconto, a questo punto, si interrompe, con l’intermezzo genealogico delle tribù discese dai
primi tre figli di Giacobbe, cioè Ruben, Simeone e Levi. La lista genealogica ripete in parte
quella fornita al capitolo 46 di Genesi, nella parashà Vaiggash.
Si diffonde con maggiori
particolari sulla tribù di Levi, cui appartengono i due prescelti esponenti, Mosè ed Aronne,
cioè il condottiero liberatore ed il fratello cooperatore che sarà il primo sacerdote, capostipite
del sacerdozio in Israele. La lista genealogica è rilevante per personaggi e connubi di cui si
parlerà nel seguito della Torà.
Apprendiamo nomi di molti personaggi della generazione dell’Esodo, nomi che si ritrovano
nell’onomastica ebraica, come primi nomi personali e come cognomi, fino ad oggi. Nella tribù
di Shimon (Simeone) troviamo uno Shaul (sarà il nome del primo re di Israele), definito figlio
della canaanea (ben ha-kenaanit). E’ un particolare che attesta connubi con genti di Canaan,
di cui si è parlato nel caso importante di Giuda. Troviamo un levita Livni, il cognome di una
esponente politica israeliana. Uno dei figli di Levi è Keat, che ha generato Amram il padre di
Mosè e Aronne, che visse 137 anni. Amram sposò la propria zia, Yocheved, cosa più tardi
proibita. Troviamo il nome della moglie di Aharon, che si chiamava Elisheva, era figlia di
Amminadav e sorella di Nachshon (l’uomo che per primo, secondo la tradizione, entrò nel mare
dei giunchi). Elisheva generò ad Aharon quattro figli (non sappiamo, come accade in genere,
di eventuali figlie): Nadav, Avihu, Elazar e Itamar. I primi due moriranno avvolti da una
fiamma nell’accendere fuochi sacri in modo improprio. Il terzo, Elazar, sposò una figlia di
Putiel e con lei generò Pinchas, il severo sacerdote che ucciderà la coppia mista ebreo-midianita
di Zimri e Kotzbi. Da Pinchas prende nome una parashà dei Numeri, che si è illustrata alla fine
dello scorso anno. Putiel, nonno di Pinchas, sarebbe un nome di Itrò, il sacerdote midianita,
suocero di Mosè, come vedremo più in là, nel libro dei Numeri, appunto nella parashà Pinchas.
La genealogia importa anche per la datazione del periodo trascorso dagli ebrei in Egitto
secondo la Bibbia: vi venne Levi con il figlio Keat, che generò Amram, l’unico a quanto pare,
vissuto sempre in Egitto (ma secondo il libro dei Giubilei venne da Hebron), Aronne figlio di
Amram è della generazione dell’esodo. Con vite miticamente lunghe, e tenendo conto della
Pagina 208
compresenza di padri e figli, per parti delle loro vite, si raggiunge la cifra di quattrocentotrenta
anni di permanenza in Egitto, indicata nel capitolo 12, al versetto 40. Se le vite non fossero state
così lunghe, per arrivare a quattrocentotrenta anni ci volevano più di quattro generazioni. O
sarebbero meno longeve o sarebbero state più generazioni, sussunte sotto quattro nomi di
spicco.
*
Mosè si accinge a tornare dal faraone per chiedergli di lasciare andar libero il popolo. Ce lo
immaginiamo giovane o uomo maturo e invece
aveva ottant’anni, e Aronne, il facondo
giovanotto, ne aveva ottantatre. Dobbiamo prendere le bibliche indicazioni di età nella
dimensione evocativa e trasfigurata di una antica longevità, specie dei giusti, che è venuta
nella Bibbia a mano a mano scemando verso la media umana dei tempi storici. A riempire i
tanti anni, ci sarebbero le imprese e i viaggi che si trovano nell’Haggadà, mentre il testo della
Torà li ha ignorati o tralasciati .
Il Signore avvisa i due inviati che il Faraone non li ascolterà. E’ una missione per ora senza
successo, ma va espletata sulla via della finale liberazione. Per piegare il Faraone, bisogna
pressarlo con una serie di richieste, seguite da altrettanti colpi. Il Faraone si sa potente e non
molla fino a che pensa di poter resistere. Se Mosè ha le labbra ottuse, il re di Egitto ha il cuore
duro e pesante, è khaved lev. Avrà bisogno, nella sua ostinazione, di ricevere e fare ricevere al
suo popolo molte batoste, prima di decidersi a fare uscire i figli di Israele. L’intransigenza del
faraone si ridesta dopo ogni smacco, incredula che possa averla scalfita per via di prodigi,
quando anch’essa ha i suoi tecnici del mestiere, e porta il cimento per le lunghe. L’ostinazione
faraonica, nel non mollare la presa sugli schiavi, si accorda con il dispiegarsi della potenza
divina per vincere una sfida di mortali e per conquistarsi la fedeltà di un popolo carente e
attraente, da soccorrere e da affascinare. Il cimento dei contenenti si accorda altresì
con
l’esigenza letteraria, che snoda e prolunga il percorso narrativo, tra l’ansia e la meraviglia dei
fedeli lettori, di generazione in generazione. Lettori del popolo salvato, fidenti o dubbiosi, che
il miracolo si rinnovi ad ogni tappa della sua dolente storia. Lettori di altre genti, entrate
nell’ottica della Bibbia, affisse allo scenario del Nilo, dell’Esodo, del Sinai.
MISURARSI CON LA MAGIA, OPERANDO PRODIGI
DIMENSIONE MAGICA E SENSO RELIGIOSO
Pagina 209
Come già nella parashà precedente, Dio ordina a Mosè e ad Aronne di stendere la verga per la
prodigiosa sua trasformazione in serpente. In un tempo di credenze nell’efficacia della magia,
si si è scesi a competere su questo piano. Gli antichi non mancavano certamente di capacità
tecniche con maggiore effetto, ma la dimensione magica, in parte associata alle abilità tecniche
e in parte ai voli dell’immaginazione, era rilevante. Il senso religioso dell’umanità, elevandosi,
ci tiene a distinguersi dalla magia, ma per altro verso, fidando nel concorso e nel soccorso di
forze superiori, quando si soffre nell’umana debolezza, si concepisce il prodigio. La lotta di una
minoranza perseguitata, per liberarsi dalla servitù, fu lunga e difficile, necessitò di sforzi, di
costanza, di fede, ed è stata tramandata in questo testo letterario, che Cassuto definisce un
«poema indirizzato al cuore della nazione» (A commentary on the Book of Exodus, già citato, p.
9). Egli ha supposto che originariamente l’Esodo fosse un vero e proprio poema epico, in versi
poetici, da cui si è ricavato il testo in prosa, con l’eccezione della Cantica dopo il miracolo del
Mare dei giunchi, rimasta in poesia.
Segnalo un libro di Guido Guidorizzi, edito dal Mulino, La trama segreta del mondo. La magia
nell’antichità, di cui apparve la recensione di Maurizio Bettini nel quotidiano “La Repubblica”
del 29 dicembre 2015. Riporto una parte della conclusione: «Il pensiero positivo, se così
vogliamo chiamarlo, ha tentato più volte di categorizzare l’esperienza magica per distinguerla,
in primo luogo, dalla religione, impresa ardua poiché in questo campo le distinzioni sono legate
a ciò che si intende per religione e, soprattutto, a quale tipo di soprannaturale si vuole riservare
questa nobile denominazione. Per gli antichi egizi, ad esempio, la pratica della magia faceva
strettamente parte della religione, così come è difficile negare che in Grecia l’intervento di
divinità quali Afrodite o Hermes venga talora invocato in contesti che a noi appaiono
decisamente magici».
**
ַשלַּח אֶ ת עַ ִמּי וְ ָיחֹגּוּ לִ י בַּ ִמּ ְדבָּ ר
«Lascia andare il mio popolo affinché mi prestino festoso culto nel deserto»
Così è formulata, in nome del Dio di Israele, da Mosè ed Aronne, la richiesta al Faraone. Al
suo primo rifiuto, dicendo il faraone che non conosce tale Dio e non li farà uscire, i due
rappresentanti della nazione, inviati di Dio, specificano che si tratta di una marcia di tre giorni
per offrire sacrifici al loro Dio, per non essere colpiti dalla peste o dalla spada. E’ una strana
Pagina 210
aggiunta in nero, di paura, contraria alla festa del pellegrinaggio, forse motivata dal volersi
mostrare costretti e dal far temere al padrone terreno il danno economico che gli verrebbe
perdendo la forza lavoro degli sotto quell’ira di un Dio, con cui se la potrebbe veder brutta
anche lui. Il faraone si arrabbia, accusa gli ebrei di pigrizia ed aggrava la loro fatica, con
l’ordine di doversi cercare da soli la paglia da cuocere col fango per fabbricare i mattoni.
Cominciano allora le piaghe con ripetizione della richiesta, comminando volta per volta una
punizione: si chiede di andare nel deserto, tutto il popolo, a celebrare il culto sacrificale. E’ una
richiesta minimale, per saggiare e avanzare all’obiettivo massimo dell’emancipazione. Sotto i
colpi delle piaghe, il faraone addiviene apparentemente alla concessione e smentendola appena
la piaga termina. Comunque delimita e condiziona, ogni volta, la concessione: fatelo entro i
confini, al che Mosè risponde abilmente che non era il caso di sacrificare in terra di Egitto
animali protetti dalla religione egiziana, che lui conosce e tratta con rispetto. La volta successiva
chiede vagamente che non si allontanino dal confine e preghino per lui, cosa diplomaticamente
accettabile, ma annullata dalla faraonica resipiscenza, appena la piaga cessa. E così via, come
torno sotto a dire.
**
Piaghe
מַ כּוֹת
L’ostinazione del Faraone viene piegata attraverso le dieci piaghe, makkot. Dieci è un numero
simbolicamente importante nel designare una serie dotata di completezza. La natura ne
suggerisce il valore con il numero delle dita, per articolazione delle mani e dei piedi nella sana
e perfetta struttura fisica dell’uomo.
I comandamenti enunciati nel patto del Sinai si
dispongono in un decalogo. Dieci saranno le sefirot nella qabbalà. L’arrivo al numero di dieci
pare un requisito costitutivo di solidale gruppo umano, come nel numero degli uomini
componenti il minyan.
Così dieci le piaghe, richiamate Haggadà di Pesah. Nello spazio narrativo di questa parashà
VAERA’ ne sono inferte sette: DAM, Sangue, ZEFARDEA, Rane, KINNIM, insetti alati o
pidocchi, AROV, miscuglio di animali dannosi, che si abbatte sull’Egitto, eccettuata la terra
di Goshen, abitata dagli ebrei, DEVER, pestilenza mortale sugli animali, eccettuati quelli degli
ebrei, SHEHIN, ulcere con bubboni sulla pelle,. BARAD, fitta grandine.
Pagina 211
Dopo la piaga del miscuglio di animali, Arov, il faraone consente di concedere agli ebrei un
permesso per compiere un rito sacrificale al Signore, purché venga eseguito entro il territorio
egiziano e non escano dall’Egitto. Mosè lo rifiuta adducendo che si devono sacrificare animali
protetti, per motivo evidentemente religioso, dagli egiziani e ciò provocherebbe odio e violenze
contro gli ebrei. Il sacrificio si dovrà quindi svolgere fuori dei confini egiziani. Il faraone
consente purché non si allontanino troppo, la raccomandazione suona ironica, come se ci tenga
tanto a loro, si intende per l’utilità che gli viene dal loro lavoro. Mosè, uscito dal suo cospetto,
ottiene la cessazione della piaga, e allora il faraone ritira la concessione e ci sarà bisogno di
altre piaghe.
Quando l’Egitto viene avvertito della grandinata, una parte dei servi del faraone teme la parola
del Signore e viene risparmiata dai danni del flagello. Il
faraone invece
persiste
nell’ostinazione, ma quando vede il paese gravemente devastato con l’eccezione della terra di
Goshen, abitata dagli ebrei, manda a chiamare Mosè ed Aronne, con apparenza di sincero
pentimento: «Ho peccato, questa volta. Il Signore è il giusto, io e il mio popolo siamo i malvagi»
אתי הַ פָּ עַ ם יְ הֹוָ ה הצַּ ִדּיק
ִ ָחָ ט
וֵ ַאנִי וְ עַ ִמּי הָ ְר ָשעִ ים
Chiede dunque a Mosé e ad Aronne di intercedere per la fine del flagello. Mosè, pur non
credendogli, si adopera per far cessare la grandine, ma, appena cessata, il faraone torna coi
suoi servi all’ostinazione.
Le prime tre piaghe il Signore ordina a Mosè che le produca Aronne, stendendo la mano con
la verga, prima verso le acque, poi verso la polvere: «Il Signore disse a Mosè ‘dì ad Aronne di
stendere la mano con la verga…» La quarta e la quinta le produce il Signore stesso. La sesta
la producono insieme i due fratelli, raccogliendo la fuliggine delle fornaci per produrre l’effetto,
e poi è Mosè a lanciarla in aria, sempre su direttiva divina. La settima la produce Mosè,
stendendo la mano verso il cielo.
Un maestro, di nome Tanhum (non so se Tanhum ben Hanilai o Tanhum ben Hiyyà)
ha
interpretato l’astensione di Mosè, su indicazione divina, dal colpire le acque e la polvere,
lasciando le due incombenze ad Aronne, come insegnamento di riconoscenza, perché le acque
lo avevano salvato, evitando di annegarlo quando era posato col cesto sulla loro superficie, e la
polvere si era prestata a coprire la salma dell’egiziano da lui ucciso nel difendere un fratello
Pagina 212
ebreo. Se si è riconoscenti, simbolicamente, verso elementi della natura, tanto più lo si deve
sapere essere per ogni beneficio ricevuto da esseri umani. La riconoscenza rientra nell’abito
morale e comportamentale detto, nella tradizione ebraica, Derekh Erez, una corretta via della
terra, giusto ed appropriato modo di stare al mondo con i propri simili.
Le piaghe di Egitto raffigurate nella HAGGADA’
Dalla Haggadà illustrata da Emanuele Luzzati, edizione Giuntina
Dopo ognuno dei flagelli si interpone una pausa, con l’apparente cedimento alla ragione da
parte del Faraone. Si ha la preghiera di Mosè e di Aronne al Signore per far cessare i malanni,
quindi i ripensamenti del faraone quando gli si lascia una tregua, le perplessità dei ministri
del Faraone che cominciano a rendersi conto dell’ineluttabile resa alla superiore forza celeste.
Vi sono egiziani che temono l’Eterno e sui quali non si abbattono certe piaghe. Al riparo sono
collettivamente gli ebrei , venendo risparmiato il paese di Goshen, dove risiedevano: «Farò
distinzione fra la terra di Goshen, dove risiede il mio popolo, e nella quale non vi sarà il
miscuglio di animali dannosi». Ma in Goshen non c’erano soltanto loro, dovevano risiedervi i
non pochi addetti alla sorveglianza degli ebrei, beneficiati in grazia di loro; non pochi se si pensa
che gli ebrei erano impiegati in opere pubbliche, evidentemente per luoghi e centri di
popolamento egiziano.
Pagina 213
Nel capitolo 9 (versetti 4, 6, 7) è detto che il Signore distingue tra ciò che appartiene agli egiziani
e ciò che appartiene agli ebrei, tra il bestiame degli uni e degli altri, sicché risulta che gli ebrei,
non alienati dalla pastorizia, conservavano una proprietà di animali. Mantenendo residui di
proprietà nella loro occupazione tradizionale di pastori, dovessero nel contempo fornire un
pesante quantitativo di manodopera per i lavori coatti. Parlavo di corvée.
*
LE PIAGHE DI DANNOSI FENOMENI NATURALI
Le piaghe di Egitto sono ovviamente parte leggendaria della Torà , ancora toccante e suggestiva
nel nostro rituale di Pesach. Ma la matura considerazione dei ricorrenti travagli umani per
eventi naturali, nei quali spesso la coscienza dei popoli ha veduto dei castighi, può avere riflesso,
in una concentrazione narrativa,
la memoria di disastri e di intemperie che hannoafflitto
l’Egitto nel corso dei tempi, con particolare intensità durante una certa fase. Alcuni studiosi si
sono dati a trovare in testi egiziani il racconto dolente di sciagure avvenute per cause naturali,
in periodi in cui si verificarono anche divisioni politiche e occupazioni straniere. Un papiro
egiziano, chiamato Ipawer, pare dal nome dello scriba, lamenta
confusioni, sconvolgimenti,
miserie, parlando, tra l’altro, di bestiame che si ammalava o che era razziato, di campi che non
producevano più grano (erano agli anni delle spighe magre avvizzite?) e di acqua del fiume
ridotta a sangue, forse per una strana colorazione rossa. Lo scriba diceva inoltre che queste
sventure erano state previste. Lo si spiega con i moniti che profeti o severi predicatori rivolgono
alle loro genti prevedendo le afflittive conseguenze di peccati e iniqui comportamenti. Questo
papiro egiziano o altri simili scritti sono riscoperti e decifrati per trovare parziali conferme al
racconto biblico, che si staglia,
ben tramandato e diffuso nel mondo, illustrando quei
lamentevoli accadimenti dell’Egitto come punizione per il trattamento crudele del popolo
ebraico e monito per lasciarlo andare libero.
**
L’espressione diventerà uno spiritual degli schiavi neri, “Let My People Go” e diventerà il motto
inalberato per l’uscita degli ebrei dalla Russia sovietica, che non li voleva fare uscire.
Pagina 214
HAFTARA’
La haftarà è tratta dal libro del profeta Ezechiele, precisamente dalla fine del capitolo 28 e dal
capitolo 29. Il nesso è costituito dal monito che il profeta, per ricorsi della politica di potenza
egiziana, rivolge al faraone e al suo paese, raffigurandoli nell’immagine del grande coccodrillo,
coricato con spavalda sicurezza fra i canali, nell’atto di dire che il Nilo, scenario ed emblema di
forza, è una sua creatura, laddove nella concezione biblica la terra con tutti i suoi paesaggi è
del Signore, che la concede agli uomini affinché ci vivano degnamente e ne facciano buon uso.
Ko amar Adonai
Hinneni alekha Parò melekh Mizraim
Hattanim ha gadol ha rovez betokh ieorav
Asher amar li ieorì vaanì asiteni
Così dice il Signore
Eccomi a te (su di te per punirti), o Faraone, re di Egitto,
il grande coccodrillo
Che se ne sta coricato (come sdraiato) in mezzo ai suoi corsi d’acqua,
e che dice ‘a me è il fiume
(mio è il fiume) e io lo ho fatto’
Ritengo che la parola tannim o tannin, che vuol dire coccodrillo si connetta al latino thynnus,
italiano tonno, avendo avuto originariamente il significato di un animale acquatico, poi
precisato in diverse lingue con riferimento a diversi animali acquatici. In ebraico tonno si dice,a
sua volta, tuna per evidente prestito dal greco tiunnos o dal latino. Col nome tonno si indica
peraltro diverse specie affini. Una può arrivare a pesare quattro quintali.
Shabbat Shalom,
Bruno Di Porto