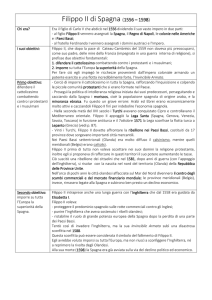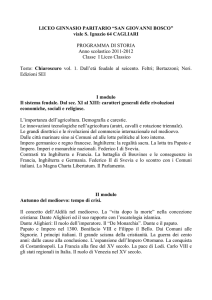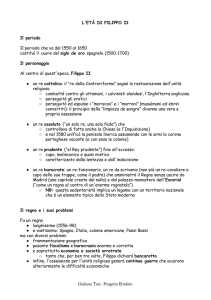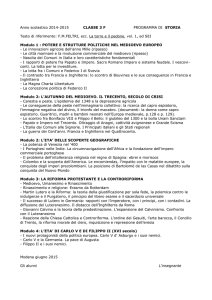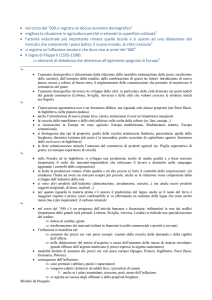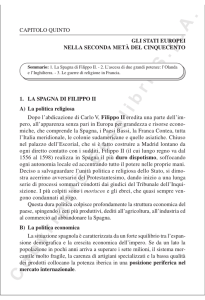unità
V
L’età di Calvino
e Filippo II
Riferimenti storiografici
1
Nel riquadro il dipinto di Pieter Bruegel ilVecchio intitolato Nozze contadine
(Vienna, Kunsthistorisches Museum): si notano in primo piano i piatti a
base di cereali, ampiamente coltivati in questo periodo.
Sommario
1
2
3
Povertà e vagabondaggio nel
Cinquecento
L’arte al servizio della fede nel
cattolicesimo del Cinquecento
Le croniche difficoltà economiche dei re
di Spagna
F.M. Feltri, Chiaroscuro – Nuova edizione © SEI, 2012
4
5
6
Verso Lepanto
L’attacco contro l’Inghilterra: gli obiettivi
di Filippo II
La posizione politica di Jean Bodin
1
Povertà e vagabondaggio
nel Cinquecento
UNITÀ V
Nella seconda metà del Cinquecento si ebbe un notevole aumento del pauperismo e della mendicità. Per fronteggiare questo problema sociale, i principali stati d’Europa decisero di non
affidare più ai privati il compito di assistere i bisognosi, ma di
assumersi tale incarico direttamente, nel tentativo di distinguere
i veri poveri dagli imbroglioni.
L’ETÀ DI CALVINO E FILIPPO II
2
Nessun altro secolo è stato tanto consapevole del
problema della povertà come il Cinquecento, in cui tutti
gli osservatori concordavano nell’affermare che il numero dei poveri e le difficoltà da essi create non erano
mai stati così grandi. Nel 1587 Sisto V deplorava in una
bolla il comportamento dei vagabondi («Riempiono di lamenti e di grida non solo i luoghi pubblici e le case private, ma perfino le chiese; fanno nascere timori e incidenti; vanno in giro come animali selvatici, senz’altra
cura che la ricerca di cibo»); Juan Luis Vives biasimava
i mendicanti che invadevano le chiese mentre i fedeli
erano in preghiera («Si fanno largo tra la gente riunita, sfigurati dalle piaghe, emanando un lezzo insopportabile»);
secondo il cronista Pierre de l’Estoile, nel 1596 a Parigi
«la folla dei poveri nelle strade era così fitta da impedire
il passaggio».
In molte città dell’Europa occidentale almeno un
quinto della popolazione era formato da indigenti. Nel
1551 il 17 per cento della popolazione di Troyes era inclusa nella categoria dei mendicanti e vagabondi, che
però non comprendeva i bisognosi domiciliati stabilmente nella città; negli stessi anni a Lovanio i poveri
erano il 21,7 per cento, a Leida circa il 40 per cento e a
Bruxelles il 21 per cento. A Segovia nel 1561 era classificato così un sesto della popolazione, senza contare i
vagabondi; a Bergamo nel 1575 su 20000 abitanti i poveri erano il 35 per cento, ma in questa categoria erano
compresi solo «i vecchi, i malati e i minori di 15 anni» a
Exeter e a Leicester al tempo di Elisabetta metà della popolazione viveva al di sotto della «linea della povertà». La
miseria era dunque una caratteristica innegabile delle
città, dove i disoccupati abbondavano; ma sarebbe errato considerarla come un fenomeno esclusivamente
urbano, e molti poveri erano originari delle campagne. [...]
I poveri senza fissa dimora furono sempre guardati
con sospetto e apprensione, anche quando non erano
così numerosi come a Troyes nel 1551. Essi affluivano
nelle città in cerca soprattutto di lavoro, di ricovero e di
assistenza: in un documento del 1569 si affermava che
la beneficenza aveva attirato a Londra «un gran numero
di vagabondi, furfanti, sbandati e oziosi, oltre che di poveri, storpi e malati». Ben presto si cominciò a pensare
che non fosse opportuno prestare a tutti i bisognosi un
aiuto indiscriminato. I vagabondi erano malvisti sia perché oziosi, sia perché rappresentavano una minaccia per
l’ordine sociale: erano gente senza radici e senza occupazione, estranei alla comunità che li ospitava, in una parola erano «diversi». Nel 1582 un magistrato del Kent,
William Lambard, si scagliava contro «i vagabondi e i
mendicanti senza fissa dimora che infettano e corrompono il mondo coi loro furti, l’ubriachezza, la prostituzione, la procreazione di [figli – n.d.r.] illegittimi, gli omicidi e infiniti altri misfatti».
Naturalmente molti di questi vagabondi cercavano
solo di procurarsi da vivere. L’emigrazione di mera sussistenza, in aumento nel XVI secolo, era strettamente
connessa col ciclo agrario: testimonianze relative all’Inghilterra degli anni dopo il 1570 mostrano che la mobilità era massima al termine della mietitura (agosto-settembre) e al tempo della semina (marzo-aprile). A
differenza dei tradizionali migranti stagionali, che si trasferivano d’estate nelle zone di mietitura, ma tornavano
in autunno ai loro villaggi, i nuovi migranti erano spesso
degli sradicati, come quel Nicholas Lawrence, nativo
dell’isola di Thanet, che dichiarò di essere «un povero
bracciante, che oggi vive in un luogo e domani in un altro». [...]
Le leggi, in base al presupposto che i disoccupati
fossero tali per volontà propria, li trattavano duramente,
come si può vedere da un decreto emanato nel 1544 nei
Paesi Bassi, in cui si ordinava che fossero mandati alle
galere «tutti i briganti e i vagabondi che non fanno altro
che angariare la povera gente, andando di villaggio in villaggio e da una fattoria all’altra a chiedere l’elemosina,
spesso con minacce, e passando la notte in taverne, fienili e luoghi simili; la loro miseria non deriva dai
mali della guerra o da altre cause legittime, ma soltanto dal loro carattere riottoso e dalla loro indolenza, nel
senso che non hanno nessuna voglia di guadagnarsi la
vita lavorando».
H. KAMEN, L’Europa dal 1500 al 1700, trad. di G. SCATTONE,
Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 179-182
Quale giudizio esprimevano sui poveri, le persone di alto livello sociale, nel Cinquecento?
In quali provvedimenti pratici si espresse la loro valutazione?
F.M. Feltri, Chiaroscuro – Nuova edizione © SEI, 2012
Mentre il calvinismo rifiutava le immagini sacre, il cattolicesimo ne fece un uso sempre più marcato nei propri luoghi di
culto, concependo l’arte come uno strumento capace di affascinare i fedeli e di tenerli legati alla Chiesa di Roma.
[Grazie ai nuovi ordini religiosi sorti nel Cinquecento],
la Chiesa si salvò, e poté guidare da Roma una delle più
straordinarie rivoluzioni dall’alto che la storia conosca. Diresse la battaglia in modo riflessivo. La civiltà che essa
propagò – poco importa il nome – fu una civiltà di combattimento, e la sua arte un mezzo, un mezzo in più.
Si tratta, in realtà, d’un’arte che appartiene alla propaganda. In certo qual modo, con i suoi lati buoni e cattivi, è un’arte guidata dall’alto. A Rubens come a Caracciolo, al Domenichino come a Ribera o a Zurbarán o
a Murillo, dei religiosi accorti, dei teologi chiesero l’esecuzione di quadri da essi composti in spirito; salvo poi a
rifiutarli, se l’esecuzione sembrasse loro difettosa. Contro il protestantesimo, nemico dei templi sontuosi e delle
immagini, la Chiesa volle coscientemente costruire le
più belle case di Dio sulla terra, immagini di Paradiso,
lembi di cielo. L’arte è un mezzo potente per combattere
e istruire. Un mezzo per affermare, mediante la potenza
dell’immagine, la santità immacolata della madre di Dio,
il valore efficace dei santi, la realtà possente dell’eucarestia, il primato di San Pietro, un mezzo per trarre argomento dalle visioni e dalle estasi dei santi. Pazientemente esaminati, pazientemente insegnati, temi
iconografici identici circolano così in tutta l’Europa. Se il
barocco forza la nota, se ha il gusto della morte, della
sofferenza, dei martiri presentati con un realismo senza
debolezze, se sembra abbandonarsi al pessimismo, al
desengano spagnolo del secolo XVII, ciò dipende dal
fatto che esso vuole e deve provare, che ricerca il particolare drammatico che colpisce e fa effetto. È un’arte ad
uso dei fedeli, che si vuol convincere e trascinare, ai quali
si vuole insegnare con l’azione una sorta di verismo, l’esattezza di tanti dogmi contestati: quelli del Purgatorio o
dell’Immacolata concezione. Arte teatrale e consapevolmente teatrale: il teatro non servì forse d’arma da
guerra ai gesuiti, specialmente nella conquista della Germania, in un tempo, aggiungiamolo, in cui esso aveva
dappertutto i suoi diritti, le sue compagnie ambulanti, ben
presto le sue scene fisse?
F. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età
di Filippo II, trad. di C. PISCHEDDA, Einaudi, Torino 1976,
pp. 881-882
Con quali finalità venne usata l’arte dalla Chiesa cattolica, nel Cinquecento e nel Seicento?
Che cosa significa l’affermazione secondo cui «L’arte è un mezzo potente per combattere e istruire»?
Spiega che cosa significa la seguente affermazione: «Il barocco (...) è un’arte ad uso dei fedeli (...)
Arte teatrale e consapevolmente teatrale».
F.M. Feltri, Chiaroscuro – Nuova edizione © SEI, 2012
UNITÀ V
L’arte al servizio della fede
nel cattolicesimo del Cinquecento
3
RIFERIMENTI STORIOGRAFICI
2
3
Le croniche difficoltà economiche
dei re di Spagna
UNITÀ V
Artiglieria, fanteria e flotte da guerra erano costosissime: i re
di Spagna, che dovevano combattere su diversi fronti contemporaneamente, si trovarono costantemente in gravissime condizioni economiche; furono costretti a indebitarsi con i finanzieri tedeschi
o genovesi e infine, a più riprese, dichiararono bancarotta.
L’ETÀ DI CALVINO E FILIPPO II
4
Rotta, da parte francese, sulla frontiera delle Fiandre,
la tregua di Vaucelles la notte dell’Epifania, nel gennaio
1557 Filippo II decide di radunare un grande esercito per
attaccare a fondo il nemico e penetrare in Francia nell’estate: che sarà, di fatto, l’estate di San Quintino [= guidato dal duca di Savoia Emanuele Filiberto, l’esercito
spagnolo riportò una grande vittoria, dopo la quale i due
contendenti stipularono la pace di Cateau-Cambrésis –
n.d.r.]. Ma a raccoglier truppe – mercenari spagnoli, tedeschi, italiani – occorron molti soldi; e di soldi il trentenne re di Spagna non ne ha. Unica risorsa, tesoro sembra sicuro, l’oro e l’argento giunti a Siviglia il 3 e il 4
ottobre 1556 da Tierra Firme e dalla Nuova Spagna: e
vale a dire da Panama, Venezuela, Colombia e dal Messico: più di cinque milioni di ducati, si ritiene, depositati
nella Casa de Contratacion di Siviglia. Una gran parte,
certo, non spetta alla Corona, sì [= bensì – n.d.r.] a mercanti, a passeggeri tornati dall’America su quelle stesse
navi che han recato i cassoni pieni d’oro e d’argento, in
lingotti e in verghe, persino a «defunti», e quindi ai loro
eredi in Spagna. Ma già Carlo V ha contratto l’abitudine
– non apprezzata da nessuno – di prelevare, quando ne
abbia bisogno, anche la parte de’ mercanti e de’ passeggeri, accordando loro in compenso juros, al 5 o al 7%
generalmente, quelli che oggi chiameremmo titoli di rendita pubblica (ed era assai magro rifacimento): e Filippo
ha dato ordine che, anche questa volta, né pur un lingotto esca dalla Casa de Contratacion. Così, meditando
il suo gran piano, spedisce in Spagna il suo favorito, Ruy
Gomez de Silva, conte di Melito, che deve premere in
loco per l’immediato invio di grosse somme, in Fiandra
e pur [= anche – n.d.r.] in Italia, dove la situazione appare
inquietante e non si sa che possono combinare papa
Paolo IV, i Francesi e quei pochi Italiani irriducibilmente
nemici a Spagna. Senza il minimo indugio, occorrono
1650000 ducati per le Fiandre, 800000 ducati per l’Italia; e ancora altri 600000 ducati per le piazzeforti spagnole sulla costa nordafricana, La Goletta e Orano, e per
la difesa della frontiera pirenaica: tutti, s’intende, da prelevare sul favoloso oro di Siviglia. Si deve fare uno sforzo
supremo, «el ultimo esfuerço», e per sollecitarlo Filippo
postilla di propria mano una lettera alla sorella Giovanna
[= in quegli anni governatrice di Spagna – n.d.r.].
Ma a Siviglia non vi sono più non diciamo i cinque milioni vagheggiati a Bruxelles, sì nemmeno i poco più di
due milioni risultanti dai computi del Consejo de Hazienda a Valladolid: vi si trovano, a disposizione del sovrano, soli 489000 ducati, un’inezia, una miseria di fronte
alle spese che si preannunziano – nell’estate, la paga
mensile dell’esercito di Fiandra ammonterà, da sola, a
quasi 400000 scudi. Il resto è stato subito portato via dai
mercanti e dai passeggeri, bene attenti a mettere al sicuro i preziosi lingotti. Fu un duro colpo per Filippo.
Aveva accarezzato un grande progetto, tale da dargli gloria e onore [...]. Ed ecco, gli vengon meno d’improvviso
i mezzi. «Niuna nuova [= Nessun’altra notizia – n.d.r.] –
scrive alla sorella, – sarebbe potuta giungermi più angosciosa; è il peggior tradimento che mi si potesse fare, e
coloro che ne sono responsabili hanno posto a rischio il
mio onore e la mia reputazione, che è la cosa a cui più
tengo, tanto più essendo questa la prima campagna che
devo intraprendere.»
Così lamentava il giovane re. Ma, da Yuste [= il monastero dopo si era ritirato dopo l’abdicazione del 1556 –
n.d.r.], salì allora una voce ch’era ben altro che lamento: e
fu quella di Carlo V. [...] In lui, Carlo, l’imprevista falla a Siviglia rivolgeva animo e pensieri a tante altre volte quando
s’era trovato con «el agua en çima de la boca», ed era stato
costretto a ricorrere agli espedienti più vari per mettere insieme un po’ di quattrini. Da quei lontani giorni tra fine febbraio e primi di marzo del ’25, quando già i suoi generali a
Pavia avevano sconfitto e addirittura fatto prigioniero il rivale acerrimo, Francesco I re di Francia; ed egli, nulla sapendo del già avvenuto trionfo – la battaglia fu combattuta
il 24 febbraio, e la notizia ne giunse a Madrid solo il 10
marzo, tant’era immenso allora il mondo e lento il contatto
fra paesi anche d’un solo sovrano –, affidava a un breve
scritto autobiografico, in francese, le sue preoccupazioni e
il suo scontento. E nelle annotazioni balzava anzitutto in
luce il bisogno di denaro: «Io mi trovo solo, i miei amici mi
hanno piantato in asso, è quasi impossibile trovar denaro... e l’unico vero rimedio è ch’io sposi l’infanta di Portogallo, Isabella, al più presto, sì da ricavar dalla dote la
maggior somma possibile di denaro in contanti». La «faute
d’argent», la mancanza di denaro, è ritornello costante. [...]
Ultimo, e più doloroso ricordo, nell’uomo Yuste che
rivedeva il passato, l’anno della umiliazione, il 1552 [=
Carlo V fu sconfitto dai principi protestanti tede- schi –
n.d.r.]: anche allora, l’acqua alla gola per mancanza di
denaro in un momento criticissimo; e il rifiuto di prestiti
da parte dei banchieri troppo bene informati della situazione, consapevoli della miseria dell’imperatore, fors’anche d’accordo con i suoi nemici. Così che né ad Augusta né altrove il signore delle miniere d’oro e d’argento
del Messico e del Perù trovava qualcuno che si lasciasse
convincere ad accordar un prestito, per quanto buone
fossero le condizioni offerte; e a Carlo V sola risorsa finanziaria un certo momento furono duecentomila scudi
inviati dal viceré di Napoli.
F. CHABOD, Carlo V e il suo impero, Einaudi, Torino 1985,
pp. 555-557; 559-560
Individua i principali stratagemmi attuati dai re di Spagna, per fronteggiare le loro croniche difficoltà economiche.
F.M. Feltri, Chiaroscuro – Nuova edizione © SEI, 2012
Lo storico Fernand Braudel ha definito la battaglia di Lepanto
una “vittoria senza conseguenze”, poiché essa non segnò una
vera svolta nei rapporti di forza tra cristianità e Islam. Il brano
che segue illustra la complessità delle relazioni internazionali
e delle pressioni che si contrapposero alla corte dei sultani nei
decenni che precedettero la battaglia.
Nel 1566 scomparve il grande Solimano. L’Occidente tirò un sospiro di sollievo; qua e là vi furono anche manifestazioni di gioia. Eppure, un velo di mestizia
sembrò offuscare quel prevedibile giubilo. Era venuto
meno uno dei protagonisti della storia del secolo, un
uomo politico e un sovrano che aveva saputo affascinare anche l’Occidente: che continuamente aveva parlato di lui, ne aveva imitato immaginificamente i fasti e i
costumi nelle sue feste e nei suoi apparati, lo aveva ammirato, lo aveva perfino a più riprese ritratto. Lo stesso
Tiziano aveva dipinto ben tre volte la sue effigie, fondandosi su immagini che gli erano state messe a disposizione e sforzandosi d’interpretarle. Paolo Giovio lo
aveva lodato come pio e magnanimo. Fu soprattutto
grazie a Solimano e al suo mito occidentale –alimentato
da Montaigne, da Bodin, da Charon – che si fondò l’idea diffusa della giustizia, dell’ordine, della potenza severa e inesorabile dell’impero turco, parallela a quella
della sua temibilità in guerra e della crudeltà dei suoi costumi. I molti viaggiatori cinquecenteschi francesi in
Oriente non risparmiavano elogi nei confronti del Gran
Turco che governava le sue genti in pace e giustizia. Si
onorava la «pace turchesca» da lui imposta al suo impero: un’espressione d’onore, evidentemente ispirata
alla pax romana, per quanto non mancasse chi ne sottolineava il carattere tirannico e feroce.
L’imponente macchina da guerra ottomana era comunque ancora in moto. Il nuovo sultano Selim II (15661574), sistemate sia pur provvisoriamente le cose sul
fronte balcanico-danubiano con la pace di Adrianopoli
del 1568, tornava a investire con foga e da più versanti
lo scacchiere mediterraneo. In un paio d’anni i cristiani
persero infatti, a ruota, Tunisi (occupata nel 1569 da UlujAli succeduto al defunto Dragut come governatore di Algeri), e Cipro, conquistata dagli infedeli fra il luglio del
1570 e l’agosto dell’anno successivo, quando la piazzaforte veneziana di Famagosta si arrese. La perdurante
intesa con i francesi rendeva più efficace l’offensiva turca.
Come accolse l’Occidente la morte di Solimano?
Quali fattori determinarono l’alleanza tra Spagna e Venezia?
F.M. Feltri, Chiaroscuro – Nuova edizione © SEI, 2012
Si dispiegava intanto, presso il sultano, l’attività politica e diplomatica d’un uomo geniale: Giuseppe Nasi,
esponente autorevole degli ebrei spagnoli esuli a Istanbul e nelle altre città dell’impero ottomano. Mentre il vizir Mehmet Sôqüllü insisteva affinché si proseguisse la
guerra contro la Spagna per il controllo dell’Africa settentrionale e magari si riprendesse quella contro l’impero
per l’Ungheria, il Nasi caldeggiava invece un conflitto
contro Venezia: e aveva intensificato la propaganda in tal
senso dopo che, nel 1566, il sovrano turco lo aveva investito duca di Nasso e di altre isole dell’Egeo. Egli organizzava intanto attorno a Tiberiade delle colonie ebraiche chiamandovi gli ebrei espulsi dall’Italia.
Se nella sua politica nordafricana il sultano seguiva
le indicazioni del suo vizir, non trascurava certo i consigli del suo amico ebreo. Il 25 marzo del 1570 erano difatti arrivate a Venezia le richieste turche relative alla resa
di Cipro. La Serenissima – che, dopo la Prévesa, aveva
sino ad allora evitato di compromettersi in un’esplicita alleanza in funzione antiturca con la Spagna per non esser coinvolta nelle questioni nordafricane – dovette rivolgersi accorata, ora, all’unico che sembrava disposto
a fermar gli ottomani: Filippo II. La Spagna cristiana –
scossa da uno sbarco dei maghrebini in Andalusia, seguito dalla rivolta dei moriscos di quella regione tra
1565 e 1570 – rispose entusiasta. Cipro seguiva come
sappiamo il suo destino: cadeva Nicosia il 9 settembre
del 1570, cadeva Famagosta il 5 agosto del 1571: quattro giorni più tardi il fratellastro del Rey prudente, Giovanni d’Austria – il vincitore dei moriscos andalusi –,
sbarcava a Napoli; e poco più d’un mese più tardi una
flotta ispano-veneto-papale salpava da Messina. L’Occidente fu investito dalle notizie relative a Cipro, che sortirono però un effetto opposto a quel che i turchi – seminando al loro solito il terrore attraverso una crudeltà
sapientemente ostentata – avevano immaginato. Il racconto del martirio inflitto al comandante veneziano di Famagosta, Marcantonio Bragadin, che lo aveva sostenuto
con impavido stoicismo, fece presto il giro della Cristianità: e concorse a provocare proprio quel che l’abile
gran vizir Mehmet Sôqüllü aveva fatto fin allora il possibile per evitare, l’alleanza tra Spagna e Venezia.
F. CARDINI, Europa e Islam. Storia di un malinteso,
Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 234-235
UNITÀ V
Verso Lepanto
5
RIFERIMENTI STORIOGRAFICI
4
5
L’attacco contro l’Inghilterra:
gli obiettivi di Filippo II
UNITÀ V
Filippo II era profondamente religioso, ma anche capace di
soppesare tutti i rischi di un’impresa militare. Il suo obiettivo principale, secondo alcuni studiosi, era di infliggere una dura lezione
alla regina Elisabetta I, al fine di costringerla a interrompere i
contatti politici con i ribelli protestanti dei Paesi Bassi e di obbligarla a togliere ogni appoggio e sostegno ai corsari inglesi
che saccheggiavano le navi spagnole cariche d’argento, nell’Atlantico.
L’ETÀ DI CALVINO E FILIPPO II
6
Indipendentemente dai suoi piani di guerra, quali
erano gli obiettivi che Filippo II si proponeva di conseguire con il progettato attacco all’Inghilterra? Per lungo
tempo la storiografia inglese ha privilegiato la tesi secondo la quale il re spagnolo non si proponeva nulla di
meno della conquista dell’Inghilterra, del rovesciamento
di Elisabetta – magari anche della sua esecuzione – e del
ristabilimento del cattolicesimo in Inghilterra, come del
resto il piano di Zúñiga [Juan Zúñiga, uno dei più autorevoli consiglieri politici di Filippo II, n.d.r.] indicava a
chiare lettere. Coloro che parteciparono alla campagna
dell’Armada, da una parte e dall’altra, sembrarono condividere in larga misura questa opinione.
Più di recente però l’orientamento degli storici in
merito è in parte cambiato. Certo, Filippo detestava il
protestantesimo con tutte le sue forze e nulla gli sarebbe
stato più gradito che vederlo schiacciato definitivamente, in Inghilterra come altrove; ma egli era anche abbastanza realista da capire quali fossero gli interessi
concreti suoi e del suo regno. Come aveva scritto a Farnese, si rendeva conto del fatto che i cattolici inglesi
erano ormai una minoranza perseguitata e ininfluente, e
che restaurare pienamente il cattolicesimo in quel paese
era ormai una causa persa. Non gli sfuggiva che,
quand’anche gli fosse riuscito di sbarcare in Inghilterra
e detronizzare la regina, si sarebbe poi trovato di fronte
a una resistenza popolare irriducibile che avrebbe rappresentato un drenaggio insostenibile sulle risorse
umane e finanziarie del suo impero. Quanto si era rivelato difficile – e alla lunga sarebbe stato impossibile – domare la rivolta olandese era un esempio più che eloquente di quale sarebbe stata l’enormità di un simile
compito in un paese più vasto e popoloso, che per di
più era un’isola. E poi quanto a lungo un’occupazione
spagnola dell’Inghilterra sarebbe stata tollerata dalle altre potenze europee, a cominciare dalla Francia? C’era
poi un altro fattore da considerare: se infatti Elisabetta
fosse stata, in qualsiasi modo, eliminata, a succederle
sul trono sarebbe stata Maria Stuarda, cattolica, sì, ma
anche mezza francese, e che era anzi già stata regina
consorte di Francia nonché legatissima alla ultrapotente
fazione dei Guisa. Maria gli doveva della gratitudine:
ma fino a che punto la gratitudine può prevalere sulle
considerazioni politiche? Bel risultato sarebbe stato di
abbattere i Tudor e i protestanti per favorire l’eventualità
che suo padre, Carlo V, gli aveva raccomandato di temere più di ogni altra, una stretta alleanza fra Francia e
Inghilterra!
F.M. Feltri, Chiaroscuro – Nuova edizione © SEI, 2012
Quella di Filippo II era una mente complessa e capace di analisi sottili. Alla sua leadership si può rimproverare di aver voluto decidere tutto dal suo piccolo studio all’Escorial senza rendersi conto di persona delle
situazioni: non solo egli non parlò mai direttamente ad
Alessandro Farnese [principe reggente nei Paesi Bassi
spagnoli, che avrebbe dovuto unire le proprie forze a
quelle dell’Armada, n.d.r.] durante tutto questo periodo,
ma non visitò mai neppure la sua flotta in allestimento a
Lisbona. Anche la sua esperienza di guerra era limitata
e la strategia che aveva alla fine prescelto soffriva senza
dubbio una scarsa aderenza alla realtà. Ma non gli si può
negare la capacità di aver soppesato attentamente i rischi che correva né di aver saputo valutare con realismo
il conto dei benefici e delle perdite che potevano derivare
da un’impresa. E questa capacità non gli venne certo
meno in questa occasione. L’analisi dei programmi e
delle azioni porta a ritenere che Filippo avesse in mente
due tipi di obiettivi, anche intercambiabili, che potevano
essere alternativamente privilegiati in funzione degli
eventi: gli obiettivi massimi e quelli minimi. Gli obiettivi
massimi erano senza dubbio realizzare lo sbarco in Inghilterra e giungere fino a Londra: ma questo non significava necessariamente l’eliminazione di Elisabetta e
del suo regime. In queste condizioni e con la sua bandiera che sventolava sulla Torre di Londra, con ogni
probabilità Filippo sarebbe stato disposto a una pace a
condizioni per lui vantaggiose, ma non del tutto devastanti per la regina. Queste condizioni avrebbero compreso la rinuncia alla guerra di corsa e alla pirateria, il ritiro delle truppe dalle Fiandre e la cessazione del
sostegno ai ribelli nonché la libertà di culto per i cattolici in Inghilterra. Probabilmente vi si sarebbe aggiunto il
pagamento di una indennità di guerra e magari il ritiro
delle guarnigioni inglesi dall’Irlanda, oltre alla garanzia del
controllo di qualche fortificazione nella stessa Inghilterra: ma Elisabetta e il protestantesimo inglese sarebbero sopravvissuti «buoni per un altro giorno» e l’esercito spagnolo sarebbe stato ritirato dal paese. Del resto,
il protestantesimo era ormai una componente dell’Europa e, al di fuori dei propri territori, Filippo non si era mai
proposto concretamente l’obiettivo di sradicarlo del
tutto.
Naturalmente gli eventi bellici hanno poi una logica
loro propria che può portare a far cambiare gli obiettivi
iniziali: ma questo è un altro problema. Nel 1586 e anche nel 1588 gli obiettivi massimi del re erano più o
meno quelli. I due più importanti erano certamente la
cessazione degli attacchi inglesi al commercio e alle coste spagnole, obiettivo che era anche quello più sentito
dalla società spagnola nel suo insieme, e la cessazione
del sostegno inglese ai ribelli olandesi. La libertà di culto
per i sudditi cattolici di Elisabetta era certamente un
obiettivo importante, ma complementare. Se questi
erano gli obiettivi massimi, l’obiettivo minimo irrinunciabile era senza dubbio farla finita con gli attacchi inglesi
per mare. Ma questo si poteva perseguirlo anche per altra via che non fosse lo sbarco in Inghilterra e perfino l’invio dell’Armada. Si poteva cioè intimidire gli inglesi a tal
punto da indurli a intavolare trattative di pace con la sola
minaccia dell’attacco diretto e dello sbarco. Questo poteva essere ottenuto tanto facendo apparire nella Manica una grande flotta in assetto di guerra, con relativo
accompagnamento di trasporti sui quali fosse imbarcato
un corpo di spedizione, quanto al limite senza necessariamente che questa partisse: bastava che si sapesse
che essa era in allestimento. Proprio per questo motivo
però era indispensabile che i preparativi fossero credibili. […] Non vi era alcun dubbio sul fatto che inviare l’Armada nella Manica avrebbe rappresentato un drenaggio
di risorse quasi insopportabile. Non sfuggiva al re che,
una volta dato l’annuncio della costituzione della flotta
per attaccare l’Inghilterra, egli non poteva desistere dall’impresa senza ottenere almeno il suo obiettivo minimo, e cioè la fine degli attacchi inglesi per mare, pena
una gravissima perdita di prestigio all’estero e anche all’interno. Costi vi sarebbero quindi stati comunque: ma
sfruttare l’elemento deterrente rappresentato dall’Armada senza dover necessariamente combattere
avrebbe almeno consentito di ridurli. Fu per questo che
Filippo esitò fin quasi alla fine prima di impartire ai suoi
capi militari gli ordini definitivi.
A. MARTELLI, La disfatta dell’Invincibile Armada. La guerra
anglo-spagnola e la campagna navale del 1588, il Mulino,
Bologna 2008, pp. 144-148
UNITÀ V
A giudizio dell’autore, Filippo II può essere definito «fanatico», cioè determinato a lottare a qualunque costo,
pur di riportare il cattolicesimo in Inghilterra e nel resto d’Europa?
Quali erano gli obiettivi massimi di Filippo II? E quali, invece, gli obiettivi minimi?
Qual era il principale motivo di rancore della società spagnola, nei confronti degli inglesi? Il re era sensibile a questo
problema? Vi era sintonia tra il sentire del re e quello della società spagnola?
RIFERIMENTI STORIOGRAFICI
7
F.M. Feltri, Chiaroscuro – Nuova edizione © SEI, 2012
6
La posizione politica di Jean Bodin
Per Jean Bodin, l’autorità dello Stato dev’essere conservata
a qualunque costo, pena il caos e l’anarchia. Da un lato, egli attacca i ribelli calvinisti, che giustificano la rivoluzione, ma dall’altro ritiene che la tolleranza religiosa sia indispensabile per
il mantenimento dell’ordine politico.
UNITÀ V
A La stabilità dello Stato come obiettivo
politico primario primo sottotitolo
L’ETÀ DI CALVINO E FILIPPO II
8
Bodin non pretende affatto di accantonare il grande
valore duraturo dell’uniformità religiosa. L’intera questione delle religioni rivali viene introdotta nel corso della
discussione e a mo’ d’esempio dei pericoli della «sedizione e del fazionalismo». Egli inizia ammettendo che
nulla è più importante per «conservare in vita gli Stati nel
loro ordinamento», giacché serve a fornire «il fondamento primo del potere» e della forza dello Stato. Qualunque cosa Bodin fosse stato disposto ad affermare e
scrivere in privato, pubblicamente, nelle sue dottrine,
affermò sempre la necessità di non accettare il diritto naturale alla tolleranza delle minoranze religiose. Egli insiste
al contrario che siccome «le dispute in materia religiosa»
tendono più di qualsiasi altra cosa «ad apportare l’eversione degli Stati, occorre proibirle per certo con leggi inviolabilissime», cosicché una religione la quale «si regge
sul consenso comune», non sia di nuovo «messa in discussione». Questi sentimenti sono tuttavia accompagnati da una percezione riluttante eppur assolutamente
chiara del fatto che, rappresentando le religioni rivali una
fonte talmente potente di discordia, laddove non possano essere soppresse, esse devono essere tollerate.
Bodin cita la situazione del suo tempo, in cui il consenso
e l’accordo della nobiltà e del popolo verso una nuova religione sono divenuti «così potenti che sarebbe impossibile o per lo meno ben difficile distruggerli senza mettere
a rischio lo Stato». «In questo caso i principi più saggi
hanno preso l’abitudine di fare come quei piloti (timonieri,
n.d.r.] prudenti che si abbandonano alla tempesta sapendo bene che resistere ad essa provocherebbe solo
un naufragio generale». Bodin sottolinea immediatamente quale lezione si deve trarre da questa similitudine:
è necessario riconoscere «tutti i collegi, corpi e comunità
di qualsiasi tipo» che non possono essere eliminati senza
porre in pericolo o distruggere lo Stato. La prima ragione
per accettare questa conclusione è, secondo Bodin,
che, pur avendo il governo il dovere di sostenere l’unità
religiosa, ciò non può alterare il fatto che «la salute e il benessere dello Stato» devono rimanere «la cosa principale
rispettata dalla legge». Dove si scopre che l’ordine è in
conflitto con l’uniformità religiosa, si deve sempre trattare
come suprema priorità il mantenimento dell’ordine.
B La polemica contro i monarcomachi
calvinisti primo sottotitolo
Bodin vide chiaramente come suo principale compito
ideologico quello di attaccare e sconfessare nei Sei libri
la teoria ugonotta della resistenza, che egli era giunto a
considerare il maggior pericolo alla possibilità di restaurare una monarchia ben ordinata in Francia. Questo fine
F.M. Feltri, Chiaroscuro – Nuova edizione © SEI, 2012
fondamentale emerge molto chiaramente nelle prefazioni programmatiche aggiunte alle edizioni successive
della sua grande opera. Bodin esterna il suo estremo orrore perché vede «i sudditi armarsi contro i principi»,
scritti sediziosi [che incitano alla rivolta armata, n.d.r.]
«pubblicarsi come fiaccole per l’incendio degli Stati» e il
popolo «con lo spettro della tirannide ribellarsi al potere
di quei re che sono dati alla stirpe umana per divino consiglio». Ripetutamente Bodin indica che è sua intenzione
rispondere a questi «uomini pericolosi», i quali con il pretesto della libertà popolare «eccitano i sudditi alla ribellione contro i loro prìncipi naturali, aprendo la porta a
quella anarchia ch’è peggio di qualsiasi tirannide del
mondo, sia [perfino della, n.d.r.] la più aspra». La risposta di Bodin ai rivoluzionari ugonotti è diretta e inflessibile:
nessun atto pubblico di resistenza di un suddito contro
il legittimo sovrano può essere mai giustificato. […]
L’attacco di Bodin alla teoria e alla pratica della rivoluzione ugonotta ci porta al cuore delle dottrine positive
enunciate nei Sei libri in quanto ci conduce alla discussione
della sovranità, considerata da Bodin «il punto principale e
più necessario per la comprensione della natura di uno
Stato». Se un governante non è «sovrano in assoluto», «è
senza alcun dubbio lecito» da parte dei suoi sudditi resistergli e «procedere contro il tiranno per via di giustizia». Ma
dovendo essere il fine fondamentale del governo quello di
assicurare non già la libertà, bensì l’«ordine», qualsiasi atto
di resistenza di un suddito contro il suo governante va completamente bandito nel nome della conservazione della fragile struttura dello Stato. Bodin è quindi tratto dalla logica
del proprio impegno ideologico a sostenere che in qualsiasi
società politica vi deve essere un sovrano assoluto, nel
senso che egli comanda ma non è mai comandato, e
quindi non può essere mai legittimamente contrastato da
nessuno dei suoi sudditi. Tale conclusione è enunciata per
esteso nel Libro I, Capitolo VIII, intitolato Della sovranità. Bodin inizia definendo la sovranità come «quel potere perpetuo e assoluto che è proprio dello Stato». Fa poi capire chiaramente che nel caratterizzare il sovrano come «assoluto»,
egli ha in mente soprattutto una cosa: perfino quando le
sue ordinanze non sono mai «eque ed oneste», «al suddito
non è lecito contravvenire alle leggi del suo principe» o opporsi in altri modi «col pretesto dell’onestà e della giustizia».
In breve, il sovrano è per definizione esente dalla resistenza armata, poiché «sovrano è chi non riconosce nulla
superiore a sé all’infuori di Dio». Sono così state già completamente gettate le fondamenta per la successiva creazione del «grande Leviatano», visto [dal filosofo inglese
Thomas Hobbes, che pubblicò la sua opera principale, Leviathan, nel 1651, n.d.r.] come «Dio mortale», a cui «sotto
il Dio immortale dobbiamo la pace e la difesa».
Q. SKINNER, Le origini del pensiero politico moderno, II. L’età
della Riforma, il Mulino, Bologna 1989, pp. 363-364, 409-413
Tra mantenimento dell’ordine e uniformità religiosa, qual
è la priorità per Bodin?
Come si deve porre il suddito nei confronti di ordinanze
sovrane che non sono «eque ed oneste»?