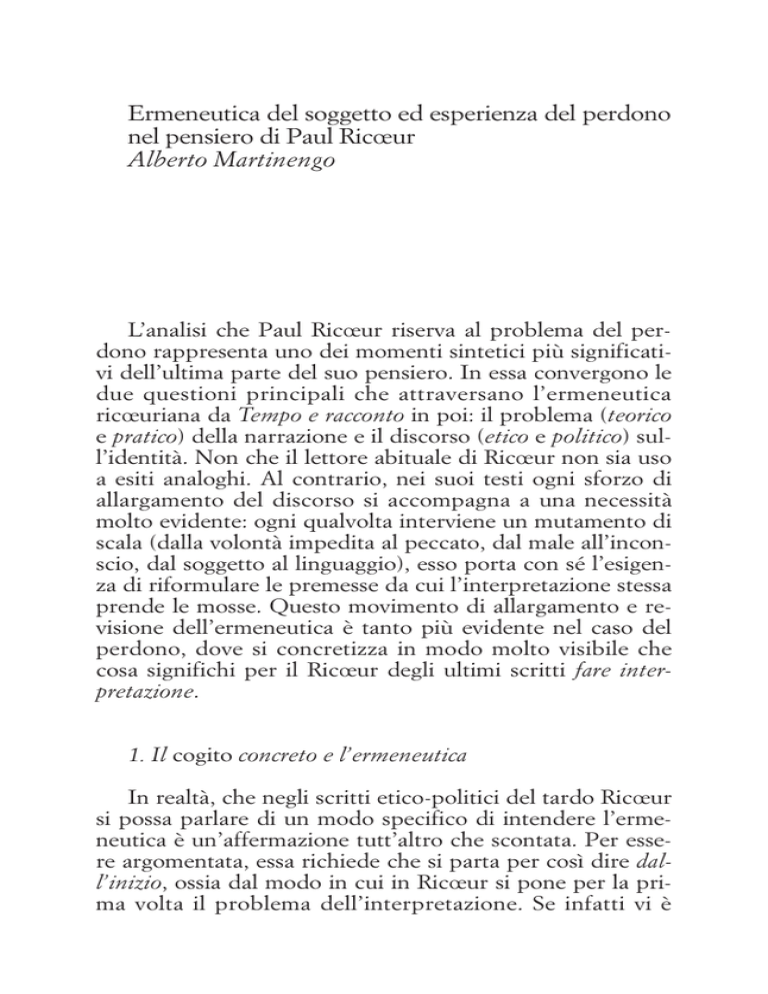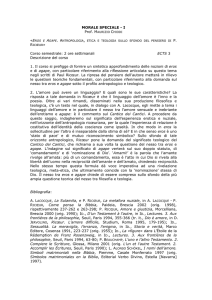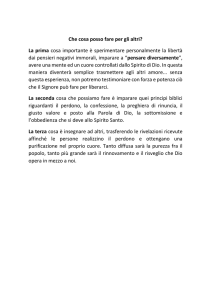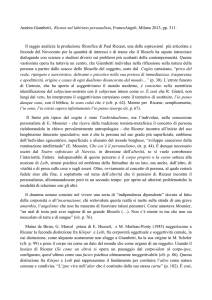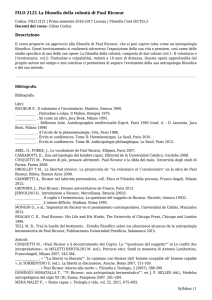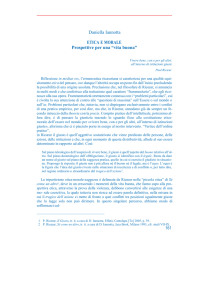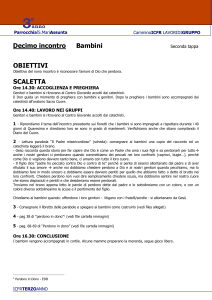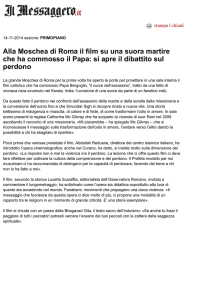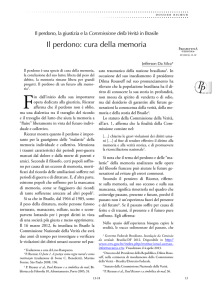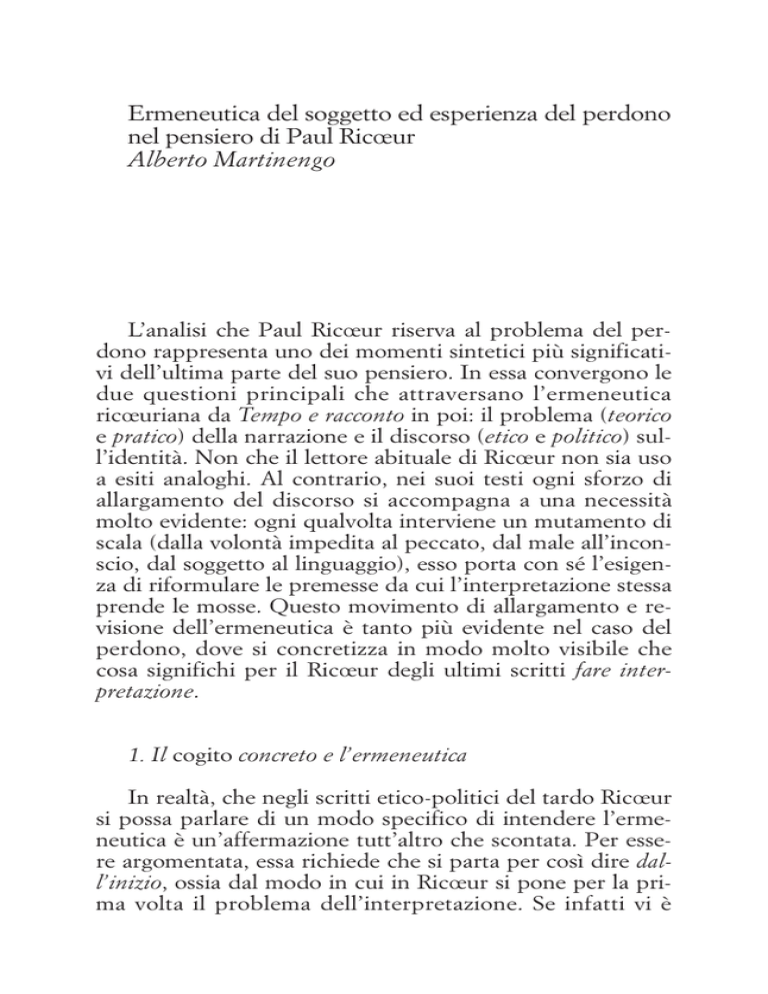
Ermeneutica del soggetto ed esperienza del perdono
nel pensiero di Paul Ricœur
Alberto Martinengo
L’analisi che Paul Ricœur riserva al problema del perdono rappresenta uno dei momenti sintetici più significativi dell’ultima parte del suo pensiero. In essa convergono le
due questioni principali che attraversano l’ermeneutica
ricœuriana da Tempo e racconto in poi: il problema (teorico
e pratico) della narrazione e il discorso (etico e politico) sull’identità. Non che il lettore abituale di Ricœur non sia uso
a esiti analoghi. Al contrario, nei suoi testi ogni sforzo di
allargamento del discorso si accompagna a una necessità
molto evidente: ogni qualvolta interviene un mutamento di
scala (dalla volontà impedita al peccato, dal male all’inconscio, dal soggetto al linguaggio), esso porta con sé l’esigenza di riformulare le premesse da cui l’interpretazione stessa
prende le mosse. Questo movimento di allargamento e revisione dell’ermeneutica è tanto più evidente nel caso del
perdono, dove si concretizza in modo molto visibile che
cosa significhi per il Ricœur degli ultimi scritti fare interpretazione.
1. Il cogito concreto e l’ermeneutica
In realtà, che negli scritti etico-politici del tardo Ricœur
si possa parlare di un modo specifico di intendere l’ermeneutica è un’affermazione tutt’altro che scontata. Per essere argomentata, essa richiede che si parta per così dire dall’inizio, ossia dal modo in cui in Ricœur si pone per la prima volta il problema dell’interpretazione. Se infatti vi è
ALBERTO MARTINENGO
una costante nell’evoluzione del pensiero ricœuriano, essa
va cercata nella scelta di ridefinire a ogni passo le condizioni sotto le quali il problema ermeneutico si pone in concreto. Soltanto alla luce di quest’evoluzione si chiarisce il valore aggiunto che la discussione sul perdono apporta all’intero sistema.
Del resto, in Ricœur il tema della concretezza dell’interpretazione è centrale fin dai testi in cui il problema ermeneutico si pone per la prima volta. Già Il volontario e l’involontario (1950), il testo fenomenologico per eccellenza
nella produzione ricœuriana, contiene importanti indicazioni in questo senso. Il volontario e l’involontario è la prima parte di quel progetto inconcluso della Filosofia della
volontà, con cui Ricœur si proponeva di estendere la fenomenologia husserliana. Ma in realtà esso si muove già all’interno di un chiaro presupposto pre-ermeneutico: il soggetto volente si rappresenta sempre come relazione con un
mondo di significati che di fatto lo precede. Ciò è particolarmente chiaro nell’analisi che Ricœur riserva alla decisione, ossia alla realtà in cui si gioca la partita tra volontà e necessità. Il problema dell’involontario si traduce nell’idea
che ogni azione (in quanto mia) sia determinata “da tutto
un ordine reale di eventi che le offrono un punto di applicazione, cioè da un insieme di interdizioni e di occasioni,
di ostacoli e di vie praticabili” (Ricœur 1950, p. 57). Quest’ordine reale, che è la presenza stessa dell’uomo nel mondo, implica che la libertà sia sempre connessa alla necessità, ossia a un processo di adeguamento dei possibili progettati ai possibili previsti. Tale adeguamento è il nucleo di
ciò che Ricœur chiama consentimento. Da esso discende
tutta la fenomenologia del corpo, che ha il suo centro nella
nozione di motivazione: qui il problema sta principalmente
nel radicamento dei motivi dell’agire all’interno della struttura corpo e nella necessità di ripensare la libertà a partire
dalla coappartenenza volontà-corpo. E proprio la decisione, che è la struttura dalla quale i motivi prendono significato, è il punto di inserzione che trasforma il volere astratto in sforzo concreto.
ERMENEUTICA DEL SOGGETTO...
Al tema della passività e al passaggio che essa impone in
direzione dell’ermeneutica sono dedicati esplicitamente i
due volumi di Finitudine e colpa (1960). In questo caso, il
problema cui Ricœur risponde è la netta separazione (teorizzata nel Volontario e l’involontario) tra l’eidetica della volontà e il suo corrispettivo storico-esemplare: là dove il primo episodio della Filosofia della volontà astraeva dal modo
in cui la volontà si rapporta al soggetto finito, qui si tratta di
togliere le parentesi in cui è stato messo il concreto, recuperandolo attraverso il problema del male, che della dimensione storica del soggetto costituisce il paradigma. Lo scopo
dell’Uomo fallibile, il primo volume di Finitudine e colpa, è
il rinvenimento di questo “‘luogo’ umano del male”
(Ricœur 1960, I, p. 57), ossia il punto in cui esso si inserisce
nella realtà umana. Il problema del male rappresenta dunque l’esempio critico del rapporto tra l’eidetica e l’empirica:
rispetto al male e alla colpa bisogna poter dimostrare a un
tempo la connessione con le strutture della volontà e la loro
relativa contingenza. In questo senso, per Ricœur si tratta di
argomentare che il male dipende sì dalla dialettica di attività e passività in cui è implicata la coscienza, ma che questa
dipendenza è semplicemente una forma tipica della dialettica stessa e non la sua determinazione necessaria. Nella
sproporzione ontologica, nella non-corrispondenza con se
stesso che caratterizza l’umano, la finitezza non è tout court
la radice della colpa: l’involontario assoluto, che è il dato ultimo della tensione tra attivo e passivo, tra finito e infinito,
è un principio di fragilità e non il male in sé. Il problema
del “luogo” umano del male corrisponde dunque alla ricerca di una mediazione tra la finitude e la culpabilité: un livello
intermedio tra il dato strutturale (la dialettica di volontario
e involontario) e il divenire storico-concreto (la colpa).
L’uomo fallibile individua tale nucleo al livello di un’evidenza strutturale che nell’uomo raccoglie lo scarto (sproporzionato, non commensurabile) tra il finito e l’infinito. Questo
medium è ciò che propriamente si definisce fallibilità.
La fallibilità è dunque una pre-esposizione al male, dalla quale discende la “debolezza costituzionale” che rende
ALBERTO MARTINENGO
possibile il male stesso (cfr. Ricœur 1960, I, p. 58). Che
però nell’Uomo fallibile sia in gioco un problema di mediazione è chiaro anche in un altro senso, che rappresenta il
nucleo meno ovvio dell’analisi di Ricœur: in modo a prima
vista inaspettato, l’antropologia della sproporzione diventa
anche una teoria della conoscenza e del significato. La sproporzione pratica tra volontario e involontario corrisponde
infatti – almeno nelle intenzioni di Ricœur – alla sproporzione che caratterizza l’ambito conoscitivo, tra il senso e la
prospettiva. In altri termini, Ricœur immagina che vi sia
una sorta di “nucleo di tutte le variazioni e di tutti gli sviluppi” (Ricœur 1960, I, p. 143) che definiscono l’umano; e
questo nucleo consiste nell’incapacità di adeguare il mondo dei significati alle prospettive da cui essi si aprono. Tuttavia questa funzione di mediazione – ed è il punto interessante del discorso di Ricœur – è qualcosa di più che una
vaga Stimmung esistenziale: essa ha a che fare direttamente
con la capacità di produrre significati. La medietà dell’umano non è dunque assunta nel senso di una scala ontologica, all’interno della quale si colloca l’esistenza. Essa è anzitutto una funzione di sintesi, che coinvolge i diversi livelli
del mondo:
L’uomo è intermediario non perché sta tra l’angelo e la bestia,
è intermediario perché è misto, ed è misto perché opera delle
mediazioni. La sua caratteristica ontologica di essere-intermediario consiste precisamente nel fatto che il suo atto di esistere
è l’atto stesso di operare mediazioni tra tutte le modalità e tutti
i livelli della realtà al di fuori di lui e in lui stesso (Ricœur
1960, I, p. 71; il corsivo è mio).
L’esistenza si dà essa stessa come un’attività sintetica; e
le sintesi sono ciò che organizza il mondo in “tutte le modalità e tutti i livelli” che lo caratterizzano. Prima di essere
una determinazione creaturale (come la fallibilità, appunto), la mediazione è dunque la matrice delle strutture che
costituiscono l’esistenza in rapporto col mondo, l’esistenza
in quanto significato.
ERMENEUTICA DEL SOGGETTO...
Qui il tono della discussione di Ricœur è ampiamente
kantiano. Tuttavia vi è in positivo un processo di universalizzazione del fatto della mediazione, che non ne fa una
funzione esistenziale tra le altre, ma la più fondamentale
di tutte. Il che – si può dire a riprova – rende il discorso
sulla fallibilità meno un’interpretazione del male che una
teoria dei significati. Si tratta però di capire come ciò accada in concreto. A essere centrale in questo senso è la nozione di immaginazione trascendentale. A partire dal discorso sulla sproporzione, la sintesi trascendentale dell’immaginazione diventa il principio unificante non semplicemente del sapere, ma dell’esistenza stessa – nella misura in
cui questa è al mondo sotto il doppio registro dell’attività
e della ricettività. Da questo punto di vista, è come se la
sensibilità e l’intelletto fossero metafora della fallibilità
stessa; o viceversa, la fallibilità una metafora della nonadeguazione di sensibilità e intelletto, in uno scambio tra
originario e derivato che non è facile districare (né peraltro è interessante farlo, dacché l’obiettivo dell’Uomo fallibile è raccogliere in modo indifferenziato tutto l’umano
sotto la categoria del fallibile).
La discussione attorno alla sintesi trascendentale va tutto sommato da sé, muovendo dalla nozione di ricettività e
associandole il tema della corporeità. Ma l’aspetto davvero
rilevante sta nel fatto che la questione del significato, che
qui emerge in una teoria del senso di stampo fenomenologico (il significato come trascendenza della percezione), risulta connessa con il discorso ermeneutico sulla sproporzione. Tuttavia, che questa teoria del significato sia davvero
il nucleo dell’analitica del finito – e che l’ontologia del fallibile sia essa stessa una teoria del senso – costituisce ancora
un passaggio in più. Ed è il passaggio rappresentato dal secondo volume di Finitudine e colpa, La simbolica del male.
Qui il problema è direttamente la colpa nella sua dimensione storico-concreta, ossia la realtà umana del male nel quale la fallibilità si attualizza1. Quest’attualizzazione include
un presupposto fondamentale dell’analisi: la colpa non si
dà mai direttamente, come una determinazione da descri-
ALBERTO MARTINENGO
vere, ma soltanto attraverso l’istituzione di un mondo di significati. È questo il senso della mitica concreta di cui parla
Ricœur: è connaturato al passaggio dall’innocenza alla colpa di darsi soltanto attraverso un universo significante – e
significante in modo simbolico. Ciò dimostra quanto si diceva in precedenza: l’esistenza, proprio in quanto è determinata in senso paradigmatico dalla finitezza e dalla fallibilità,
è aperta oltre che alla colpa, alla produzione di mediazioni e
significati. Si può dirlo ancora più categoricamente: l’esistenza è matrice di significati (simbolici) nella misura in cui
è anche produttrice di mediazioni.
Questo è il senso più proprio del passaggio che Finitudine e colpa compie dalla fenomenologia all’ermeneutica:
l’ermeneutica subentra al metodo fenomenologico-descrittivo in quanto tutta la dialettica del volontario e dell’involontario sfocia in un ambito totalmente condizionato dal
simbolo. A questo livello, l’ermeneutica è il metodo che
consente di decifrare concrezioni di senso complesse, che
non si risolvono al livello letterale: in esse la lettera fa segno verso un altro livello (simbolico), contribuendo a svelarlo2. Almeno in questa fase, dunque, per Ricœur l’ermeneutica è un lavoro di decifrazione, che si collega alla mitica concreta con l’obiettivo di fornirne una versione iuxta
propria principia. Al versante storico della fallibilità corrisponde infatti un particolare universo del discorso, che
può essere connotato come linguaggio della confessione; ma
“comprendere il linguaggio della confessione – conclude
Ricœur (1960, I, p. 57) – significa affrontare un’esegesi del
simbolo che esige talune regole di decodificazione, vale a
dire un’ermeneutica”.
È da questi presupposti che prende avvio quella che
Ricœur a più riprese definisce la via lunga dell’interpretazione, ossia il metodo che considera i contenuti esistenzialmente significativi come il punto d’arrivo di un percorso più articolato, che si origina nel mondo dei segni. Da qui deriva la
vasta rassegna di simboli interpretati, che occupa gran parte
del testo e che produce una vera e propria archeologia della
coscienza colpevole. Ma il punto critico dell’analisi non è
ERMENEUTICA DEL SOGGETTO...
tanto l’interpretazione delle figure che pertengono al tema
dell’impuro (il simbolismo della macchia, la purificazione,
l’oscillazione tra il fisico e l’etico…), al peccato (il Patto, il
comandamento, la collera di Dio…), alla colpevolezza (colpa
e colpevolezza, individuo e comunità, imputazione penale e
giustificazione…) e alla caduta (nei miti cosmologici, orfici,
tragici e adamitici). Il vero nucleo della questione sta nel
modo in cui l’interpretazione simbolica entra in relazione
con la filosofia. Questo spostamento dall’eidetico al mediato
non è affatto una determinazione occasionale, legata alla
specificità del tema del volontario: l’ermeneutica del simbolo diventa la premessa per una ridefinizione del compito
stesso della filosofia. Nella Simbolica del male c’è insomma la
prima intenzione di ciò che, dalla Metafora viva (Ricœur
1975a) in avanti, si potrà definire il passaggio dal regionale
all’ontologico, quel trasferimento di determinazioni da una
disciplina specifica – in questo caso la filosofia del religioso
– all’ambito generale della filosofia. Al livello della Simbolica
si tratta ancora di una questione circoscritta, che si raccoglie
sotto la nota tesi secondo cui “il simbolo dà a pensare” (cfr.
Ricœur 1960, II, pp. 623-634). In questa prospettiva, il simbolo non è più soltanto l’ambito cui si applica un metodo
capace di pensarne i significati: esso diventa ciò a partire da
cui si origina la possibilità stessa della filosofia; e si tratta di
una possibilità che si dà per via mediata, dacché il mythos (e
il simbolo che lo genera) è per eccellenza un discorso – un
logos, dice Ricœur – aperto alla riflessione3.
Per comprendere con esattezza che cosa l’interpretato
(il simbolo) importi sull’interpretante (la filosofia) è centrale proprio la nozione di mediazione. Il simbolo è il venire
al linguaggio di un’esperienza, in particolare l’esperienza
della colpevolezza:
Ciò che è vissuto come impurità, come peccato, come colpevolezza esige la mediazione di un linguaggio specifico: il linguaggio dei simboli. Senza l’ausilio di questo linguaggio l’esperienza rimarrebbe muta, oscura, chiusa sulle sue contraddizioni implicite (…) (p. 419).
ALBERTO MARTINENGO
La confessione, nel senso dell’universo di discorso tipico della fallibilità, è parola ed è per eccellenza (nella Simbolica del male) parola significante. Se dunque vi è qualcosa che il simbolo dà da pensare alla filosofia è questo: la
funzione del significato intesa di per sé come mediazione,
come una traduzione linguistica che esorbita dal livello
della descrizione (di essenze, di dati di fatto o di evidenze
della coscienza).
2. Narrazione, identità, perdono
Il linguaggio simbolico (ma lo stesso potrà dirsi per gli
altri livelli semantici: il mito, la metafora, il discorso narrativo in generale) rappresenta dunque un modello fondamentale di costruzione del significato. Esso ha nell’esistenza concretamente intesa la propria origine: il simbolo è ciò
che, più e meglio del linguaggio descrittivo, raccoglie e articola i significati esistenzialmente rilevanti. Tuttavia resta
ancora da capire di che cosa esattamente si dia un intrigo,
sia esso simbolico, mitico o narrativo. È a questo problema
che Ricœur risponde nelle fasi più recenti del suo pensiero,
in particolare a partire dai tre volumi di Tempo e racconto
(Ricœur 1983-85), che completano la sua teoria generale
dell’interpretazione.
2.1. Il soggetto tra continuità e discontinuità
In effetti, in Tempo e racconto Ricœur porta a chiarezza
un elemento assolutamente centrale per la questione: se il
problema del linguaggio simbolico è mettere in significati
(cioè mediare) contenuti di per sé opachi, impenetrabili alla
dizione diretta, questo vasto insieme di determinazioni ha
una struttura comune? O, al contrario, dal punto di vista
formale il simbolo possiede una struttura che varia a seconda dell’ambito di discorso cui si rivolge (il peccato, la realtà
pulsionale, il religioso…)? La tesi fondamentale di Tempo e
racconto è che tutte le competenze referenziali del linguaggio non-descrittivo, a partire dalla più generale (la narrazio-
ERMENEUTICA DEL SOGGETTO...
ne), siano accomunate dal fatto di essere la trascrizione di
un’unica esperienza fondamentale: l’esperienza della temporalità. In altri termini, ciò che tiene assieme realtà esistenziali differenti, come quelle racchiuse nel simbolo, nel mito
o nella metafora, è il dato più ovvio ed evidente dell’esperienza umana, ovvero la sua dimensione temporale. È il tempo, considerato come il tessuto dell’esperienza e come la sua
condizione di orizzonte, a impedire di ridurre i linguaggi
non-descrittivi al paradigma descrittivo.
Ricœur arriva a questa conclusione attraverso un percorso piuttosto articolato. Tempo e racconto parte infatti dalla
considerazione secondo cui il linguaggio narrativo sa rispondere all’enigma del tempo (l’agostiniano “Quid est
enim tempus?”) meglio di quanto abbia dimostrato di fare
la filosofia: non è mai stato possibile produrre qualcosa come una filosofia del tempo, nemmeno nelle versioni accurate
dell’analisi fenomenologica; al contrario esistono molti
esempi di racconto del tempo, cioè svariati modelli razionali
di messa in intrigo che sono in grado di fornire un criterio
d’ordine (e dunque di dicibilità) dell’esperienza temporale.
Questo è a grandi linee il punto di partenza di Tempo e racconto. In realtà il prosieguo dell’analisi dimostra qualcosa di
alquanto diverso: non soltanto il registro del filosofico non
viene del tutto abbandonato, ma anzi è il narrativo stesso a
essere dichiarato insufficiente allo scopo. La rilettura filosofica della funzione narrativa – dacché di questo si tratta, e
non di un salto extra-metodico al di là della filosofia – non
fa che confermare la stessa impasse in cui incorreva il discorso speculativo: il tempo effettivamente messo in intrigo,
anche nella forma debole dell’intrigo narrativo, non esaurisce il tutto dell’esperienza. Ogni discorso sull’esperienza
(sia esso filosofico, simbolico o narrativo) è sì la costruzione
di una forma possibile della temporalità; ma ciò non satura
affatto la totalità del fenomeno, che dunque risulta più resistente rispetto a qualsiasi formalizzazione logica4.
È a questo livello che nella Memoria, la storia, l’oblio
(Ricœur 2000), in perfetta continuità con i presupposti di
Tempo e racconto, entra in gioco il problema della memoria.
ALBERTO MARTINENGO
La memoria è per Ricœur il dispositivo che denuncia meglio di qualsiasi altro l’impossibilità di ridurre l’esperienza
del tempo a puro significato: è considerando i modi in cui il
passato si iscrive e si archivia nel soggetto che si comprende
in che senso il tempo resti definitivamente inadeguabile al
mondo dei significati. Questa rilevazione – al di là del fatto
che si tratti di un dato perfettamente intuitivo – è una questione fenomenologica piuttosto insidiosa, che Ricœur prova a dirimere (in chiave teorica e storico-filosofica) nella
prima delle tre parti de La memoria, la storia, l’oblio. Tuttavia anche qui il discorso non si esaurisce al livello fenomenologico; o meglio è soltanto a un altro livello – quello ermeneutico – che se ne può comprendere la complessità.
Nella versione che ne dà Ricœur, l’ermeneutica della
memoria muove infatti dall’aporia che sta al centro di ogni
discorso sul passato: da una parte, come dicono il senso
comune e la fenomenologia, la memoria non può essere mai
una rappresentazione totale del passato, dacché il suo funzionamento è inscindibile dall’oblio; dall’altra però, come
vuole l’ermeneutica, alla memoria si è soliti attribuire una
funzione fondamentale rispetto all’esistenza – quella di essere il fattore fondamentale della costruzione identitaria. In
altri termini, posto che una delle determinazioni fondamentali dell’ermeneutica sia il superamento della nozione
sostantiva di soggettività, questa revisione viene fatta alla
luce di una rilettura narrativo-memoriale dell’identità: il
soggetto, non affermandosi più come il fondamento inconcusso della verità (Cartesio), viene recuperato a partire dall’idea di continuità temporale. Ma è proprio qui che si addensa, secondo Ricœur, il maggior numero dei problemi:
se infatti la memoria non è – né può essere – la trascrizione
totale dell’esperienza temporale, che ne è della stessa soggettività? Posto che la memoria sia necessariamente discontinua, come è possibile che su tale discontinuità si costruisca una identità narrativa?
Naturalmente l’aporia della continuità/discontinuità
del tempo, che oppone a un dato fenomenologico inoppugnabile (la parzialità della memoria) un dato ermeneutico
ERMENEUTICA DEL SOGGETTO...
altrettanto potente (l’esistenza di forme narrative di identità), non ha soltanto una valenza individuale. Essa si ripete in modo analogo ogni volta in cui vi sia una soggettività
(personale, plurale o collettiva) che si autodesigna come
tale. È qui che il discorso si fa particolarmente pregnante
rispetto al tema del perdono; per Ricœur, infatti, il perdono non può che essere uno dei dispositivi fondamentali
che presiedono alla costruzione dell’identità collettiva5.
Come si arrivi a una considerazione del genere è abbastanza evidente, almeno in prima istanza. Al livello dell’identità collettiva entrano in gioco infatti, in maniera macroscopica, due elementi fondamentali: in primo luogo l’idea
che la memoria abbia sempre una portata pubblica e condivisa, ossia costituisca un fattore essenziale per la scrittura della storia; ma in secondo luogo l’intuizione secondo
cui una memoria pubblica così concepita ha sempre a che
fare con l’uso ragionato dell’oblio. Da questo punto di vista, la costruzione della memoria collettiva è sempre un atto pubblico di selezione del passato, nel quale si corregge
(per approssimazioni successive) il confine tra ciò che deve essere ricordato e ciò che si può dimenticare. Qui
Ricœur ha senz’altro in mente ciò che Benjamin aveva figurato dicendo che la storia è discorso scritto dai vincitori. Alla base della produzione condivisa del passato vi è insomma un presupposto epistemologico fondamentale: la
scrittura della storia è il primo atto pubblico attraverso il
quale il vincitore legittima la propria autoaffermazione sui
vinti; ma questa autoaffermazione coincide sempre con il
ricorso a una specifica disciplina dell’oblio. Non che l’insieme di questi usi sia completamente unilaterale, dacché
richiede – e lo si vedrà – il riconoscimento di coloro contro cui si afferma; e tuttavia in esso è quanto mai urgente
la necessità, per la memoria, di parzializzare i contenuti da
tramandare. È in questo quadro che entrano in gioco tutti
i fenomeni di attestazione pubblica dell’oblio che ricadono, per esempio, sotto le nozioni di grazia e di amnistia: la
grazia e l’amnistia rappresentano le due fattispecie di costruzione dell’identità pubblica (diremmo: di costruzione
ALBERTO MARTINENGO
del legame sociale), in cui emerge più chiaramente l’uso
combinato della memoria e dell’oblio.
In realtà, che le cose stiano in questi termini rispetto alla storia non significa che il problema del perdono sia già
risolto. Al contrario, per Ricœur, attraverso gli istituti della
grazia e dell’amnistia, che pure fanno parte di una normale
amministrazione dell’oblio, si resta ancora molto lontani da
una vera attestazione di ciò che il perdono è realmente. Resta dunque da capire che cosa sia il perdono per Ricœur e
quale sia il problema cui si cerca di rispondere per suo tramite. Ancora una volta la questione è tutta legata al modo
in cui si sceglie di intendere la soggettività, in particolare la
sua capacità di gestione dei significati. Da questo punto di
vista, il perdono non è che uno dei modi fondamentali attraverso cui il soggetto costruisce una regione di significati
(i significati facenti capo agli atti imputabili): esso non è
che una delle risposte possibili all’enigma pratico della colpa, in particolare alla colpa come debito gravante sulla coscienza pratica dell’imputato6.
Ma naturalmente, anche posta in questi termini, la questione del perdono non è del tutto esente da problemi. Anzi, è proprio qui che il discorso di Ricœur inizia a entrare
nel vivo. L’esperienza stessa della colpa richiede infatti, al
pari di tutti gli altri simboli, un vero e proprio supplemento di pensiero: la culpabilité è un insieme di significati che
ha a che fare con la struttura dell’uomo capace (ossia del
soggetto pratico) – e come tale deve essere interpretata.
Sotto queste premesse, ciò che della colpa interessa è la sua
determinazione come datità imputabile, il suo essere l’affare di un soggetto responsabile. Qui entra in gioco quello
che Ricœur connota come il primo polo dell’aporia del
perdono. Se infatti, attraverso l’imputazione, la colpa ha a
che fare direttamente con il soggetto, essendo ciò che più
propriamente lo lega alle sue azioni, allora la questione del
perdono è strettamente connessa con la possibilità di continuare a denotare il soggetto come tale: strappare totalmente la colpevolezza all’esistenza equivarrebbe infatti a
distruggere da cima a fondo l’esistenza stessa. Eppure, an-
ERMENEUTICA DEL SOGGETTO...
che di fronte a questa contraddizione, che almeno a livello
teorico sembra insolubile, vi è – e forte – un Faktum: nell’esistenza dell’uomo si dà pur tuttavia un’esperienza forte
del perdono; nonostante ciò che dice il modello teorico
dell’imputazione, l’atto del perdonare appare come parte
costitutiva dell’esperienza umana. Che questo Faktum sia
in qualche misura reale è ciò che testimoniano, ancora una
volta, i simboli dell’umano: la tradizione cui apparteniamo
(ma lo stesso si potrebbe dire per tutte le altre tradizioni
concretamente articolabili) ci consegna in innumerevoli
forme il simbolismo del perdono; e ce lo consegna –
Ricœur si riferisce in primis alla tradizione biblica – nel
senso di un’esperienza estrema e incondizionata.
2.2. Il perdono come forma del riconoscimento
La questione filosofica del perdono prende dunque
corpo all’interno di questa polarità: se c’è il perdono come
inno, come rappresentazione simbolica di un atto incondizionato e gratuito, c’è anche il perdono per noi, per le nostre relazioni individuali e collettive? O forse si dovrà dire
che il perdono sia il caso – invero singolare – di un simbolo che non rappresenta una realtà esistenziale e dunque, in
fin dei conti, non dice il vero? La risposta di Ricœur procede per gradi, partendo nuovamente dalla dimensione
pubblica-condivisa del problema. È qui che la questione
appare a prima vista fuori luogo: le grandi istituzioni pubbliche, in particolare gli organismi giuridici, sembrano
non assegnare alcun ruolo positivo a esso. L’ordinamento
giuridico si regge infatti su una relazione di corrispondenza nella quale non vi è spazio (né può esservene) per il
perdono: il circolo accusa-punizione. Da questo punto di
vista, tanto nelle fattispecie comuni, quanto di fronte al
grande crimine, il diritto nasce dalla sospensione di un altro circolo: quello dell’offesa e della vendetta. In altri termini, il funzionamento della giustizia si basa sull’idea che
il processo, il dibattimento e i diversi gradi del giudizio
siano istituti volti a due obiettivi in particolare: in primo
luogo la sostituzione della violenza con il discorso, ossia la
ALBERTO MARTINENGO
sospensione dell’escalation delittuosa attraverso il ricorso
alla dialettica tra le parti; in secondo luogo, la ricerca di
un racconto coerente dei fatti, ossia la configurazione di
un passato il più possibile condiviso dai soggetti coinvolti.
L’uno e l’altro dispositivo costituiscono, almeno formalmente, il principio di avvicendamento tra la vendetta e la
punizione, avvicendamento nel quale tutto sembra essere
all’opera, tranne che un atto di perdono.
In effetti le cose stanno così: il perdono non appartiene, né di diritto né di fatto, alla famiglia delle istituzioni
giuridiche. E tuttavia il discorso per Ricœur non si chiude
ancora qui. L’obiettivo fondamentale dell’azione giuridica
non si esaurisce con l’istituzione del registro della punizione. O meglio, quest’instaurazione ha a che fare con un livello ulteriore del problema, che non è del tutto estraneo
al sistema del perdono: sullo sfondo dell’azione giuridica
vi è infatti l’esigenza di costruire uno specifico regime del
discorso, di attivare una particolare capacità narrativa; ma
quest’obiettivo ha a che fare, e non secondariamente, con
la necessità di una reciproca apertura di credito tra le parti,
su una relazione fondamentale di riconoscimento. In prima
istanza, il processo è un dispositivo di mutuo riconoscimento, almeno nella forma minimale della reciproca attestazione di esistenza: io esisto – tu esisti. Ed è soltanto su
questa prima relazione che si può compiere il passo successivo, ossia la definizione pubblica delle responsabilità,
la designazione dei posti rispettivi dell’aggressore e della
vittima: io esisto come colpevole – tu esisti come innocente,
e viceversa.
L’istituzione del diritto tiene dunque in sé due determinazioni non immediatamente sovrapponibili: da una parte
il circolo unilaterale dell’accusa e della punizione, per il
quale la vittima (o chi per lei) accusa il colpevole e ne chiede la punizione; e dall’altra un particolare “regime dello
scambio”, il cui punto di arrivo è il riconoscimento (possibilmente reciproco) di una vittima e di un colpevole. È
questo secondo aspetto che consente di fare un passo al di
là del problema della giustizia. Il processo è infatti l’attri-
ERMENEUTICA DEL SOGGETTO...
buzione alla vittima e al colpevole di due distinte capacità
di narrazione, che il dibattimento deve in qualche modo
dirimere; ma questo contesto, nel quale due atti di discorso
potenzialmente conflittuali vengono messi faccia a faccia,
non può essere in alcun modo riportato all’universo del
giuridico. Il problema del perdono prende le mosse esattamente da qui, configurando due soluzioni diametralmente
opposte: da una parte l’interpretazione non-condizionale
del perdono, che Ricœur rimanda sostanzialmente a Jacques Derrida (non vi è perdono se non unilaterale; non vi è
perdono se non come atto impossibile); e dall’altra l’idea
della condizionalità del perdono, posta in modo radicale
da Vladimir Jankélévitch rispetto all’Olocausto (“Forse
qualcuno ci ha chiesto perdono?”). Di fronte a questa divaricazione, la tesi di Ricœur è che si debba unificare la
questione sotto un unico modello. Il che può avvenire soltanto a partire da un particolare regime dello scambio: quello che ruota attorno alla nozione di dono.
Anche la questione del dono, come quella che fa capo al
perdono – e per altri versi alla giustizia – ha a che fare con
una sostanziale indecidibilità. La tesi più suggestiva e definitoria vuole che il dono sia un atto integralmente unilaterale, pena la ricaduta nel meccanismo dello scambio commerciale. Ma d’altra parte proprio questa unilateralità – come
dimostra Marcel Mauss – può rappresentare il fattore di
una nuova reciprocità, in virtù della quale la restituzione
stessa appare in qualche modo indotta. Una volta che la
questione del dono venga posta in questi termini, il meccanismo del perdono sembra minarne interamente la struttura, ripetendo la tensione assoluta tra gratuità e obbligatorietà. Tuttavia l’indecidibilità del dono dipende dal fatto
che esso viene interpretato non come un semplice scambio,
ma come uno scambio commerciale. Tutte le obiezioni all’economia del dono – qui la guida di Ricœur è ancora Mauss
– presuppongono l’esistenza di un interesse celato dietro alla generosità dell’offerta: proprio questa presupposizione (e
solo essa) trasforma il dono in una possibile offesa del donatario, riparabile soltanto ristabilendo una simmetria per-
ALBERTO MARTINENGO
fetta tra donare e rendere. Ma si tratta – Ricœur lo dice chiaramente – di una presupposizione sbagliata. Il vero scambio
implicato dal dono non è quello tra il donare e il rendere,
come vorrebbe la logica commerciale; l’unica vera richiesta
che il dono fa – e la risposta non è affatto ovvia – è di essere
accettato. Il dono autentico non chiede il contraccambio,
ma semplicemente l’accettazione: donare significa rendere
giuridicamente libero l’altro, che se accetta l’oggetto donato si fa libero di ripetere l’atto in senso inverso. È in questo scambio tra donare e (saper) ricevere che entra in gioco il riconoscimento, aprendo l’analogia con la giustizia.
Ciò cui la reciprocità del donare e del ricevere mette fine
non è il disequilibrio del prendere senza dare nulla in
cambio, bensì quella che Ricœur chiama la dissimmetria del
dono senza spirito di ritorno; ed è questa reciprocità che fa
capo al riconoscimento. Di fatto il donante non si aspetta
che il suo atto sia ricambiato – questo può essere vero, ma a
un livello successivo della relazione. Ciò che egli si aspetta è
anzitutto che il dono sia accettato e che sulla base di questo
riconoscimento sia possibile iniziare una relazione.
Se la questione del dono sta in questi termini, l’accostamento al perdono diventa del tutto conseguente. Anche rispetto all’atto del perdonare – scrive Ricœur – si associano
una determinata credenza teoretica e una particolare convinzione pratica: secondo l’una il perdono è un atto integralmente gratuito e immotivato, mentre per l’altra esiste
una correlazione inscindibile tra il perdono richiesto e il
perdono accordato. Il modo per fare stare assieme le due
credenze è fornito proprio dal paradigma del dono. L’idea
è che la confessione della colpa e la concessione del perdono entrino sì in una connessione necessaria, ma che ciò avvenga secondo la forma dello scambio non commerciale:
soltanto questo modello consente di comprendere l’articolazione (assieme condizionale e incondizionale) tipica dell’atto di perdono. Da questo punto di vista, è vero che la
richiesta di perdono è la premessa maggiore della sua concessione; ma tale premessa si apre anzitutto alla possibilità
del rifiuto. Chiedere perdono significa acquisire lo status di
ERMENEUTICA DEL SOGGETTO...
colui che si prepara a un possibile rifiuto; e ciò garantisce
che la sua concessione sia una risposta alla richiesta formulata, ma una risposta interamente libera (e liberata) attraverso la prospettiva del rifiuto.
Soltanto in questa prospettiva la dialettica tra richiesta e
risposta può mettere capo a una relazione. Il rapporto tra richiesta e concessione (nel caso in cui la vittima disponga in
tal senso, dacché altrimenti la relazione abortirebbe) richiede
infatti un’ulteriore risposta, che parte nuovamente dal colpevole: come nel meccanismo del dono, al perdono concesso
corrisponde la capacità di riceverlo da parte di chi ne beneficia; e questa ricezione è già il principio di una nuova relazione. La prospettiva del perdono apre dunque un doppio scambio, che tiene assieme la richiesta con la concessione e la concessione con la ricezione. In che cosa consista esattamente
questo scambio Ricœur lo dice con chiarezza quando parla
della struttura interna al perdono: la dialettica dello slegare e
del legare. Di fatto, l’atto del perdono consiste nell’istituzione
di un rapporto duplice tra i contraenti: la vittima slega il colpevole dall’insieme delle azioni che questi ha compiuto, alleggerendolo delle responsabilità che inevitabilmente gravano su di lui; ma al tempo stesso, sulla base di questo scioglimento, la vittima introduce una nuova responsabilità, che si
volge al futuro del colpevole anziché al suo passato. In altri
termini, perdonare ed essere perdonati significa saper replicare in maniera responsabile ai vincoli temporali cui è sottoposta la continuità dell’azione: il colpevole riconosce che le
azioni a lui imputate appartengono effettivamente alla continuità temporale che lo costituisce; e tuttavia accetta di declinare al futuro, anziché al passato, questa continuità. Ciò che
è implicato nel perdono è dunque uno spostamento di prospettiva: chi ha offeso accetta di impegnarsi di fronte alla vittima – e di farlo nel senso di non ripetere più il passato. Al
perdono autentico corrisponde sempre una contropartita,
che si concretizza nella capacità da parte del colpevole di tenere fede a una promessa: il reo non soltanto non viene sciolto dalla sua responsabilità, ma ne assume una doppia che si
volge non più al passato ma al futuro.
ALBERTO MARTINENGO
La dialettica di perdono e promessa diventa così una
replica responsabile alle intermittenze che scaturiscono
dalla volontà: essa assume in toto la complessità che caratterizza gli atti umani (la compresenza di motivi e cause, la
simultaneità del volontario e dell’involontario, l’imponderabilità delle conseguenze…), scegliendo di declinarne al
futuro le implicazioni. L’evento del perdono ha la capacità
di mettere a nudo il fenomeno del debito, ossia di denunciare la dipendenza del qui-e-ora da una catena di scelte
non revocabili; ma al tempo stesso tenta di staccare l’agente dal suo atto passato, rendendolo capace di ricominciare.
Da questo punto di vista – argomenta La memoria, la storia, l’oblio – è vero ciò che Derrida dice rispetto al soggetto del perdono: perdonare significa rivolgersi a un soggetto che è altro rispetto a colui che aveva compiuto l’offesa;
tuttavia proprio dalla possibilità che il responsabile diventi un soggetto altro rispetto al sé colpevole il perdono trae il
suo significato. Sotto il segno della remissione della colpa,
il responsabile viene ritenuto capace di qualcosa di diverso rispetto ai suoi delitti. Il perdono è l’attestazione reciproca che dice al colpevole: “Tu vali molto di più delle tue
azioni”. Ma questa capacità di ricominciare è al tempo
stesso morale e teoretica, giacché libera sì il presente dell’azione dal peso della colpa, ma assieme libera la costruzione di una memoria autenticamente comune. Che poi la
memoria liberamente condivisa tra soggetti (e di questo si
tratta: per Ricœur il perdono resta una questione relazionale, e non politica) sia necessariamente parziale cessa di
essere uno scandalo. Al contrario, essa diventa a tutti gli
effetti una chance: la costruzione del passato include inevitabilmente l’opzione della perdita, ossia l’ammissione che
nel conto dei significati condivisi qualcosa necessariamente non torna.
1
Sul male umano come passaggio dalla potenza all’atto, cfr. per esempio
Ricœur 1960, II, p. 247.
ERMENEUTICA DEL SOGGETTO...
2
Sulla criteriologia del simbolo, cfr. in particolare Ricœur 1960, II, pp.
254-264. Che la relazione col simbolo implichi una sospensione delle determinazioni descrittive, a vantaggio di una referenza di altro genere, sarà chiaro
quando nel Saggio su Freud (1965) Ricœur parlerà di una “struttura intenzionale che non consiste nel rapporto del senso con la cosa, ma in un’architettura del senso, in un rapporto del senso con il senso, del senso secondario con
quello primario” (Ricœur 1965, p. 30). Il simbolo è per eccellenza una struttura intenzionale ma non descrittiva.
3
Sul rapporto simbolo-filosofia e sull’idea di una “‘ripetizione’ filosofica della confessione”, cfr. in particolare Ricœur 1960, II, pp. 264-265, 623634.
4
Sull’irriducibilità del tempo a qualsiasi supporto logico, compreso il
racconto, cfr. in particolare Ricœur 1983-85, III, pp. 369-413.
5
Seppur tacitamente, l’aporia della memoria sta alla base dell’analisi di
Sé come un altro (Ricœur 1990a), in cui lo stesso problema viene affrontato
però sul versante dell’identità personale.
6
La colpa è sì una questione di iscrizione/ascrizione delle azioni a un
soggetto, ma è anzitutto un’ipoteca posta alla sua capacità di agire. Proprio a
quest’ipoteca il perdono si propone di rispondere.