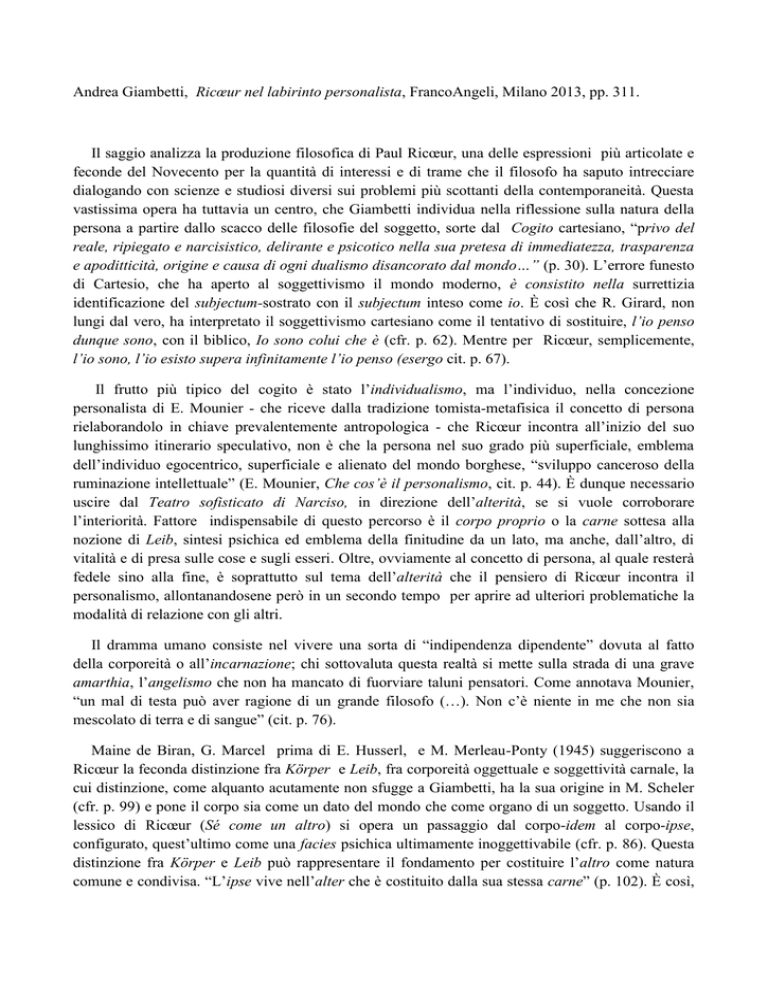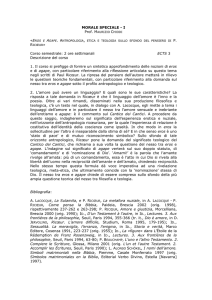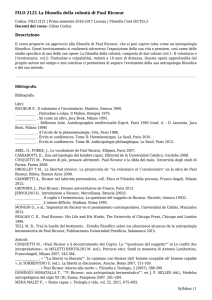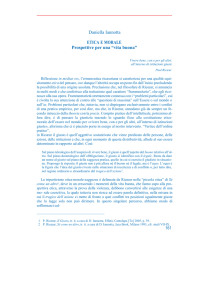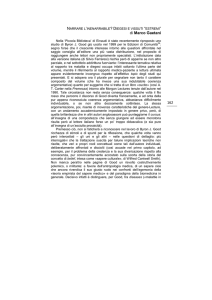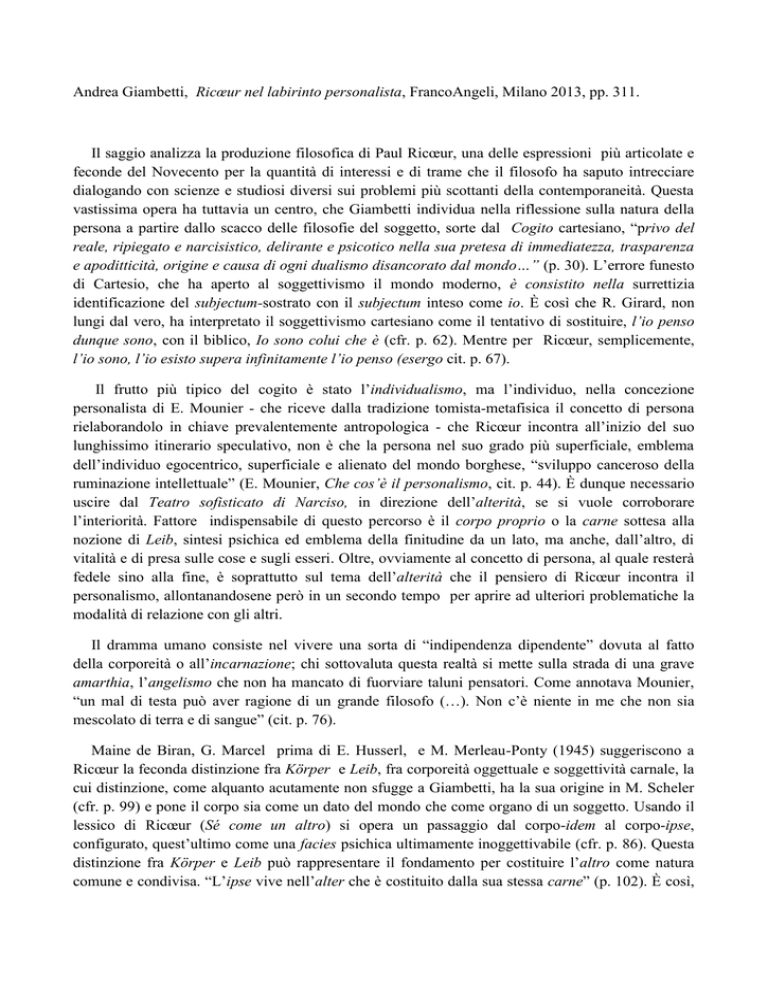
Andrea Giambetti, Ricœur nel labirinto personalista, FrancoAngeli, Milano 2013, pp. 311.
Il saggio analizza la produzione filosofica di Paul Ricœur, una delle espressioni più articolate e
feconde del Novecento per la quantità di interessi e di trame che il filosofo ha saputo intrecciare
dialogando con scienze e studiosi diversi sui problemi più scottanti della contemporaneità. Questa
vastissima opera ha tuttavia un centro, che Giambetti individua nella riflessione sulla natura della
persona a partire dallo scacco delle filosofie del soggetto, sorte dal Cogito cartesiano, “privo del
reale, ripiegato e narcisistico, delirante e psicotico nella sua pretesa di immediatezza, trasparenza
e apoditticità, origine e causa di ogni dualismo disancorato dal mondo…” (p. 30). L’errore funesto
di Cartesio, che ha aperto al soggettivismo il mondo moderno, è consistito nella surrettizia
identificazione del subjectum-sostrato con il subjectum inteso come io. È così che R. Girard, non
lungi dal vero, ha interpretato il soggettivismo cartesiano come il tentativo di sostituire, l’io penso
dunque sono, con il biblico, Io sono colui che è (cfr. p. 62). Mentre per Ricœur, semplicemente,
l’io sono, l’io esisto supera infinitamente l’io penso (esergo cit. p. 67).
Il frutto più tipico del cogito è stato l’individualismo, ma l’individuo, nella concezione
personalista di E. Mounier - che riceve dalla tradizione tomista-metafisica il concetto di persona
rielaborandolo in chiave prevalentemente antropologica - che Ricœur incontra all’inizio del suo
lunghissimo itinerario speculativo, non è che la persona nel suo grado più superficiale, emblema
dell’individuo egocentrico, superficiale e alienato del mondo borghese, “sviluppo canceroso della
ruminazione intellettuale” (E. Mounier, Che cos’è il personalismo, cit. p. 44). È dunque necessario
uscire dal Teatro sofisticato di Narciso, in direzione dell’alterità, se si vuole corroborare
l’interiorità. Fattore indispensabile di questo percorso è il corpo proprio o la carne sottesa alla
nozione di Leib, sintesi psichica ed emblema della finitudine da un lato, ma anche, dall’altro, di
vitalità e di presa sulle cose e sugli esseri. Oltre, ovviamente al concetto di persona, al quale resterà
fedele sino alla fine, è soprattutto sul tema dell’alterità che il pensiero di Ricœur incontra il
personalismo, allontanandosene però in un secondo tempo per aprire ad ulteriori problematiche la
modalità di relazione con gli altri.
Il dramma umano consiste nel vivere una sorta di “indipendenza dipendente” dovuta al fatto
della corporeità o all’incarnazione; chi sottovaluta questa realtà si mette sulla strada di una grave
amarthia, l’angelismo che non ha mancato di fuorviare taluni pensatori. Come annotava Mounier,
“un mal di testa può aver ragione di un grande filosofo (…). Non c’è niente in me che non sia
mescolato di terra e di sangue” (cit. p. 76).
Maine de Biran, G. Marcel prima di E. Husserl, e M. Merleau-Ponty (1945) suggeriscono a
Ricœur la feconda distinzione fra Körper e Leib, fra corporeità oggettuale e soggettività carnale, la
cui distinzione, come alquanto acutamente non sfugge a Giambetti, ha la sua origine in M. Scheler
(cfr. p. 99) e pone il corpo sia come un dato del mondo che come organo di un soggetto. Usando il
lessico di Ricœur (Sé come un altro) si opera un passaggio dal corpo-idem al corpo-ipse,
configurato, quest’ultimo come una facies psichica ultimamente inoggettivabile (cfr. p. 86). Questa
distinzione fra Körper e Leib può rappresentare il fondamento per costituire l’altro come natura
comune e condivisa. “L’ipse vive nell’alter che è costituito dalla sua stessa carne” (p. 102). È così,
come suggerisce Giambetti, che Ricœur potrebbe ri-tradurre Leib con Chair, tanto in Husserl
quanto in Heidegger, traendo dal rimosso occidentale la cruciale nozione di carne (cfr. p. 105).
Su queste basi Ricœur può indicare tre strutture cardine della vita etica: “stima di sé”,
“sollecitudine per l’altro” e “istituzioni giuste”. Senza reciprocità - Anerkennen - Riconoscimento
hegeliano – per Ricœur, “l’alterità non sarebbe quella di un altro da sé, ma l’espressione di una
distanza indiscernibile dall’assenza”. Pertanto la morale può costituirsi integralmente non solo sulla
nozione dell’Altro mio simile, ma anche sulle esigenze di quei terzi rimasti esclusi dall’amore;
terzo è quell’altro che non è prossimo, il lontano, lo straniero (cit. pp.168-169).
Ricostruendo i fondamenti della speculazione personalista-mounieriana, si palesano due
direttrici, quella dell’”emergenza” o della trascendenza, e quella della “immergenza” o
dell’incorporazione. Si può, grazie a Giambetti, misurare qui, ad esempio, la distanza fra un
Mounier e un Sartre, sulla base del principio posto dal personalista, in base al quale, la persona “non
apprende se stessa se non situata e comunicata” e che “gli altri (les autres... Enfer) non limitano la
persona, anzi le permettono di essere e di svilupparsi”, anche perché la prima esperienza della
persona è quella della seconda persona, il tu viene prima dell’io (cfr. pp. 119-120). L’alterità è
costitutiva della stessa ipseità e, mentre il corpo-proprio è il percepito, la carne è l’origine della
percezione anche del corpo-proprio. Questa Leiblichkeit (consistenza carnale) di un ente, fonda il
legame con gli altri esseri viventi (cfr. pp. 106-107). A partire da questa consapevolezza del ruolo
del Mitsein (essere-con… altri), come ci indica Giambetti, Ricœur matura in contrasto (il più forte,
ritiene l’Autore) con Mounier, una nuova coscienza destinata a trarre dal limbo la relazione io-tu
per condurla nel medio istituzionale, ovvero nel seno della terzietà istituzionale, certamente neutra,
ma strutturante e proteggente la relazione intersoggettiva, il vis à vis, il faccia a faccia. Sono dunque
le istituzioni del vivere associato, istituti familiari, giuridici, economici, sociali e politici che
rendono possibili i legami interpersonali, anche quelli di natura più intima. “Perciò anche se solo
una piccola parte dei rapporti umani può essere personalizzata, non se ne deduce che la rimanente e
preponderante parte sia destinata all’anonimato dell’impersonal” (cfr. pp. 186-188).
Molto suggestiva e sottile risulta poi l’analisi del tragico e dell’atteggiamento di fronte alla morte
maturato da Ricœur in continuo dialogo con filosofi e teologi che hanno sondato quell’ultimo e
arduo segmento della vita. A tal propostio Landsberg ci pare faccia eco allo spinoziano, sentimus
experimurque nos aeternos esse, quando sostiene che “anche l’angoscia della morte rimarrebbe
incomprensibile, se la struttura fondamentale del nostro essere non contenesse il postulato
esistenziale di un aldilà, non come istinto biologico da Wille zum Leben schopenhaueriano, ma
come conato della persona a realizzarsi ed eternizzarsi spiritualmente, (cfr. p. 253) non solo a livello
individuale, ma degli stessi rapporti interpersonali, per cui in Ricœur il religioso fondamentale è
dato dal valicare il confine della comune mortalità, sulla base della consapevolezza che la
sopravvivenza sono gli altri (cit. p. 255).
Un filosofo come Ricœur che ha lungamente vissuto entro tutto l’arco del XX secolo e oltre la
soglia del XXI, sperimentandone sulla propria pelle tutti gli orrori, compresa la perdita del figlio
Olivier per suicidio, come apprendiamo dal documentatissimo Giambetti, potrebbe ergersi a pieno
titolo quale Giobbe contemporaneo, ovvero di testimone, il quale partito provvisto di una robusta
fede, giunge dopo tante tragedie, sulla soglia della morte travalicando i limiti del religioso
confessionale anche attraverso una lotta contro l’immaginario del post mortem, ossia soprattutto
dell’interiorizzazione di questa prima del suo avvento. Ricœur insegna infatti come la morte
(Ultima latet ripete pure E. Lévinas) porti a trascendere la barriera fra le religioni, in quanto il
morire è trans-culturale, esso è trans-confessionale, trans-religioso (cfr. p. 245).
Nell’ultima parte del suo saggio Giambetti, e qui ci si accorge di quanto appropriate siano le
parole di A. Danese nella Prefazione circa la completezza delle fonti da lui esaminate, forse
memore del detto aristotelico che una vita si può giudicare solo una volta giunti al suo compimento,
si china con grande perizia teologica sullo stato del lucignolo fumigante di Ricœur, che come
apprendista teologo (in effetti ogni convinto calvinista lo è) precede il filosofo di professione (cfr. p.
258). Vicenda, quella del filosofo francese, emblematica e forse anche diffusa per mille circostanze,
non ultima quella della demitizzazione operata dalla critica a spese dei cristianesimi storici. Nozioni
teologiche quali sacrificio, giudizio, colpa, inferno, etc. che hanno attraversato i secoli plasmando la
Cristianità, si sono sbriciolate nel crogiolo dell’esegesi, dell’ermeneutica e della modernità
scientifica in genere (Giambetti, fornito di sconfinata erudizione, cita i più illustri operai del grande
cantiere della demitizzazione da R. Bultmann agli archeologi Finkelstein e Silberman). Ma
nemmeno Xavier Léon-Dufour e René Girard, mettendo in discussione il paradigma sacrificale che
procedeva dalla Epistola agli Ebrei, e si era guadagnato un’enorme spazio soprattutto a partire dal
XVI secolo, non hanno reso più agevole l’actus credendi, anche se, con loro, è stata resa maggior
giustizia ai Vangeli e, non da ultimo, hanno consentito di cogliere, come l’Autore non manca di
fare, quanto la logica ricœuriana della morte intesa come un abbandonarsi all’altro, lasciando la
presa della proprio vita offerta all’altro che ci sopravviverà, sia del tutto ascrivibile ad una retta
Imitatio Christi (cfr. p. 265). Fra i pensatori che si sono cimentati su questa via, Giambetti cita
Simone Weil, per la quale l’umiltà totale è il consenso alla morte, che fa di noi un nulla inerte.
Questa Gelassenheit, già nota alla grande mistica occidentale, non è esattamente, come si è visto più
sopra, congeniale a Ricœur il quale avendo accettato le sfide poste dalla filosofia, ne ha assunto i
rischi e, come molti suoi compagni, ha terminato il viaggio, con la consapevolezza che – come
diceva d. Mazzolari – perdersi è il solo guadagno, ma senza certezze circa la sua antica fede
cristiana. Giambetti si chiede se “l’apprendista teologo sia caduto sotto i colpi esiziali del filosofo di
professione”. Indubbiamente due assoluti si contendono - sempre più - la mente e il cuore: quello
personale dell’adesione alla pistis tramandata e ricevuta e quello professionale della speculazione
filosofica che assume come metodo l’agnosticismo, da qui, come già in G. Marcel antico maestro e
amico, il rifiuto del facile epiteto di “filosofo cristiano”, meglio forse, la veemenza quasi
nietzschiana di un’affermazione filosofica tout court (cfr. pp. 275-276 n.130).
Marco Montori