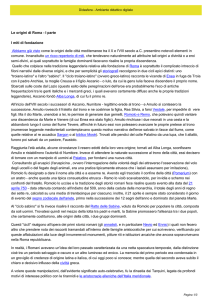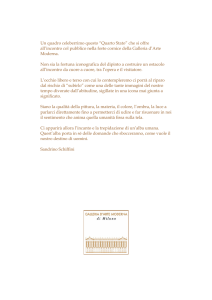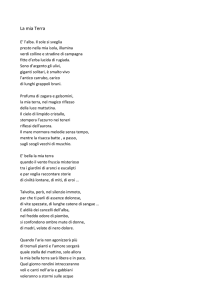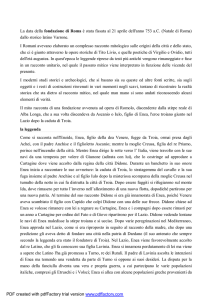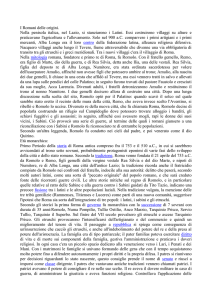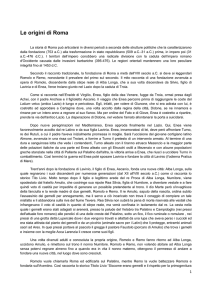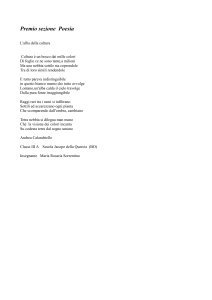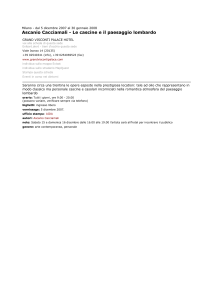IO ROMA
Storia e Tradizione
Donatella Cerulli
IL FUOCO DEGLI DEI: LA PRIMA ROMA
Ascanio
La leggenda narra che dopo la scomparsa di Enea regnò sui Latini il giovane
Ascanio il quale, però, non era gradito al popolo che avrebbe preferito vedere sul
trono un diretto discendente di Latino. Per questo motivo Lavinia, che era in
attesa di un figlio di Enea, temendo che Ascanio potesse sbarazzarsi con un
infanticidio del legittimo erede al trono, si rifugiò nella foresta dove diede alla
luce un bambino che chiamò Silvio (da “selva”, foresta).
La nascita del piccolo accrebbe l’ostilità dei Latini verso il figlio maggiore di Enea
che fu così costretto, trent’anni dopo la fondazione di Lavinio, a lasciare la città e
a fondare una sua città, che chiamò Alba Longa, nel luogo dove suo padre aveva
sacrificato una bianca scrofa1 ed i suoi trenta piccoli, come il dio Tevere aveva
annunciato in sogno ad Enea:
Ecco, perché non pensi che vane forme ti fingano i sogni,
la gran scrofa, trovata, sotto gli elci del lido
giacerà, dato un parto di trenta lattonzoli, bianca,
sdraiata al suolo, bianchi i capezzoli nati.
[questo della città sarà il sito, qui certa la fine dei mali]
Per questo, compiuti tre volte dieci anni, qui Ascanio
Città dal nome glorioso ti fonderà: Alba2.
Nonostante le paure di Lavinia e l’ostilità dei Latini, Ascanio si dimostrò degno
figlio di Enea regnando con saggezza, lungimiranza e, soprattutto, con la purezza
nel cuore; infatti, morto senza figli, Ascanio nominò Silvio suo erede al trono di
Alba Longa.
In un passo dell’Eneide, variamente interpretato, Virgilio chiama Silvio “postuma
prole” e alcuni studiosi propendono per una particolare versione: quando
nacque Silvio, Enea era ancora in vita; “postumo”, dunque, è da intendere come
“ultimo”. Per Livio, invece, Silvio era figlio di Ascanio e in seguito il nome Silvio
rimase un appellativo di tutti i re che regnarono ad Alba.
Virgilio chiama Ascanio spesso anche Julo (piccolo Jupiter) e questo nome faceva
vantare la famiglia romana degli Julii di discendere da Enea e, di conseguenza, di
essere di origine divina.
Il nome Iulo deriverebbe dal gr. iobolos, “abile nello scagliare dardi”, oppure dal
gr. ioulos, “dalla barba incipiente”. Virgilio, nell’Eneide, fa dire a Giove: «Ma il
piccolo Ascanio, che adesso anche Iulo è detto (e fu Ilo, fin che Ilio ebbe regno)...»
suggerendo così che il nome Iulo deriverebbe da Ilo, il nome della rocca di Troia.
Per Virgilio, infatti, Ascanio-Iulo è figlio di Enea e di Creusa: nipote di Priamo da
parte di madre e nipote di Venere attraverso suo padre.
Tito Livio, invece, racconta che dal matrimonio di Enea con Lavinia «nacque
anche un figlio maschio cui i genitori diedero il nome di Ascanio»; però dice anche:
«Non starò a discutere - chi infatti potrebbe dare per certo un fatto così antico? se sia stato proprio questo Ascanio o un altro maggiore di lui, nato dalla madre
Creusa quando Ilio era ancora in piedi e poi compagno del padre nella fuga di là,
quello stesso Iulo dal quale la famiglia Giulia sostiene derivi il proprio nome.
Questo Ascanio, quali che fossero la madre e la patria d’origine, era comunque
figlio di Enea».
Altre versioni, ancora, riferiscono che Ascanio e Iulo erano due personaggi ben
distinti e che Iulo era un sacerdote, figlio di Ascanio, mai citato né nell’Iliade né
nell’Odissea.
Affinché i Romani non dimenticassero mai di chi erano “figli” e - soprattutto - da
chi discendevano gli Iuli, Cesare innalzò un tempio a Venere, madre di Enea,
onorandola come Venus genitrix, Madre Venere.
Alba Longa
Città latina situata nel territorio delle odierne Albano (Albanum) e
Castelgandolfo, fu distrutta dai Romani nel VII sec. a.C., sotto il regno di Tullo
Ostilio, e i suoi abitanti trasferiti a Roma.
«(...) Sul fianco della montagna sorgeva la città di Alba Longa, famosa nella
leggenda virgiliana come città madre di Roma, sebbene il fatto non sia
confermato dall’archeologia.
Se Alba abbia fondato altre città del Lazio, come narrano le leggende, e, se così
stanno le cose, quante, è una questione che rimane egualmente incerta. Ma
merita di essere accettata la notizia che la città sia stata a capo di una sorta di
lega di città latine a partire presso a poco dal decimo secolo a.C. in poi, quando
cominciò ad esercitare il controllo sulla principale via di terra verso il sud. Le
città del Lazio, essendo raggruppate tutt’intorno ad una piana e guardando verso
l’interno della medesima, erano inclini a formare associazioni di questo tipo,
delle quali sembra che ve ne siano state molte; e Alba Longa, situata sui pendii
del sacro Monte Albano, era nella posizione più adatta per assicurarsi la guida di
una di esse.
Ma Alba Longa si trovava ad appena dodici miglia di Roma e, con sovrani
aggressivi sul trono romano, uno scontro era inevitabile. Infatti, avvenne, e
Roma vinse. La leggenda attribuisce la vittoria ad un sovrano pre-etrusco della
città, e l’archeologia conferma che già fin dal nono e dall’ottavo secolo a.C.
l’equilibrio della potenza cominciava a subire spostamenti fra Albani e Romani:
ma l’eclisse definitiva di Alba Longa e di altre città del Lazio nord occidentale
può essere considerata come una conseguenza della generale espansione di
Roma avvenuta verso l’epoca di Servio Tullio, cioè durante il sesto secolo.
Non v’è alcun motivo per mettere in dubbio la tradizione secondo la quale, dopo
il confronto decisivo, alcune delle più importanti famiglie di Alba si trasferirono
a Roma dove vennero ammesse nella aristocrazia della città...»3
Secondo la leggenda arcaica, rielaborata più tardi da Tito Livio, durante il regno
del terzo Re di Roma Tullo Ostilio, fra Roma e Alba Longa scoppiò un feroce
conflitto a causa di una serie di razzie compiute dai Romani e dagli Albani nei
rispettivi territori. Entrambe le popolazioni chiesero l’una all’altra un
risarcimento che, ovviamente, rifiutarono entrambe. La guerra fu dunque
inevitabile e - per parità di forze ed armi - sembrava non avere mai fine. Così, le
due città decisero di affidare l’esito della guerra ad un duello fra i campioni delle
opposte fazioni: i tre gemelli romani Orazi e i tre gemelli albani Curiazi.
Dopo il duello, risolto a favore della piccola compagine romana, poiché
continuano le ostilità da parte degli Albani, Tullo Ostilio invia ad Alba un esercito
al comando di Marco Orazio (il gemello superstite) con l’ordine di distruggere la
città e di deportare i suoi abitanti a Roma dove viene loro riservato il Colle Celio.
Rea Silvia
Sono trascorsi trecento anni da quando Ascanio ha fondato Alba Longa e diversi
re sono succeduti ai figli di Enea.
Il dodicesimo re della dinastia degli Eneidi, Proca, ha due figli maschi ai quali,
poco prima di morire, decide di lasciare in parti uguali il suo regno: la gestione
delle ricchezze e il potere governativo. Il figlio maggiore Numitore, giovane di
animo nobile, sceglie il governo facendo così la felicità del fratello Amulio, avido
ed intrigante.
Amulio, grazie alle ricchezze ereditate, riesce a tessere una subdola rete di
relazioni che gli consentono di imprigionare il fratello e di diventare l’unico re di
Alba Longa. Poi, per salvaguardarsi da qualsiasi tentativo di vendetta e
rivendicazione del trono, uccide il figlio di Numitore ed obbliga la figlia di questi,
Rea Silvia, a consacrarsi alla dea Vesta. Le sacerdotesse di Vesta, infatti, erano
tenute alla castità e questa condizione metteva al sicuro Amulio da qualsiasi
eventuale discendenza da parte di Amulio. Rea, giovane di particolare grazia ed
avvenenza, è però amata dal dio Marte e dà alla luce due gemelli.
Secondo la versione leggendaria più comune, il dio Marte sedusse la
sacerdotessa di Vesta nel bosco sacro in cui la fanciulla si era recata a raccogliere
l’acqua per l’ufficio dei rituali. Ma si raccontava anche che era stata violentata da
Marte durante il sonno. Comunque fossero andate le cose, la nascita dei due
gemelli diede ad Amulio l’opportunità di condannare a morte la giovane
murandola viva in una grotta.
Anche sulla fine di Rea Silvia vi sono diverse versioni: dopo che fu scoperta la
sua colpa fu condannata a morte dallo zio Amulio ma salvata per intercessione di
sua cugina Anto; fu seppellita viva; fu giustiziata seduta stante; fu gettata nel
Tevere.
Altrettanto diverse sono le interpretazioni del suo nome e dei suoi attributi:
Silvia, in quanto diretta discendente di Silvio; Rea, invece, significherebbe la
colpevole, la rea; oppure la voti rea, la “consacrata agli Dei”, in quanto
sacerdotessa. Un’ulteriore ipotesi la identifica con la Madre Terra: Rea, la Terra
Feconda, e Silvia dal latino silva, “selva”4.
Al di là della versione mitologica o dell’interpretazione del suo nome, Rea Silvia
esprime dei punti dominanti, propri di teogonie universali, sia più antiche che
successive: la fecondità in Natura, l’acqua e la verginità, la maternità virginea,
l’atto creativo grazie ad un dio, madre di un uomo destinato a cambiare le sorti
del mondo.
Anche Rea Silvia, dunque, garantisce il rinnovamento di un nuovo ciclo: la
Grande Madre Vergine, la Terra Feconda, per virtù di un dio concepisce ed
emana la realtà, il mondo materiale e dualistico espresso dai due gemelli.
Nel microcosmo come nel macrocosmo: come la Creazione dell’Universo si è
compiuta attraverso vari cicli cosmici, altrettanto avviene per la creazione di
Roma. Un ciclo si è chiuso con la morte di Enea e uno nuovo si apre grazie a Rea
Silvia.
L’originalità italica del mito è indubbiamente dimostrata sia dall’attribuzione
della paternità a Marte (se si fosse trattato di un plagio della tradizione greca il
padre sarebbe stato un altro dio solare, ovvero Apollo), sia perché il frutto
dell’unione non è un figlio unico bensì una coppia gemellare che ben esprime il
principio dualistico dell’autoctono Giano.
Vesta, le Vestali e il Fuoco Sacro di Roma
Vesta è una divinità romana il cui nome è etimologicamente ricollegabile alla
radice sanscrita was, “abitare”; Vesta significa letteralmente “casa”.
La greca Estia e la romana Vesta si corrispondono ma, in questo caso, non si
tratta di un processo di identificazione di una dea romana con una greca: sono
due diverse divinità che esprimono lo stesso concetto. Il carattere originale di
Vesta è confermato dal fatto che il suo animale sacro è l’asino (animale
tipicamente mediterraneo) al contrario del cavallo (sacro ad Estia), animale
indoeuropeo5.
Vesta presiede al fuoco del focolare domestico ed il suo carattere è assai antico,
riconducibile al Neolitico (“età della pietra nuova”, tra il 10.000 e il 5.000 a.C.)
quando in tutta l’Europa le credenze religiose erano basate sul culto della Dea
Madre e il fuoco alimentato dalle donne, in una grotta o in una capanna,
rappresentava il centro sociale, un punto di aggregazione della comunità.
Nei primi anni della Fondazione, probabilmente, l’arcaico focolare di Vesta si
trovava al centro della regia palatina di Romolo in quanto l’ara del fuoco e la
dimora del Re costituivano il centro sociale dell’intera popolazione, il simbolo
vivente, luminoso ed unificante di Roma. Per alcuni studiosi, in quest’epoca
arcaica il fuoco sacro era presieduto da Caca, figlia di Vulcano e sorella del
gigante Caco. Secondo la tradizione il culto di Vesta fu introdotto da Alba Longa a
Roma da Numa Pompilio e sostituì quello più antico tributato a Caca. Sotto il
regno di Numa (VIII-VII sec. a.C.) avvenne anche il trasferimento del centro
politico-religioso di Roma dall’acropoli palatina alla valle del Foro e la
contestuale dislocazione della regia e del sacro fuoco di Vesta. Il tempio, di forma
circolare, aveva in origine le pareti di semplici canne a imitazione delle primitive
abitazioni, le capanne. All’interno del santuario non vi era alcun simulacro della
Dea, ma solo il fuoco sacro custodito da vergini «secondo le leggi patrie dei
latini».
Nel tempio potevano entrare soltanto le Vestali e il Pontefice Massimo6; vi
potevano accedere anche le altre donne solo in occasione delle Vestalia (fra il 9
ed il 15 giugno), purché scalze. In quei giorni si adornavano con fiori le macine
dei mulini e gli asinelli che, inghirlandati anche con serti di piccoli pani, erano
condotti in giro per le vie di Roma. Le famiglie si riunivano in allegri banchetti
davanti al focolare domestico e cibi prelibati venivano inviati al tempio in offerta
alla Dea. I Vestalia si concludevano il 15 giugno con la pulizia e la purificazione
del tempio: le immondizie (purgamina Vestae) venivano buttate nel Tevere e il
tempio lavato con acqua sorgiva. La mattinata di questo giorno era considerato
un dies nefastus (infausto, empio), al punto che alle sacerdotesse era proibito
pettinarsi i capelli, mentre il pomeriggio era fastus (favorevole, di buon augurio)
tanto da essere favorevole ad intraprendere nuove iniziative e a contrarre
matrimoni.
Durante le Vestalia rimaneva aperto il Penus Vestae che Festo7 descrive come
«un luogo interno nell’edificio sacro alla dea, tutto circondato da una zona di terra
fertile». Questo luogo era accessibile solo alla Vestale Massima e in esso erano
conservati, tra l’altro, i Pignora Imperii.
Adiacente al tempio di Vesta sorgeva la Casa delle Vestali, più volte ampliata e
restaurata.
Il collegio delle Vestali fu fondato da Numa Pompilio ed era costituito in
principio solo da due sacerdotesse che in seguito divennero quattro e infine
portate a sei da Servo Tullio, il Sesto Re.
Nei primi tempi della loro istituzione le Vestali erano scelte fra le bambine di età
compresa fra i sei e i dieci anni, sane di corpo e di mente, figlie di genitori viventi
nati liberi e che non avevano mai esercitato umili professioni. In seguito le
sacerdotesse vennero sorteggiate fra venti fanciulle selezionate dal Pontefice
Massimo o anche accettate fra le bambine offerte dagli stessi padri che
trovavano oltremodo onorevole e vantaggioso sul piano sociale diventare
genitori di una Vestale.
Alla neo sacerdotessa venivano tagliati i capelli che poi si lasciavano crescere
nuovamente lunghi. La chioma recisa veniva appesa ad un albero di loto (lotus
capillaris) piantato nel tempio di Giunone Lucina.
Il loro ministero durava trenta anni: dieci come educande, dieci come esercenti e
dieci come docenti. Giunto al termine del trentesimo anno di sacerdozio, le
Vestali potevano ritornare allo stato laico, anche se difficilmente optavano per
un “rientro nel mondo” per via dei privilegi e degli onori di cui godevano.
Appena entrata ufficialmente nel collegio delle Vestali, la sacerdotessa acquisiva
automaticamente i privilegi della sua condizione, non accordati a nessun’altra
donna romana: non era più soggetta alla patria potestà, poteva redigere
testamento anche se bambina e, se il padre era vivo, poteva testimoniare.
Vestiva di bianco, con il capo fasciato da una benda detta infula e quando
sacrificava si copriva il capo con un velo quadrato.
Compito principale delle Vestali era la custodia del fuoco sacro che doveva
essere mantenuto acceso tutto l’anno e riacceso alle calende di marzo con riti
ben precisi. Stando ai racconti degli autori classici, sembra che i rituali ammessi
per tale accensione fossero due: uno, indicato da Plutarco, prescriveva di
riempire un vaso con acqua piovana o di fonte e di far riflettere in essa i raggi del
sole che dovevano poi a loro volta riflettersi su del materiale infiammabile;
l’altro, descritto da Festo, consisteva nel soffregare un legno d’albero fruttifero
sino a far sviluppare la fiamma. Le Vestali avevano anche il compito di preparare
la mola salsa. Con questo nome si indicava sia una miscela di farina di farro,
acqua e sale che veniva cosparsa sugli animali da sacrificare (da cui inmolare,
“immolare”), sia delle focacce di farina di farro che le Vestali preparavano tre
volte l’anno e che venivano usate nei sacrifici incruenti. Poiché il farro (il più
antico cereale coltivato, affiancato dal frumento solo dal V sec. a.C.) rivestì
sempre per i Romani un carattere sacro, le Vestali si occupavano anche di
raccogliere le spighe di farro destinate alla preparazione della mola salsa.
Durante il sacerdozio erano tenute a conservare la verginità ed erano sottoposte
alla tutela del Pontefice Massimo che puniva severamente la Vestale che veniva
meno ai suoi voti o ai suoi doveri. La Vestale che si era resa colpevole di aver
fatto spegnere il fuoco sacro o di aver avuto rapporti sessuali, in epoca albana
veniva uccisa a colpi di verghe, senza mai toccarla con mano; in epoca numaica,
sempre senza toccare la colpevole, veniva gettata nel fiume, lapidata o sepolta
viva; dai Tarquini in poi divenne definitivo il seppellirla viva in un luogo fuori le
mura della città, nel Campo Scellerato nei pressi di Porta Collina. Sia le modalità
di punizione, sia l’interdizione a toccare la Vestale condannata avevano lo scopo
di impedire alla comunità di essere contaminata dalla colpa.
Pignora Imperii
Servio è l’unico autore dell’antichità a rivelare che a Roma erano custoditi nel
tempio di Vesta “Sette cose fatali”, sette fatidici talismani dalla cui conservazione
dipendeva l’esistenza di Roma e dell’Impero.
Secondo quanto ci ha lasciato scritto Servio, essi erano: l’Ago della Madre degli
Dei; le Ceneri di Oreste; lo Scettro di Priamo; il Velo di Ilione; il Palladio; gli
Ancili; la Quadriga di creta dei Veienti.
Dei Sette Pignora Imperii, i primi cinque erano riconducibili al ciclo della mitica
ascendenza troiana vantata da Roma, gli ultimi due alla tradizione italica.
Per i Romani, infatti, i Sette Pignora rappresentavano il segno tangibile della
volontà degli Dei di garantire (pignus ha il significato di pegno, garanzia, ipoteca,
ostaggio, prova, testimonianza) alla stirpe di Enea la promessa di un Impero
Eterno che, come la Fenice, sarebbe rinato a Roma dalle ceneri di Troia.
Questi simulacri non erano sacri di per se stessi, ma in quanto espressioni,
testimonianze materiali e durevoli della volontà propizia degli Dei di garantire a
Roma un Aeternum Imperii.
Con la venuta di Stilicone a Roma (IV secolo d.C.) si perde ogni traccia dei
Pignora. Alcune fonti, scarse e frammentarie, riferiscono però che essi non
andarono perduti, bensì vennero nascosti in luoghi sicuri, custoditi e onorati in
segreto dai primogeniti di alcune famiglie patrizie.
۩
I Divini Gemelli
Appena nati, Amulio sottrae i bambini alla madre e li consegna ad un servo per
farli uccidere, ma l’uomo ne ha pietà e decide di lasciarli in vita: li mette in una
cesta che affida alle acque del Tevere. Poiché il fiume è ingrossato dalla pioggia,
una corrente contraria, invece di trascinarla verso il mare, fa arenare la cesta in
una piccola ansa nell’area del Velabro8, alle pendici del Germalo (altura
settentrionale del Palatino), ai piedi di un fico selvatico che poi i Romani
chiameranno ruminalis ficus9. Sotto quest’albero i Gemelli vengono trovati da
una lupa10 che aveva appena perso i suoi cuccioli e che prende ad allattarli
salvandoli da morte sicura. Anche un picchio verde porta del cibo ai bambini che
riescono così a sopravvivere fino a quando, un giorno, li scorge il pastore
Faustolo11 che li raccoglie, li porta a casa ed affida alle cure di sua moglie Acca
Larentia i Gemelli che «furono chiamati Romolo e Remo in riferimento alla
mammella (...) della lupa» (Plutarco, Vita di Romolo).
I bambini crescono e da subito «Romolo sembra possedere maggiore capacità di
giudizio e un’innata perspicacia politica, mostrando nei rapporti con i confinanti
per il diritto al pascolo e di caccia una naturale predisposizione al comando
piuttosto che alla sottomissione» (Plutarco, Op. cit.).
Remo e Romolo, una volta adulti, vengono inviati a studiare a Gabi12, considerato
in quel tempo il maggior centro culturale del Lazio.
Di certo doveva trattarsi di una ben strana “università”, visto che i due fratelli,
una volta tornati a casa sul Palatino, si danno immediatamente, e con successo,
al proficuo mestiere del brigantaggio in compagnia di altri giovani, altrettanto
scapestrati. «Irrobustitisi nel corpo e nello spirito, non affrontavano solo le fiere,
ma tendevano imboscate ai banditi carichi di bottino. Dividevano il bottino delle
rapine con i pastori e dividevano con loro cose serie e ludiche, mentre cresceva il
numero dei giovani giorno dopo giorno» (Livio, Ab Urbe condita).
Fra una ruberia e l’altra, accade che un giorno Remo e alcuni suoi compagni di
scorribande assalgono le greggi di Amulio che, però, sono ben custodite dai
pastori del re: i ladruncoli vengono catturati ed imprigionati.
Incalzato da questi avvenimenti, Faustolo decide di rivelare a Romolo la verità
sulla sua nascita e lo convince ad andare a liberare il fratello. Romolo l’avrebbe
volentieri lasciato nelle mani di Amulio cogliendo al volo l’occasione propizia
per liberarsi del suo gemello con il quale da tempo non correva buon sangue. Ma
Faustolo insiste e Romolo, al comando di un gruppo di giovani, riesce a
penetrare nella città di Alba Longa, libera Remo e compagni e, detronizzato
Amulio, riconsegna il potere a suo nonno Numitore.
Dopo questi avvenimenti, Remo e Romolo, anziché approfittare di un regno già
bello e pronto che nonno Numitore porge loro su un piatto d’argento, decidono
di fondare una nuova città.
Acca Larentia
Alcuni studiosi fanno derivare il suo nome dal sanscrito okka’, “madre”. Il mito
narra che era la madre dei dodici fratelli Arvali13 che, per questo, venivano
anche chiamati “Fratelli di Romolo”. Venne poi venerata come la dea dei campi e
in suo onore il 23 dicembre si celebravano le Accalia o Larentalia, una festa che
comprendeva dei rituali a carattere funerario tra i quali l’offerta alla Dea di teste
d’aglio, forse in sostituzione degli arcaici sacrifici umani (teste di bambini). I
rituali si svolgevano sulla tomba di Acca Larentia che la tradizione collocava
nell’area del Velabro. Alcuni antichi studiosi, come Plutarco, ma soprattutto
quelli cristiani, sostennero che la lupa che aveva allattato i Gemelli fosse la stessa
Acca Larentia che di mestiere faceva la lupa, ovvero la prostituta. È più probabile
che Acca Larentia fosse una sacerdotessa della Dea Lupa nel cui nome le
sacerdotesse esercitavano la prostituzione sacra, ierodulia, imitando il verso
della lupa. D’altronde anche la Dea della fecondità etrusca Feronia, venerata nel
Lucus Feroniae14 ai piedi del monte Soratte, era una Dea Lupa. Ne rimase nella
Roma antica il termine dispregiativo “lupa” per indicare una prostituta e il
termine “lupanare” per i postriboli. Alcuni studiosi ritengono che la Lupa
Capitolina sia quanto resta di un monumento funebre dedicato alla licantropa
Acca Larentia.
Note
1] Scrofa: era l’animale che di preferenza veniva sacrificato per propiziare la fecondità delle
unioni e dei raccolti della terra. Secondo Varrone, il maiale era offerto alla Madre Terra
affinché premiasse con abbondanti frutti il duro lavoro della coltivazione. Veniva altresì
immolato in occasione dei matrimoni perché fossero benedetti da numerosa prole e, inoltre, si
sacrificava una scrofa per sancire un trattato di pace fra gruppi in tempo in guerra, divenuti
poi, con la resa di uno dei due, un nuovo nucleo, armonico e prolifico di rinnovate generazioni.
La scrofa con i suoi piccoli rappresentava i Latini. In origine i trenta maialini furono
identificati con i trenta popoli che costituivano la Lega Latina sconfitta da Roma nel 338 a.C.
2] Virgilio, Eneide, 8, 42-48
3] M. Grant, Storia di Roma antica, Ed. Newton Compton
4] Dai culti misterici eleusini dedicati a Demetra si evincono tre aspetti riferiti alla Madre
Terra: Gea, la Terra concepita come principio primordiale; Rea, la Terra feconda; Demetra, la
Terra che produce frutti e messi.
5] Indoeuropei: popoli accomunati da una famiglia di lingue parlate da popolazioni comprese
fra l’Europa, l’Asia Minore e l’India, legate da una comunanza di elementi fonetici, morfologici
e lessicali che inducono gli studiosi a ritenere che alla loro origine vi sia una fase di stretta
connessione.
6] Pontefice Massimo: la tradizione attribuisce a Numa Pompilio l’istituzione del collegio
sacerdotale dei Pontefici il cui nome, secondo Varrone, derivava dalla loro funzione di
“costruttori o curatori del ponte” (pontem facere). I Romani appresero dagli Etruschi l’arte di
costruire ponti: un’arte sacra e segreta.
Il collegio dei Pontefici (costituito inizialmente da 6 membri portati in seguito a 16), il cui
capo era il Pontifex Maximus, eletto a vita, aveva il compito di mantenere e di fare osservare le
tradizioni religiose di Roma, di stabilire le pene per le mancanze religiose, di vigilare sul
corretto svolgimento dei riti e dei culti pubblici e privati, di regolare le feste religiose e il
calendario e di redigere gli Annali, ovvero l’elenco ufficiale, redatto in ordine cronologico, di
tutti gli avvenimenti importanti dell’anno.
In origine il Pontefice Massimo era eletto dal Re, durante la Repubblica era designato dai
pontefices, in seguito dal popolo e nel periodo imperiale dal Senato.
Cesare fu il primo “capo di Roma” ad assumere il titolo di Pontifex Maximus, poi imitato da
Augusto e da tutti gli altri imperatori fino a Graziano, imperatore d’Occidente, che abolì titolo
e carica (378). Dal V secolo il titolo di Pontifex Maximus divenne prerogativa della massima
autorità cristiana.
7] Sesto Pompeo Festo: grammatico latino probabilmente del II sec. d.C., autore di un
dizionario enciclopedico in 20 libri, uno per ogni lettera. Il testo originale è andato in gran
parte perduto e ciò che ne è rimasto ci è pervenuto grazie ad un manoscritto dell’XI secolo
che, sebbene a sua volta mutilo e danneggiato, è comunque una preziosa fonte di notizie
linguistiche e antiquarie.
8] Velabro: l’etimologia del toponimo è incerta: Varrone la riferiva a vehere, “trasportare”, o a
velaturam facere, “traghettare”, mentre Plutarco la correlava all’uso di coprire con vele il
percorso del corteo trionfale che comprendeva anche il Velabro. Molto più probabilmente
deriva da velum aureum, ovvero da un velo di sabbia dorata depositata dal Tevere.
Corrisponde alla parte centrale di un tratto pianeggiante compreso tra le pendici del
Campidoglio e dell’Aventino, area dove sorgono attualmente l’Arco di Giano e le chiese di S.
Giorgio al Velabro e di S. Teodoro al Palatino. In questo punto il terreno si abbassava
notevolmente e, a causa delle acque provenienti dal Foro Romano e delle piene del Tevere, per
alcuni mesi dell’anno tutta la zona si trasformava in un’ampia palude. La zona fu bonificata
all’epoca di Tarquinio il Superbo (V sec. a.C.) con la costruzione della Cloaca Massima (“la
fogna più grande”) che iniziava nella valle del Foro e sbucava nel Tevere. Verso la fine del III
secolo a.C., poi, per limitare i danni causati dalle piene del fiume, tutta l’area del Velabro venne
rialzata con un grande terrapieno. Il Velabro era un quartiere a carattere commerciale e
industriale, attraversato da due strade molto importanti, il vicus Tuscus e il vicus Iugarius, che
lo collegavano con il Foro.
9] Fico Ruminale: varie etimologie, come ruma, “mammella” o Rumon, un arcaico nome del
Tevere. Per Varrone il nome sarebbe dovuto alla vicinanza di questa pianta ad un antico
tempio dedicato a Rumina, una divinità che proteggeva i neonati. Riveste un ruolo da
protagonista nel mito dei Gemelli per una sua caratteristica: secerne un fluido lattiginoso dalle alte
proprietà nutritive che per le arcaiche popolazioni pastorali ne faceva un albero della nutrizione.
Era, infatti, un sostituto del latte materno, il primo cibo dei bambini dopo lo svezzamento.
L’appellativo Ruminalis deriva proprio da questo aspetto.
I Romani credevano che finché questo fico fosse vissuto, la grandezza di Roma non sarebbe
mai declinata. Una leggenda narrava che, per un intervento divino operato dall’augure Atto
Navio, il fico sarebbe stato poi trasportato al centro del Foro dove sarebbe vissuto per 830
anni.
L’elenco delle divinità e dei rituali connessi al fico è lungo, ma è costante il suo simbolismo di
sapienza divina e non: Adamo ed Eva, scoprendosi nudi, si vestono di foglie di fico; Gesù lo
maledice riferendosi al sapere che esso rappresenta; Giuda, in alcune rappresentazioni, pende
impiccato da un albero di fico; Mithra, nato nudo, si ripara fra i rami di un fico, si nutre dei
suoi frutti e si riveste con le sue foglie; Buddha medita per sette anni e ottiene l’illuminazione
sotto un fico...
10] Lupa: il simbolismo del lupo ha un duplice aspetto, benefico e feroce. Poiché vede nel buio
è un animale solare. Al contrario, la forza e la ferocia che mostra in combattimento ne fanno
un’allegoria della guerra. Entrambe queste caratteristiche lo rendono l’animale per eccellenza
sacro a Marte, dio solare e guerriero. Il lupo è l’animale simbolo di Roma, il capostipite
comune a tutti i gruppi etnici che concorsero alla formazione e urbanizzazione della Città. In
quest’ottica sembra vada interpretato il famoso gruppo statuario della Lupa Capitolina che
rappresenta sì la lupa che allatta i due Gemelli ma anche l’unione di due popoli, i Sabini e i
Romani, in un nuovo nucleo sociale: i Quiriti. Ancora oggi il simbolismo del lupo-lupa è molto
vivo e presente a Roma, raffigurata un po’ dappertutto, dai gagliardetti sportivi a ornamento
di palazzi e fontanelle. Fino ai primi anni della seconda metà del secolo scorso, una sparuta
lupa in carne ed ossa si aggirava depressa fra le sbarre di una angusta gabbia posta a fianco
della scalinata che porta al Campidoglio. Nello stesso posto era collocata anche un’altra gabbia
dove era rinchiusa un’aquila, altrettanto sparuta e depressa. Poi Marte deve aver illuminato la
giunta capitolina e gabbie, lupa ed aquila sono state definitivamente rimosse.
11] Faustolo: restò ucciso durante la contesa fra Remo e Romolo e fu sepolto nel Foro,
secondo la tradizione sotto il lapis niger. Il suo nome, come quello di Fauno, si ricollega alla
radice del verbo faveo, “essere favorevole”. Sembra che in epoca classica sul Palatino ancora
esistesse la capanna di Faustolo, tugurius Faustoli, onorata come un luogo sacro.
12] Gabi: antica città del Lazio, fondata probabilmente da Alba Longa. Oggi dell’antica città
(individuata su una collina a lato del km 20 della via Prenestina) restano solo pochi avanzi del
Foro e degli edifici adiacenti fra cui alcuni templi, il più importante dei quali è quello di
Giunone.
13] Arvali: secondo la tradizione, il Collegio dei Fratres Arvales, “Fratelli del campo seminato”
(arvum, “campo coltivato”), fu istituito da Romolo ed era composto da 12 membri scelti fra gli
esponenti delle famiglie patrizie. Rimanevano in carica a vita e quando uno di loro moriva, il
sostituto veniva nominato dai Fratres in carica. La loro origine arcaica è testimoniata dal
carmen che intonavano durante le cerimonie e che costituisce uno dei testi più antichi in
lingua latina. Nella seconda metà del mese di maggio gli Arvali officiavano una cerimonia di
purificazione dei campi, Ambarvalia, che consisteva nel percorrere a passo di danza il
perimetro degli arva allo scopo di propiziare i raccolti e nell’offerta dei prodotti della terra
che poi venivano bruciati e le loro ceneri sparse sui campi. Gli Ambarvalia erano una festa
mobile e duravano tre giorni. Il XV Municipio di Roma è denominato “Arvalia Portuense” dai
resti di un tempio fatto erigere da Augusto che riorganizzò il Collegio e riservò a se stesso e ai
suoi successori il diritto a farne parte. Il Collegio rimase attivo fino al IV secolo d.C.
14] Lucus Feroniae: oggi è un sito archeologico situato nel comune di Capena sulla via
Tiberina, nei pressi del limitrofo comune di Fiano Romano. L’esatta ubicazione fu individuata
solo nel 1953, quando il principe Vittorio Massimo, proprietario del Castello di Scorano e dei
terreni circostanti, segnalò alla Soprintendenza dell’Etruria Meridionale l’affioramento,
durante dei lavori, di reperti archeologici. Il Lucus (“Bosco Sacro”) Feroniae preromano non
era un tempio, ma una intera località sacra alla Dea Feronia, una Grande Madre italica, Dea
della natura e delle acque, del parto e della prolificità, della vita e della morte. La Dea Feronia
proteggeva in particolare gli schiavi liberati e aveva proprietà guaritrici, confermate dai
numerosi ex-voto ritrovati in loco: ancor prima degli scavi, la località era chiamata Bambocci
per la notevole quantità di ex-voto anatomici che spuntavano dal terreno. Di questo
antichissimo luogo di culto ne danno notizie alcuni storici che affermano che il santuario era
un centro fiorente già in epoca regia e vi si raccoglievano mercanti e fedeli provenienti
dall’Etruria, dal Lazio e dalla Sabina. Il Santuario - famoso per le sue ricchezze - fu
saccheggiato da Annibale nel 211 a.C. Anche se il tempio fu subito ricostruito, il culto di
Feronia decadde e la località perse importanza fino a che Cesare, nel 59 a.C., vi stanziò i
veterani del proprio esercito, fondando la Colonia Iulia Felix Lucus Feroniae. L’attuale
impianto urbano risale in gran parte all’epoca di Augusto che proseguì e ingrandì l’opera
iniziata dal padre adottivo. L’ultimo dato epigrafico che testimonia la frequentazione del
santuario è del 266 d.C. e probabilmente il suo completo abbandono risale al V sec. d.C.