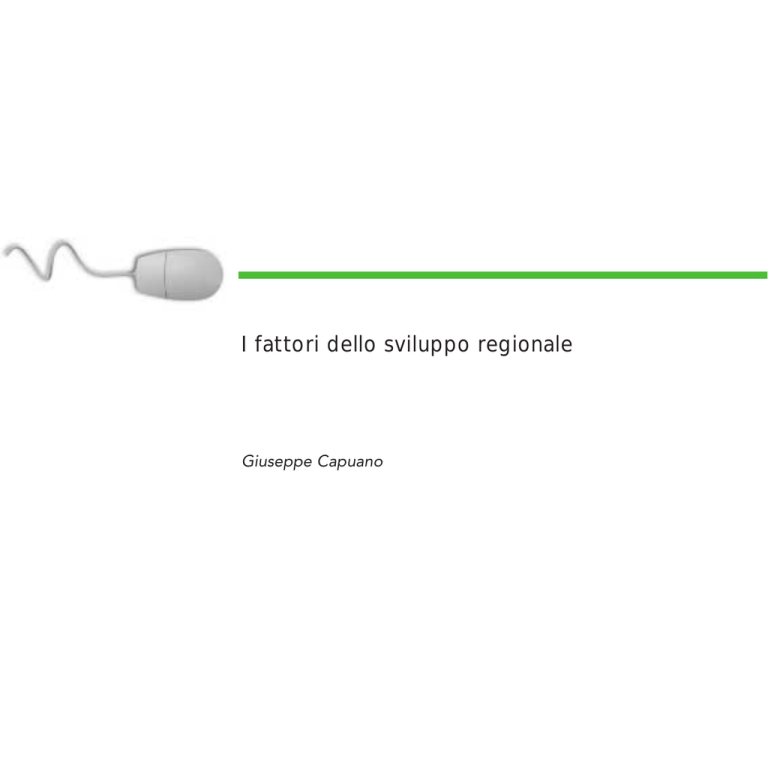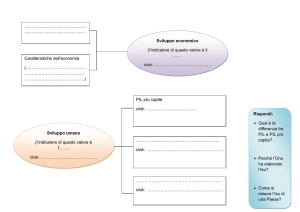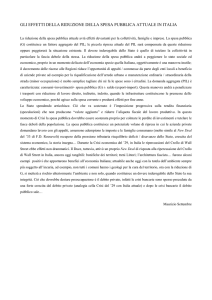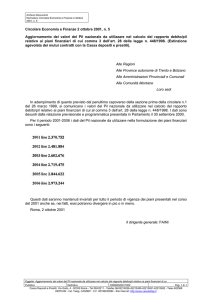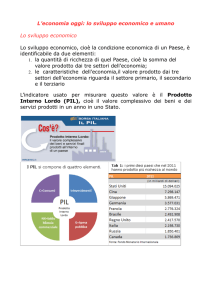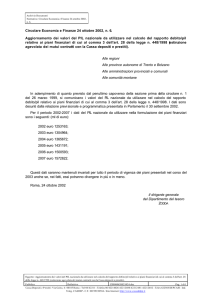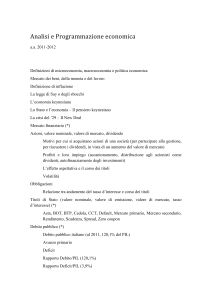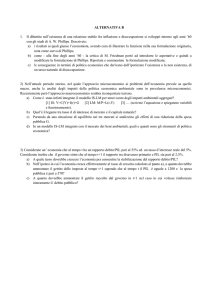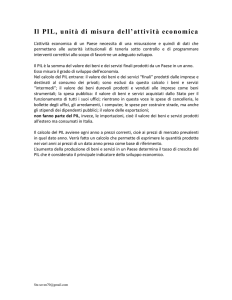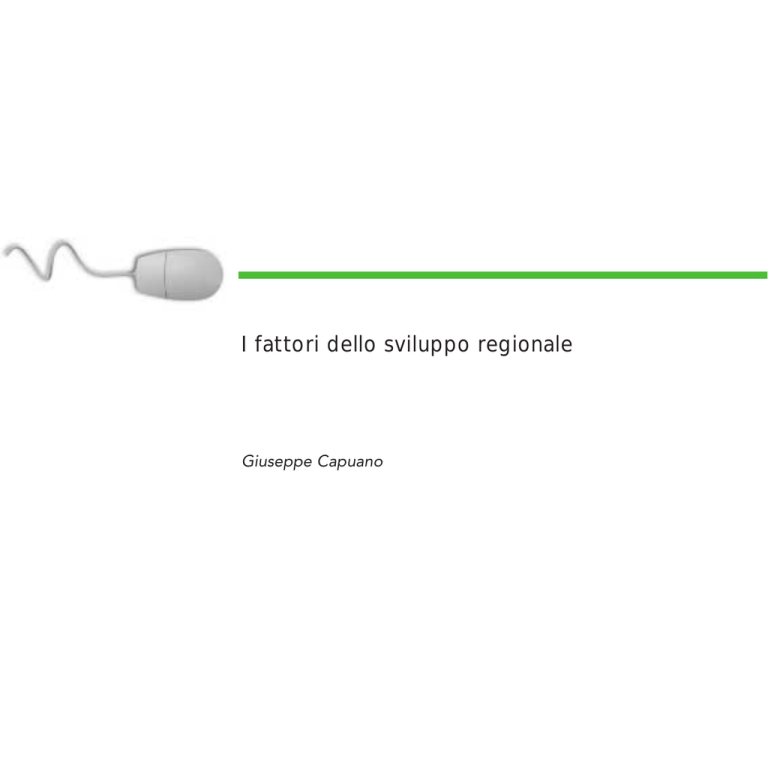
I fattori dello sviluppo regionale
Giuseppe Capuano
A mia moglie e a mia figlia
Indice
Giuseppe Capuano
6
Prefazione.................................................................................................................9
Premessa .................................................................................................................13
1. Il concetto di territorio nella teoria economica dominante ......................17
1.1 Il quadro teorico di riferimento ....................................................................19
1.2 Il livello mesoeconomico tra macro e microeconomia ...................................23
2. Introduzione alle principali teorie dello sviluppo regionale.......................31
2.1 Il modello neoclassico ...................................................................................34
2.1.1
Modello neoclassico e commercio internazionale. Il caso delle delocalizzazioni produttive .....38
2.2 Lo sviluppo esogeno trainato dalle esportazioni .............................................41
2.3 La teoria di Heckscher-Ohlin........................................................................47
2.3.1 Verso il superamento del teorema di Heckscher-Ohlin...............................................49
2.4 L’approccio input-output nei modelli di economia regionale .............................51
2.5 La teoria weberiana della localizzazione.........................................................52
2.5.1 La teoria delle zone centrali ..............................................................................53
3. I processi di convergenza e divergenza tra le province italiane:
il modello della convergenza non lineare......................................................57
3.1 Il dibattito teorico .........................................................................................59
I fattori dello sviluppo regionale
3.1.1 La critica all’approccio marginalista .....................................................................59
3.1.2 Le recenti evoluzioni del dibattito .......................................................................62
3.1.3 La “convergenza non lineare” (CNL) .................................................................63
3.2 La verifica “sul campo” della “convergenza non lineare” (CNL) .....................64
3.2.1 I limiti dell’utilizzo del Pil pro capite come misura del livello di sviluppo.......................64
3.2.2 I risultati dell’analisi provinciale nel periodo 1995-2002 ..........................................66
3.3 I fattori che contribuiscono alla “convergenza non lineare”................................72
3.4 Le traiettorie dello sviluppo delle province italiane attraverso l’analisi del PIL......73
4. Il ruolo del risparmio nello sviluppo regionale............................................85
4.1 Il risparmio nel modello Harrod-Domar .......................................................87
4.2 Una rivisitazione della teoria del “ciclo vitale”di Modigliani
e sua applicazione ad una economia a basso livello di sviluppo ......................89
7
5. Debito pubblico, redistribuzione del reddito e squilibri regionali ............97
5.1 Lo scenario economico di riferimento ..........................................................99
5.2 La crescita del debito pubblico negli anni ottanta.........................................102
5.3 L’impatto del debito pubblico sulla redistribuzione del reddito.....................107
5.4 L’impatto del debito pubblico sugli squilibri regionali..................................113
5.5 Conclusioni.................................................................................................115
Riferimenti bibliografici ................................................................................117
Prefazione
I
l fattore territorio così come il concetto di sviluppo
Prefazione
locale hanno rappresentato una crescente attenzione
nel dibattito e nelle teorie economiche a partire dagli
ultimi decenni del secolo scorso. Anche in una disciplina anch’essa relativamente giovane come il marketing, negli ultimi tempi si è evidenziata l’importanza del marketing territoriale, con la proposta di modelli di attrazione di investimenti a partire da una
variabile - opportunità come il territorio.
La Fondazione Tagliacarne, nata dal sistema delle Camere di Commercio e quindi degli
enti espressione delle comunità economiche locali, ha occupato nell’ultimo ventennio un
ruolo importante nella ricerca sullo sviluppo economico territoriale, elaborando contributi teorici e prodotti di studio come la realizzazione di osservatori settoriali, osservatori delle
economie provinciali, la progettazione e gestione di importanti sistemi informativi.
E’ quindi soprattutto l’esperienza maturata dall’Autore nell’Area Studi e Ricerche
dell’Istituto Tagliacarne che ha favorito la realizzazione di questa pregevole pubblicazione, che può prestarsi ad orizzonti di fruizione anche più ampi di una guida didattica per un modulo formativo per il Master STARTER - Statistica, Economia e
Ricerche di Mercato per lo Sviluppo del Territorio. Oltre che la utile indicazione di sintesi delle principali teorie di sviluppo regionale si sottolinea la classificazione dei vari modelli in relazione al ruolo passivo o attivo attribuito al territorio.
Originale è il tentativo di lettura dell’applicazione dei vari modelli nei percorsi di sviluppo delle realtà provinciali dal 1960 ad oggi e l’analisi della convergenza o divergen-
11
Giuseppe Capuano
12
za dei processi di sviluppo territoriale che si basa sulle stime provinciali del PIL, che rappresentano storicamente una connotazione fondamentale del lavoro di ricerca
Unioncamere – Istituto Tagliacarne. Altri due spunti interessanti si ritrovano nell’analisi
critica dell’applicazione della teoria del “ciclo vitale” di Modigliani alle regioni in ritardo di sviluppo come il nostro Mezzogiorno e nello studio delle conseguenze che la formazione del debito pubblico negli anni ’80 hanno avuto sugli squilibri regionali NordSud.
Luigi Pieraccioni
Consigliere Scientifico dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne
Premessa
I
l principale obiettivo di questo lavoro, attraverso la
Premessa
lettura delle più significative teorie dello sviluppo
economico regionale e locale, è riflettere sul crescente ruolo che il territorio (livello mesoeconomico dello sviluppo) ha nell’articolazione del pensiero economico e nella determinazione dei percorsi di sviluppo locale e soprattutto, se la cosiddetta “cassetta dei ferri del mestiere” dell’economista è adeguata a spiegare una realtà territoriale sempre più complessa, disomogenea e in un continuo divenire.
Cercare quindi di comprendere in che modo i fenomeni economici più importanti
del recente passato, in particolare i processi di globalizzazione economica, le delocalizzazioni produttive, l’introduzione dell’Euro in Europa, la progressiva riduzione della propensione al risparmio, impatteranno sull’attualità del concetto di territorio, sui processi
di convergenza economica tra i territori e, quindi, sulla geografia economica del nostro
Paese.
A tal proposito, nel libro saranno presentati tre lavori originali. Il primo sui processi
di convergenza/divergenza nelle province italiane e un primo tentativo di superamento
della teoria neoclassica della convergenza; il secondo, è una applicazione al Mezzogiorno
della Teoria del ciclo vitale di Modigliani, con la proposta di alcune modifiche e integra-
15
Giuseppe Capuano
16
zioni per renderla più coerente con la realtà economico-sociale delle nostre regioni
meridionali; il terzo, è una riflessione sulla formazione del debito pubblico negli anni
ottanta e il suo impatto negativo sulla formazione degli squilibri regionali nel nostro
Paese.
Inoltre, nel testo si esporranno in forma schematica, senza avere nessuna pretesa di
essere esaustivi, le principali teorie dello sviluppo regionale, applicando, dove è possibile,
alcune verifiche empiriche relative alle dinamiche delle regioni e province italiane.
L’obiettivo è puramente didattico e ha lo scopo di costituire un primo punto di riferimento, anche bibliografico, per coloro che iniziano ad avvicinarsi alla materia, rimandando a manuali e testi originali per gli eventuali e necessari approfondimenti.
Il lavoro è stato realizzato nell’ambito del Master STARTER – Statistica, Economia
e Ricerche di Mercato per lo Sviluppo del Territorio.
Questa riflessione, che ha costituito la guida didattica per il modulo “Economia del
Territorio” del suindicato Master, prende spunto dall’esperienza maturata in circa venti
anni di lavori sull’osservazione e il monitoraggio delle economie regionali che l’Autore
da economista ha realizzato prima, presso la Direzione Studi del Parlamento Europeo di
Bruxelles, e poi, all’Istituto Guglielmo Tagliacarne dove è Responsabile dell’Area Studi e
Ricerche. Negli ultimi anni, inoltre, tale riflessione, è stata arricchita da una vasta esperienza didattica maturata attraverso corsi e seminari svolti presso alcune Università
Italiane (Università “La Sapienza” di Roma, Università Lumsa di Roma, Università
“Cattaneo” di Varese, Università Cattolica di Piacenza, Università di Trento) ed in particolare al corso svolto presso la cattedra di Analisi Statistica - Economica Territoriale della
Facoltà di Economia dell’Università “Parthenope” di Napoli, e Università straniere come
l’Università della Svizzera Italiana (USI) di Lugano.
CAPITOLO
1
Il concetto
di territorio
nella teoria
economica
dominante
R
1.1 Il quadro teorico di riferimento
ipercorrendo la storia del pensiero economico dell’Ottocento e dei primi
decenni del Novecento, con particolare riferimento alla vasta letteratura sullo sviluppo
economico e sulle cause dei processi di accumulazione e di distribuzione del reddito, l’economia è stata da sempre considerata “a-spaziale”, con la rappresentazione dei meccanismi di trasmissione all’interno del circuito economico, come se l’economia di un paese
fosse una unica entità omogenea.
Nessuna delle principali scuole di pensiero economico del passato, da quella classica
a quella neoclassica e keynesiana, alle più recenti scuole di pensiero economico1 (monetaristi, nuova macroeconomia classica, nuova macroeconomia keynesiana, etc.) se si escludono alcuni sviluppi delle teorie di Alfred Marshall2, ha introdotto in maniera sistematica nel dibattito teorico l’importanza degli aspetti territoriali nella formazione del prodotto e della distribuzione del reddito3.
Una delle principali motivazioni di questa lacuna presente nelle teorie economiche
del passato va ricercata soprattutto nel basso livello di sviluppo raggiunto dalle principali economie prima della fine dell’Ottocento (se si esclude la Gran Bretagna) e nella concezione teorica, di stampo meramente neoclassico, che lo sviluppo, essendo caratterizzato da un processo che porta all’equilibrio generale di lungo periodo, interessa l’intera
popolazione della nazione, anche se con modalità di partecipazione alla formazione del
prodotto (lavoratori, capitalisti, latifondisti) e fonti di reddito (salari, profitti, rendite) differenti.
1
Per una panoramica sulle
più recenti scuole di pensiero economico sia di
derivazione neoclassica
che keynesiana: Boitani,
A. and Damiani, M.
(2003).
2
Marshall, A. (1890).
3
Per una rassegna delle
principali scuole di pensiero economico: A. Graziani, (1981).
Giuseppe Capuano
20
Le teorie economiche furono formulate, comunque, in una economia europea che
già nel XIX e sicuramente nei primi decenni del XX secolo, conosceva evidenti differenze di tipo territoriale, in termini sia di caratteristiche dei settori partecipanti alla formazione del prodotto che nei livelli di sviluppo. Si pensi all’economia delle città, in particolare delle Capitali europee dell’epoca, alle vaste regioni agricole oppure a quelle
realtà, che in particolare in Gran Bretagna, ma anche in Francia, in Germania e nella stessa Italia nell’età giolittiana dei primi del secolo, erano caratterizzate da una incipiente
industrializzazione.
L’evidente carenza di un impianto teorico che sostenesse l’importanza del ruolo del
territorio nei processi di sviluppo nasce anche dal “rifiuto” della teoria dominante dell’epoca di considerare la presenza di squilibri regionali nel lungo periodo e dalla convinzione che l’intera economia nazionale, a parità di input di politica economica, reagisce nei medesimi tempi e modalità. Questi due ultimi aspetti sono tra i principali punti
di una visione dei meccanismi economici che solo dagli anni cinquanta del secolo scorso, è stata lentamente modificata e integrata, quando il concetto di sviluppo locale è
entrato a far parte del dibattito economico contemporaneo.
Con il concetto di sviluppo locale si fornisce una risposta al crescente scetticismo
circa la capacità delle teorie tradizionali dominanti di analizzare le relazioni esistenti tra
il livello macro, quale l’economia nazionale, e il livello micro, determinato dalla singola
azienda. In realtà si introducono le basi teoriche per un’analisi approfondita dell’esistenza di un livello intermedio o mesoeconomico che rappresenta il luogo dove si creano i
sistemi di relazioni o d’interazioni che costituiscono a loro volta il meccanismo di trasmissione tra il singolo settore produttivo e l’intero sistema economico. In effetti, si individuano i primi fondamenti di una teoria mesoeconomica, complementare e non alternativa alle teorie micro e macroeconomiche.
Con la rivisitazione delle principali teorie economiche in termini di economia
regionale, gli elementi che costituiscono o determinano lo sviluppo e la competizione
dei sistemi economici-politici-territoriali sono stati letti, in principio, attraverso una logica dicotomica di tipo “funzionale” (teorie tradizionali) o “territoriale” (localisti).
Nell’approccio di tipo “funzionale” lo spazio è stato considerato un vincolo al comportamento dei soggetti economici e gli è stato attribuito un ruolo passivo, un costo,
quasi un vincolo per le attività produttive e, quindi, per lo sviluppo. Tutte le teorie che
possono essere raggruppate come modelli di sviluppo regionale equilibrato (ad esempio
la teoria neoclassica della crescita) o quelle che potremmo definire come modelli di sviluppo squilibrato (ad esempio le teorie neokeynesiane relative allo sviluppo regionale) che esa-
I fattori dello sviluppo regionale
mineremo brevemente nel Cap.2, attribuiscono un ruolo passivo al territorio e soprattutto considerano il susseguirsi dei fenomeni economici indipendentemente dal contesto territoriale nel quale si collocano, intendendo il territorio come una “variabile esogena” al processo di sviluppo.
In genere questi modelli considerano la regione come un’entità omogenea secondo
il principio dell’uniformità di tutti gli elementi che la compongono.
Nel caso dell’approccio “territoriale”, seguito dalla più recente letteratura in materia di sviluppo locale, al contrario, si attribuisce al territorio un ruolo attivo e in continua trasformazione. Secondo questa impostazione, gli ambiti locali assumono un ruolo
fondamentale nel determinare le caratteristiche dello sviluppo.
Il modello centro-periferia di Krugman (1995) e i cosiddetti modelli di rete (approccio
distrettuale4, cluster industriali5, milieu innovateur6, approccio relazionale7, etc.) sono un
esempio di suddetta impostazione. Essi danno un ruolo centrale al territorio inteso non
solo come fattore fisico, ma di contesto più generale, nel quale le imprese, le Istituzioni,
i cittadini, operano insieme per perseguire lo sviluppo. In definitiva, l’economia territoriale è considerata come un insieme di relazioni o stock di beni relazionali.
L’ottica è quella di integrare le relazioni tra imprese nelle loro principali accezioni
con i luoghi dove tali relazioni si formano e si sviluppano, avendo questi ultimi una nuova
centralità in un contesto sempre più globalizzato; in quanto, i fenomeni delle delocalizzazioni produttive, l’internazionalizzazione delle imprese, le reti trasnazionali, hanno portato ad interpretare lo “spazio” non più come una sorgente di costo (si veda tutta la letteratura italiana in materia distrettuale – l’opera di Becattini e della scuola di Firenze o i contributi della letteratura internazionale, da Krugman, Fujita e Porter in poi) ma
come un fattore di sviluppo, in un’ottica di gerarchia e di reti fra luoghi8.
Il confronto e simbiosi tra scuole di pensiero simili – quella distrettualistica italiana e
quella dei modelli core-periphery prevalentemente americana – hanno consentito di dare
una base di teoria economica all’interpretazione dello sviluppo, con particolare riferimento ai tradizionali fattori d’agglomerazione produttiva legati alla situazione socio-istituzionale (scuola distrettualista) e alle sue determinanti tecnologico-economiche, quali
economie di scala e costi di trasporto (Modelli core-periphery) che hanno interessato con
diversa intensità le regioni del NEC9 ma anche quelle del nostro Mezzogiorno (Viesti,
2000 10).
Il territorio, insieme alle tecnologie e alle organizzazioni, per dirla con Storper
(1997), fa parte di una nuova “santa trinità” degli elementi cardine dell’economia regionale. Un paradigma eterodosso, elaborato negli anni settanta al fine di spiegare i fenome-
4
Tra gli altri: Becattini,
(1989); Sabel, (1989), Sforzi
(1990), Garofoli (1991).
5
Porter (1990): nel suo libro
“The competitive Advantage of Nations” afferma
testualmente: “l’unità elementare di analisi per capire il vantaggio nazionale è
il settore industriale. Le nazioni hanno successo non
per settori industriali, però,
ma in aggregati o cluster
(grappoli) di settori industriali, connessi da relazioni
verticali e orizzontali”.
6
Tra gli altri: Aydalot,
(1986); Maillat and Perrin
(1992).
7
Tra gli altri: Lorenzoni
(1990); Lipparini (1995).
8
Per una rassegna aggiornata sul dibattito economico: Istituto Tagliacarne,
Impresa e Territorio (a cura
di G. Garofoli), Il Mulino,
2003.
9
Con questa divisione si indicano le regioni italiane
del Nord Est e del Centro.
10
Viesti G. (2000), Come nascono i distretti industriali,
Laterza; Viesti G. (a cura
di), Mezzogiorno dei distretti, Meridiana Libri.
Giuseppe Capuano
22
ni di deindustrializzazione nelle regioni di antica industrializzazione e successivamente
maturato a cavallo degli anni ottanta e novanta, quando si è cercato di interpretare i fenomeni di rinascita delle economie regionali.
Il quadro teorico che ne consegue, potrebbe essere giudicato, però, insufficiente o
parziale nello spiegare le dinamiche di sviluppo locale in un contesto di globalizzazione
dell’economia che ha evidenziato l’importanza della dimensione sovranazionale dei
fenomeni economici.
Ciò pone al centro del dibattito economico alcuni quesiti di estremo interesse: un
primo interrogativo è se un simile processo possa portare alla convergenza dei percorsi di
sviluppo regionale. Un secondo si riferisce al ruolo del territorio nei modelli di sviluppo locale e se esso continui ad avere quella centralità che ha assunto fin dagli anni sessanta.
Sul primo punto alcuni economisti non hanno dubbi: se negli anni trenta si riteneva la tecnologia capace di favorire una maggiore convergenza, oggi questo ruolo lo ha
assunto la concorrenza, grazie all’intensificazione delle relazioni internazionali tra soggetti economici e all’elevata mobilità dei fattori produttivi. Quindi, seguendo uno schema teorico tipico della scuola marginalista, i citati elementi determinano una convergenza nei livelli di produttività e più in generale dei prezzi.
Altri, al contrario, sono concordi nel ritenere che la globalizzazione, se favorisce alcune economie regionali deprime altre, determinando una accentuazione degli squilibri
regionali non solo tra paesi ricchi e paesi poveri ma anche all’interno dei primi.
Un’ampia letteratura in materia, afferma, ad esempio, che l’introduzione della moneta unica nell’Unione europea accentuerà nel tempo i divari regionali. Ciò avverrà a causa
di un processo di spostamento dei capitali da regioni meno concorrenziali verso regioni
più produttive, con l’effetto di determinare concentrazioni di specializzazioni produttive
a tutto favore delle regioni più ricche rispetto a quelle più povere e conseguente aumento dei divari occupazionali e di reddito a tutto favore delle prime (Krugman, 1995;
Capuano, 1998; Cencini, 1999).
Rispetto al secondo quesito, un filone di pensiero sostiene che, dagli anni novanta, si
stia verificando una costante perdita di centralità da parte del territorio come fattore di
sviluppo. L’internazionalizzazione dei mercati finanziari, gli effetti determinati dall’introduzione dell’euro finalizzata al completamento di un reale mercato unico europeo, l’armonizzazione delle politiche economiche (aspetto macro) e l’affermarsi di processi di
delocalizzazione produttiva (aspetto micro) partiti soprattutto da quelle latitudini dove il
territorio aveva un importante ruolo nei modelli di sviluppo locale (si veda ad esempio
cosa è successo nei distretti industriali del Nord Est o dell’Emilia - Romagna) sarebbero
solo alcuni esempi di un processo in atto e dell’irrilevanza dei fattori legati al territorio.
Dunque, i processi di crescita stanno dando vita ad una “a - territorialità” dello sviluppo, proprio nel momento in cui le politiche regionali, in particolare nelle aree più
deboli del paese, sono sempre più pensate e gestite a livello locale ma condizionate in
maniera crescente da dinamiche macroeconomiche e da centri decisionali che spesso
sono fuori regione se non addirittura fuori del paese interessato.
Al contrario, altri autori sono più cauti nel giungere a conclusioni su di un processo
che tutto può dirsi tranne che concluso e ritengono che la globalizzazione, grazie ad una
crescente capacità dei territori di attrarre conoscenza e innovazione, potrà coincidere con
le esigenze della domanda locale (Favaretto, 2000).
Su questa posizione, pur riconoscendo l’importanza di riconsiderare il ruolo del territorio nei modelli di sviluppo locale, si collocano i “neolocalisti”11 tra i quali si inserisce
la scuola di pensiero dell’Istituto Tagliacarne a cui appartiene l’Autore.
In conclusione, la risposta che proviene dalla rivisitazione delle principali correnti di
pensiero che da Marshall ai nostri giorni hanno dato importanza al concetto di economia e sviluppo locale e da alcune analisi originali proposte dall’Autore nei capitoli di
questo libro è la seguente: la teoria economica moderna, al fine di determinare i suoi modelli
interpretativi, non può prescindere dal ruolo ricoperto dal livello mesoeconomico (livello intermedio)
12
come luogo di formazione dei meccanismi di trasmissione e di mediazione economica tra i mercati nazionali dei beni reali e della moneta e le scelte di politica economica (livello macro) da un lato,
e la singola impresa e più in generale dei soggetti economici (livello micro) dall’altro.
1.2 Il livello mesoeconomico tra macro e microeconomia
Il livello mesoeconomico solo di recente ha assunto rilevanza nel dibattito economico come variabile analitica all’interno dei processi economici e dello sviluppo locale.
Dalla Fig.1 di pag.15, in cui si è fatto un tentativo di organizzare le principali teorie e
modelli di sviluppo regionale a seconda di come questi considerano il ruolo del territorio nella formazione della catena del valore, è evidente come per molto tempo gli economisti ne hanno sottovalutato il significato e, solo negli anni più recenti, la logica territoriale e la differenziazione nei percorsi di sviluppo (gli “n” modelli di sviluppo locale
Il concetto di territorio nell’economia regionale
I fattori dello sviluppo regionale
11
In Italia, uno dei riferimenti culturali di questa corrente di pensiero economico è sicuramente l’Associazione Italiana di
Scienze Regionali (AISRE).
12
Il termine mesoeconomico o mesoeconomia ancora non è presente nei dizionari dei termini economici. Il primo elemento
della parola, meso, deriva
dalla parola greca mésos
che significa medio. A tal
fine, in questa sede, si cercherà di fornire un contributo definitorio che certamente non ha pretese di
completezza.
Giuseppe Capuano
24
determinati dalle specifiche caratteristiche produttive e dal differente peso dei settori
nella formazione del PIL) è stata accettata dalla comunità scientifica.
Secondo i teorici del localismo, lo sviluppo locale è fortemente condizionato dai
comportamenti degli attori locali dello sviluppo, dal contesto istituzionale locale e
soprattutto dall’esistenza di relazioni, formali e informali, tra imprese. A tal proposito, è
d’estrema importanza tutta l’ampia letteratura sui distretti industriali che ha le sue radici
nel pensiero dell’economista inglese Alfred Marshall e al suo esplicito riferimento alle
economie esterne all’impresa (Becattini, 1989).
Il territorio, come visto in precedenza, è considerato come un fattore della produzione e dello sviluppo alla stessa stregua del lavoro e del capitale ma non nel senso fisico del
termine (si pensi al fattore “terra” nella teoria classica), quanto come luogo dove gli attori
locali dello sviluppo (imprese, Istituzioni, cittadini, etc.) organizzano la “produzione”.
A tal proposito, noi riteniamo che esiste una curva di domanda e offerta quante sono
le realtà territoriali che per convenzione individuiamo nella ripartizione amministrativa
della provincia, con un Prodotto Interno Lordo del territorio (Yter) che si fonda sui consumi dei suoi abitanti (Cter); sugli investimenti, sia pubblici (Gter), realizzati dagli Enti
locali e/o direttamente dallo Stato centrale, sia privati (Iter), determinati dal tessuto di
imprese ivi localizzate; su di una autonoma attività di esportazioni/importazioni (Eter –
Mter); l’insieme di questi elementi contribuisce alla formazione del reddito dei suoi abitanti partecipanti alla produzione del territorio e alla loro propensione al risparmio.
Formalmente potremmo così definire l’equazione:
Yter = Cter + Iter + Gter + Eter – Mter
13
Il problema di ricavare
una macroeconomia dall’analisi microeconomica
si è posto sia per la nuova
macroeconomia classica
che la nuova scuola keynesiana. La prima, partendo dall’indirizzo teorico walrasiano, la seconda
dalla teoria dei mercati
imperfetti.
Assistiamo, quindi, alla creazione di un passaggio intermedio (il livello “mesoeconomico”) nella creazione della ricchezza di un Paese, che si inserisce nella formazione della
“catena del valore” e concorre a determinare le relazioni e i comportamenti esistenti tra
singoli soggetti economici (il livello “microeconomico”) e le variabili economiche
aggregate (il livello macroeconomico). Quindi, se è vero che la ricerca economica negli
ultimi venti anni ha concentrato i suoi sforzi nel fornire i fondamenti microeconomici
alla macroeconomia13, un nuovo filone di ricerca è nato per fornire i “mesofondamenti”
sia alla macro che alla microeconomia.
La conseguenza di un simile ragionamento, è la seguente:
l’efficacia della politica economica di un Paese (politica monetaria restrittiva/espansiva, politica di
I fattori dello sviluppo regionale
In base a questi principi, anche se i processi di globalizzazione ne sfumeranno i confini e ridurranno d’importanza gli elementi di contiguità territoriale (il concetto di “meta
distretto14” o i processi di delocalizzazione conosciuti dai distretti industriali ne costituiscono solo un esempio), non cancelleranno il territorio come fattore caratterizzante lo
sviluppo endogeno di una determinata area.
Lo sviluppo basato su fattori endogeni, quindi, individua un nuovo ruolo del territorio: non più importante per le sole risorse di cui è dotato (risorse naturali, lavoro, etc.)
e come mero luogo di produzione (ciò rappresenta la vecchia concezione dei distretti)
ma soprattutto come luogo dell’attività di ideazione e progettazione imprenditoriale (la
risposta alla concorrenza dei Paesi di nuova industrializzazione come la Cina). Un nuovo
posizionamento competitivo basato sulla capacità innovativa dei sistemi locali trainata da
fattori materiali e immateriali (ambiente, servizi, infrastrutture, etc.) ivi localizzati.
In ogni caso, la ricerca della crescita non sempre è risultata convergente tra regioni
con livelli di sviluppo di partenza differenti (come d’altronde vorrebbe la teoria neoclassica della convergenza) ne ha avuto una diffusione sul territorio, secondo dei sentieri della
crescita equilibrata o di steady state. Anzi, lo sviluppo è comunque per sua stessa natura
dirompente e squilibrato, con fasi che spesso rappresentano dei momenti di rottura con
i passati tassi e processi di crescita di una realtà e spesso rompono equilibri, semmai in
economia ve ne fosse esistito uno.
Un esempio di sviluppo squilibrato è quello trainato dalle esportazioni secondo la
teoria della base economica e delle esportazioni e crescita cumulativa. A differenza dei modelli
neoclassici dove la crescita è esclusivamente fondata sulle risorse locali (approccio valido
per insiemi economici di grandi dimensioni), lo sviluppo (in particolare per regioni di
piccole dimensioni) secondo queste teorie è determinato da fattori esogeni quali la
domanda di esportazioni.
Da un punto di vista empirico, come si vedrà successivamente, alcuni riscontri di
queste teorie li ritroviamo nel modello di sviluppo perseguito nel cosiddetto “triangolo
industriale italiano” durante gli anni sessanta-settanta.
I percorsi di sviluppo regionali sono stati da sempre il risultato di una contrapposizione tra territori, tra centro e periferia, di egemonia economica di una regione
Il concetto di territorio nell’economia regionale
bilancio, politica dei redditi, etc.) dipenderà da come il livello mesoeconomico reagirà agli input esogeni, sia in termini temporali (immediati al tempo t, ritardati al tempo t + 1) che di trend (reazione dello stesso o differente segno). Nei casi estremi, gli interventi di politica economica potrebbero risultare “neutrali” o addirittura controproducenti per la singola economia locale.
14
Per “meta distretto” si intendono le aree tematiche di intervento di tipo
orizzontale, non limitate
da un territorio omogeneo e determinate sulla
base dell’integrazione intersettoriale dei sistemi
produttivi delle diverse
sotto aree che li compongono. In altri termini, si
tratta di aree non necessariamente caratterizzate
da contiguità fisica, che
sono assemblate sulla
base dell’intensità dei legami di filiera dei sistemi
produttivi che vi insistono. Attualmente questo
principio è stato utilizzato dalla Regione Lombardia per l’individuazione
dei distretti industriali
della regione.
Giuseppe Capuano
26
15
A questo proposito sul
concetto di regione si veda Boudeville (1966) e
Meyer (1963) e più di recente Markusen (1987).
rispetto ad altre e all’interno delle stesse tra aree con caratteristiche diverse e livelli
di reddito diversi.
La teoria della causazione circolare cumulativa (il processo di sviluppo regionale tende a
divergere piuttosto che a convergere), il modello del filtering down (l’esistenza gerarchica di
aree urbane, dove diversi livelli di offerta di economie esterne portano a fenomeni di
concentrazione/decentramento tra aree) o il modello del polo di sviluppo (attraverso le economie esterne l’industria motrice genera un effetto cumulativo e moltiplicativo concentrato nello spazio; modello perseguito in alcune realtà del nostro Mezzogiorno attraverso l’intervento straordinario degli anni cinquanta, sessanta), sono solo degli esempi di teorie che seguono un “approccio ineguale allo sviluppo” (per una rassegna più completa
delle teorie dello sviluppo si rimanda al Cap. 2 del libro).
Di conseguenza, in un contesto regionale dove è evidente che la realtà economica è
formata da numerosi percorsi di sviluppo locale (a questo proposito il caso italiano è
emblematico), è più coerente parlare di come gestire lo sviluppo che non quello di ridurre gli squilibri. Infatti, a nostro avviso, le traiettorie dello sviluppo locale dovrebbero
essere lette in termini trasversali ai territori uscendo da un “localismo estremo” ed in una
logica non strettamente settoriale ma di filiera.
Da ciò ne consegue che la logica di perseguire politiche di sviluppo locale come strumento per ridurre le distanze tra gruppi di regioni forti e gruppi di regioni deboli, secondo un approccio di automatico susseguirsi di fasi di crescita, deve essere necessariamente
superata. Nel Cap. 3 di questo libro si è, infatti, sostenuto che le province italiane hanno
da tempo abbandonato dei processi di convergenza lineare, ma hanno perseguito negli
anni novanta un sentiero di crescita che potremmo definire di “convergenza non lineare”
dove le distanze in termini di PIL pro capite seguono un percorso di tipo “sinusoidale”.
Questa visione è in antitesi rispetto all’approccio di sviluppo equilibrato perseguito
dal modello neoclassico il quale teorizza l’annullamento delle disparità esistenti tra le
regioni nel lungo periodo, in cui la convergenza dei livelli di sviluppo è certa e non esistono rapporti di dominanza e di dipendenza tra le regioni.
In conclusione, tuttavia, nonostante gli studi realizzati in anni recenti sia a livello
empirico che teorico, e l’interessante evoluzione e affinamento della base teorica di
riferimento, incontriamo ancora difficoltà a parlare «con piena dignità scientifica di una
dimensione locale della crescita economica» (Bramanti, Maggioni, 1995). E’ noto come
sono ancora presenti, e solo parzialmente superate, le problematiche che si incontrano
nel definire lo stesso concetto di regione economica15 essendo tutte le definizioni parziali
e/o insufficienti e soprattutto riferite ad unità territoriali troppo estese o spesso ina-
deguate per una corretta analisi statistico-economica del territorio e delle sue traiettorie di sviluppo.
Ciò è stato possibile soprattutto per l’assenza di fondamenti mesoeconomici della
teoria dello sviluppo regionale che ha impedito un collegamento organico e funzionale
tra le teorie macroeconomiche e la tradizionale scuola di pensiero neoclassica legata ai
comportamenti di singoli soggetti economici.
Figura 1 - Territorio e modelli di sviluppo regionale
Logica funzionale
Modelli di sviluppo
equilibrato
(regione omogenearuolo passivo del territorio)
Logica territoriale
(ruolo attivo del territorio)
• L’approccio neoclassico
(ad un settore e a due settori)
• L’approccio dello sviluppo per tappe
27
• Teoria weberiana della localizzazione
• Teoria delle zone centrali
(Christaller, Loesch e Isard)
• Base esportazioni
Modelli di sviluppo
squilibrato
Il concetto di territorio nell’economia regionale
I fattori dello sviluppo regionale
• Il modello di Richardson
• Modello centro/periferia di Krugman
• Causazione circolare cumulativa
• Modelli di network:
- approccio distrettuale
- approccio del milieu innovativo
- approccio relazionale
• Il modello Kaldor/Dixon/Thirlwall
• I modelli del polo di sviluppo
• La teoria del filtering-down
ed il ciclo di vita del prodotto
• Modello di sviluppo non lineare
Giuseppe Capuano
Figura 2 - Esempi di modelli di sviluppo in Italia dal 1960 ad oggi
28
I fattori dello sviluppo regionale
Modello grande impresa
Quota occupati GI nell’area
15,1%
Quota occupati GI media Italia
12,1%
Quota pil industria nell’area
37,1%
Quota pil terziario nell’area
85,0%
Quota pil industria media Italia
30,6%
Quota pil terziario media Italia
68,5%
Fonte: elaborazione propria su dati Istituto G.Tagliacarne-ISTAT
Modello località centrali
Fonte: elaborazione propria su dati Istituto G.Tagliacarne
Modello distrettuale
Quota occupati PMI nell’area
91,6%
Quota occupati PMI media Italia
87,9%
Quota export sul totale nell’area
39,3%
Quota export sul totale non area
60,7%
Fonte: elaborazione propria su dati Istituto ISTAT
Il concetto di territorio nell’economia regionale
Figura 3 - Alcuni modelli di sviluppo in cifre
Modello monocentrico
Il 10-15% dei comuni concentrano
circa il 65-70% dell’occupazione
e della ricchezza prodotta
Fonte: elaborazione propria su dati Istituto G.Tagliacarne-ISTAT
Modello agro-alimentare
Quota pil agricolo sul totale nell’area
8,7%
Quota pil agricolo sul totale media Italia
3,3%
Quota export agro-alimentare nell’area
9,5%
Quota export agro-alimentare media Italia 6,5%
Fonte: elaborazione propria su dati Istituto G.Tagliacarne-ISTAT
29
CAPITOLO
2
Introduzione
alle principali
teorie
dello sviluppo
regionale
I
n questa parte del lavoro si esporranno, in forma schematica e a scopo meramente didattico senza avere la pretesa di dare una esaustiva panoramica della vasta letteratura, le principali teorie dello sviluppo regionale, rimandando a manuali e testi
originali per gli eventuali e necessari approfondimenti.
Come Armstrong e Taylor (1985, testo preso a riferimento di questo capitolo) autorevolmente affermano nel loro manuale, sulle cause che determinano la crescita economica non c’è assoluto accordo tra gli economisti. Se alcuni seguono il sentiero tracciato
dai neoclassici, dando un ruolo da protagonista nel processo di crescita ai fattori dal lato
dell’offerta (offerta di lavoro, stock di capitale, progresso tecnico, etc.), altri prediligono,
secondo l’insegnamento keynesiano, il ruolo svolto dai fattori della domanda. Altri ancora
individuano nelle dinamiche degli scambi internazionali un importante determinante della
crescita. Queste tre famiglie di filoni di analisi non danno particolare importanza allo spazio, cosa che invece, pur in un contesto teorico marginalista, è rilevante nelle teorie della
localizzazione e nei modelli di rete.
33
Giuseppe Capuano
2.1 Il modello neoclassico16
34
Come è noto in letteratura, la funzione di produzione aggregata rappresenta uno dei
punti di riferimento della teoria neoclassica17 della crescita. In un contesto economico
dove il progresso tecnico non esiste, la produzione deve la sua esistenza a due fattori, il
capitale e il lavoro:
Qt = F (Kt, Lt)
dove:
Qt è la produzione al tempo t, Kt è lo stock di capitale al tempo t
e L è la forza lavoro al tempo t.
Dato il livello dell’offerta del capitale e di lavoro, il tasso di crescita della produzione
è espresso come funzione dei tassi di crescita del capitale e del lavoro in un contesto di
rendimenti costanti e di concorrenza perfetta, si può esprimere il seguente semplice
modello di crescita:
16
Il modello neoclassico
della crescita presenta
una prima ipotesi ad un
settore (molto semplificatrice della realtà), e una
ipotesi a due settori (più
realistica). Considerate le
finalità del nostro testo
considereremo solo l’ipotesi più semplice.
17
Essa indica nel linguaggio corrente la “teoria
economica marginalista”. Il termine fu coniato
dal sociologo e economista Th. Veblen.
dove:
rappresenta la crescita della produzione,
quella dello stock di capitale e
quella della forza lavoro. Le costanti α e 1 - α rappresentano, rispettivamente, il contributo degli input di capitale e di lavoro alla produzione globale.
Questa equazione mostra come il prodotto per addetto possa aumentare soltanto se
la crescita del capitale eccede quella dell’offerta di lavoro.
Figura 4 - Prodotto per addetto e rapporto capitale / lavoro
Introduzione alle principali teorie dello sviluppo regionale
I fattori dello sviluppo regionale
35
Nota: Se la F(K,L) è una funzione omogenea di primo grado Q=F(K,L) implica Q/L=F(K/L).
La più nota e utilizzata funzione della produzione è quella proposta originariamente nel 1928 dall’economista P.H. Douglas e dal matematico C.W.Cobb (funzione di
Cobb-Douglas), che grazie alle sue numerose proprietà formali viene spesso utilizzata nei
modelli di crescita.Tra queste citiamo i rendimenti di scala costanti, i prodotti marginali
crescenti di entrambi i fattori e l’elasticità di sostituzione tra i fattori costante e uguale a
uno. Essa è una funzione del tipo rappresentato nella Fig.4.
Approfondendo l’analisi si giunge alle seguenti conclusioni: il prodotto per addetto
aumenta con l’aumentare del capitale pro capite a disposizione dei lavoratori (processo
noto come capital deepening). Inoltre, in assenza di progresso tecnico, il processo non può
andare all’infinito in quanto il capitale - come del resto anche il lavoro - è caratterizzato da rendimenti marginali decrescenti.
Di conseguenza Q/L aumenterà ad un tasso decrescente come si evince dalla Fig. 4.
Giuseppe Capuano
36
Il modello neoclassico può essere reso più realistico se consideriamo anche l’esistenza del progresso tecnico. L’effetto “progresso tecnico” consentirà di spostare verso l’alto
la funzione della produzione per addetto, e dato il livello del rapporto capitale/lavoro si
avrà un aumento del prodotto per addetto rispetto ad una situazione in assenza di progresso tecnico (Fig. 5).
Figura 5 – L’effetto del progresso tecnico sul prodotto per addetto
Di conseguenza l’equazione della crescita con progresso tecnico sarà la seguente:
dove:
è il progresso tecnico.
In conclusione, secondo il modello neoclassico i differenziali di crescita del prodotto per addetto e, quindi, del tasso di crescita delle regioni, sono dovuti sostanzialmente ai
differenziali di crescita del rapporto capitale/lavoro e del progresso tecnico (esogeno).
Si giunge, quindi, a dimostrare che il tasso di crescita della produzione (secondo un
processo che coinvolge i salari le cui variazioni sono date dagli squilibri domanda/offerta) tende ad eguagliare il tasso di crescita dell’offerta di lavoro e quello del progresso tecnico. Essendo le due grandezze considerate costanti, il modello neoclassico porta alla
conclusione che il livello del reddito, quando tale eguaglianza è verificata, si trova in un
sentiero di steady state18 e, se ciò non si verifica, converge verso di esso.
Una versione più forte della teoria esclude anche la necessità della presenza di uno
squilibrio sul mercato del lavoro per avere una convergenza verso la steady state, anzi presuppone l’esistenza di un perfetto equilibrio.
Dal dibattito scaturito dai risultati di ricerche empiriche è stato evidente, in ogni
modo, come non vi sono prove di processi diffusi di convergenza tra le economie regionali. Questa evidenza è in netta contraddizione, come visto in precedenza, rispetto a
quanto teorizzato dai neoclassici. Al fine di superare le difficoltà create alla scuola neoclassica, durante gli anni ottanta è nata la “teoria della crescita endogena”19.
Secondo i neoclassici gli elementi fondamentali della convergenza sono due: progresso tecnico esogenamente dato e la produttività marginale decrescente del capitale, in
connessione con una funzione di produzione con rendimenti costanti di scala.
I teorici della crescita endogena affrontano i problemi connessi alle difficoltà di verificare la convergenza, seguendo principalmente due strade che possono essere combinate oppure no:
Introduzione alle principali teorie dello sviluppo regionale
I fattori dello sviluppo regionale
18
Nell’analisi economica lo
stato stazionario rappresenta una condizione
ideale del sistema economico caratterizzata da
un prodotto netto costante, invariabilità dei
processi produttivi e assenza di accumulazione e
di crescita. Già Carl Marx
nel Capitale e gli economisti classici (in particolare Davide Ricardo), si rifecero a questo principio
nelle loro formulazioni
teoriche.
19
Per un approfondimento
sulla teoria della crescita
endogena, tra gli altri:
Boggio, L. e Serravalli, G.
(1999); Solow M. R.,
(1994).
❏ il progresso tecnico da esogeno diventa endogeno;
❏ il concetto di capitale si allarga, considerandolo un fattore riproducibile, e quindi
eliminando il concetto della sua produttività marginale decrescente.
La teoria, quindi, recupera il concetto di rendimenti crescenti di scala che già altri,
da Adams Smith a Alfred Marshall a Nicolas Kaldor, avevano teorizzato e utilizzato nelle
loro analisi. Un approccio, in ogni modo, da sempre inviso ai neoclassici perché mal si
conciliava con il principio di concorrenza perfetta e più in generale con la loro teoria
dei prezzi.
In questi modelli, la crescita della produttività non ha più origine da un progresso
tecnico endogeno, ma dallo stato interno delle tecnologie utilizzate e dall’organizzazio-
Giuseppe Capuano
38
ne dell’impresa. Situazioni che il modello neoclassico o aveva trascurato o considerato
eccezionali.
Altra spiegazione della riduzione degli squilibri regionali, sempre nel mondo neoclassico, è costituita dai movimenti interregionali dei fattori della produzione verso i territori dove i rendimenti sono più elevati: il lavoro si sposterà verso realtà dove i salari sono
più elevati e il capitale dove i rendimenti sono maggiori. Nei modelli neoclassici della
crescita il livello dei salari sarà alto nelle regioni dove è elevato il rapporto capitale/lavoro, e quindi il rendimento netto sull’investimento in capitali sarà basso. La principale conseguenza è che i fattori della produzione si muoveranno in direzione opposte: afflusso di
lavoro e deflusso di capitali nelle regioni ad alti salari; il contrario nelle regioni a salari
bassi, dove si registrerà un maggiore afflusso di capitale.
Questo aspetto introduce un argomento di estrema attualità che associa il modello
neoclassico con gli effetti del commercio internazionale sulla crescita.
2.1.1 Modello neoclassico e commercio internazionale:
il caso delle delocalizzazioni produttive
Il teorema del pareggiamento dei prezzi dei fattori, affermando che il libero commercio
tenderà a parificare i prezzi dei fattori nelle varie regioni smentisce, almeno parzialmente, quanto assunto dalla teoria neoclassica.
La relazione tra commercio e prezzi dei fattori regionali è importante. In ciascuna
regione, la specializzazione della produzione per l’esportazione provoca un aumento
effettivo della domanda derivata per i fattori in precedenza abbondanti, diminuendo, allo
stesso tempo, quella per i fattori scarsi.
Come risultato, le differenze interregionali nei prezzi dei fattori - anche in assenza
di spostamenti dei fattori stessi - tenderanno a ridursi, ed “il commercio funziona, quindi,
come perfetto sostituito della mobilità fattoriale, poiché esso implica il pareggiamento dei prezzi dei
fattori anche in condizioni di immobilità dei fattori della produzione” (Krauss e Johnson, 1974).
Osservando questo fenomeno da una prospettiva leggermente diversa, una regione con
una abbondante dotazione di lavoro e bassi salari, esporta lavoro sostanzialmente in due
modi: direttamente, tramite il deflusso di questo fattore, ed indirettamente, sotto forma di
servizi lavorativi incorporati nei beni nella cui esportazione si è specializzata la regione.
Il commercio, quindi, agisce come sostituto degli spostamenti, consentendo alle
regioni di utilizzare intensivamente il loro fattore relativamente più abbondante. Ciò
porta a due diversi tipi di beneficio. In primo luogo, i prezzi dei fattori vengono pareggiati in tutte le regioni. In secondo luogo, l’economia nel suo insieme se ne avvantaggia,
poiché commercio e specializzazione sono più efficienti dell’autarchia, e tutte le regioni
ne trarranno beneficio.
Se questo approccio è realistico, i processi di delocalizzazione di fasi o dell’intera produzione da regioni di paesi relativamente ricchi (si veda ad esempio il caso del Veneto o
dell’Emilia Romagna) in regioni di paesi relativamente poveri (si veda ad esempio le
localizzazioni produttive presenti a Timisoara in Romania da parte di imprese trevigiane) sono dettati da una strategia di breve-medio periodo che sarà probabilmente sconfessata nel lungo periodo.
Questo perchè l’introduzione materiale dell’euro, ha eliminato le frontiere tra economia internazionale ed economia regionale nell’Unione europea e nel medio-lungo
periodo, l’integrazione europea riduce le differenze in termini di salari tra le regioni,
enfatizza le specializzazioni produttive locali e i rendimenti crescenti dei fattori della produzione e cambierà la nozione di “spazio”, da non intendersi più come dizione limitata
al territorio dove è localizzata l’azienda (le imprese si deterritorializzano), ma come
ambiente economico più vasto, a volte sovranazionale, da cui deriveranno la crescita
sostenuta e la determinazione del ciclo economico di un’area.
Ne scaturisce un modello di sviluppo europeo con una componente di internazionalizzazione maggiore.Tale componente è centrata non soltanto sul miglioramento della
propensione all’esportazione delle singole regioni, ma su una serena consapevolezza dell’esistenza di una incipiente attività di delocalizzazioni di parti di “distretto” o di fasi di
produzioni aziendali di imprese non distrettuali, da aree più sviluppate o comunque a sviluppo industriale avanzato, verso realtà dell’Est Europa a più bassi salari. Da un punto di
vista teorico, la “fase di delocalizzazione” potrebbe essere collocata, in relazione al distretto, come successiva alla “fase di maturità” nel ciclo di vita del distretto marshalliano20.
Questi avvenimenti hanno anche cambiato l’approccio teorico di riferimento utile a
spiegare il perchè degli scambi internazionali (ormai regionali) in Europa, rendendo superato il modello ricardiano dei vantaggi comparati (al centro dell’analisi sono poste le differenze di produttività del lavoro e quindi dei salari) e, più in generale, l’approccio neoclassico.
Molto spesso l’esplorazione dei mercati esteri attraverso le esportazioni ha rappresentato per le imprese italiane una prima fase dell’approccio ai nuovi mercati, che successivamente si è sviluppata, in alcuni casi, in investimenti diretti all’estero o in varie iniziative di internazionalizzazione. Infatti, se dai primi anni novanta si è assistito, da un lato,
ad un brusco rallentamento della crescita multinazionale dell’industria italiana, dall’altro,
Introduzione alle principali teorie dello sviluppo regionale
I fattori dello sviluppo regionale
39
20
Per “distretto marshalliano” si intende la capacità
di un territorio di coniugare economia e società nell’ambito di un ambiente
caratterizzato da processi
di agglomerazione di imprese, spesso di piccole e
medie dimensioni, con
specializzazione monosettoriale, nel quale hanno un ruolo importante le
economie esterne o più in
generale le esternalità.
Giuseppe Capuano
40
21
Essa è anche chiamata
“traffico di perfezionamento passivo”, in quanto le imprese grazie allo
sfruttamento di un particolare regime di tariffe
doganali, trasferiscono
fasi di produzione all’estero, reimportando i semilavorati, rifinendo il
prodotto in Italia.
è andato aumentando il numero di investitori italiani all’estero secondo un processo
delocalizzativo.
In particolare, il processo di internazionalizzazione produttiva ha riguardato sempre
più le PMI, polarizzandosi verso i settori con maggiori vantaggi competitivi (tessile, abbigliamento, cuoio, pelletteria, calzature e prodotti in legno), la meccanica strumentale e
l’alta tecnologia.
Il sistema produttivo italiano inserito in questo scenario dinamico, deve essere pronto a conquistare nuovi mercati e ad accrescere la propria competitività anche attraverso
una riorganizzazione della catena del valore sul territorio.
La crescente tendenza all’innovazione e l’evoluzione della società dell’informazione, ha
consentito anche al sistema di piccole e medie imprese di rispondere ai cambiamenti imposti dalla globalizzazione, sfruttando le opportunità legate alla presenza diretta all’estero e
all’ampliamento delle potenzialità produttive e commerciali che da essa scaturiscono.
In generale, la delocalizzazione della filiera produttiva può conseguire i suoi obiettivi attraverso joint venture, accordi di fornitura di lungo periodo21 e acquisizioni o creazione in loco di unità produttive. Quest’ultima tipologia di IDE si può definire “labour
(resource) seeking”.
Se quanto detto è vero, e comunque considerando la delocalizzazione di attività produttive una “normale” strategia aziendale da non demonizzare e comunque perseguita da
tempo dai grandi gruppi industriali italiani, va fatta qualche precisazione.
Il problema della competitività del tessuto produttivo locale e/o del distretto, trova
solo parziale soluzione con delocalizzazioni che hanno queste caratteristiche, in quanto
non sempre a bassi salari corrispondono livelli di produttività soddisfacenti (in genere, in
paesi a bassi salari con livello di sviluppo inferiore, la produttività media è inferiore rispetto ai paesi economicamente più avanzati) ne è possibile ricreare e realizzare in loco tutte
quelle attività e quel “microclima” tipico del territorio distrettuale di origine (ad esempio la creazione di network locali).
In effetti, le scelte localizzative dovrebbero essere pensate in termini soprattutto di
produttività complessiva dell’investimento realizzato e del potenziale mercato di sbocco,
in quanto un’analisi costi-benefici centrata solo sul costo della manodopera può essere
valida nel breve periodo ma presentarsi fallimentare in quello medio-lungo.
Inoltre, la delocalizzazione comporta una riorganizzazione della “rete” nella nuova
area prescelta, in quanto essa dovrà ricreare e realizzare in parte o in toto tutte quelle
attività e quel “microclima” tipico del territorio distrettuale di origine.
Alla luce di queste brevi considerazioni, si arriva alla conclusione che non per tutti i
Introduzione alle principali teorie dello sviluppo regionale
I fattori dello sviluppo regionale
settori merceologici la competitività può essere individuata prevalentemente nei costi
relativi al fattore lavoro ne è possibile ricreare ovunque le medesime condizioni tipiche
delle economie di agglomerazione presenti soprattutto in un distretto.
Comunque, sembrerebbe che una simile strategia trovi la sua migliore applicazione
nei settori labour intensive e/o con alta elasticità della domanda nei confronti del prezzo.
In prospettiva, in ogni caso, anche per questi settori, in base al “teorema del pareggio dei
prezzi dei fattori” dovuto al commercio interregionale, a nostro avviso lo scenario di riferimento cambierà.
Infatti, il vantaggio assoluto dei livelli salariali nei Paesi dell’Est tenderà a
ridursi/scomparire a causa di un aumento della domanda di manodopera dall’area comunitaria, dei movimenti dei lavoratori “in entrata” nell’Ue, e soprattutto grazie al graduale ingresso, dal 2004, di questi Paesi nell’Unione europea, che li costringerà a seguire una
politica economica più vicina al dettato di Maastricht.
A questo proposito l’esempio della Repubblica Ceca è emblematico, dove salari e costi
di produzione, dal 2001, seguono un trend al rialzo, soprattutto nelle aziende a capitale
straniero. Ciò che è avvenuto nella Repubblica Ceca è solo una incipiente fase di un processo piu’ complesso. In un primo momento si porrà in essere un modello dualistico dove
i salari saranno più elevati nelle imprese a capitale straniero rivolte prevalentemente all’export; al contrario, i salari saranno più bassi nelle imprese locali proiettate soprattutto sul
mercato domestico. Nel medio – lungo periodo, per un effetto “dimostrazione”, i salari
del secondo gruppo di imprese tenderanno ad eguagliare il livello salariale del primo
gruppo, con l’effetto di un generalizzato aumento del monte salari dell’economia.22 Questi
processi e la loro gestione rappresenteranno una ulteriore sfida per le prospettive di crescita delle imprese a capacità produttiva in parte o totalmente delocalizzata e per avere successo, le iniziative imprenditoriali dovranno avere necessariamente una visione rivolta ai
mercati di sbocco e non solo ad una mera ricerca di manodopera a basso costo.
41
2.2 Lo sviluppo esogeno trainato dalle esportazioni
I modelli regionali di crescita basati sull’effetto trainante delle esportazioni (export-led
growth) rifiutano le spiegazioni fornite dal modello neoclassico, dando una particolare
importanza alle componenti della domanda secondo l’insegnamento keynesiano. Le evidenti carenze del modello neoclassico basato prettamente sui fattori dell’offerta e del pro-
22
Su questo argomento: A.
Graziani (1979) (a cura di),
L’economia italiana dal
1945 a oggi, il Mulino,
Bologna, pag. 225 – 262.
Giuseppe Capuano
42
gresso tecnico, sono colmate secondo questi economisti dal fatto che le regioni possono
commerciare tra di loro e che proprio la differenza tra la propensione ad esportare di una
regione rispetto ad un’altra determina i differenziali di crescita tra una realtà e l’altra.
I modelli della base economica furono tra i primi modelli formali per la determinazione del reddito regionale collegati ad un settore di base che ha come principale mercato di sbocco le vendite ad altre regioni. Il reddito prodotto da questo settore, come si
vedrà, secondo il modello, determinerà il reddito totale della regione che a sua volta condiziona l’andamento del reddito percepito dal settore non di base (proiettato sul mercato
locale). Ampliando l’approccio potremmo individuare in questo modello uno dei primi a
considerare le vendite extraregionali e quindi le esportazioni, un volano della crescita.
A questo seguirono altri approcci come quello della “base delle esportazioni” che,
partendo dal principio che lo stimolo iniziale allo sviluppo regionale può essere individuato nelle esportazioni di materie prime, fu esteso successivamente al commercio dei
prodotti industriali.
Molti limiti sono stati attribuiti a tali teorie in quanto l’influenza della domanda estera sulla crescita di una regione dipende da tanti altri fattori, sia dal lato della domanda (ad
esempio il livello del reddito dei paesi/regioni importatrici) che dell’offerta (ad esempio
tutti quei fattori che determinano la competitività di un regione sui mercati esteri).
Un’interessante evoluzione di tali teorie fu dovuta prima a Kaldor (1970) e poi a
Dixon e Thirlwall (1975) che collegarono le esportazioni regionali con il processo di causalità cumulativa. In pratica, il processo di crescita creato dalle esportazioni può generare
un processo cumulativo.
In particolare, secondo Kaldor la rapidità con la quale si determina la crescita della
produzione pro capite di una regione viene spiegata soprattutto dalla capacità di quest’ultima di sfruttare le economie di scala e nei benefici dettati da una più intensa specializzazione, in particolare nel settore manifatturiero rispetto a specializzazioni “landbased” come l’agricoltura o il settore minerario.
Le regioni con queste caratteristiche cresceranno più rapidamente secondo un processo di tipo cumulativo che le renderà più concorrenziali rispetto ad altre, rinforzando
la propria specializzazione grazie all’espansione delle proprie esportazioni.
Dixon e Thirlwall specificano quanto già intuito da Kaldor spiegando in modo rigoroso i meccanismi che determinano il processo di causazione cumulativa tenendo conto
di un effetto di ritorno che lo sviluppo regionale ha sulla competitività e quindi dei volumi di prodotti esportati. Il circolo virtuoso che lega competitività-esportazioni-produzione-produttività-crescita permette agli autori di legare il proprio approccio a quello
dettato dalla Legge di Verdoorn (1949) secondo la quale “la crescita della produttività è in
parte determinata dalla crescita della produzione”.
A tal proposito, un altro elemento può essere aggiunto al circolo virtuoso quale la
densità di impresa, in quanto, a nostro avviso, la presenza di una fitta rete di unità produttive presenti sul territorio favorisce la capacità di esportare del sistema produttivo.
Infatti, da una verifica empirica, incrociando il dato provinciale della propensione all’export con quello della densità di impresa, è evidente come le realtà che esportano di più
in termini di PIL sono, spesso, anche quelle con i valori di impresa più elevati.
Da un punto di vista macroeconomico, invece, ci sono alcune attinenze tra il modello di sviluppo in questione e quello seguito in Italia dalla seconda metà degli anni cinquanta. Infatti, l’Italia, ed in particolare le regioni del Nord Ovest (il cosiddetto “triangolo industriale”) secondo alcuni economisti (Ackley, 1961) ha conosciuto il boom economico nel periodo 1958-1963 grazie ad un meccanismo di questo genere. Inoltre, la
relativa arretratezza di molte realtà del nostro Mezzogiorno, è addebitata proprio ad una
bassa propensione all’export , come lo sviluppo di molti distretti industriali italiani è attribuito al dinamismo conosciuto dalla componente estera. Non è un caso che le realtà provinciali a maggiore presenza distrettuale sono anche quelle a più alta intensità di imprese, con una maggiore propensione ad esportare e, quindi, con un più elevato valore del
PIL pro capite.
In sintesi, partendo dall’assunto della causazione cumulativa, arricchendolo con
nostre considerazioni, si potrebbe arrivare alla seguente conclusione dimostrata dai dati
presenti nella tab. 1:
la crescita della produttività è in parte determinata dalla crescita della produzione che
beneficia degli effetti della componente estera della domanda aggregata. Quest’ultima è
tanto più importante quanto maggiore è la presenza di uno spesso tessuto di impresa
organizzato “in distretti” o comunque dove le relazioni sono fitte sul territorio. Il risultato è un tasso di crescita e un valore del PIL pro capite più elevato.
Introduzione alle principali teorie dello sviluppo regionale
I fattori dello sviluppo regionale
43
Giuseppe Capuano
Tab. 1 - Graduatoria delle province italiane per grado di propensione all’export (2002)
Pos
44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Prov.
Propensione
Vicenza
Gorizia
Prato
Reggio E.
Arezzo
Pordenone
Modena
Chieti
Treviso
Siracusa
Como
Mantova
Novara
Vercelli
Bergamo
Biella
Lecco
Varese
Lucca
Verona
Belluno
Ancona
Cuneo
Milano
Udine
Bologna
Parma
Torino
Brescia
Frosinone
Padova
Rieti
Pistoia
Alessandria
Massa Carrara
56,8
54,9
48,2
46,1
46,0
45,4
44,8
43,0
42,5
42,3
39,5
39,5
38,8
36,8
36,2
35,9
35,6
34,1
32,9
32,6
32,4
32,1
31,1
30,8
29,4
29,1
28,6
28,3
28,2
27,8
27,8
27,7
27,7
27,7
27,5
Pos
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Prov.
Propensione
Ascoli Piceno
Firenze
Pesaro e Urbino
Venezia
Pisa
Latina
Pavia
Macerata
L’Aquila
Forlì
Terni
Isernia
Teramo
Asti
Ravenna
Piacenza
Ferrara
Cremona
Siena
Trieste
Potenza
Lodi
Trento
Bolzano
Rovigo
Rimini
Verbania
Cagliari
Bari
Livorno
Aosta
Matera
Savona
Taranto
Sondrio
Fonte: elaborazione propria su dati Istituto G.Tagliacarne-ISTAT
27,1
25,3
24,3
24,3
24,2
24,1
23,9
23,7
23,4
23,0
22,8
21,5
21,5
21,5
21,1
20,4
19,9
19,8
19,8
18,4
18,1
17,7
17,2
16,5
16,0
15,6
15,4
14,4
14,2
13,6
12,7
12,3
11,9
11,8
11,8
Pos
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Prov.
Propensione
Avellino
Perugia
Genova
Napoli
Brindisi
Salerno
Caserta
Imperia
Lecce
La Spezia
Caltanissetta
Pescara
Catania
Roma
Viterbo
Campobasso
Sassari
Foggia
Ragusa
Grosseto
Messina
Trapani
Palermo
Oristano
Benevento
Nuoro
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Agrigento
Crotone
Cosenza
Enna
Catanzaro
11,7
11,7
11,3
11,3
10,6
10,1
9,2
8,4
7,9
7,8
7,8
7,6
6,4
6,4
5,9
5,7
4,5
4,5
4,1
4,0
3,9
3,6
2,8
2,3
2,1
2,1
2,1
1,5
1,4
1,3
0,8
0,7
0,6
ITALIA
22,5
IL
MOLTIPLICATORE DELLA BASE ECONOMICA
Al fine di ottenere il moltiplicatore della base economica si scompone il reddito totale della regione in due componenti:
T=S+B
dove:
T = reddito regionale totale
S = reddito percepito nel settore non di base (che “serve” la regione)
B = reddito percepito nel settore di base
S = sT
Dove
unendo le equazioni 1 e 2 otteniamo:
T = (1 / 1 - s) * B
Introduzione alle principali teorie dello sviluppo regionale
I fattori dello sviluppo regionale
dove 1 / (1 - s) è il moltiplicatore della base economica
ESPORTAZIONI
E CRESCITA CUMULATIVA
Il modello viene esposto formalmente attraverso quattro relazioni funzionali:
1) crescita del volume della produzione e crescita della produttività;
2) aumento dei costi di produzione e tasso di inflazione;
3) crescita delle esportazioni dipende dal tasso di inflazione dei prezzi della regione,
dal tasso di inflazione dei principali concorrenti e dalla crescita mondiale;
4) crescita del volume della produzione con la crescita delle esportazioni.
1)
dove:
45
Giuseppe Capuano
2)
dove:
46
3)
dove:
η e σ rappresentano l’elasticità della domanda rispetto ai prezzi, e ε quella rispetto
al reddito;
4)
dove:
Possiamo ottenere il tasso di equilibrio della crescita del volume della produzione
sostituendo le equazioni 1, 2 e 3 nella 4, e risolvendo per
. Questo ci dà:
I fattori dello sviluppo regionale
2.3 La teoria di Heckscher-Ohlin
Un paese ha un vantaggio comparato negli scambi internazionali nella produzione di
quei prodotti per i quali, relativamente ad altri, ha una maggiore disponibilità di risorse
produttive, in quanto il lavoro non è l’unico fattore della produzione. Una spiegazione,
quest’ultima, più realistica dei processi economici che assegna anche ad altri fattori della
produzione un ruolo da svolgere. Questo è il principio sul quale si basa la teoria sviluppata da Eli Heckscher nel 1919 e successivamente riproposta da Bertil Ohlin (1933)23
nota in letteratura come il teorema di Heckscher-Ohlin. Secondo i due economisti svedesi,
il commercio internazionale è in larga misura determinato dalle differenze nelle dotazioni di risorse e poiché questa teoria mostra l’importanza dell’interazione tra le proporzioni in cui i fattori produttivi sono disponibili nelle diverse economie nazionali e la
proporzione in cui essi sono utilizzati nei diversi settori, spesso si definisce come teoria
della proporzione dei fattori.
La teoria non solo perfeziona, mediante l’introduzione di altri fattori della produzione, come ad esempio il capitale, la spiegazione data da Ricardo alle cause del commercio internazionale24, ma tenta anche di dare una concisa esplicitazione delle cause del
vantaggio comparato.
Non è possibile applicare meccanicamente questa teoria per spiegare le cause del
commercio interregionale, anche se essa, come vedremo, costituisce un importante punto
di partenza per gli economisti che hanno intrapreso un percorso di verifica sia teorica
che empirica. Dal momento che le regioni hanno relazioni commerciali con il resto del
mondo, le variabili che influenzano i flussi commerciali internazionali sono evidentemente importanti anche per esse e quindi, le teorie che ne spiegano le cause, sono ragionevolmente applicabili, oltre alla componente internazionale del commercio, anche a
quella interregionale di una regione.
Il commercio interregionale è molto più libero per innumerevoli e intuibili motivi
del commercio internazionale e le cause che ne determinano la specializzazione non
sono certamente riconducibili ad una unica spiegazione.
La versione più semplice del teorema di Heckscher-Ohlin afferma che esistono
solo due fattori della produzione, il lavoro e il capitale. La causa di fondo del vantaggio comparato è data dalla dotazione iniziale di lavoro e capitale di ogni regione.
Secondo questo ragionamento, una regione dotata della risorsa lavoro si specializzerà
in prodotti labour intensive (ad esempio nel settore tessile) o viceversa, se dotata di capitale si specializzerà in attività capital intensive (ad esempio nella produzione dell’acciaio).
23
Ancora oggi questa teoria desta un forte interesse ed è una delle più importanti dell’economia
internazionale. Essa da
una visione complessa e
articolata del commercio
internazionale che contrasta con i modelli matematici più rigorosi e semplificati che la seguirono.
24
Secondo il modello ricardiano dei vantaggi comparati (David Ricardo
(1817), Sui principi dell’economia politica e della
tassazione) il lavoro è il
solo fattore di produzione e il vantaggio comparato si può determinare
solo per effetto di differenze internazionali nella
produttività del lavoro.
Queste ultime, pur importanti nello spiegare le
cause del commercio internazionale, non sono
esaustive in quanto, quest’ultimo, è anche determinato da differenze nella dotazione di risorse di
ogni paese.
Giuseppe Capuano
48
25
Il commercio regionale e
lo spostamento dei fattori sono collegati tra loro
anche per quanto prevede il teorema del pareggiamento dei prezzi dei
fattori. A tal proposito si
veda il par.2.1.1.
L’ipotesi che esistono solo due fattori della produzione, oltre a non rispondere alla
realtà, non corrisponde al lavoro iniziale di Heckscher-Ohlin, in quanto l’importanza
delle risorse naturali per il processo produttivo è evidente. Inoltre, noi aggiungiamo
anche il fattore ”territorio” inteso non solo come elemento fisico ma come l’insieme
di attività, relazioni, come ambiente economico favorevole all’attività economica di
una determinata regione. Esso influenza fortemente lo sviluppo di specializzazioni produttive di una determinata area.
Una ulteriore ipotesi del teorema di Heckscher-Ohlin che deve essere abbandonata
è quella relativa ai rendimenti costanti. A livello regionale tale ipotesi è estremamente
irrealistica. Pur se non vi sono economie interne di impianto, da tempo si è riconosciuta l’esistenza di economie esterne e di agglomerazione che influenzano l’attività produttiva in alcune aree e ne favoriscono la localizzazione (ad esempio aree densamente popolate o a forte presenza di localizzazioni industriali).
Un’altra importante ipotesi posta dal teorema di Heckscher-Ohlin riguarda l’assenza di mobilità fattoriale tra le varie regioni.
Se l’aggiunta delle risorse naturali ai fattori capitale e lavoro ha migliorato il
modello di base ed è comunque stata abbastanza agevole, abbandonare l’ipotesi di
assenza di mobilità fattoriale in modo da rendere il modello più realistico non è altrettanto facile.
Il fattore fondamentale che nel teorema determina il vantaggio comparato è l’abbondanza locale di lavoro o di capitale. Se questi ultimi possono essere alimentati da
un afflusso dei fattori o ridotti da un loro deflusso, il risultato è che la teoria non può
più prevedere quali sono i prodotti per i quali una regione mantiene un vantaggio
comparato.
Quindi, se i fattori possono circolare liberamente la teoria di Heckscher-Ohlin viene
a cadere25. E proprio questa potrebbe essere la ragione per cui tale teoria non è riuscita
a prevedere la specializzazione commerciale all’interno del Regno Unito (Smith,1975)
oppure le specializzazioni produttive dei distretti italiani, dove la distanza tra una area e
l’altra è relativamente piccola - se paragonata, ad esempio, con la situazione degli Usa.
In conclusione, il semplice teorema a due fattori di Heckscher-Ohlin sostiene che il
nocciolo della specializzazione regionale consiste nell’abbondanza locale di fattori. Le
dettagliate verifiche empiriche condotte su questa teoria indicano che il teorema di
Heckscher-Ohlin non fornisce, di per sé, una spiegazione adeguata. In considerazione di
ciò, gli studiosi si sono rivolti allo sviluppo di spiegazioni alternative più radicali che
esporremo in sintesi nel paragrafo successivo.
2.3.1 Verso il superamento del teorema di Heckscher-Ohlin
Alcune versioni più complesse e articolate del teorema di Heckscher-Ohlin, soprattutto quelle che tengono conto delle risorse naturali e del capitale umano come fattori
addizionali, possono sicuramente spiegare meglio il contesto economico nel quale vengono a formarsi le specializzazioni produttive delle regioni.
Tali versioni, in ogni modo, non sono da sole sufficienti, in quanto una visione più
completa delle dinamiche e le cause che caratterizzano il commercio interregionale
richiede uno sforzo aggiuntivo che non sia il semplice abbandono di alcune delle ipotesi meno realistiche del teorema di Heckscher-Ohlin.
In questa sede esamineremo brevemente cinque tesi alternative.
Le prime due, ossia la teoria del divario tecnologico di Posner (1961) e la teoria del ciclo
del prodotto di Vernon (1966), sono molto simili, in quanto entrambe evidenziano l’importanza del ruolo svolto dall’innovazione e dal progresso tecnico.
Le spiegazioni che traggono origine dalla teoria della localizzazione industriale (terza
teoria di Hay 1979; Harrigan 1982), poi, sono molto diverse dal teorema di HeckscherOhlin. Inoltre, esiste la possibilità che il commercio interregionale abbia le stesse peculiarità degli scambi “infrasettoriali” che caratterizzano il commercio internazionale (quarta teoria di Grubel e Lloyd 1973).
Iniziamo con la teoria del divario tecnologico. Essa sostiene che “una regione in grado di
dar vita ad un ampio flusso di nuovi prodotti ed innovazioni ne trarrà un vantaggio per
la produzione dei prodotti stessi”.
Vantaggio che non potrà essere permanente, anche se è possibile che ci sarà un ritardo temporale prima che le altre regioni possano produrre il medesimo prodotto.
Nello stesso filone di pensiero della teoria del divario tecnologico si può collocare la
teoria del ciclo del prodotto di Vernon. Comunque simile, ma non identica.Tale teoria sostiene che alcune regioni possono costituire, ad un certo stadio del ciclo di vita di un prodotto, la localizzazione migliore per la sua produzione, mentre in stadi successivi altre
regioni potrebbero risultare preferibili.
A tal proposito sono stati identificati tre stadi. Nel primo stadio, quello innovativo, è
la regione che è più capace di fornire i necessari input di ricerca e sviluppo ad alto livello e di manodopera altamente specializzata che monopolizzerà la produzione;
Introduzione alle principali teorie dello sviluppo regionale
I fattori dello sviluppo regionale
49
Giuseppe Capuano
Nel secondo stadio, il prodotto diviene più standardizzato, e si cominciano ad introdurre le tecniche di produzione di massa;
50
Nell’ultimo stadio, quello di maturazione, le regioni dove i salari sono più bassi e con
abbondanza di manodopera semispecializzata, risultano avvantaggiate per la produzione
di massa del prodotto ormai altamente standardizzato.
Un terzo filone per la spiegazione della specializzazione del commercio regionale si
basa sull’analisi della localizzazione industriale. Un’analisi particolarmente interessante, dato
che pone in evidenza alcune variabili, trascurate dal teorema di Heckscher-Ohlin, che
influenzano la specializzazione produttiva regionale.
La teoria tradizionale della localizzazione, ad esempio, sostiene che l’insediamento
delle attività industriali avverrà nei luoghi dove i costi di produzione sono minori (costi
di trasporto, non presi in considerazione dal teorema di Heckscher-Ohlin, e della manodopera).
I costi di localizzazione, inoltre, sono fortemente condizionati dalle economie esterne di scala e di agglomerazione. Anche in questo caso aspetti trascurati dal teorema di
Heckscher-Ohlin, nonostante la loro potenziale importanza per la spiegazione della specializzazione regionale.
Un quarto approccio è determinato dal fenomeno del commercio infrasettoriale che ha
attirato negli ultimi anni molta attenzione.
Le teorie del commercio internazionale finora esaminate, supponevano che ogni
regione si concentrasse sui propri prodotti caratteristici, che esportavano in cambio di
prodotti diversi. Cosa vera ma incompleta, in quanto, tra le regioni, riveste una notevole
importanza anche il commercio infrasettoriale.
Ultimo, ma non meno importante, è il commercio di beni intermedi. Spesso trascurato
dalla ricerca a livello regionale. Le teorie della localizzazione partono dal principio che
le economie regionali si specializzino in prodotti, e quindi, in tutti gli stadi della loro produzione. Ciò rappresenta una parte della realtà se consideriamo che anche la specializzazione per stadi di produzione è molto diffusa.
Introduzione alle principali teorie dello sviluppo regionale
I fattori dello sviluppo regionale
2.4 L’approccio input-output nei modelli di economia regionale26
La predisposizione di una particolareggiata analisi dei legami input-output (tra settori produttivi) esistenti all’interno di una regione rappresenta uno strumento alternativo
alla costruzione di modelli di economie regionali.
L’approccio input-output è stato sviluppato da Leontief negli anni ‘30, con notevole
successo applicativo, inclusa l’analisi dell’impatto regionale.
La rete di legami “input-output” presenti in una economia (regionale/nazionale) può
essere formalizzata e costituire una chiara fotografia mediante la costruzione di una
Tavola delle transazioni (o matrice dei flussi). In essa si registrano le connessioni tra i vari
settori produttivi e quindi, tutti i flussi produttivi che si verificano all’interno dell’economia regionale durante un determinato periodo (generalmente un anno).
La costruzione di una tavola input-output per l’economia regionale non si limita ad
avere come obiettivo, pur importante, la descrizione dei flussi input-output, in quanto,
dopo aver quantificato le relazioni settoriali, è possibile valutare l’effetto sull’intero sistema di qualsiasi variazione si verifichi nella domanda finale.
La tecnologia produttiva è a “coefficienti tecnici fissi” (a volte nota come tecnologia
di Leontief). Ciò significa che l’industria J, per poter raddoppiare la sua produzione (output), dovrebbe raddoppiare i fattori della produzione impiegati (input).
La relazione tra output e input rimane costante nel tempo per il quale ogni previsione viene formulata:
51
flusso di output dal settore i al settore j, intendendo i come riga e j come colonna;
Dall’equazione si evince che il flusso di output dal settore i al settore j costituisce una
proporzione fissa del prodotto lordo del settore j. Se il prodotto lordo del settore j
aumenta di 1 unità, vi è allora bisogno di aij input extra dal settore i. Il coefficiente aij si
ottiene dalla tavola delle transazioni semplicemente dividendo xij per xj.
26
A tal proposito: Leontief,
W. (1953); Leontief, W.
(1956).
Giuseppe Capuano
2.5 La teoria Weberiana della localizzazione
52
Il principale obiettivo della teoria di Weber (1909) della localizzazione è il superamento dell’ipotesi di territorio omogeneo (come visto nel Cap 1 essa è presente nei
modelli macroeconomici regionali, sia di tipo neoclassico che Keynesiano) e introduce il
concetto di regione nodale. La conseguenza di tale approccio è quello di considerare il
territorio come eterogeneo all’interno di un contesto regionale più vasto.
La teoria weberiana inserisce nell’analisi della localizzazione l’importante ruolo svolto dall’agglomerazione (diffusione sul territorio delle attività produttive) e della distanza
misurata sulla base degli spostamenti, considerando la collocazione delle imprese in relazione ai costi di trasporto e del peso di localizzazione. Il calcolo del costo di trasporto
viene introdotto attraverso la stima delle isopadane.
Per isopadana si intende una curva che esprime uguali costi di trasporto. Supponendo
che il trasporto sia possibile in tutte le direzioni, si otterranno curve di costi di trasporto
concentriche.
Il centro della curva rappresenterà il luogo dove il costo di trasporto è minimo.
L’isopadana sarà definita “critica” se identifica il luogo geometrico delle curve a minor
costi di trasporto.
Ciò significa che non è possibile individuare un punto avente un costo di trasporto
minimo al di fuori di quella isopadana, in quanto, in caso contrario, l’impresa preferirà
un’altra localizzazione.
I costi dello spostamento sono pari al prodotto tra peso di localizzazione (del totale
delle merci), distanza dello spostamento e costo unitario di trasporto.
Ci sarà convenienza alla delocalizzazione se:
A > Ldt
dove:
A= vantaggio in termini di economia di agglomerazione;
L d e t = peso di localizzazione, distanza dello spostamento e costo unitario di trasporto.
2.5.1 La teoria delle zone centrali
La teoria della localizzazione trascurava, evidentemente, il ruolo dei servizi in una
economia moderna. La teoria delle zone centrali, in considerazione della crescente
importanza del settore dei servizi nella formazione del PIL e, più in generale, della vita
economica, arricchisce il dibattito teorico cercando di colmare una lacuna. Infatti, pur
esaminando il problema della localizzazione delle attività economiche, la teoria poneva
al centro della riflessione la localizzazione delle attività terziarie con una considerazione
del mercato più marcata di quanto rilevasse la teoria weberiana.
La definizione di località centrali si riferisce al luogo dove si forniscono una vasta
gamma di beni e servizi alla popolazione del suo entroterra (regione complementare),
che esprime quella domanda.
Gli elementi chiave della teoria sono la soglia della domanda (livello minimo per quantificare l’offerta di un servizio) e la sua entità (ambito territoriale entro il quale il servizio
viene offerto). Partendo da questi due elementi è possibile definire l’area che caratterizza la zona d’influenza di un’impresa rappresentata da una forma esagonale. Quest’ultima
è la figura geometrica più indicata per delimitare il mercato di riferimento, in quanto
consente la massima agglomerazione delle aree, in coerenza con l’esigenza di minimizzare i costi di trasporto.
Inoltre, partendo dalla considerazione che non tutti i servizi sono uguali e non
rispondono alla medesima domanda, si introduce il concetto di “rango dei servizi offerti” (ad esempio i servizi di rango superiore o rari). Si definisce, quindi, una “gerarchia dei
centri” in cui sono offerti questi beni e servizi.
Seguendo l’approccio di W. Christaller (1933) la ripartizione gerarchica delle località si
realizza in modo che una zona che offre beni e servizi di livello gerarchico superiore, fornisce anche tutti quelli dei livelli gerarchici inferiori.
I punti centrali della teoria sono sostanzialmente due:
❏ esiste una relazione stabile tra la popolazione di una zona centrale e quella dell’a-
rea di mercato che la zona centrale serve;
❏ l’ampiezza del centro, quanto quella della popolazione da esso servita, aumenterà
al crescere del livello gerarchico, in coerenza con l’aumento delle funzioni del
centro all’aumentare del livello gerarchico del centro stesso.
Tali aspetti rappresentano un punto di debolezza della teoria, dandogli scarsa flessibilità.
Introduzione alle principali teorie dello sviluppo regionale
I fattori dello sviluppo regionale
53
Giuseppe Capuano
54
27
A questo proposito il richiamo al circuito della
causazione circolare cumulativa è evidente.
In risposta ai limiti dell’approccio di Christaller e la fine di introdurre una maggiore flessibilità nel modello delle località centrali,A. Lösch (1954) ha sviluppato la teoria delle
località centrali.
Egli sostiene che il rapporto tra i ranghi delle diverse località non è fisso e definito,
ma esiste la possibilità di sviluppo di centri e di aree con dimensioni molto diverse a
seconda dell’offerta di beni e servizi. Nel modello viene meno anche il principio che i
centri di ordine superiore forniscono tutti i servizi di rango inferiore con la possibilità di
specializzazioni di centri con diverso ordine gerarchico. Emerge la possibilità di identificare un sistema di centri urbani specializzati.
L’impostazione dei due modelli, comunque, ha un importante limite: essi considerano la ripartizione della popolazione in modo omogeneo sul territorio, senza rilevare nessuna differenza. Ciò, ovviamente, non si verifica nella realtà, e poiché dalla numerosità
della popolazione dipende l’ampiezza del mercato (quindi la dimensione degli esagoni)
occorre un correttivo che successivamente sarà introdotto da Isard (1956).
Egli introduce il concetto di differenziazione della dimensione degli esagoni in ragione della diversa distribuzione spaziale della popolazione e dei mercati di riferimento. In
questo modo il modello delle località centrali può meglio comprendere le dinamiche
dello sviluppo urbano.
In tutti i modelli esposti brevemente in precedenza non si assegna al mercato un
ruolo determinante, se non marginalmente come nella teoria delle località centrali.
Il modello centro-periferia di Krugman (1995), al contrario, cerca di colmare questa
lacuna. Infatti, pur considerando l’importanza dei vantaggi localizzativi, il modello, partendo proprio dalle caratteristiche del mercato, spiega la localizzazione delle imprese in
un determinato territorio come un problema che favorisce un percorso cumulativo di
diversificazione dello sviluppo regionale27.
Il modello centro-periferia, infatti, spiega la concentrazione o i deflussi di attività economiche e, più in generale, dei fattori produttivi, da e verso alcune aree geografiche
coniugando alcuni aspetti localizzativi con quelli dello sviluppo delle attività produttive.
Krugman, inoltre, arricchendo l’impianto teorico, inserisce alcuni elementi trascurati dalle tradizionali teorie della localizzazione:
❏ non c’è un unico percorso di localizzazione;
❏ la funzione di equilibrio è legata al ruolo svolto da particolari circostanze stori-
che.
Introduzione alle principali teorie dello sviluppo regionale
I fattori dello sviluppo regionale
Secondo questo Autore la localizzazione geografica di attività produttive è favorita da
tre fattori principali: la presenza di economie di scala elevate; costi di trasporto bassi; ed
infine, un quota elevata della produzione non fissa sul territorio come nel caso dell’industria manifatturiera. La presenza di queste tre condizione favorisce il formarsi di un
circolo virtuoso che si autoalimenterà e che porterà ad una maggiore concentrazione
delle attività produttive in luoghi dove la domanda è più elevata che a sua volta si autoalimenterà grazie alla stessa maggiore concentrazione di imprese.
Il modello, comunque, non spiega le cause dell’inizio di un simile processo, che
potrebbe essere attribuito ad un caso della storia o alle aspettative che un simile fenomeno genera.
La teoria introduce, da un punto di vista formale una doppia modellistica, la pr ima
macro (come una struttura del tipo nucleo-periferia possa emergere su scala nazionale),
la seconda micro (sono considerati gli aspetti di localizzazione delle attività economiche) e prevede la possibilità di path-dependence28 con possibili percorsi di crescita divergenti tra loro.
Qualche riflessione aggiuntiva merita un simile approccio, soprattutto a seguito delle
trasformazioni in atto dovute alla globalizzazione. Castells (1996) sostiene che l’economia globale non è simmetrica ma si muove per linee asimmetriche, superando una chiave di lettura centro-periferia dei fenomeni economici.
Una geografia economica che supera, anche in Italia, il concetto Nord-Sud, se è vero
che, come nelle regioni settentrionali esistono fenomeni di declino industriale ovvero di
riconversione produttiva, in alcune realtà del nostro Mezzogiorno, si individuano luoghi
di eccellenza o sistemi produttivi locali estremamente interessanti dal punto di vista del
livello di sviluppo raggiunto.
Quindi, anche la realtà italiana si presenta territorialmente policentrica e diffusa, con
caratteristiche da economia matura. Da qui, la conclusione che ragionare in termini
esclusivamente dicotomici (sviluppato-sottosviluppato; centro-periferia; aree costierearee interne, etc.) per spiegare le traiettorie dello sviluppo, può essere oggi limitativo e
poco calzante rispetto alle reali caratteristiche di molte economie regionali.
55
28
Per path-dependence si
intende la condizione data dal confronto tra alternative diverse, quando la
scelta dipende dall’ordine in cui le alternative sono state considerate.
CAPITOLO
3
I processi
di convergenza
e divergenza
tra le province
italiane:
il modello della
convergenza
non lineare
L
3.1 Il dibattito teorico
3.1.1 La critica all’approccio marginalista
a teoria marginalista ipotizza che le forze del mercato si trovino tendenzialmente in equilibrio, in una situazione di concorrenza perfetta in cui non esistono asimmetrie informative (l’informazione sui mercati è ampiamente diffusa tra i soggetti economici), e in un contesto di assoluta mobilità e sostituibilità dei fattori della produzione (capitale e lavoro).
Inoltre, la funzione di produzione è caratterizzata da rendimenti di scala costanti, rendimenti marginali decrescenti del capitale e del lavoro, con un tasso costante e predeterminato di crescita della produttività, e da un progresso tecnico “free good” esogenamente dato29.
Ciò porta alla conclusione, se tale ipotesi è verificata, che Paesi o regioni con uguali tecnologie e con la medesima propensione al risparmio creino dei meccanismi “automatici” di convergenza (misurati attraverso i valori del PIL pro capite) tra le regioni più
forti e quelle più deboli, con una crescita dello stock di capitale e del reddito pro capite
maggiore nelle seconde. Le diverse performance regionali sono determinate dal fatto che
le regioni meno sviluppate, caratterizzate da un più basso stock iniziale, pur registrando
rendimenti decrescenti del capitale sperimentino una discesa meno rapida. In altri termini, esisterebbe una relazione inversa tra variazioni del tasso di crescita e livello iniziale
29
Negli anni ottanta, al fine
di superare i limiti dell’approccio neoclassico, nasce la “teoria della crescita
endogena”. Essa affronta
il problema della non-convergenza, sostituendo l’ipotesi di progresso tecnico come free good con
quella di progresso tecnico endogeno e allarga il
concetto di capitale (fattore riproducibile), al fine di
eliminare ogni fattore ad
esso complementare e, di
conseguenza, anche le
cause della sua produttività marginale decrescente. Per un approfondimento sul tema: Solow M.
R., op.cit.; Musu e Cazzavillan (1997); Boggio,L.,
Seravalli, G., op.cit.
Giuseppe Capuano
del reddito pro capite, nota in letteratura come convergenza beta assoluta30, che, partendo
dall’equazione di convergenza marginalista o neoclassica fornita dal modello di Solow
(1956) e Swan (1956), potremmo esprimere come segue:
60
30
Oltre al concetto di convergenza beta, in letteratura è presente anche il
concetto di convergenza
sigma, che indica una riduzione nel tempo della
variabilità del prodotto
pro capite.
dove il termine di sinistra rappresenta il tasso di crescita del reddito pro capite in un
determinato periodo di riferimento (0,t), il coefficiente b è il tasso di convergenza verso
uno stato di equilibrio (steady state) e (y/l)o rappresenta il livello di reddito pro capite di
partenza, dove y sintetizza il reddito e l la popolazione residente.
Una variante a questo approccio è rappresentata dal contributo di J. G. Williamson
(1973) che, a differenza dei teorici neoclassici che consideravano nei loro modelli solo i
fattori capitale e lavoro, esamina anche la capacità che una elevata domanda e un alto
livello dei consumi di una regione hanno di attrarre investimenti, rispetto a realtà locali
con un livello di domanda inferiore.
Egli sostiene, secondo una visione storicistica dell’economia, che esiste una significativa relazione tra squilibri regionali e livello di sviluppo di un Paese, dove, in una fase iniziale della crescita, la presenza di squilibri è minore. Nelle fasi successive di raggiungimento del proprio “take off ” e di maturità, gli squilibri andranno progressivamente ad
aumentare, per poi ridursi e quindi scomparire del tutto, seguendo un andamento “campanulare” della crescita. In pratica si considera lo sviluppo come un processo a tappe, nel
quale, a differenza dell’approccio “neoclassico puro”, pur arrivando alle stesse conclusioni, si sottolinea l’esistenza di squilibri regionali transitori che spariranno grazie ad un progressivo adeguamento strutturale di medio-lungo periodo.
Entrambi gli approcci semplificano le fasi dello sviluppo e rappresentano, in maniera
schematica, l’economia reale che è invece molto più complessa e meno “equilibrata”. Al
contrario, l’evidenza empirica smentisce la continuità nel tempo della riduzione degli
squilibri regionali. La teoria marginalista della convergenza assoluta, basandosi su un
approccio parametrico (convergenza Beta e Sigma), può essere accettata solo in particolari casi, nei quali il livello di sviluppo di partenza è eccezionalmente basso, costituendo
un caso particolare di un principio più generale.
Ciò si verifica principalmente perché non sempre le fasi di sviluppo sperimentate da
un paese o da una regione sono necessariamente identiche e caratterizzate dalla medesi-
I fattori dello sviluppo regionale
ma intensità e durata; inoltre, i differenziali di crescita non sono temporanei e spesso vengono amplificati dalla presenza di imperfezioni dei mercati dalla presenza/assenza di economie esterne e/o economie di agglomerazione e dai rendimenti crescenti/decrescenti
delle attività produttive31.
La conclusione, alquanto semplicistica rispetto alla reale dinamica dei fenomeni economici, alla quale perviene l’approccio neoclassico, è che i differenziali regionali di sviluppo sono meramente temporanei, destinati nel lungo periodo (processo di convergenza) ad essere assorbiti grazie ai meccanismi sprigionati dalle libere forze del mercato.
Inoltre, tale approccio presuppone un’altra condizione, pur in forma latente e poco dibattuta: i percorsi di sviluppo locale, pur partendo da condizioni iniziali diverse, tendono ad
assumere le stesse caratteristiche, secondo le traiettorie di crescita settoriali indicate dalla
“teoria dei tre settori” di Colin Clark (1951).
Anche in questo caso, i differenti livelli di sviluppo conosciuti negli ultimi decenni
dai sottosistemi regionali (ad esempio le province) che qualificano qualsiasi sistema economico «maturo» rendono obsoleta una simile visione dello sviluppo locale, e la prova è
rappresentata dal fatto che le economie provinciali non si comportano uniformemente
rispetto agli input di politica economica (comunitaria, nazionale e regionale) e non reagiscono con la stessa intensità e cadenza temporale agli impulsi provenienti dal “centro”.
Nella realtà, l’influenza dei diversi livelli di sviluppo, le peculiarità produttive locali e
le caratteristiche geografiche del territorio, insieme ad altri fattori endogeni ed esogeni
al sistema subregionale, condizionano fortemente i comportamenti degli operatori economici e, quindi, l’andamento dell’economia locale, vanificando gli effetti dell’utilizzo di
strumenti di politica regionale troppo spesso standardizzati e non adeguatamente calibrati.
L’evidenza empirica tratta da una nostra elaborazione con la “clusterizzazione” del
contributo dei principali settori economici (agricoltura, manifatturiero, turismo e servizi) alla formazione del PIL delle 103 province italiane dimostra come si sia in presenza
di 412 valori32 diversi (Tab. 2) relativi ad un solo anno di riferimento (1999).
Questo risultato non è ovviamente esaustivo, ma rappresenta sicuramente una proxy
di come ogni realtà locale conosca una diversa traiettoria del proprio sviluppo e take-off
differenziati nel tempo.
31
Le relazioni empiriche
presentate, note anche
come “leggi di Kaldor”,
potremmo riassumerle
come segue: forte correlazione positiva tra tasso
di crescita del reddito e
tasso di crescita della
produzione manifatturiera; tra crescita della produttività e crescita della
produzione all’interno
del settore manifatturiero; effetto indotto dalla
crescita della produzione
manifatturiera sul trasferimento intersettoriale
dell’occupazione. Citazione ripresa da: N.Kaldor, Causes of the Slow
Rate
of
Economic
Growth in the United
Kingdom, Cambridge
U.P., Cambridge, 1966.
32
Il dato è il risultato del
prodotto dei quattro indicatori per le 103 province italiane.
Giuseppe Capuano
Tab. 2 - Peso percentuale del valore aggiunto dei settori sul totale - 1999 (prime e ultime dieci province)
Agricoltura
Pos Prov.
62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ragusa
Oristano
Foggia
Siracusa
Matera
Viterbo
Cremona
Caserta
Enna
Agrigento
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Torino
Firenze
Roma
Como
Lecco
Trieste
Varese
Milano
Genova
Prato
Industria
Valore
Pos Prov.
Servizi
Valore
Pos Prov.
Turismo
Valore
Pos Prov.
Valore
17,87
14,19
12,71
12,29
9,79
9,55
9,39
9,27
9,26
8,75
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lecco
Vicenza
Biella
Reggio E.
Bergamo
Modena
Treviso
Varese
Novara
Belluno
40,9
39,0
38,2
38,2
37,7
37,5
36,9
35,4
34,8
34,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Roma
Trieste
Palermo
Genova
Messina
Catania
Reggio C.
Napoli
Agrigento
Aosta
84,5
83,9
83,0
81,4
81,3
80,3
80,1
80,1
78,9
78,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bolzano
Rimini
Savona
Genova
Imperia
Belluno
Siena
Grosseto
Livorno
Trento
15,5
10,8
83,0
10,0
8,6
8,1
7,7
7,4
7,4
7,1
0,94
0,84
0,68
0,64
0,54
0,50
0,42
0,39
0,31
0,13
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Cosenza
Vibo Valentia
Ragusa
Trapani
Messina
Enna
Oristano
Agrigento
Reggio C.
Imperia
9,9
9,2
9,0
9,0
8,9
8,6
8,4
7,7
7,3
6,5
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Cuneo
Cremona
Novara
Bergamo
Modena
Treviso
Mantova
Lecco
Reggio E.
Vicenza
57,1
56,4
56,1
55,1
55,1
54,6
54,4
54,2
52,9
52,8
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Bari
Ragusa
Siracusa
Avellino
Torino
Taranto
Milano
Vercelli
Prato
Biella
2,2
2,2
2,1
2,0
2,0
2,0
1,9
1,7
1,5
1,3
Fonte: Unioncamere - Istituto G.Tagliacarne
3.1.2 Le recenti evoluzioni del dibattito
33
Tra gli altri, Bernard e
Durlauf (1995) hanno mostrato come lo stimatore
Beta nelle regressioni
cross-country non raggiunga l’obiettivo perché
non permette di identificare l’intensità e la direzione dei movimenti dei
diversi Paesi/Regioni.
La più recente letteratura in materia, criticando l’approccio parametrico (neoclassico), ha tentato di spostare l’attenzione da questi concetti, essendo misure medie e sintetiche allo studio analitico in termini dinamici di tutta la distribuzione per classi di reddito di un’economia secondo un approccio non parametrico (Quah, 1993). La critica parte
dall’assunto che utilizzando l’equazione della crescita, che comprende tra i regressori il
livello del PIL pro capite iniziale con coefficiente Beta, se si perviene ad un risultato di
segno negativo (e significativo del coefficiente), lo stesso viene interpretato come convergenza condizionata “tout court”, ma non si raggiunge l’obiettivo in quanto non si
identificano i Paesi che divergono da quelli che convergono33.
I fattori dello sviluppo regionale
Inoltre, lo stesso Quah sostiene che le regressioni basate sul tasso di crescita medio di
ciascun Paese sarebbero accettabili solo nel caso in cui essi evidenziassero, nel corso degli
anni, un tasso di crescita del PIL stabile. Ciò che, invece, nella realtà non avviene.
Partendo da queste critiche, altri autori (Boggio, Serravalli, op.cit.) sostengono che
per accertare la convergenza si può utilizzare il concetto di Sigma-convergenza, che basa
l’approccio sulla varianza dei livelli del PIL pro capite tra Paesi/regioni. Anche questo
approccio, in ogni modo, presenta dei limiti di tipo statistico e l’alternativa è di spostare
l’attenzione non più sull’utilizzo di misure medie, o comunque di sintesi (come perseguito dall’approccio di tipo parametrico) quanto sullo studio dell’evoluzione dinamica
della distribuzione per classi di reddito (approccio non parametrico), o più semplicemente, come nel nostro caso, valutare le variazioni del PIL pro capite a livello provinciale in un periodo relativamente ampio (sette anni), studiandone i processi di convergenza/divergenza rispetto ad un valore medio nazionale, attraverso il calcolo della varianza
e dello scarto quadratico medio.
3.1.3 La “convergenza non lineare” (CNL)
In questo quadro teorico si è svolta la nostra analisi, che, applicando un approccio
non parametrico alle dinamiche del PIL pro capite delle province italiane, è giunta alla
seguente conclusione: le economie locali in Italia e soprattutto nelle province, hanno
conosciuto una CNL dove i percorsi di sviluppo non tendono ad un automatico annullamento degli squilibri nel lungo periodo ma perseguono un percorso di tipo “sinusoidale” che porta solo in alcuni casi ad un annullamento/riduzione degli squilibri iniziali
ed interessano, nel lungo periodo, realtà territoriali diverse. Si tratta di una altalenante
riduzione-aumento-riduzione dei divari regionali. Secondo il nostro approccio, la lettura degli avvenimenti di lungo periodo non può essere fatta in modo dicotomico in termini di convergenza o divergenza. La realtà economica, infatti, non si presenta in forme
così nette e lineari.34
Ciò è dovuto ad una velocità non costante della crescita (come d’altronde già verificato da Quah in un lavoro del 1993 (op.cit.) in relazione a 118 Paesi) che può assumere, in alcuni casi e in determinati periodi, anche valori negativi, aumentando il gap con
i valori medi di riferimento e modificando la geografia degli squilibri regionali. Questo
punto differenzia la nostra tesi dalla “scuola delle divergenze” ed in particolare dalla “teoria della causazione circolare cumulativa” (Myrdal, 1957; Hirschman, 1958).
34
Su questo aspetto teorico si veda: G. Capuano,
L’osservatorio economico: strumento quantiqualitativo per la lettura e
l’analisi delle dinamiche
economiche e dei processi di convergenza/divergenza, Memoria di Licenza presentata alla Facoltà di Scienze Economiche, Università della
Svizzera Italiana, Lugano,
2000 - ripreso anche in:
IRE, Monitor strutturale:
10 anni di crescita economica tra divari e convergenze interregionali, Lugano, 2002 - nel quale si
dimostra che, anche dal
confronto tra le dinamiche del PIL del Canton Ticino e di alcune province
della Lombardia, che insieme formano l’area ticinese, oltre al fatto che l’ipotesi neoclassica della
convergenza assoluta o
per tappe progressive
non è verificata, siamo di
fronte a percorsi che
sembrerebbero seguire
l’ipotesi della “convergenza non lineare”; G.
Capuano (2001), “I processi di convergenza e i
percorsi di sviluppo locale”, in Del Colle E. (a cura
di), Lo Stato di salute dei
comuni. Una ricerca sulle
condizioni economiche,
sociali e demografiche
dei comuni italiani, Franco Angeli, Roma.
Giuseppe Capuano
64
35
36
I dati utilizzati nel paragrafo sono relativi alla serie storiche del valore aggiunto provinciale dell’Istituto G. Tagliacarne, calcolato a prezzi base (comprese le imposte indirette
alla produzione e i contributi correnti sui prodotti
ed escluse le imposte indirette sui prodotti ed i contributi correnti sulla produzione) e a prezzi correnti secondo quanto definito dal Sec 95. In precedenza il v.a. era calcolato al
“costo dei fattori”.
I più recenti dati disponibili del reddito pro-capite comunale in Italia risalgono al 1987, con una
pubblicazione del Banco
di Santo Spirito. L’Istituto
Tagliacarne da alcuni anni ha iniziato una sperimentazione che dovrebbe portare ad un aggiornamento di questi dati.
Secondo questa teoria, lo sviluppo regionale tende, comunque, ad innescare dei processi di divergenza più che di convergenza, in quanto i differenziali di reddito tendono
ad accentrarsi anziché restringersi. Ciò è provocato dal fatto che gli effetti di diffusione
(positivi) presenti nelle aree meno sviluppate risultano inferiori agli effetti di riflusso
(negativi), alimentando quindi e consolidando gli squilibri esistenti.
La conclusione è che dovremmo assistere a processi di divergenza tra regioni storicamente sviluppate e non sviluppate, a tutto favore delle prime. Al contrario, a nostro
avviso, non è possibile dare una lettura degli avvenimenti di lungo periodo in maniera
dicotomica (convergenza/divergenza), seguendo un approccio deterministico (i casi della
storia hanno determinato il livello di sviluppo di una regione o i differenziali di crescita
tra di esse). La realtà economica non si presenta in forme così nette e lineari e i percorsi di sviluppo di medio-lungo periodo possono capovolgere i rapporti di forza tra regioni con livelli di sviluppo di partenza differenziati.
3.2 La verifica sul “campo” della “convergenza non lineare” (CNL)35
3.2.1 I limiti dell’utilizzo del PIL pro capite come misura del livello di sviluppo
Le basi teoriche della nostra tesi si fondano su di una articolata verifica empirica che
si è avvalsa dell’utilizzo delle variazioni annuali del PIL pro capite a livello provinciale (i
limiti presentati dall’indicatore sono notori in letteratura). Per ridurre al massimo l’errore, prima di iniziare le elaborazioni, si è proceduto a delle semplici quanto importanti
verifiche, come descritto successivamente.
Il PIL pro capite come indicatore statistico è notoriamente definito come una
misura in valore dei beni e servizi finali prodotti in un determinato paese ed è utilizzato come indicatore di sintesi del livello di sviluppo raggiunto da un certo ambito territoriale (ad esempio una regione, provincia o comune36). L’utilizzo dell’indicatore, in
particolare ai fini dell’analisi della crescita di realtà territoriali (ad esempio le province,
NUTS III) pone una serie di problemi e limiti evidenziati da tempo dalla letteratura
economica internazionale. Esso esclude dal calcolo i servizi non retribuiti (ad esempio
il lavoro delle casalinghe, il volontariato), non tiene conto delle dinamiche demografi-
che (ad esempio il più elevato tasso di natalità al Sud e il tasso di invecchiamento della
popolazione più alto al Nord), mentre non viene decurtato dei danni che il processo
produttivo apporta all’ambiente.
Limiti che possono presentare degli inconvenienti, con fenomeni di distorsione dei
dati e, quindi, inficiare le conclusioni di carattere economico37. In ogni caso, come d’altronde conferma anche la Commissione europea, al momento non esistono misure alternative, altrettanto valide, del livello di sviluppo.
La Commissione ritiene che il PIL pro capite in termini di SPA (standard di potere
di acquisto) sia l’indicatore chiave per valutare i livelli di sviluppo economico delle regioni e le loro disparità di andamento.
Il suo ruolo è sancito dai regolamenti dei Fondi strutturali e dall’art.87 (3)a del
Trattato sulla politica delle concorrenza e viene utilizzato anche da numerose istituzioni
internazionali (tra cui Banca Mondiale, FMI, OCSE, etc.). Esso può evidenziare un mutamento nel rapporto tra un’economia ed un’altra non solo a causa di una differenza nel
tasso di crescita del PIL in termini reali (la cosiddetta “convergenza reale”), ma anche per
effetto di un cambiamento nel livello dei prezzi relativi. Questo aspetto distorce l’analisi
delle variazioni del PIL pro capite nel tempo, in quanto un suo aumento relativo, determinato da una riduzione nel livello relativo dei prezzi, potrebbe avere implicazioni leggermente differenti rispetto ad un aumento determinato da una crescita relativa del PIL
reale. L’indicatore alternativo più semplice consiste nella misurazione del PIL pro capite
in Euro anziché in SPA. In questo modo si evidenzia il valore di mercato della produzione in ciascuna regione, anziché i livelli di reddito reale. Tale indicatore, comunque,
accresce l’entità delle differenze a livello regionale, dato che i livelli dei prezzi sono positivamente correlati con la ricchezza di una regione: un basso livello del PIL pro capite
presente nelle regioni economicamente sfavorite, tende ad essere parzialmente compensato da un minore costo della vita.
Quindi, pur tenendo conto dei problemi e dei limiti evidenziati in precedenza, anche
la nostra analisi sulla convergenza si è fondata sullo studio dell’evoluzione di lungo periodo del PIL pro capite (Y/P = Y/L * L/P) delle province (1995-2002), dove Y/P = PIL
pro capite;Y/L = produttività media del lavoro; L/P = tasso di occupazione. Tali componenti svolgono un importante ruolo nel determinare le dinamiche del PIL pro capite
delle singole realtà territoriali e quindi dei processi di catching up; infatti, distinguendo il
PIL pro capite nelle due componenti rappresentate dalla produttività del lavoro e dalla
quota di occupati sulla popolazione, si rileva come la formula risenta, nel primo caso,
della dotazione di capitale, del livello di tecnologie presenti e della struttura settoriale del-
I processi di convergenza e divergenza tra le province italiane
I fattori dello sviluppo regionale
65
37
A questo proposito: Guarini, R. e Tassinari, F., Statistica Economica, Il Mulino, 2000.
Giuseppe Capuano
66
l’occupazione. Sulla seconda influiscono principalmente le caratteristiche del mercato del
lavoro, oltre ai fattori socio-demografici (ad esempio il tasso di invecchiamento della
popolazione).
In uno studio dell’ISAE (2001) relativo alle regioni appartenenti all’Ue 12, si rileva
esserci stato un processo di convergenza dei livelli di produttività all’interno dei 12 stati
membri considerati (tra cui l’Italia). Il PIL pro capite, però, non ne ha beneficiato sia per
la presenza di un “effetto divergenza” dei tassi di occupazione, sia a causa della relazione
negativa esistente tra produttività e occupazione. La conclusione è che le regioni caratterizzate da bassi livelli di produttività relativa erano quelle che avevano incrementi del
tasso di occupazione inferiori alla media comunitaria.
3.2.2 I risultati dell’analisi provinciale nel periodo 1995-2002
38
Tra gli altri: S. Fabiani, G.
Pellegrini, Convergenza e
divergenza nella crescita
delle province italiane, Ricerche quantitative per la
politica economica, 1997.
39
In analogia al Regolamento relativo ai Fondi
Strutturali, una regione
(NUTS II) è ritenuta in ritardo di sviluppo quando
presenta un livello soglia
del PIL pro capite uguale
o inferiore al 75% della
media
comunitaria
(EUR15 =100).
L’approccio CNL trova una sua evidenza empirica grazie all’analisi delle dinamiche del
PIL pro capite delle province italiane nel periodo 1995-2002, che per certi aspetti aggiorna alcune analisi realizzate negli anni scorsi38 per periodi immediatamente precedenti.
Il primo risultato è dato dallo studio dell’evoluzione del coefficiente di variazione del
numero indice del PIL pro capite provinciale nel periodo considerato. Esso ci rivela che il
coefficiente si riduce nel Mezzogiorno (dallo 0,14 del 1995 allo 0,12 del 2002) portandosi sui livelli delle province del Centro (rimasto invariato nel periodo a quota 0,12) e avvicinandosi alle province del Nord (0,11), che al contrario registrano un leggero incremento rispetto al 2001 (0,10). Ciò fa supporre che, pur restando evidenti gli squilibri territoriali tra le aree, all’interno delle province del Mezzogiorno, in particolare negli ultimi anni,
si è assistito ad un lento ma costante processo di crescita che interessa tutte le province, premesso che ha consentito di ridurre gli squilibri interni all’area. Cosa che non avviene nelle
province settentrionali, dove si afferma invece l’esistenza di un “Nord nel Nord”.
Il secondo risultato che scaturisce dalla nostra analisi è che il principio della convergenza assoluta sembrerebbe verificato solo quando il livello di reddito pro capite di partenza è molto più basso rispetto al valore medio di riferimento: nel nostro caso tale valore è stato individuato convenzionalmente, in analogia alle direttive comunitarie39, al di
sotto del 75% del dato medio dell’Italia. Infatti, nella graduatoria delle prime 10 province
italiane, costruita in base alla variazione cumulata del PIL pro capite nel periodo 19952002 (Tab.3), seguono un percorso di convergenza lineare solo le prime tre (Crotone,Vibo
Valentia e Matera); ben 3 province, con un valore del PIL pro capite superiore al 75% (nel-
l’ordine di PIL pro capite, Bolzano, Massa Carrara e Isernia) evidenziano un andamento
“sinusoidale”, in quanto, alcune delle sette osservazioni effettuate (dal 1995 al 2002) hanno
presentato un andamento del PIL pro capite altalenante (Tab.4). Quest’ultimo gruppo si
arricchisce di 11 province se si allarga la graduatoria alle prime 30.
La conclusione che si può trarre è la seguente: è poco verificata la relazione inversa
tra livello di partenza del reddito e tasso medio di crescita (convergenza beta assoluta),
ma si rileva in molti casi una relazione diretta, in quanto si è evidenziato che le province con un livello di sviluppo di partenza più elevato hanno registrato tassi di crescita più
sostenuti rispetto alle province con un PIL pro capite di partenza più basso, e molte di
esse presentato un andamento non lineare (sia in termini di convergenza che di divergenza).
Quindi, soprattutto nel caso delle province cosiddette “intermedie” (convenzionalmente si è utilizzato il range compreso tra 75 e 115 del valore medio Italia=100), la velocità del processo di convergenza o rallenta o addirittura si trasforma in divergenza rispetto ad un valore medio, dando vita ad un percorso che potremmo definire a “balzi” o di
tipo sinusoidale, e che noi definiamo di “convergenza non lineare”.
I processi di convergenza e divergenza tra le province italiane
I fattori dello sviluppo regionale
67
Giuseppe Capuano
Tab. 3 - Tassi medi annui di crescita del PIL pro capite e numeri indice - 1995/2002 (Dato Italia=100)
Pos
68
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Prov.
Var. %
95-02
Crotone
7,19
Vibo Valentia 6,35
Matera
6,00
Isernia
5,95
Grosseto
5,94
Potenza
5,79
Massa Carrara 5,61
Ragusa
5,56
Bolzano
5,48
Enna
5,39
Belluno
5,27
Sassari
5,27
Trapani
5,24
Siena
5,18
Benevento
5,18
Napoli
5,13
Reggio Calabria 5,12
Ravenna
5,09
Catanzaro
5,03
Catania
5,03
Oristano
4,97
Lecce
4,94
Cosenza
4,92
Campobasso
4,91
Agrigento
4,90
Genova
4,89
Avellino
4,88
Forlì
4,87
Venezia
4,86
Terni
4,84
Messina
4,83
Gorizia
4,79
Salerno
4,79
Firenze
4,77
Taranto
4,76
N.I.
1995
Pos
48,3
55,9
63,5
77,5
85,8
70,4
83,6
68,2
139,9
54,6
120,5
74,4
61,4
104,4
63,9
60,6
62,5
113,4
64,4
63,0
68,0
58,1
59,2
75,0
56,9
100,9
67,3
118,3
117,7
93,5
68,4
108,6
68,0
124,0
66,0
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Fonte: Unioncamere - Istituto G.Tagliacarne
Prov.
Var. %
95-02
Palermo
Ascoli Piceno
Rovigo
Pescara
Pesaro Urbino
Bari
Pistoia
Macerata
Caserta
Asti
Lucca
Ancona
Arezzo
Piacenza
Cremona
Chieti
Rimini
Roma
Savona
Treviso
Pavia
Lodi
Verbano C. O.
Ferrara
Perugia
Alessandria
Latina
Trento
La Spezia
Novara
Imperia
Livorno
Bologna
Padova
Varese
4,67
4,62
4,57
4,56
4,54
4,52
4,52
4,52
4,51
4,50
4,49
4,45
4,36
4,35
4,32
4,26
4,25
4,24
4,22
4,16
4,15
4,14
4,14
4,10
4,10
4,10
4,09
4,08
4,07
4,06
4,06
4,06
4,04
4,04
4,02
N.I.
1995
63,8
95,1
99,6
85,3
96,8
68,0
99,2
96,3
63,0
98,9
104,4
110,0
104,2
109,4
113,2
87,1
122,4
120,0
110,0
119,4
104,1
106,9
96,8
106,7
99,9
107,9
92,3
125,1
102,4
117,1
105,8
105,2
139,8
112,9
114,1
Pos
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Prov.
Var. %
95-02
N.I.
1995
Foggia
Cagliari
Torino
Milano
Cuneo
Mantova
Frosinone
Parma
Modena
Nuoro
Sondrio
Verona
Rieti
Teramo
Brindisi
Pisa
Caltanissetta
Vicenza
L’Aquila
Bergamo
Udine
Trieste
Brescia
Vercelli
Biella
Siracusa
Reggio Emilia
Pordenone
Viterbo
Prato
Como
Lecco
Aosta
4,02
4,01
4,00
4,00
3,89
3,81
3,78
3,78
3,74
3,74
3,71
3,69
3,68
3,64
3,64
3,53
3,53
3,49
3,44
3,40
3,38
3,35
3,34
3,33
3,23
3,14
3,09
2,98
2,93
2,76
2,68
2,34
2,31
59,5
75,5
122,1
154,6
123,7
129,3
86,0
132,3
142,1
70,2
104,0
119,4
84,3
85,3
70,8
110,6
60,5
127,1
85,5
122,0
116,1
112,9
122,8
111,7
116,8
79,4
133,4
122,7
90,1
126,0
114,6
119,7
136,2
ITALIA
4,29 100,0
Tab. 4 - Andamento del PIL pro capite provinciale - 1995/2002
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Province
N.I. 95
N.I. 96
N.I. 97
N.I. 98
N.I. 99
N.I. 00
N.I. 01
N.I. 02
Crotone
Vibo Valentia
Matera
Isernia
Grosseto
Potenza
Massa Carrara
Ragusa
Bolzano
Enna
Belluno
Sassari
Trapani
Siena
Benevento
Napoli
Reggio Calabria
Ravenna
Catanzaro
Catania
Oristano
Lecce
Cosenza
Campobasso
Agrigento
Genova
Avellino
Forlì
Venezia
Terni
48,3
55,9
63,5
77,5
85,8
70,4
83,6
68,2
139,9
54,6
120,5
74,4
61,4
104,4
63,9
60,6
62,5
113,4
64,4
63,0
68,0
58,1
59,2
75,0
56,9
100,9
67,3
118,3
117,7
93,5
49,4
55,3
66,1
79,8
86,2
71,6
83,3
68,4
142,2
55,0
119,8
75,2
61,6
104,9
64,2
60,4
61,0
114,9
65,0
61,3
69,7
58,9
58,1
75,8
57,8
102,7
66,3
120,6
117,8
92,1
49,5
57,3
66,2
82,0
87,9
73,0
85,4
70,1
139,1
58,8
120,0
76,0
60,9
107,0
65,0
62,8
62,8
111,9
65,6
61,4
71,3
57,7
59,3
80,2
59,6
104,3
67,1
117,9
118,1
91,3
51,6
57,1
69,2
82,3
89,1
72,4
83,9
69,6
143,0
56,6
121,1
77,5
60,5
108,6
63,9
64,0
62,4
112,7
63,0
61,4
69,6
58,4
60,1
75,7
57,3
104,6
66,2
118,9
118,3
90,3
52,9
57,8
73,1
78,5
91,9
73,4
84,0
69,5
139,6
56,1
120,3
78,4
61,6
110,5
64,0
63,7
62,9
112,0
64,5
62,8
75,4
59,2
62,8
75,6
57,0
105,1
67,3
118,9
117,6
92,5
54,3
57,4
70,6
82,1
92,1
73,5
85,4
70,7
144,2
58,1
122,7
78,2
63,4
113,0
62,7
63,3
62,1
113,0
65,1
63,4
70,2
59,9
62,4
76,4
55,3
106,2
69,4
118,7
117,5
93,1
56,1
59,3
70,9
86,1
92,5
74,2
88,9
71,2
148,9
58,9
123,9
80,3
62,7
109,5
64,1
63,7
64,8
117,1
67,1
64,1
72,2
60,4
63,2
77,0
56,2
107,4
71,3
118,6
121,4
93,4
58,5
64,2
71,2
86,6
95,8
77,8
91,3
74,3
151,5
58,8
128,7
79,4
65,4
110,9
67,8
64,1
66,1
119,7
67,7
66,2
71,1
60,7
61,8
78,1
59,2
105,0
70,1
123,0
122,3
97,0
ITALIA
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Fonte: Unioncamere - Istituto G.Tagliacarne
I processi di convergenza e divergenza tra le province italiane
I fattori dello sviluppo regionale
69
Giuseppe Capuano
Graf. 1 - Coefficiente di variazione del numero indice del PIL pro capite provinciale (Anni 1995/2002)
70
Fonte:Elaborazione propria su dati Unioncamere - Istituto G.Tagliacarne
Graf. 2 – Convergenza beta assoluta del PIL pro capite provinciale (Anni 1995-2002)
Fonte:Elaborazione propria su dati Unioncamere - Istituto G.Tagliacarne
In conclusione, una lettura delle dinamiche dei percorsi di sviluppo locale può essere valida seguendo gli automatismi della teoria marginalista della convergenza solo in
contesti palesemente in ritardo di sviluppo e solo per periodi di tempo ben limitati. Al
contrario, quando si utilizzano le stesse categorie concettuali per studiare dinamiche che
interessano gruppi di province caratterizzate da livelli di sviluppo intermedio/alto, ovvero tendenze di sviluppo di lungo periodo di economie non sviluppate, la stessa funzione
risulta essere inadeguata e si preferisce utilizzare il concetto di “convergenza non lineare”.
Graf. 3 - Coefficiente di variazione del numero indice del PIL pro capite provinciale (Anni 1995/2002)
I processi di convergenza e divergenza tra le province italiane
I fattori dello sviluppo regionale
71
Giuseppe Capuano
3.3 I fattori che contribuiscono alla “convergenza non lineare”
72
In questo lavoro non ci si è limitati a verificare gli andamenti economici sintetizzati
attraverso lo studio del PIL pro capite, ma si è cercato anche di individuare i fattori che
contribuiscono alla permanenza degli squilibri territoriali. Essi sono molteplici, a partire
da una differente dose di progresso tecnico incorporato nella funzione di produzione,
dalla presenza di rendimenti di scala crescenti, ad una produttività marginale non sempre
decrescente del capitale, secondo quanto verificato dalle più recenti “teorie dello sviluppo endogeno” (Romer, 1986; Lucas, 1988).
Oltre a queste concause spesso riprese dalla letteratura specialistica, in questa sede si
propongono altri elementi che a nostro avviso condizionano, e non poco, la permanenza degli squilibri territoriali. Grazie alla disponibilità di dati provinciali in serie storica,
abbiamo verificato alcuni fattori che direttamente (popolazione, tasso di occupazione e
produttività media del lavoro) o indirettamente (fattori che potremmo definire di contesto, come la reattività della crescita del PIL alle variazioni del tasso di apertura verso i
mercati esteri e alla riduzione del costo del danaro) hanno alimentato gli squilibri territoriali nel corso del tempo.
Formalmente potremmo descrivere quanto in precedenza affermato con la seguente
equazione:
dove:
il termine di sinistra rappresenta il differenziale tra il PIL pro capite delle province i
e j in un determinato anno;
il termine di destra rappresenta la differenza dei contributi forniti, negli n anni precedenti a quello di riferimento, da fattori socio-economici diretti e indiretti alla formazione del PIL pro capite delle province i e j.
Le nostre elaborazioni relative al periodo 1998-2002 hanno preso in considerazione
i seguenti indicatori:
❏ saldo migratorio e naturale della popolazione residente;
❏ tasso di occupazione;
❏ tasso di interesse a breve per flussi di cassa;
❏ tasso di apertura verso l’estero;
pervenendo ad un eloquente risultato: se si escludono 7 casi su 984 verifiche, nessuna provincia conserva la stessa posizione in graduatoria relativa al singolo indicatore nei
due anni presi a riferimento (1998 e 2002) e rispetto a tutti gli indicatori utilizzati. Un
risultato che è stato determinato da livelli diversi dell’indicatore rilevato e dalla presenza
di differenziali, in alcuni casi rilevanti, tra un anno e l’altro.
La conclusione che se ne trae è che esiste una forte variabilità dei fattori che determinano lo sviluppo, ne condizionano il tasso di crescita del PIL pro capite e il suo livello, e, cosa più importante ai fini del nostro lavoro, contribuiscono alla creazione di differenziali provinciali in termini di crescita relativa.
3.4 Le traiettorie dello sviluppo delle province italiane attraverso l’analisi del PIL
Dopo una lettura delle dinamiche di sviluppo delle province italiane attraverso la
strumentazione teorica fornita dall’ampia letteratura della convergenza, in questo paragrafo cercheremo una valutazione di tipo qualitativo dei percorsi di sviluppo intrapresi
dalle economie locali nel periodo 1995-2002. I cicli economici che si sono susseguiti in
questo periodo, non sembrano aver inciso sulla distribuzione del PIL pro capite in Italia,
se è vero che le prime quattro province più ricche nel 1995 (nell’ordine, Milano,
Modena, Bolzano e Bologna) sono le stesse del 2002. Milano risulta sempre al primo
posto, questa volta seguita da Bolzano, Bologna e Modena. In fondo alla graduatoria delle
province ritroviamo Crotone, come nel 1995, seguita da Foggia (che perde tre posizioni
rispetto al 1995) ed Enna (terzultima nel 1995).
Se agli estremi della graduatoria non si sono verificati evidenti ribaltamenti, in quanto il trend di crescita del PIL non è stato tale da permettere un radicale riposizionamento competitivo delle province (non è un caso che le posizioni delle prime e delle ultime
10 province sono state generalmente mantenute), significativi cambiamenti si sono avuti,
invece, nelle realtà a sviluppo intermedio o che hanno conosciuto un consolidamento
delle traiettorie di sviluppo attraverso processi di riconversione economico-produttiva
intrapresi durante le fasi del ciclo più favorevoli. Cambiamenti conosciuti, almeno quelli più evidenti, soprattutto dalle province del Centro-Nord, contro un “fisiologico” movimento, tranne casi isolati, delle realtà del Mezzogiorno.
I processi di convergenza e divergenza tra le province italiane
I fattori dello sviluppo regionale
73
Giuseppe Capuano
Tab. 5 - Prime 10 e ultime 10 province italiane per PIL pro capite - 1995/2002
Province
74
Milano
Bolzano
Bologna
Modena
Firenze
Parma
Belluno
Roma
Reggio Emilia
Mantova
Province
Vibo Valentia
Palermo
Caserta
Lecce
Cosenza
Agrigento
Caltanissetta
Enna
Foggia
Crotone
pos. 02
N.I. 02
pos. 95
N.I. 95
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
152,6
150,6
136,5
135,4
129,0
127,9
127,4
124,6
122,9
122,9
1
3
4
2
11
7
20
13
6
8
155,4
139,1
139,1
140,8
125,1
133,3
119,3
123,6
133,7
127,4
pos. 02
N.I. 02
pos. 95
N.I. 95
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
64,1
64,0
63,4
61,6
61,3
60,5
58,8
57,7
57,5
56,9
101
91
92
97
98
100
95
102
99
103
56,1
62,5
62,2
59,1
58,7
57,9
61,0
54,2
58,5
47,2
Fonte: Unioncamere - Istituto G.Tagliacarne
Una lettura del cambiamento, quest’ultima, che probabilmente supera un approccio
dicotomico “Nord-Sud” spesso alla ricerca di probabili, ma comunque deboli, segnali di
riduzione degli squilibri tra le province: tra l’inizio e la fine del periodo considerato, il
Mezzogiorno passa (dato Italia=100) da 65,8 a 68 contro il 119,6 e il 118 del CentroNord. Una riduzione del divario che risulta essere trainata nel periodo 1995-2002 dalla
maggiore crescita di molte province meridionali rispetto a quelle del Nord: delle dieci
province con il più alto tasso di crescita cumulato, ben sette appartengono infatti al
Mezzogiorno. In particolare Crotone, nonostante l’ultimo posto in graduatoria per il PIL
pro capite, evidenzia segnali di recupero posizionandosi al primo posto per tasso di crescita. Ciò le consente di migliorare il numero indice del PIL pro capite che, posto il dato
Italia=100, passa dal 48,3 del 1995 al 56,9 del 2002.
Proprio dall’analisi dei dati di Crotone emerge come le traiettorie dello sviluppo
locale debbano essere lette in termini trasversali alle tradizionali grandi ripartizioni territoriali ed in una logica non strettamente settoriale ma di filiera, e che richiedono policy
rivolte più alla ricerca dello sviluppo (più elevati tassi di crescita) che non alla riduzione
degli squilibri tra province forti e province deboli del Paese, che tra l’altro ne rappresentano una mera conseguenza.
Passando all’analisi dei singoli dati provinciali, segnali chiaramente positivi provengono da Siena, che nel periodo 1995-2002 guadagna 18 posizioni (dal 47° al 29° posto).
Una performance dovuta soprattutto ad un processo di internazionalizzazione dell’economia iniziato nei primi anni novanta ed a un modello produttivo integrato sostenuto
dal settore manifatturiero di qualità (soprattutto farmaceutico-biomedicale-meccanico) e
dalla filiera agroalimentare-turismo. Ugualmente interessante la performance di
Ravenna, che guadagna nello stesso periodo ben 15 posizioni (dal 31° al 16° posto), e di
Genova, che ne guadagna 13, passando dal 52° al 39° posto.
Un cenno particolare merita il capoluogo ligure che, distinguendosi in ciò dal resto
della regione (da La Spezia in particolare), deve molto di questa performance ad un processo di riconversione economica forse tra i più forti fra le “tradizionali” capitali dell’industria italiana, con un terziario che oggi pesa per l’80,3% (8° posto nella graduatoria settoriale) nella formazione del PIL contro appena il 19,2% dell’industria (85° posto della
graduatoria settoriale).
Un processo di terziarizzazione conosciuto dalle altre capitali dell’industria italiana
degli anni sessanta-settanta, quali Torino (15° posto nella graduatoria del PIL pro capite)
e Milano, che consente loro di mantenere sostanzialmente le posizioni del 1995; senza
escludere peraltro Roma che, in questo contesto, si conferma al primo posto per peso del
terziario nella formazione del PIL (87,1%) e guadagna cinque posizioni in termini di PIL
pro capite (dal 13° all’8° posto).
Tra le realtà locali, che al contrario hanno accusato vistosi arretramenti, rientrano in
particolare quelle province della cosiddetta “distrettualità tradizionale”, legate ad un
modello di specializzazione produttiva tradizionale, ad alta elasticità della domanda rispetto al prezzo ed esposte fortemente alla concorrenza dei Paesi di Nuova
Industrializzazione (NICs) come la Cina. Ci riferiamo nell’ordine a Lecco (passata dal
I processi di convergenza e divergenza tra le province italiane
I fattori dello sviluppo regionale
75
Giuseppe Capuano
76
22° posto del 1995 al 47° del 2002), Como (dal 29° al 50° posto), Prato (dal 22° al 47°
posto) e Pordenone (dal 19° al 31° posto). Realtà provinciali dove il peso dell’industria
nella formazione del PIL è tra i più alti d’Italia, con punte del 45,9% a Lecco (1° posto
in Italia), del 40% a Pordenone (9° posto) e del 39,9% a Prato (10° posto).
Province a vocazione distrettuale, a forte presenza industriale (soprattutto made in Italy)
che come si evince anche dal “Rapporto PMI 2002” dell’Unioncamere-Istituto Tagliacarne
e dalle analisi delle Camere di Commercio locali risultano in evidente crisi da alcuni anni.
Una situazione di particolare disagio presenta l’industria del pratese, il cui peso in termini
di PIL si riduce tra il 1995 e il 2002 di circa cinque punti percentuali, e del lecchese dove
la riduzione si assesta contemporaneamente sui quattro punti percentuali.
Una perdita di posizioni determinata anche da un andamento dell’economia sostanzialmente stagnante negli ultimi anni, ascrivibile soprattutto alla debolezza dei mercati
esteri. Infatti, nell’ordine, Lecco, Como, Prato e Pordenone registrano il 102°, il 101°, il
100° e il 98° posto nella graduatoria relativa ai tassi di crescita cumulati del PIL nell’intervallo 1995-2002. Un andamento peggiore registra solo Aosta (ultima in graduatoria)
che perde anch’essa 14 posizioni in termini di PIL pro capite.
Un altro indicatore del cambiamento delle traiettorie dello sviluppo è la crescente
importanza del settore agricolo e della filiera agroalimentare nella formazione del PIL.
Infatti, nelle realtà provinciali a maggior valenza della filiera agroalimentare (le prime 15
province più agricole d’Italia), dopo il “tradizionale” buon posizionamento di Mantova
(10° posizione nella graduatoria italiana del PIL pro capite) ritroviamo gli interessanti
miglioramenti di Vibo Valentia e Isernia (+ 7 posizioni), Grosseto (+ 6 posizioni), Matera
(+ 6 posizioni), Ragusa (+ 3 posizioni) e Benevento (+ 3 posizioni). Province con un
tessuto imprenditoriale formato da micro-piccole imprese con una spiccata vocazione
agroalimentare di qualità ed una organizzazione produttiva sul territorio di tipo sistemico, in alcuni casi caratterizzata dalla presenza di prodotti tipici con marchio di tutela (ad
es. DOP, IGP, etc.).
A supporto di questa lettura della geografia economica italiana va rilevato che, secondo la graduatoria dei tassi di crescita del periodo 1995-2002, nelle prime 15 province
d’Italia ben 7 sono realtà a forte vocazione agroalimentare. Questi sono tutti segnali che
indicano come, dopo il processo di industrializzazione conosciuto dall’Italia negli anni
cinquanta-sessanta a cui è seguito il periodo post-industriale con l’avvento della terziarizzazione dell’economia e dello sviluppo diffuso caratterizzato dall’impresa minore e
distrettuale degli anni ottanta-novanta, oggi siamo in presenza di un nuovo fenomeno
caratterizzato dalle filiere produttive a forte valenza agroalimentare.
Non è un caso che, con tutta la prudenza che l’argomento impone, nell’arco di
tempo considerato, le province del Mezzogiorno presentano dinamiche interessanti sia in
termini di crescita del PIL (ben 9 province delle 15 che hanno registrato un tasso di crescita cumulato del PIL più elevato appartengono al Mezzogiorno) che di performance
settoriali, con particolare risalto della filiera agroalimentare, che in una fase di crescita rallentata, è probabilmente il comparto che ha tenuto meglio il mercato.
Detto ciò, i segnali di riduzione degli squilibri territoriali in termini di PIL pro capite appaiono sostanzialmente deboli dovuti ad una maggiore omogeneità (al ribasso) nelle
performance economiche. Probabilmente la risposta a questa apparente contraddizione è
indicata dal fatto che la crescita segnata dalle province meridionali non è stata abbastanza forte e il risultato finale osservato è da attribuire, tra l’altro, ad un rallentamento delle
aree economiche del Centro-Nord, notoriamente più aperte al ciclo economico internazionale e dove il peso della componente pubblica sul totale dell’economia, relativamente basso, costituisce un fattore di stabilizzazione del ciclo minore rispetto al Sud.
Tab. 6 - Prime 15 e ultime 15 province italiane per peso dell’agricoltura, dell’industria e dei
servizi sul PIL - 1995/2002
Agricoltura
Prov.
Oristano
Foggia
Ragusa
Cremona
Mantova
Matera
Viterbo
Benevento
Enna
Ferrara
Vibo Valentia
Rovigo
Grosseto
Catanzaro
Imperia
Pos. 02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Peso % 02 Peso % 95
10,5
9,9
9,6
8,1
7,8
7,6
7,2
7,1
6,9
6,7
6,6
6,6
6,3
6,2
6,0
Fonte: Unioncamere - Istituto G.Tagliacarne
9,9
12,6
15,5
9,1
8,7
10,1
8,3
8,2
8,0
7,6
6,4
8,0
6,6
5,6
11,0
Prov.
I processi di convergenza e divergenza tra le province italiane
I fattori dello sviluppo regionale
77
Pos. 02
Lucca
89
Belluno
90
Massa Carrara
91
Trieste
92
Biella
93
Como
94
Firenze
95
Torino
96
Roma
97
Lecco
98
Verbano-Cusio-Ossola 99
Genova
100
Varese
101
Prato
102
Milano
103
Peso % 02 Peso % 95
1,1
1,0
1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
2,1
1,1
1,4
0,9
1,4
0,7
0,9
0,9
0,7
0,4
1,0
0,5
0,4
0,3
0,3
Giuseppe Capuano
Industria
Prov.
78
Lecco
Reggio Emilia
Bergamo
Vicenza
Novara
Modena
Treviso
Biella
Pordenone
Prato
Belluno
Varese
Como
Brescia
Mantova
Pos. 02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Peso % 02 Peso % 95
45,9
44,7
42,7
42,7
41,8
40,9
40,9
40,2
40,1
39,8
38,9
38,8
38,1
37,4
37,3
49,5
45,3
47,1
47,3
44,1
43,9
45,0
46,2
42,2
44,7
41,9
44,0
42,1
41,3
40,9
Prov.
Ragusa
Foggia
Napoli
Enna
Catania
Catanzaro
Agrigento
Reggio Calabria
Trieste
Grosseto
Vibo Valentia
Messina
Palermo
Imperia
Roma
Pos. 02
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Peso % 02 Peso % 95
17,9
17,1
16,7
16,7
16,7
16,0
15,9
15,8
15,6
14,8
14,3
14,0
13,8
13,7
12,4
16,9
17,0
19,6
18,3
19,3
17,7
16,2
14,1
17,7
16,8
17,0
16,1
16,2
13,8
14,6
Servizi
Prov.
Roma
Palermo
Trieste
Messina
Napoli
Catania
Imperia
Genova
Vibo Valentia
Grosseto
Reggio Calabria
Agrigento
Massa Carrara
Aosta
Catanzaro
Pos. 02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Peso % 02 Peso % 95
87,1
84,0
83,6
83,3
81,7
80,8
80,4
80,3
79,1
78,8
78,8
78,8
78,4
78,2
77,7
Fonte: Unioncamere - Istituto G.Tagliacarne
84,6
80,9
81,3
80,4
78,7
77,1
75,3
79,5
76,6
76,6
77,9
76,6
74,0
73,5
76,8
Prov.
Belluno
Prato
Brescia
Biella
Cuneo
Pordenone
Cremona
Treviso
Modena
Novara
Bergamo
Vicenza
Mantova
Lecco
Reggio Emilia
Pos. 02
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Peso % 02 Peso % 95
60,2
59,8
59,4
59,0
58,1
57,3
57,0
56,9
56,3
56,1
55,9
55,2
54,9
53,7
52,0
57,0
55,0
55,0
52,5
54,5
53,7
54,2
52,1
52,9
53,4
51,6
50,5
50,4
50,1
51,1
Tab. 7 - Prime 15 e ultime 15 province italiane per tasso medio di crescita del PIL pro capite
- 1995/2002
Prov.
Crotone
Vibo Valentia
Matera
Isernia
Grosseto
Potenza
Massa Carrara
Ragusa
Bolzano
Enna
Belluno
Sassari
Trapani
Siena
Benevento
Var. % 95-02
7,19
6,35
6,00
5,95
5,94
5,79
5,61
5,56
5,48
5,39
5,27
5,27
5,24
5,18
5,18
n.i. 95
48,3
55,9
63,5
77,5
85,8
70,4
83,6
68,2
139,9
54,6
120,5
74,4
61,4
104,4
63,9
Prov.
L’Aquila
Bergamo
Udine
Trieste
Brescia
Vercelli
Biella
Siracusa
Reggio Emilia
Pordenone
Viterbo
Prato
Como
Lecco
Aosta
Var. % 95-02
3,44
3,40
3,38
3,35
3,34
3,33
3,23
3,14
3,09
2,98
2,93
2,76
2,68
2,34
2,31
n.i. 95
85,5
122,0
116,1
112,9
122,8
111,7
116,8
79,4
133,4
122,7
90,10
126,00
114,60
119,70
136,2
Fonte: Unioncamere - Istituto G.Tagliacarne
Da ultimo, l’analisi dei dati delle serie storiche del PIL con le relative articolazioni
(valori pro capite e di settore) fornisce ulteriori indicazioni. L’attenzione delle policy,
come già accennato, dovrebbe avere tra le priorità (uscendo da una lettura tradizionale
dei fenomeni economici su base regionale) soprattutto la determinazione di maggiori
tassi di crescita, più che la riduzione degli squilibri, che notoriamente possono essere
conseguiti anche in un contesto di sviluppo territoriale debole. Conseguire lo sviluppo
e non gestire gli squilibri, potrebbe essere un buon punto di partenza per la riflessione
degli attori locali dello sviluppo e per le Autorità centrali competenti.
I processi di convergenza e divergenza tra le province italiane
I fattori dello sviluppo regionale
79
Giuseppe Capuano
Cartina 1 - Mappatura provinciale in base al numero indice del PIL pro capite - Anno 2002
80
Fonte: Unioncamere - Istituto G.Tagliacarne
Cartina 2 - Mappatura provinciale in base al peso dell’agricoltura sul PIL - Anno 2002
I processi di convergenza e divergenza tra le province italiane
I fattori dello sviluppo regionale
81
Fonte: Unioncamere - Istituto G.Tagliacarne
Giuseppe Capuano
Cartina 3 - Mappatura provinciale in base al peso dell’industria sul PIL - Anno 2002
82
Fonte: Unioncamere - Istituto G.Tagliacarne
Cartina 4 - Mappatura provinciale in base al peso dei servizi sul PIL - Anno 2002
I processi di convergenza e divergenza tra le province italiane
I fattori dello sviluppo regionale
83
Fonte: Unioncamere - Istituto G.Tagliacarne
CAPITOLO
4
Il ruolo
del risparmio
nello sviluppo
regionale
A
40
I tratti principali della teoria keynesiana sono i seguenti: eguaglianza tra risparmio e investimento;
l’investimento determina
il risparmio; la domanda
aggregata determina il livello di produzione ed è
composta da consumi, investimenti, spesa pubblica e esportazioni nette.
41
La teoria dell’investimento basata sul principio
dell’acceleratore considera che gli investimenti
siano stimolati dall’accrescimento della domanda
finale. Se quest’ultima
fosse stazionaria, gli investimenti sarebbero limitati alla mera sostituzione
dei beni capitali obsoleti,
in base alla seguente relazione:
I = b (Xt – Xt-1). Il coefficiente b, che misura il
rapporto tra aumento di
reddito e aumento del
fondo capitale investito,
è l’acceleratore. Per un
approfondimento sul tema: A. Graziani (1981),
Teoria Economica, ESI,
Napoli, pp.439- 455.
4.1 Il risparmio nel modello Harrod-Domar
A partire dagli anni ’60 quasi tutti i piani di sviluppo elaborati nei
Paesi in via di sviluppo (PVS), hanno seguito implicitamente l’uso dei modelli di Harrod
(1948) e Domar (1958) o di loro derivazione (successivamente denominati H-D). Questi
modelli appartengono alla tradizione keynesiana, in quanto accolgono in pieno la “teoria del reddito” di J. M. Keynes (1936)40.
Il modello H-D è uno dei più semplici modelli macroeconomici dello sviluppo ed è
il primo che utilizza esplicitamente il meccanismo dell’acceleratore41, trasformando la teoria del reddito nazionale (statica e di breve periodo) in teoria dello sviluppo (dinamica e di
lungo periodo). La caratteristica di questo modello è quella di considerare la propensione
al risparmio (s/y) come variabile data e costante42, con la conseguenza che il tasso di sviluppo di equilibrio del sistema economico è determinato dal valore di questa variabile.
In questo contesto le scelte individuali sulla ripartizione delle risorse tra consumi e
investimenti sarà fondamentale per la determinazione del tasso di sviluppo, relegando in
secondo piano le decisioni degli imprenditori-investitori43.
Per comprendere meglio quanto svilupperemo successivamente, faremo un esempio
pratico del modello, utilizzando degli elementari esempi numerici.
Se la popolazione di un paese/regione aumenta del 2% l’anno, per ottenere una crescita del reddito pro capite del 2%, occorrerà che il reddito nazionale/regionale cresca del
4%. Ipotizzando che il rapporto marginale capitale-prodotto sia 3 (ciò significa che per
aumentare il prodotto di 1 Euro sarà necessario investirne 3), per conseguire un aumen-
Giuseppe Capuano
88
42
Nella teoria postkeynesiana la propensione al risparmio non è considerata costante come nella
teoria keynesiana ma dipende dalla distribuzione
del reddito nazionale tra
salari (la propensione al risparmio dei salariati è più
bassa) e profitti (la propensione degli imprenditori è più elevata). Di conseguenza, la propensione
media al risparmio dell’intera collettività dipenderà
dalla distribuzione del
reddito nella società.
43
Altre correnti di pensiero
hanno sostenuto posizioni opposte, ponendo il
ruolo dell’imprenditoreinvestitore in primo piano
rispetto alle scelte individuali. Tra questi si veda la
posizione dei Post-Keynesiani come J. Robinson,
N. Kaldor, R. Kahn e L. Pasinetti. Per una esposizione generale sul pensiero
postkeynesiano: I. Musu
(1980), I neokeynesiani,
Bologna, Il Mulino.
to del reddito del 4% bisognerà risparmiare e investire il 12% del PIL. Infatti, la formula
finale del modello è rappresentata dal rapporto: G = s/br dove: G è il tasso di accrescimento del reddito; s è la propensione al risparmio; br è il coefficiente di capitale. In termini numerici il rapporto nel nostro esempio sarà: 12%/3 = 4%.
Questa impostazione è stata sostenuta da numerosi economisti del sottosviluppo (ad
esempio Lewis, 1963; Myint, 1967, etc.), i quali ritenevano che una economia per raggiungere il “take-off ” dovrà risparmiare ed investire più del 10% del reddito nazionale/regionale.
Tale tesi è stata comprovata da alcuni studi sul risparmio riguardante i paesi occidentali durante il loro decollo economico.
Considerando con riserva la possibilità di applicazione di modelli economici e risultati empirici dei Paesi occidentali ai PVS o comunque a regioni in ritardo di sviluppo
dei Paesi industrializzati, riteniamo che il problema vada differenziato a seconda che si
considerino i primi o i secondi.
La realizzazione dei piani di sviluppo nei PVS ha visto nell’accumulazione del capitale, prima ancora della mancanza di un’adeguata propensione ad investire, uno dei maggiori problemi. Infatti, i modelli di sviluppo che si rifacevano a quello di H-D non hanno
dato i risultati sperati, a causa di un’insufficiente livello del risparmio necessario a favorire l’espansione degli investimenti.
Al contrario, il problema centrale del nostro Mezzogiorno, è antitetico a quello dei
PVS, in quanto il livello del risparmio potrebbe risultare sufficiente (grazie anche al
risparmio generato in altre realtà del nostro Paese e dai trasferimenti dovuti alla Pubblica
Amministrazione) a garantire una potenzialità d’investimento elevata, mentre la vera
strozzatura del modello è rappresentata dalla insufficienza degli investimenti e dalla loro
bassa produttività dove sono realizzati.
Di conseguenza, nel caso dei PVS, sarà il valore del numeratore (propensione al
risparmio) ad essere troppo basso da poter generare un tasso di crescita sufficientemente
elevato; nel Mezzogiorno, invece, è il livello degli investimenti ad essere insufficiente,
dando origine ad un tasso di accrescimento “effettivo” del reddito, inferiore al tasso di
accrescimento “giustificato”, dalle risorse disponibili e creare fenomeni di divergenza
rispetto alle economia regionali più forti del nostro Paese.
I risparmi, quindi, superano gli investimenti (esiste anche un gap negativo tra depositi e
impieghi realizzati nella macroregione) e ciò si manifesta generalmente in un accumularsi
delle scorte e quindi in un eccesso del coefficiente di capitale “effettivo” rispetto a quello
“giustificato”. La conseguenza è il perpetuarsi degli squilibri Nord-Sud e la realizzazione di
tassi di crescita insufficienti per il conseguimento del “take-off ” dell’economia meridionale.
I fattori dello sviluppo regionale
Il ruolo del risparmio nello sviluppo regionale
In conclusione, seguendo l’impostazione di H-D, è la propensione al risparmio a
determinare il tasso di sviluppo di equilibrio di una economia, e solo interventi che ne
determinino il livello (in aumento/diminuzione), prescindendo da variazioni della produttività del capitale, possono accelerare o ritardare lo sviluppo.
4.2 Una rivisitazione della teoria del “ciclo vitale” di Modigliani
e sua applicazione ad una economia a basso livello di sviluppo
Il livello della propensione al risparmio e del volume di reddito risparmiato in una
economia, in un determinato periodo è sempre stato ritenuto di estrema importanza nel
quantificare il grado di sviluppo raggiungibile da un paese/regione.
J.M. Keynes considerava il risparmio come mero residuo derivante dalla scelta del
soggetto economico di quanto destinare al consumo del reddito percepito, e teorizzava
una relazione diretta tra incremento del reddito ed incremento del risparmio (Y=sY),
anche se la quantificazione di tale relazione non risultava proporzionale.
Dallo studio delle serie storiche relative ai Paesi occidentali, però, tale incremento
non si registrava, nonostante l’aumento del livello del reddito.
Modigliani dette negli anni sessanta una brillante spiegazione della contraddizione
che si aveva tra l’ipotesi Keynesiana e la realtà economica. Egli elaborò una teoria del
“ciclo vitale” secondo la quale i soggetti economici risparmiano durante la loro età lavorativa per disinvestire durante la vecchiaia44.
La formulazione di tale teoria ha vissuto due momenti fondamentali: il primo risale
all’elaborazione di un lavoro presentato nel 1958 nel quale si sosteneva che la domanda
di beni di consumo dipende oltre che dal reddito corrente anche dal reddito futuro atteso.Tale ipotesi risulta irrilevante quando la differenza tra i due redditi è tendente a zero,
mentre al contrario essa è di estrema importanza in economie in fase di sviluppo.
Modigliani parte dalla considerazione che un individuo risparmi per preservarsi da
fluttuazioni di reddito future e contro l’incapacità di produrre reddito durante la vecchiaia, quindi egli fa le proprie scelte basandosi su un livello medio del reddito ritenuto
normale. In una economia dove sia crescita del reddito che della popolazione siano ritenute stazionarie, il risparmio netto ne risulterebbe nullo.
Al contrario, in una società progressiva, dove sia il reddito che la popolazione abbiano degli incrementi netti positivi, vi sarà un risparmio netto positivo, dovuto sia al fatto
che le classi che risparmiano, ossia quelle più giovani, sono più numerose di quelle anzia-
89
44
Per un approfondimento
sui principali scritti scientifici di Franco Modigliani: Modigliani, Reddito,
Interesse e Inflazione,
scritti scientifici raccolti
da Tommaso e Fiorella
Padoa-Schioppa, Einaudi, 1987, Torino.
Giuseppe Capuano
90
ne, sia perché, essendo il reddito previsto per la vecchiaia commisurato ad un reddito
medio crescente, l’ammontare di reddito risparmiato sarà maggiore.
Il secondo momento della teoria del “ciclo vitale” è rappresentato da uno studio apparso nel 196345, dove Modigliani riformulò parzialmente quanto ora detto, sostenendo che il
consumo (e quindi il risparmio), dipende dall’insieme di risorse in possesso del soggetto economico e cioè: a) reddito corrente; b) ricchezza accumulata; c) reddito futuro atteso.
Dato che si presume che il reddito futuro atteso sia proporzionale al reddito corrente, si può ritenere che il consumo dipenda solo dalle prime due grandezze (reddito corrente e ricchezza cumulata), potendo scrivere: Ct = Wt + cXt dove: W rappresenta la
ricchezza accumulata e c rappresenta l’influsso esercitato sul consumo dal reddito corrente e dal reddito atteso (Xt).
Dalle considerazioni fatte da Modigliani sul perché si possa avere un livello anziché
un altro del volume di risparmio presente in una economia, riferendoci al caso specifico
di una economia regionale in fase di sviluppo come il Mezzogiorno d’Italia, riteniamo
che le motivazioni addotte da Modigliani per spiegare il livello del risparmio in una economia nazionale o regionale che non sia fortemente sviluppata, presentano qualche
punto debole, nel senso che la teoria del “ciclo vitale” è valida a spiegare il livello di
risparmio quando si tratta di economie avanzate; al contrario presenta qualche problema
di tipo esplicativo quando l’analisi si sposta su realtà in fase di sviluppo.
Per dare una evidenza empirica alle nostre affermazioni daremo successivamente
alcuni dati sull’andamento della popolazione e del risparmio nel Mezzogiorno confrontandoli con quelli del Centro-Nord d’Italia e traendone alcune conclusioni.
La popolazione nel Mezzogiorno è passata dai 18 milioni 874mila unità del 1971 ai
20 milioni 475mila del 2002 (Tab.8), passando dal 34 al 35,9% sulla popolazione totale
italiana, contro una riduzione del peso delle regioni del Centro-Nord (65% nel 1971
contro il 64% del 2002).
Tab. 8 - Andamento della popolazione (migliaia di unità)
45
Modigliani, F. (1963), The
“Life Cycle” Hipothesis
of Saving: Aggregate Implications and Test, in “
American Economic Review”, vol. 53.
1971
1981
1991
2001
2002
Centro-Nord
35.262
36.504
36.241
36.054
36.598
Mezzogiorno
18.874
20.053
20.537
20.251
20.475
Italia
54.137
56.557
56.778
56.306
57.073
Fonte: ISTAT
I fattori dello sviluppo regionale
Tab. 9 - La popolazione italiana e l’indice di vecchiaia
1971
1981
1991
2000*
Più di 65 anni
6.101.820
7.475.719
8.700.185
10.555.935
Totale
54.136.547
56.556.911
56.778.031
57.844.017
Indice di vecchiaia
41,9
66,8
105,2
127,1
CENTRO-NORD
1971
1981
1991
2000
Più di 65 anni
n.d.
5.212.362
6.052.997
7.256.540
Totale
n.d.
36.564.493
36.240.547
36.993.866
Indice di vecchiaia
n.d.
75,2
124,4
154,4
MEZZOGIORNO
1971
1981
1991
2000
Più di 65 anni
n.d.
2.263.357
2.647.188
3.299.395
Totale
n.d.
19.992.418
20.537.484
20.850.151
Indice di vecchiaia
n.d.
44,2
63,9
91,5
* Il dato non censuario relativo alla popolazione presenta una notevole differenza con quello presente nella tabella precedente
(censuario, 2001) a causa delle diverse modalità di calcolo.
Fonte: ISTAT
Tale andamento ha portato ad un invecchiamento della popolazione italiana più forte
al Centro-Nord che al Sud. Seguendo la teoria di Modigliani, il risparmio nelle regioni
meridionali avrebbe dovuto avere un trend migliore rispetto al Centro-Nord. Invece, l’evidenza empirica sembrerebbe confutare tale ipotesi: se al Nord la propensione al risparmio del sistema economico macroregionale, nell’ultimo decennio, è stata pari a circa il
21%, nel Mezzogiorno risulta pari a circa il 17%. Inoltre, il risparmio delle regioni del
Centro Nord nello stesso periodo è cresciuto del 23% contro il 19% del Sud.
Il ruolo del risparmio nello sviluppo regionale
ITALIA
91
Giuseppe Capuano
Tab. 10 - Tasso di disoccupazione
92
1981
1991
2001
2002
Centro-Nord
7,2
6,5
5,0
4,7
Mezzogiorno
13,9
19,9
19,3
18,3
Italia
9,2
10,9
9,5
9,0
Fonte: ISTAT
A nostro avviso tale situazione è spiegabile con l’inserimento nel ragionamento teorico anche del concetto di “aspettativa” e di differenti tipologie di fonte di reddito.
Nel modello presentato da Modigliani una popolazione più giovane, è sinonimo di
maggiore produttività e maggiore occupazione, caratteristiche tipiche di una economia
altamente sviluppata, con un relativo incremento del volume di reddito risparmiato. Al
contrario in una economia in fase di sviluppo, come quella del Mezzogiorno, una popolazione in crescita è una delle cause della maggiore disoccupazione (Tab. 10). L’alto livello della disoccupazione meridionale produce una rilevante quota di redditi da trasferimento di vario genere (a volte integrate anche da redditi derivanti da “lavoro nero”), atti
a compensare il mancato reperimento di redditi da lavoro (Tab. 11).
Tab. 11 - Struttura del reddito familiare (2000)
Reddito lavoro Reddito libera Reddito da
dipendente
professione trasferimento
Reddito da
capitale
Totale
Centro-Nord
41,0
14,4
21,5
22,9
100,0
Mezzogiorno
38,1
15,3
28,0
18,6
100,0
Italia
40,0
14,6
23,2
22,1
100,0
Fonte: BANCA D’ITALIA
Caratteristica di queste particolari fonti di reddito è che esse hanno una più bassa
propensione media al risparmio dovuta sia all’esiguità dell’importo pro-capite dei sussidi sia alla temporaneità della loro erogazione.
Partendo da questo assunto e ampliando il campo di applicazione della riflessione,
noi sosteniamo che esistono non una ma n propensioni medie al risparmio quante sono le tipologie di fonti di reddito dalle quali è generata, in quanto i comportamenti umani sono diffe-
I fattori dello sviluppo regionale
Il ruolo del risparmio nello sviluppo regionale
renziati in base alle caratteristiche, in termini di valore e durata, del reddito percepito e,
soprattutto, di quello atteso.
Questa nostra conclusione si basa sui principi dettati dall’economia comportamentale ed
in particolare sul concetto di “contabilità mentale”, che unisce la scienza economica alla
psicologia. Questa idea, sviluppata da Richard Thaler dell’Università di Chicago, sottolinea come uno degli errori più comuni e costosi legati al denaro, ovvero la tendenza a
valutare il valore, ad esempio di un euro, minore di un altro euro a seconda della fonte
di reddito e della sua quantità46.
Formalizzando una simile conclusione si può descrivere il fenomeno con la seguente equazione:
S/Y = Sj/Yj + Sn/Yn
dove:
S/Y è la propensione media al risparmio totale;
Sj/Yj è la propensione media al risparmio determinata da redditi da lavoro dipendente/autonomo;
Sn/Yn è la propensione media al risparmio determinata da altre fonti di reddito (in
particolare sussidi, trasferimenti, etc.);
Più le caratteristiche delle fonti di reddito si avvicinano a quelle da lavoro dipendente/autonomo (reddito costante nel tempo, adeguato almeno ai livelli minimi di settore,
etc.) maggiore, a parità di condizioni, è la propensione media al risparmio (S/Y) di una
regione rispetto a quelle dove la composizione del reddito vede le fonti di reddito “non
permanenti” o che si avvicinano alla “gratuità” (Sn/Yn), avere un peso più elevato.
Questa affermazione ben si sposa con un assunto già conosciuto nella letteratura economica con il quale si afferma che le regioni economiche con più basso livello di reddito
hanno una propensione al consumo (C/Y) più elevata rispetto a realtà a reddito più alto.
Altra componente che influenza la formazione del risparmio, sono le aspettative
riguardanti la possibilità di uno sviluppo accelerato o comunque con tassi di crescita più
elevati rispetto al resto del Paese. Esse sono mediamente peggiori perché basate su informazioni di tipo storico che ne influenzano fortemente la formazione.
La differenza di segno delle aspettative tra una realtà regionale più ricca rispetto ad
una più povera non è l’unica, in quanto, a parità del trend previsto, i comportamenti sono
diversi secondo il livello del reddito: in un paese avanzato economicamente, la presenza
93
46
Per un approfondimento
sull’economia comportamentale: Belsky, G. and
Gilovich, T, (2003), Soldi
al vento, Etas.
Giuseppe Capuano
94
47
In questa direzione va anche il modello econometrico del Ministero del Tesoro
nel Piano di Sviluppo del
Mezzogiorno 2000-2006
che, grazie all’input degli investimenti generati dai
Fondi Strutturali, aveva previsto una crescita tanto elevata (5-6% annuo, tasso tre
volte superiore alla crescita
media registrata dal Mezzogiorno nella seconda metà
degli anni novanta), da riassorbire in parte la disoccupazione meridionale e un
cambiamento della struttura sociale, in quanto il sottosviluppo del Sud non ha
cause solo economiche, ma
soprattutto culturali e politiche; in pratica “crescita più
cambiamento” come affermava H. Singer (1975), The
strategy of economic development, Mac.Millan. Per
una critica ai risultati in termini di tasso di crescita del
modello econometrico del
Ministero del Tesoro: Capuano, G., Il ciclo di vita dell’Osservatorio Economico
Locale. Un approccio teorico alla lettura delle dinamiche del territorio, W.P. Istituto Tagliacarne, n.27.00.
di aspettative negative favorisce il risparmio per far fronte ad una diminuzione in termini reali del reddito futuro atteso con una conseguente contrazione dei consumi; in una
economia più debole avviene generalmente il contrario.
Infatti, in economie in fase di sviluppo, come possono essere considerate molte regioni del Mezzogiorno, le aspettative negative sulla crescita, coadiuvate da livelli di reddito
pro-capite medio-bassi e da particolari fonti di reddito (in particolare da trasferimenti,
sussidi, etc.), portano ad una diminuzione della propensione media al risparmio del sistema o comunque ad un suo livello più basso rispetto ad una situazione di “ottimo paretiano” ed a un aumento dei consumi.
Altro aspetto riguarda la formazione del reddito futuro atteso. In una economia in
fase di sviluppo esso risulta essere indipendente rispetto al reddito corrente o comunque
non avere un forte legame. Ciò è in parte spiegabile in base all’esperienza storica dei
trend di crescita del PIL. Lo sviluppo di una economia si manifesta quasi sempre per
“balzi” e l’esempio del “boom” italiano nel periodo 1958-1963 o l’esempio dei Paesi di
nuova industrializzazione ne sono una prova47.
Solo se la crescita è graduale e costante nel medio-lungo periodo (come quella statunitense alla quale Modigliani fa riferimento), il reddito futuro atteso è proporzionale al
reddito corrente. Ciò non accade per le motivazioni esposte in precedenza in quelle economie nazionali o regionali in fase di sviluppo/deboli. Per questo motivo uniformare il
reddito futuro atteso con quello corrente nella funzione al consumo è discutibile quando si analizza il livello del consumo in una economia del secondo tipo. Inoltre, anche la
propensione al consumo è condizionata, secondo le tesi esposte in precedenza, dalla fonti
di reddito che lo generano.
Da ciò la funzione del consumo potrà essere scritta nella forma seguente:
1) C = Cr + Cf ;
2) Cr = Cn + Cj;
3) C = Cn + Cj + Cf ;
dove :
Cr = reddito corrente;
Cj è il consumo determinato da redditi da lavoro dipendente\autonomo;
Cn è il consumo determinato di altre fonti di reddito;
Cf è il consumo determinato dalle aspettative sul reddito futuro atteso.
Considerando l’equazione del reddito in termini keynesiani ossia Y = C + S e andando a sostituire al secondo membro la funzione del consumo e al risparmio (modificata
con la componente determinata dalle aspettative) come da noi esposte ed integrate in
precedenza, avremo:
4) Y = (Cn + Cj + Cf) + (Sj + Sn + Sf)
5) Y – Cn – Cj – Cf = (Sj + Sn + Sf)
L’equazione 2) può anche essere espressa in funzione del consumo totale introducendo dei coefficienti che esprimono il rapporto tra il consumo derivante dalle altre fonti
di reddito, da lavoro e dalle aspettative sul reddito futuro atteso.
Più elevato sarà il valore dei sussidi erogati (componente importante delle “altre fonti
di reddito” in una realtà economica debole), maggiori saranno le aspettative negative nei
termini spiegati precedentemente, più alti saranno i consumi, e di conseguenza più basso
sarà il livello di reddito risparmiato.
In conclusione, la teoria del “ciclo vitale” può spiegare meglio il livello di risparmio
in un paese economicamente avanzato, mentre la teoria del “ciclo vitale integrata” (come
si sintetizza nella 4), ci sembra più efficace nel tentare di spiegare la formazione del
risparmio in una regione in fase di sviluppo o a economia debole di un paese industrializzato come potrebbero essere alcune realtà regionali del nostro Mezzogiorno.
Il ruolo del risparmio nello sviluppo regionale
I fattori dello sviluppo regionale
95
CAPITOLO
5
Debito pubblico,
redistribuzione
del reddito
e squilibri
regionali
I
n questo ultimo capitolo si analizzerà un particolare aspetto di finanza pubblica,
quale il finanziamento del deficit dello Stato attraverso il debito pubblico e
come quest’ultimo ha impattato sulla distribuzione del reddito e su come la sua
formazione abbia contribuito agli squilibri regionali Nord-Sud.
Al centro della nostra analisi è lo studio delle dinamiche del debito pubblico nel
periodo compreso tra il 1975 ed il 1985 (anno in cui per la prima volta il debito pubblico superò il valore complessivo del PIL), anni cruciali per la formazione del debito
dello Stato sui livelli che ancora oggi conosciamo. La nostra tesi è che la forte crescita del
debito pubblico di quegli anni e il suo successivo mantenimento su livelli superiori al
100% del PIL ha influito negativamente sulla riduzione degli squilibri Nord-Sud a tutto
vantaggio delle regioni settentrionali del Paese.
L’analisi svolta è un evidente esempio di come fattori di natura palesemente macroeconomica e di apparente neutralità sul livello mesoeconomico, hanno un impatto notevole nella determinazione delle traiettorie dello sviluppo regionale.
5.1 Lo scenario economico di riferimento
Dalla fine degli anni ’50 gli Stati europei si sono dotati di un regime di protezione sociale che non aveva precedenti nelle economie occidentali: il cosiddetto “Welfare State”.
L’impostazione macroeconomica che accompagnava la costituzione dello “Stato
sociale”, era prevalentemente Keynesiana e prevedeva un aumento dell’intervento dello
Stato nell’economia tramite l’incremento dei livelli di spesa.
99
Giuseppe Capuano
100
La spesa pubblica doveva essere lo strumento di politica economica atto a sollecitare
la crescita del PIL ed assumere il ruolo di ammortizzatore sociale nell’intento di elevare
il tenore di vita dei soggetti economici con livelli di reddito medio-bassi.
In ogni caso questo tipo di intervento statale era l’espressione di una situazione congiunturale che negli anni sessanta presentava alti tassi di crescita del PIL (in media 5-6%
annuo) e forti incrementi dell’occupazione (aumento medio annuo dell’1-1,5%).
Il favorevole andamento ciclico subì una inversione di tendenza negli anni ’70.
Le cause principali che portarono al mutamento dello scenario dell’economia internazionale le ritroviamo principalmente nell’aumento dei prezzi delle materie prime alimentari negli anni 1970-72 e nelle due crisi petrolifere (1973–1974 e 1978-1979) e in
tutti gli effetti a catena che da esse generarono.
Questo decennio fu caratterizzato (come i primi anni ’80) da una fenomeno sconosciuto alle economie europee fino ad allora: la stagflazione, ossia un mix tra alti tassi d’inflazione e elevata disoccupazione (Tab.1).
Tab. 12 - Inflazione e disoccupazione nell’Europa a 10
Paese
48
Per “curva di Phillips” si
intende la relazione empirica rilevata dall’economista inglese A.W.Phillips (1914-1975) tra variazione dei salari (successivamente trasformata da
R.G.Lipsey in tasso di inflazione) e livello della disoccupazione in uno studio sull’economia britannica apparso nel 1958.
Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito
1961-70
Infl.
3.1
5.8
2.7
2.5
4.3
4.6
3.8
2.5
4.1
3.9
1971-80
Disoc.
2.2
1.1
0.8
°*°
0.9
4.5
5.2
0.1
1.0
1.9
Infl.
7.1
10.1
5.1
13.6
9.5
13.8
14.6
6.7
7.8
13.3
1985
Disoc.
5.5
3.8
2.7
°*°
3.8
7.4
6.0
0.3
4.5
4.2
Infl.
6.0
4.2
2.1
18.0
5.8
5.7
8.6
3.7
2.4
5.3
Disoc.
13.8
9.1
8.4
8.3
10.7
17.1
12.6
1.7
13.2
12.0
Fonte: Commissione Europea, Relazione Economica Annuale 1985-86
La presenza di questo fenomeno mise in discussione tutta l’impostazione Keynesiana,
a cominciare dal ruolo svolto dallo Stato nell’economia a finire alla validità empirica della
“curva di Phillips”48.
Nonostante lo scenario economico internazionale fosse cambiato radicalmente in
senso negativo, si vollero mantenere gli stessi livelli di spesa, anzi essi aumentarono in ter-
Debito pubblico, redistribuzione del reddito e squilibri ...
I fattori dello sviluppo regionale
mini reali, passando nella Ue dal 37,9% del PIL nel 1970 al 51,5% del PIL nel 1985.
Tale incremento portò inevitabilmente ad una crescita dei deficit nazionali. Ciò si
verificò in quanto se la spesa pubblica poteva essere agevolmente finanziata con prelievi
obbligatori in anni di forte crescita, in un periodo in cui il tasso di crescita del PIL era
debole o addirittura negativo (1981-1983) l’equilibrio tra entrate e uscite degli Stati
veniva a rompersi.
Altra caratteristica presente nella spesa pubblica negli anni settanta - ottanta è la
modificazione della sua struttura.
Se nel 1973 le spese in conto capitale rappresentavano mediamente il 4,1% del PIL,
esse cadevano al 2,9% nel 1982, mentre le spese in conto corrente delle Amministrazioni
Pubbliche aumentavano, nello stesso periodo, dal 35% al 47% del PIL 49.
Tutto ciò andava contro gli stessi principi Keynesiani, ai quali essa si era ispirata, dato
che, J.M. Keynes teorizzava che solo le spese per investimenti fossero finanziate in deficit e non certo, anche e soprattutto quelle per trasferimenti.
Non a caso, nella Ue, il deficit pubblico dal 3,1% del PIL nel 1971-80 passò al 5,7%
nel 1982, per poi discendere al 5,2% del 1985, al 4,6% nel 1986 e al 4,4% nel 1987.
Ovviamente la situazione dei singoli Paesi Ue si presentava alquanto eterogenea (Tab.
13): vi erano alcuni Paesi dove il deficit superava il 10% del PIL (Irlanda, Portogallo e
Italia), altri in cui il saldo del bilancio statale era in attivo (Lussemburgo e Danimarca).
Di conseguenza, quando si parla di media Ue in quel periodo, bisogna considerare lo
stato di eterogeneità in cui si presentavano le singole economie, situazione che, attraverso il rispetto dei parametri di Maastricht, si è abbastanza modificata a favore di una maggiore omogeneità.
Nonostante tutto, gli Stati europei hanno ancora oggi l’esigenza di contenere un
deficit strutturale che comunque si è molto ridimensionato negli ultimi anni, in particolare in Italia (da alcuni anni il deficit di bilancio è al di sotto del 3% in termini di PIL).
101
49
M.Albert - R.J.Ball, Per
una ripresa dell’economia europea negli anni
’80, in Documenti di Lavoro, Parlamento Europeo, 1983.
Giuseppe Capuano
Tab. 13 - Evoluzione del deficit del bilancio dello Stato (in % del PIL)
Paese
102
1970
1973
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Olanda
Portogallo
Regno Unito
-2.2
4.1
0.2
°*°
0.7
0.9
°*°
-3.5
2.7
-1.2
°*°
3.0
-3.3
5.2
1.2
°*°
1.1
0.9
°*°
-7.0
3.3
1.0
°*°
-2.7
-12.6
-7.1
-3.9
-10.6
-3.0
-1.8
-15.8
-11.7
-2.3
-5.2
-10.1
-2.7
-11.1
-9.3
-3.4
-9.4
-5.8
-2.5
-14.2
-12.7
-1.3
-7.1
-8.8
-2.4
-11.7
-7.3
-2.5
-8.9
-5.4
-3.2
-11.8
-12.4
-0.8
-6.5
-7.1
-3.7
-9.8
-4.2
-1.9
-10.1
-5.0
-2.9
-9.7
-13.0
1.5
-6.3
-7.7
-4.2
-9.3
-1.9
-1.1
-13.9
-6.2
-2.6
-11.4
-14.0
4.2
-5.1
-11.1
-3.1
-8.9
2.4
-0.7
-9.5
-5.1
-2.4
-9.6
-12.7
3.7
-5.2
-11.2
-3.2
-8.1
3.2
-0.3
-6.4
-4.7
-2.6
-9.
-12.8
2.6
-5.8
-11.2
-2.9
UE a 12
0.3
1.0
-5.2
-5.7
-5.6
-5.4
-5.2
-4.6
-4.4
Fonte: Commissione Europea
5.2 La crescita del debito pubblico negli anni ottanta
La presenza di un elevato deficit di bilancio, a partire dalla fine degli anni settanta,
determinò in Italia un forte aumento del debito pubblico.
Le alternative di finanziamento del debito possono essere generalmente le seguenti:
a) espansione della base monetaria;
b) aumento della pressione fiscale;
c) ricorso al debito pubblico;
d) prestiti esteri.
A riguardo della base monetaria la tentazione di far ricorso all’espansione degli
aggregati monetari (M1; M2; M3) in quegli anni era molto forte. Essa si attuava principalmente tramite un processo di monetizzazione del debito pubblico. La Banca centrale
sottoscriveva dei titoli pubblici, rimpiazzando con un debito non remunerato (la moneta Banca centrale) i titoli di Stato con remunerazione reale.
I fattori dello sviluppo regionale
Infatti, in uno studio dell’OCSE 50 si dimostrava che, anche se non vi era una relazione diretta e proporzionale tra crescita del deficit pubblico e base monetaria, esisteva
negli anni ’70 un preciso rapporto causa-effetto (Tab. 14).
Tab. 14 - Espansione monetaria in alcuni Paesi occidentali (in %)
Paese
1970
1975
1982
USA
Giappone
Germania Fed.
Francia
Gran Bretagna
Italia
Belgio
Danimarca
5.9
16.9
8.9
15.0
9.4
14.9
8.1
4.8
10.2
14.5
11.5
15.7
7.1
15.7
15.3
27.0
12.2
7.6
6.9
11.3
11.4
17.5
7.7
11.1
Fonte: FMI, Statistiques Financières Internationales, 1983.
Ma la spinta a finanziare il deficit tramite l’aumento della base monetaria doveva
rientrare per problemi di natura inflazionistica, che portarono i governi europei ad applicare una politica monetaria restrittiva con un aumento dei tassi d’interesse, che seguendo a ruota la crescita dell’inflazione, aumentavano il costo medio del debito.
Se si fosse seguita all’infinito tale politica, la crescita del PIL nominale sarebbe stata
necessariamente maggiore, con un tasso di inflazione costantemente accelerato, superiore ai tassi d’interesse pagati per il debito corrente, ottenendo la riduzione del debito pubblico, del deficit e dell’onere sul debito in termini di PIL, operando anche la possibilità
di far aumentare la spesa.
Di conseguenza negli anni ’80 si conobbe una situazione economica in cui la politica di spesa risultava espansiva e la politica monetaria restrittiva. Il risultato fu l’annullamento dei reciproci effetti, dove gli incrementi di produzione e domanda interna messi
in essere dalla politica di bilancio espansiva, furono quasi totalmente frenati dall’aumento dei tassi d’interesse51.
Per quanto riguarda la pressione fiscale, in quel periodo aumentò fortemente, limitando i margini di manovra negli anni successivi, portando la pressione fiscale in Europa
ai livelli poi conosciuti anche negli anni novanta52.
50
P. Atkinson - A. Blundell
Wignall, Financement du
déficit budgétaire et controle monétaire; R. Price,
Déficit du secteur public:
problémes et implication
em matiére de politique;
i due lavori sono stati presentati dall’OCSE nel
1983.
51
M. J. de Larosiére, Les récentes augmentations
de la dette pubblique
menacent la reprise économique, in Bulletin del
FMI del 10 settembre
1984.
52
Già C. Clark affermava
che una pressione fiscale
del 25% poteva provocare fenomeni inflazionistici
mentre J.M. Keynes
preannunciava la rivoluzione se tale pressione
avesse superato il 50%.
Giuseppe Capuano
104
Mediamente nei paesi della CEE, nel 1984, essa era pari al 46,4%, per assestarsi su
questi valori sia nel 1985 (46,3%) che nel 1986 (46%). Anche in questo caso la situazione nell’Unione Europea si presentava eterogenea: in Danimarca e Olanda la pressione
fiscale era pari al 55%, in Italia al 48%, in Germania al 46%, in Francia al 45%, in Gran
Bretagna al 41%, in Grecia al 25%, e in Spagna al 26,3%.
In ogni caso, per ragioni di ordine economico-sociale e per il livello della spesa pubblica, interventi sul volume delle entrate, sia in aumento che in diminuzione, erano tecnicamente improponibili se non si fossero verificati mutamenti sia qualitativi che quantitativi del bilancio degli Stati membri.
Secondo l’annuale relazione della Banca centrale spagnola del 1986, una soluzione
duratura del deficit pubblico doveva basarsi sulla riduzione della spesa pubblica, in quanto, come confermava l’esperienza maturata, gli intenti di risolvere il problema con un
aumento delle entrate, senza ridurre la spesa, finiscono spesso per creare una situazione
nella quale il maggior volume di introiti fiscali finanzia un livello superiore di spesa.
A questo proposito, è rilevante ai fini del nostro lavoro sottolineare la composizione
di alcune voci delle entrate dei vari Stati Ue nel periodo 1970 - 1985. Se le imposte indirette rappresentavano un peso alquanto invariato in termini di PIL tra il 1970 ed il 1985
(anzi una leggera diminuzione), le imposte dirette crebbero dal 10,3% del 1970 al 13,2%
del 1985 (Tab. 15).
Tab. 15 - Struttura delle entrate della UE (in % del PIL)
Imposte indirette
Imposte dirette
1970
1982
1985
13.9
10.3
13.5
13.0
13.8
13.2
Fonte: EUROSTAT
Questi dati confermano l’ipotesi che i redditi da lavoro dipendente erano quelli che
maggiormente subirono l’aumento della pressione fiscale sia per far fronte agli aumenti
della spesa pubblica sia, come vedremo successivamente, per l’aumento dell’onere degli
interessi sul debito pubblico. E cosa più preoccupante è che l’andamento della struttura
produttiva europea, a partire da quel periodo, si indirizzò sempre più ad aumentare il peso
del lavoro autonomo sul totale, a discapito del lavoro dipendente, con la conseguenza di
concentrare in maniera crescente la pressione fiscale su un numero decrescente di contribuenti.
Questo dato è ancora più rilevante se lo commisuriamo all’aumento pro-capite dei
redditi da lavoro dipendente nei singoli Paesi Ue nel triennio 1983 - 85.
Tab. 16 - Redditi da lavoro dipendente (RDL), imposte dirette (ID), tasso di inflazione (infl.) (var.%)
RDL
1983
ID
infl.
RDL
1985
ID
infl.
Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito
6.7
6.4
3.9
19.7
10.9
19.3
16.0
6.6
3.4
8.7
1.9
13.3
3.6
17.6
11.9
15.1
25.2
18.6
-2.4
6.6
7.5
7.1
3.2
19.5
9.4
8.3
14.9
9.1
2.8
5.2
5.7
3.7
3.2
19.0
5.9
7.0
10.2
4.9
1.4
7.7
7.4
9.5
6.3
23.2
4.6
6.8
8.9
6.1
0.1
8.6
4.9
4.2
2.1
18.0
5.8
5.7
8.6
3.7
2.4
5.3
CEE
10.1
11.1
8.7
6.8
8.1
6.0
Paese
Fonte: elaborazione propria su dati EUROSTAT
Dalla Tabella 5 si nota che in termini reali i redditi da lavoro dipendente pro-capite
crebbero di poco tra il 1983 ed il 1985, anzi in alcuni Paesi (come ad esempio in
Danimarca e Olanda), subirono un decremento. Al contrario, le imposte dirette si attestarono su incrementi reali consistenti in tutti i Paesi (ad accezione dell’Olanda e della
Francia nel 1985) o, in molti casi, si registrò un aumento più che proporzionale delle
imposte dirette sulla crescita conseguita dai redditi del lavoro dipendente. Gli unici Paesi
dove l’aumento dei redditi da lavoro dipendente crebbero maggiormente sia rispetto alle
imposte dirette che all’inflazione furono l’Italia, la Francia e l’Irlanda (1985), anche se il
nostro Paese nel 1983 fece registrare il più alto incremento delle imposte dirette
(+25,2%) nella Comunità Europea di allora.
Quanto rilevato ci sarà di estrema utilità per le conclusioni di questo breve saggio.
In riferimento ai punti c) e d) se si considera modesto il finanziamento della spesa
pubblica italiana tramite i prestiti esteri (è il caso ad esempio della Germania), non ci
Debito pubblico, redistribuzione del reddito e squilibri ...
I fattori dello sviluppo regionale
105
Giuseppe Capuano
106
rimane che analizzare il ricorso al debito pubblico, che è stato lo strumento di politica di
bilancio maggiormente utilizzato fino ad oggi.
Infatti, tra il 1975 ed il 1986 il valore del debito pubblico in percentuale al prodotto
interno lordo italiano crebbe enormemente, superando nel 1985 la “barriera” del 100%
in termini di PIL (tab. 17), fino a raggiungere nel 1994 il suo valore più alto (il valore del
debito pubblico italiano raggiunse in quell’anno il 124,9% del PIL).
Anche in altri Paesi europei tale percentuale superò in quegli anni il valore del prodotto interno lordo (oltre all’Italia, anche Belgio e Irlanda), mentre in altri subì un incremento molto forte (Danimarca).
Una delle ragioni di questo processo indiscriminato di crescita lo si deve alla sottovalutazione per molto tempo del problema, in quanto l’accelerazione dell’inflazione (in
quel periodo a “due cifre”), con la caduta dei tassi d’interesse reali, provocò l’effetto di
ridurre temporaneamente il livello del debito pubblico sul reddito nazionale.
Tab. 17 - L’indebitamento pubblico in Europa (in % del PIL)
Paese
Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Olanda
Portogallo
Regno Unito
UE a 12
1973
1981
1982
1983
1984
1985
1993
1994
1995
63.2
5.0
18.6
°*°
°*°
25.1
65.5
62.5
20.5
43.4
°*°
63.3
88.1
43.6
36.4
33.0
21.0
26.0
89.8
73.2
14.0
50.3
59.0
51.1
96.1
52.7
39.5
36.7
26.2
29.1
96.6
80.0
14.4
55.6
62.2
57.7
105.1
62.7
41.7
41.4
32.1
30.7
107.7
87.6
14.8
62.3
70.9
57.4
111.6
67.6
42.0
49.9
39.3
29.3
113.6
94.5
14.8
67.0
75.7
58.7
118.3
66.3
42.7
56.8
46.3
31.8
115.7
103.0
14.5
70.6
81.2
56.9
135.2
81.6
48.0
111.6
60.0
45.3
96.3
119.1
6.1
81.2
63.1
48.5
133.5
78.1
50.2
109.3
62.6
48.5
89.1
124.9
5.7
77.9
63.8
50.5
131.3
73.3
58.0
110.1
65.5
52.7
82.3
124.2
5.9
79.1
65.9
53.9
40.35
44.9
49.8
53.4
56.0
58.9
65.9*
68.0*
Fonte: Commissione Europea
(*) I valori relativi agli anni 1993, 1994 e 1995 sono il risultato di una media considerando l’Ue a 15 e non a 12.
71.0*
Debito pubblico, redistribuzione del reddito e squilibri ...
I fattori dello sviluppo regionale
D’altro canto il forte incremento dei tassi di crescita degli anni ’60 e inizio anni ’70
aveva fatto pensare, erroneamente, che tale crescita potesse persistere all’infinito e permettere di finanziare senza problemi il debito pubblico.
Ciò si spiega col fatto che quando il tasso di crescita del PIL è elevato il valore del
deficit pubblico diminuisce (effetto combinato di maggiori entrate fiscali e minori spese
assistenziali) facendo decrescere anche il valore del debito dello Stato in termini del PIL.
La situazione è molto differente quando la crescita dell’economia è debole, i deficit
sono alti e i tassi d’interesse reali tendono a crescere. Questa ipotesi rispecchia fedelmente
la reale situazione economica verificatasi nella Ue nei primi anni ottanta, con il risultato di
accrescere sia il debito pubblico che l’onere degli interessi pagato dallo Stato sullo stesso.
5.3 L’impatto del debito pubblico sulla redistribuzione del reddito
Dopo la descrizione dello scenario di riferimento nel quale si è determinata la
crescita del debito pubblico tra il 1975 ed il 1985, arriviamo alla formulazione della
prima tesi sostenuta in questo capitolo: il debito pubblico ha determinato un effetto redistributivo del reddito.
Già nel XIX secolo alcuni economisti si ponevano il problema del deficit dello Stato e
se fosse irrilevante finanziarlo con ulteriori imposte o facendo ricorso al debito pubblico.
Davide Ricardo, in un primo momento, sosteneva la tesi “dell’equivalenza” per poi
disconoscerla successivamente dicendo che se le imposte riducono i consumi, il debito
riduce il risparmio e se nel breve periodo esso ha un effetto espansivo sull’economia
rispetto alle imposte, nel lungo periodo provoca delle strozzature nell’accumulazione del
capitale53.
Altri economisti, rifacendosi alla prima tesi di Ricardo, ritengono che il debito pubblico non provochi un “effetto ricchezza” ma che esso crei un “effetto zero” per l’intera
collettività, con un processo di traslazione del debito tra una generazione e l’altra54, mentre altri ancora sono di opinione nettamente contraria55. In questo ultimo filone si pone
il nostro lavoro, dove si tenta di dimostrare che il debito pubblico favorisce una redistribuzione del reddito all’interno del Paese, quindi esso è un fenomeno che produce effetti netti e non nulli.
La nostra tesi si basa sul fatto che i soggetti che sono titolari di titoli di Stato e che
quindi usufruiscono del pagamento degli interessi, sono differenti e numericamente
53
D. Ricardo, On the Principales of Political Economy and Taxation, in J.
R. Mc Culloch, The Works
of Davide Ricardo, Cambridge, 1951.
54
R. Barro, Are Governement Bonds Real Wealth
in Journal of Political
Economy, nov. dic. 1984,
pp. 1095-1117.
55
W. Buiter - J. Tobin, DEBT
Neutraly: A Brief Review
of Doctrine and Evidence, in Social Security vs.
Private Saving, a cura di
G.von Fustemberg, Cambridge (Mass), 1980, pp.
39-63.
Giuseppe Capuano
108
meno numerosi rispetto a coloro sui quali grava il maggior peso della pressione fiscale: i
lavoratori dipendenti (vedere paragrafo precedente).
Con questo non si vuol dire che i lavoratori dipendenti non posseggono titoli di Stato,
ma che la percezione degli interessi sui titoli da loro posseduti li compensa solo in parte delle
imposte pagate allo Stato per far fronte al maggiore onere in conto interessi. Onere che tra
il 1975 e il 1985 in molti Paesi Ue, assunse un peso rilevante sul valore del PIL (tab. 18).
Tab. 18 - Valore dell’onere degli interessi sul debito pubblico in rapporto al PIL (%)
Paese
Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Olanda
Portogallo
Regno Unito
1973
1981
1982
1983
1984
1985
1993
1994
1995
63.2
5.0
18.6
°*°
°*°
25.1
65.5
62.5
20.5
43.4
°*°
63.3
88.1
43.6
36.4
33.0
21.0
26.0
89.8
73.2
14.0
50.3
59.0
51.1
96.1
52.7
39.5
36.7
26.2
29.1
96.6
80.0
14.4
55.6
62.2
57.7
105.1
62.7
41.7
41.4
32.1
30.7
107.7
87.6
14.8
62.3
70.9
57.4
111.6
67.6
42.0
49.9
39.3
29.3
113.6
94.5
14.8
67.0
75.7
58.7
118.3
66.3
42.7
56.8
46.3
31.8
115.7
103.0
14.5
70.6
81.2
56.9
135.2
81.6
48.0
111.6
60.0
45.3
96.3
119.1
6.1
81.2
63.1
48.5
133.5
78.1
50.2
109.3
62.6
48.5
89.1
124.9
5.7
77.9
63.8
50.5
131.3
73.3
58.0
110.1
65.5
52.7
82.3
124.2
5.9
79.1
65.9
53.9
40.35
44.9
49.8
53.4
56.0
58.9
56
J.F. Melon, Essai politique sur le commerce,
1791, pag.296.
57
A. De Viti De Marco, Principi di Economia Finanziaria, Torino, 1961, pag. 402.
Fonte: Commissione Europea
58
E.F. Schumacher, La finanza pubblica e il suo
rapporto con la piena occupazione, in AA.VV., L'economia della piena occupazione, Torino, 1979,
pag. 138.
59
W. H. Beveridge, Full Employment in a Free Society, London, 1948, pag.
201.
Per questi motivi non siamo d’accordo con chi sostiene che “i debiti di una nazione
sono debiti che la mano destra deve alla mano sinistra, senza indebolire il corpo sociale56
ma siamo più vicini alle posizioni di Antonio de Viti De Marco57, E. F. Schumacher58 e W.
H. Beveridge59 e più in generale alla visione dei Post Keynesiani della stratificazione
sociale sostenendo che: se per lo Stato il debito pubblico può rappresentare una “partita
di giro” certamente non lo è per l’intera collettività, in quanto aumenta i redditi di alcuni cittadini nella stessa misura in cui le imposte necessarie al servizio del debito diminuiscono quelle degli altri e tale situazione diventa un grave ostacolo per una qualsiasi
politica basata sull’eliminazione degli squilibri economico-sociali tendente a ridurre le
UE a 12
65.9*
68.0*
71.0*
(*) I valori relativi agli anni 1993, 1994 e 1995 sono il risultato di una media considerando l’Ue a 15 e non a 12.
disuguaglianze nella distribuzione dei redditi.
I dati in nostro possesso riferiti ai possessori di titoli di Stato di alcuni Paesi europei e degli
Stati Uniti d’America nella metà degli anni ottanta confermano questa linea di pensiero.
Infatti, nella tabella 8, si riscontra che tra i detentori di titoli pubblici le “famiglie”
non superano mai la soglia del 50% del totale dei titoli emessi.Al contrario, come in Italia
(42%), Germania (40%), e USA (27%), il settore famiglie, in quel periodo, aveva una percentuale di detenzione di titoli pubblici molto più piccola.Anche in Spagna si ha lo stesso fenomeno, dove le famiglie, pur essendo conteggiate insieme alle imprese non finanziarie, che generalmente detengono titoli di Stato per valori intorno al 5-10%, registrano il 43% del totale di obbligazioni pubbliche emesse.
Inoltre, bisogna puntualizzare che, in alcune contabilità nazionali, come quella italiana, nella voce “famiglie” si comprendono anche piccole imprese artigiane e industriali e
naturalmente anche tutti quei soggetti economici che percepiscono il proprio reddito
con un lavoro autonomo. Questi ultimi, nell’aggregato, sono proprio i detentori dei redditi più alti che maggiormente risultano possessori di titoli di Stato.
Debito pubblico, redistribuzione del reddito e squilibri ...
I fattori dello sviluppo regionale
Tab. 19 - Detentori di Titoli di Stato in alcuni Paesi occidentali (in %)
(1984)
Famiglie
Altri
di cui: Banche
Assicurazioni
Imprese ind.
Italia
Belgio
Danimarca
Spagna
USA
42
58
53
1
4
64*
36
28
8
-
40
60
33
8
5
43*
57
42
11
-
27
73
43
23
0.5
* In questi Paesi il dato è comprensivo anche della quota spettante alle imprese (Spagna) e altri (Belgio)
Fonte: elaborazione propria su dati BankItalia e OCSE (1985)
Se la realtà italiana rappresenta il caso più evidente di questo fenomeno, dalle tabelle mostrate in precedenza riteniamo che la maggior parte dei Paesi Ue sia interessata
all’”effetto redistributivo” dovuto all’espansione del debito pubblico. Lo stesso Lord
Beveridge, il padre del “Welfare State” britannico, già negli anni ‘40 paventava qualche
preoccupazione a questo proposito.
Tale tesi è sostenuta dal fatto che sono i redditi medio-alti ad avere una propensione
al risparmio maggiore e quindi con crescenti possibilità di allocare il proprio risparmio
anche e soprattutto in periodi di stagnazione economica, nell’acquisto di titoli di Stato.
109
Giuseppe Capuano
110
Anche la Commissione Ue nella relazione economica annuale 1985-1986 riconobbe una simile eventualità dicendo testualmente: “non è escluso poi che sorgano problemi di distribuzione del reddito tra titolari di obbligazioni e i lavoratori dipendenti”60. In
pratica, il valore degli interessi, pagato tramite la tassazione, viene trasferito da coloro che
li pagano a coloro che li ricevono, dal contribuente allo Stato, al creditore verso lo Stato.
Tab. 20 - Depositi e impieghi per categorie (in %)
Depositi
Imprese
Famiglie
Altri (P.A.)
Impieghi
Imprese
Famiglie
Altri (P.A.)
1975
1978
1982
1984
1985
21.0
72.6
6.4
100.0
19.9
71.9
8.2
100.0
20.7
74.5
4.8
100.0
20.8
74.8
4.4
100.0
20.1
75.6
4.3
100.0
79.0
8.0
13.0
100.0
85.6
8.9
5.5
100.0
83.5
11.5
5.0
100.0
83.4
11.1
5.5
100.0
84.5
12.1
3.4
100.0
Fonte: Banca d’Italia
Graf. 4 - Evoluzione grafica del reddito da lavoro dipendente (RDL), imposte dirette (ID), inflazione (Infl.) (media UE a 10)
(ID)
(RLD)
(Infl.)
60
Commissione Europea,
Relazione Economica
Annuale 1985-86, Bruxelles, nov. 1985, pag. 63.
Fonte: Commissione UE
Graf. 5 - Evoluzione grafica del debito pubblico e l’onere per interessi sul debito pubblico
(in % del Pil, media UE a 10)
(Debito Pubblico)
Debito pubblico, redistribuzione del reddito e squilibri ...
I fattori dello sviluppo regionale
(Onere interessi)
111
Fonte: Commissione UE
Tab. 21 - Investimenti in titoli (in %)
Titoli di Stato
Titoli di altri emittenti
Fonte: Banca d’Italia
1974
1978
1982
1984
1985
32.9
67.1
100.0
53.6
46.4
100.0
60.0
40.0
100.0
65.5
34.5
100.0
67.5
32.5
100.0
Giuseppe Capuano
Tab. 22 - Differenziali dei tassi
112
1974
1978
1982
1984
1985
14.31
8.06
6.25
16.86
10.66
6.20
23.08
15.03
8.05
19.07
12.93
6.14
17.51
11.66
5.85
n.d.
n.d.
-
18.90
9.40
9.50
26.60
13.20
13.40
22.30
11.90
10.40
20.30
10.80
9.50
Calcolati su depositi e impieghi
censiti dalla Centrale Rischi (1)
Tassi sui prestiti in Lit.
Tassi lordi sui depositi
Differenza
Rendimenti a costi unitari
stimati dalla Banca d’Italia (2)
Tassi impieghi int. Lit.
Tassi raccolta int. Lit.
(1) Sui depositi - solo per quelli superiori a 20 milioni di lire.
(2) Sui prestiti - solo per quelli superiori a 30 milioni di lire fino al 1979, 50 milioni di lire dal 1980 al 1983, 80 milioni di lire dal 1984.
Fonte: Banca d’Italia - Relazione annuale 1985 - Tav. AD 14
In realtà, il contribuente, in parte è ricambiato delle imposte da lui pagate con i servizi pubblici, ma questi ultimi sia per l’inefficienza presente nell’amministrazione statale,
sia per la cattiva allocazione delle risorse pubbliche, certamente è compensato in maniera meno che proporzionale.
Di conseguenza, l’abnorme crescita del debito pubblico ha favorito la formazione dei
“rentiers” da interessi sui titoli di Stato a tutto discapito dei lavoratori dipendenti, arrivando al paradosso che se l’intervento dello Stato nell’economia e la creazione del
“Welfare State” era destinato a regolare le forze del mercato dirigendole verso una più
equilibrata distribuzione della ricchezza nazionale, la degenerazione del ruolo dello Stato,
da strumento equilibratore a “Stato assistenziale”, portò a favorire i “rentiers” a tutto
discapito delle classi medio-basse.
Debito pubblico, redistribuzione del reddito e squilibri ...
I fattori dello sviluppo regionale
5.4 L’impatto del debito pubblico sugli squilibri regionali
Nella presente sezione esamineremo la seconda tesi sostenuta nel capitolo: la crescita
dell’indebitamento dello Stato ha favorito l’aumento degli squilibri regionali in Italia.
Il nostro ragionamento parte dai dati presenti nella tabella 8: il settore bancario è
quello che maggiormente detiene titoli di Stato negli anni ottanta.
Per quanto riguarda le imprese e le società di assicurazioni, in tutti i Paesi rappresentano valori non trascurabili sul totale.
Questi dati mettono in evidenza un aspetto del problema molto interessante.
La maggior parte delle aziende creditizie, industriali e assicurative hanno i loro centri decisionali generalmente in quelle aree che presentano maggiori caratteristiche di
dinamicità economica (ad esempio la Lombardia in Italia oppure la Catalogna in Spagna,
etc.) specialmente in quei Paesi dove i problemi regionali sono più gravi e accentuati. Un
fenomeno che si è molto stressato negli ultimi anni, con la “scomparsa” del sistema creditizio meridionale.61
Di conseguenza, la maggior parte degli interessi percepiti dalle aziende di credito rappresentano un flusso di reddito aggiuntivo verso le regioni più sviluppate che va ad
aggiungersi ai flussi di reddito percepiti dai detentori di titoli di Stato residenti nelle
regioni medesime.
Considerando l’entità del fenomeno, potremmo ritenere che esso ha contribuito certamente negli ultimi anni ad aumentare gli squilibri regionali in Italia e all’interno della
stessa Ue.
In questo caso ritroviamo che, in base a politiche regionali basate sull’afflusso di spesa
pubblica in regioni dove la propensione al consumo è maggiore62 (generalmente quelle
meno sviluppate) per favorire la diminuzione degli squilibri regionali, le stesse hanno
portato, tra i molti effetti positivi anche alcuni negativi.Tra questi si possono considerare i trasferimenti di ingenti flussi di redditi supplementari alle regioni a crescita superiore in virtù del pagamento dell’onere degli interessi sul debito pubblico, con la conseguenza che se tali politiche dovevano favorire le aree più deboli, con il ricorso al debito
pubblico per coprire il fabbisogno dello Stato, si è prodotto un effetto di ritorno a tutto
vantaggio delle regioni più forti.
Si pensi, ad esempio, che in Italia, nel 1985, lo Stato ha pagato per l’onere degli interessi sul debito pubblico 46.6 miliardi di euro di cui 27.9 miliardi di euro sono andati
alle aziende creditizie e non, e che il nuovo piano per lo sviluppo del Mezzogiorno dell’epoca prevedeva uno stanziamento in 9 anni di 62mild di euro pari a 6,9mild di euro
113
61
Nel 1990 le banche con
sede legale nel Mezzogiorno erano pari a 313
contro le 168 del 2001.
Nello stesso periodo le
fusioni/acquisizioni gestite da banche del Nord
e che hanno interessato
le banche del Sud sono
state 219. Su questo argomento: Istituto Tagliacarne, Le dinamiche creditizie a livello provinciale, Collana “Le Ricerche”, giugno 2003.
62
H. Richardson, Economia
Regionale,
Bologna,
1970.
Giuseppe Capuano
114
63
Sull'influenza esercitata
sui tassi d'interesse dal
debito pubblico e quindi
sugli investimenti si veda
la "teoria dello spiazzamento" ad opera della
"scuola di St. Louis". A riguardo degli effetti sul risparmio si veda il lavoro
di J.E. Meade, Is the National Debt a Burden?, in
Oxford Economic Papers, giugno 1958.
all’anno, ossia circa il 25% di ciò che le aziende finanziarie e non, percepivano per il possesso di titoli di Stato in un solo anno.
In conclusione, il forte accrescersi del debito pubblico, nel periodo 1975-1985, è
stato uno dei fattori che ha contribuito all’accentuazione/mancata riduzione degli squilibri economici, sia dal punto di vista della distribuzione dei redditi, provocando un andamento a tutto vantaggio delle fasce di reddito più elevate, sia dal punto di vista della
diminuzione degli squilibri regionali, accentuandoli a tutto favore delle regioni più ricche, tramite un flusso aggiuntivo di reddito.
La conclusione di policy che si trae dal nostro ragionamento è che una sana politica
che tenda a ridurre le differenze a livello sociale e regionale deve assolutamente includere nel suo programma la riduzione del debito pubblico che altrimenti, in particolare in
quei periodi dove esistono degli alti tassi d’inflazione, determina una divaricazione a forbice tra percettori di reddito da lavoro dipendente e regioni deboli da un lato, e percettori di reddito da lavoro autonomo e da capitale e regioni forti dall’altro, a tutto vantaggio dei secondi.
Questo particolare aspetto del problema, determinato dall’aggravarsi della situazione
debitoria dello Stato nei confronti dei privati, non sempre viene rilevato quando si analizzano gli effetti che un crescente debito pubblico ha sull’economia.
Spesso le analisi economiche si soffermano sull’accrescimento che il debito pubblico
esercita sul livello della pressione fiscale (in particolar modo gli economisti di scuola
monetarista), o sulla struttura dell’imposizione, che tende a gravare maggiormente sui
redditi da lavoro dipendente (economisti di scuola keynesiana).
Oppure, si cerca di mettere in evidenza i vantaggi che un minore livello del debito
dello Stato conferisce ad una economia, sia in termini di allocazione del risparmio privato, sia sul livello degli investimenti (essendo la pressione fiscale minore e il livello dei
tassi d’interesse più bassi, gli investimenti produttivi sono incentivati)63.
5.5 Conclusioni
Dopo circa dieci anni dal momento in cui l’Italia raggiunse il più alto valore del
debito pubblico (1994 = 124,9%) e dopo diciotto anni dal momento che il debito pubblico superò per la prima volta la barriera del 100% in termini di PIL (1985 = 103%) e
nonostante gli sforzi realizzati per rispettare i parametri di Maastricht (il parametro relativo al debito pubblico è pari al 60% del PIL), al 2003, il valore del debito è fermo al
106,2 in termini di PIL, con una stima per il 2005 pari al 102,6% e una previsione di
conseguimento dell’obiettivo europeo solo nel 2013. Un risultato che sarà raggiunto con
estrema difficoltà se i livelli di deficit pubblico rimarranno superiori al 2% in termini di
PIL (valore medio dell’ultimo triennio) e soprattutto se l’avanzo primario (differenza tra
entrate e uscite), dai valori positivi del 5,5% del PIL della fine degli anni novanta, è sceso
al 2,6% nel 2003, con una stima per il 2004 pari al 2,5% del PIL.
Ciò è ancora più importante se consideriamo che la spesa per interessi in valore del
PIL si è assestata intorno al 5% e che difficilmente, considerati gli attuali livelli dei tassi
di interesse, potrà migliorare.
Se tutto ciò è vero, molto probabilmente le “colpe” dei padri ricadranno nel prossimo futuro sui figli e gli squilibri regionali Nord-Sud, fermo restando la struttura proprietaria dei titoli di Stato, avranno maggiore difficoltà a ridursi.
Debito pubblico, redistribuzione del reddito e squilibri ...
I fattori dello sviluppo regionale
115
Riferimenti
bibliografici
ARMSTRONG, H. AND TAYLOR, J. (1985), Regional Economic and Policy,
Philip Allan Publishers Limited, Oxford.
ACKLEY, G. (1963), Un modello econometrico dello sviluppo italiano nel dopoguerra,
Giuffrè, Roma.
AYDALOT, PH. (1986), Les technologies nouvelles et les formes actuelles de la division spatiale du travail,
Dossier du Centre Economie Espace Environment, 47, Paris.
BARANZINI, M. (1999), Corso di Economia Politica II,
Lugano.
BECATTINI G. (1979), “Dal settore industriale al distretto industriale. Alcune considerazioni sull’unità di indagine dell’economia industriale”,
in “Rivista di Economia e Politica Industriale”,V, n.1, genn.-apr.;
BECATTINI, G. (a cura di) (1989), Modelli locali di sviluppo,
Il Mulino, Bologna.
BERNARD, A.B. AND DURLAUF, S.N., (1995) “Interpreting Tests of the Convergence
Hypothesis”,
Journal of Applied Econometrics, 71, pp.161-173.
BOGGIO, L. AND SERRAVALLE, G., (1999), Sviluppo e crescita economica,
McGraw-Hill, Milano.
BOITANI, A. AND DAMIANI, M. (2003), Una nuova economia keynesiana,
Il Mulino, Bologna.
BOUDVILLE, J.R., (1966) Problems of Regional Economic Planning,
Edinburgh University Press, Edinburgh.
BRACALENTE, B., (1991), «Analisi di dati spaziali», in G. Marbach (a cura di) Statistica economica, Utet,Torino.
Debito pubblico, redistribuzione del reddito e squilibri ...
I fattori dello sviluppo regionale
119
Giuseppe Capuano
BRAMANTI, A. AND MAGGIONI M. (1995), Nuovi approcci per vecchi problemi: dove va lo sviluppo locale, Atti XVI Conferenza Italiana di Scienze Regionali,
30 ott.-1 nov. 1995, Siena.
120
CASS, D., (1965), “Optimum growth in an aggregate model of capital accumulation”,
Review of economic studies, 32, pp.223-240.
CASTELLS, M. (1996). La sociedad red.
Alianza editorial, Madrid.
CELANT, A. (1994), Geografia degli squilibri,
Edizioni Kappa, Roma.
CICIOTTI, E. (1998), Competitività e Territorio,
Carocci, Roma.
COCHRAN,W.G., (1977) Sampling Techniques,
Wiley, New York.
CAPUANO, G., (1995), Lo sviluppo locale e la politica regionale comunitaria,
Working Paper dell’Istituto G.Tagliacarne, n. 4, Roma.
CAPUANO, G. (1998), Moneta Unica, Sviluppo Economico e Economie Locali,
Roma.
CAPUANO, G. (2002), “I processi di convergenza e i percorsi di sviluppo locale”,
in (a cura di) Enrico Del Colle, Lo stato di salute dei comuni, Franco Angeli.
CHRISTALLER, W. (1933), Die zentralen Orte in Suddeutschland, Jena.
DEL COLLE, E. (1991) (a cura di), Metodi statistici per l’analisi economica territoriale,
Strumenti Istituto G.Tagliacarne, n. 4.
DEL COLLE, E. (1997), Le aree produttive, Franco Angeli,
Milano.
DIXON R.J. AND THIRLWALL A.P. (1975), “A model of regional growth rate differentials along
Kaldorian lines”,
Oxford Economic Papers.
DOMAR, E. (1958), Essays in the theory of economic growth,
Oxford.
FUJITA, M, KRUGMAN, P. AND VENABLES, A.J., (2001), The Spatial Economy,
The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
FUJITA, M, AND THISSE J.F., (2002), Economics of Agglomeration,
University Press, Cambridge.
GAROFOLI, G. (1991), Modelli locali di sviluppo,
Franco Angeli, Milano.
GAROFOLI, G. (1992), Economia del Territorio. Trasformazioni economiche e sviluppo regionale,
Etaslibri, Milano.
A. GRAZIANI, (1981) Teoria Economica, Macroeconomia,
ESI, 1981.
GRUBEL, H.G.
McMillan.
AND
LLOYD, P.J. (1973), Intra-Industry Trade,
GUARINI, R. AND TASSINARI, F., (2000), Statistica economica,
Il Mulino, Bologna.
HAY, D.A. (1979), The location of industry in a developing country,
Oxford University Press.
HARRIGAN, F.J. (1982), Revealed Comparative Advantage and Regional Industrial
Specialization:The Case of Scotland,
The Fraser of Allender Istitute Discussion Paper 22, University of Strathaclyde.
Il concetto di territorio nell’economia regionale
I fattori dello sviluppo regionale
121
Giuseppe Capuano
HARROD, R.F. (1948), Towars a dynamic economics,
Londra, MacMillan.
122
HICKS, J. R., (1946), Value and Capital,
Cambridge Press.
HIRSCHMAN, A.O. (1958), The Strategy of Economic Development,
Yale University Press, Cambridge (Mass.).
ISARD,W. (1956), Localizzazione e spazio economico,
Milano.
ISARD,W. (1960), Methods of Regional Analysis: an Introduction to Regional Science,
M.I.T., Boston.
J. M. KEYNES (1936), Teoria generale dell’occupazione, interesse e moneta,
Cambridge.
KALDOR, N, (1970), “The case for regional policies”, Scottish Journal of Political Economy.
KOOPMANS,T.C. (1965), “On the concept of optimal economic growth”,
in The econometric approach to development plannig, Amsterdam, North-Holland.
KRAUSS, M.B. AND JOHNSON, H.G. (1974) General Equilibrium Analysis,
Allen & Unwin.
KRUGMAN, P. (1995), Geografia e commercio internazionale,
Garzanti, Milano.
LEWIS, A. (1963), Teoria dello Sviluppo Economico,
Feltrinelli, Milano.
LEONTIEF,W. (1953), Domestic production and foreign trade: the American capital postition re-examined
Proceedings of the American Philosophical Society.
LEONTIEF, W. (1956), “Factor proportions and the structure of American trade: further
theoretical and empirical analysis”,
Review of Economics and Statistics.
LETI, G. (1983), Statistica descrittiva,
Il Mulino, Bologna.
LLOYD, P.E. AND DICKEN P. (1979), Spazio e Localizzazione, Franco Angeli, Milano.
LIPPARINI, A. (1998), Assetti relazionali per lo sviluppo e l’integrazione delle competenze, in A. Lipparini (a cura di), Le competenze organizzative. Sviluppo, condivisione, trasferimento, Carocci, Roma.
LORENZONI, G. (1990), L’architettura di sviluppo delle imprese minori,
Il Mulino, Bologna.
LÖSCH, A. (1954), The Economics of Location,
New Haven.
MADDISON,A. (1991), Dynamic Forces in Capitalist Development: a Long-Run Comparative View,
Oxford University Press.
MAILLAT, D. AND PERRIN, J.-C. (eds.) (1992), Entreprises innovatrices et développement territorial,
Neuchatel, EDES.
MANKIW, N., ROMER, D., WEIL, D.N. (1992), “A Contribution to the Empirics of
Economic Growth”, Quaterly Journal of Economic,107, pp.407-437.
MARKUSEN, A.R. (1987) Regions:The Economics and Politics of Territory,Totowa,
Rowman and Allanheld.
MARSHALL, A. (1890), Principi di economia, Cambridge.
MARTINI, G. AND PONTAROLLO E. (1989), Indicatori economici ed economie locali,
Strumenti Istituto G.Tagliacarne, n. 1.
Il concetto di territorio nell’economia regionale
I fattori dello sviluppo regionale
123
Giuseppe Capuano
MEYER, D.R., (1963), «Regional Economics: A Survey». American Economic review, vol. 3.
124
MYINT (1967), The Economics of the Developing Countries,
Londra.
MYRDAL, G. (1957), Economy Theory and Underdeveloped Regions,
Duckworth, London.
MUSUL, I. AND CAZZAVILLAN, G. (1997), Introduzione alla teoria della crescita endogena,
Laterza, Bari.
PORTER, M. (1985) Competitive Advantage,
Free Press, N.Y.
PORTER, M. (1990) The Competitive Advantage of Nations,
Free Press, N.Y.
PORTER, M. (1998) On Competition, Boston (MA),
Harvard Business School Press.
POSNER, M.V. (1961), “International trade and technical change”,
Oxford Economic Papers.
QUAH, D. (1993) “Empirical Cross-Section Dynamics i Economic Growth”,
European Economic Review, 37, pp. 426-434.
RAMSEY, F. (1928), “A mathematical theory of saving”, Economic Journal, 38, pp.543-559.
RICHARDSON, H.W. (1969), Elements of Regional Economics,
Penguin Books,
Harmondsworth; trad.it. (1971), Economia Regionale,
Il Mulino, Bologna.
RICHARDSON, H.W. (1973), Regional Growth Theory,
Macmillan, London.
SABEL, C. (1989), “Flexible specialization and the re-emergence of regional economies”
in P. Hirst and J. Zaitlin (eds.), Reversing Industrial Decline?Industrial Structure and Policy
in Britain and Her Competitors, London, Routledge, pp.17-70.
SATO, R. (1963), “Fiscal policy in a neoclassical growth model: an analysis of the time
required for equilibrating adjustment”, Review of Economic Studies, pp.16-23.
SFORZI, F. (1989), “The geography of industrial districs in Italy”, in R.Goodman, J.
Bamford and P. Saynor (eds.),
Small Firms and Industrial Districts in Italy, London, Routledge, pp.153-173.
SMITH, B. (1975), “Regional specialisation and trade in the UK”,
Scottish Journal of Political Economy.
SOLOW, R.M. (1994), Lezioni sulla teoria della crescita endogena,
NIS, Roma.
SOLOW, R. (1956), «A Contribution to the Theory of Economic Growth»,
Quarterly Journal of Economics, pp.65-94.
SWAN,T. (1956) “Economic Growth and Capital Accumulation”,
Economic Record, 1956, pp.334-361.
VERDOORN, P.J. (1949), “Fattori che regolano lo sviluppo delle produttività del lavoro,
L’Industria.
VERNON, R. (1966), “International investment and international trade in the product
cycle”, Quarterly Journal of Economics.
WEBER, A. (1909), Theory of the Location of Industries, Chicago.
WILLIAMSON, J.G. (1973), Disuguaglianze regionali e il processo di sviluppo nazionale: esposizione
degli schemi di sviluppo,in Needlemann L.(a cura di),Analisi regionale,Franco Angeli,Milano
WORLD BANK (1998), World Development Report, Oxford University Press.
Il concetto di territorio nell’economia regionale
I fattori dello sviluppo regionale
125