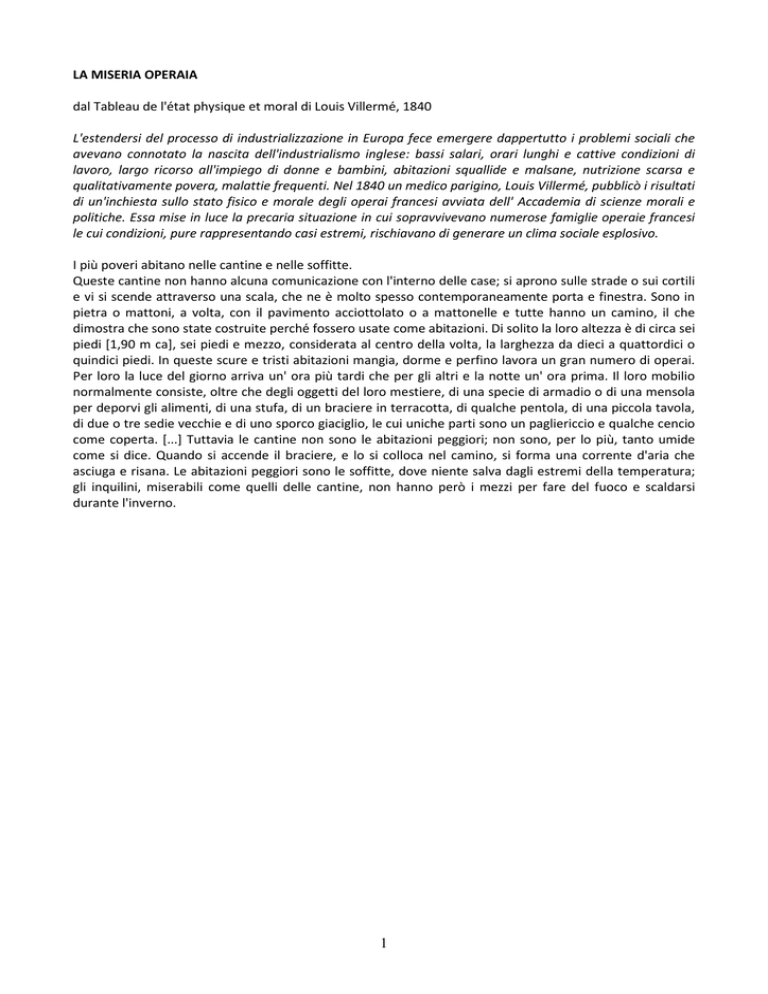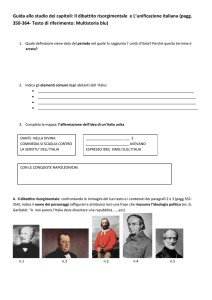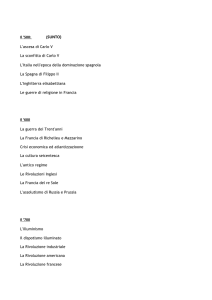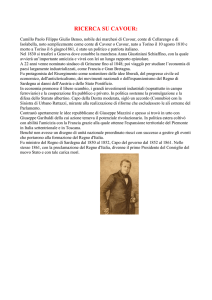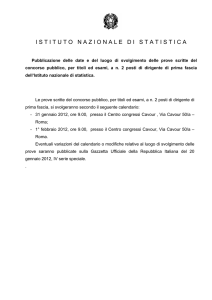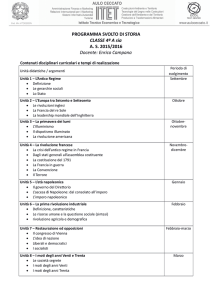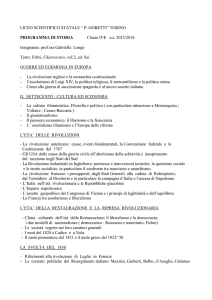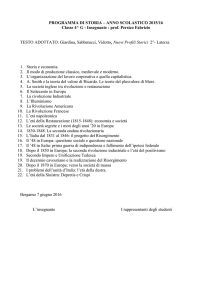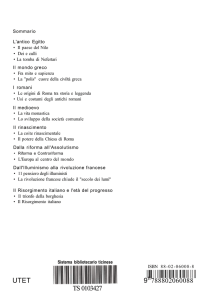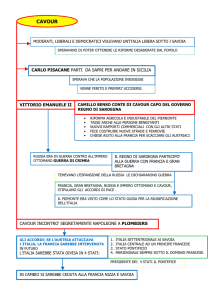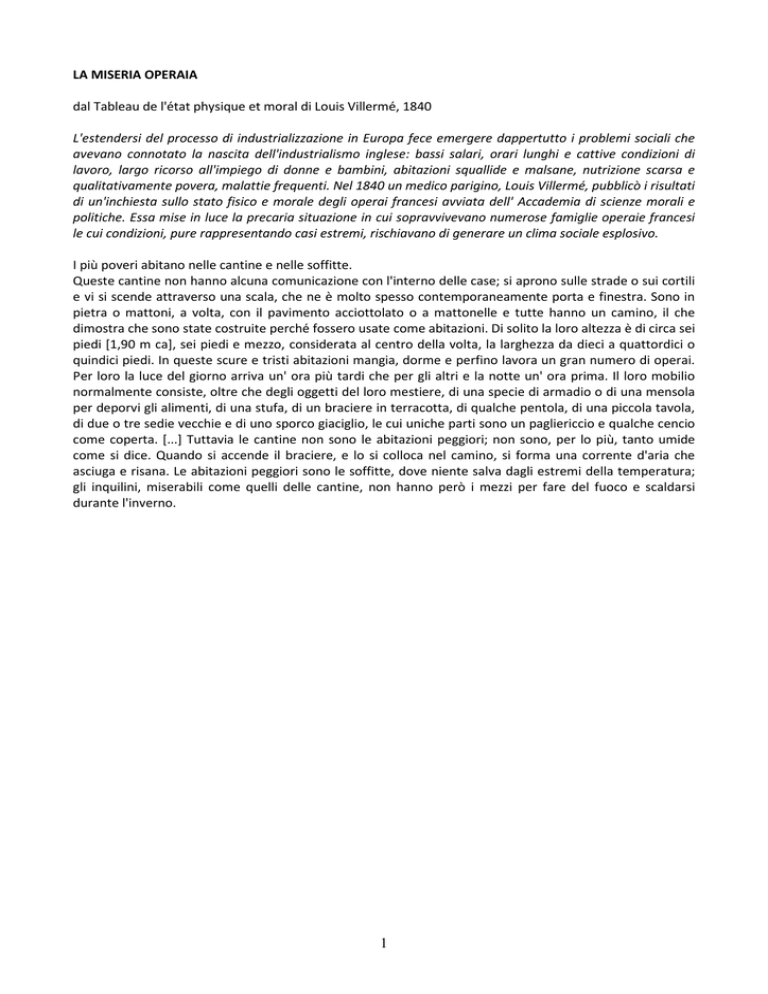
LA MISERIA OPERAIA
dal Tableau de l'état physique et moral di Louis Villermé, 1840
L'estendersi del processo di industrializzazione in Europa fece emergere dappertutto i problemi sociali che
avevano connotato la nascita dell'industrialismo inglese: bassi salari, orari lunghi e cattive condizioni di
lavoro, largo ricorso all'impiego di donne e bambini, abitazioni squallide e malsane, nutrizione scarsa e
qualitativamente povera, malattie frequenti. Nel 1840 un medico parigino, Louis Villermé, pubblicò i risultati
di un'inchiesta sullo stato fisico e morale degli operai francesi avviata dell' Accademia di scienze morali e
politiche. Essa mise in luce la precaria situazione in cui sopravvivevano numerose famiglie operaie francesi
le cui condizioni, pure rappresentando casi estremi, rischiavano di generare un clima sociale esplosivo.
I più poveri abitano nelle cantine e nelle soffitte.
Queste cantine non hanno alcuna comunicazione con l'interno delle case; si aprono sulle strade o sui cortili
e vi si scende attraverso una scala, che ne è molto spesso contemporaneamente porta e finestra. Sono in
pietra o mattoni, a volta, con il pavimento acciottolato o a mattonelle e tutte hanno un camino, il che
dimostra che sono state costruite perché fossero usate come abitazioni. Di solito la loro altezza è di circa sei
piedi [1,90 m ca], sei piedi e mezzo, considerata al centro della volta, la larghezza da dieci a quattordici o
quindici piedi. In queste scure e tristi abitazioni mangia, dorme e perfino lavora un gran numero di operai.
Per loro la luce del giorno arriva un' ora più tardi che per gli altri e la notte un' ora prima. Il loro mobilio
normalmente consiste, oltre che degli oggetti del loro mestiere, di una specie di armadio o di una mensola
per deporvi gli alimenti, di una stufa, di un braciere in terracotta, di qualche pentola, di una piccola tavola,
di due o tre sedie vecchie e di uno sporco giaciglio, le cui uniche parti sono un pagliericcio e qualche cencio
come coperta. [...] Tuttavia le cantine non sono le abitazioni peggiori; non sono, per lo più, tanto umide
come si dice. Quando si accende il braciere, e lo si colloca nel camino, si forma una corrente d'aria che
asciuga e risana. Le abitazioni peggiori sono le soffitte, dove niente salva dagli estremi della temperatura;
gli inquilini, miserabili come quelli delle cantine, non hanno però i mezzi per fare del fuoco e scaldarsi
durante l'inverno.
1
LA POVERTÀ CONTADINA IN IRLANDA
(dalla testimonianza di Daniel O'Connell alla Commissione parlamentare di inchiesta, 1825)
Non meno difficili delle condizioni di vita degli operai delle regioni industriali fu la situazione dei contadini
delle 'aree agricole più arretrate, quelle cioè in cui la scarsa inclinazione all' investimento da parte dei
proprietari e il disinteresse dei pubblici poteri favori il perpetuarsi di una condizione di immobilismo.
Esemplare in questo senso è il caso dell'Irlanda ottocentesca, ferma a un modello di agricoltura povera,
risultato dell'indifferenza dei grandi proprietari inglesi nei confronti delle loro proprietà "coloniali", dove la
coltivazione primaria, se non esclusiva, fu costituita dalle patate.
Fra il 1816 e,il 1820 vennero approvate alcune leggi che rendevano più agevole ai proprietari terrieri lo
sfratto dei contadini dipendenti in caso di mancato pagamento dell'affitto. Al contadino dopo la sfratto non
restava che la ricerca frenetica e pressoché disperata di un altro lavoro, oppure 1'emigrazione in Inghilterra,
mentre la mendicità era il destino della famiglia. La precaria condizione economico-giuridica delle
popolazioni irlandesi emerge nella testimonianza resa a una commissione parlamentare d'inchiesta da
Daniel O'Connell (1775-1847), che, eletto deputato nel 1828, si batté per l'emancipazione dei cattolici
irlandesi.
Per quanto ho verificato, la condizione delle classi inferiori è tale che suscita meraviglia il fatto di vederle
conservare la loro buona salute e la loro allegria, prive come sono del minimo segno di comodità e
sottoposte a condizioni che gli animali inferiori sopporterebbero a fatica e che, nel nostro Paese, non
sopportano. Le case non si chiamano neppure case, né potrebbero esserlo; sono chiamate capanne, sono
costruite con fango, coperte di paglia e di parti di un rivestimento da essi chiamato scraw, attraverso cui
inevitabilmente filtra la pioggia quando batte a lungo. Ho notato tuttavia che la notte questa specie di
costruzione offre un vantaggio: quando si accende il fuoco, tutta la casa si riscalda come una stufa, e questo
produce quasi l'effetto di un bagno a vapore su chi vi abita. [...] Non hanno nulla che meriti il nome di
mobilio. È già un lusso avere quello che essi chiamano uno scaffale per riporvi un piatto o un altro oggetto
del genere: possono avere, e in genere non hanno nient'altro che un vaso di ghisa, un tino per il latte che
chiamano keeler. [...] In che cosa consiste la loro biancheria da letto? Solo paglia e qualche rara coperta
nelle zone di montagna. In riva al mare stanno meglio e hanno qualche agio in più; saltuariamente pescano.
Sono senza lettiera? Di solito sì. L'intera famiglia dorme nello stesso spazio, lo chiamano camera, c'è una
specie di divisione tra questo spazio e la parte dove c'è il fuoco; le persone di diverso sesso sono separate
da sottili divisori. [...]
Sopra il letto di paglia hanno coperte sufficienti per coprirsi? In genere no. Dormono con addosso i loro
vestiti? Nella contea di Kerry1 spesso dormono vestiti; stanno meglio a coperte nelle zone più fuori mano,
casi nei distretti più lontani della conte a di Cork; ma ho ragione di credere che a Limerick, in una parte
della contea di Clare e in a1cune parti della contea di Cork dormano vestiti. So che vicino a Dublino
dormono vestiti e che secondo recenti indagini nel raggio di otto-dieci miglia intorno a Dublino, su
quattordici o quindici famiglie, solo presso due sono state trovate delle coperte. Né uomini né donne
portano in genere scarpe e calze, considerate un lusso.
Hanno il cambio di vestiti se si bagnano? Parlando in generale, non hanno cambio di vestiti; non hanno
altro che quello che indossano al momento; ovviamente, ci sono differenze nel grado di povertà, ma io mi
riferisco alla condizione generale dei lavoratori delle campagne.
Per quanto riguarda l'a1imentazione, in che cosa consiste? Tranne che sulla costa, di patate e di acqua per
la maggior parte dell' anno, di patate e latte acido nel resto; quando non hanno a1tro che acqua, con le
patate consumano un po' di sa1e. Sulla costa, hanno il pesce. I ragazzi vanno sulla spiaggia, come pure le
donne, e raccolgono crostacei di ogni genere, e si procurano anche diversi tipi di pesce. Non c'è
occupazione sufficiente per guadagnare denaro per i momenti difficili? No, certamente. Non credo che
esista a1 mondo una classe contadina più disposta di quella irlandese ad accettare un basso sa1ario per
lavorare.
1
Kerry, Cork, Limerick e Clare sono quattro contee della provincia di Munster situata nella parte sudoccidentale
dell'isola.
2
Non c'è una richiesta di impiego durevole per la classe lavoratrice? Per quel che ne so e ho verificato, non
c'è nemmeno qualcosa che possa esser chiamato domanda occasionale; la domanda è cosi bassa che non
merita neppure il nome di domanda; è una domanda più accidentale che occasionale.
Può dare alla commissione l'idea della quantità di persone disoccupate? Tentare di fornire dati numerici
significa andare per congetture, ma certo non ce n'è uno su venti occupato; ovvero non vi è per quel
numero alcun lavoro stabi1e.
3
LE FABBRICHE SOCIALI
da Louis Blanc, L'organizzazione del lavoro, 1841
Durante il regno di Luigi Filippo si diffusero in Francia elaborazioni teoriche e programmi che si ispiravano in
largo senso agli ideali socialisti. Alla denuncia dello sfruttamento operaio, conseguenza dell' organizzazione
capitalistica del lavoro e della logica del mercato e della concorrenza, si accompagnava la richiesta di un
nuovo modello di società. In questo quadro si colloca l'opera di Louis Blanc (1813-1882), che nel 1841
pubblicò uno scritto, L'organizzazione del lavoro (da cui è tratto il brano seguente), dove si proponeva come
rimedio alla disoccupazione e ai rovinosi effetti delle crisi economiche di istituire delle industrie finanziate
dallo Stato e gestite dai lavoratori: le cosiddette "fabbriche sociali" (ateliers sociaux).
In competizione con le fabbriche private, avrebbero dovuto portare al progressivo controllo dello Stato sulla
produzione industriale, eliminando il fattore disgregante della concorrenza e favorendo la crescita dell'
associazionismo. La nuova organizzazione del lavoro, fondata sulla collaborazione e non più
sull'individualismo e sull'emulazione esasperata, avrebbe consentito di sviluppare non solo un diverso
scenario economico ma anche nuovi rapporti tra gli uomini.
Il governo dovrebbe emettere un prestito, il cui utile sarebbe destinato alla creazione di "fabbriche sociali",
nei rami più importanti dell'industria nazionale.
Poiché questa creazione esigerebbe un anticipo considerevole di fondi, il numero delle fabbriche dovrebbe
essere, in origine, rigorosamente limitato; ma in virtù della loro stessa organizzazione [...] esse dovrebbero
essere dotate di una forza d'espansione immensa. Il governo, considerato l'unico fondatore delle "fabbriche
sociali", ne redigerebbe gli statuti.
Questa proposta, deliberata e votata dalla rappresentanza nazionale, avrebbe forma e forza di legge.
Tutti gli operai, muniti di garanzie di moralità, dovrebbero esser chiamati a lavorare nelle "fabbriche
sociali", fino alla concorrenza del capitale originariamente raccolto per l'acquisto degli strumenti di lavoro2.
Siccome l'educazione falsa e antisociale data alla generazione attuale non permette di cercare se non in un
sovrappiù di retribuzione un motivo d'emulazione e d'incoraggiamento, la differenza dei salari dovrebbe
esser graduata sulla gerarchia delle funzioni, poiché un' educazione nuova deve, su questo punto, cambiare
idee e costumi. Logicamente il salario dovrebbe, in ogni caso, esser sufficiente per l'esistenza del
lavoratore.
Per il primo anno dell'entrata in funzione delle fabbriche sociali, il governo regolerebbe la gerarchia delle
funzioni. Dopo il primo anno, non sarebbe più così. Avendo avuto i lavoratori il tempo di apprezzarsi
reciprocamente ed essendo tutti interessati, come vedremo, al successo dell'associazione, la gerarchia
nascerebbe dallo stesso principio elettivo3. Si dovrebbe stendere ogni anno il computo del guadagno netto,
di cui si farebbero tre parti: una, da dividersi in parti eguali fra i membri dell' associazione; l'altra, da
destinarsi:
I. al mantenimento dei vecchi, degli ammalati, degli infermi; 2. a rendere meno gravi le crisi che
graverebbero su altre industrie, poiché le diverse industrie si devono reciprocamente aiuto e soccorso; la
terza, infine, da destinarsi a rifornire gli strumenti di lavoro a coloro che volessero far parte
dell'associazione, in modo che questa possa estendersi indefinitamente.
In ognuna di queste associazioni, riservate a industrie che lavorano in grande, potrebbero esser ammessi
coloro che esercitano mestieri che, per la loro stessa natura, costringono a restare disuniti e a localizzarsi.
Così, ogni fabbrica sociale potrebbe esser composta di professioni diverse, raggruppate attorno a una
grande industria, parti diverse di un solo tutto, obbedienti alle stesse leggi e partecipanti ai medesimi
vantaggi.
Ogni membro della fabbrica sociale avrebbe diritto di disporre a proprio piacere del salario; ma l'evidente
risparmio e l'innegabile eccellenza della vita in comune non tarderebbero a far nascere dall'associazione dei
2
Il numero dei lavoratori impiegati sarebbe quindi determinato dal capitale fornito dallo Stato a ogni singola impresa.
Blanc appare consapevole della necessità di non introdurre in modo troppo rapido e traumatico delle innovazioni
radicali nella tradizionale organizzazione del lavoro. Pertanto riconosce l'opportunità sia di mantenere inizialmente delle
differenze salariali basate sulla diversa importanza delle funzioni, sia di determinare "dall'alto" questa gerarchia. Precisa
però che in seguito tale distribuzione di compiti dovrà essere stabilita per via elettiva e che una quota dei profitti
dell'impresa dovrà essere ripartita in misura uguale fra tutti i membri dell'associazione.
3
4
lavori l'associazione volontaria delle necessità e dei piaceri4. I capitalisti dovrebbero esser chiamati
nell'associazione, e potrebbero percepire l'interesse del capitale versato, interesse che sarebbe loro
garantito sul bilancio; ma non parteciperebbero agli utili se non come lavoratori.
Si comprende, del resto, quali risultati potrebbe dare la fabbrica sociale, costituita secondo questi principi.
In ogni industria importante, quella delle macchine, per esempio, o della seta, del cotone, o quella
tipografica, ci sarebbe uno stabilimento sociale, in concorrenza con l'industria privata. La lotta sarebbe
lunga? No, perché l'azienda sociale avrebbe, rispetto a ogni fabbrica individuale, il vantaggio dell'economia
della vita in comune e il giovamento di un sistema organizzativo in cui ogni lavoratore, senza eccezione, è
interessato a produrre presto e bene5. La lotta sarebbe sovversiva? No, perché il governo sarebbe sempre
in grado di attutirne gli effetti, impedendo che i prodotti delle fabbriche sociali calino a un tasso troppo
basso.
4
Blanc è convinto che l'associazionismo praticato all'interno delle fabbriche sociali porterà necessariamente i singoli
membri a stringere più intensi e solidali rapporti anche al di fuori dell'ambito lavorativo.
5
Il principale fattore che dovrebbe garantire la maggiore efficienza delle fabbriche sociali rispetto a quelle private
consiste per Blanc nel fatto che i lavoratori, non essendo più semplici salariati ma compartecipi della conduzione
dell'impresa, risulterebbero più motivati all'impegno produttivo.
5
LA PROPRIETÀ È UN FURTO
(da Pierre-Joseph Proudhon, Che cos' è la proprietà?, 1840
Nel 1840 uscì un libro destinato a suscitare scandalo nell'opinione benpensante e a movimentare il dibattito
nei circoli democratici e socialisti. Alla domanda - che costituiva anche il titolo dello scritto «Che cos'è la
proprietà ?», l'autore, Pierre-Joseph Proudhon, rispondeva provocatoriamente: «Un furto». Dietro a questa
fortunata formula non vi era però la richiesta della soppressione della proprietà: anzi Proudhon chiedeva
che essa fosse estesa e generalizzata. La proprietà non era solo furto, ma anche libertà. Le due affermazioni
non erano per lui contraddittorie; bisogna infatti distinguere fra la proprietà come fattore originario e
ineliminabile e il sistema sociale in cui il controllo dei mezzi di produzione è di pochi, il lavoro è separato dal
godimento dei suoi frutti e la proprietà è una rendita parassitaria.
Negli anni successivi Proudhon approfondì il suo pensiero fino a pubblicare nel settembre 1848 sul giornale
«Le peuple» il manifesto del suo programma politico. Tre erano le sue rivendicazioni di fondo: il lavoro come
diritto e come dovere; la proprietà, come il lavoro, per tutti; la repubblica come forma di governo e di
società. Egli auspicava un nuovo ordinamento sociale capace di sorgere in maniera spontanea dal basso
attraverso una rete di associazioni autonome, liberamente collegate fra loro, senza il peso di una autorità
centrale. Di qui la sua diffidenza verso ogni forma di organizzazione politica, verso la democrazia
rappresentativa, verso lo Stato e verso ogni forma di controllo delle spinte pluralistiche emergenti dalla
società.
Da Che cos' è la proprietà? riproduciamo alcuni passi tratti dal primo capitolo in cui Proudhon denuncia, con
forte spirito polemico, il persistere di ingiustizie e privilegi dopo le rivoluzioni del 1789 e del 1830.
Se dovessi rispondere alla seguente domanda: «Che cos'è la schiavitù?» e rispondessi con una sola parola:
«È un assassinio», il mio pensiero sarebbe subito compreso. Non avrei bisogno d'un lungo discorso per
dimostrare che il potere di privare l'uomo del pensiero, della volontà, della personalità, è un potere di vita e
di morte, e che rendere schiavo un uomo significa assassinarlo. Perché dunque a quest'altra domanda:
«Che .cos'è la proprietà?» non posso rispondere allo stesso modo: «È un furto» senza avere la certezza di
non essere compreso, benché questa seconda proposizione non sia che una trasformazione della prima?
Io mi accingo a mettere in discussione il principio stesso del nostro governo e delle nostre istituzioni, la
proprietà; sono nel mio diritto: posso ingannarmi nella conclusione che risulterà dalle mie ricerche; sono
nel mio diritto: mi piace mettere il concetto finale del mio libro al principio; sono sempre nel mio diritto.
Qualche autore insegna che la proprietà è un diritto civile, nato dall'occupazione e sancito dalla legge;
qualche altro sostiene che essa è un diritto naturale, che sorse dal lavoro: e queste dottrine, per quanto
sembrino opposte, sono incoraggiate e applaudite. lo affermo che né il lavoro, né l'occupazione, né la legge
possono creare la proprietà; ch'essa è un effetto senza causa: mi si può biasimale?
Ma si mormora:
- «La proprietà è un furto»! Ma questo è il segnale del 17936! è la parola d'ordine della Rivoluzione!...
Lettore, rassicurati: non sono un agente di discordia, un sedizioso incendiario. Mi limito ad anticipare un
poco sulla storia; espongo una verità di cui cerchiamo invano d'arrestare gli sviluppi; scrivo il preambolo
della nostra futura costituzione.
Del resto, io non creo un sistema: chiedo la fine del privilegio, l'abolizione della schiavitù, l'eguaglianza dei
diritti, il regno della legge. Giustizia, nient'altro che giustizia; in questo si riassume il mio discorso; lascio ad
altri la cura di dare un ordine al mondo. [...] Lo spirito che provocò il movimento del 1789 fu uno spirito di
contraddizione; ciò basta a dimostrare che l'ordine di cose che fu sostituito all'antico non ebbe nulla in sé di
metodico e meditato; che, nato dalla collera e dall'odio, non poteva avere gli effetti d'una scienza fondata
sull' osservazione e lo studio; che le sue basi, in una parola, non furono dedotte dalla conoscenza
approfondita delle leggi della natura e della società. [...]
La preoccupazione e il pregiudizio si rivelano a ogni passo sotto la retorica dei nuovi legislatori. Il popolo
aveva sofferto d'una quantità di esclusioni e privilegi; i suoi rappresentanti fecero a suo nome la seguente
dichiarazione: «Tutti gli uomini sono eguali per natura e di fronte alla legge»; dichiarazione ambigua e
6
Anno che segna - oltre alla decapitazione di Luigi XVI - il momento di massima affermazione del movimento
giacobino.
6
pleonastica. «Gli uomini sono eguali per natura»: vuol dire forse che sono tutti della stessa statura, della
stessa bellezza, dello stesso ingegno, della stessa virtù? No: dunque è l'eguaglianza politica e civile che si è
voluto designare. Ma allora bastava dire: «Tutti gli uomini sono eguali di fronte alla legge». Ma che cos'è
l'eguaglianza di fronte alla legge? Né la costituzione del 1790, né quella del 1793, né la carta concessa da
Luigi XVIII, né quella accettata da Luigi Filippo hanno saputo darne una definizione. Tutte presuppongono
un'ineguaglianza di beni e di rango sociale accanto alla quale è impossibile trovare l'ombra d'una
eguaglianza di diritti7.
7
È qui espresso un punto forte dell'ideologia socialista, che cioè nessuna uguaglianza giuridica sia di fatto realizzabile
senza il superamento delle disuguaglianze sociali.
7
I LIMITI DELLO SVILUPPO
(da Thomas R. Malthus, Saggio sul principio della popolazione, 1803
Pubblicato la prima volta nel 1798 e più volte ampliato negli anni successivi, il Saggio sul principio della
popolazione e la sua influenza sul miglioramento futuro della società dello storico ed economista inglese
(nonché reverendo della Chiesa anglicana) Thomas Malthus ebbe un'enorme risonanza. L'autore metteva
radicalmente in discussione la prospettiva di una crescita illimitata del benessere che aveva dominato il
pensiero nel corso del secolo XVIII e individuava delle rilevanti contraddizioni nei meccanismi stessi della
produzione della ricchezza. La principale fra queste consisteva nella tendenza da parte della popolazione ad
aumentare a un ritmo nettamente superiore a quello - da Malthus considerato poco modificabile - con cui
cresceva la produzione agricola.
In assenza di uno sforzo per limitare la crescita della popolazione attraverso quelli che egli indica come
ostacoli «preventivi» - fra i quali egli ritiene moralmente lecito solo il ritardo nel contrarre il matrimonio
accompagnato da una rigida astinenza sessuale - si determinano fenomeni di sovrappopolazione. In tal caso
scattano inevitabilmente carestie, guerre (per il controllo del territorio), epidemie che costituiscono i
cosiddetti ostacoli «repressivi», unico modo per ristabilire una situazione di equilibrio.
Si può affermare con tutta franchezza che la popolazione, quando non è arrestata da alcun ostacolo, si
raddoppia a ogni periodo di venticinque anni, crescendo cosi in progressione geometrica.
Il rapporto, secondo il quale si può ritenere che aumentino le produzioni della terra, non è altrettanto facile
da determinare. Di una cosa, tuttavia, siamo ben certi e cioè del fatto che questo rapporto dev'essere
completamente diverso da quello secondo il quale procede l'aumento della popolazione.
Mille milioni di uomini si devono raddoppiare in venticinque anni, per effetto della procreazione,
precisamente come farebbero mille soltanto. Ma i viveri necessari ad un maggior numero non possono di
sicuro ottenersi con uguale facilità. L'uomo è necessariamente limitato dallo spazio. Quando si aggiunge un
ettaro di terreno dopo l'altro, finché tutta la terra fertile venga occupata, l'aumento della produzione deve
necessariamente dipendere dal miglioramento delle terre già coltivate. Per condizioni naturali, la capacità
produttiva, invece di crescere, va sempre diminuendo8.
E intanto la popolazione, se non mancasse di viveri, si moltiplicherebbe con la medesima vigoria, e
1'aumento di un periodo diventa una nuova forza procreatrice nel periodo seguente, e ciò senza alcun
limite. Esaminiamo ora con quale progressione il prodotto di quest'Isola [l’Inghilterra] potrebbe accrescersi
nelle circostanze più favorevoli. [...]
Gli ostacoli che agiscono di continuo con forza maggiore o minore in ogni società, e che mantengono la
popolazione al livello dei mezzi di sussistenza, possono essere distinti in due categorie principali: gli uni
sono preventivi, gli altri sono repressivi. L'ostacolo preventivo è tipico dell'uomo, e deriva dalla superiorità
della sua ragione che lo mette in grado di calcolare le conseguenze lontane. Le piante e gli animali non
sembra che abbiano dubbio alcuno intorno alla futura sussistenza della loro progenie; quindi gli ostacoli al
loro indefinito moltiplicarsi non sono che repressivi. Ma l'uomo non può girare intorno lo sguardo senza
riconoscere la ristrettezza in cui gemono le famiglie numerose; egli non può contemplare i suoi attuali
mezzi di sussistenza, appena sufficienti a lui, e calcolare quanto risulteranno ridotti allorché si tratterà di
dividerli fra sette o otto individui, senza avvertire il timore che gli venga a mancare ogni modo di alimentare
la prole se cederà alle sue tendenze di procreazione. Tali riflessioni sono atte a impedire, e certamente
impediscono, che molti, in tutte le nazioni incivilite, cedano all'istinto naturale di legarsi giovanissimi a una
donna9. [...] Gli ostacoli repressivi sono molteplici e comprendono ogni causa, derivante da vizio o da
privazione, che contribuisca in qualsiasi modo ad abbreviare la durata della vita umana. [...]
Questi effetti, nell'attuale condizione della società, sembrano prodursi nel modo seguente. Si supponga che
i mezzi di sussistenza in un certo Paese siano esattamente sufficienti a nutrire i suoi abitanti. Lo sforzo
continuo che tende a far crescere la popolazione, e che agisce anche nelle società più viziose, aumenterà il
8
Le terre che vengono messe a coltivazione per far fronte all'accresciuta domanda sono inevitabilmente meno fertili di
quelle già coltivate.
9
La rinuncia alla procreazione non può essere attuata secondo Malthus - che era un reverendo della Chiesa anglicana che attraverso l'astinenza sessuale.
8
numero degli uomini prima che si aumentino i loro mezzi di sussistenza. Gli alimenti che potevano nutrire
undici milioni di individui dovranno ora ripartirsi fra undici milioni e mezzo. Di conseguenza i poveri
peggioreranno il loro tenore di vita e parecchi di essi si troveranno ridotti nelle condizioni più dure. Siccome
intanto il numero di quelli che lavorano sarà divenuto sproporzionato rispetto all' attività da svolgere, il
prezzo del lavoro non potrà fare a meno di diminuire, mentre contemporaneamente il prezzo dei viveri
crescerà. Il lavoratore sarà costretto a faticare di più per guadagnare quanto otteneva prima. Nel corso di
quest'epoca di penuria i matrimoni saranno scoraggiati a tal punto, e la difficoltà di nutrire la propria
famiglia sarà cosi cresciuta, che la popolazione dovrà rimanere pressoché stazionaria.
Nel medesimo tempo il basso prezzo del lavoro, la sovrabbondanza di lavoratori e il bisogno di una
maggiore attività serviranno di incoraggiamento ai coltivatori per dedicare maggiori sforzi alla loro terra,
per dissodare terreni incolti, per migliorare e concimare quelli già coltivati; finché i mezzi di sussistenza non
ritornino al rapporto in cui stavano prima rispetto alla popolazione. La condizione del lavoratore tornerà a
essere meno penosa e l'ostacolo alla popolazione ne verrà attenuato; in breve tempo, però, lo stesso
movimento, retrogrado e progressivo, si ripeterà. [...] Quando la popolazione è cresciuta fino agli estremi
limiti della sussistenza, tutti gli ostacoli preventivi e repressivi agiranno naturalmente con maggiore forza.
Le abitudini viziose saranno più generali, l'abbandono dei neonati sarà più frequente, la probabilità e la
necessità delle guerre e delle epidemie risulteranno considerevolmente maggiori; e queste cause
continueranno forse ad agire finché la popolazione non sia discesa al livello dei viveri; allora il ritorno a una
relativa abbondanza produrrà di nuovo un aumento e, dopo un certo periodo, i suoi ulteriori progressi
verranno nuovamente impediti dalle medesime cause.
9
BORGHESI E COMUNISTI
(da Karl Marx e Friedrich Engels, Manifesto del partito comunista, 1848
Alla fine del febbraio 1848 uscì a Londra, il Manifesto dal partito comunista, cui gli autori, Karl Marx e
Friedrich Engels, avevano lavorato fra il 1847 e l'inizio del 1848, su invito di un piccolo gruppo operaio, la
Lega dei comunisti. Il motivo della straordinaria fortuna di quest'opera sta nella sua capacità di condurre
un'analisi specifica dei meccanismi della società borghese-capitalistica e delle lotte politiche europee, al di
là dello scontro "classico" fra democrazia e liberalismo.
La prospettiva di un radicale cambiamento della società, che avrebbe dovuto unire tutti i proletari, al di là
delle barriere nazionali, nella lotta contro le classi dominanti, era resa possibile dalle condizioni di
sfruttamento create dalla borghesia che, dopo avere abbattuto l'Antico regime, prodotto un sapere in grado
di controllare la natura, dato vita a una struttura economica capace di garantire prosperità (seppure
iniquamente ripartita) aveva ormai perso il controllo sul processo in corso.
Con l'estendersi dell'industrialismo la borghesia aveva visto sorgere la forza antagonista del proletariato,
destinata a prendere il sopravvento, in quanto soggetto attivo della produzione.
Perché ciò accadesse era necessario che il proletariato superasse gli inadeguati strumenti di lotta del
passato (come la distruzione delle macchine) e rinnovasse i propri strumenti di conoscenza, per trasformare
le vecchie strutture sociali fino all' abolizione della proprietà privata.
La borghesia ha avuto nella storia una parte sommamente rivoluzionaria.
Dove ha raggiunto il dominio, la borghesia ha distrutto tutte le condizioni di vita feudali, patriarcali,
idilliche. Ha lacerato spietatamente tutti i variopinti vincoli feudali che legavano l'uomo al suo superiore
naturale e non ha lasciato fra uomo e uomo altro vincolo che il nudo interesse, il freddo "pagamento in
contanti". [...] In una parola: ha messo lo sfruttamento aperto, spudorato, diretto e arido al posto dello
sfruttamento mascherato d'illusioni religiose e politiche10. [...] Solo la borghesia ha dimostrato che cosa
possa compiere l'attività dell'uomo. [...] La borghesia non può esistere senza rivoluzionare continuamente
gli strumenti di produzione, i rapporti di produzione, dunque tutti i rapporti sociali. Prima condizione di
esistenza di tutte le classi industriali precedenti era invece l'immutato mantenimento del vecchio sistema di
produzione. Il continuo rivoluzionamento della produzione, l'ininterrotto scuotimento di tutte le situazioni
sociali, l'incertezza e il movimento eterni contraddistinguono l'epoca dei borghesi fra tutte le epoche
precedenti.
Si dissolvono tutti i rapporti stabili e irrigiditi, con il loro seguito di idee e di concetti antichi e venerandi, e
tutte le idee e i concetti nuovi invecchiano prima di potersi fissare. Si volatilizza tutto ciò che vi era di
corporativo e di stabile, è profanata ogni cosa sacra, e gli uomini sono finalmente costretti a guardare con
occhio disincantato la propria posizione e i propri reciproci rapporti.
Il bisogno di uno smercio sempre più esteso per i suoi prodotti sospinge la borghesia a percorrere tutto il
globo terrestre11. [...] Con lo sfruttamento del mercato mondiale la borghesia ha dato un'impronta
cosmopolitica alla produzione e al consumo di tutti i Paesi. Ha tolto di sotto i piedi all'industria il suo
terreno nazionale, con gran rammarico dei reazionari. Le antichissime industrie nazionali sono state
distrutte, e ancora adesso vengono distrutte ogni giorno. Vengono soppiantate da industrie nuove, la cui
introduzione diventa questione di vita o di morte per tutte le nazioni civili, da industrie che non lavorano
più soltanto materie prime del luogo, ma delle zone più remote, e i cui prodotti non vengono consumati
solo nel Paese stesso, ma anche in tutte le parti del mondo. Ai vecchi bisogni, soddisfatti con i prodotti del
Paese, subentrano bisogni nuovi, che per essere soddisfatti esigono i prodotti dei Paesi e dei climi più
lontani. All' antica autosufficienza e all' antico isolamento locali e nazionali subentra uno scambio
universale, un'interdipendenza universale fra le nazioni. E come per la produzione materiale, così per quella
intellettuale. I prodotti intellettuali delle singole nazioni divengono bene comune. [...] Con il rapido
10
L'assoggettamento dell'uomo ad altri uomini, che nel periodo feudale veniva giustificato sulla base di complessi
rapporti personali (in nome di valori quali la protezione, la fedeltà e la dedizione) nonché sulla base di giustificazioni di
natura religiosa (il principio che ogni autorità legittima proveniva da Dio), viene spogliato per opera della borghesia di
queste componenti e riportato alla cruda logica dello sfruttamento economico.
11
Nell'analisi della nuova logica di mercato che si va affermando Marx ed Engels sembrano addirittura prefigurare
alcuni aspetti di quelli che oggi definiamo "processi di globalizzazione".
10
miglioramento di tutti gli strumenti di produzione, con le comunicazioni infinitamente agevolate, la
borghesia trascina nella civiltà tutte le nazioni, anche le più barbare. I bassi prezzi delle sue merci sono
l'artiglieria pesante con la quale essa spiana tutte le muraglie cinesi, con la quale costringe alla
capitolazione la più tenace xenofobia dei barbari12. Costringe tutte le nazioni ad adottare il sistema di
produzione della borghesia, se non vogliono andare in rovina, le costringe a introdurre in casa loro la
cosiddetta civiltà, cioè a diventare borghesi. In una parola: essa si crea un mondo a propria immagine e
somiglianza.
La borghesia ha assoggettato la campagna al dominio della città. Ha creato città enormi, ha accresciuto su
grande scala la cifra della popolazione urbana in confronto di quella rurale, strappando in tal modo una
parte notevole della popolazione all'idiotismo della vita rurale. Come ha reso la campagna dipendente dalla
città, la borghesia ha reso i Paesi barbari e semibarbari dipendenti da quelli inciviliti, i popoli di contadini da
quelli di borghesi, l'Oriente dall'Occidente.
La borghesia elimina sempre più la dispersione dei mezzi di produzione, della proprietà e della popolazione.
Ha agglomerato la popolazione, ha centralizzato i mezzi di produzione, e ha concentrato in poche mani la
proprietà. Ne è stata conseguenza necessaria la centralizzazione politica. Province indipendenti, legate
quasi solo da vincoli federali, con interessi, leggi, governi e dazi differenti, vennero strette in una sola
nazione, sotto un solo governo, una sola legge, un solo interesse nazionale di classe, entro una sola barriera
doganale. [...] Ma la borghesia non ha soltanto fabbricato le armi che le porteranno la morte; ha anche
generato gli uomini che impugneranno quelle armi: gli operai moderni, i proletari.
Nella stessa proporzione in cui si sviluppa la borghesia, cioè il capitale, si sviluppa il proletariato, la classe
degli operai moderni, che vivono solo fintantoché trovano lavoro, e che trovano lavoro solo fintantoché il
loro lavoro aumenta il capitale. Questi operai che sono costretti a vendersi al minuto, sono una merce
come ogni altro articolo commerciale, e sono quindi esposti, come le altre merci, a tutte le alterne vicende
della concorrenza, a tutte le oscillazioni del mercato. [...] Quel che contraddistingue il comunismo non è
1'abolizione della proprietà in generale, bensì l'abolizione della proprietà borghese.
Ma la proprietà privata borghese moderna è l'ultima e più perfetta espressione della produzione e
dell'appropriazione dei prodotti che poggia su antagonismi di classe, sullo sfruttamento degli uni da parte
degli altri. In questo senso i comunisti possono riassumere la loro teoria nella frase: abolizione della
proprietà privata. Ci si è rinfacciato, a noi comunisti, che vogliamo abolire la proprietà acquistata
personalmente, frutto del lavoro diretto e personale [...] Proprietà frutto del proprio lavoro, acquistata,
guadagnata con le proprie forze! Parlate della proprietà del minuto cittadino, del piccolo contadino che ha
preceduto la proprietà borghese? Non c'è bisogno che l'aboliamo noi, l'ha abolita e la va abolendo di giorno
in giorno lo sviluppo dell'industria.
O parlate della moderna proprietà privata borghese?
Ma il lavoro salariato, il lavoro del proletario, crea proprietà a questo proletario? Affatto. Il lavoro del
proletario crea il capitale, cioè quella proprietà che sfrutta il lavoro salariato, che può moltiplicarsi solo a
condizione di generare nuovo lavoro salariato, per sfruttarlo di nuovo. [...] Voi inorridite perché vogliamo
abolire la proprietà privata. Ma nella vostra società attuale la proprietà privata è abolita per i nove decimi
dei suoi membri; la proprietà privata esiste proprio per il fatto che per nove decimi non esiste. Dunque voi
ci rimproverate di voler abolire una proprietà che presuppone come condizione necessaria la privazione
della proprietà dell'enorme maggioranza della società. In una parola, voi ci rimproverate di volere abolire la
vostra proprietà. Certo, questo vogliamo.
Appena il lavoro non può più essere trasformato in capitale, in denaro, in rendita fondiaria, insomma in una
potenza sociale monopolizzabile, cioè, appena la proprietà personale non può più convertirsi in proprietà
borghese, voi dichiarate che è abolita la persona. Dunque confessate che per persona non intendete
nient'altro che il borghese, il proprietario borghese. Certo questa persona deve essere abolita. Il
comunismo non toglie a nessuno il potere di appropriarsi di prodotti della società, toglie soltanto il potere
di assoggettarsi il lavoro altrui mediante tale appropriazione.
12
Il basso costo delle merci e, ancor prima, la logica stessa del mercato appare l'arma con cui la borghesia occidentale
riesce a penetrare anche nelle regioni più remote e un tempo inaccessibili. Il riferimento alla Cina non è casuale, dal
momento che proprio obbligando con la forza questo Paese a legittimare l'importazione d'oppio (la prima guerra
dell'oppio risale al 1839-1842), l'Inghilterra era riuscita ad avviare la conquista dell'immenso mercato di questo Paese,
per secoli impenetrabile alle merci occidentali.
11
IL SECONDO IMPERO DI NAPOLEONE III
da P. FARMER, Il secondo impero in Francia, 1970
Giunto al potere con un colpo di Stato cui il popolo francese dà legittimazione mediante due plebisciti, Luigi
Napoleone inaugura un governo personale e paternalistico - il Secondo impero - che gli consente di
governare la Francia per quasi vent'anni.
Controverso è il giudizio degli storici su questo periodo. Alcuni vi hanno visto una sorta di dittatura larvata,
che imbavaglia l'opposizione e la stampa, revoca le libertà, controlla tutti i settori della vita civile, quasi
precorrendo i moderni totalitarismi. Altri, pur non negando gli indubbi elementi autoritari, gli riconoscono
l'intento di porre fine alle tensioni sociali e agli scontri fra partiti e fazioni mediante la costituzione di
un'autorità - l'imperatore - che si pone al di sopra delle parti e si fa interprete delle esigenze dell'intera
nazione.
A tale fine Bonaparte ritiene che questa autorità debba godere, da una parte, di ampi poteri - da cui i
provvedimenti che limitano le libertà civili, neutralizzano l'opposizione, subordinano a lui polizia,
magistratura, burocrazia - ma, dall'altra, anche del sostegno della stragrande maggioranza del popolo. Per
ottenerlo egli cerca di legare a sé i più ampi strati della popolazione: dapprima i contadini e i cattolici,
successivamente la borghesia imprenditoriale e finanziaria. Meno tutelati sono invece operai e artigiani e,
sul piano politico, repubblicani e socialisti verso cui Bonaparte mantiene un atteggiamento di diffidenza e
una strategia sostanzialmente repressiva.
Come lo storico Paul Farmer spiega nelle pagine che seguono, Bonaparte realizza in tal modo un regime
autoritario e demagogico; a favorire questo processo è soprattutto la fase espansiva dell'economia francese
- si pensi agli effetti della "rivoluzione bancaria", del grande sviluppo delle ferrovie - che migliora le
condizioni generali di vita della popolazione, facilita il mantenimento dell'ordine pubblico, accresce il
consenso popolare nei confronti del regime.
Napoleone III era convinto che la Francia avesse soprattutto bisogno della stabilità politica, e che i
legittimisti, gli orleanisti e i repubblicani si fossero tutti dimostrati incapaci di soddisfare tale esigenza. Non
rimaneva dunque altra soluzione che il governo di un sovrano il quale, ponendosi al di sopra delle fazioni,
interpretasse la volontà delle masse silenziose del Paese, il cui desiderio appunto non era tanto di veder
trionfare un partito particolare, quanto di godere i benefici di un governo stabile. Ma Napoleone III non
avrebbe certo potuto eliminare con la forza movimenti di opinione cosi radicati come quello dei
repubblicani, degli orleanisti e dei legittimisti13, né per lui sarebbe stato opportuno o possibile cercare di
creare un partito che difendesse la sua causa e si ponesse in lizza a fianco degli altri partiti esistenti. Egli
non ebbe quindi altra scelta che quella di tenere saldamente in mano le redini del governo, facendo d'altra
parte a tutti i partiti concessioni sufficienti a spuntarne l'opposizione, senza diventare però prigioniero di
nessuna fazione. Questa tattica era indubbiamente una forma di opportunismo, ma era stata adottata
nell'interesse della Francia e non soltanto dell'imperatore.
Un governo autocratico combinato con un abile gioco di equilibri tra una fazione e l'altra, in modo che si
neutralizzassero a vicenda, non era tuttavia sufficiente. L'Impero doveva anche ottenere la sanzione della
Chiesa, senza la quale nessun regime poteva sperare di conquistare i consensi di larghi settori delle masse
contadine e delle classi ricche delle città. Inoltre bisognava dare impulso all'economia del Paese in modo da
soddisfare le esigenze di espansione della borghesia e contemporaneamente rendere possibile un
miglioramento delle condizioni di vita del proletariato urbano. Questi erano dunque gli obiettivi di
Napoleone III, il quale non vedeva alcuna contraddizione nel fatto di voler da un lato soddisfare gli interessi
della Chiesa e dall'altro difendere la causa del progresso materiale, o di voler proteggere le classi ricche ed
essere sollecito verso quelle povere.
Sembra dunque che questi fossero i principi fondamentali a cui si ispirava l'imperatore all'inizio del regno, e
in effetti fino al 1859 la linea politica da lui seguita parve rispondere a un programma coerente. In questo
periodo, infatti, Napoleone III esercitò un potere autoritario e personale, stabili una stretta intesa tra la
13
Gli orleanisti si battevano per la restaurazione monarchica nella persona di Luigi Filippo, il sovrano deposto nel 1848,
mentre i legittimisti sostenevano i diritti di successione dei discendenti del ramo principale della famiglia Borbone, cui
appartenevano i due sovrani della Restaurazione, Luigi XVIII e Carlo X, quest'ultimo deposto nel 1830
12
Chiesa e il governo, incoraggiò e anzi diede un aiuto decisivo alle iniziative economiche della borghesia. In
questi anni, inoltre, la Francia mostrò in generale di accettare il nuovo regime e le manifestazioni di
dissenso furono veramente poche. Invece dal 1859 in poi l'Impero visse momenti difficilissimi sia all'
interno sia all'estero, e l'imperatore re agi modificando i propri orientamenti. Cedendo alle pressioni che gli
giungevano da più parti, concesse infatti maggiori poteri al parlamento sino a che col tempo il regime
assunse addirittura un carattere liberale e la politica dell' imperatore rivelò il suo desiderio di ingraziarsi la
sinistra piuttosto che la destra. Il regno di Napoleone III può essere quindi diviso in due periodi; è
opportuno però precisare che mentre la politica da lui seguita inizialmente è il risultato di un programma
preciso, quella degli anni successivi deve essere considerata il frutto di un compromesso con i suoi principi.
In un primo tempo l'imperatore non tentò quasi nemmeno di mascherare il suo governo personale […]. Il
conferimento al governo delle prerogative che garantivano il potere personale di Napoleone venne sancito
dalla costituzione del I4 gennaio 1852, che ebbe bisogno soltanto di qualche lieve emendamento, quando
fu proclamato l'Impero.
Tale costituzione non solo rendeva l'imperatore padrone assoluto dell'esecutivo, ma gli affidava anche ampi
poteri di intervento nel campo legislativo. Nella sua qualità di sovrano, egli era l'unico responsabile della
politica estera, aveva il diritto di dichiarare guerra e di firmare trattati ed era il comandante supremo
dell'esercito e della marina; inoltre nominava e licenziava a propria discrezione i ministri, i quali erano
responsabili verso di lui a titolo personale e non in quanto membri di un organo collegiale. Il gabinetto
aveva pertanto il carattere di un comitato di funzionari e non quello di un organo autonomo di governo in
grado di opporre una volontà collettiva a quella dell'imperatore. Per l'approvazione del bilancio e la
promulgazione di leggi che non avessero carattere costituzionale il governo doveva ottenere il voto
favorevole del corps législatif, i cui membri venivano eletti a suffragio universale per sei anni.
Tuttavia il corps législatif non aveva il diritto di formulare le leggi o di elaborare e modificare il bilancio e
altri progetti di legge senza il consenso del consiglio di Stato, composto di funzionari ai quali era stato
affidato il compito di preparare tutte le leggi. La Camera elettiva quindi poteva soltanto approvare o
respingere le misure proposte dai funzionari nominati dall'imperatore. In effetti il corps législatif era stato
concepito più come sorta di organo consultivo che come un'istanza parlamentare che avesse il compito di
elaborare la linea politica fondamentale del governo. Dato che aveva questa funzione limitata, esso
avrebbe dovuto riunirsi normalmente soltanto per una sessione di tre mesi all'anno, e i suoi membri non
avrebbero dovuto essere retribuiti: in pratica però le sessioni duravano règolarmente più di tre mesi, e alla
fine i deputati ricevevano uno stipendio sotto forma di "indennità". In base alla costituzione venne creato
inoltre un Senato, di cui facevano parte marescialli, ammiragli e cardinali - che erano membri di diritto - e
altri senatori fino a un totale di centocinquanta nominati a vita dall'imperatore. [...] In realtà, neppure nel
periodo del governo personale di Napoleone III l'Impero fu tanto oppressivo quanto la sua costituzione
potrebbe far supporre. Dato che i sostenitori fidati del regime non furono mai molti, non superando
politicamente il gruppetto di amici intimi e di complici che avevano aiutato il Bonaparte ad attuare il colpo
di Stato, questi non poté escludere dalla vita politica tutti coloro che continuavano a preferire un diverso
regime. Egli non cercò di impedire ai capi riconosciuti del partito orleanista e di quello legittimista di
esprimere per mezzo della stampa la loro opinione sui problemi politici, né li escluse dalle cariche
pubbliche: gli bastava che pronunciassero il giuramento di fedeltà. Benché nelle elezioni il governo facesse
valere la propria influenza per garantire la vittoria di un particolare candidato a preferenza di altri - cosa
che del resto avevano fatto anche i precedenti regimi -, spesso fu costretto a scegliere fra vari candidati,
nessuno dei quali poteva essere considerato un sicuro sostenitore della sua politica. È vero che ai
repubblicani fu lasciata libertà di movimento molto più limitata, e tuttavia anche a loro fu concesso di
presentarsi candidati alle cariche pubbliche, sempre che dimostrassero di avere di fatto accettato l'Impero.
Fin dall'inizio l'imperatore fece capire chiaramente di desiderare l'approvazione della Chiesa. Continuò a
mantenere a Roma la guarnigione francese che era stata inviata in aiuto del papa nel 1849 e lasciò alla
Chiesa piena libertà di estendere la propria influenza nella scuola primaria e secondaria (legge Falloux del
1850)14. In particolare la Chiesa dovette al governo imperiale il rapido sviluppo degli ordini religiosi, dai
quali poté trarre il personale insegnante necessario a rendere concreto questo suo nuovo massiccio
14
La legge stabiliva la libertà dell'istruzione superiore e universitaria sotto la supervisione dello Stato, dandogli la
facoltà di sovvenzionare le scuole private. Di fatto solo gli ordini religiosi erano in condizione di poter organizzare
istituzioni educative in grado di confrontarsi con quelle statali.
13
inserimento nel campo dell'istruzione; il governo giunse perfino a incoraggiare le autorità locali ad
approfittare di un articolo della legge Falloux che consentiva loro di affidare l'insegnamento nelle scuole
pubbliche a membri di ordini religiosi.
Nel frattempo vennero prese misure intese a favorire quell'espansione economica che avrebbe dovuto
costituire l'elemento di integrazione dell'ordine politico. Particolarmente importanti in questo campo
furono i provvedimenti volti a facilitare il credito. [...] Man mano che Napoleone III si avviava a tradurre in
realtà la sua vaga promessa di conciliare il progresso materiale con un regime politico conservatore,
l'Impero riscuoteva consensi sempre più larghi e convinti da parte dell'opinione pubblica. Fino al 1859, anzi,
sembrava che i problemi che per tanto tempo avevano diviso il Paese potessero essere gradualmente
dimenticati e che i francesi riuscissero a trovare di nuovo il modo di operare uniti per uno scopo comune.
14
BISMARCK E L'UNIFICAZIONE TEDESCA
da GEOFFREY BARRACLOUGH, Le origini della Germania moderna, 1964
Otto von Bismarck, cancelliere del Regno di Prussia e principale artefice dell'unificazione tedesca, era un
membro dell'aristocrazia terriera degli Junker, classe sociale di cui condivideva l'orientamento
profondamente conservatore e la diffidenza verso i principi liberali. Forte di una solida esperienza
diplomatica (era stato ambasciatore a Pietroburgo e a Parigi) e di una chiara visione strategica, egli opera
costantemente nella prospettiva di trasformare la Prussia in una grande potenza.
In questa linea si muove la sua azione di governo nell'ambito della politica economica (potenziamento delle
comunicazioni, commesse statali, tariffe doganali), di quella militare (finanziamenti al settore degli
armamenti e all'esercito), di quella estera (accordi per assicurarsi la neutralità delle nazioni che potrebbero
avversare l'unificazione della Germania, scontro militare con quelle che la ostacolano).
In particolare nella scrupolosa preparazione diplomatica e nella conduzione militare delle guerre che
apriranno la strada alla nascita del Secondo Reich, Bismarck si preoccupa di evitare che si accendano
rivoluzioni liberali o sociali, come era accaduto nel 1848. Come sottolinea lo storico Geoffrey Barraclough
nelle pagine seguenti, l'abilità dello statista prussiano consiste nello sganciare l'ideale nazionale da quello
liberale, facendo si che la guerra per l'unità non degeneri in pericolose insurrezioni che minaccino di alterare
gli equilibri sociali e politici. In ciò Bismarck è favorito dalle condizioni economiche del Paese, che sta
attraversando una positiva fase di espansione e vede attenuarsi le tensioni sociali e le richieste di riforme.
Molti anni prima del 1871 lo specialista prussiano di arte militare Clausewitz aveva azzardato l'opinione che
«c'era un solo modo per la Germania di raggiungere l'unità politica, e cioè con la spada: uno degli Stati deve
ridurre gli altri in soggezione». Le guerre del 1866 e del 1870 parvero dargli ragione.
Sotto molti aspetti è vero che la Germania è stata una conquista prussiana ottenuta a spese dell'Austria e
della Francia. Nel 1866 l'opinione pubblica tedesca nel complesso era schierata dalla parte dell'Austria e
persino in Prussia, particolarmente in Renania, ci fu resistenza alla guerra; a Berlino non mancarono
dimostrazioni in questo senso. Alla dieta federale15 tutti gli Stati non rigorosamente controllati dai cannoni
prussiani votarono la condanna della Prussia, e sebbene questo voto esprimesse prevalentemente il punto
di vista dei principi, esso rappresentava anche il sentimento delle classi medie di orientamento liberale, cui
ripugnava la prassi anticostituzionale del governo di Bismarck. C'è pertanto molto di vero nell'affermazione
secondo la quale la Germania «fu conquistata, non unita». E tuttavia questa non è tutta la verità. Molti
fattori di antica data lavoravano in favore della Prussia; è stato infatti osservato non senza ragione che «la
Germania era praticamente unita prima ancora che Bismarck cominciasse ad agire». Evitando gli errori del
1848-1849, Bismarck imperniò la sua politica sui robusti cardini delle tendenze già esistenti, valorizzando al
massimo i fattori favorevoli alla causa prussiana. Primo fra questi era il fatto che l'Austria stava sulla
difensiva, adoperandosi per tenere a freno le ambizioni prussiane, ma riluttava ad addossarsi l'onere e la
responsabilità delle faccende germaniche; essa non era un' aspirante alla corona germanica, che Francesco
I16 aveva rifiutato nel 1815, ma solo un' oppositrice decisa a impedire che il trono lasciato vacante dagli
Asburgo nel 1815 fosse occupato da altri. Il secondo fattore era la ridistribuzione della potenza territoriale
prussiana disposta nel 1815; estendendosi dal Reno alla Vistola, rinsanguata da considerevoli aggiunte di
territorio e da un complesso di riforme amministrative, la Prussia era per la prima volta in grado di
annullare la discontinuità fra domini dell'Est e dell'Ovest e di tenere sotto il suo controllo l'intera pianura
tedesca settentrionale. Ma nessuno di questi vantaggi fu importante quanto l'avvento della rivoluzione
industriale che diede alla Germania un urgente motivo pratico e contemporaneamente i mezzi per attuare
l'unificazione, il che era fino allora mancato. Lo Zollverein17 del 1834, la fondazione di una rete ferroviaria
unificata e la rivoluzione industriale tedesca che si iniziò dopo il 1850, furono pietre miliari sulla strada che
menò all'Impero bismarckiano del 1871. Questi fattori contribuirono a intensificare il senso dell'unità
germanica e, tanto sotto questo aspetto, quanto come strumenti di politica concreta, furono accortamente
15
L'assemblea generale dei rappresentanti di tutti i Paesi membri della Confederazione tedesca.
Francesco I d'Asburgo (1804-1835), imperatore d'Austria, rifiutò la corona della Confederazione germanica, costituita
nel giugno 1815.
17
L'unione doganale che comprendeva gli Stati della Confederazione germanica dal 1834 al 1871
16
15
valorizzati dalla Prussia, che aveva la fortuna di possedere i grandi giacimenti carboniferi della Ruhr.
Quando, dopo il 1850, questi giacimenti furono convenientemente sfruttati, fornirono i presupposti per lo
sviluppo di un'industria carbonifera e siderurgica che presto fu in grado di reggere vittoriosamente il
confronto con le più antiche industrie boeme. Per conseguenza la Prussia fece rapidi e sostanziali progressi,
distanziando in breve volgere di tempo l'Austria, che conservava una struttura prevalentemente agricola.
Inoltre, la prosperità diffusasi tra il 1850 e il 1871 avvantaggiò grandemente la politica di Bismarck. Come in
Inghilterra dopo la grande esposizione del 1851 il movimento dei lavoratori entrò in una fase di apatia, così
in Germania l'alba di un'epoca di abbondanza tolse vigore alle agitazioni radicali; in entrambi i Paesi si ebbe
l'impressione che il benessere e il liberalismo potessero essere raggiunti grazie alla cieca operazione di
benefiche forze economiche in graduale espansione e che il radicalismo del 1830-1848 fosse stato, oltre
che sfortunato, mal diretto dai suoi capi. Cosicché le condizioni favorevoli offerte dall'ambiente economico
agevolarono Bismarck nei suoi sforzi per dissociare il liberalismo dal nazionalismo; i vantaggi economici
dell'unificazione apparvero più evidenti proprio nel momento in cui i benefici della prosperità rendevano
più urgente una riforma radicale. Questo era un punto importante. Bismarck sapeva bene che l'unità
tedesca doveva essere conquistata, ma questo valeva solo nei confronti dell' opposizione austriaca e
francese; davanti al popolo tedesco egli aveva bisogno di qualcosa di più che la vittoria di un conquistatore,
perché solo in tal modo la sua vittoria poteva essere permanente. Non meno degli uomini del 1848, egli si
rese perfettamente conto dell' abisso che separava le aspirazioni nazionali del periodo 1790-18l5 dalla
realtà della Restaurazione e perciò non risparmiò gli sforzi per mettere al servizio della Prussia le speranze
deluse del popolo tedesco. Il suo successo fu dovuto anche (e non fu la ragione meno importante) alla
breve fase di prosperità durante la quale fu realizzato il grosso della sua opera.
Prima del 1848 l'unità nazionale disgiunta dalla riforma liberale non avrebbe soddisfatto nessuno, né fu
motivo di sufficiente soddisfazione per il popolo tedesco dopo la recessione del 1873; ma Bismarck fu
avvantaggiato dalle circostanze e fu abbastanza abile da volgerle in suo favore. Quando, nel 1866, dopo la
sua vittoria sull' Austria, il parlamento prussiano lo "compensò" con una maggioranza di 230 voti a 75 per il
procedimento incostituzionale con cui aveva riscosso imposte senza consenso parlamentare dal 1862 in
poi, egli registrò il suo primo trionfo sul liberalismo18. Fu anche la prima prova del fatto che, per il
momento, l'unità nazionale era apprezzata dall' opinione pubblica più dei benefici dell' autogoverno. [...]
L'instaurazione dell'unità germanica, implicita nell'impetuoso movimento rivoluzionario del 1848 e poi
prepotentemente sollecitata dai rapidi mutamenti economici, era inevitabile. L'opera di Bismarck consisté
nel determinare la forma particolare e scegliere il momento più opportuno per l'attuazione. La sua
magistrale diplomazia debellò l'inveterata ostilità della Francia, che altrimenti avrebbe potuto differire la
decisione di alcuni decenni, e assicurò col minimo turbamento un risultato che in altre circostanze avrebbe
richiesto una guerra di proporzioni europee e forse anche una rivoluzione. Il fatto che egli riuscisse a
manovrare secondo i suoi fini le forze unitarie all'interno della Germania, d'altra parte fece sì che l'unità
della nazione si compisse sotto la guida della Prussia.
Senza la sua opera, l'unificazione avrebbe potuto seguire un corso radicalmente differente. L'ostilità nei
confronti della Prussia e la paura dell' egemonia prussiana erano state vive e sensibili nel 1848, e si deve al
solo Bismarck, assecondato dagli sviluppi economico-sociali che egli seppe volgere a suo vantaggio, se
questa ostilità fu superata dopo il 1866. Il nuovo Reich del 1871, quale che fosse la sua facciata teorica, era
in pratica un Reich prussiano, plasmato in conformità degli interessi prussiani, costruito sullo stampo delle
tradizioni prussiane, governato dalla dinastia di Hohenzollern, dominato dalla classe prussiana degli
Junker19.
18
Per attuare la riforma dell' esercito, osteggiata dal parlamento, Bismarck fece passare ripetutamente il bilancio dello
Stato (in cui si specificavano, oltre alle spese da affrontare, anche la loro copertura finanziaria, ovvero le imposte che
avrebbero fornito il denaro necessario) attraverso decreti legislativi che praticamente scavalcavano l'approvazione
parlamentare. Tale prassi era di fatto anticostituzionale in quanto era una prerogativa del parlamento l'approvazione di
leggi che richiedessero nuove fonti di finanziamento.
19
Aristocrazia terriera e militare prussiana.
16
IL CONCETTO DI NAZIONE
da ERIC JOHN HOBSBAWM, Il trionfo della borghesia 1848-1875, 1979
Se è innegabile che il consolidarsi di Stati-nazione rappresenti il tema di fondo del venticinquennio
successivo alla metà dell'Ottocento, è altrettanto doveroso riconoscere che tale nozione non possiede
l'evidenza che i suoi sostenitori - gli esponenti dell'ideologia nazionalista - tendono ad attribuirle. Sembra
quindi opportuno, a coronamento dello studio di un periodo che ha visto il sorgere di nuove nazioni (l'Italia,
la Germania e, in una certa misura, l'Ungheria), ha assistito al ricompattarsi di altre attorno a nuovi modelli
istituzionali (la Francia), o alla loro messa in discussione (gli Stati Uniti), mentre in altri popoli ha rafforzato
l'aspirazione alla loro creazione (come per gli irlandesi, i polacchi e le popolazioni slave assoggettate agli
Imperi austro-ungarico, russo e ottomano), cercare di considerare in modo critico sia il concetto di nazione
sia quello di Stato-nazione.
È quanto cerca di fare lo storico inglese Eric J. Hobsbawm. Le sue considerazioni, mostrandoci il carattere al
fondo convenzionale (il che non significa di per sé arbitrario) di ciò che nei secoli viene considerato una
nazione, ci aiutano a capire quanto siano complessi gli intrecci che si vengono a costituire attorno alle
rivendicazioni nazionali. Sotto questa luce risulta meglio comprensibile il fatto che un'ideologia come quella
nazionalista abbia continuato, sia pure sotto mutate forme, ad alimentare le tensioni internazionali, dentro
e fuori l'Europa, per tutto il secolo XIX e anche il XX.
Su che cosa verteva la politica internazionale degli anni fra il 1848 e il 1870-1880? La storiografia
occidentale di tipo tradizionale ha ben pochi dubbi: verteva sulla creazione di un'Europa di Stati-nazione.
Poteva regnare una notevole incertezza circa il rapporto fra questo aspetto dell'epoca ed altri che gli erano
evidentemente collegati, come il progresso economico, il liberalismo e forse la stessa democrazia; ma
nessuna circa il ruolo centrale della nazionalità.
E invero, come poteva essere altrimenti? Il 1848, la "primavera dei popoli", qualunque altra cosa fosse, fu
chiaramente anche - e, in termini internazionali, in primo luogo - una asserzione di nazionalità, o meglio di
nazionalità rivali. [...] Le rivoluzioni fallirono, ma la politica europea del venticinquennio successivo fu
dominata dalle stesse ,aspirazioni. Come abbiamo visto, esse vennero in una forma o nell' altra soddisfatte,
benché con mezzi non-rivoluzionari o solo marginalmente rivoluzionari. La Francia tornò ad una caricatura
della "grande nazione" sotto una caricatura del grande Napoleone; l'Italia e la Germania vennero unite
sotto i regni di Savoia e di Prussia; l'Ungheria ottenne in pratica l'autonomia grazie al Compromesso del
1867; la Romania divenne uno Stato attraverso la fusione dei due "principati danubiani". Solo la Polonia,
che non aveva preso parte adeguata alla rivoluzione del I 848, non raggiunse neppure l'indipendenza o
l'autonomia con l'insurrezione del 1863. [...] Sembrava innegabile che il "far nazioni" fosse un processo
comune a tutto il mondo, e una caratteristica ovvia e dominante dell' epoca.
Così ovvia, che non ci si preoccupò di studiare la natura del fenomeno. "La nazione" fu data come fatto
acquisito. Come scriveva Bagehot: «Non possiamo immaginare coloro ai quali essa crea difficoltà e che
dicono: "Sappiamo che cos'è quando non ce lo chiedete"; ma non possiamo di punto in bianco spiegarla o
definirla», e pochi credevano di averne bisogno. Certo, gli inglesi sapevano che cosa significava essere
inglesi; ma i francesi, i tedeschi, gli italiani o i russi, non avevano dubbi sulla loro identità collettiva? Forse
no, ma nell'era della costruzione di nazioni si pensava che ciò implicasse la logica, necessaria, non meno che
desiderabile, trasformazione di "nazioni" in Stati-nazione sovrani, con un territorio compatto definito dall'
area occupata dai membri di una "nazione" a sua volta definita dalla sua storia passata, dalla sua cultura
comune, dalla sua composizione etnica e, sempre più, dalla sua lingua.
Ma non v'è nulla di logico in questa implicazione. Se l'esistenza di gruppi diversi di uomini, che si
distinguono da altri gruppi per una varietà di criteri, è insieme innegabile e vecchia quanto la storia, non lo
è altrettanto il fatto ch'essa implichi quella che il secolo XIX considerava una "nazionalità". E lo è ancor
meno il fatto d'essere organizzati in Stati territoriali del tipo ottocentesco, non parliamo poi di Stati
coincidenti con "nazioni".
[...] Dobbiamo quindi distinguere con la maggior chiarezza possibile tra formazione di nazioni e
"nazionalismo" da un lato, nei limiti in cui si presentarono in questo periodo, e creazione di Stati-nazione
dall' altro.
17
Il problema non era soltanto analitico, ma pratico. Perché l'Europa, non parliamo poi il resto del mondo, era
evidentemente divisa in "nazioni" sui cui Stati, o sulle cui aspirazioni a fondare Stati, esistevano, a torto o a
ragione, scarsi dubbi, e in nazioni in merito alle quali v'era una notevole dose di incertezza. La guida più
sicura alle prime era il fatto politico, la storia delle istituzioni o la storia della cultura, per limitata che fosse
a una piccola cerchia di persone. Francia, Inghilterra, Spagna, Russia erano innegabilmente delle "nazioni",
perché possedevano Stati identificati con i francesi, gli inglesi ecc. Ungheria e Polonia erano delle nazioni,
perché un Regno ungherese esisteva come entità distinta nell'ambito stesso dell'Impero asburgico e uno
Stato polacco era a lungo esistito prima che venisse distrutto alla fine del secolo XVIII. La Germania era una
nazione sia perché i suoi numerosi principati, sebbene mai uniti in un solo Stato territoriale, avevano a
lungo costituito il cosiddetto "Sacro Romano Impero della nazione tedesca" e formavano ancora la
Confederazione germanica, sia perché tutti i tedeschi colti condividevano la stessa lingua scritta, la stessa
letteratura. L'Italia, benché non fosse mai stata un'entità politica in quanto tale, vantava forse la più antica
cultura letteraria comune alla sua elite. E cosi via.
Il criterio "storico" della nazionalità implicava quindi l'importanza decisiva delle istituzioni e della cultura
delle classi dominanti o delle elite colte, supposto - come si supponeva - che si identificassero, o non
fossero troppo ovviamente incompatibili, con quelle del popolo comune.
Ma l'argomento ideologico a favore del nazionalismo era assai diverso e molto più radicale, democratico e
rivoluzionario. Esso poggiava sul fatto che, qualunque cosa dicessero la storia o la cultura, gli irlandesi
erano irlandesi e non inglesi; i cèchi, cèchi e non tedeschi; i finnici, finnici e non russi, e nessun popolo
doveva essere sfruttato e dominato da un altro. [...] La base di questo senso di separazione non era
necessariamente "etnica", cioè non poggiava su differenze facilmente identificabili dell' aspetto fisico, e
neppure linguistica. Durante il nostro periodo, i movimenti degli irlandesi (la maggioranza dei quali parlava
già l'inglese), dei norvegesi (la cui lingua letteraria non si distingueva gran che dalla danese), o dei finlandesi
(i cui nazionalisti erano sia svedofoni che finnofoni), non accampavano argomenti fondamentalmente
linguistici. Se questi erano culturali, poggiavano non sull'''alta cultura", che pochi dei popoli interessati
finora possedevano, ma piuttosto sulla cultura orale - canzoni, ballate, epopee ecc., i costumi e modi di vita
del folk, il popolo comune; cioè, ai fini pratici, il contadiname. […] Il dato importante è che la tipica nazione
"non-storica" o "semi-storica" era anche una piccola nazione, per cui il nazionalismo ottocentesco si
trovava posto di fronte a un dilemma che solo di rado si riconosce. Infatti, i campioni dello "Stato-nazione"
assumevano che questo dovesse essere non soltanto nazionale, ma "progressista", cioè atto a sviluppare
un'economia, una tecnica, un' organizzazione statale e una forza militare dotati di vita propria: in altri
termini, almeno di una certa grandezza. Doveva in realtà, essere la cellula "naturale" di sviluppo della
moderna società liberale, progressiva e, de facto, borghese. Il suo principio era l"'unificazione" non meno
della "indipendenza", e là dove non esistevano argomenti storici a favore dell'unificazione - come per
esempio ne esistevano in Italia e Germania -, la si formulava, se possibile, come programma. [...]
L'argomento più semplice, per coloro che identificavano gli Stati-nazione col progresso, era di negare ai
popoli piccoli e arretrati il carattere di "vere" nazioni [...] V'era in argomenti simili un forte elemento di
inegualitarismo e, forse, uno ancor più forte di pretesa a un trattamento speciale. Certe nazioni - le grandi,
le "progredite", le consolidate, compresa (certo) quella dell'ideologo - erano destinate dalla storia a
prevalere o (se l'ideologo preferiva una fraseologia darwiniana) a uscire vincitrici dalla lotta per l'esistenza;
altre no.
Ma il fatto non andava meramente interpretato come una congiura di alcune nazioni per opprimerne altre,
benché non si potesse dar torto ai portavoce di nazionalità non riconosciute se la pensavano appunto così.
Perché l'argomento era diretto non tanto contro gli idiomi e le culture regionali della nazione stessa,
quanto contro gli outsiders, e non ne prevedeva necessariamente la scomparsa, ma solo la retrocessione
dallo status di "lingua" a quello di "dialetto". Cavour non negava ai savoiardi il diritto, in una Italia unita, di
parlare la loro lingua (più simile al francese che all'italiano): egli stesso la usava in famiglia. Insisteva
unicamente, come altri nazionalisti italiani, sulla necessità che esistessero una sola lingua ufficiale e un solo
veicolo ufficiale di istruzione, cioè l'italiano, e che gli altri colassero a picco, o restassero come meglio
potevano a galla. Allo stato dei fatti, in questa fase, poiché né i siciliani né i sardi insistevano sulla propria
nazionalità separata, il loro problema poteva essere ridefinito al massimo come "regionalismo". Il fatto
assumeva importanza politica solo quando la nazionalità era rivendicata da un piccolo popolo, come i cèchi
nel 1848, allorché i loro esponenti respinsero l'invito dei liberali tedeschi a partecipare ai lavori dell'
Assemblea di Francoforte. [...]
18
Nessuno straniero si preoccupava di osservare che diversi degli "Stati nazionali" di più antica storia erano in
realtà multinazionali (es. l'Inghilterra, la Francia, la Spagna), perché i gallesi, gli scozzesi, i bretoni, i catalani
ecc. non ponevano alcun problema internazionale e (con la possibile eccezione dei catalani) nessun
problema di rilievo nella politica interna dei rispettivi paesi.
19
LA POLITICA DEL “CONNUBIO”
da ROSARIO ROMEO, Cavour e il suo tempo, 1977
Nonostante Cavour ne andasse fiero come del più bell'atto della sua vita politica, sulla strategia del
connubio e sui suoi effetti il giudizio degli storici non è altrettanto positivo. La scelta di creare un forte
centro, che raccolga le forze liberali-moderate e progressiste, produce infatti conseguenze non positive: gli
estremi, esclusi dalla possibilità di governare, accentuano il loro atteggiamento critico, assumendo posizioni
intraducibili nella concretezza della vita politica, visto che non vi sono per loro reali prospettive di essere
chiamati ad assumersi responsabilità di governo; le forze di governo, sicure della loro stabilità, tendono
invece all'inerzia e scelgono la via dei piccoli compromessi e degli accordi sotto banco.
Essendo questo il quadro, in Italia, diversamente da quanto accade nelle democrazie più avanzate del
tempo, come quella inglese e statunitense, non si creano le condizioni per quel chiaro bipartitismo che renda
possibile una proficua dialettica e alternanza fra conservatori e progressisti.
Rosario Romeo, nel tracciare una valutazione complessiva della politica del connubio, mostra come in realtà
l'obiettivo della creazione di un sistema bipartitico fosse originariamente nella mente sia degli avversari che
dei fautori di tale strategia. Ciò che però di fatto si realizzerà sarà la costante tendenza delle forze di centro
ad allearsi tra loro - anche sulla base di compromessi e discutibili alleanze - allo scopo di mantenere la
direzione del Paese e di escludere dal governo l'estrema destra e l'estrema sinistra.
Con l'operazione del connubio, effettuata quando la situazione politica era apparsa matura, dopo la
decantazione delle passioni e degli estremismi del 1848, Cavour realizzava una delle istanze più profonde e
più tenaci del suo liberalismo, intorno alla quale si era sviluppata gran parte del suo pensiero politico.
Pure, il giudizio corrente intorno alla alleanza allora stretta fra "centro destro" e "centro sinistro",
fondamentale nella vita politica del conte e nella storia del liberalismo italiano, per decenni celebrata con
accenti incondizionatamente apologetici, e dallo stesso Cavour indicata come «il più bell'atto della sua vita
politica», si è venuto facendo negli ultimi tempi più pesante, sino ad apparire, nella sostanza, rovesciato.
Invece di essere salutato come un gesto di audace e ragionato progressismo, nello spirito della più classica
tradizione liberale, il connubio è stato condannato come l'atto che inaugurò la tradizione "trasformistica"20
della vita parlamentare italiana, da allora caratterizzata dal predominio di maggioranze centriste
sostanzialmente immobili e prive di alternative, capaci solo di "decapitare" le opposizioni assorbendole e
svuotandole, senza dar sbocco alle esigenze reali di cui esse erano espressione. Nella mancanza di ogni
concreta ipotesi di ricambio, si dice, i governi vennero indotti, da allora in poi, a ripiegare sul mero
godimento del potere, e i mutamenti, frequentissimi, delle formazioni ministeriali furono, di regola, il
risultato di combinazioni e manovre personalistiche, alle quali rimaneva estranea ogni modificazione reale
degli indirizzi di governo. Prive di ogni prospettiva reale di conquista del potere, le opposizioni venivano
invece respinte sulle posizioni politiche più dottrinarie ed estreme, mentre i governi, al sicuro da ogni
minaccia di rovesciamento, praticavano una politica di sostanziale immobilismo e di conservazione.
Tutto il contrario, si asserisce, di quanto accade nei Paesi del bipartitismo classico, la Gran Bretagna, gli
Stati Uniti e talune democrazie nordiche, dove la netta distinzione dei due grandi schieramenti
conservatore e progressista ha consentito un effettivo alternarsi delle forze politiche alla direzione del
Paese, la cui vita politica in tal modo si caratterizza come una fisiologica successione di fasi di rinnovamento
e di conservazione, nel quadro di un graduale e ordinato progresso. [...]
Il modello del bipartitismo inglese era ben presente anche alla cultura politica piemontese del tempo e agli
stessi protagonisti dell'operazione realizzata nel febbraio 1852. Nel dibattito sul significato della nuova
alleanza Cavour-Rattazzi lo invocò, tra gli avversari del connubio, Cesare Balbo, che al problema aveva
anche dedicato qualche anno prima attente meditazioni nella Monarchia rappresentativa. L'illustre storico
ricordò allora che all'interno di ciascuno dei due grandi partiti della conservazione e del progresso
dovevano essere presenti anche gradazioni minori, nelle quali il principio ispiratore di tutto il partito si
rispecchiava in modo più o meno accentuato; e che l'esclusione di qualcuna di queste gradazioni
20
L'espressione "trasformismo" richiama la politica della Sinistra storica, inaugurata da Depretis nel 1876, con la quale
il governo cerca il sostegno della destra moderata, per rafforzare la maggioranza che lo può sostenere; a questo scopo
deve attenuare il carattere innovativo della sua linea di governo, orientandosi verso scelte più moderate.
20
menomava gravemente la capacità del partito di assolvere la propria funzione. «In generale» osservava «i
campi parziali [o] sono più moderati che il grosso del partito, o sono più estremi, più vivi;» e di
conseguenza, scindendosi dal partito, essi «se sono più moderati, tolgono la moderazione; se sono più vivi,
tolgono la vivacità. In tal guisa il partito intiero da cui essi si distaccano non sarà più un partito compìto...»
Al bipartitismo si richiamò anche il presidente della Camera Pinelli, [che] si augurava la divisione «soltanto
in due partiti, in quelli che credono che il Ministero attuale possa condurre a buon fine il Governo, e
l'appoggiano, o in quelli i quali opinano di doversi spingere verso un Ministero che si proponga una meta
più larga, più libera, e segue una via più ardimentosa».
E appunto a questo i fautori dell'operazione cavouriana ritenevano che potesse condurre la nuova alleanza
Cavour-Rattazzi: grazie a essa, commentava il «Risorgimento», la Camera «avrà fondato, onorandolo, il
sistema costituzionale, se veramente questa tornata esordisce alla formazione, definitiva di due partiti
egualmente costituzionali e onesti: de' tory [sic] e dei wighs [sic]... del Parlamento subalpino». Nella nuova
e più grave situazione all'interno e all'estero, scriveva il giornale, che continuava a essere considerato
fedele espressione del pensiero cavouriano, «non possono più esistere quelle minime frazioni di partiti che
facevano d'ogni anche leggera gradazione delle opinioni un motivo di separazione e uno stimolo a
reciproche ostilità»; ed era invece possibile ritenere che nella prossima sessione parlamentare «le più inutili
fra quelle distinzioni saranno sparite, e in mezzo ai due eccessi dell'impreveggenza e della paura starà
numeroso e compatto il vero partito costituzionale; cioè il partito di tutti coloro che hanno fede nella
libertà congiunta al principato».
L'esclusione dei due «eccessi» era, come sappiamo, di capitale importanza tra le motivazioni che, nella
visione del Cavour, spingevano alla formazione di un partito capace di riunire tutte le frazioni liberali e a un
tempo riformatrici e progressiste. Altrettanto netta la condanna degli estremi nel Balbo e nel Pinelli,
concordi nel ritenere che non potessero avere legittima rappresentanza in parlamento tanto coloro che
miravano a «ritornare ai tempi del dispotismo», quanto i «repubblicani» e gli estremisti in genere, che per
ciò stesso si collocavano fuori dello Statuto. E chiaro però che per effetto di queste esclusioni il
frazionamento dei partiti, cosi energicamente rifiutato in linea di principio, finiva per riapparire in linea di
fatto, e che le professioni di bipartitismo restavano confinate a una sfera meramente teorica; e appunto su
questo aspetto si è spesso imperniata la critica alla tradizione centrista della vita parlamentare italiana, e
alla sua incapacità di assicurare un effettivo ricambio di forze nella direzione del Paese.
21
CAVOUR E L'IMPRESA DEI MILLE
da DENIS MACK SMITH, Cavour e Garibaldi nel 1860, 1958
Dopo il successo raggiunto nella Seconda guerra d'indipendenza contro l'Austria, Cavour, soddisfatto
dell'acquisizione della Lombardia, non prevede di riprendere le armi per liberare il Mezzogiorno. In
conversazioni private esprime anzi la speranza che Napoli e la Sicilia restino tranquille per alcuni anni; la
presenza dei Borbone al Sud non costituisce un ostacolo ai suoi immediati progetti per l'Italia che prevedono
un'alleanza o mia confederazione di Stati e non uno Stato italiano unitario.
L'iniziativa dei Mille impone tuttavia a Cavour di rivedere i suoi progetti:
il successo dei garibaldini avrebbe potuto aprire la strada a un'iniziativa dei democratici che, ottenuto il
controllo del Mezzogiorno, avrebbero potuto crearvi un governo repubblicano; l'eventuale invasione dei
territori pontifici da parte di Garibaldi avrebbe poi scatenato la prevedibile reazione di Napoleone III.
Compromessi i "buoni" rapporti con la Francia, Cavour avrebbe perso il suo alleato più prezioso e l'Italia la
sua credibilità internazionale.
I timori di Cavour si dimostrano fondati quando, nel settembre del 1860, Garibaldi dopo aver liberato la
Sicilia e il Mezzogiorno, punta sullo Stato pontificio. È in questo scenario che matura nello statista
piemontese la decisione di intervenire. In quel momento, come spiega Mack Smith nelle pagine che
seguono, «combattere l'influenza di Garibaldi e impedire che la rivoluzione si estenda nel Regno... era più
importante che combattere contro l'Austria».
Cavour comprese che si era giunti a ciò che sentiva essere la fase suprema, quella critica quindi, del
Risorgimento. E, pur essendo riconoscente a Garibaldi di alcune delle grandi cose da lui compiute per
l'Italia, era tuttavia adesso più convinto che mai che il dittatore costituiva essenzialmente un pericolo, oltre
a essere per lui una fonte di fastidi. [...] Nominalmente Garibaldi aveva sotto di sé nel Mezzogiorno
un'estensione di territorio e un numero d'italiani non inferiori a quelli su cui regnava Vittorio Emanuele;
c'era quindi serio pericolo che, in confronto col trionfante dittatore, la reputazione guerriera che i
piemontesi avevano con tanta difficoltà creata per il loro re andasse perduta e che Vittorio Emanuele
apparisse soltanto come un amico di Garibaldi, facitore di re. Il 1° settembre Ricasoli si rivolgeva
insolentemente e con la violenza della disperazione al governo, dicendo a questo proposito che «les Italiens
cherchent en vain leur Roi»21; e toccando così sul vivo tanto Cavour che Sua Maestà. Non restava ancora
molto a Garibaldi per giungere a contatto con le forze a difesa di Roma; se ci fosse giunto, l'autorità del
sovrano e l'alleanza con la Francia, su cui i conservatori liberali fondavano la loro politica, sarebbero state
fortemente scosse - così almeno pensava Cavour - e forse ciò avrebbe anche dato occasione a
quell'intervento straniero in Italia per evitare il quale Cavour tanto si era dato da fare; la stessa struttura
politica interna del Piemonte ne sarebbe stata minacciata: e, infatti, quantunque Cavour probabilmente
non credesse del tutto ai pericoli del repubblicanesimo, restava il fatto che un dittatore che traeva il suo
potere dal diritto di conquista chiedeva al re di disfarsi del rappresentante responsabile del "popolo" in
Parlamento e da questo eletto22. C'era poi il fatto che - come osservava il rappresentante britannico a
Napoli- «nessun Paese [aveva] più interesse del Piemonte ad impedire il diffondersi di dottrine
rivoluzionarie estremiste». Meglio correre qualsiasi rischio piuttosto di lasciare che Garibaldi proseguisse
indisturbato il suo cammino; ma era preferibile, se ce ne fosse la possibilità, far compiere un passo falso ai
radicali, e far ricadere cosi su loro la responsabilità di una rottura che Cavour avrebbe potuto fingere di
deplorare.
Cavour si era preparato per tale eventualità almeno fin dalla metà d'agosto; e il primo indubitabile passo da
lui compiuto in tal senso era costituito dalla circolare del 13 agosto, che vietava l'arruolamento di volontari.
Ma egli ammetteva anche che il solo modo per cattivarsi l'opinione pubblica consisteva nel togliere a
Garibaldi un po' del suo prestigio; perciò avrebbe dovuto aderire alla rivoluzione per poter ereditare e
legittimare le conquiste dei radicali.
21
"Gli italiani cercarono inutilmente il loro sovrano".
Garibaldi, in una lettera pubblicata il 15 settembre 1860 sul «Giornale di Napoli», esprimeva il proprio dissenso nei
confronti di Cavour, colpevole di aver «venduto Nizza ai francesi, (come previsto a Plombières), mantenendo invece il
proprio ossequio nei confronti del re.
22
22
Il vero banco di prova sarebbe consistito nel vedere se egli potesse spodestarli e succeder loro senza
scendere in campo aperto contro di loro; se avesse potuto vincere senza sembrare ignominiosamente
ingrato; e, in pratica, se fosse potuto arrivare in tempo a Napoli: donde la risoluzione d'invadere il territorio
pontificio, per poter cosi gareggiare con i rivoluzionari sul loro terreno e assicurare, in pari tempo, il libero
passo verso sud alle truppe piemontesi. [...] Senza dubbio, Cavour aveva d'improvviso compreso che,
poiché Garibaldi avrebbe potuto in ogni caso valicare in breve tempo la frontiera del territorio pontificio ed
estendere la lotta a tutta l'Italia centrale, egli non avrebbe avuto certo nulla da guadagnare e molto da
perdere astenendosi dall'azione.. Riteneva probabile che la Francia si sarebbe opposta all'invasione
garibaldina, mentre avrebbe potuto indursi a guardar con favore l'intervento piemontese se le fosse stato
presentato come una soluzione più a buon prezzo per impedire il diffondersi della rivoluzione e per salvare
al papa almeno Roma. Solo se si fosse potuto convincere la Francia ad accettare questo punto di vista, la
progettata invasione avrebbe avuto buone probabilità di procurare en passant al Regno sardo le province
pontificie dell'Umbria e delle Marche, e, presumibilmente, anche quelle del Napoletano e della Sicilia; e
avrebbe così offerto agli italiani un'alternativa al loro entusiasmo per Garibaldi, le cui virtù militari
avrebbero forse, per effetto di tale impresa, perso molto del loro fulgore, e anche impedito una sua
ulteriore avanzata verso nord.
Cavour aveva quindi tutto da guadagnare; e, anche se avesse perso qualcosa, era almeno convinto o quasi
che, in ogni altro caso, avrebbe subito perdite maggiori, giacché se fosse rimasto inerte o avesse seguito
una qualsiasi altra linea di condotta, l'Europa avrebbe potuto allora metter termine alla politica del nonintervento; senza dire che, se avesse continuato a opporsi alla corrente del sentimento nazionale, ne
sarebbe stato certamente travolto.
23
LE CORAGGIOSE RIFORME PRESERVANO IL PAESE DALLE «COMMOZIONI» RIVOLUZIONARIE
da C. CAVOUR, Discorsi parlamentari
Il 7 marzo 1850 il Cavour, non ancora ministro, prese posizione in Parlamento a favore del progetto di legge
Siccardi. Si trattava, propriamente, di tre disegni di legge intesi a sottrarre alla Chiesa i suoi antichi privilegi
in nome della concezione laica e moderna dello Stato.
Il primo di tali disegni prevedeva infatti l'abolizione del foro ecclesiastico e del diritto di asilo riconosciuto
alle chiese e ai conventi: misure di stampo illuministico già realizzate in molti paesi europei fin dal tempo
dell' assolutismo riformatore. La battaglia fu asperrima nel Parlamento e nel paese per la irriducibile
opposizione dei conservatori più retrivi e del clero levatosi a difendere i propri privilegi, e tuttavia la legge fu
approvata.
Le argomentazioni del Cavour a favore della legge risultarono convincentissime: se si aveva caro lo spirito
«conservatore», se si volevano preservare le istituzioni liberali dalle minacce sovvertitrici occorreva
concedere le riforme richieste dai tempi. Non v' era altro mezzo per disarmare lo spirito rivoluzionario. «Le
riforme compiute a tempo, invece di indebolire l'autorità la rafforzano; invece di crescere la forza dello
spirito rivoluzionario, lo riducono all'impotenza». Era la lezione dei grandi statisti inglesi, che, in virtù delle
riforme effettuate in tempo, avevano preservato il paese dalle tempeste rivoluzionarie .
Questa riforma è da alcuni ravvisata come un atto di debolezza, come una concessione fatta allo spirito
rivoluzionario [...]. A questi uomini io mi farò lecito di dire: volgete gli occhi a tutti i paesi d'Europa, e vedete
chi sono coloro che poterono resistere alla bufera rivoluzionaria. Non poterono i principi di Germania, i
quali videro tutti più o meno insanguinate le loro capitali; nol poté la Francia, che vide rovesciato in poche
ore un trono. In questo paese vi erano uomini distinti, oculatissimi, che senza contrapporre il merito delle
riforme politiche, le rimandarono dicendole inopportune, e con questa procrastinazione furono colti dallo
spirito rivoluzionario, e le riforme, invece di compiersi con maturità ed esperienza, si compirono colla
violenza e colla rivoluzione. Se il signor Guizot, il quale non contrastava egli stesso la giustizia di coloro che
domandavano la riforma elettorale, non l'avesse rimandata come inopportuna, egli è probabilissimo che
Luigi Filippo sarebbe ancora sul trono.
Quale è dunque il solo paese che seppe preservarsi dalla bufera rivoluzionaria? E’ quell'Inghilterra a cui
accennava il deputato Balbo. In quel paese, uomini di Stato i quali avevano caro il principio conservatore,
che sapevano far rispettare il principio di autorità, ebbero pure il coraggio di compiere immense riforme, a
petto delle quali quella di cui ci occupiamo è ben poca cosa, e ciò quantunque una parte numerosa dei loro
amici politici le combattessero come inopportune [...].
Nel 1829 il duca di Wellington, al quale non si può certamente negare fermezza di carattere ed energia,
seppe pure separarsi dai suoi amici politici, e compiere l'emancipazione cattolica23, che l'intiera chiesa
anglicana combatteva come inopportuna; e con questa riforma evitò nel 1830 una guerra religiosa
nell'Irlanda.
Nel 1832 lord Grey, separandosi dalla maggior parte del ceto a cui apparteneva, seppe pure fare accettare e
dalla Corona e dalla aristocrazia la riforma elettorale, che si riputava non solo inopportuna, ma quasi
rivoluzionaria; e con questa riforma lord Grey preservò l'Inghilterra da ogni commozione politica.
Finalmente, o signori, un esempio più recente ed anche più luminoso fu quello che ci diede sir Robert Peel
nel 184624. Egli seppe compiere una riforma economica malgrado gli sforzi di tutta l'aristocrazia territoriale,
nella quale questa non perdeva solo una giurisdizione eccezionale, ma una parte delle rendite; e per
compiere questa grande riforma il ministro Peel ebbe il coraggio di scostarsi dalla massima parte dei suoi
amici politici e di soggiacere all'accusa che più compisce un uomo di Stato generoso come il Peel, quella di
apostasia e di tradimento. Ma di questo fu largamente compensato dalla sua coscienza, e dal sapere che
quella riforma salvava l'Inghilterra dalle commozioni socialistiche, che agitavano tutta l'Europa, e che
parevano dover trovare esca maggiore in Inghilterra.
23
Sotto la pressione dell'Associazione cattolica irlandese, fondata da D. Q'Connell nel 1823, il governo Wellington
abrogò nel 1829 il Test Act o Atto di Prova, che risaliva al lontano 1673, per il quale venivano esclusi dalle cariche
pubbliche tutti i non-anglicani.
24
Si tratta dell'abolizione della legge protettiva sul commercio dei grani.
24
Vedete dunque, o signori, come le riforme, compiute a tempo, invece di indebolire l'autorità, la rafforzano;
invece di crescere la forza dello spirito rivoluzionario, lo riducono all'impotenza. Io dirò dunque ai signori
ministri: imitate francamente l'esempio del duca di Wellington, di lord Grey e di sir Robert Peel, che la
storia proclamerà i primi uomini di Stato dell'epoca nostra; progredite largamente nella via delle riforme, e
non temete che esse siano dichiarate inopportune; non temete d'indebolire la potenza del trono
costituzionale che è nelle vostre mani affidato, ché invece lo afforzerete, invece con ciò farete sì che questo
trono ponga nel nostro paese cosi salde radici, che quand'anche s'innalzi intorno a noi la tempesta
rivoluzionaria, esso potrà non solo resistere a questa tempesta, ma altresì raccogliendo attorno a sé tutte le
forze vive d'Italia, potrà condurre la nostra nazione a quegli alti destini cui è chiamata.
25
LIBERTÀ ECONOMICA E LIBERTÀ POLITICA NEL PROGRAMMA DI CAVOUR
da G. PROCACCI, Storia degli Italiani, 1968
Per procedere sulla via del rinnovamento e dell' ammodernamento del Piemonte il Cavour capì che
bisognava inserire il paese nel grande circuito dell' economia europea. A questo fine già come ministro
dell'agricoltura nel gabinetto d'Azeglio egli stipulò una serie di trattati commerciali con la Francia,
l'Inghilterra, il Belgio, l'Austria improntati a un pronunciato liberismo. Per incoraggiare le tendenze
mercantili e capitalistiche della nuova borghesia piemontese e ligure, per stimolare l'iniziativa dal basso di
produttori e agricoltori, promosse la costruzione di grandi opere pubbliche a carattere infrastrutturale:
canali di irrigazione, trafori alpini, ferrovie, facendo riguadagnare al Piemonte e all' Italia parte del tempo
perduto. A questa politica economica doveva corrispondere nei propositi del Cavour il perseguimento
dell'opera di laicizzazione dello Stato già avviata dal d'Azeglio, oltre a rendere effettivamente operanti, in
ordine alle libertà civili e politiche, i principi scritti nello Statuto albertino. Con ciò egli veniva incontro alle
diffuse aspirazioni democratiche fermentanti nei ceti borghesi e piccolo-borghesi. Per realizzare questo
programma occorreva una sicura maggioranza parlamentare onde garantirsi contro le impazienze dei
mazziniani e le nostalgie dei ceti aristocratici più retrivi.
Maturò cosi l'alleanza con la corrente più moderata della Sinistra, il «connubio» Rattazzi-Cavour.
Saliva al potere l'uomo al cui nome è legata la realizzazione dell'unità d'Italia, una tra le poche figure della
storia italiana passata ai posteri con il fascino del vincitore e non con quello del vinto. Cadetto di una
famiglia di vecchia nobiltà e indirizzato dal padre alla carriera militare, egli l'aveva ben presto abbandonata
per una vita di viaggi, di affari, di speculazioni, di studi e di amori, e per dedicarsi in età più matura alla
politica.
In una società in cui molti erano gli aristocratici taccagnamente imborghesiti e molti i borghesi che
ostentavano pose nobiliari, egli possedeva al tempo stesso tutte le virtù del borghese e tutte le virtù
dell'aristocratico: l'irrequietezza intellettuale e l'abitudine al comando, il gusto di far denaro e quello di
spenderlo, la freschezza di energie di una nuova classe sociale e lo stile di una vecchia. Di orientamenti
politici moderati, alieno da ogni simpatia verso la rivoluzione e il romanticismo politico dei mazziniani, egli
si rese conto peraltro della impossibilità di governare contro le diffuse aspirazioni democratiche
fermentanti nei ceti borghesi e piccolo-borghesi e, prima ancora di assumere le redini del gabinetto, si
assicurò una sicura maggioranza nel Parlamento, stringendo un'alleanza (il cosiddetto «connubio») con le
correnti più moderate della sinistra e con il loro esponente più in vista, Urbano Rattazzi. Essendosi in tal
modo garantito contro l'impazienza dei mazziniani e le nostalgie retrive dei «municipali» della corte, poté
svolgere con relativa tranquillità il programma di liberalizzazione e di ammodernamento della società
piemontese che aveva in mente.
Innanzitutto nel campo economico: da buon lettore di Adam Smith e da imprenditore agricolo illuminato e
intraprendente quale egli era, il Cavour nutriva una concezione dello sviluppo economico essenzialmente
liberista. La via del rinnovamento della società piemontese passava a suo giudizio attraverso la vittoria delle
tendenze mercantili e capitalistiche già operanti in essa e questa a sua volta aveva per presupposto una
radicale e tonificante liberalizzazione del mercato e l'inserimento pieno del Piemonte nel grande circuito
dell'economia europea. Profondamente convinto della giustezza e della fecondità di questa prospettiva di
sviluppo economico, il Cavour, già nei diciotto mesi durante i quali aveva occupato la carica di ministro dell'
Agricoltura, aveva stipulato una serie di trattati commerciali - con la Francia, con l'Inghilterra, con il Belgio,
con l'Austria tutti improntati a un pronunciato liberismo.
La visione che egli nutriva dello sviluppo capitalistico era essenzialmente fondata sulla prospettiva di una
sua germinazione dal basso, attraverso l'iniziativa coraggiosa dei singoli produttori e agricoltori, così come
era avvenuto nelle evolute società dell'Europa occidentale, in Inghilterra e in Francia. Ciò richiedeva
peraltro dei tempi assai lunghi e Cavour, che non era un dottrinario e che aveva ben appreso dai testi che
aveva letto la distinzione tra economia teorica e politica economica, non escludeva affatto che si potessero
trovare delle scorciatoie e degli espedienti che consentissero all'economia piemontese, o italiana, di
riguadagnare parte del tempo perduto. A questo fine, al fine cioè di sollecitare e agevolare il libero sviluppo
dell'economia borghese, doveva essere diretta l'azione dello Stato. Ed ecco il Cavour progettare e
promuovere nella sua azione di governo la costruzione in grande stile di opere pubbliche a carattere
26
infrastrutturale: il canale che da lui prese nome e che consenti l'irrigazione razionale delle campagne
novaresi e vercellesi, il traforo del Fréjus, le ferrovie. In questo quadro va anche vista la costituzione di un
grande istituto centrale e statale di credito, la Banca nazionale, embrione della futura Banca d'Italia.
I frutti di questa politica economica non tardarono ad apparire evidenti: al principio del 1859 il Piemonte
contava 850 chilometri di ferrovie, tra private e statali, contro i 986 esistenti in tutti gli altri Stati d'Italia, e il
suo commercio estero era notevolmente superiore a quello del vicino e florido Lombardo- Veneto. In
un'Italia in cui il ritmo dello sviluppo economico, dopo la curva ascendente del periodo 1830-46, segnava il
passo, il Piemonte era l'unico Stato che riuscisse a tener dietro in qualche modo alla vertiginosa crescita
dell'economia capitalistica europea.
Ma la libertà economica non era concepibile senza la libertà politica, la libertà del borghese senza quella del
cittadino. Cavour ne era pienamente consapevole e proseguì perciò con grande fermezza nell'opera di
laicizzazione dello Stato già intrapresa dal d'Azeglio. Nel 1855, pur di non rinunciare a una legge che
sopprimeva un cospicuo numero di conventi, egli non esitò a affrontare una difficile crisi di governo (la
cosiddetta «crisi Calabiana») e a tener testa al re, che si era impegnato con Pio IX ad adoperarsi perché la
legge in questione non passasse. Sotto il governo di Cavour il Piemonte fu il solo tra gli Stati italiani in cui
non solo la vita politica e parlamentare si svolgeva secondo le norme della monarchia costituzionale e dello
Statuto, ma anche quello in cui vigeva un regime di effettiva libertà di stampa, di associazione e di
insegnamento. Ciò finì per fare del regno subalpino un centro di attrazione per molti degli emigrati politici
italiani, che sempre più numerosi vennero a stabilirsi a Torino e vi ottennero dal governo importanti
incarichi nell'insegnamento e nell'amministrazione. Il loro numero raggiunse ben presto le varie decine di
migliaia, al punto che il problema della loro convivenza con la popolazione piemontese si pose seriamente.
Tra di essi vi erano uomini di grande prestigio e autorità, quali il romagnolo Luigi Carlo Farini, il lombardo
Cesare Correnti, il modenese Manfredo Fanti, che divenne generale dell'esercito piemontese, il siciliano
Francesco Ferrara, un economista di grande valore, cui si deve l'iniziativa della collana «Biblioteca
dell'economista», che fece conoscere in Italia i classici dell'economia politica moderna, il napoletano
Bertrando Spaventa, filosofo di scuola hegeliana e Francesco De Sanctis, pure napoletano, il più dotato
critico e storico letterario dell'Ottocento italiano. Di diversa provenienza regionale, gli emigrati politici in
Piemonte erano divisi anche per orientamenti politici: alcuni - come il Mamiani, il Bonghi, il Bianchi - erano
più o meno vicini al moderatismo piemontese e cavourriano, altri - come il folto gruppo dei residenti a
Genova, nel quale facevano spicco Rosolino Pilo, Agostino Bertani e lo stesso Pisacane - erano stati o erano
ancora mazziniani.
Dopo il fallimento dell'impresa di Sapri una sempre più larga convergenza sulle posizioni cavourriane venne
manifestandosi nelle file dell'emigrazione. Nacque cosi, per impulso del La Farina e di Daniele Manin, la
Società nazionale che si proponeva di raccogliere attorno a sè e sotto la bandiera dell'unitarismo
monarchico tutto il patriottismo italiano. Ad essa aderì anche Giuseppe Garibaldi. L'isolamento di Mazzini
era cosi completo. Autorizzata tacitamente in un primo tempo, incoraggiata poi pubblicamente e
ufficialmente, la Società nazionale fu uno strumento di prim'ordine della politica estera e nazionale
cavouriana.
27
UNA LETTERA DI CAVOUR A NIGRA SULLA NECESSITÀ DI SALVARE L'ITALIA DAI GARIBALDINI (22
SETTEMBRE 1860)
La lettera va riferita al momento dell'intervento nell'Italia centrale da parte dell' esercito regio, a seguito del
successo di Garibaidi in Sicilia e a Napoli. Un'insurrezione negli Stati pontifici dette al Cavour il pretesto per
intervenire. Il 18 settembre i Piemontesi, al comando dei generali Fanti e Cialdini, sbaragliarono le truppe
papaline presso Castelfidardo e assunsero il controllo delle terre della Chiesa, lasciando al papa solo il Lazio.
Un'azione biasimevole questa, agli occhi della diplomazia, come scrive il Cavour; ma si trattava di arrestare
il movimento rivoluzionario, di impedire la prosecuzione della marcia di Garibaidi verso il Nord d'Italia. La
lettera al Nigra è chiarissima in proposito. «Se Garibaidi persevera nella via funesta nella quale si è
imbarcato, entro quindici giorni noi andremo a ristabilire l'ordine a Napoli e a Palermo, anche se bisognasse
per questo gettare in mare i Garibaldini». L'imperatore dei Francesi non doveva avere timori in proposito.
Costantino Nigra è una figura di primo piano nella storia del nostro Risorgimento. Entrato nella carriera
diplomatica nel 1851, collaborò col d'Azeglio e poi col Cavour, specie come intermediario tra Torino e Parigi
per la preparazione della guerra del '59. Alla data della lettera egli è rappresentante del governo
piemontese presso Napoleone III.
1860, 22 settembre
Mio caro Nigra, Non cercate di giustificare con argomenti sottili la nostra condotta [l'invasione degli Stati
della Chiesa]. Confessate che agli occhi della diplomazia essa è biasimevole. Ciò che ci assolve è la necessità
nella quale eravamo d'agire per salvare la causa dell'Italia dagli eccessi della rivoluzione. Non essendo stato
arrestato Garibaldi a Napoli, bisognava ad ogni costo arrestarlo negli Stati della Chiesa. Se non l'avessimo
fatto egli ci avrebbe trascinati a una sicura rovina, quand'anche avesse rinunciato a marciare su Roma. Non
arrestandolo, egli avrebbe marciato fino alle nostre frontiere, e avrebbe sconvolto il paese.
Garibaldi è un ispirato, inebriato da successi insperati. Egli crede di aver ricevuto una missione
provvidenziale e di essere autorizzato a compierla con tutti i mezzi. Ora egli s'immagina che è con gli uomini
della rivoluzione che egli deve marciare. Ne consegue che egli semina sulla sua strada il disordine e
l'anarchia. Se noi non portiamo rimedio a questo stato di cose, l'Italia perirà senza che l'Austria se ne
immischi. Noi siamo decisi a non permetterlo. Dichiaratelo chiaramente all'Imperatore; se Garibaldi
persevera nella via funesta nella quale si è imbarcato, entro quindici giorni noi andremo a ristabilire l'ordine
a Napoli e a Palermo, anche se bisognasse per questo gettare tutti i Garibaldini in mare.
L'immensa maggioranza della nazione è con noi. Gli esiti delle votazioni in Parlamento lo proveranno.
Gianduia [il popolo di Torino] è furioso contro Garibaldi. La Guardia Nazionale di Torino marcerebbe contro
di lui se ci fosse bisogno. I soldati di Fanti e di Cialdini non domandano di meglio che di sbarazzare il paese
dalle camicie rosse.
Dite all'Imperatore di non avere nessuna inquietudine a questo riguardo. Noi abbiamo atteso, siamo stati
concilianti, deboli anche in apparenza, per avere il diritto di battere forte quando fosse venuto il momento.
Bisognava attendere che questi Signori gettassero la maschera monarchica che essi portavano. Ora la
maschera è stata gettata e noi andiamo avanti. Il Re è deciso a finirla. D'altronde io non ammetterei
esitazioni [...].
28
IL RISORGIMENTO COME MANCATA RIFORMA AGRARIA. PERCHÉ IL PARTITO D'AZIONE NON POSE LA
QUESTIONE AGRARIA
da A. GRAMSCI, Il Risorgimento
Perché il Partito d'Azione, che pure era costituito da democratici e rappresentava in qualche modo, la
tradizione giacobina, non pose la questione agraria? A detta del Gramsci si trattò di una scelta di classe. Si
ritennero «nazionali» l'aristocrazia e i proprietari, non i milioni di contadini. Eppure «la quistione agraria era
la molla per far entrare in moto le grandi masse» e risolvere per tale via la questione romana battendo
l'atteggiamento antiunitario del papa. Si rivelarono in fondo molto più arditi i moderati, subentrati nel
governo del Mezzogiorno al Partito d'Azione, che crearono coi beni ecclesiastici confiscati un nuovo ceto di
grandi e medi proprietari legandoli alla nuova situazione politica. Nocquero al Partito d'Azione anche le
velleità di una riforma religiosa avanzata dal Mazzini, una riforma che le masse contadine non capivano e
che le tenne lontane dai «nuovi eretici».
Sul Partito d'Azione e sulla sua base sociale è opportuno richiamare l'illuminante giudizio dello stesso
Gramsci: «I moderati rappresentavano un gruppo sociale relativamente omogeneo, per cui la loro direzione
subì oscillazioni relativamente limitate (e in ogni caso secondo una linea di sviluppo organicamente
progressivo), mentre il cosi detto Partito d'Azione non si appoggiava specificamente a nessuna classe storica
e le oscillazioni subite dai suoi organi dirigenti in ultima analisi si componevano secondo gli interessi dei
moderati; cioè storicamente il Partito d'Azione fu guidato dai moderati: l'affermazione attribuita a Vittorio
Emanuele II di avere in tasca il Partito d'Azione o qualcosa di simile è praticamente esatta e non solo per i
contatti personali del Re con Garibaldi, ma perché di fatto il Partito d'Azione fu diretto indirettamente dal
Cavour e dal Re».
Perché il Partito d'Azione non pose in tutta la sua estensione la quistione agraria?
Che non la ponessero i moderati era ovvio: l'impostazione data dai moderati al problema nazionale
domandava un blocco di tutte le forze di destra, comprese le classi dei grandi proprietari terrieri, intorno al
Piemonte, come Stato e come esercito. La minaccia fatta dall'Austria di risolvere la quistione agraria a
favore dei contadini, minaccia che ebbe effettuazione in Galizia contro i nobili polacchi a favore dei
contadini ruteni, non solo gettò lo scompiglio tra gli interessati in Italia, […] ma paralizzò lo stesso Partito
d'Azione, che in questo terreno pensava come i moderati e riteneva «nazionali» l'aristocrazia e i proprietari
e non i milioni di contadini. Solo dopo il febbraio '53 Mazzini ebbe qualche accenno sostanzialmente
democratico (vedi Epistolario di quel periodo), ma non fu capace di una radicalizzazione decisiva del suo
programma astratto. E’ da studiare la condotta politica dei garibaldini in Sicilia nel 1860, condotta politica
che era dettata da Crispi: i movimenti di insurrezione dei contadini contro i baroni furono spietatamente
schiacciati e fu creata la Guardia Nazionale anticontadina; è tipica la spedizione repressiva di Nino Bixio
nella regione catanese, dove le insurrezioni furono più violente. Eppure, anche nelle Noterelle di G.C. Abba
ci sono elementi per dimostrare che la questione agraria era la molla per far entrare in moto le grandi
masse: basta ricordare i discorsi dell' Abba col frate che va incontro ai garibaldini subito dopo lo sbarco di
Marsala.
In alcune novelle di G. Verga ci sono elementi pittoreschi di queste sommosse contadine, che la Guardia
Nazionale soffocò col terrore e con la fucilazione in massa. Questo aspetto della spedizione dei Mille non è
stato mai studiato e analizzato.
La non-impostazione della quistione agraria portava alla quasi impossibilità di risolvere la quistio ne del
clericalismo e dell'atteggiamento antiunitario del Papa. Sotto questo riguardo i moderati furono molto più
arditi del Partito d'Azione: è vero che essi non distribuirono i beni ecclesiastici fra i contadini, ma se ne
servirono per creare un nuovo ceto di grandi e di medi proprietari legati alla nuova situazione politica, e
non esitarono a manomettere la proprietà terriera, sia pure solo quella delle Congregazioni. Il Partito
d'Azione, inoltre, era paralizzato, nella sua azione verso i contadini, dalle velleità mazziniane di una riforma
religiosa, che non solo non interessava le grandi masse rurali, ma al contrario le rendeva passibili di una
sobillazione contro i nuovi eretici. L'esempio della Rivoluzione francese era li a dimostrare che i giacobini,
che erano riusciti a schiacciare tutti i partiti di destra fino ai girondini sul terreno della quistione agraria e
non solo a impedire la coalizione rurale contro Parigi ma a moltiplicare i loro aderenti nelle province,
29
furono danneggiati dai tentativi di Robespierre di instaurare una riforma religiosa, che pure aveva, nel
processo storico reale, un significato e una concretezza immediata.
30
CONTRO LA TESI GRAMSCIANA DEL RISORGIMENTO COME MANCATA RIVOLUZIONE AGRARIA
da R. ROMEO, Risorgimento e capitalismo, 1970
Presupposto della tesi gramsciana e di tutta la storiografia marxista sull' argomento (la tesi è stata ripresa a
approfondita da Emilio Sereni ne Il capitalismo nelle campagne italiane (1860- 1900) uscito nel 1947, che
allarga il discorso a tutta la storia d'Italia inquadrando il problema della mancata rivoluzione agraria nel
rapporto tradizionale città-campagna lasciato irrisolto dal Medioevo) è «l'esistenza di una struttura
contadina mobilitabile ai fini della rivoluzione nazionale e democratica, l'esistenza cioè di una oggettiva
possibilità rivoluzionaria, che il Partito d'Azione, a differenza dei giacobini francesi, non seppe tradurre in
atto». Ma esisteva veramente questa alternativa al Risorgimento quale si è concretamente realizzato? e
questa presunta alternativa rappresentava veramente un progresso rispetto alla soluzione storicamente
raggiunta? Per lo storico R. Romeo questa alternativa rimane fuori della realtà storica e politica, «per le
condizioni storiche di fondo in cui era destinato a svolgersi il Risorgimento». A suo dire, una rivoluzione
agraria e giacobina non era allora concepibile data la situazione internazionale. Essa avrebbe provocato
«uno schieramento antitaliano in tutte le maggiori potenze europee interessate alla conservazione sociale».
Né si può asserire, afferma lo storico, che l'alternativa della rivoluzione agraria avrebbe rappresentato un
progresso rispetto alla struttura sociale ed economica quale si realizzò in effetti attraverso il Risorgimento.
Una rivoluzione contadina, che dal Sud si sarebbe necessariamente estesa al Nord, «avrebbe
inevitabilmente colpito anche le forme di più avanzata economia agraria, liquidando gli elementi
capitalistici dell' agricoltura italiana per sostituirvi un regime di piccola proprietà indipendente». «Una volta
liquidato dalla rivoluzione contadina il più progredito capitalismo agrario, e nella generale debolezza di
quello industriale e mobiliare, il paese avrebbe subito un colpo d'arresto nella sua evoluzione a paese
moderno». E dunque indubbio, per il Romeo, che l'Italia avrebbe pagato un prezzo storicamente troppo alto
in conseguenza della rivoluzione agraria «in termini di ritardo dello sviluppo capitalistico, e cioè di sviluppo
in senso moderno e occidentale di tutto il paese». Il modo con quale gli uomini del Risorgimento risolsero il
compito che loro si poneva sul piano economico e sociale fu perciò il più coerente alle condizioni dell' Italia
del tempo: potenziare l'economia capitalistica del Nord e unificare il mercato erano le «premesse
storicamente indispensabili per l'ulteriore riscatto e per le trasformazioni delle campagne meridionali».
Si può obbiettare che non è lecito giustificare ciò che è accaduto per il fatto che è accaduto. «Tutto si
sarebbe svolto», scrive il Catalano, «nell'unico modo possibile e nel migliore dei modi, il che finisce coll'
"approdare ad un fatalismo storico che è quanto di più deprimente possa esservi per l'uomo, perché la
storia, come sua creazione, è sempre il regno della libertà, delle libere e autonome scelte politiche [...]. La
nostra classe moderata scelse volontariamente una determinata linea, preferendo riversare sui ceti popolari
il maggiore peso della ricostruzione e del risanamento del bilancio, mentre altre correnti politiche ed altri
ambienti economici suggerivano una diversa condotta».
Gramsci scorge nella supremazia dei moderati il risultato della incapacità del Partito d'Azione a svolgere la
propria politica in modo coerentemente giacobino, includendovi anche le finalità e i problemi sociali dei
contadini; e inquadra questa concezione in una visione della storia d'Italia dominata dalla incapacità delle
città italiane del Medioevo a superare il conflitto con le campagne delineato si dopo la prima fase
dell'alleanza antifeudale. Questa frattura rimane dunque alla radice di tutta la storia del paese, e ad essa si
riporta la secolare oppressione delle campagne, il declino della capacità creativa delle città, il fallimento di
ogni politica unitaria col connesso cosmopolitismo della cultura e della civiltà italiana25. Da ciò l'istanza
politica profonda dell'alleanza degli operai e dei contadini come sbocco storico di questa esigenza quasi
millenaria della storia del paese, come sforzo risolutivo dei suoi contrasti e dei suoi problemi fondamentali
[...].
Ma il presupposto di tutta la tesi è l'esistenza di una struttura contadina mobilitabile ai fini della rivoluzione
nazionale e democratica, l'esistenza cioè di una «oggettiva»-possibilità rivoluzionaria, che il Partitò
d'Azione, a differenza dei giacobini francesi, non seppe tradurre in atto, ma che non per questo era meno
reale e meno concreta […] Al di là di ogni discussione metodologica generale vanno poste, a proposito della
25
Gramsci spiega il cosmopolitismo della cultura italiana (certamente più europea che nazionale) col distacco, in tutta la
storia del paese, tra gli intellettuali ed il popolo. L'Umanesimo è tipicamente europeo, cosi il Barocco e l'Arcadia.
31
tesi del Gramsci, due questioni fondamentali, relative da una parte alla reale possibilità di una rivoluzione
agraria, all'effettiva esistenza cioè di una alternativa al Risorgimento quale si è concretamente realizzato; e
dall'altra al carattere più o meno progressivo rispetto alla soluzione storicamente raggiunta, di questa
presunta alternativa. Che è questione non meno importante della prima: perché appunto sul non aver
saputo spingere fino in fondo tutte le possibilità di progresso «oggettivamente» contenute nella situazione
italiana si accentra la critica del Gramsci alla classe dirigente risorgimentale; e soprattutto perché da una
giusta valutazione del significato della mancata rivoluzione agraria dipende un'esatta impostazione dei reali
problemi dello sviluppo capitalistico e moderno in Italia del sec. XIX.
Ora, nonostante gli elenchi sempre più folti di insurrezioni e moti contadini che la storiografia - e non solo
quella marxista, d'altronde - ci viene apprestando; nonostante la indubbia esistenza di condizioni di grande
miseria o di disagio in gran parte delle campagne italiane e la persistenza di larghi residui feudali, specie nel
Mezzogiorno; nonostante il fatto massiccio della presenza di una popolazione contadina di oltre quindici
milioni nel 1860, di cui la maggior parte contadini poveri o braccianti o «salariati», e i propositi talora
affaciatisi di mobilitare questa massa contro i vecchi regimi assolutistici; sembra innegabile che la presunta
alternativa rimane fuori della realtà storica e politica. E ciò, non tanto per il tenace sanfedismo delle
campagne, magari superabile con la impostazione del problema della terra; quanto per le condizioni
storiche di fondo in cui era destinato a svolgersi il Risorgimento. Sembra certo anzitutto che una rivoluzione
agraria e giacobina in Italia avrebbe provocato uno schieramento antitaliano di tutte le maggiori potenze
europee, interessate alla conservazione sociale, e legate a una visione della civiltà e dei rapporti
internazionali profondamente ostile a quel genere di sovvertimenti [...].
Un discorso più complesso richiede il preteso carattere progressivo dell'alternativa della rivoluzione agraria,
l'affermazione cioè che la struttura sociale ed economica realizzatasi in Italia attraverso il Risorgimento
rappresenti una fase storicamente più arretrata di quella raggiungibile attraverso la rivoluzione agraria. E
proprio questo concetto che anima gran parte della polemica marxista contro il Risorgimento;
ed è appunto in esso che più chiaramente si rivela la genesi «dottrinaria», oltre che pratico-politica, della
tesi del Gramsci. Già si è accennato ch'essa ha il suo nucleo originario nella visione marxista dello sviluppo
capitalistico, che il Gramsci applica all'Italia soprattutto rifacendosi al modello della rivoluzione borghese di
Francia […] Sennonché, il problema dello sviluppo capitalistico in Italia non può essere identificato [...] con
quello dello sviluppo capitalistico in Francia, che si distingue dall'analogo processo italiano per uno
svolgimento delle città e del capitalismo urbano incomparabilmente più rapido e più vigoroso [...].
Ben diversa la situazione italiana fin oltre la metà del sec. XIX. Qui l'industria aveva ancora un peso quasi
trascurabile nel quadro dell'attività economica del paese, e anche il commercio, nonostante avesse certo
un rilievo assai maggiore, era tuttavia subordinato all'agricoltura, esaurendo quasi interamente il suo
compito nel mettere in movimento i prodotti delle colture locali. Persino nella regione più avanzata, la
Lombardia, lo Jacini calcolava che nell'agricoltura si investisse una somma sei volte maggiore di quella
investita nel commercio e nell'industria messi insieme; e la stessa Milano era ancora una città nello stadio
commerciale del suo sviluppo. Indubbiamente esistevano anche nelle città italiane, specie del Nord, ma non
solo del Nord, grosse fortune mobiliari, nelle mani di banchieri e di mercanti imprenditori, che
controllavano un parte più o meno larga, nelle varie zone, dell'attività industriale esercitata a domicilio: ma
il peso di quelle fortune nel complesso dell'economia nazionale era in Italia assai meno rilevante che non in
Francia [...]. .
E infatti su tale sfondo di debole sviluppo del capitalismo cittadino e di incipiente capitalismo agrario che va
studiato i1 significato della mancata rivoluzione contadina auspicata da parte marxista. In un paese come
l'Italia del sec. XIX, dove già la borghesia aveva posto le mani su buona parte della proprietà ecclesiastica
nell'età napoleonica [...] e dove l'introduzione del codice Napoleone aveva già cancellato ogni differenza
giuridica tra proprietà feudale e proprietà borghese; una rivoluzione contadina mirante alla conquista della
terra avrebbe inevitabilmente colpito - dovunque avesse potuto consolidarsi e dunque, si può presumere,
specialmente nel Nord e nel Centro della penisola - anche le forme di più avanzata economia agraria,
liquidando gli elementi capitalistici dell'agricoltura italiana per sostituirvi un regime di piccola proprietà
indipendente, e imprimendo all'Italia agricola una fisionomia, appunto, di democrazia rurale.
Una volta liquidato dalla rivoluzione contadina il più progredito capitalismo agrario, e nella generale
debolezza di quello industriale e mobiliare, il paese avrebbe subito un colpo d'arresto nella sua evoluzione
a paese moderno, e non solo sul piano della vita economica, ma in genere dei rapporti civili e sociali [...].
32
Nelle condizioni storiche dell'Italia di allora la rivoluzione agraria avrebbe rappresentato uno sforzo in senso
contrario alla tendenza che da oltre un secolo si era determinata (in maggiore o minore misura) in buona
parte delle campagne del Nord e del Centro della penisola, verso l'accumulazione capitalistica a spese dei
contadini, avrebbe cioè rappresentato uno sforzo diretto non già a potenziare e ad accelerare lo sviluppo
storico reale, ma a deviarlo violentemente verso una direzione diversa e contraria. Insomma, la conquista
del potere da parte della borghesia nel Risorgimento coincide in larga misura, a causa del ritardato sviluppo
storico italiano, con il processo della accumulazione primitiva a spese delle campagne, cioè con una fase di
accentuato antagonismo fra città e campagna, fra borghesia e contadini. Questa fase era già stata
largamente oltrepassata dalla Francia nell'età della Rivoluzione, e proprio per questo la borghesia aveva
potuto impegnarsi a fianco dei contadini contro la proprietà feudale. In Italia invece la proprietà feudale
sopravviverà parzialmente al Risorgimento e i rapporti fra il nuovo mondo borghese e questo vecchio
mondo feudale non potranno più porsi, dopo il 1860, sul piano dell'alleanza rivoluzionaria fra borghesia e
contadini. E sarà, questo ritardato sviluppo antifeudale, una grave passività nella storia d'Italia; ma altra era
stata la storia di Francia e d'Inghilterra nell'età moderna, altra quella d'Italia [...].
Il compito che si poneva agli uomini del Risorgimento sul piano economico-sociale, e che essi risolsero nel
modo più coerente alle condizioni dell'Italia del tempo, era dunque di procedere a un potenziamento
forzato dell'economia capitalistica cittadina del Nord e all'unificazione del mercato, quali premesse
storicamente indispensabili per l'ulteriore riscatto e per la trasformazione delle campagne meridionali [...].
Certo, tutto il processo si svolge a lungo su una base di compromesso con gli elementi semifeudali del
vecchio mondo agrario, specie meridionale; e volle dire, tutto questo, potenziamento della città a spese
della campagna, incremento del Nord a spese del Sud. L'inferiorità economica del Mezzogiorno si presentò
infatti per un certo periodo, e sotto certi aspetti si presenta tuttora, come una condizione storica dello
sviluppo industriale del Nord; ma si tratta di una condizione «temporanea» (anche se si è protratta per
molti decenni), e destinata ad essere rovesciata dallo stesso sviluppo interno dell'industrialismo
settentrionale. Anzitutto, non va dimenticato che l'unità contribuì assai presto ad imprimere un ritmo più
accelerato anche a taluni settori dell'economia meridionale: si pensi ad esempio ai progressi delle
esportazioni agricole del Sud dopo il 1860, o all'incremento di città come Bari o Catania. Ma specialmente
occorre sottolineare che lo stesso sviluppo economico e industriale delle regioni settentrionali ha posto le
basi della politica meridionalista, iniziatasi timidamente con le leggi speciali dei primi del secolo, e che ha
assunto dimensioni assai rilevanti nel secondo dopoguerra. Basi economiche, in quanto strettamente
collegate con la potenzialità produttiva e le esigenze di espansione dell'industria settentrionale; e basi
politiche, in quanto dipendenti dalla possibilità di impostare e realizzare una politica nazionale verso il
Mezzogiorno che solo la salda unificazione politico-morale del paese ha reso possibile. Un processo, certo,
assai contorto e faticoso: e tuttavia, era questa la via più rapida e più breve che la storia consentiva perché
l’Italia conquistasse la struttura e i caratteri propri di un paese moderno.
33