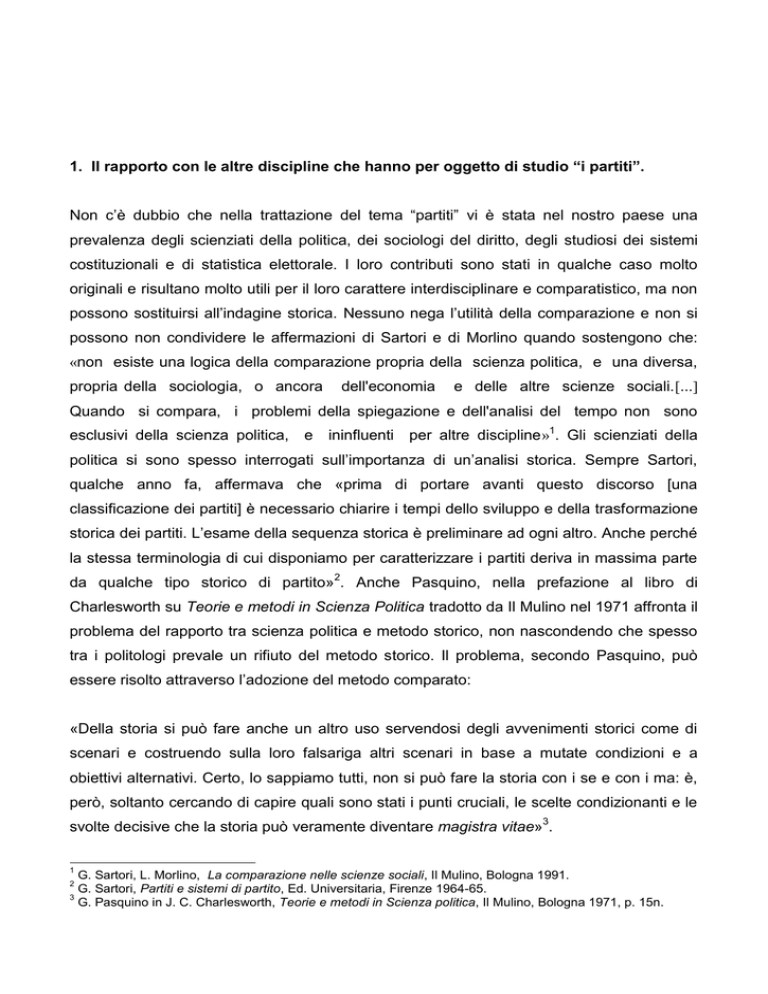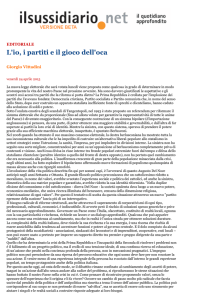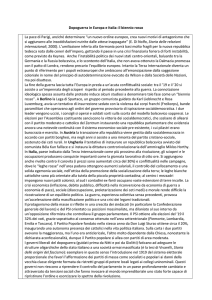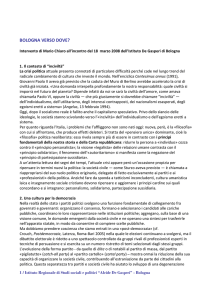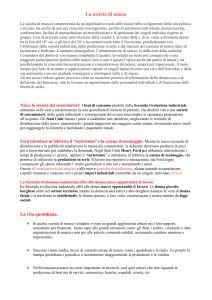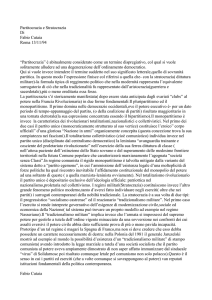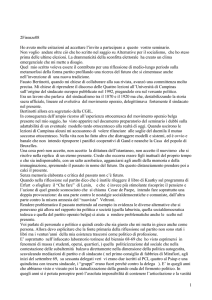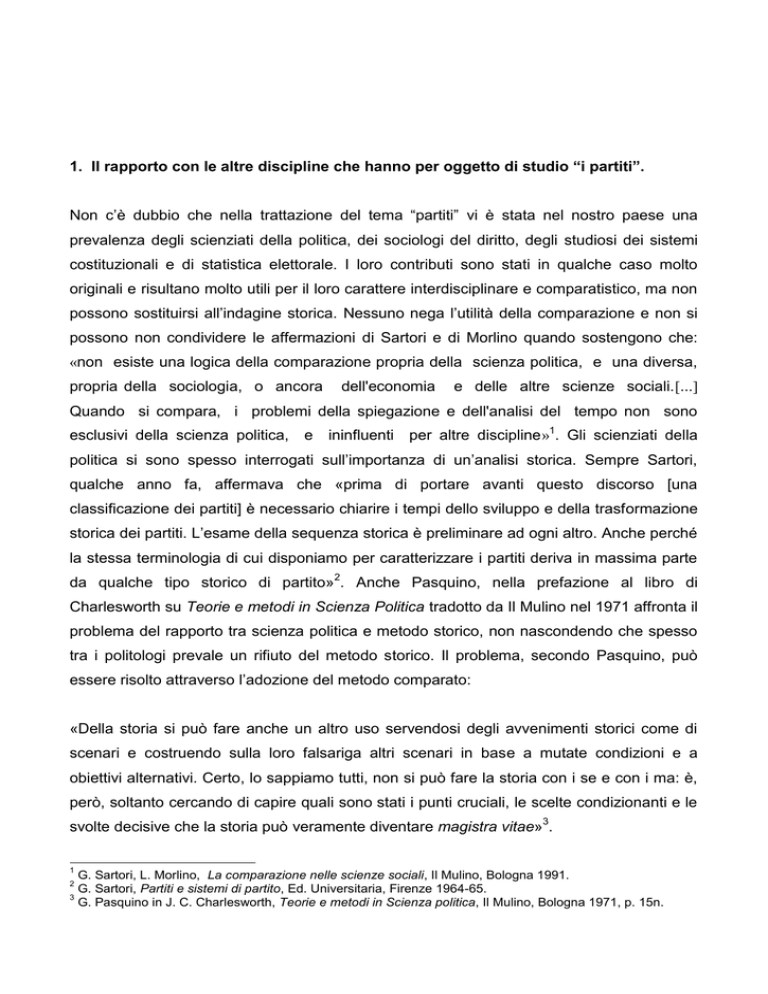
1. Il rapporto con le altre discipline che hanno per oggetto di studio “i partiti”.
Non c’è dubbio che nella trattazione del tema “partiti” vi è stata nel nostro paese una
prevalenza degli scienziati della politica, dei sociologi del diritto, degli studiosi dei sistemi
costituzionali e di statistica elettorale. I loro contributi sono stati in qualche caso molto
originali e risultano molto utili per il loro carattere interdisciplinare e comparatistico, ma non
possono sostituirsi all’indagine storica. Nessuno nega l’utilità della comparazione e non si
possono non condividere le affermazioni di Sartori e di Morlino quando sostengono che:
«non esiste una logica della comparazione propria della scienza politica, e una diversa,
propria della sociologia, o ancora
dell'economia
e delle altre scienze sociali.[...]
Quando si compara, i problemi della spiegazione e dell'analisi del tempo non sono
esclusivi della scienza politica,
e
ininfluenti per altre discipline»1. Gli scienziati della
politica si sono spesso interrogati sull’importanza di un’analisi storica. Sempre Sartori,
qualche anno fa, affermava che «prima di portare avanti questo discorso [una
classificazione dei partiti] è necessario chiarire i tempi dello sviluppo e della trasformazione
storica dei partiti. L’esame della sequenza storica è preliminare ad ogni altro. Anche perché
la stessa terminologia di cui disponiamo per caratterizzare i partiti deriva in massima parte
da qualche tipo storico di partito»2. Anche Pasquino, nella prefazione al libro di
Charlesworth su Teorie e metodi in Scienza Politica tradotto da Il Mulino nel 1971 affronta il
problema del rapporto tra scienza politica e metodo storico, non nascondendo che spesso
tra i politologi prevale un rifiuto del metodo storico. Il problema, secondo Pasquino, può
essere risolto attraverso l’adozione del metodo comparato:
«Della storia si può fare anche un altro uso servendosi degli avvenimenti storici come di
scenari e costruendo sulla loro falsariga altri scenari in base a mutate condizioni e a
obiettivi alternativi. Certo, lo sappiamo tutti, non si può fare la storia con i se e con i ma: è,
però, soltanto cercando di capire quali sono stati i punti cruciali, le scelte condizionanti e le
svolte decisive che la storia può veramente diventare magistra vitae»3.
1
G. Sartori, L. Morlino, La comparazione nelle scienze sociali, Il Mulino, Bologna 1991.
G. Sartori, Partiti e sistemi di partito, Ed. Universitaria, Firenze 1964-65.
3
G. Pasquino in J. C. Charlesworth, Teorie e metodi in Scienza politica, Il Mulino, Bologna 1971, p. 15n.
2
Giuliano Urbani, per esempio, ha ritenuto che il metodo storico sia inutilizzabile per la
Scienza politica, per la natura stessa dell’indagine storiografica che è «individualizzante».
L’inutilizzabilità deriverebbe secondo Urbani dal fatto che «la spiegazione storica è diversa
da quella della Scienza politica solo a causa del carattere individuante dei propri strumenti
d’indagine»4.
Sartori ritorna sull’argomento qualche anno dopo, spiegando che:
«Dopotutto la storia è un immenso deposito di esperienze, esperienze (non esperimenti)
dalle quali ricaviamo, o possiamo ricavare, conferme o smentite. In linea di principio,
dunque, negare la storia è assurdo, è autolesionismo. Il problema non è se la storia sia una
preziosa fonte di dati alla quale attingere: lo è. Le perplessità sorgono sul come, e cioè su
come utilizzare il materiale storico ai nostri fini, che sono – ricordiamolo – fini di controllo»5
Ma Sartori arriva alla conclusione che il controllo storico è, per la Scienza politica, più
debole di quello comparato soprattutto per la reperibilità dei dati perché «ogni epoca
registra se stessa per come si vede, con le sensibilità e gli interessi conoscitivi che ha. A
questo effetto, dunque, il controllo storico si imbatte in un ostacolo che risulta insuperabile,
e che certo ne limita grandemente l’applicabilità»6.
Tra gli interventi più recenti riguardanti i possibili reciproci contributi tra le due discipline si
sottolinea in particolare quello di A. Panebianco, Per una storia del partito politico: il
contributo della politologia, in cui viene messa in luce la sovrapposizione di confini tra
Scienza politica e storiografia. Secondo Panebianco, «la scienza politica e la sociologia
hanno messo capo a un corpo piuttosto ragguardevole di modelli, teorie, o anche soltanto
semplici generalizzazioni empiriche a carattere induttivo […], di cui gli storici più accorti
fanno uso nel loro lavoro» (pag. 776). Ma anche la storiografia è utile alla scienza politica:
«Osservato dal punto di vista della scienza politica il rapporto con la storiografia si presta a
due considerazioni: la prima, più ovvia, riguarda, da un lato l’elaborazione di
generalizzazioni e, dall’altro, il controllo empirico delle teorie. Per entrambi i compiti il lavoro
storiografico, e quindi le conoscenze storiche accumulate, sono l’inevitabile punto di
3
4
6
G. Urbani in AA. VV. , Antologia di Scienza politica, a cura di G. Sartori, Il Mulino, Bologna 1970, p. 42.
G. Sartori, La politica, Sugarco, Milano, 1979, p. 248.
Ibidem, p. 250
riferimento del politologo; la seconda, forse meno ovvia […] riguarda il carattere
storicamente condizionato dei modelli e delle teorie che la scienza politica di volta in volta
elabora»7.
Molto significativa a tal proposito è la citazione di Weber da parte di Panebianco:
«Restando al problema del contributo che la scienza politica può offrire alla storiografia,
credo che si debba partire dalla celebre tesi di Weber secondo il quale le scienze sociali
dette sistematiche (sociologia, scienza politica, ecc.) hanno come loro compito specifico
quello di soddisfare una particolare esigenza: svolgere quel modesto lavoro preparatorio
(che in realtà, richiede un addestramento specifico) di fornire a chiunque voglia farne uso, e
in primo luogo agli storici, non teorie generali (che per lo più non esistono) ma
generalizzazioni empiriche e modelli – tipi ideali nell’accezione weberiana – che
rappresentano indispensabili artifici metodologici mediante i quali soltanto è possibile la
ricerca storico-empirica»8.
E partendo dalla considerazione che la Scienza politica può indubbiamente risultare utile
alla storiografia politica, anche Pombeni ricorre a Weber nella elaborazione di una
categoria idealtipica (la forma-partito, di cui parleremo), nella convinzione cioè che sia
impossibile operare nella storia politica senza la costruzione di «elementi di misura» 9. Dello
stesso parere è anche G. Are, secondo il quale la Scienza politica è utilissima alle indagini
storiografiche riguardanti gli argomenti politici, quindi anche la storia dei partiti, scrive infatti:
«Per quanto mi riguarda non credo che si possa più fare la storia politica del presente
senza ricorrere ampiamente a categorie o inventate o ampiamente collaudate in sede di
scienza politica. Tali ad esempio: gli andamenti e i comportamenti elettorali; gli indici di
insediamento dei partiti e dei sindacati; la qualificazione sociologica dei militanti e dei
votanti per i diversi partiti; gli indicatori di polarizzazione; l’analisi delle strutture di comando,
e dei modi di formazione e di selezione del personale dirigente; l’analisi degli inputs e degli
outputs dei processi decisionali; quella del rapporto fra personale politico e gruppi
d’interesse; e via esemplificando. […] Riconosco, dunque, alla Scienza politica un’utilità
7
in G. QUAGLIARELLO, Il partito politico nella belle époque, Giuffrè, Milano 1990, p. 776.
Ibidem, pp. 777-778
9
Cfr. P. Pombeni, La storia come scienza della politica. A proposito della forma partito, in G. Quagliarello, cit.
, pp. 61-84 e Introduzione alla storia dei partiti politici, Il Mulino, Bologna 1990.
8
incostituibile per una storiografia del presente d’impostazione moderna»10.
Tuttavia l’autore critica la Scienza politica di questi anni soprattutto per la sua difficoltà
nell’applicazione di classificazioni troppo rigide e di tipi ideali. La Scienza politica, cioè, di
fronte a tutto ciò che ha l’impronta del «nuovo, della svolta, della scelta drammatica, del
mutamento qualitativo», ossia davanti a tutto ciò che «costituisce l’essenza stessa del
divenire storico», perderebbe addirittura ogni carattere di scienza, cioè ogni capacità
previsionale, e sarebbe persino «sprovvista di qualunque strumento che la caratterizzi e le
dia attitudini conoscitive in qualche modo più penetranti di quelle che ha un comune dotato
osservatore politico bene attrezzato di cultura storica, e fornito di esperienza del mondo in
generale e dei fenomeni osservati in
particolare»11. La conclusione di Are è molto
significativa e meriterebbe forse maggiore attenzione:
«Insomma se lo storico ha tutto da guadagnare dall’assimilare nella sua opera risultanze e
materiali della ricerca politologica, lo scienziato politico ha ancora più da guadagnare dal
percepire con modestia i limiti dei propri strumenti; e soprattutto dal comprendere che
nessuno di questi lo dispensa dal formulare in ultima istanza le proprie conoscenze nei
modi del discorso storico e dal punto di vista dello svolgimento storico. Se dovessi tradurre
ciò in termini prescrittivo-istituzionali direi che la formazione dello scienziato politico
dovrebbe avere una base più storicistica che comportamentistica. E dovrebbe esser
depurata dall’illusione di poter mai usare strumenti capaci di definire relazioni univoche fra il
presente e il futuro; e ancor meno di predeterminare questo»12.
In soccorso al valore del metodo storico e alla positività di una interdisciplinarità rimane la
posizione di Giorgio Sola, la cui produzione scientifica, peraltro, attesta una particolare
vicinanza alla metodologia della storia del pensiero politico. L’occasione gli è data dalla
curatela di una serie di scritti sul problema del partito in Gramsci, che secondo Sola aveva
tentato di «rivitalizzare una scienza politica storicizzata che identifica la politica con la
storia», nel tentativo cioè di «conciliare materialismo storico e scienza politica». Gramsci
costituirebbe quindi un modello in cui l’analisi dei partiti si dispiega attraverso due percorsi
complementari:
10
G. Are, Scienza politica e storiografia: commento, in “Rivista italiana di Scienza politica”, 1, IL Mulino,
Bologna 1991, pp. 138-139.
11
Ibidem, p. 140.
12
Ibidem, p. 142.
«Un percorso configura la necessità di ricostruire la storia dei partiti politici; un secondo
percorso delinea invece l’opportunità di edificare una teoria che, differenziandosi da una
dottrina meramente prescrittiva, si alimenti di concetti, tipologie e generalizzazioni
empiriche. […] La raccolta di materiale grezzo e di osservazioni empiriche viene
considerata di grande rilievo e meritevole di costituire la base di partenza per uno studio
scientifico dei partiti»13.
Gramsci avvalorerebbe quindi un approccio secondo il quale «solo un’analisi accurata dei
fatti storici può mettere in rilievo gli aspetti costanti e gli aspetti variabili dei fenomeni
politici, come pure può evidenziare l’apparire di fattori nuovi e mettere in luce la caducità,
l’estinzione o la sostituibilità di equilibri ritenuti, in una data epoca e in una data società,
inevitabili e immodificabili»14, ciò a cui in parte sembra alludere Are nella sua critica alla
Scienza politica attuale.
Rapporti tra indagine storica e Scienza politica sono stati messi recentemente in evidenza
ancora da G. Pasquino, quando sottolinea come la Scienza politica abbia privilegiato il
ruolo della storia come fonte di materiale sul quale fondare generalizzazioni e teorie15 e da
M. Cotta, il quale sostiene che «funzioni e modi di operare dei partiti hanno mostrato di
mutare
nel tempo. Molte
analisi storico-comparate
si sono
quindi concentrate
sull’evoluzione dei partiti individuando – pur all’interno di una notevole varietà a seconda
della ideologia, base sociale, condizioni istituzionali specifiche per specifici partiti – una
tendenziale successione dei vari tipi nel tempo”16.
Considerando queste premesse, che attestano una posizione che non è univoca nei
confronti della validità del metodo storico e della positività della interdisciplinarità, non si
può negare che gli studi di carattere politologico hanno qualche volta il difetto di non aver
utilizzato appieno la potenzialità del metodo storico.
Bisogna dire che il discrimine tra la storia dei partiti e la scienza della politica sta nel fatto
che quest’ultima cerca di comprendere (verstehen) i fenomeni politici (Weber) o individuare
13
G. Sola, Scienza politica e analisi del partito in Gramsci, in Gramsci: il partito politico nei Quaderni, a cura di
S. Mastellone e G. Sola, CET, Firenze, 2001, p. 36-37. Nel passo citato è stato omesso il riferimento di
Gramsci al metodo di Michels, nei confronti del quale il giudizio di Gramsci è ambivalente: da una parte «la
consueta critica all’impostazione sociologica», dall’altra «le numerose annotazioni che, tratte proprio da
questo lavoro, serviranno a Gramsci per affrontare lo studio dei partiti in chiave empirica e non ideologica».
La raccolta di materiale grezzo, infatti, si riferisce al metodo di Michels.
14
Ibidem, pp. 30-31.
15
In Corso di scienza politica, Il Mulino, Bologna 2000.
16
In Scienza politica, Il Mulino, Bologna 2001, p. 229
un “sistema di leggi” (Kaplan) e, più specificamente per quanto riguarda la formulazione
della teoria del partito, la scienza della politica tende a costruire un tipo ideale di partito o di
modelli di partito astratti, cercando di dimostrare deduttivamente l’aderenza di singole
fattispecie a tali modelli. Se si privilegia lo studio dei sistemi e si procede per grandi
classificazioni si rischia di confezionare - seppure come ipotesi di lavoro - delle formepartito idealizzate, aventi cioè dei caratteri tanto generali da divenire “ombre della realtà”. In
definitiva, bisogna che i modelli interpretativi seguano e non precedano la ricostruzione
storica dei fenomeni. Sarebbe poco coerente al carattere scientifico della teoria della
politica se i politologi volessero prevedere il futuro come se i partiti ed i movimenti fossero
degli organismi viventi, determinati cioè nella loro evoluzione da leggi biologiche. Per parte
sua, lo storico sa che la storia non è una scienza esatta, in quanto i fenomeni storici non
sono regolati da leggi di sviluppo. Egli, quindi, può solo segnalare analogie e rapporti di
casualità relativamente, però, ad avvenimenti che si sono prodotti nel passato. La
politologia dà, invece, preferibilmente risultati scientifici nell’osservazione dei fenomeni
attuali, anche se un’osservazione dei fenomeni sul lungo periodo e l’adozione di un
approccio storico non può che essere d’aiuto. Giova comunque concludere con una
citazione di Gaetano Mosca, dal quale si fa “iniziare” la Scienza politica, che dà luce al
valore del metodo storico e agli effetti positivi che l’interdisciplinarità può avere sui risultati
scientifici:
«Si rifletta che fra gli ostacoli al suo svolgimento che noi abbiamo enumerato, quello che è
senza dubbio il più importante, la scarsità e l’imperfezione dei materiali storici, senza
riparare al quale niente di serio si potrebbe intraprendere, oggi si può dire che più non
esista. Ora che non solo conosciamo la storia della Grecia, di Roma, quella del Medio Evo
e la moderna immensamente meglio di come la conoscevano i nostri avi di un secolo fa,
ma possiamo anche giovarci della storia degli Imperi dell’antico Oriente, di quella della
China, del Giappone e delle Indie, intorno alla quale non si avevano che idee
imperfettissime; oggi che siamo al caso di essere, come siamo, perfettamente informati
della struttura e dell’organizzazione sociale non solo dei popoli nostri vicini, ma anche di
quella dei più lontani e di civiltà e di cultura più differente dalla nostra; oggi infine quando le
materie sussidiarie alla storia nel raccogliere e valutare i fatti sociali, la statistica,
l’archeologia, la preistoria, l’etnografia, la filologia comparata, vengono a dirci tante cose
nuove sull’uomo e le società umane, non possiamo veramente ancora asserire che siano le
cognizioni ed i fatti che ci manchino per poter osservare e concludere: i fatti ci sono, le
cognizioni le abbiamo, è il caso di dire a noi stessi: chi ha occhi per vedere veda» 17
Riguardo ai confini tra la sociologia e la storia, ed in particolare quella dei partiti, non si può
non segnalare l’importanza di R. Michels e della sua “Sociologia del partito politico” (
ripubblicata da Il Mulino, Bologna, nel 1966). In apertura, Michels scriveva appunto che
«lo studio e l’analisi del partito politico costituiscono un nuovo ambito della ricerca
scientifica, una scienza di confine che sta tra le discipline economico-sociali, quelle
filosofico-psicologiche e quelle storiche e che in quanto tale sarebbe destituita di valore se
non potesse diventare oggetto di analisi approfondita. Ormai cresciuti e invecchiati i partiti
moderni, il settore più primitivo di questa scienza, quello storiografico, ha raggiunto un
significativo sviluppo quanto alla qualità e quantità della produzione. Quasi ogni partito
europeo possiede perciò una sua storia più o meno ben scritta. Non si è invece altrettanto
avanti nel secondo, più recente settore di ricerca, cioè nella indagine analitica sul partito
politico»18.
In
tempi più recenti, L. Cavalli, sociologo che da tempo studia il problema delle élite
politiche e da ultimo della leadership, ha messo in evidenza come tra le diverse discipline
che studiano la società non esistano dei confini netti:
«Non esistono confini invalicabili e domini esclusivi nel vasto campo delle scienze sociali
contemporanee. Il sociologo e lo storico, l’economista, l’antropologo e lo psicologo sociale,
possono affrontare gli stessi fenomeni e trattare la stessa materia: non di rado lo fanno.
Anche in sede teorica e metodologica la distinzione non è netta. Accade sempre più spesso
che sociologi, storici e altri studiosi della società abbiano una discreta conoscenza degli
strumenti concettuali e metodologici degli altri, e ne facciano almeno marginalmente uso.
La differenza rilevante è, alla fine, solo di prospettiva, di taglio, e anche soltanto di accenti.
Forse di dovrebbe dire che è, in ultima analisi, una differenza di mentalità; in quanto
ciascuno porta con sé l’habitus mentale che si è fatto frequentando certi autori, vivendo in
17
G. Mosca, Teorica dei governi e governo parlamentare, ora in Scritti Politici, a cura di G. Sola, vol. I. , Utet,
Torino 1982, pp. 201-202.
18
Nel testo citato, pp. 6-7.
un certo ambiente scientifico, riflettendo soprattutto su certi problemi e lavorando
abitualmente con certi strumenti»19.
Sul problema della conflittualità/complementarità tra sociologia e storia si sono interrogati
molti sociologi, in generale tutti concordi nell’affermare che, nonostante le differenze di
approccio, riconducibili in primo luogo ad una tendenza individualizzante della storia contro
quella più generalizzante della sociologia, ci può essere una positiva collaborazione tra le
due discipline soprattutto per quanto riguarda la scelta dei problemi e dei fenomeni sociali
da analizzare20
G. Sivini, nella “Sociologia dei partiti politici” (Il Mulino, Bologna 1979), presentando i saggi
di Ostrogorsky, Michels, Weber e Duverger, suggerisce proprio una lettura in chiave
storica, «per evitare di ricorrere abusivamente a quelle concettualizzazioni trattando della
situazione attuale dei partiti», una lettura storica che sarebbe indispensabile «per
comprendere […] la collocazione specifica dei partiti nei diversi stadi di sviluppo dello stato
borghese, in rapporto alle diverse forme di legittimizzazione che assume».
La sociologia politica si è costituita in modo specifico proprio nell’analisi delle formazioni
politico-sociali «sorte come aspetto politico della società industriale e come conseguenza,
prima dell’allargamento del suffragio, poi del suffragio universale. Essa, pertanto, si colloca,
storicamente e analiticamente, come presa di coscienza del passaggio della società
contemporanea da sistema politico fondato sulla partecipazione e il controllo di una élite a
sistema politico fondato sulla rilevanza crescente della maggioranza della popolazione, sia
in senso “democratico-parlamentare” (democrazia di massa), sia in senso dittatoriale»21. È
vero, comunque, che si può parlare di una “sociologia storica”, la quale, secondo la
definizione di Abrams, non si limita a riconoscere che un processo storico fa da sfondo al
presente, ma considera i fenomeni come «frutto di un continuo processo di costruzione nel
tempo, che diventa il fulcro dell’analisi sociale»: secondo Abrams, «le innumerevoli crisi di
governo in Italia non sono spiegate dall’incompetenza o dall’opportunismo degli uomini
19
L. Cavalli, Sociologia della storia italiana 1871-1974, Il Mulino, Bologna 1974, p. 9. L. Cavalli ha
recentemente pubblicato Il leader e il dittatore. Uomini e istituzioni di governo nel “realismo radicale”,
Ideazione, Roma 2003.
20
Per un orientamento bibliografico di base: F. Ferrarotti, La sociologia. Storia, concetti, metodi, ERI, Torino
1962; V. Titone, Storia e Sociologia, La nuova Italia, Firenze 1964; G. Gurvitch, Trattato di sociologia, Il
Saggiatore, Milano 1967; B. S. Phillips, Metodologia della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna 1972, in
particolare il paragrafo intitolato Lo storico e il sociologo; W. Rohrich, Sociologia politica, Il Mulino, Bologna
1980; P. Burke, Sociologia e storia, Il Mulino, Bologna 1982; N. Smelser, Manuale di sociologia, Il Mulino,
Bologna 1987; M. Rush, Politica e società, Il Mulino, Bologna 1998.
21
P. Farneti, Sociologia politica, in Dizionario di politica, diretto da N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino,
Torino, UTET, 1990
politici contemporanei, ma da problemi che dipendono dalle difficoltà che per cento anni
hanno incontrato tutti i tentativi di formare uno stato unitario da una società profondamente
divisa e frammentata. Quando respingiamo spiegazioni del presente che tengono conto
soltanto del presente, quando ci rivolgiamo alla storia per avere spiegazioni più
soddisfacenti, cerchiamo una comprensione più profonda e realistica dei fenomeni. E al
tempo stesso andiamo verso la sociologia»22. La sociologia dei partiti, a differenza della
scienza politica, che affronta lo studio del sistema politico nel suo insieme, dovrebbe
occuparsi principalmente del partito come soggetto largamente autonomo del sistema
politico e cioè studiare la tipologia dei partiti come struttura organizzativa dal punto di vista
genetico e funzionale e ha, quindi, molti punti di contatto con la storia dei partiti23.
Lo studio dei partiti può essere poi affrontato nel quadro della filosofia della politica, intesa
come analisi delle forme di governo, del fondamento dello stato, della natura della politica
ed infine del linguaggio e della metodologia24.
Sulla reciproca utilità di filosofia politica e storia scrive Bobbio:
«La teoria politica senza storia è vuota, la storia senza teoria è cieca. Sono fuori strada
tanto i teorici senza storia, quanto gli storici senza teoria, mentre i teorici che ascoltano la
lezione della storia e gli storici che sono ben consapevoli dei problemi di teoria che la loro
ricerca presuppone, traggano vantaggio dall’aiutarsi reciprocamente»25.
È indubbio poi che importa conoscere quella che è stata l’evoluzione del concetto di partito,
la valutazione politica ed etica di quest’ultimo in rapporto con le diverse teorie dello stato,
anche se ciò che interessa di più è l’incidenza di queste teorie sulla concreta prassi in
termini di organizzazione della società politica in generale e di compatibilità delle
22
P. Abrams, Sociologia storica, Bologna, Il Mulino, 1983, p. 18
Cfr. G. Sivini, Sociologia dei partiti, Bologna, Il Mulino, 1971, pp. 9 -12. Si veda a tal proposito L. GALLINO,
I partiti politici: tipi e funzioni, in Manuale di sociologia, UTET, Torino 1994 dove i partiti di notabili, di massa,
pigliatutto vengono classificati in base ad un’analisi storico-sociologica.
24
N. Bobbio, Considerazioni sulla Filosofia Politica, in Rivista italiana di Scienza politica, a. 1, 1971, pp. 367379. Riguardo alla metodologia della filosofia politica ed al suo rapporto con la storia si segnala E. Weil,
Filosofia politica, Guida, Napoli 1973, in cui l’autore scrive: «Le scienze sociali teoriche non potrebbero
dunque costituirsi senza far ricorso alla storia. Ma non s’interessano alla storia intesa come una successione
unica e fornita di senso di eventi unici. Concepite allo scopo di render prevedibile il risultato di un’operazione,
sono dirette a far sì che l’uomo che agisce sulla società non debba agire alla cieca. Si sottopongono,
pertanto, alla verifica delle loro tesi secondo il criterio del successo pratico delle esperienze fatte in coerenza
col loro insegnamento. Non mirano alla comprensione degli atti passati, benchè possano aiutare lo storico nel
suo tentativo di comprendere il passato storico nella sua unicità» (p. 92).
25
In Ragioni della filosofia politica, in S. Rota, F. Barca, Studi politici in onore di Luigi Firpo, Franco Angeli,
Milano 1990, p. 183. Sull’importanza della filosofia politica per la storia dei partiti si veda anche A. Passerin
D’Entreves, Filosofia della politica, in Dizionario di politica diretto da N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino,
Utet, Torino 1990, pag. 392-399.
23
associazioni politiche con i fini dello stato. Una grande rilevanza a tal proposito può avere lo
studio delle dottrine politiche, se tale studio è condotto sul piano storico, ma vi è il rischio di
incorrere in una sopravvalutazione degli aspetti ideologici e dottrinari del dibattito politico
cui pure danno vita i partiti, senza curarsi troppo di verificare se vi sia stata coerenza tra
ideologia e prassi, tra programma ed azione concreta e, soprattutto, rischiando di
trascurare gli aspetti organizzativi e “funzionali” della vita dei partiti. È certo comunque che
la storia delle dottrine politiche, soprattutto quando in essa prevale l’approccio filologico
della ricerca – il più trascurato, segnalava Luigi Firpo qualche anno fa – può dare dei
contributi di grande rilievo per una completa analisi delle forme dell’associazionismo
politico. Basti citare, a titolo esemplificativo, gli studi di Salvo Mastellone su Mazzini e la
Giovine Italia o quelli di Sergio Amato sul problema del partito negli scrittori politici
tedeschi26.
I partiti possono essere, inoltre, studiati dal punto di vista del diritto costituzionale, ma il
carattere dommatico di questa disciplina, fondata esclusivamente sull’interpretazione
giuridica degli istituti costituzionali di diritto positivo, esclude ogni ricorso ad un approccio
storico che prenda in considerazione la genesi degli stessi istituti. Anche la storia del diritto
può prendere in considerazione il fenomeno partitico, ma la dimensione normativa non
riesce a cogliere il partito nella sua complessa realtà interna e nei suoi rapporti con il
sistema politico27.
Possiamo concludere dicendo che la disciplina in questione è dunque una disciplina
storica, ma deve essere distinta dalle altre discipline storiche. Non può essere confusa con
la storia sociale perché i partiti nella loro realtà non possono essere mere espressioni di
classi o di gruppi economici, in quanto la coscienza politica non è mai il prodotto meccanico
della struttura sociale, né la sua funzione può rispondere ad interessi di un solo aggregato,
anche se, naturalmente, conoscere l’insediamento sociale di un partito può essere un
elemento - non l’unico - per comprenderne il comportamento politico.
La storia dei partiti può essere considerata parte della storia politica e più propriamente
della storia istituzionale. Più precisamente, riprendendo ancora quanto affermava Michels,
si può dire che la storia dei partiti è una sorta di Grenzenwissenshaft, un’area di confine tra
la storia politico-istituzionale e la storia sociale, cioè «un ramo di scienza che confina da un
26
S. Mastellone, Il progetto politico di Mazzini, Olschski, Firenze 1994; La democrazia etica di Mazzini, Roma
2000; S. Amato, Il problema partito negli scrittori politici tedeschi. 1851-1914, CET, Firenze 1996. Per una
visione d’insieme e riguardo al metodo filologico si rimanda a L. Firpo, Storia delle dottrine politiche, in La
storiografia italiana degli ultimi vent’anni, Marzorati, Milano 1970.
27
Per un’approddio giuridico costituzionale al tema dei partiti politici si veda G. Rescigno, Corso di Diritto
Pubblico, (4^ ed.), Zanichelli, Bologna 1999/2000, pp. 316-344.
lato con le discipline sociali ed economiche, da un altro con quelle psicologiche, e da un
terzo lato con quelle storiche e che trovasi quindi in margine con parecchie scienze»28.
Sin qui abbiamo cercato di indagare sui rapporti tra storia dei partiti e le altre discipline,
ma si puó affermare che esista un'autonomia della storia dei partiti senza che questa
affermazione appaia come una petizione di principio? Si può cioè sostenere che vi sia
una sfera scientifica cui appartenga in modo prevalente e specifico lo studio dei partiti ?
Pombeni, nella sua opera “Partiti e sistemi politici nella storia contemporanea”, si domanda
se la storia dei partiti sia «un ramo del sapere oppure una semplice specificazione
dell’oggetto della scienza storica» e risponde affermando che la specificità disciplinare della
storia dei partiti non stia nell’oggetto ma nella metodologia. Ancora Pombeni precisa, infatti,
che « la storia dei partiti come ambito disciplinare specifico si occupa di un idealtipo: il
partito politico. Anzi per favorire la comprensione della differenza concettuale tra
idealtipo e astrazione categoriale, diremo che essa non si occupa dell’individuazione del
“partito ideale”
[...] ma
intende individuare la
articolarsi e di prodursi della
sfera
politica
forma-partito,
mediante
ovvero la modalità di
la presenza
organizzative che riuniscono soggetti sociali trasformandosi in istituzioni».
di
strutture
Ad ulteriore
chiarimento del concetto di idealtipo, Pombeni scrive:
«il tipo ideale non vuole dunque descrivere un fatto storico esistente, nè estrapolare
omogeneità rispetto a fenomeni diversi. Esso è semplicemente uno strumento di
misura, un mezzo per dare significato a dei fenomeni e mettere in chiaro relazioni e nessi
causali tra loro» 29.
È bastato osservare, cioè, che la tipicità di questo insegnamento non sta tanto nello studio
dell’oggetto-partito, ma nel metodo specifico con cui si affronta lo studio dei partiti, un
metodo che si può definire “storico-funzionale”, caratterizzato dall’impiego di un approccio
storico attraverso il quale analizzare non modelli astratti, né categorie interpretative, ma
forme concrete e realizzate di aggregazione politica. Abbiamo anche visto come i partiti
politici possono essere studiati da molti punti di vista e l’interdisciplinarietà degli approcci
può essere molto proficua. Lo studio della storia dei partiti deve essere, però, affrontato con
un metodo specifico, cioè con il metodo storico-funzionale e quindi deve essere condotto in
28
R. Michels, Il partito politico nella democrazia moderna, Torino 1924, p. XI
In particolare sulla “forma-partito” si veda P. Pombeni, Introduzione al sistema politico europeo ed alla
forma-partito contemporanea in Partiti e sistemi politici nella storia contemporanea, Bologna, Il Mulino, 1994,
pp. 19-34
29
modo tale da cogliere anche gli aspetti funzionali della vita del partito, della sua
organizzazione interna e dei suoi rapporti con il sistema politico, l’ordinamento
costituzionale e con la società nel cui ambito esso opera.
2. Oggetto della disciplina: le forme dell’aggregazione politica; partiti e movimenti;
l’associazionismo politico; partiti e associazioni come istituzioni politiche private.
Dovremo ora cercare di individuare quale sia l’oggetto di questa disciplina.
Se ci
rimettiamo alla definizione offerta dagli statuti universitari, notiamo una qualche incertezza:
esistono, infatti, insegnamenti di storia dei partiti e dei movimenti politici. Riesce difficile
comprendere, in effetti, come si possa far valere questa distinzione, separando il partito dal
movimento, intendendo per partito la dimensione politico -organizzativa ed il movimento
come la dimensione economico-sociale o culturale. Risulta davvero problematico
considerare, per esempio, i partiti socialisti, o anche il partito comunista, isolati dai
movimenti operai di ispirazione socialista o comunista e considerarli quindi avulsi dalle loro
aree culturali e dal movimento di idee, nonché dal reticolo associazionistico che vi ruota
attorno e attraverso il quale essi vengono in contatto con la società civile 30. E ciò a
prescindere dai rapporti di dipendenza o di autonomia da cui possono essere caratterizzate
le relazioni partito-sindacato-associazionismo economico e culturale. Allo stesso modo è
impensabile pretendere di studiare i partiti cattolici senza tener conto dei loro rapporti con il
movimento e con il mondo cattolico in genere. Mentre per movimento cattolico si deve
intendere l’associazionismo laicale e le organizzazioni ecclesiali, cioè quel complesso di
soggetti tra di loro interrelati e aventi un rapporto organizzativo con la chiesa cattolica, il
mondo cattolico è quella più vasta comunità di persone e di gruppi che si ispirano ai valori
del cattolicesimo, senza necessariamente avere un legame organico con la chiesa31.
30
Riguardo ai rapporti tra movimento e partito socialista, ha scritto Sabbatucci che «i partiti socialisti svolgono
nella storia del movimento operaio una funzione di orientamento e di guida» e S. Colarizi che «la storia del
Partito Socialista si articola, dunque, sui due momenti, movimento e istituzione, in un rapporto sempre
dialettico e in alcune fasi particolarmente tormentato». Per un orientamento bibliografico: AA. VV. (Bosio,
Francovich, Marini, Manacorda e Valiani), Il movimento operaio e socialista. Bilancio storiografico e problemi
storici, Milano 1961; G. Manacorda, Il movimento operaio italiano attraverso i suoi congressi (1850-1892),
Roma 1975; E. Ragionieri, Il movimento socialista in Italia. 1850-1922, Milano 1976; A. Romano, Storia del
movimento socialista in Italia, Bari 1966-67; E. Santarelli, Movimento operaio e movimento socialista, Urbino
1976; G. Sabbatucci (a cura di), Storia del socialismo italiano, Roma 1980-81; S. Merli, Proletariato di fabbrica
e capitalismo industriale. Il caso italiano 1880-1900, Firenze 1972. Per un riscontro di tale rapporto attraverso
le biografie dei protagonisti: F. Andreucci-T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano. Dizionario
biografico, 5 voll. , Roma 1975-78.
31
Per un inquadramento storiografico del problema: F. Fonzi, I cattolici e la società italiana dopo l’Unità,
Roma 1953; G. Candeloro, Il movimento cattolico in Italia, Roma 1953; G. De Rosa, Storia del movimento
Anche se si accetta la classificazione di partito in una dimensione esclusivamente politica,
come ipotesi di lavoro o come una fatalità accademica, non si può dimenticare, soprattutto
se si considerano i partiti “moderni”, che esiste un collegamento permanente tra questi
ultimi, la società civile ed il mondo economico e del lavoro, rapporto che, peraltro, si è
profondamente modificato in coincidenza con le trasformazioni della società, tanto che è
oggi difficile considerare come un dato permanente l’insediamento sociale e un patrimonio
ideologico-culturale.
Se si considera che l’oggetto della disciplina siano soltanto i partiti ed i movimenti politici,
bisogna sgomberare il campo da un possibile equivoco, causato da alcune teorie
evoluzionistiche, che sostengono che nel suo sviluppo il partito avrebbe seguito un
itinerario, che partiva da un’organizzazione di tipo embrionale per arrivare sino a quelle
forme ritenute perfette che sono i partiti di massa. In questo tipo di analisi rientra la tesi di
Duverger, il quale, differenziando tra una origine “interna”, elettorale-parlamentare, ed una
successiva origine “esterna” dei partiti, cioè quella scaturita dall’impulso di forme
organizzative preesistenti (sindacati, società di pensiero, chiese e sette religiose,
raggruppamenti industriali o commerciali, associazioni di ex combattenti, ecc.), descrive un
processo evolutivo che avrebbe la sua origine nel partito di comitati e il suo punto di arrivo
nel “moderno” partito di massa, secondo uno schema progressivo i cui presupposti della
trasformazione sarebbero stati dettati dal passaggio da una democrazia ristretta,
caratterizzata dalle varie forme di suffragio censitario, ad una democrazia fondata sul
suffragio universale. A sostegno della sua tesi, nel 1951 - anno della pubblicazione
francese di un testo che è considerato un classico della storia dei partiti, in rapporto
soprattutto alla trattazione in modo organico del partito come fenomeno organizzativo a tutti
i suoi livelli - il politologo francese affermava che: «un regime senza partiti garantisce la
perennità delle élites dirigenti espresse dalla nascita, dal denaro o dalla funzione: per
penetrare nell’oligarchia governante, un uomo del popolo deve compiere uno sforzo
considerevole per uscire dalla sua primitiva condizione; deve inoltre seguire le trafile
dell’educazione borghese e perdere il contatto con la sua classe di origine. Un regime
senza partiti è necessariamente un regime conservatore. Esso corrisponde al suffragio
censitario, oppure traduce uno sforzo per paralizzare il suffragio universale, imponendo al
popolo dei dirigenti che non emanino da esso: esso è ancora più lontano dalla democrazia
cattolico in Italia. Dalla restaurazione all’età giolittiana, Bari 1966; G. Verucci, Il movimento cattolico italiano.
Dalla restaurazione alprimo dopoguerra, Firenze 1977; M. Isnenghi-S. Lanaro (a cura di ), Movimento
cattolico e sviluppo capitalistico, Padova 1974;
del regime dei partiti. Storicamente, i partiti sono sorti quando le masse popolari hanno
cominciato a entrare realmente nella vita politica: essi hanno formato il quadro necessario
che permetteva loro di reclutare in se stesse le proprie élites [...]Le classiche proteste
contro la loro influenza nella vita politica, contro il predominio dei militanti sui deputati, dei
congressi e dei comitati sulle Assemblee, ignorano la capitale evoluzione compiutasi in
questi cinquant’anni e che ha accentuato il carattere formale dei ministri e dei parlamenti.
Un tempo strumenti esclusivi degli interessi privati, finanziari ed economici, gli uni e gli altri
sono divenuti strumenti dei partiti: fra questi, i partiti popolari occupano un posto sempre
maggiore. Questa trasformazione costituisce un’evoluzione della democrazia e non un
regresso»32.
Lo schema “evoluzionistico” riguardante il partito politico vale sia per lo storicismo di
stampo idealista, che ha concepito la storia come storia della libertà o dello spirito, sia per
lo storicismo marxista. Il primo considera la civiltà liberale come punto di arrivo e di
conseguenza tende a limitare la funzione del partito quando essa contraddice con la teoria
della rappresentanza, fondata essenzialmente su di una concezione individualistica dei
diritti politici e della sovranità popolare. Il movimento politico, per la scuola liberale classica,
diviene partito con la formazione della democrazia rappresentativa e si trasforma da partito
di comitati con funzione quasi esclusivamente parlamentare in partito “moderno”, e cioè in
uno strumento dotato di una poderosa macchina organizzativa, capace di organizzare il
consenso in una società di massa e di gestire il potere (modello “americano”). Non
diversamente accade nell’interpretazione marxista, secondo la quale la storia sarebbe
determinata da un processo che avrebbe dovuto portare - o in virtù dello scoppio delle
contraddizioni della società capitalistica o per intervento di un soggetto politico
rivoluzionario - ad una transizione al socialismo. Il modello di partito è stato, sino al crollo
del “socialismo reale”, quello leninista. Secondo l’interpretazione marxista, dalle prime
associazioni
operaie
ed
internazionaliste
si
sarebbe
passati
ai
partiti
di
tipo
socialdemocratico e, dopo il “fallimento” della II Internazionale, a quelli terzointernazionalisti, che, grazie al successo della rivoluzione sovietica, erano divenuti partitistato. Per quanto in Occidente si siano cercate “terze vie” tra il vecchio modello
socialdemocratico ed il partito di stampo marxista-leninista, e impossibili conciliazioni tra
eurocomunismi e democrazie liberali, questa ricerca non ha prodotto risultati. La stessa
32
M. Duverger, I partiti politici, Milano, Ed. di Comunità, 1961, pp. 516-517. Per la tesi sull’origine dei partiti,
cfr. pp. 15-31. Essa è trattata anche in, Id. , Introduction à la politique, Gallimard, 1964, pp. 167-182.
idea di partito è in crisi un pò dovunque, mentre si considera vincente la democrazia
liberale.
Queste concezioni storicistiche, la marxistica e la liberale (la socialdemocrazia è divenuta
ormai una variabile del sistema liberale), pur proponendo visioni diametralmente opposte
per quanto riguarda l’idea della democrazia e la teoria del partito, hanno, però, un punto in
comune e cioè quello di considerare il movimento un prius rispetto al partito, che
costituirebbe la forma più matura di aggregazione politica. I movimenti non possono,
tuttavia, considerarsi delle semplici correnti di idee, degli antecedenti rispetto ai partiti,
insomma dei pre-partiti. Impropriamente, si è parlato di movimenti protosocialisti o di
socialismo utopico, intendendo ciò che precede la fondazione dei partiti; sono stati
catalogati come movimenti cattolici quelle associazioni politiche ed unioni elettorali esistite
prima della creazione di un vero e proprio partito. In realtà, si può dire che i movimenti
esistano anche dopo la costituzione dei partiti e spesso con il termine movimento si vuole
indicare un’area più vasta di quella rappresentata da un partito. Ma con ciò non si può dire
che un movimento, per avere una sua espressione politica, debba necessariamente
trasformarsi in partito. Il caso più emblematico è rappresentato dal movimento liberale in
Italia dall’Unità al fascismo: un vero e proprio partito liberale venne fondato solo nel 1922.
Prima di allora, nel movimento liberale coesistevano gruppi parlamentari (ed anche un
movimento) in competizione tra loro, ma che avevano valori, regole ed obiettivi comuni.
Dopo la caduta del muro di Berlino, ci si può legittimamente interrogare non solo sul futuro
del comunismo “realizzato”, ma anche del socialismo democratico, che è stato il grande
rivale del comunismo, ma, per qualche verso, anche il grande alleato nella critica del
capitalismo. In via subordinata, c’è poi da domandarsi non tanto se questa crisi riguardi i
valori del socialismo, quanto le forme-partito socialdemocratiche e laburiste, o anche le
neo-socialiste. In realtà, la domanda che ci si può porre è se tutte le forme storiche di
partito abbiano fatto il loro tempo, compreso il partito americano, che, dopo una
temporanea reviviscenza, ha rivelato tutta la sua inadeguatezza con le elezioni che hanno
portanto Bush e poi Obama alla presidenza. Lo stesso new-labour di Blair non è stato
l’ultimo stadio del laburismo inglesesembra in crisi ed anche il bipartitismo inglese sembra
essere un sistema con delle vischiosità.
Indubbiamente, si può dire che i partiti, se hanno la forza di rinnovarsi dovranno competere
non solo tra loro, ma anche con un associazionismo politico che sembra essere la novità
dei nostri tempi. Quella dei movimenti non può, dunque, considerarsi un’area “residuale”,
lasciata fuori da un processo di specializzazione che porterebbe alla creazione di un partito.
Spesso, un movimento si pone in modo autonomo nei riguardi del partito e ne può costituire
un serbatoio ai fini del ricambio del personale politico e una riserva da cui trarre idee ed
elaborazioni critiche, utili al rinnovamento dei suoi programmi. Il movimento può anche
mantenere un rapporto di comunicazione più aperto ed attivo con la società ed essere per
certi versi più credibile di un partito, legato alla gestione del potere. Partiti e movimenti
possono convivere dialetticamente, anche se esistono dei movimenti che non aspirano a
divenire partiti o che si pongono in modo alternativo ai partiti, anzi desiderano sostituirsi ad
essi, considerando la forma-partito inadeguata o superata.
Gli sviluppi più recenti hanno dimostrato la vitalità dei movimenti. A titolo esemplificativo e
guardando alla realtà internazionale possono essere chiamati in causa i movimenti di
liberazione del terzo mondo; i movimenti ecologisti; i forum e le associazioni politiche del
dissenso, prima della caduta del comunismo; i movimenti creatisi in Italia dopo i referendum
del ’93 e la riforma elettorale, il movimento no-global. Nel primo caso si tratta di
organizzazioni che per il loro scopo devono dar luogo alla federazione di più partiti e
movimenti; nel secondo caso, ci troviamo di fronte ad una fenomenologia molto
differenziata. Possiamo trovare dei movimenti con scopi limitati (quello che gli inglesi
chiamano a single issue movement), come le leghe ambientali o movimenti che si
prefiggono scopi più generali. Tra questi ultimi, alcuni si pongono in modo conflittuale nei
confronti del sistema dei partiti ed intendono operare per via extra-parlamentare, altri, in
concorrenza con i partiti, operano a livello parlamentare. Il movimento no-global, ad
esempio, era dichiaratamente a-partitico ma se si analizza attentamente la sua
organizzazione non si può dire che le organizzazioni partitiche ne siano poi effettivamente
escluse. Il divieto alla partecipazione dei partiti esplicitato nello statuto del Global Social
Forum ad esempio viene più spesso eluso dalla partecipazione delle singole personalità
politiche o da sindacati che hanno poi rapporti organici con i partiti. Non si può dire poi che
tale movimento manchi di organizzazione, essendo provvisto di organi permanenti: un
Comitato organizzatore, un Consiglio internazionale, una Segreteria, delle Commissioni,
degli organi periferici come i Forum regionali o tematici. È vero che il movimento si propone
scopi sociali e si muove prevalentemente su questo terreno, anche se cerca di operare una
forte pressione a livello di opinione pubblica al fine di condizionare le scelte politiche. Non si
può dire quindi che sia alieno dalla sfera della politica33.
33
Sul movimento no-global si rimanda ad uno dei titoli più recenti di una ricchissima bibliografia: D. Della
Porta, New Global, Il Mulino, Bologna 2003.
Si possono perciò avere dei movimenti che assumono la forma delle leghe, quella del
“partito trasversale”, del “movimento-partito” o di un “superpartito”. La recente storia politica
italiana insegna che un sistema politico può essere caratterizzato dalla compresenza di
partiti “tradizionali” e movimenti tra di loro concorrenti, basti pensare al fenomeno delle
leghe (Lega Lombarda; Veneta; ecc.), delle associazioni referendarie, del Partito Radicale
e della Rete di Orlando, dei 5 Stelle. Una situazione che, peraltro, non è nuova per l’Italia:
nel primo dopoguerra, infatti, accanto ai partiti esistettero dei movimenti di questo tipo. Non
si può dire, perciò, che soltanto i partiti si pongono degli obiettivi generali, abbiano
programmi e filosofie complessive, lottino per la conquista del potere, perché molti
movimenti hanno gli stessi scopi. Comunemente si è creduto che i movimenti fossero delle
entità diverse e distinte rispetto ai partiti dal punto di vista organizzativo: mentre questi
ultimi sarebbero delle associazioni politiche con strutture centralizzate ed apparati
permanenti in grado di imporre la disciplina ai propri aderenti, i movimenti sarebbero
aggregazioni meno vincolanti, che non disporrebbero di grandi macchine organizzative. In
realtà, si è visto che vi sono partiti la cui organizzazione è molto più debole di quella posta
in essere da alcuni movimenti. La classificazione delle associazioni politiche in partiti e
movimenti ha dunque un valore puramente indicativo. Sarebbe forse meglio dire che
oggetto della storia dei partiti è lo studio delle istituzioni politiche “private”, distinguendole
dalle istituzioni pubbliche. Ma anche questa classificazione ha un valore relativo in quanto
vi sono alcune di queste organizzazioni politiche che hanno una rilevanza costituzionale. In
alcuni casi, vi sono dei partiti che hanno la configurazione di enti di natura pubblica o
addirittura possono essere degli organi dello stato (come è stato il caso dei partiti unici nei
regimi totalitari). La natura giuridica di queste organizzazioni politiche può, dunque, variare
a seconda delle posizioni che esse hanno nell’ambito dei diversi sistemi costituzionali. Ma
al di là di questi nominalismi, la disciplina deve occuparsi di tutte le forme di partecipazione
politica storicamente realizzate. Rispetto alla nozione di partito, si devono poi considerare
gli ambiti spaziali e temporali. Il termine partito è stato adoperato con significati diversi nel
Medioevo, nell’età moderna ed anche nell’antichità: non è qui il caso di far ricorso alla
semantica politica per ricordare come partito abbia significato: “fazione”, “consorteria”,
“clan”. È, quindi, lecito occuparsi anche di queste aggregazioni politiche, esistenti prima
della nascita dei partiti in senso moderno. Si deve tuttavia tenere presente che la nascita
dei partiti moderni si colloca nella transizione tra lo stato costituzionale e lo stato
rappresentativo. Si può dire, cioè, che il partito abbia assunto la sua configurazione
moderna con la formazione delle democrazie parlamentari. La costituzione dei partiti in
senso moderno è, dunque, un fenomeno “contemporaneo” e ha, almeno in un primo
momento, riguardato essenzialmente il mondo occidentale. Ciò non toglie che ci si possa
occupare anche di quelle forme di aggregazione politica che si sono manifestate in periodi
più antichi o al di fuori dell’area occidentale o che sono da mettere in rapporto con
organizzazioni
sociali
“tradizionali”
o
che
rappresentano
forme
“residuali”
di
un’organizzazione sociale primitiva. Ciò è possibile purchè tale studio sia condotto con
metodo storico e la singola forma politica sia messa in relazione con il sistema che la ha
prodotta.
In conclusione, la storia dei partiti è lo studio delle forme dell’aggregazione politica in
rapporto con i sistemi politici e le società civili nell’ambito dei quali hanno storicamente
operato. Partiti e sistemi politici interagiscono fra di loro e si influenzano reciprocamente. I
partiti e le altre associazioni politiche sono in realtà “funzioni” dei sistemi politici.
3. Gli elementi costitutivi del partito. Gli elementi ideologico-culturali: l’ideologia del
partito, la cultura, il programma, la propaganda, la ritualità, il mito e il rapporto tra
partito e leader; gli elementi organizzativi: il modello, lo statuto, l’organizzazione e il
finanziamento; elementi sociologici e funzione sociale del partito.
Se il metodo storico-funzionale è quello che sembra il più adatto per studiare il partito,
l’oggetto di tale studio deve riguardare l’organizzazione interna del partito stesso ed i
rapporti di quest’ultimo con il “sistema dei partiti” e con il sistema politico ed, in modo
più generale, con la società civile nel suo complesso.
Occorre, perciò, definire in primo luogo quali siano gli elementi costitutivi del partito politico.
Per comodità di esposizione questi fattori possono essere divisi in tre diverse categorie:
quelli di ordine ideologico-culturale; di ordine organizzativo e di ordine sociologico.
Per quanto riguarda il primo ordine di fattori, occorre considerare i seguenti aspetti:
a) l’ideologia del partito;
a1) la cultura;
a2) il programma;
a3) la propaganda;
a4) la ritualità;
a5) il mito;
a6) il culto del leader.
Per quanto riguarda il fattore organizzativo vanno tenuti presenti questi aspetti:
b) modello del partito;
b1) statuto del partito;
b2) organizzazione;
b3) finanziamento.
Per quanto riguarda i fattori di ordine sociale va tenuta presente :
c) la condizione economica;
dei dirigenti,
c1) l’origine sociale della famiglia;
dei parlamentari,
c2) la formazione culturale;
dei quadri intermedi,
c3) la funzione professionale.
degli iscritti,
dei simpatizzanti,
degli elettori.
Elementi ideologico-culturali.
Per quanto riguarda il primo ordine di fattori occorre domandarsi non solo se un partito
abbia un’ideologia, ma se l’accettazione di essa sia condizione per l’appartenenza al
partito, da un punto di vista formale, e se tale ideologia sia di fatto professata dal corpo
del partito. Se la professione di un’ideologia è una condizione formale per l’iscrizione al
partito questa condizione è espressamente prevista nello statuto del partito. Il primo statuto
del Partito Comunista d’Italia, ad esempio, si apre con un prologo articolato in 10 punti in
cui è espressa l’ideologia ispiratrice del partito ed il suo programma. L’art. 2 stabiliva poi
che il partito era organizzato sulla base delle adesioni individuali tramite iscrizione nella
sezione e, all’ art. 3 dello statuto, che la sezione aderiva «ai principi esposti nel programma
ed accetta[va] lo Statuto del Partito Comunista d’Italia». L’art. 8 esplicitava che «la
iscrizione è fatta mediante un modello uniforme distribuito alle Sezioni dal Comitato
Centrale; essa implica l’adesione incondizionata al programma, nonché la osservanza del
presente Statuto e la più rigorosa disciplina verso i deliberati del Partito e della
Internazionale Comunista». Lo statuto del 1948 all’art. 1 recitava che «il partito comunista
italiano è l’organizzazione politica dei lavoratori italiani i quali lottano in modo conseguente
per la distruzione di ogni residuo del fascismo, per l’indipendenza e la libertà del paese, per
la edificazione di un regime democratico e progressivo, per la pace tra i popoli, per il
rinnovamento socialista della società». Il partito era concepito come una «organizzazione
unitaria combattiva, retta da una disciplina volontaria che impegna tutti i suoi membri».
«Ogni membro del Partito è tenuto ad accettare il programma politico e lo statuto del
Partito, a lavorare in una delle sue organizzazioni e a pagare regolarmente la tessera e le
quote» (art. 2). Tra i doveri degli iscritti al partito stabiliti dall’art. 9 al punto b) si stabiliva
che ogni iscritto era tenuto a «migliorare di continuo la propria conoscenza della linea
politica del partito e la propria capacità di lavorare per la sua applicazione ed approfondire
la conoscenza del marxismo-leninismo», con un chiaro rimando quindi all’ideologia del
partito34. Lo statuto del PNF del 192635 si apriva con un ampio prologo di natura ideologica
che non a caso portava il titolo “Fede”. Il secondo capoverso della norma 27 di quello
statuto stabiliva che i nuovi iscritti dovevano prestare giuramento davanti al Segretario con
la formula «giuro di seguire senza discutere gli ordini del duce e di servire con tutte le mie
forze e se è necessario, col mio sangue la causa della Rivoluzione fascista». La norma 29
stabiliva poi che qualora un fascista fosse venuto meno al suo dovere per indisciplina o per
deficienza delle qualità che costituivano lo spirito fascista, e cioè: «Fede (fascista),
Coraggio, Laboriosità e Onestà», sarebbe stato sottoposto ad inchiesta da parte del
Direttorio. Da quest’ultima disposizione statutaria si desume che tra i requisiti necessari per
l’iscrizione al partito c’era la totale accettazione, senza possibilità di discussione o di critica,
dell’ideologia cui si ispirava il partito.
Un passo di uno scritto di Benedetto Croce spiega bene in quale modo si configura il
rapporto tra ideologia e partito:
«[…] ogni partito sviluppa una ideologia o teoria, o piuttosto pseudoteoria, che gli serve non
ad altro fine che a suscitare la parvenza di avere a sé alleate la Verità, la Ragione, la
Filosofia, la Scienza e la Storia, deità che avrebbero disertato il campo avversario […] Le
pseudoteorie, con le quali i partiti ragionano i loro programmi, possono essere, prese per
sé, corrette e vere, com’è, per esempio, la teoria dello svolgimento storico per antinomie,
34
Partito Comunista Italiano. Statuto. Appprovato dal IV Congresso Nazionale del PCI (Milano – gennaio
1948)
35
Approvato dal Gran Consiglio del fascismo nella seduta dell’8 ottobre 1926 ed entrato in vigore il 15
novembre del 1926.
alla quale si richiama il liberalismo col suo graduato progressismo; ma non hanno nessun
legame col partito in quanto volontà politica, e volontà storicamente determinata e
individuata, la cui unica ragione è in sé stessa; e, messe in quella forzata relazione,
s’imbevono di falso. Ma altre volte sono false anche prese per sé, come, per esempio,
quelle marxistiche del plusvalore e del materialismo storico e del salto dal regno della
necessità in quello della libertà, e tutto al più esprimono in forma di apparenza logica ma
intrinsecamente fantastica i sentimenti e le tendenze pratiche del partito; e nondimeno
anche in questi casi adempiono al loro ufficio. Fuori di tale ufficio, che è oratorio e
avvocatesco a vantaggio del partito, e che talvolta si esercita sugli uomini stessi e perfino
sui capi del partito, prigionieri dei loro sofismi, le ideologie non ne hanno altro»36.
In genere, quando si parla di ideologia di partito con riferimento a partiti democratici si
intende l’ideologia nel suo significato “debole” e cioè come quel sistema di idee e di valori
che orientano l’azione politica del movimento. L’ideologia può essere anche intesa in senso
“forte” e consiste nella “cattiva coscienza” di un gruppo dirigente che fornisce una
giustificazione della sua egemonia e/o dominio nei riguardi del partito e della società. In
questo contesto l’ideologia si manifesta come falsa motivazione e falsa rappresentazione,
nel senso che in base ad essa la leadership costruisce la sua legittimazione e in forza della
seconda viene fabbricata una verità valida per i militanti a cui essi devono credere perché
affermata dalla leadership. Nei partiti unici nei sistemi totalitari l’ideologia aveva questa
funzione. Non tutti i partiti fanno necessariamente riferimento ad un’ideologia: alcuni la
rifiutano e si proclamano pragmatici, a-ideologici, anti-ideologici o post-ideologici37. Il
rapporto con l’ideologia è molto forte nei partiti unici, nei partiti marxisti e socialdemocratici,
mentre è meno forte nei partiti democratici e liberali dove semmai gioca di più il legame con
la tradizione e la cultura di partito. Procediamo ad alcuni esempi: nello statuto del Partito
Comunista d’Italia del 1921 che abbiamo citato viene esplicitata la teoria marxista dello
sviluppo di «un sempre crescente contrasto fra le forze produttive ed i rapporti di
produzione», che stava alla base della «antitesi di interessi ed alla lotta di classe tra il
proletariato e la borghesia dominante». Allo stesso modo, la democrazia rappresentativa
veniva intesa ideologicamente come espressione del «potere dello Stato borghese» e
come «organo per la difesa degli interessi della classe capitalistica» e non, cioè, come un
terreno in cui poter mediare attraverso una tattica riformista anche gli interessi degli strati
36
37
B. Croce, Elementi di Politica, Laterza, Bari 1925, pp. 42-43.
Per una definizione di “ideologia” vedi Il Dizionario di Politica, a cura di N. Bobbio, ad vocem.
inferiori della società. In tale contesto ideologico, prendeva corpo anche il principio che
«indispensabile» organo della lotta rivoluzionaria fosse il Partito comunista – non un partito
tra gli altri partiti, ma il solo capace di interpretare gli interessi del proletariato in senso
rivoluzionario, l’unica modalità di lotta politica possibile. Partito che «riunendo in sé la parte
più avanzata e cosciente del proletariato, unifica[va] gli sforzi delle masse lavoratrici» ed
aveva il compito di «diffondere nelle masse la coscienza rivoluzionaria, di organizzare i
mezzi materiali di azione e di dirigere nello svolgimento della lotta il proletariato». Da qui,
l’altro principio ideologico della necessità della rivoluzione, secondo il quale il sistema dei
rapporti capitalistici di produzione da cui derivava lo sfruttamento del proletariato non
poteva essere infranto né modificato «senza l’abbattimento violento del potere borghese»
e, ancora, che «la lotta di classe non [poteva] che risolversi in conflitto armato fra le masse
lavoratrici ed il potere degli Stati borghesi»38. Sempre nello stesso prologo, non mancava
un richiamo al sistema da edificare dopo l’abbattimento del potere borghese, che
consisteva nella «instaurazione della propria dittatura [del proletariato]», «ossia basando le
rappresentanze elettive dello Stato sulla sola classe produttiva ed escludendo da ogni
diritto politico la classe borghese». La forma di rappresentanza politica dello Stato
proletario era quindi il sistema dei consigli dei lavoratori (operai e contadini), «già in atto
nella rivoluzione russa, inizio della rivoluzione proletaria mondiale e prima stabile
realizzazione della dittatura proletaria»39. Altro tipico esempio di ideologia in senso forte è
quella a cui si ispirava l’organizzazione di partito del PNF, di cui è possibile trovare traccia
nello statuto del 1926 già citato. In esso si legge che le origini del fascismo «si confondono
con la rinascita della coscienza italica e con la volontà della Vittoria», da cui traspare
un’operazione ideologica di accreditare il partito come unico interprete della storia
nazionale, storia nazionale che coincide con quella del partito. Si legge poi che «il
Fascismo non [era] soltanto un raggruppamento di italiani intorno ad un determinato
programma realizzato e da realizzare, ma [era] soprattutto una fede», una fede che «aveva
avuto i suoi confessori» e che aveva i suoi ordinamenti, in cui operavano «come militanti,
gli Italiani nuovi, espressi dallo sforzo della guerra vittoriosa e dalla successiva lotta fra la
Nazione e l’antinazione», da cui emerge l’idea di partito come strumento operativo di una
ideologia che non concepisce forme di espressione ad essa opposta o da essa diversa e,
pertanto, “antinazionali”. L’idea che il partito fosse l’unica possibile voce di una nazione
rinnovata, che viveva «in funzione dell’avvenire», in cui «ordinamenti e gerarchie»
38
39
Ai punti 3 e 5 dell’art. 1 dello statuto del 1921 del PCd’I.
Ai punti 6 e 7 dell’art. citato sopra.
ricevevano «luce e norma dall’alto», cioè dal duce, e che solo questi avesse «una visione
completa degli attributi e dei compiti, delle funzioni e dei meriti» è l’idea di un partito
totalitario in un sistema che non ammette altre forme di espressione politica40.
Avvicinandoci ai nostri giorni si può poi fare un esempio in cui in luogo di una ideologia in
senso forte si può parlare di un richiamo ad una ben precisa tradizione politico-culturale.
Quando, nel 1990, il PCI mutò il proprio nome in Partito Democratico della Sinistra si dotò
di uno statuto dall’ampio prologo, in cui si tentava di risolvere a livello formale il nodo del
rapporto con il proprio passato, travolto dagli avvenimenti del 1989. In quel testo si parla di
un partito «di uomini e di donne che professano comuni valori fondamentali: i valori della
libertà, dell’uguaglianza, della solidarietà, della pace, della difesa della natura. Che si
riconoscono in un progetto e in un programma politico: il progetto della democrazia, via del
socialismo; un programma politico di riforme per la profonda trasformazione della società
umana». Più avanti si provvede a saldare la “nuova” esperienza con il proprio retroterra
politico-culturale, quando si afferma appunto che il partito affondava «le sue radici nel
patrimonio storico del movimento operaio e socialista, nell’originale tradizione culturale e
politica dei comunisti italiani», ma accettando anche «l’eredità delle rivoluzioni liberali e
democratiche», sebbene «portandole oltre i loro storici limiti di classe». Nel testo, in cui
traspare evidente una certa difficoltà di conciliare due tradizioni, quella liberal-democratica
e quella comunista, che sono tra loro opposte, si riconosce «il fallimento dei regimi dispotici
costituitisi in nome del comunismo» e si opta per una azione da «condurre nell’ambito del
socialismo europeo e in rapporto con tutte le forze democratiche avanzate», nella necessità
di «superare un’esperienza storica, [di] raccogliere ed oltrepassare le tradizioni, per
contribuire […] alla costruzione di una sinistra (italiana, europea, mondiale) profondamente
rinnovata». Nel capoverso successivo si precisa: «In essa [cioè nella sinistra italiana] il PCI
porta un’inestimabile esperienza di cultura, di idee, di lotte, di impegno politico e civile, di
passioni e sacrifici personali e collettivi», una citazione che ai fini del nostro discorso vale
come un richiamo diretto ad un ben preciso contesto politico e culturale di riferimento41.
Giovanni Sartori in un testo della metà degli anni Sessanta ha operato una interessante
correlazione tra sistemi di partito e grado di ideologizzazione dei partiti. Sartori configura
innanzitutto una «scala di intensità ideologica» riducendola in quattro voci: 1) ideologia
rigida e intensa; 2) ideologia intensa ma flessibile; 3) ideologizzazione debole; 4)
pragmatismo. Secondo l’ipotesi di Sartori, il punto minore di intensità ideologica si
40
41
I passi citati sono tratti della statuto del PNF del 1926 nella parte introduttiva intitolata “Fede”.
I passi citati sono tratti da Partito Democratico della Sinistra. Statuto, a cura del PDS, Roma 1991.
raggiunge nell’area dei sistemi bipartitici e il massimo di pragmatismo sarebbe riscontrabile
nella stessa area. L’intensità ideologica crescerebbe man mano che si procede in direzione
del pluripartitismo estremo. I casi quindi sarebbero i seguenti:
a) i sistemi politici a partito unico sono necessariamente ideologici, ma con sensibili
variazioni di intensità e di rigidità:;
b) con ogni probabilità un sistema a partito predominante esibirà un grado modesto di
ideologizzazione debole (altrimenti avremmo un partito egemonico)
c) un sistema bipartitico non può essere ideologico
d) è probabile che un sistema pluripartitico sia riconducibile a una configurazione
prevalentemente pragmatica quando i partiti sono tre-quattro, e a una configurazione
prevalentemente ideologica quando i partiti sono cinque o più42.
Altro elemento fondamentale è quello di conoscere quale sia la cultura ufficiale di un partito.
C’è da domandarsi in primo luogo quale sia il rapporto tra la cultura di partito e la cultura
politica del paese. In genere, quest’ultima viene definita come cultura ufficiale, “grande
cultura”, “cultura delle élites”, mentre quella dei partiti viene considerata una sub-cultura
(sub-cultura socialista, cattolica, comunista) rispetto alla cultura nazionale. Si può, tuttavia,
parlare di sub-cultura solo quando quest’ultima vuole porsi in modo autonomo o separato
nei riguardi alla cultura nazionale. Se, invece, vi è un rapporto dialettico tra le due culture,
rapporto reso vivo dal contributo di intellettuali che partecipano sia della vita di partito che di
quella accademica, delle redazioni dei giornali e dei centri di produzione della cultura non
si può segnare una linea di demarcazione tra la “cultura di partito” e la “cultura nazionale”.
Quanto più il partito vive in un circuito chiuso tanto più questa “cultura di partito” rischia di
essere una sub-cultura. In una società “aperta” e in presenza di partiti democratici che
competono tra loro vi è massima comunicazione tra le due culture. Nelle società repressive,
dove i partiti devono operare in un regime di piena o parziale clandestinità, questa
comunicazione manca. Nei regimi totalitari la “cultura di partito” ha tentato di esercitare una
sua egemonia nei confronti della cultura nazionale, ma il risultato non è stato molto felice e
spesso ci si è limitati a produrre
istituzioni. Degno di interesse è il problema della
circolazione della cultura tra il vertice e la base del partito. Può infatti accadere che mentre
gli scritti, gli articoli dei dirigenti del partito siano da considerarsi un contributo alla cultura
non solo del movimento ma alla “grande cultura” del paese ed abbiano un’influenza nel
42
G. Sartori, Partiti e sistemi di partito. Corso di Scienza politica, Ed. Universitaria, Firenze, 1964-65, pp. 5860.
dibattito politico e scientifico non abbiano poi un eguale impatto nella cultura materiale
dell’organizzazione. Si tratta di vedere quali siano le modalità di divulgazione e di
trasmissione del messaggio culturale e quanto esso venga recepito dai quadri intermedi e
dai militanti. Nell’ambito della sinistra italiana, per esempio, il problema del rapporto tra
patrimonio culturale del partito e la base è stato oggetto di ripetute attenzioni.
Molto chiaro in proposito sarà Franco Fortini che sull’ «Avanti!» distingueva tra cultura per il
proletariato, «che è qualcosa di estrinseco e di impartito, non di spontaneo e creativo» e la
cultura del proletariato, cioè «quelle particolari forme di espressioni, consuetudini mentali,
costumi morali, etc. , che sono […] le resultanze delle particolari condizioni di vita del
proletariato stesso […] Dov’è questa spontaneità e creatività del nostro proletariato operaio
e contadino? È evidente che dovremo cercarla innanzitutto nell’azione politica del
proletariato stesso, nelle sue organizzazioni sindacali e di partito, nella storia dei suoi
scioperi, delle sue lotte, delle sue sconfitte e vittorie»43
Per quanto riguarda il programma del partito esso viene di solito approvato dai congressi,
sia che si tratti di programmi “massimi”, cioè che consistono nella traduzione nella pratica
dell’ideologia e che definiscono gli obiettivi massimi e a lungo termine del partito, o
“minimi”, che tendono a quegli obiettivi più realistici che possono essere realizzati
nell’immediato. Se si guarda allo statuto del Partito dei Lavoratori Italiani del 1892 si può
notare che il programma ha come «scopo finale» la «socializzazione dei mezzi di
produzione e la gestione sociale della produzione», strumenti attraverso i quali i lavoratori
possono conseguire la loro emancipazione. Tale scopo finale poteva raggiungersi
«mediante l’azione del proletariato organizzato in partito di classe», che si esplicava però
sotto il «doppio aspetto» 1) di una «lotta di mestieri per i miglioramenti immediati della vita
operaia (orari, salari, regolamenti di fabbrica, ecc) lotta devoluta alle camere del lavoro ed
alle altre Associazioni di arti e mestieri»; 2) «di una lotta più ampia e intesa a conquistare i
poteri pubblici (Stato, Comuni, Amministrazioni pubbliche, ecc) per trasformarli, da
strumento che oggi sono di oppressione e di sfruttamento, in uno strumento per
l’espropriazione economica e politica della classe dominante»44. Ricorriamo ad un passo di
un discorso pronunciato di Turati al V congresso del PSI di Bologna del 1897 per
comprendere meglio la differenza tra programma “massimo” e “minimo” nell’interpretazione
43
Franco Fortini, Per la fine di un equivoco. La cultura proletaria, in «Avanti!», 26 giugno 1947, citato da V.
Strainati, Politica e cultura nel Partito Socialista Italiano. 1945-1978, Liguori Ed. , Napoli 1980, pp. 63-64.
44
Il Programma e lo statuto del Partito dei Lavoratori Italiani. Testo definitivo, agosto 1892.
ufficiale della linea del partito:
«Il programma minimo dei socialisti non è il loro programma di governo. Il socialismo non
potrà incominciare ad essere attuato se non dopo la conquista dei pubblici poteri; nel che è
da intendere, non già la conquista di qualche seggio o di qualche minor corpo deliberante,
ma la presa di possesso da parte del proletariato socialista dei congegni fondamentali del
potere politico […] Il programma minimo dei socialisti non è che l’indice sempre mutabile e
progressivo di quelle riforme di maggior portata, le quali, mentre appaiono compatibili col
fondamentale ordinamento economico di un dato momento, ne agevoleranno la graduale
evoluzione a forme superiori, sia elevando il tenore di vita dei lavoratori, sia consentendo
un più normale e cosciente svolgimento delle lotte di classe, sia ringagliardendo le forze del
partito socialista. Il programma minimo dei socialisti è essenzialmente un programma
d’agitazione. Esso si distingue da richieste analoghe di altri partiti per le sue finalità; ravvisa
come mezzo ciò che per altri è fine. Le riforme indicate nel programma minimo dovranno
essere sempre presentate non come soluzioni definitive, ma come facilitazioni al
conseguimento del solo rimedio radicale ai mali sociali, la socializzazione dei mezzi di
produzione»45.
Il passo citato costituisce un esempio di interpretazione di disposizioni statutarie in tema di
programma. Nel caso specifico, il problema dell’adozione di un programma minimo si
inseriva anche nel dibattito sulla opportunità o meno delle alleanze elettorali con i partiti
“affini” (repubblicani e radicali), problema sul quale il partito era diviso tra favorevoli e
“intransigenti”, così come risulta evidente dalla preoccupazione di Turati di precisare che il
programma minimo socialista si distinguesse da «richieste analoghe di altri partiti», che lo
consideravano un fine, quando per i socialisti il fine ultimo rimaneva la socializzazione dei
mezzi di produzione ed il programma minimo un semplice «mezzo» per il suo
conseguimento. Bisogna tener presente, tuttavia, che si trattava, appunto, di una
interpretazione, adottata poi come linea ufficiale del partito, ma rispetto alla quale, e ciò fa
capire l’importanza del momento del dibattito nella vita interno di un partito democratico,
esistevano anche posizioni critiche o divergenti. Vale la pena citare al proposito le posizioni
di Gaetano Salvemini, contrario alla distinzione fatta da Turati tra programma di governo
(socialista) e programma minimo di riforme «compatibili col fondamentale ordinamento
45
In atti del V congresso di Bologna, in F. Pedone, Novant’anni di pensiero e azione socialista attraverso i
congressi del PSI. 1892-1914, Palermo 1983.
economico di un dato momento» e favorevole invece ad un solo programma, «socialista»,
da adottare sia che il partito si trovasse al governo, sia che questo fosse all’opposizione.
Salvemini preferiva parlare di «riforme socialiste» e di «programma pratico» ed al proposito
scriveva:
«Ciò posto, è chiaro che noi non abbiamo due programmi: uno massimo, uno minimo; uno
di governo, uno d’opposizione. Noi non abbiamo che un metodo ricostruttivo, il quale
suggerisce,
a
seconda
delle
circostanze,
riforme
immediate,
le
quali
variano
continuamente, e, ottenute le prime, il nostro metodo ce ne suggerisce delle altre. Il nostro
programma non esiste, diviene»
Ciò che può apparire come una sterile disputa nominalistica o teorica aveva invece
l’importante obiettivo di dare un significato non riduttivo o fuorviante al concetto di
programma minimo, e di riempirlo di contenuti maggiormente incisivi. Da qui l’esigenza di
sottolineare «il nesso indissolubile fra le riforme più immediate e legali e le riforme più
lontane e più rivoluzionarie» e di fare in modo che «specialmente le riforme immediate e
compatibili colla presente costituzione politica ed economica [avrebbero dovuto] essere
presentate non come soluzioni definitive, ma come facilitazioni al conseguimento del solo
rimedio radicale ai mali sociali, la socializzazione dei mezzi di produzione»46.
Tornando al nostro discorso sul programma come elemento costitutivo di un partito politico,
bisogna distinguere tra “programma elettorale”, cioè quei punti che entrano a far parte delle
piattaforme elettorali e “programmi di governo”, che vengono fissati al momento della
formazione del governo. Quando il governo è costituito da un solo partito, il programma di
governo tende a ricalcare quello elettorale, anche se le “piattaforme elettorali” contengono
maggiori elementi di utopia rispetto ai policy statement dei governi. Se questi ultimi sono di
coalizione i programmi di maggioranza e di governo sono frutto di trattative tra i partiti e
rappresentano spesso un compromesso tra le diverse posizioni.
Bisognerà, inoltre, vedere quanto dell’ideologia, della cultura e dello stesso programma di
partito viene fatto conoscere all’esterno e quali siano gli strumenti della propaganda
46
Cfr. Contributo alla riforma del programma minimo, in “Critica Sociale”, 16 aprile-1 maggio 1898, ora in G.
Salvemini, Opere, II, vol. III, Movimento socialista e questione meridionale, Feltrinelli, Milano 1969. Su G.
Salvemini si veda AA. VV, Gaetano Salvemini, Laterza, Bari 1959; M. L. Salvadori, Gaetano Salvemini,
Einaudi, Torino 1963; G. Cingari, Gaetano Salvemini tra politica e storia, Laterza, Roma-Bari, 1986; AA. VV. ,
G. Salvemini metodologo delle scienze sociali, Rubbettino, Soveria Mannelli 1996; F. Grassi Orsini, La “Lega
Democratica per il rinnovamento della politica nazionale”: dalla rivista di cultura al superpartito della
democrazia, in Il partito politico dalla Grande Guerra al fascismo, a cura di F. Grassi Orsini, G. Quagliariello, Il
Mulino, Bologna 1996.
politico-culturale ed elettorale. Per propaganda si intende la diffusione deliberata e
sistematica di messaggi indirizzati ad un determinato uditorio e miranti a creare una
immagine positiva o negativa di determinati fenomeni. Si tratta cioè di uno sforzo
consapevole che mira ad influenzare le opinioni e le azioni di un certo pubblico. Anche nelle
sue moderne definizioni politologiche, il termine viene fatto risalire all’utilizzazione che ne
fece la Chiesa per indicare attività di proselitismo. Nella ideologia e nella prassi comunista
di solito viene fatta una distinzione tra agitazione e propaganda, con il primo termine si
intende la diffusione e la presentazione di una sola idea o poche idee ad un gran numero di
persone, mentre nel secondo caso si intende la diffusione di molte idee ad un uditorio
ristretto. Pasquino afferma che la propaganda ha acquistato nel tempo un’accezione
negativa: essa, infatti, si differenzierebbe dalle altre forme di persuasione perché dà
maggiormente risalto ad elementi puramente emotivi, ricorre a stereotipi, mette in rilievo
soltanto certi aspetti della questione, ha un carattere partigiano47.
Ai fini di una
classificazione dei partiti politici attraverso gli elementi che lo costituiscono ha un rilievo
analizzare infatti se nel diffondere l’ideologia, la cultura e le stesse parole d’ordine del
partito si faccia uso di argomenti e di tecniche che si rivolgono alla razionalità o tendono,
invece, a fare appello all’emozionalità, ai sentimenti, all’inconscio delle masse, cioè se si
ricorra alla diffusione di un credo dogmatico, di una mistica, in breve, alla fabbricazione di
un mito e a tale fine se vengano praticate forme di ritualità funzionali allo scopo
dell’integrazione di aderenti e simpatizzanti nel corpo del partito.
Rispetto alle tecniche di propaganda bisogna ricordare che negli ultimi anni si è registrata
un’attenzione crescente nei confronti della comunicazione politica, con degli studi dai
diversi approcci (sociologici, storici, linguistici) sulle tecniche, gli strumenti, il linguaggio
della comunicazione. Bisogna sottolineare che le attenzioni nei confronti di quest’aspetto
della politica, che investe indistintamente le organizzazioni di partito, si sono moltiplicate in
Italia in coincidenza con le trasformazioni subite dal sistema dei partiti agli inizi degli anni
Novanta e con il conseguente apparire di forme di organizzazione politica sotto certi aspetti
“nuove”, ed in particolare per gli aspetti che riguardano appunto il modo in cui il partito si
apre verso l’esterno. Il primo impatto è stato dominato da una diffidenza e da una ricezione
negativa non scevra di implicazioni ideologiche, che ha portato a giudizi demonizzanti su
TV e gigantografie elettorali, inni musicali, gagliardetti di partito e comizi in teleconferenza o
sprezzanti circa la presunta esistenza addirittura di una nuova ed inferiore categoria
47
Vedi voce Propaganda, in Dizionario di Politica, diretto da N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Utet,
Torino 1990
antropologica, quella dell’homo videns, alludendo ad un elettorato che subisce
passivamente ed a-criticamente il messaggio televisivo, simbolo dell’era del «postpensiero»48. Si tratta tuttavia di un atteggiamento fuorviante e non del tutto disinteressato di
interpretare il fenomeno, se solo si prova ad adottare anche in questo caso un criterio
storico. Il problema del linguaggio della politica, della ricerca e dell’uso degli strumenti più
idonei alla comunicazione è, infatti, vecchio quanto la politica stessa ed è ovvio che tali
tecniche siano adoperate con maggior profitto sfruttando al massimo i vantaggi offerti
dall’innovazione tecnologica.
Da un punto di vista storico le tecniche di propaganda politica hanno subito dei profondi
mutamenti determinati da fattori come il crescente rilievo assunto dal messaggio ideologico
dalla Rivoluzione Francese in poi; la rivoluzione industriale e l’allargamento della sfera della
politica; l’aumento della popolazione mondiale ed il suo inurbamento avvenuti tra Otto e
Novecento; la diffusione della stampa, che da mezzo ristretto ad un’élite diventa un mezzo
di comunicazione di massa; l’accelerazione decisiva impressa dal primo conflitto mondiale
sui tempi e sui modi della circolazione degli uomini e delle idee. Quando la politica comincia
ad assumere una dimensione di massa, il modello di comunicazione da seguire è preso a
prestito dalla tradizione del cristianesimo, sull’efficacia del quale, storicamente, non
possono esserci dubbi: al tempo delle prime rivendicazioni cartiste in Gran Bretagna, nei
primi anni Trenta dell’Ottocento, alcune associazioni radicali, come la Working Men’s
Association di William Lovett, per la diffusione del loro messaggio di emancipazione sociale
e politica tra i lavoratori utilizzavano un modello organizzativo ricalcato su quello della
chiesa metodista inglese, grazie al quale i membri dell’associazione potevano esercitare
una forma di “catechismo” in seno a gruppi di venti-trenta lavoratori con appuntamenti
settimanali. Nella tradizione politica italiana, fu Mazzini ad operare un’efficace sintesi tra le
forme della propaganda sansimoniana – che dava grande importanza al momento del
messaggio, al valore della corrispondenza scritta come forma di diffusione delle idee, alla
necessità di creare una nuova chiesa e di “convertire” al verbo sansimonista -, il
“catechismo” cartista e la tradizione rivoluzionaria repubblicana francese, che faceva uso
regolare di fogli di propaganda, manifesti e giornali. Non a caso, l’organo di stampa della
seconda Giovine Italia che si chiamava indicativamente “Apostolato Popolare”, ad uso degli
operai, visti ormai come elemento indispensabile per la rivoluzione nazionale, nasce nel
1840 a Londra, in pieno dibattito sulla miglior forma della democrazia in Europa. La
48
Cfr. G. Sartori, Homo videns: televisione e post-pensiero, Laterza, Roma-Bari 1997. Il libro ha conosciuto
due successive edizioni (1998 e 1999).
tradizione mazziniana viene ripresa in Italia dal movimento socialista. Sul rapporto tra
religione e propaganda politica nella tradizione della sinistra italiana basti citare quanto
scrive Ettore Ciccotti in Psicologia del movimento socialista, scritto nel 1903:
Dire socialismo significa dire propaganda, anche più che per ogni altra fede o religione o
indirizzo d’opinione; perché alla propaganda spinge l’indole della fede, la natura di chi vi è
stato tratto, la necessità di un’azione fattiva onde non isfumi in un’astrazione e non approdi
a una contraddizione. Questo desiderio e bisogno, al tempo stesso di proselitismo, cerca
naturalmente tutte le vie, escogita i mezzi più efficaci, si innesta su tutti gli addentellati,
mette a partito tutte le occasioni49.
Ed ancora a proposito della festa del Primo maggio:
«Negli stessi impulsi, negli stessi motivi, negli stessi fini, da cui hanno origine queste
dimostrazioni, trova la sua ragion d’essere la solennità del Primo maggio. È una
dimostrazione? È una festa? È una rivista? È un monito? È tutto questo, insieme, e qualche
altra cosa ancora. È il più geniale trovato, che dal punto di vista psicologico, estetico,
politico, si potesse escogitare. È una rinnovellata Pasqua cristiana, una festa di ricordi, di
speranze, di rimpianti, triste del presente che si deplora, gioconda dell’avvenire che
s’invoca e si matura, balda della forza che si espande, adombrata di tutte le incertezze e le
pene del futuro. Il fatto di riconcentrare, per mezzo di essa, su di un dato ordine di idee e su
di un indirizzo pratico, a ricorrenza fissa, tutto il proletariato mondiale, dà la guarentigia di
una efficacia pratica mirabile; e si ha la magia e la filosofia di tutte le festività, da quelle
pagane a quelle cristiane, ma estesa sino ad avere per confine il mondo, sino a
raggiungere, con l’universalità, proporzioni altamente epiche»50.
Il libro di Ciccotti, al quale si rimanda per una ricostruzione dettagliata delle forme e dei
mezzi della propaganda socialista, è indicativo di un approccio attento a leggere il
fenomeno mettendolo in relazione con una serie di fattori che ne condizionano la natura: il
sistema politico di riferimento; il contesto sociale - «Già, innanzitutto, da noi abbondano gli
49
E. Ciccotti, Psicologia del movimento socialista, Laterza, Bari 1903, pp. 94-95.
Ibidem, p. 120. Sull’importanza del Primo maggio per il movimento socialista si veda Storie e immagini del
1° maggio. Problemi della storiografia italiana e internazionale, a cura di G. C. Donno, Lacaita, Manduria 1990
50
analfabeti per cui non è possibile altra propaganda che quella parlata», scriveva Ciccotti51 -;
l’ambiente in cui si comunica (un’aula del Parlamento o una piazza per un comizio
elettorale, una festa popolare o una commemorazione funebre, ecc.); il target di riferimento
(un pubblico di notabili o di contadini, di operai o di studenti universitari, di donne o di
uomini, ecc.). Riguardo al contesto socio-politico di riferimento, ha scritto Michele Salvati in
una articolo di recensione ad un libro di Colin Crouch dal titolo Postdemocrazia che oggi
«gli stessi grandi partiti usano sempre di più messaggi ultra-semplificati e semi-populistici,
volti a catturare lampi di momentanea emozione in elettori disinteressati alla politica, non a
coinvolgerli in un ragionamento pacato: ovunque le tecniche della pubblicità commerciale
sommergono il vecchio mondo dei programmi e delle piattaforme elettorali ragionate»52.
Tornando al nostro discorso iniziale sulla propaganda e chiarito il fatto che utilizzare al
meglio uno strumento di propaganda in un sistema democratico non equivale
automaticamente ad avere pretese da Grande Fratello orwelliano e che non si tratta di
un’attitudine appartenente soltanto ad una tradizione reazionaria o totalitaria, ma anche a
movimenti politici e partiti che sono stati bandiere di democrazia, di progressismo e di
avanzamento sociale, bisogna dire che oggi lo stato degli studi su linguaggio e strumenti
della comunicazione politica consente di leggere il fenomeno in maniera più equilibrata 53.
D’altronde, i continui progressi nel campo dell’innovazione tecnologica costringono gli
addetti ai lavori, in primo luogo gli attori della politica, a mantenersi costantemente
aggiornati, così come dimostra l’uso massiccio del web da parte ormai di quasi tutti i partiti
politici, senza distinzione di campo, i quali più che come mezzo di estensione della
partecipazione politica, utilizzano i loro siti come “vetrine” attraverso le quali esporre la
propria immagine, in funzione, appunto, propagandistica54.
51
Ibidem, p. 99.
M. Salvati, Il populismo nei Paesi ricchi e i rischi della post-democrazia, in “Il Corriere della Sera” del 3
novembre 2003. Il libro di Colin Crouch è edito da Laterza.
53
Citiamo alcuni testi di riferimento: C. Dato Giurickovic, Polimatica? L’impatto delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione sulla vita politica, ESI, Napoli, 1990; G. Mannoni, Di Pietro e
Berlusconi: la rivincita del senso comune nell’era tecnologica, Firenze 1994; Linguaggio e politica, a cura di C.
Ciseri Montemagno, Le Monnier, Firenze 1995; La comunicazione politica tra Prima e Seconda Repubblica, a
cura di M. Livolsi e U. Volli, Angeli, Milano 1995; A. Forconi, Parola da cavaliere. Il linguaggio di Berlusconi
dai tempi del potere al tempo dell’opposizione, Ed. Riuniti, Roma 1997; La costruzione linguistica della
comunicazione politica, a cura di D. R. Miller e N. Vasta, Cedam, Padova 1997; G. Mazzoleni, La
comunicazione politica, Il Mulino, Bologna 1998; Il cambiamento imperfetto: i cittadini, la comunicazione
politica, i leader degli anni Novanta, a cura di F. P. Colucci, Unicopli, Milano 1998; S. Bentivegna, Comunicare
in politica, Carocci, Roma 2001.
54
Sull’uso di Internet da parte dei partiti politici si veda F. Grassi, G. Nicolosi, Luci ed ombre della
cyberpolitica: i governi on-line, il partito telematico, in “Storia e Futuro. Rivista Informatica di Storia
Contemporanea”, n° 1, aprile 2002 (www.storiaefuturo.com).
54
Moisei Ostrogorski, nel suo studio della leadership nel partito inglese di fine Ottocento, aveva per primo
individuato la “venerazione” per il leader liberale William Gladstone, dotato di qualità magnetiche e di
52
Infine, un altro aspetto da indagare è di accertare quale sia il rapporto tra il leader (o i
dirigenti del partito) e gli iscritti e i militanti. Se cioè il rispetto e la fiducia verso il capo
dipende da un rapporto di natura politica: se si ritiene che egli meglio serva gli interessi di
partito, ne interpreti con maggior successo la linea, dimostri di possedere maggiori qualità
politiche o se il suo carisma deriva solo dal fatto di rivestire quell’ufficio, come riflesso della
indiscussa autorità ed infallibilità del partito, e nei suoi confronti si venga a creare un culto
della personalità. Il problema della leadership non si è posto soltanto in relazione ai leader
“carismatici” nel contesto dei regimi totalitari o delle cosiddette “democrazie plebiscitarie”.
E’
vero che la questione del rapporto diretto leader-masse si pose nei riguardi del
“cesarismo
bonapartista”
che
costituì
un
tentativo
di
superare
il
modello
del
costituzionalismo censitario. Diverso fu invece il problema dei leader carismatici nei regimi
totalitari. Questi due esempi, che non riguardano i regimi democratici, semmai la loro crisi,
appartengono ad epoche tanto diverse che è anche difficile vedere molti lati comuni ai
“sistemi plebiscitari”. Il problema della leadership si pone in modo assai diverso nei sistemi
democratici, in presenza di partiti moderni. Questo problema fu individuato dagli scienziati
politici di fine Ottocento che studiarono la nascita dei partiti moderni (Ostrogorski; Michels,
Weber)55. Se noi prendiamo in esame le democrazie moderne, che si fondano su sistemi di
partito, dove, aldilà del carisma del leader, non è possibile un rapporto diretto con le masse
di tipo plebiscitario, il problema della leadership si pone in due diversi modelli: quello delle
“democrazie con leader” (sistemi presidenziali
o semi-presidenziali) e quello delle
“democrazie acefale” o meglio a leadership-collettiva (L. Cavalli). Nelle “democrazie con
leader” non vi sono rischi plebiscitari. È opportuno a questo proposito ricordare quanto
scrive Cavalli:
«[…] le dittature totalitarie fra le due guerre si sono imposte nella crisi di democrazie deboli,
“senza leader”, e non in quelle caratterizzate, come il Regno Unito, da una forte leadership
[…] Ma, soprattutto, non si dovrebbe mai dimenticare che la leadership monocratica nelle
democrazie occidentali si può ormai manifestare soltanto entro i solidi limiti posti dalle leggi
e da una coscienza pubblica largamente autonoma, e con il controllo delle verifiche
elettorali. Come è accaduto in Francia […] Sicché quelle preoccupazioni, alla luce della
capacità oratorie. Max Weber aveva descritto l’elemento carismatico nella leadership quale fattore di
produzione della “democrazia plebiscitaria”, individuando un rapporto diretto capo-masse. Michels si riferiva al
“cesarismo plebiscitario” e analizzava in particolare i leaders carismatici della Socialdemocrazia tedesca.
Secondo Michels tale tendenza era il risultato della sopravvivenza di un elemento religioso primitivo: c’era
dunque una continuità del misticismo e della ritualità cristiana nella leadership moderna.
fredda ragione, non hanno oggi ragion d’essere; e restano forti in campo gli argomenti a
favore della democrazia con leader»56.
Il rapporto tra ideologia, cultura, propaganda, mito e leadership è tale da definire alcuni
caratteri distintivi del partito.
Ad esempio, in un partito d’opinione l’ideologia è un elemento “debole”, se non assente o
addirittura contestato, la cultura e la tradizione del partito vengono evocati come semplici
riferimenti ideali ai fini della indicazione di un’identità storica, ma l’elemento fondamentale
su cui si unifica il partito e si articola la propaganda è il programma e la piattaforma
elettorale. Nella propaganda si fa piuttosto riferimento ad elementi razionali e ci si serve di
tecniche prese a prestito dalla pubblicità; la ritualità è molto bassa e semmai risponde alla
esigenze di una società dello spettacolo. La leadership è un elemento importante, ma non
si ricorre al culto della personalità.
In un partito democratico-elettorale di massa, invece, l’ideologia in quanto tale è una
reminiscenza del passato, che continua ad avere un certo fascino, la cultura e la tradizione
hanno molta importanza e spesso finiscono per prevalere sul programma, che ha valore in
quanto è coerente con il passato e ne rappresenta un aggiornamento. Nella propaganda
non si tende a far ricorso ad elementi di carattere irrazionale, ma in ogni caso si deve tener
maggiore conto della psicologia delle masse. La ritualità può essere presente in qualche
misura anche nel partito non ideologico, ed anche una leadership forte ed autorevole è un
elemento necessario. Tale leadership è spesso collettiva, sotto forma di un gruppo
dirigente.
Diversa è ancora la situazione in cui si sono venuti a trovare i partiti unici nei regimi
totalitari. Per essi l’ideologia doveva prevalere sulla cultura, e nella propaganda la
propensione verso la diffusione del mito era irresistibile; molto forte era la ritualità ed
immancabile era il ricorso al culto della personalità.
56
L. Cavalli, Il leader e il dittatore. Uomini e istituzioni di governo nel “realismo radicale”, Ideazione, Roma
2003, p. 98.
Tabella 1 Partiti ed elementi idologico-culturali
Partiti
Ideologia
Partito
Debole/Assente Tradizione/Identità Forte
d’opinione
Partito
Cultura
Programma Propaganda Ritualità Leader
Razionale
Assente Media/Forte
storica
Debole/Media
Importante
elettorale
Prevale
democratico
programma
Media
sul
Diretta
alle Media/
masse
– Forte
Forte
meno
di massa
razionale
Partito
Forte/Prevale
Cultura
Totalitario
sulla cultura
Ideologia
= Debole
Non
Forte
Forte/ Culto
razionale
–
della
ricorso
al
personalità
mito
Elementi organizzativi.
Per quanto riguarda gli elementi più propriamente organizzativi si deve far riferimento al
modello, allo statuto, al programma e alle strutture organizzative del partito.
Il modello di partito è una cosa diversa da quella categoria idealtipica cui abbiamo fatto
inizialmente riferimento (la forma-partito). Esso può essere inteso in modi diversi e ha dato
luogo nei differenti contesti disciplinari a molteplici classificazioni di partito. I partiti possono
essere classificati a secondo della loro formazione, secondo cioè un “criterio genetico” (per
creazione interna o esterna, per diffusione o penetrazione territoriale), a secondo delle
modalità di istituzionalizzazione oppure a secondo del ruolo esercitato nella competizione
tra i partiti e nel sistema politico. Essi possono poi essere classificati dal punto di vista
morfologico e delle caratteristiche organizzative, oppure della loro storia. Se usiamo il
termine modello nel significato di forma storica, allora parleremo di “modello liberaldemocratico”, di “modello socialdemocratico”, di “modello comunista”. Forse più
propriamente si potrebbe utilizzare il termine modello nel significato organizzativoistituzionale
(partito d’opinione, partito democratico-elettorale
organizzativo di massa, partito unico in un regime totalitario).
di
massa,
partito
Lo statuto è la “costituzione” del partito. Come abbiamo avuto modo di vedere, gli statuti in
apertura contengono di norma una parte introduttiva dedicata all’ideologia, ai principi/valori
o alla cultura o tradizione cui si ispira il partito o il movimento, anche se ciò non costituisce
una regola.
Tuttavia, se si tiene conto di questi elementi organizzativi, si può vedere come in un partito
d’opinione abbia poca importanza il riferimento ad un modello, mentre lo statuto sia un
elemento centrale nella vita sociale. In genere, in questi partiti si riscontra una scarsa
centralizzazione delle decisioni, una maggiore autonomia delle organizzazioni periferiche,
la minore consistenza degli apparati permanenti, la scarsa presenza o l’assenza di
“professionisti della politica”, una maggiore democrazia interna, il riconoscimento della
libertà di coscienza e l’assenza di un rigore disciplinare, salvo in caso di gravi infrazioni. In
un partito d’opinione, la cui espressione maggiore è quella della partecipazione alle
elezioni, prevalgono le contribuzioni esterne, di solito versate localmente.
Nel partito democratico di massa, l’importanza del modello è più grande, ma il rispetto
dello statuto non è inferiore a quello che dimostra un partito d’opinione. L’organizzazione di
un partito democratico elettorale di massa può contare su di una forte e capillare
organizzazione locale, che utilizza sia funzionari pagati che agenti volontari. Ha un ufficio
centrale che ha funzioni di coordinamento; può servirsi di un quadro di funzionari, il che non
contraddice la democrazia interna, anche se la minoranza è tenuta a rispettare le decisioni
della maggioranza e la disciplina esterna. Il partito democratico di massa ricorre in parte
all’autofinanziamento, in parte a finanziamenti privati.
I partiti organizzativi di massa hanno una struttura fortemente centralizzata e un forte
apparato burocratico.
Nei partiti unici dei regimi totalitari, il modello prevale nei riguardi dello statuto, la cui
osservanza è solo formale. Manca una democrazia interna, in quanto i suoi componenti
non solo devono rispettare la disciplina all’esterno, ma devono allinearsi alla linea del
gruppo dirigente se non
vogliono
passare
per frazionisti. La formula impiegata dai
comunisti per giustificare questa regola, come abbiamo visto, era il cosiddetto “centralismo
democratico”, ma altrettanto avveniva nei partiti fascisti o nazisti. Nei partiti totalitari, il culto
della personalità o il “Fuehrer Prinzip” era una regola . Per quanto riguarda il finanziamento
dei partiti unici, esso era prevalentemente pubblico, anche se non mancavano le
quotizzazioni degli iscritti.
Tabella 2 Partiti ed elementi organizzativi
Partiti
Modello Statuto Organizzazione Democrazia Disciplina
Finanziamento
Interna
Partito
Debole
Forte
Leggera
Maggiore
Debole/Media Esterno
Forte
Meno
Media/Forte
Media
Media/Forte
d’opinione
Partito
elettorale di
Forte
Contribuzioni
massa
Partito
Autofinanziamento/
private
Forte
Debole Forte
Assente
Forte
Pubblico
Totalitario
Elementi sociologici
Grande importanza nella caratterizzazione di un partito ha la sua composizione sociologica.
Uno studio dei parlamentari e dei dirigenti per quanto riguarda la situazione economica,
l’estrazione sociale, la provenienza geografica, la formazione culturale e la situazione
professionale è assai significativa per comprendere non tanto quelli che possono essere i
comportamenti politici, quanto a stabilire quale rapporto il gruppo dirigente ha con le classi
dominanti del paese da una parte, e, dall'altra, con gli iscritti che rappresentano. Molto
spesso accade che i dirigenti dei partiti “operai” provengano dalla piccola e media
borghesia, in qualche caso anche dall’alta borghesia. Ciò non contraddice necessariamente
il carattere di classe del partito, in quanto alla base dell’adesione del singolo dirigente al
partito può esserci stata una scelta di campo ed una rottura con la classe di origine. Più
significativa dell’origine sociale, è il comportamento politico di questi dirigenti di estrazione
borghese. D’altra parte, in origine questi ultimi hanno svolto un ruolo di supplenza nei
confronti di una nuova classe politica. Naturalmente più produttiva, è un’analisi statistica dei
quadri intermedi e del corpo del partito ed infine dell’elettorato che gravita attorno al partito.
Il dato sociologico rischia di essere spesso in contraddizione con la politica di un partito ed
anche con la funzione di classe che essi dichiarano di svolgere.
Conclusioni
In conclusione, l’analisi dei caratteri del partito cui abbiamo fatto cenno deve riguardare la
cultura e rivelare se si tratti di un partito ideologico che privilegi i valori rispetto agli
interessi e sia portatore di una diversa visione del mondo, conservando la speranza di poter
produrre un cambiamento radicale della società. Al contrario, si tratterebbe di un partito
pragmatico, che mette in primo piano la tutela degli interessi e si pone come obiettivo la
gestione del potere. Da questo punto di vista, si può trattare di un partito che non intende
cambiare le regole del gioco, anzi sia del tutto soddisfatto del sistema e lo intenda
conservare nei suoi aspetti migliori o che, pur rispettando le regole, voglia operare in modo
gradualistico, per cambiare in senso innovativo gli equilibri politici e sociali o un partito che
intenda promuovere un cambiamento radicale del sistema e che ha una concezione
integralistica e totalitaria della politica. I partiti possono su questa base essere classificati
come conservatori, riformisti o rivoluzionari o, se volete, totalitari.
Se, invece, si prendono in esame i modelli storici cui si ispirano, essi possono partiti
liberaldemocratici, socialdemocratici, comunisti, ecc. Se si tiene conto del loro statuto e
si vede come si risolve il rapporto tra maggioranza e minoranze, individuando se vi sia il
riconoscimento della liceità dell’organizzazione delle correnti, allora si potrà dedurre se ci
troviamo dinanzi ad un partito che garantisce o meno la democrazia interna. Se si parte
da un’indagine sull’organizzazione interna si potrà concludere se il partito abbia
un’organizzazione forte o debole. Se, invece, ci si sofferma a considerare il modo con cui
è risolto il rapporto tra centro e periferia, si potrà concludere se ci troviamo di fronte ad
un’organizzazione più o meno accentrata, se le unità territoriali periferiche siano dotate
di grande autonomia potremo parlare di un partito di tipo federalista e ciò vale soprattutto
quando il partito risulti dalla federazione di sezioni, circoli culturali ed associazioni di
categoria tra di loro indipendenti, ma collegate con il partito. Se si guarda al numero degli
iscritti e alle dimensioni del partito potremo parlare o meno di partito di massa.
Inoltre, lo studio di un partito non può limitarsi alla sua storia “interna”, perché si deve aver
riguardo anche dei suoi rapporti con il movimento. In realtà, bisogna analizzare quale
rapporto ci sia tra il partito e la sua area militante, con i simpatizzanti e con gli elettori. Un
partito può essere scarsamente interessato ad aumentare gli iscritti, mentre invece si
sforza di aggregare consensi attorno alle sue campagne politiche, tenendo cioè ad
avere pochi iscritti e molti simpatizzanti. In questo caso, si tratterà di un partito
d’opinione. Se, al contrario, tenderà a far divenire militanti i suoi simpatizzanti si avrà
un partito d’integrazione. Se, invece, il partito non intende aumentare il numero dei suoi
simpatizzanti o dei suoi sostenitori esterni, ma si contenterà di formare i suoi dirigenti si
tratterà di un partito di quadri. Se, infine, si preoccuperà soltanto di incrementare le sue
fortune elettorali ed agirà solo nel contesto parlamentare si dirà che si tratta di un partito
elettorale di rappresentanza individuale. Da un simile studio, possono emergere alcuni
elementi importanti riguardo alla capacità di mobilitazione, all’efficienza elettorale e politica
di un determinato partito ed al suo coefficiente di sociabilità. L’individuazione di questo
rapporto può servire quindi a rilevare quale funzione svolge il partito rispetto agli iscritti o
all’area militante o agli elettori, così come risulta dalla sintesi della tabella che segue:
Tabella 3 Partiti e scritti/area militante/elettori
Partiti
Rapporto
Livello di
Funzione
interesse
Partito d’opinione
a) dirigenti - iscritti
a) scarso
Partito di
b) dirigenti - area
b) moderato
rappresentanza
militante
c) massimo
individuale;
c) dirigenti - elettori
Partito parlamentare
Partito democratico di
a) dirigenti - iscritti
a) moderato
massa
b) dirigenti - area
b) massimo
militante
c) massimo
Partito d’integrazione
c) dirigenti - elettori
Partito totalitario
a) dirigenti - iscritti
a) scarso
b) dirigenti - area
b) massimo
militante
c) scarso
Partito di quadri
c) dirigenti - elettori
Il rapporto tra partito e “movimento”, inteso come area di insediamento sociale, come
spazio politico-elettorale e come area culturale non va visto soltanto in un quadro
atomistico, dove cioè compaiono, da una parte, l’organizzazione politica, dall’altra, degli
individui che siano iscritti, militanti, sostenitori, simpatizzanti od elettori, titolari di diritti,
aspettative e doveri via via più attenuati a seconda dell’impegno che queste categorie di
cittadini si assumono nei riguardi del partito. C’è da considerare il tipo di collegamento che
si stabilisce tra quest’ultimo e le organizzazioni sindacali, associazioni culturali o di
categoria, movimenti femminili, giovanili, ambientalisti. Questi rapporti possono essere di
completa autonomia reciproca; oppure vi può essere un collateralismo tra associazioni
fiancheggiatrici e partito, che si serve di questi strumenti come sue “cinghie di
trasmissione”; vi può essere, al contrario, una preminenza di queste associazioni
sull’organizzazione politica.
A titolo esemplificativo, possiamo ricordare che nell’Italia repubblicana lo statuto del Partito
Radicale del 1967 prevedeva proprio un modello di partito federativo articolato in partiti
regionali e associazioni radicali, che potevano costituirsi per perseguire finalità «politiche,
culturali, sindacali o altre autonomamente determinate». In quel modello, era prevista
anche l’adesione di associazioni non radicali, che potevano anche non iscriversi al partito e
per un periodo limitato nel tempo e prefissato. Durante il dibattito statutario emerse il
concetto che fossero le associazioni a fungere da organi periferici del partito, ma con una
differenza sostanziale rispetto alle sezioni, ai circoli o alle federazioni dei partiti tradizionali:
riguardo ad esse, infatti, lo statuto del partito garantiva l’autonomia di azione e
l’autoregolamentazione e, elemento essenziale, esse non avevano una delimitata
competenza territoriale, tant’è vero che nello stesso ambito potevano coesistere più
associazioni con obiettivi diversi ed in linea di principio sia le associazioni che i partiti
regionali avrebbero dovuto intraprendere iniziative politiche non locali, cioè di carattere
nazionale o internazionale. L’idea era insomma quella di creare «non delle associazioni di
partito, ma un partito di associazioni», nell’esigenza di aprire il partito verso l’esterno e
sfruttare più canali attraverso i quali convogliare la domanda politica. Giocava a favore di
quel tipo di organizzazione l’esperienza positiva della LID, la Lega Italiana per il Divorzio,
che era stato appunto un modello di organizzazione di massa sulla quale si era registrata la
convergenza di elementi di diversa affiliazione partitica ed alternativa rispetto alle strutture
tradizionali. Una struttura federale che prevede la presenza di organi di partito ‘locali’
(Divisional Labour Parties) ed associazioni di natura politica (come la Fabian Society),
cooperative o sindacali è quella del Partito Laburista inglese, a cui infatti sembra che
abbiano guardato i Radicali di Pannella al tempo dell’elaborazione del loro primo statuto57.
57
Per lo statuto del secondo Partito Radicale si veda M. Teodori, P. Ignazi, A. Panebianco, I nuovi radicali.
Storia e sociologia di un movimento politico, Mondadori, Milano, 1977. Sul dibattito statutario: G. Nicolosi, Il
secondo Partito Radicale. Idea di partito e organizzazione, relazione al convegno “I Partiti politici nell’Italia
repubblicana”, Siena 5-6 dicembre 2002, atti in corso di pubblicazione. La relazione è al momento disponibile
nella sezione “attualità politica” del sito www.radioradicale.it.
Il partito nell'ordinamento costituzionale
Si è già ampiamente messo in rilievo come il partito sia “funzione” del sistema politico. La
società politica è formata dallo Stato, dalla Amministrazione Pubblica, dai poteri locali e dal
sistema dei partiti.
Occorre, in primo luogo, approfondire quale sia la valutazione dell’ordinamento
costituzionale nei confronti dei partiti. A questo riguardo, l'ordinamento può avere un
atteggiamento di ostilità (Bekampfung), indifferenza (Ignorierung), riconoscimento giuridico
(Anerkennung und Legalisierung) e inserimento nell'organizzazione statale (Inkorporation)
(Triepel). Di conseguenza, i partiti possono essere vietati, tollerati, non avere una loro
personalità giuridica ed essere considerati delle società di fatto senza il bisogno di essere
riconosciuti; avere una loro personalità giuridica ed essere degli enti di natura privatistica
(per la cui esistenza si richieda un'autorizzazione) o avere carattere pubblicistico e, nel
qual caso, i partiti possono essere considerati degli enti ausiliari o addirittura organi dello
stato. Il trattamento giuridico del partito dipende dal tipo di ordinamento e/o dal tipo di
sistema politico, dalla visione più o meno liberale che il legislatore costituzionale dimostra
di avere in materia di libertà d’associazione, può , inoltre, dipendere da quella che è la
teoria
della rappresentanza e, infine,
da quelle che sono le tradizioni politiche di un
determinato paese. La fase dell'ostilità nei confronti dei partiti politici fu comune all'inizio a
molti ordinamenti. In verità, la concezione individualistica dei diritti politici, prevalsa con la
rivoluzione francese, e la stessa idea del sistema rappresentativo allora prevalente, si
scontrava con la formazione di associazioni politiche, che erano considerate come “società
speciali”, che si interponevano tra il cittadino e lo stato, mettendone in pericolo l’unità e la
sovranità. Seguì una fase di “tolleranza” in cui si riconobbe che il
era fondato sulla
sistema parlamentare
libera competizione di organizzazioni politiche ed elettorali,
ma si
riteneva che esse facessero parte della sfera privata e per questo non dovessero essere
soggette a controllo pubblico se non contravvenivano alla legge. Successivamente, si prese
atto che i partiti politici, pure rimanendo nella sfera privata, esercitavano una funzione nella
formazione di organi pubblici come le assemblee rappresentative, vista la loro opera nella
designazione dei candidati e la loro partecipazione alle campagne elettorali. Questa
funzione di “creatori di organi” che i partiti assolsero nel sistema parlamentare pose il
problema della acquisizione della personalità giuridica e del controllo pubblico sulle
associazioni politiche. Infine, date le funzioni svolte dai partiti, si giunse in qualche caso
anche alla loro incorporazione nell’ordinamento costituzionale, attribuendo loro uno statuto
pubblico.
L’evoluzione della disciplina delle associazioni politiche nell’ambito del più generale diritto
di associazione, che fu, a sua volta, filiazione di quello di riunione, ebbe fasi diverse nei
differenti ordinamenti occidentali ed arrivò anche a sbocchi tra di loro differenziati.
In Francia, nel periodo rivoluzionario, dopo un’iniziale incertezza, le associazioni vennero
proibite. Nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 26 agosto 1789 non si menzionava
esplicitamente il diritto di associazione. La legge del 13 e 19 novembre 1790, oltre al diritto
di riunione, riconosceva la libertà di formare “società libere purché osservassero le leggi
che reggevano tutti i cittadini”. Il che portò alla straordinaria fioritura dei clubs. Già con la
legge 18-22 maggio 1791 venne vietata la costituzione di associazioni. Con la Costituzione
del 1791 venne sancita la libertà di riunione, ma venne contemporaneamente formalizzato il
divieto
di
votare
petizioni,
costituire
delegazioni
sostituendosi
alle
istituzioni
rappresentative. Con il decreto 16 ottobre 1794, pur con molte limitazioni, venne ammessa
la liceità delle associazioni, che tuttavia vennero proibite successivamente dalla
costituzione del 1795. Anche durante il periodo napoleonico si faceva una distinzione tra
diritto di riunione e quello di associazione. L’ostilità, quindi, perdurò e venne aggravata con
la Restaurazione. Nel Secondo Impero, la costituzione non assicurava il diritto di
associazione, ma prevedeva soltanto quello di riunione, sottoponendolo all'autorizzazione
preventiva di polizia. Sino alla soglia degli anni ’80, le associazioni politiche erano vietate.
I progetti di legge presentati alla Camera nello scorcio di secolo non portarono ad una
definizione del problema. Con la progressiva attenuazione delle leggi repressive dei clubs
il fenomeno trovò nella legge del 1901 una soluzione
contrattualistica, in quanto le
associazioni politiche vennero omologate a quelle di diritto comune. É soltanto verso la fine
della III^ Repubblica che i partiti acquisirono una loro legittimazione, in particolare, con la
Résolution del 1 luglio 1910 sul riconoscimento dei gruppi parlamentari e con la successiva
legge del 12 luglio 1919, che introduceva lo scrutinio di lista (Kheitmi).
Anche in Gran Bretagna, il diritto di associazione non fu conquistato senza grandi lotte. Tra
il 1794 ed il 1831, le associazioni vennero proibite ed in alcuni casi l' “habeas corpus”
venne sospeso nei riguardi, prima, dei dirigenti delle associazioni democratiche e, poi,
dell'Associazione cattolica d'Irlanda. Il principio su cui si basava l’ostilità dell’ordinamento
era la convinzione che quelle
associazioni tendevano a sostituire il parlamento come
corpo rappresentativo e a usurpare i poteri di un organo depositario della sovranità
nazionale. Tale posizione fu riaffermata anche nei confronti della Unione di Birmingham,
che mirava a «formare un’associazione tra
le
classi
inferiori e
le
classi
medie»,
adottando una organizzazione nazionale fondata sul sistema dei caucus. La Camera dei
Lords sostenne che «le associazioni, composte di corpi separati, con diverse divisioni e
suddivisioni, con capi gerarchicamente organizzati e distinti, soggette al controllo e alla
direzione di un consiglio superiore, erano illegali ed incostituzionali». A partire dagli anni ‘70
dell’800, a seguito delle lotte sostenute per il diritto di associazione, in Gran Bretagna si era
stabilita una fitta rete di società politiche e per la legge inglese i cittadini conquistarono il
diritto di formare liberamente associazioni. Nel 1877, in risposta a due interrogazioni degli
onn. Bowyer e Chamberlain, rispettivamente per i liberali ed i conservatori, l’Attorney
General58 rispose che, «non cadendo le associazioni politiche sotto l’applicazione della
legge, egli non intendeva perseguirle, né consultare i giureconsulti della corona» e che le
leggi repressive ed in particolare l'Atto del 1799 erano giustificate dalla situazione politica
del
tempo
ed
erano
dirette
ad
impedire
e
sciogliere
delle
società
segrete.
L’associazionismo è da quel momento divenuto la base dell’educazione politica ed il
fondamento della società civile inglese.
La Germania è stato il paese europeo che dimostrò la maggior larghezza di vedute in
materia di diritto di associazione, anche se sottopose le associazioni politiche al controllo
dello stato. Sino al 1830 non vi furono restrizioni alla libertà di riunione. Con il decreto
federale del 1832, vennero proibite le “associazioni politiche”. Nella costituzione tedesca
del 1848, nel terzo paragrafo dell'art.7, si disponeva che «i tedeschi hanno diritto di formare
associazioni. Questo diritto non deve essere limitato da alcuna disposizione preventiva». Il
fallimento della rivoluzione del 1848 portò ad una restrizione del diritto di associazione, ma
nel 1858, la legge sassone prevedeva che «non ci fosse bisogno di autorizzazione per
costituire associazioni. Queste non acquistavano la personalità giuridica che in virtù di una
concessione espressa dello stato». Le altre legislazioni statali finirono
questo
per uniformarsi a
principio e l’ordinamento tedesco recepì la regolamentazione statale. A parte
alcune leggi eccezionali contro i socialisti ed i cristiano-sociali, la libertà di associazione fu
quindi garantita, anche se l'esistenza delle associazioni fu subordinata al riconoscimento
statale.
Negli Stati Uniti, la libertà di associazione nel campo politico fu sempre illimitata e
l'esistenza di un vasto reticolo di associazioni è da considerarsi una delle caratteristiche
58
Il Procuratore Generale
fondamentali della democrazia americana. Tocqueville riconosceva che negli Stati Uniti «la
libertà di associazione è
diventata una garenzia necessaria contro la tirannide della
maggioranza».
In Italia, prima del 1848, gli ordinamenti degli Stati preunitari furono marcati dall'ostilità
verso le associazioni politiche. Lo Statuto albertino, all'art. 32, riconosceva il diritto di
riunione: «É riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente senz'armi, uniformandosi alle
leggi che possono
regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa
disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici o aperti al pubblico, i quali
rimangono soggetti alle leggi di polizia».
Nello Statuto, divenuto con l'Unità la costituzione del Regno d'Italia, non vi era nessuna
disposizione che facesse espresso riferimento al diritto di associazione. Con la
promulgazione dello statuto venivano, però, aboliti anche quegli articoli del codice penale
sardo, ispirato alla legislazione francese, che vietavano le associazioni politiche.
L’abrogazione di tali articoli avvenne sulla base del riconoscimento da parte del legislatore
della contraddizione tra queste disposizioni ed il “nuovo ordine politico” (Decreto Reale del
26 settembre 1848). La dottrina dominante riteneva che il diritto di associazione fosse
implicitamente riconosciuto, anche se la sua disciplina doveva poi essere affidata ad una
legge ordinaria (Brunialti). Si osservava, inoltre, che la libertà di riunione si doveva
considerare come una delle più preziose guarentigie costituzionali, anche perché «il nostro
diritto pubblico non si può far consistere tutto nella lettera o nello spirito di un articolo del
medesimo o di leggi speciali, bensì emana dal complesso sviluppo della vita pubblica,
traverso al quale appunto
dobbiamo ricercare in qual modo sia intesa presso di noi
codesta grande libertà» (Ferracciu). Alla Camera italiana venne a più riprese discusso il
problema di regolamentare le associazioni, non mai per vietarle dato che, da parte del
Parlamento, venne sempre riconosciuta questa libertà costituzionale, né per introdurre un
controllo preventivo, ma semmai per prevedere dei limiti a queste organizzazioni e facilitare
la repressione di quelle società che propagandavano “principi
contrari allo statuto e
all'ordine pubblico”. Il governo Rattazzi, affermando il suo diritto a sciogliere le associazioni
“pericolose” mise fuori legge, nell'agosto 1862, le “Società emancipatrici” che sostenevano
l'iniziativa di Garibaldi. I successivi governi della Destra, con l'approvazione o senza
l'approvazione del Parlamento, sciolsero le associazioni che ritenevano “pericolose”. I
gabinetti di Sinistra non seguirono una linea diversa, basti pensare allo scioglimento delle
organizzazioni anarchiche da parte del Ministro Nicotera nel 1877. Nel 1878-1879, si ebbe
alla Camera un dibattito sulla opportunità dello scioglimento preventivo di associazioni, per
evitare la perpetrazione di reati e
di atti tendenti a comportare turbamenti dell'ordine
pubblico, il che avrebbe inevitabilmente reso
necessaria la introduzione di
un'autorizzazione preventiva dell'autorità di polizia per la costituzione di un'associazione.
Tale impostazione, portata avanti da alcuni esponenti della Destra (Minghetti e Bonghi) fu
confutata sia da Cairoli che da Zanardelli, i quali sostenevano che lo statuto non dava al
potere esecutivo la facoltà di vietare preventivamente le riunioni, né di sciogliere le
associazioni pericolose, ma soltanto quella di deferirle all'autorità giudiziaria quando si
aveva sentore di reato e che spettava a quest'ultima il potere di reprimerle. Cairoli e
Zanardelli dovettero lasciare il potere perché la Camera respinse un o.d.g. sul quale il
governo chiedeva la fiducia. Il 3 aprile 1879, Depretis, prendendo lo spunto dalla attività
propagandistica delle organizzazioni repubblicane, dichiarava la posizione del governo in
ordine alle associazioni politiche: «Nessun provvedimento
finché queste associazioni
rimangono nel campo speculativo [...] Se escono dal campo speculativo ed entrano in
quello dell'azione [...], il governo deve alla sua volta riservare la sua libertà d’azione per
reprimerle. Il dovere che il governo si
impone
“è quello di
esercitare” un’immediata
repressione all’apparire di qualsiasi fatto che a termini delle leggi vigenti costituisca reato o
l’evidente preparazione a commettere un reato». La Camera, prendendo atto delle
dichiarazioni del Presidente del consiglio approvò un ordine del giorno che “riaffermava
l'inviolabilità del diritto d’associazione”. Spaventa, nel suo celebre discorso sulla “Giustizia
nell’Amministrazione”, qualificò l’interpretazione dell'art. 32 da parte di Depretis un «arbitrio
mostruoso» quello di sottoporre alla repressione preventiva della polizia gli atti preparatori
non qualificati come reati dalla legge penale. Spaventa non contestava il diritto di sciogliere
associazioni pericolose. Nella prassi amministrativa si conoscono in quel periodo lo
scioglimento di alcune associazioni irredentiste tra il 1889-1890. Nel
1891, venne
esaminata la opportunità di vietare le organizzazioni anarchiche. Tale legge non fu
necessaria, perché la magistratura le qualificò, a termine dell'art. 248 del codice penale,
«associazioni di malfattori». A seguito dei Fasci siciliani, vennero votate dal Parlamento tre
contestatissime leggi eccezionali: una diretta a reprimere le attività degli anarchici; l'altra
contro l'apologia dei reati commessi a mezzo stampa; la terza che vietava “le associazioni
che avevano per oggetto di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali”. Quest'ultima
legge mirava a colpire i socialisti.
Queste leggi avevano carattere provvisorio perché
venivano a termine il 31 dicembre del 1895 ed i tentativi di inserirle nell'ordinamento trovò
una opposizione vincente, non solo da parte della opposizione di sinistra, ma anche da
parte delle correnti più liberali della Camera. La svolta liberale del 1901 consolidò il diritto di
associazione e mise al riparo le associazioni politiche dalla repressione. Nel corso dell'età
liberale non vi fu una regolamentazione legislativa dei partiti, né furono approvate norme
per il loro riconoscimento. I partiti venivano considerati come delle associazioni di fatto. Nel
primo dopoguerra, si giunse quasi alla soglia del riconoscimento, che non fu mai varcata,
ma, come osservò qualche giurista, l'introduzione del suffragio universale e del sistema
elettorale proporzionale ed il riconoscimento dei gruppi parlamentari da parte dei
regolamenti della Camera, nel 1920, avrebbero potuto aprire la strada per un cambiamento
nell'atteggiamento dell'ordinamento costituzionale verso i partiti. Alcuni giuristi, sulla base
delle trasformazioni indotte dalle riforme elettorali e dalle stesse modificazioni della formapartito, ed, in una parola, in considerazione della nascita di una democrazia dei partiti,
avevano preconizzato un mutamento anche del quadro legislativo relativo alla disciplina
delle associazioni politiche.
Gabriele Ambrosini riteneva che la nuova legge elettorale
avesse introdotto un nuovo tipo di “rappresentanza proporzionale”, che costituiva il
superamento della rappresentanza politica fondata su di una concezione individualistica
59
.
Questo nuovo tipo di rappresentanza postulava il riconoscimento di nuovi soggetti collettivi:
i partiti politici. Dal
riconoscimento dei diritti politici individuali si doveva passare al
riconoscimento del diritto di associazione. Del resto, sul terreno economico questo diritto di
associazione era stato riconosciuto nei confronti dei sindacati. La concezione atomistica
della rappresentanza cozzava con l'esperienza politica moderna, segnata dall'emergere
dei grandi partiti. Se la vecchia teoria della rappresentanza aveva consentito che i deputati
da “espressione della volontà popolare” diventassero “commissionari degli interessi privati
dei loro elettori”, il passaggio alla proporzionale aveva fatto sì che i parlamentari non
fossero più i rappresentanti di singoli elettori, ma di “gruppi omogenei di elettori costituiti
dall'insieme delle persone che erano concordi nelle stesse idee e che si associavano
volontariamente per propagandarle ed attuarle, dando vita ai partiti politici”. La riforma
elettorale del 15 agosto 1919 apportava, perciò, nell'ordinamento costituzionale - secondo
Ambrosini - «una innovazione profonda». In
base a questa riforma, «i partiti politici
diventavano o dovevano diventare in luogo degli individui il fulcro della vita politica e
costituzionale». Sempre per Ambrosini, l'azione dei partiti non doveva esaurirsi nella lotta
59
Cfr. G. Ambrosini, Partiti politici e gruppi parlamentari dopo la proporzionale, Firenze, La Voce, 1921, pp. 15
sg.
Secondo Ambrosini, il principio individualistico atomistico, non era divenuto soltanto anacronistico, ma
«portava anche al dissolvimento della vita politica e alla degenerazione del regime parlamentare. Da ciò,
l’assenza di veri programmi nelle lotte politiche ridotte spesso a pure competizioni personali o di campanile, la
mancanza di ordine e di senso di responsabilità nel funzionamento della Camera, l’abbassamento della
sincerità e del carattere degli elettori e degli eletti, ed il trionfo dell’incompetenza, del personalismo e
dell’affarismo del regime parlamentare in genere»
elettorale:
«I partiti hanno bisogno di conquistare il potere per realizzare, almeno in parte il
programma [...]I partiti senza porsi il problema della conquista del potere sono destinati a
sfasciarsi. I partiti per loro stessa natura e ragion d'essere non possono limitarsi alla
propaganda delle idee, ma debbano contemporaneamente lottare per realizzarle lottare per
la conquista del potere».
La legislazione eccezionale del 1925, con la quale vennero sciolti i partiti democratici,
comportò una restrizione del diritto di associazione così come si era sviluppato nella
consuetudine dell’età liberale. Santi Romano, esemplificando la tipologia delle associazioni,
ne distingue tre categorie: quelle vietate (le associazioni sovversive ed antinazionali, quelle
che cospirano contro la personalità dello stato, le associazioni segrete); quelle permesse
(le società civili e commerciali, regolate dalla legge, le fondazioni ecc.) ed infine quelle né
ammesse né vietate (come le associazioni politiche non rientranti nella prima categoria).
Le leggi fascistissime limitavano di fatto la libertà di associazione
alle associazioni
permesse e, conseguentemente, tale diritto veniva negato ad ogni tipo di associazione
politica. Con lo scioglimento degli altri partiti, sulla base della legge di pubblica sicurezza
perché contrarie all’ “ordine nazionale dello stato”, e la instaurazione dello stato totalitario,
il PNF divenne il partito unico. Santi Romano, poteva affermare nel suo “Corso di Diritto
costituzionale” che «conseguenza di siffatta posizione assunta dal Partito è stata la sua
progressiva trasformazione ormai completa, da semplice associazione privata, qual'era
quando sorse, in una istituzione pubblica, non solo in senso politico, ma anche in senso
giuridico, il che vuol dire che esso è stato, come suol dirsi inserito o inquadrato nello
Stato». Si tratta di un caso di “Inkorporation”. Il PNF venne considerato un ente di diritto
pubblico, organo ausiliario dello stato, al quale fu attribuita personalità giuridica.
Nell’ordinamento provvisorio, instaurato all’indomani della caduta del fascismo venne
riconosciuta una certa “soggettività” ai partiti (Crisafulli) e la partecipazione dei partiti a
“funzioni di governo” nel quadro dei CLN venne interpretato da alcuni giuristi come
l’esercizio di “un ruolo costitutivo del nuovo ordinamento costituzionale” (Ferrara).
Nella
costituzione repubblicana, il diritto di associazione è riconosciuto all'art. 18, che
recita: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che
non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle
che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere
militare».
Il problema del riconoscimento dei partiti venne discusso all'Assemblea Costituente senza
che si giungesse ad una soluzione legislativa. Nell'art. 49 si riconosce, tuttavia, la funzione
politica dei partiti a fare da tramite tra gli elettori ed il parlamento, di costituire un canale di
raccolta del consenso e di concorrere così a «determinare la politica nazionale» 60. L’unico
limite che si poneva all'esistenza dei partiti era che nel loro statuto si riconoscesse che
nelle competizioni politiche i partiti stessi si impegnavano a rispettare il metodo
democratico. All'art. XII delle disposizioni transitorie
si vietava la «riorganizzazione,
sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista». Il che consentì lo scioglimento di alcune
organizzazioni neofasciste (Legge Scelba), unico esempio di intervento
repressivo del
governo della Repubblica. I partiti, dal punto di vista giuridico sono da considerarsi delle
“associazioni di fatto” e non godono di personalità giuridica. Tale basso profilo giuridicoformale contrasta con il ruolo assunto dal partito sia nei regolamenti parlamentari, che nella
stessa vita politico-costituzionale del paese. Questa contraddizione si è drammaticamente
rivelata quando
si è voluto concedere un finanziamento pubblico dei partiti e,
contemporaneamente, si è cercato di disciplinare il finanziamento privato. Ciò avvenne con
la legge 2 maggio 1974 n. 195 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici,
a cui seguì una serie di leggi di modifica. Non aver risolto il problema del riconoscimento
costituzionale dei partiti ed aver voluto conservare il loro carattere privatistico, la stessa
mancanza di personalità giuridica61 delle associazioni politiche hanno creato problemi di
funzionalità interna delle organizzazioni politiche (impossibilità di garantire la correttezza
del processo di nomina dei dirigenti e la trasparenza e l’autenticità dei bilanci e di poter
individuare responsabilità civile e patrimoniale dei dirigenti). Ancora maggiori problemi sono
stati creati per l'intero sistema politico ed anche condizionamenti gravissimi per l'economia
nazionale. La crisi che ha investito il sistema dei partiti in Italia nei primi anni ‘90,
determinata, da una parte, dalla loro eccessiva invadenza nella gestione del potere e,
dall'altra,
dalla
mancanza
di
responsabilità
democratica,
postulerebbe
una
costituzionalizzazione dei partiti. Una legge costituzionale di disciplina dei partiti potrebbe
portare, con il riconoscimento pubblico, ad un ridimensionamento delle
loro attività
extraistituzionali ed, insieme, ad un controllo sul funzionamento dei meccanismi democratici
al loro interno.
Aldilà delle prescrizioni della costituzione formale, la funzione dei partiti può avere una
rilevanza maggiore di quella prevista dalla norma scritta e ciò può dipendere dalla prassi
60
«Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale» (Art. 49 Cost.)
61
Si ricorda che una delle caratteristiche proprie delle persone giuridiche è “l’autonomia patrimoniale”, cioè il
fatto che il patrimonio della persona giuridica rimane nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti.
costituzionale, dalle consuetudini e regolamenti parlamentari o dal diritto amministrativo.
Aldilà di quella che può essere la valutazione dell'ordinamento nei riguardi dei partiti sul
piano giuridico-formale, molto dipende anche dall'atteggiamento dei partiti
verso
l'ordinamento costituzionale. Vi sono, infatti, partiti che hanno contribuito a fondare un
sistema politico-costituzionale o lo sostengono e sono disposti ad operare nel suo quadro;
partiti che rifiutano il riconoscimento perché temono l'ingerenza dello stato nella vita interna
del partito; partiti che si pongono al di fuori o contro l'ordinamento costituzionale. Vi sono
perciò partiti “costituzionali”, in quanto professano la loro fedeltà all'ordinamento; partiti
“anticostituzionali” o “sovversivi”, che si oppongono al sistema. Essi possono operare
apertamente quando, pur contestando il sistema, non mettono in opera nessun atto illecito
per sovvertire l'ordine costituito. L’ordinamento può riconoscere ai partiti una libertà così
ampia da permettere anche il diritto di contestare le istituzioni nel quadro di una concezione
molto tollerante della libertà di opinione. In altri ordinamenti, invece, sono contenute norme
di “autodifesa”, per le quali vanno perseguiti quei partiti che non dichiarano la loro fedeltà
al sistema. In questo caso, questi partiti sono dichiarati illegali e se vogliono esistere
devono lavorare nella clandestinità. In definitiva, però, quale che sia l'atteggiamento del
partito verso l’ordinamento costituzionale, la posizione giuridica delle associazioni politiche,
può oscillare tra l’ “indifferenza” e l’ “incorporazione”. Si deve tener presente anche in
quest’ultimo caso che il partito dà luogo ad un ordinamento speciale ed è comunque
sottoposto, quale che sia la sua autonomia interna, all’ordinamento statuale.
Partiti, gruppi di pressione (lobbies), gruppi di pubblico interesse
I partiti moderni tendono a dismettere, per quelli che ne avevano una, la loro connotazione
e funzione di classe come il loro rigido credo ideologico e a dimostrarsi sempre più
pragmatici. I partiti tendono ad essere sempre meno “partiti verità” e sempre più “partiti di
interessi”. I partiti tendono a difendere sempre meno interessi di classi e si caratterizzano
in base a chiari programmi economici. Vi sono partiti che riconoscono la necessità
dell’intervento dello stato nell’economia, altri che lo avversano o, infine, altri che lo
accettano, ma a determinate condizioni. Vi sono, infatti, partiti che
economiche di tipo dirigistico o di tipo liberistico;
hanno visioni
vi sono partiti che si battono per la
nazionalizzazione dei mezzi di produzione e sono partigiani di una politica di piano più o
meno rigida
con qualche concessione all’autogestione delle imprese; partiti che, al
contrario, ritengono che l’economia debba essere governata dalla “mano invisibile” del
mercato. Vi sono, poi, partiti che pur riconoscendo l’esigenza di preservare il meccanismo
di mercato accettano l’idea di una programmazione economica. Questi ultimi sono perciò a
favore di un’economia mista in cui il settore privato sia in concorrenza con un settore di
proprietà o a gestione pubblica. Una forma intermedia è quella delle public companies,
società a gestione pubblica ma con un diffuso azionariato privato. Vi sono partiti che
ritengono che i settori economici debbano essere tre: quello privato, quello pubblico e
quello cooperativo.
Tra i partiti che si battono per la libertà di mercato e avversano l’idea di uno “stato
imprenditore”
ve ne sono alcuni che ritengono che si debbano usare altre leve come la
tassazione, il credito, le tariffe doganali per aiutare le imprese. Altri ritengono che lo stato
debba intervenire per garantire la libera concorrenza e per impedire il predominio dei
monopoli, il quale annullerebbe i diritti dei consumatori (mercato sociale); altri, pur
lasciando integro il meccanismo del mercato, preferiscono
che lo stato intervenga,
attraverso il prelievo fiscale, a coprire i rischi della disoccupazione, della
malattia e della
vecchiaia (stato sociale). In alcuni casi, un partito può ritenere che sia necessario
proteggere la produzione nazionale dalla concorrenza estera e si batte per delle misure
protezioniste o, invece, ritiene che si debba sostenere un programma libero-scambista. In
altri casi, un partito può essere favorevole a proteggere un settore specifico dell’economia:
ad esempio l’industria, qualificandosi “industrialista” o l’agricoltura, assumendo la difesa
degli interessi agrari. Tutte queste posizioni tra di loro alternative possono essere assunte
da uno o dall’altro partito in concorrenza tra di loro e fatto oggetto di un programma di
governo e di opposizione.
E’ naturale che i partiti possano essere sostenuti per i programmi che enunciano; grave
sarebbe se i programmi fossero
assunti in funzione degli appoggi che possono ottenere.
Ancora più grave se i partiti, dichiarando di voler fare una politica ne fanno, poi, un’altra per
favorire dei “gruppi di potere”, facendo degli accordi obliqui con essi. Più discutibili ancora
sono le transazioni che possono avvenire nei corridoi
parlamentari tra i rappresentanti di
gruppi economici (lobbisti) e parlamentari di diversi partiti per l’adozione di provvedimenti
legislativi di interesse per quei gruppi. Si vengono così a creare dei veri e propri “partiti
traversali”. Accade che gruppi di industriali o di agricoltori oppure rappresentanze
di
categoria o infine sindacati o cooperative influiscano sul partito a loro più affine perché
prevalgano principi a loro favorevoli. E se ciò rientra nella logica parlamentare, resta da
vedere se debba affermarsi la legge del più forte. Se è difficile per un parlamentare sottrarsi
alle pressioni dei gruppi a lui più vicini, sarebbe auspicabile che il parlamento, nel fare una
sintesi degli interessi in campo, deliberasse tenendo conto di quelli più generali. La
peggiore di tutte le decisioni è quella che risulta dal compromesso tra interessi non legittimi
di gruppi forti, ad esempio tra industriali e sindacati a danno di settori deboli del mondo del
lavoro o di un settore dell’agricoltura e di un settore dell’industria a danno dei consumatori.
Il problema della democrazia moderna è quello di stabilire e far rispettare delle regole
chiare in materia di rapporti tra partiti e gruppi di potere. Si tratta di far sì che questi rapporti
siano improntati alla massima pubblicità e trasparenza. Ciò richiede che nella legislazione
relativa ai finanziamenti di partiti siano previste norme sulla pubblicità dei bilanci, la
limitazione dei budget pubblicitari delle campagne elettorali, un regime di incompatibilità tra
cariche elettive ed incarichi dirigenziali che riguardano una serie di enti economici sotto
forma di incapacità elettorale passiva o possibilità di optare per una carica politica
rinunciando ad una posizione direttiva nel campo economico; controlli fiscali sulla posizione
finanziaria dei dirigenti
politici, divieto alle industrie pubbliche di finanziare partiti politici.
Qualsiasi legislazione per quanto perfetta può essere elusa ed i modi di eluderla sono
infiniti. Ciò che conta è non vietare l’esistenza di rapporti tra partiti e gruppi di potere,
quanto sottoporli ad un controllo pubblico per evitare che l’influenza delle lobbies snaturi il
carattere dei partiti, attraverso infiltrazioni innaturali, accordi trasversali tra partiti diversi di
carattere economico. L’illecita ingerenza dei gruppi di potere nella vita politica può essere di
doppia natura: causare un inganno degli elettori; limitare l’indipendenza del parlamento, del
governo, e, ancora peggio, quella dell’amministrazione.
I rapporti tra gruppi d’interesse e sistema dei partiti prescinde dalla tipologia dei partiti. Si è
sostenuto che i partiti ad organizzazione debole - i partiti d’opinione - siano più vulnerabili e
più suscettibili di essere dominati dai gruppi di potere e si è portato come esempio il
sistema liberale pre-fascista, dove le maggioranze trasversali erano frequenti su numerose
leggi (nazionalizzazione delle ferrovie, leggi di sostegno all’industria, leggi tariffarie), ma
anche un sistema di partiti di massa non è esente da difetti. Si
è affermato che in
un’economia di mercato i partiti sono più esposti allo strapotere dei gruppi di interesse di
quanto lo siano in un’economia statalizzata. Non si può dire che nei paesi dove è stato
realizzato uno “stato sociale” la forza di persuasione delle lobbies sia minore e che più
forte, viceversa, sia l’influenza di sindacati e partiti operai. Non sono infrequenti, invece, gli
accordi tra i maggiori gruppi industriali ed i sindacati, spesso a danno di sezioni più deboli
della società (contadini, agricoltori, lavoratori non organizzati, disoccupati, pensionati). In
conclusione è assai negativa una situazione in cui i gruppi di potere prevalgano sul sistema
dei partiti, ma non è più raccomandabile ai fini dell’efficienza del sistema una situazione in
cui siano i partiti a comprimere l’autonomia della vita economica. Lo studio della storia dei
partiti, aldilà dei giudizi di valore e dei modelli astratti, deve indagare sullo stato reale dei
rapporti tra questi ultimi ed i gruppi di potere e sulle tecniche cui essi ricorrono. Le lobbies
possono esercitare un’influenza diretta sul parlamentare o indiretta, finanziando campagne
sulla stampa e attraverso la televisione o intervenendo nelle elezioni o avviando cause
presso i tribunali. Possono infiltrarsi nelle organizzazioni di partito e ricorrere alla
corruzione. Alcuni di questi gruppi di pressione danno luogo ad organizzazioni permanenti
che raccolgono fondi e possono contare su apparati burocratici permanenti (Political Action
Committees). Nella sociologia americana si tende a distinguere i “gruppi di pressione”
(lobbies) e i “gruppi di interesse economico”, dai “gruppi di interesse pubblico” (public
interest groups) i quali non operano a vantaggio di interessi economici privati, ma per una
“causa” (Sartori).
Questi gruppi sono stati anche definiti “propaganda” o “promotional
group”. Si è notato come da una parte i cittadini si mobilitino più facilmente attorno a cause
di rilevanza
sociale (common cause) piuttosto che su piattaforme politiche. Attraverso
questa azione sociale i cittadini tendono a reagire all’incapacità della classe parlamentare
di risolvere i problemi collettivi e di resistere all’influenza dei gruppi economici più forti e a
stabilire un nuovo equilibrio (Theory of civic balance, Mc Farland).
Altri sociologi,
teorizzando i rapporti tra gruppi di pressione, gruppi di interesse pubblico e partiti, hanno
parlato di “pluralismo critico” (Pizzorno). Alcuni studiosi hanno assunto un atteggiamento
critico nei confronti di questa “group theory of politics” secondo la quale la socializzazione
del conflitto che è alla base del sistema politico e che dovrebbe essere fondato sulla regola
della maggioranza viene arbitrato attraverso il negoziato non tra attori politici, come sono i
partiti, ma tra i partiti, i gruppi di pressione e i gruppi di interesse pubblico che hanno una
posizione intermedia, costituendo dei sottosistemi rispetto al sistema dei partiti. Il difetto di
questa concezione è quello di indebolire il sistema politico dando forza ad interessi che
non riescono a trovare spazio nella maggioranza (Schattschneider). L’esistenza di questi
“gruppi di interesse pubblico” tende a delegittimare il partito il quale viene sempre meno ad
essere portatore di valori e di ideologie sino al momento in cui non sarebbe possibile
distinguere sotto l’aspetto funzionale i partiti dai gruppi. Né, d’altra parte, alla luce di questi
sviluppi vi sono sostanziali differenze tra il rapporto rappresentativo
che intercorre tra
elettori e rappresentanti (indipendenza) e quello tra cittadini e leader
dei gruppi di
interesse (mandato). I partiti difendono interessi, danno vita a una classe politica che
persegue il proprio interesse: sarebbero cioè divenuti dei “Superpac”; e così anche i gruppi
danno luogo ad organizzazioni stabili con diramazioni territoriali e tendono a coordinarsi
con associazioni affini, generano burocrazie che agiscono sempre in modo indipendente ed
autonomo rispetto ai titolari di interessi che dovrebbero rappresentare. La presenza di
questi gruppi non garantisce un pluralismo politico di tipo democratico se l’azione dei
gruppi di pressione non sia controbilanciata da un lato,
dal ruolo attivo dei partiti, e,
dall’altro, dall’impegno civico dei gruppi di interesse pubblico. Ma la chiave di volta di un
sistema pluralistico, nel cui contesto l’esistenza di gruppi abbia sua legittimità, sta tutto nel
garantire un controllo pubblico su questo fenomeno, attraverso una disciplina legislativa
relativa alla attività dei gruppi. In America il problema venne regolamentato dal “Federal
Regulation of Lobbying Act” del 1946, il cui funzionamento non è privo di critiche. In paesi
come l’Italia l’attività dei gruppi di pressione costituisce un fenomeno sommerso.