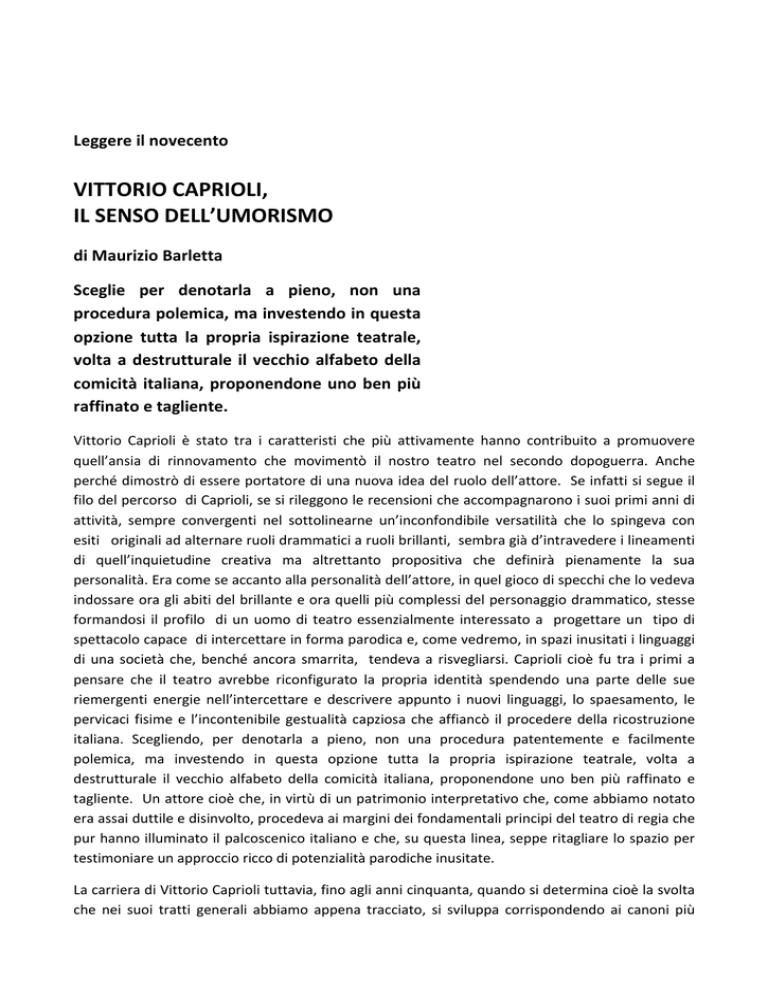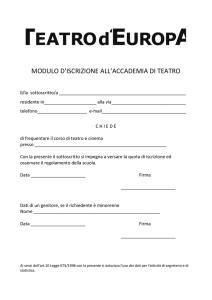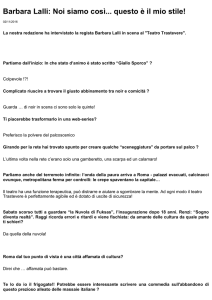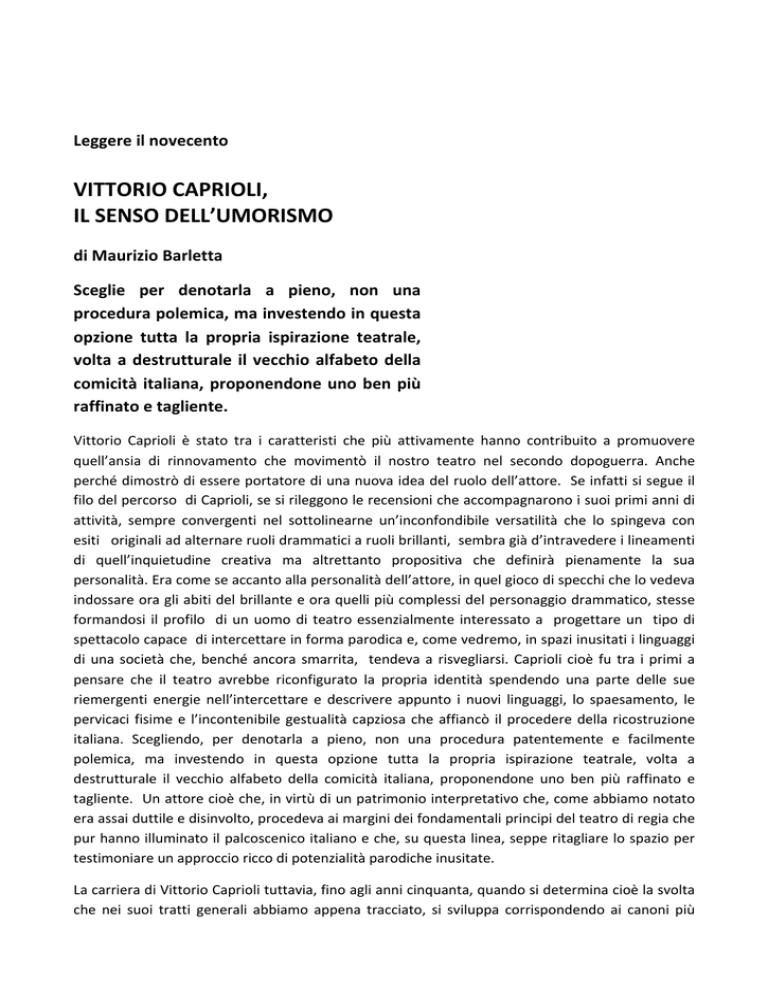
Leggere il novecento VITTORIO CAPRIOLI, IL SENSO DELL’UMORISMO di Maurizio Barletta Sceglie per denotarla a pieno, non una procedura polemica, ma investendo in questa opzione tutta la propria ispirazione teatrale, volta a destrutturale il vecchio alfabeto della comicità italiana, proponendone uno ben più raffinato e tagliente. Vittorio Caprioli è stato tra i caratteristi che più attivamente hanno contribuito a promuovere quell’ansia di rinnovamento che movimentò il nostro teatro nel secondo dopoguerra. Anche perché dimostrò di essere portatore di una nuova idea del ruolo dell’attore. Se infatti si segue il filo del percorso di Caprioli, se si rileggono le recensioni che accompagnarono i suoi primi anni di attività, sempre convergenti nel sottolinearne un’inconfondibile versatilità che lo spingeva con esiti originali ad alternare ruoli drammatici a ruoli brillanti, sembra già d’intravedere i lineamenti di quell’inquietudine creativa ma altrettanto propositiva che definirà pienamente la sua personalità. Era come se accanto alla personalità dell’attore, in quel gioco di specchi che lo vedeva indossare ora gli abiti del brillante e ora quelli più complessi del personaggio drammatico, stesse formandosi il profilo di un uomo di teatro essenzialmente interessato a progettare un tipo di spettacolo capace di intercettare in forma parodica e, come vedremo, in spazi inusitati i linguaggi di una società che, benché ancora smarrita, tendeva a risvegliarsi. Caprioli cioè fu tra i primi a pensare che il teatro avrebbe riconfigurato la propria identità spendendo una parte delle sue riemergenti energie nell’intercettare e descrivere appunto i nuovi linguaggi, lo spaesamento, le pervicaci fisime e l’incontenibile gestualità capziosa che affiancò il procedere della ricostruzione italiana. Scegliendo, per denotarla a pieno, non una procedura patentemente e facilmente polemica, ma investendo in questa opzione tutta la propria ispirazione teatrale, volta a destrutturale il vecchio alfabeto della comicità italiana, proponendone uno ben più raffinato e tagliente. Un attore cioè che, in virtù di un patrimonio interpretativo che, come abbiamo notato era assai duttile e disinvolto, procedeva ai margini dei fondamentali principi del teatro di regia che pur hanno illuminato il palcoscenico italiano e che, su questa linea, seppe ritagliare lo spazio per testimoniare un approccio ricco di potenzialità parodiche inusitate. La carriera di Vittorio Caprioli tuttavia, fino agli anni cinquanta, quando si determina cioè la svolta che nei suoi tratti generali abbiamo appena tracciato, si sviluppa corrispondendo ai canoni più classici dell’apprendistato teatrale. Diploma all’Accademia d’arte drammatica di Roma. Seguirà nel ’42, il debutto a Milano, in un’Italia belligerante e già attraversata, almeno nei settori più consapevoli della società, dal presagio di un’inevitabile sconfitta che aprirà la strada a nuove sofferenze, umiliazioni e spietate vessazioni. Scritturato dalla compagnia Carli-­‐Racca, Caprioli è tra gli interpreti di un testo di William Saroyan, “ I giorni della vita”. Testo non memorabile, oscillante tra un benevolo ottimismo e cadenze addirittura favoleggianti. Ma non sarà comunque un’esperienza priva di lasciti positivi. Le compagnie che audacemente sfidavano la realtà rappresentarono una propizia occasione, benché evidentemente avventurosa, per tutta una generazione di attori che accettarono quella sfida, che riconsiderata a distanza di tanti anni, appare inoltre come una selezione che sfoltì bruscamente i ranghi . In particolare per gli attori che entravano in campo per la prima volta forse confidando più del lecito nell’imprimatur dell’Accademia. Il salto dalla “Scuola” alla “Compagnia” si rivelò per molti di quegli audaci e pur dotati autori come un passaggio in una seconda forma di apprendistato, meno aristocratico e soprattutto inatteso. Non così fu per Vittorio Caprioli. Nella compagnia Carli-­‐ Racca incontra Vittorio De Sica, Nino Besozzi, Vivi Gioi, presenze autorevoli che avevano frequentato non soltanto i palcoscenici della prosa, ma (per quanto riguarda De Sica e Besozzi) anche quelli del varietà e della rivista, dove i due si erano rivelati come impareggiabili virtuosi dell’improvvisazione. Come confiderà in un’effervescente intervista televisiva dei tardi anni sessanta, Caprioli dirà di avere appreso da questi due virtuosi, appunto come la tecnica dell’improvvisazione non fosse un volgare espediente, quanto piuttosto uno straordinario strumento sussidiario incredibilmente sofisticato e vincente per soffocare sul nascere quei maligni vuoti di memoria che, di tanto in tanto, aggrediscono alle spalle anche i più consumati navigatori del palcoscenico. Si ritroverà con Vittorio De Sica nel ’59, in un film diretto da Roberto Rossellini, “Il generale Della Rovere”, che lo vedrà interprete di una caratterizzazione drammatica nella quale lo spessore della sua formazione teatrale troverà l’occasione per confermarsi, a conclusione di un decennio che anche dal punto di vista della propositività, come vedremo, può essere considerato come il più saliente e ricco di esplorazioni di tutto il suo percorso artistico. Quando il teatro italiano nel fervore del dopoguerra identificò nei Teatri stabili lo strumento ideale per recuperare il tempo perduto e debellare l’arretratezza organizzativa e culturale che lo contraddistingueva, ritroviamo Caprioli in prima fila nell’indimenticabile legione dei caratteristi che molto contribuirono al processo innovativo introdotto con il Piccolo di Milano da Giorgio Strehler e Paolo Grassi. In quello che si prospetta fin dai suoi primi passi come il tempio del teatro di regia, Caprioli interpreterà in successione per un biennio, a partire dal ’48, Shakespeare, Gozzi, Pirandello, Thornton Wilder. Una scia di caratterizzazioni su testi che contrassegnarono la rinascita teatrale in quel decennio. “La tempesta” shakespeariana (che andò in scena con la regia di Strehler nel ’48) e poi “Il corvo”, del Gozzi, fino al ’50, dedicato alla rivisitazione pirandelliana dapprima con “Questa sera si recita a soggetto” e successivamente con “I giganti della montagna”. In dieci anni, pertanto, Vittorio Caprioli aveva partecipato a tutte le più stimolanti e formative occasioni che erano state offerte ai quadri di maggior spessore culturale entrati in scena negli anni quaranta. Ma evidentemente c’era in lui, forse già nelle stagioni dell’Accademia, (e poi negli anni del tanto coinvolgente avvio del Piccolo), un’originale propensione a delineare e vivere in prima persona una figura d’attore particolarmente interessato a esplorare quei percorsi che, quando erano stati intrapresi, erano sempre rimasti ai margini dell’ufficialità e dell’ambizione didascalica che da noi era rappresentata dal palcoscenico. L’idea era, senza rinnegare i precedenti riferimenti, di cimentarsi piuttosto in una lampeggiante dimensione dialogica e parodistica, epigrammatica per meglio dire, e per certi versi di stampo flaianeo, determinata a creare l’incontro con il pubblico in una prospettiva che non soltanto riconosceva le potenzialità del cabaret, ma ne raffinava i procedimenti stilistici, dove l’allusione ai comportamenti sociali evidenziava soprattutto i travisamenti degli atteggiamenti e dei linguaggi,delle movenze e delle motivazioni che coglievano quel particolare paese che è l’Italia nella transizione del suo modo d’essere da una stagione all’altra della sua storia. Un teatro che si proiettava nella contemporaneità con un sense of humor di straordinaria fattura, anche per il contributo offerto alla buona riuscita dell’impresa da Luciano Mondolfo in veste di regista. Nel 1951 Caprioli fonda appunto con Alberto Bonucci, (suo compagno di studi negli anni dell’Accademia d’arte drammatica e poi al Piccolo strehleriano), il Teatro dei Gobbi. Li seguì, in qualità di regista, come accennato, Luciano Mondolfo. Una delle tante meteore che hanno segnato la storia del nostro teatro in uno suoi dei periodi più felici e originali, e che comunque contribuì decisamente a siglare l’operazione cabarettististica del Teatro dei Gobbi come la più brillante e preziosa nel suo genere. Una formula che, quanto più favoriva il ritmo incalzante di una comicità che seguiva nella dizione e nella mimica i tempi dello sketch, tanto più rendeva trasparente la propria eleganza. Il duo Bonucci-­‐Caprioli si trasformò in trio nel ’51, quando venne ad aggiungersi il personalissimo talento di Franca Valeri. Le scenografie erano state radicalmente abolite, il palcoscenico soppiantato dall’ambiente del locale notturno, che funzionò immediatamente come generatore di quell’insostituibile atmosfera che accompagnava il disegno parodico tracciato dai tre attori. E anche quando i Gobbi vennero a Roma nel teatro di via Vittoria, sede storica per la messa in scena dei saggi dell’Accademia d’arte drammatica, sul piccolo palcoscenico le scenografie furono sostituite e, in questa circostanza, soppiantate da un paravento. Benché accolto con un grande successo di pubblico, e salutato da un fervido consenso della critica, particolarmente nella difficile piazza francese, molto orgogliosa di essere depositaria con la Germania della più riconosciuta tradizione cabarettistica, elogiato da quel sovrano delle lettere e delle forme teatrali che era allora Jean-­‐ Paul Sartre, il Teatro dei Gobbi attraversò con il suo autentico charme il firmamento dello spettacolo europeo soltanto per tre stagioni. Due testi in tre anni: Il “Carnet de notes” del ’51, ripreso nel ’52, e il “Carnet de notes n. 2 rappresentato dal formidabile trio nel ’53. Poi l’improvviso congedo, tanto più stupefacente in quanto, a giudizio del fedelissimo ed esigente pubblico e della stessa critica più attendibile, non un granello di polvere si era insinuato nei meccanismi comici che, anche nelle iterazioni formali, suscitavano l’impressione di essere sottoposti a un imprescindibile rinnovamento. Erano un terzetto, ma tenacemente continuarono a definirsi la Compagnia dei Gobbi. E nessuno poteva smentirli, perché la loro vitalità comica era tale e talmente coinvolgente, così cangiante, da far pensare che fossero almeno trentatre personaggi interpretati da trentatre attori diversi. Ciascuno, peraltro, assolutamente inimitabile. Ritroveremo Caprioli sul palcoscenico nel ’54, quando indosserà gli abiti di Estragone, in occasione della prima italiana di “Aspettando Godot”, di Samuel Beckett. Firmerà poi alcune regie per testi scritti e interpretati con il consueto charme da Franca Valeri. D’altra parte certe caratterizzazioni di Caprioli nei film della cosiddetta commedia all’italiana, prodotti tra gli anni cinquanta e sessanta, possono oggi essere riconsiderate come un preludio al suo esordio come regista cinematografico e come sceneggiatore. Un passaggio inevitabile, che interveniva come una conferma di quell’inquietudine e spavalda creatività già del tutto evidente nelle giovanili stagioni dell’Accademia e degli esordi. Almeno due sue regie cinematografiche meritano di essere ricordate. Nel ’61 “Leoni al sole”, sceneggiato con Raffaele La Capria: uno scorcio efficacemente cromatico sulla gioventù borghese partenopea che riprendeva il verbiage sintomatico del romanzo dello scrittore napoletano (“Ferito a morte”), reduce da una contrastata ma legittima vittoria nel Premio Strega di quello stesso anno. Nel ’62, “Parigi o cara”. Altra eccellente regia cinematografica. Un film contrassegnato da un’interpretazione di Franca Valeri esaltante nell’equilibrio che sviluppava tra garbo e divertissement. Infine “Splendori e miserie di Madame Royale”, che è del ’70, un saggio di eleganza, dove forse qualche eccesso formalistico, pur nella complessiva eccellenza del film, appesantiva l’abituale speditezza narrativa che anche nel cinema, in veste di regista, aveva comunque saputo confermare. Seguì un ritorno al teatro. “Mercadet l’affarista”, felice incontro con la commedia umana di balzacchiana memoria. Come del resto confermò l’integrità e duttilità della sua fibra di grande caratterista in un nuovo confronto con due classici già positivamente visitati negli anni giovanili. Il Goldoni de “La bottega del caffè” e la pirandelliana “Trilogia del teatro nel teatro” che fu l’ultima sua apparizione su quei palcoscenici italiani sui quali aveva lasciato un segno profondo e permanente nella storia del teatro del Novecento..