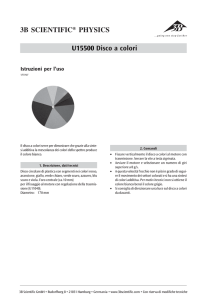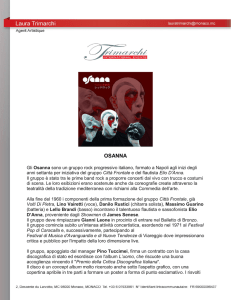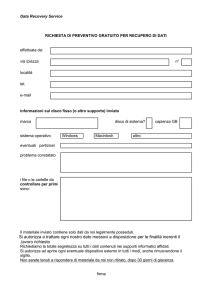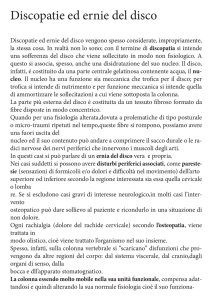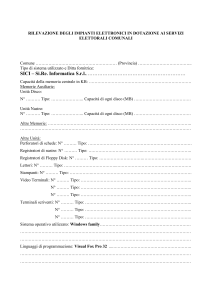digital magazine dicembre 2010
N.74
Bjørn
torske
Norwegian hauntology
Coldcut
we love ninja tune
The Kinks
Non voglio che Clara
Giancarlo Onorato
Turn On
p. 4
Tre Allegri Ragazzi Morti
6
Warpaint
8
Baustelle
10
Dark Star
Tune IN
p. 11
Non voglio che Clara
Giancarlo Onorato
14
Drop Out
18
Sufjan Stevens
30
Napoli Caput Mundi
Recensioni
40
A Classic Education, Warpaint, Ebo Taylor, Autumn Defense....
Rearview Mirror
84
The Kinks
Rubriche
76
Gimme Some Inches
78
Re-boot
80
China Underground
90
Giant Steps
91
Classic Album
SentireAscoltare online music magazine
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05
Editore: Edoardo Bridda
Direttore responsabile: Antonello Comunale
Provider NGI S.p.A.
Copyright © 2009 Edoardo Bridda.
Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale,
in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo,
è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare
Direttore: Edoardo Bridda
Direttore Responsabile: Antonello Comunale
Ufficio Stampa: Teresa Greco
Coordinamento: Gaspare Caliri
Progetto Grafico
e
Impaginazione: Nicolas Campagnari
Redazione: Antonello Comunale, Edoardo Bridda, Gabriele Marino, Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Stefano Pifferi,
Stefano Solventi, Teresa Greco.
Staff: Giancarlo Turra, , Edoardo Bridda, Marco Braggion, Antonello Comunale, Fabrizio Zampighi, Teresa Greco,
Stefano Solventi, Stefano Pifferi, Andrea Napoli, Luca Barachetti, Stefano Gaz, Mauro Crocenzi, Stefano Solventi,
Simone Madrau.
Guida
In
2
spirituale:
copertina:
Adriano Trauber (1966-2004)
Bjørn Torske
Turn On
Tre Allegri
Ragazzi Morti
—Futurivismo—
Che si tratti di una svolta definitiva
o di una semplice toccata e fuga poco
importa. I Tre allegri ragazzi morti
rimangono esploratori entusiasti del
suono anche in versione dub.
S
crittura, idee, disegni, immaginario. E poi una musica legata al concetto di evoluzione. L'adolescenza che caratterizzava il punk dei Tre allegri Ragazzi Morti fino agli albori de La seconda rivoluzione sessuale trova con
Primitivi del futuro e Primitivi del dub una nuova dimensione, allargando il proprio raggio d'azione oltre i Quindici anni già. Dall'alba dell'individuo intesa in senso anagrafico si passa a quella dell'uomo intesa in senso evolutivo
(cacciatori, raccoglitori / beoni, spacciatori / contadini, dissidenti/ ballerine, pensatori / puttane felici e giocatori), in un
ritorno alle origini che diventa il passaggio essenziale per comprendere – e magari per cambiare – una contemporaneità in cui non ci si riconosce. “La memoria che non è / quello che ricordi della storia passata / è qualcosa di più
profondo / che ha a che fare con la memoria del mondo / che può farti capire qualcosa / del processo che possiamo
fermare / l'origine dell'alienazione della specie” canta Davide Toffolo in Primitivi del futuro. Ovvero conta quello che
siamo e non quello che ci vogliono far credere d'essere, perché non c'è tecnologia che possa gratificare un individuo che abbia perso il contatto con la sua reale essenza. Fuori da un bieco pseudo-naturalismo new age e dentro
4
a una riflessione condivisibile che mira a un'etica del
“passo indietro”, a un primitivismo quasi biologico e
delle intenzioni. La musica diventa esaltazione delle
radici, su un dub/reggae rubato alla Giamaica di Lee
Perry che mantiene comunque forti punti di contatto
con lo stile dei TARM. Come ci fa capire anche Enrico
Molteni - bassista della formazione di Pordenone - in
questa breve intervista.
Due dischi e un universo capovolto: i Tre Allegri
ragazzi Morti nuovi alfieri dei ritmi giamaicani/
africani o gli ultimi capitoli Primitivi del futuro e Primitivi del dub rappresentano solo una deviazione
necessaria e fortemente (e)voluta di un percorso
artistico coerente?
A mio avviso i Tre allegri ragazzi morti sono sempre
stati scrittura, a matita o col plettro. Sono idee ed immaginario. In questo senso mi stupisce che il nuovo
corso abbia colpito così tanto. È come cambiare abbigliamento ad una persona. La persona è sempre la
stessa, anche se con colori e taglie nuove. Tre allegri
ragazzi morti rimangono (anti)eroi nemici delle convenzioni anche quando suonano in levare.
Quanto il “primitivismo” sottolineato dai suoni e
dai titoli dei due ultimi episodi ha a che fare con la
personalità della band ?
È raro che l’eleganza sostituisca l’emozione. Vivere insieme per due anni nella campagna agricola del nordest ci ha fatto apprezzare Zerzan. I problemi della
nostra società arrivano dal neolitico, non da governi
attuali o precedenti. Quando l’uomo ha smesso di
essere cacciatore e raccoglitore e si è stabilizzato, ha
smesso di essere libero. Suono e titoli sono al 100%
quello che Tre allegri ragazzi morti sono oggi.
Su cosa avete lavorato per affrontare il netto cambio di stile e come è stato farsi forgiare da un esperto del “settore” come Paolo Baldini?
Siamo passati da una misteriosa voglia di suonare in
levare ad un’istruzione alta a riguardo grazie al maestro Baldini. Ore in sala prove ad ascoltare, ad esercitarsi, ad immaginare un incontro reale fra la Jamaica
e Pordenone. Avevamo bisogno di contaminare il nostro suono, perché il pensiero lo era già da tempo.
In L'ultima rivolta nel quartiere Villanova non ha fatto feriti cantate: “Stacca la tua connessione / non lo
fai”. Che rapporto hanno i Tre Allegri ragazzi morti
con la tecnologia e in maniera particolare col mondo di Internet?
Internet è stato importante per noi, abbiamo sempre
cercato di svilupparne le potenzialità con fantasia.
Dall’arrivo del 2.0, tuttavia, siamo rimasti spiazzati e
tutt’ora stiamo cercando di svincolarci da quella palu-
de che è il social network. Se tutto sembra importante,
tutto perde di valore. Tutti sono allenatori della nazionale, tutti sono critici musicali. Conta di più un copricapo bizzarro che una melodia perfetta. Siamo tornati
alla predominanza dell’apparenza. E noi ci siamo celati
dietro ad una maschera anche per evitare che questo
succedesse.
Interrogato da SA a proposito del peso che puo' ricoprire la rete nella promozione di una band, Francesco Bianconi dei Baustelle ha sottolineato come
il tam tam mediatico di internet sia alla fine una
rivoluzione solo di facciata, dal momento che non
influisce in maniera rilevante sui dischi venduti
né sulla notorietà degli artisti. Michele Bitossi dei
Numero 6 ha replicato invece dicendo che se da un
lato quello di Bianconi puo' essere un parere condivisibile sulla carta, dall'altro nasce da presupposti
un po' snobistici che arrivano dall'alto di una notorietà ormai acquisita e lontana dalla realtà di un
gruppo emergente bisognoso di farsi conoscere.
Tu cosa ne pensi?
Fondamentalmente sono d’accordo con Bianconi e
Godano, forse perché, come loro, ricordo bene com’era
prima. Compravi un mensile ed imparavi ad avere fiducia in una firma. Ascoltavi alcuni programmi radio
ed il giorno dopo ordinavi il disco in America. A scuola
ci si passava i dischi sottobanco. Guardavi tanti video
in tv alla ricerca di nuovi stimoli. Andavi ai concerti con
una curiosità maggiore. C’era una preselezione, è vero,
ma mi sembra di ricordare che fosse tutto più bello. La
situazione attuale è molto eccitante, c’è una possibilità maggiore di arrivare alla gente, ma non ci sono più
regole ed alle volte i nuovi successi sono solo fuochi
di paglia. Sono uno di quelli che sostiene che Arctic
Monkeys avrebbero comunque avuto successo, anche
nel 1987.
Fabrizio Zampighi
5
Turn On
Warpaint
—Le nuove ragazze
di città—
L'ultima sensazione made in Los
Angeles al debutto su Rough Trade.
S
hannyn Sossamon è la starlette hollywodiana che faceva bella mostra di sé in Le Regole dell’Attrazione di
Roger Avary, così come in decine di film dall’appeal commerciale altalenante. Un volto che buca gli schermi
e i cuori, al punto che non a caso quel nerd camuffato da pop-rocker di Graham Coxon le dedica il primo singolo
tratto da Happiness In Magazines, Spectacular.
Shannyn è anche la sorella di Jenny Lee Lindberg e un bel giorno, insieme, decidono di metter su una band rock
con le amiche d’infanzia, Emily Kokal e Theresa Wayman. L’embrione di quello che sarebbero diventate di lì a poco
le Warpaint, l’ennesima e spavalda formazione “all female” che si trova a muovere i primi passi nel caotico e magmatico universo losangelino della West Coast americana. Non proprio le tipe giuste per il posto giusto se è vero
che tutto lo scenario tipico fatto di palme altissime in quel di Beverly Hills e di impronte nel cemento nella walk of
fame suonava quanto meno ironico già all’epoca delle prime session: “L’atmosfera della nostra musica riflette solo
parzialmente Los Angeles – sostiene Emily – qualcosa del clima, delle persone, delle cose che abbiamo intorno c’è, ma
siamo piuttosto come il cuore vero di questa città, ovvero lo sgomento e l’oscurità”. Una visione disillusa e disincantata,
che le quattro condividono con altre formazioni del nuovo rock losangelino, quelle del giro Not Not Fun in primis,
anche se in un settore del tutto diverso.
La band diventa rapidamente trio, perdendo per strada proprio Shannyn che deve star dietro alle cose della settima arte. Di lì in poi il percorso delle tre prende il verso giusto grazie ad una miscela ben calibrata di psichedelica,
6
postpunk e ballad eteree trovando un padre putativo di quelli giusti, nella persona di John Frusciante,
che si trova a missare presso i suoi studi i cinque brani
dell’ep di debutto, Exquisite Corpse, lavoro spartano
ma pieno di una energia grezza e sincera che va di pari
passo con la scelta di autoprodursi.
La “nuova sensazione” è presto fatta e nei circuiti il
nome prende a circolare con sempre più insistenza fino all’hype vero e proprio che esplode in questi
giorni, in occasione della pubblicazione del disco di
debutto, The Fool, distribuito da una griffe influente
come Rough Trade che si invaghisce della band dopo
averla sentita su Myspace. E’ la stessa Emily ha ricordare come è andata, non senza una punta di sorpresa:
“Quelli della Rough Trade ci hanno visto su Myspace e ci
hanno chiesto di spedirli il nostro disco, quando ancora
non avevamo un batterista. Poi siamo andati in tour negli USA e un giorno mentre stavamo suonando a Portland ed eravamo in procinto di firmare con un’altra label,
piomba Scott McQueen dicendoci di non firmare con
nessuno. Abbiamo accettato eppure a guardare indietro
com’è andata c’è da dire che siamo state scritturate senza che nessuno di loro ci avesse visto suonare una volta e
senza avere nemmeno un batterista fisso!”.
Con un suono come quello delle quattro (al trio storico si aggiunge ufficialmente, poco prima delle registrazioni di The Fool, Stella Mozgawa) è facile andare
incontro ai gusti più eterogenei. Ma innanzitutto l’immagine, che è austera ma retrò. Le Warpaint fanno le
cose come si facevano un tempo: singoli, video, session fotografiche, tutto come se si fosse tornati agli
anni novanta, così come una neppure tanto velata fierezza femminile che se proprio non le porta dalle parti
del “foxycore” anni’90 (quello di Bikini Kill e derivati
per intenderci…) le allinea a formazioni come Sleater
Kinney ed Electrelane, che non hanno mai messo
l’accento su un femminismo di battaglia, ma neppure ci hanno glissato sopra. “Alla fine è stato un elemento positivo. Non abbiamo mai avuto l’impressione che
fossimo etichettate come una band di donne – precisa
Emily – e in fin dei conti le persone hanno capito che non
era una faccenda determinante per poter venire ai nostri
show o ascoltare le nostre canzoni. Certo a volte ti capita
lo scemo che si mette a parlare delle nostre caratteristiche fisiche…
Del resto equilibrio e misura sono i tratti distintivi della
band. Musicalmente parlando evocano evidenti assonanze con il pop rock scuro di marca Tanya Donnelly.
In particolare, le doppie voci di Emily e Theresa risentono del fascino di gruppi come Throwing Muses e
Raincoats. In mancanza di un aggettivo che calzasse
per tutti i brani, sono state spesso descritte con un
termine omnicomprensivo quale “psichedelia”, che è
un po’ come dire che c’è la crisi economica e la disoccupazione non accenna a diminuire… per descrivere
Exquisite Corpe i termini più usati nelle webzine di
mezzo mondo sono stati: “dreamy”, “psychedelic”, “hypnotic”, “soundscapes”, “intimacy” a cui si aggiunge con
The Fool l’accento su una produzione più professionale e meno grezza e rabbiosa.
Andando più a fondo nel suono delle quattro, impossibile innanzitutto non scomodare i padri del post-punk
inglese, Joy Division o Fall o tutta la new wave anni
Ottanta, al primo sussulto ritmico tra basso e batteria
(Bees pare in questo senso un omaggio ironico e devoto). Il taglio delle chitarre non a caso ricorda quello
ascoltato qualche anno fa nel debutto dei The Organ,
ma è una similitudine che può andar bene solo per i
brani più tirati, perché per il resto del programma Warpaint diventa sinonimo di meditazione malinconica, di
gorgheggi eterei e di chitarre trattate in direzione del
sogno. Sarà pur sempre il vecchio retaggio della prima 4AD, ma quando prendono il pendio delle melodie più scure (Shadows, Majesty, Warpaint) le Warpaint
riescono a somigliare alle Spires That in The Sunset
Rise, in una maniera però molto più diretta e pop. Le
stregonerie rock e sperimentali sono costantemente
tenute a bada e questo da un lato fa perdere punti sul
piano della ricerca, dall’altro le rende immediatamente riconoscibili. Un “easy listening” che è tutto fuorché
un difetto in questo caso.
Alla fin fine importa davvero poco se le Warpaint siano
l’ennesimo gruppo destinato a sfornare si e no un paio
di dischi, impegnate con la grammatica di sempre,
quella di un rock che si riproduce costantemente dalle proprie ceneri. Il progetto è serio, i riconoscimenti
arrivano puntualmente e The Fool è lavoro capace di
conquistarsi il proprio spazio nel caotico maelstrom
della comunicazione globale. In tutto e per tutto la
storia di un successo, ma l’aria di Emily e delle altre
è quella di quattro ragazze che non potrebbero fare
nient’altro che suonare la propria musica e le proprie
canzoni. Ovvero, nessun tentativo di sovvertire il mondo e portare la rivoluzione delle idee. Solo il vecchio e
sano rock’n’roll. That’s all, folks… e se avete la curiosità
di sapere da dove venga il nome Warpaint e cosa significhi davvero, andate pure su Urban Dictionary, scoprirete che può indicare tanto un make-up esagerato e
di cattivo gusto quanto una serie di pratiche sessuali
a base di tamponi vaginali e altro… del resto l’ironia
è donna.
Antonello Comunale
7
Turn On
Baustelle
— Apocalittico
integrato—
Il decennale del Sussidiario,
con relativa succosa ristampa, è
l'occasione per tracciare bilanci sullo
stato delle cose. Non proprio idilliaci.
8
U
n decennale è un decennale, ok, ma qui la trama s'infittisce. Cerchi su cerchi che si chiudono.
Evoluzioni particolari e generali. Dieci anni fa si aprivano gli anni zero (enigmatici, volatili, tenaci, lividi,
controversi...) e con essi, tra le altre cose, s'inaugurava
la carriera discografica dei Baustelle. Disco che colpì
non poco pubblico e critica, quel Sussidiario illustrato della giovinezza co-prodotto da Amerigo Verardi.
Il premio come miglior esordio elargito dal Mucchio
Selvaggio non fu che il suggello di una cavalcata vincente nell'immaginario indie, malgrado una distribuzione che ancora oggi Francesco Bianconi definisce
"non adeguata".
Pop-wave inzuppato d'innocenza e ormoni, echi di
colonne sonore e brume da chansonnier, il dandismo
nostalgico e spiegazzato dei Pulp tra spasmi marionettistici Alberto Camerini, soprattuto quel senso di
precarietà periferica ma illuminata, non troppo distante da come si presentarono al mondo, incantandolo, i
Belle And Sebastian. E poi la disarmante franchezza
dei testi, sospesi tra parafrasi colte e minimi termini da
fotoromanzo neorealista. Il tutto affidato all'intepretazione languida e disincantata della coppia BastreghiBianconi: ingredienti di una ricetta che sfornò gemme
tarslucide come Canzone del parco e potenziali craque
da superclassifica come Gomma o Le vacanze dell'83.
"Piacque di noi forse il fatto che avevamo un'incosciente
sfrontatezza nel fare un tipo di musica italiana strana,
con molti riferimenti alle colonne sonore, ai cantautori
italiani e francesi, all'elettronica e alla new wave". Francesco Bianconi rievoca senza ostentare nostalgia, se
non per quell'etichetta - la Baracca e Burattini di Paolo
Bedini - che li lanciò e non c'è più. "Bedini lasciava molto fare, non interferì assolutamente dal punto di vista
artistico. Ebbe da ridire solo sul titolo, che gli sembrava
troppo pretenzioso. Ma a me piaceva, e la spuntai". Da
allora i Baustelle sono diventati altro, persino tutt'altro
potremmo dire.
Questione di mezzi a disposizione o inevitabile espansione artistica. Probabilmente entrambe le cose. In
ogni caso, se la ristampa era un'eventualità sacrosanta
considerato che da tempo il disco risultava introvabile,
stupisce un po' la ricchezza del formato (cd, vinile, 45
giri e booklet) ed il tour apposito (Il tour del sussidiario)
messo in piedi come una vera e propria celebrazione.
Anzi, di più: somiglia ad una dichiarazione d'appartenenza, un rivendicare radici che in molti rimproverano
alla band d'avere smarrito (non certo chi scrive).
Cerchi che si chiudono, dicevamo. Occasione per bilanci che somigliano più ad accuse nei confronti del
presente che a rimpianti del passato. "Era un altro
mondo. Si vendevano più dischi. All'epoca le mie speranze erano di vivere con la musica e arrivare a più gente
possibile. Questo non significa calare le braghe, sputtanarsi. Significa non considerare la propria musica come
qualcosa che debba essere ascoltata solo da quelli che la
possono capire. Non volevamo considerarci di nicchia".
Già. Ma oggi le nicchie sono esplose, è un mondo di
nicchie espanse, accessibili e simultanee. Potenza della
neo-socialità internettara. "Uso con molta parsimonia il
mio profilo Facebook, ma sono curioso dei nuovi mezzi
di comunicazione quindi ce l'ho. Non lo uso per testare
la reazione del pubblico dei Baustelle, non credo che un
musicista debba basarsi su questo".
Opinione del tutto condivisibile. Però va messo in
conto che in molti lo fanno più per necessità che per
opportunismo. E comunque il tam tam battente della
rete ci ha regalato qualche bella sorpresa che, se fosse stato per i canali ufficiali, forse non avremmo mai
conosciuto. Bianconi sbotta, più apocalittico che integrato: "Negli anni novanta, prima che esistessero i nuovi
mezzi di comunicazione, band come i Non Voglio Che
Clara o Vasco Brondi sarebbero forse anche più famosi di
adesso, anche senza il tam tam mediatico di internet. Voglio dire che tutto questo gran parlarne, questo circolare
di informazioni serve, fa bene, ma non agli artisti. I dischi
venduti sono pari allo zero. Le etichette indipendenti
chiudono. Sui blog e sui social network si parla molto di
una band, ma questa, se vuole far uscire un disco, deve
pagarselo coi propri soldi. Nel 2000 il Sussidiario magari
non fu promosso adeguatamente, ma Baracca e Burattini finanziò interamente la produzione. In questo senso la
rivoluzione del web è di facciata perché non aiuta realmente la musica indipendente, che ha vita più dura".
Già che siamo in vena di analisi, e visto che siamo qui
a celebrare un decennale, spendiamo due parole su
questi cazzo di anni zero. "Credo sia troppo presto per
parlare musicalmente degli anni zero. Semmai possiamo
dire che politicamente e culturalmente non stiamo passando un bel momento in Italia, la musica è concepita
come un sottofondo divertente e gratis, è un valore senza
valore, e tutto questo non è bene perché la musica ha il
diritto d'essere considerata una cosa importante come i
romanzi o le opere d'arte. Questa è una cosa che mi dispiace degli anni zero ed il nostro governo attuale non
aiuta a migliorare la situazione". E il futuro, invece? "Se
dovessi fare un disco domani lo farei acustico, con un
quartetto d'archi e senza batteria. Ma faccio già fatica
a pensare al presente, non riesco ad immaginare come
sarà un disco dei Baustelle che uscirà fra un anno, un
anno e mezzo..."
Stefano Solventi
9
Darkstar
Turn On
Tune-In
Non Voglio
Che Clara
—Twinkle Twinkle
Darker Star—
—Il Tempo e i cani—
La nuova scommessa di Kode9
L
a stella che segna il nord nel mondo post-dubstep
spariglia il gioco e si toglie di dosso le lugubri atmosfere di East/South London, puntando direttamente al vocal pop. I Darkstar sono la nuova ed eccitante
scommessa dell’etichetta di Kode9: il lungimirante
produttore e burattinaio del mondo elettronico del
suburbio londinese, capisce come i tempi siano maturi per un ripensamento dell’ultima e nuova sensation UK. Ci mette poco a tentare nuovamente il botto,
come aveva fatto con Burial. Ricetta: guardare alla tradizione synth UK e utilizzare la lezione di questi ultimi
dieci anni, che con il dubstep in fatto di darkness hanno costruito un’estetica prolifica e - mano a mano che
è passato il tempo - più aperta e accogliente.
Il dubstep, dicevamo. Oggi anche questa catalogazione tende a sfaldarsi e nei prodotti più avant si sente l’urgenza di rimettersi in gioco. Vedi la techno che spinge
sul lato dancefloor, le derive commerciali di Magnetic
Man o gli ostinati in levare ragga di Ramadanman e
affini. James Young ed Aiden Whalley partono invece
con una classica formazione da nerd dello smanettamento, ma ben presto si accorgono che i loro singoli
non sono propriamente come quelli dei giovani amici
che li circondano. Per capire cosa fare e come proseguire cercano allora la voce di un cantante. Nell’impegno di James Buttery trovano il punto di svolta: “non
era più come usare un semplice vocoder. Nell’album abbiamo prodotto una voce vera. Da un punto di vista di
scrittura abbiamo delineato le melodie che James avreb10
be cantato invece che pensare a tracce per il dancefloor.
Questo ci ha modificato il suono, che è diventato subito
qualcos’altro, quello che potete ascoltare in North”.
Il nord dell’album è la parafrasi delle periferie aliene
alla capitale. La premiata ditta Whalley & Young ha
sede infatti a Manchester: ritorna perciò lo spettro
dell’elettronica ‘nordista’ della Warp e degli isolamenti eremitici di Aphex Twin. Le coordinate geografiche
imputano un distacco che si rinsalda comunque alla
tradizione melodica (vedi tra l’altro la citazione degli
Human League nella cover di Gold), che i tre perseguono già dagli esordi: “I nostri primi singoli suggerivano una forma canzone più convenzionale. L’album è
stato la continuazione di quel percorso con le voci”.
Le voci non sono il soul di Burial, bensì le bianchissime e melanconiche paranoie pop che intristiscono e
alimentano l’hype di smanettoni stanchi del sudore
da balera. I riferimenti d’ascolto (ci dicono via e-mail)
sono guardcaso la commerciabilissima epopea di Kanye West, il wonky di Actress, il sempreverde universo
Beatles, e per chiudere i principi del synth New Order.
Senza pensare troppo alle conseguenze, questi tre ragazzi hanno gettato le basi per un nuovo modo di fare
dubstep. Basta colate di lava nera dal cuore. Oggi si
punta al melò pop. They call it sadstep.
Marco Braggion
Testo: Luca Barachetti
La canzone d'autore anni Sessanta, l'amore, le colpe:
l'apice dei Non Voglio Che Clara un passo prima di
una svolta necessaria.
11
“Personalmente avevo voglia di una pausa, mi sono dedicato a lavori altrui (Valentina Dorme, Public), ho sperimentato qualche soluzione inedita per la band come la
serie di concerti a formazione ridotta contestuali all’uscita
di Bene, ma soprattutto ho scritto un discreto numero di
canzoni nuove, alcune delle quali sono finite in Dei cani.
C’è anche da dire che la formazione nel frattempo è mutata per i due quarti e questo ha sicuramente portato un
certo ritardo nella pubblicazione del disco”. Ecco spiegato il perché del quadriennio di (quasi) silenzio dei Non
Voglio Che Clara. Come a dire che qui il tempo conta,
e non solo perché si torna a quel Tempo, lo si recupera,
rimescola con il dopo, quel tanto che basta. Ma anche
perché c'è voluto del tempo per scrivere il disco che,
molto probabilmente, l'innamoramento per quel Tempo e relative filiazioni li chiude.
Parliamoci chiaro: è dagli inizi degli anni zero che si è
tornati ad ascoltare la leva cantautorale dei sessanta.
Bindi, Tenco, Paoli, Endrigo. E poi ancora Endrigo, Paoli, Tenco, Bindi. Vigoroso gesto postmoderno al limite
della strangolatura, un passo più in là e siamo al calco soffocante, vedasi chi quel passo l'ha fatto. Non gli
splendidi Amor Fou, non i Perturbazione del siderale
apice antiestivo (Agosto come la Mi sono innamorato di
te del nuovo millennio). Non un Paolo Benvegnù a debita e viscerale distanza o un Alessandro Grazian che
ancora non ci ha detto tutto. Ma pensate al Morgan
perennemente nostalgico e perennemente involuto
su sé stesso o a quello spirito camerettardo, da tutto il
dolore del mondo qui fra la mia scrivania e la mensola
coi libri di Murakami, di tante altre produzioni, magari
minori, magari no. Non ce ne voglia il nipponico tirato
in ballo più da questi imbronciati perennemente pallidi che da noi, ma serviva un colpo di mano. Come nella
fotografia, il bianco e nero stava diventando la coloratura photoshop di scatti mediocri e ripetitivi, dunque
ripetitivo anch'esso, e per giunta in un'epoca così istantanea come gli anni zero.
E allora un disco come Dei cani, produzione ad hoc
di Giulio Ragno Favero, è quello che ci voleva. Dopo
due uscite inaspettate e succulente come Hotel Tivoli
(2004) e l'omonimo del 2006, fondamentali per capire un innamoramento generazionale, la nostalgia di
un passato non vissuto, fors'anche l'esigenza di ritornare ad una dimensione più genuina nel raccontare i
rapporti tra le persone – cui ha corrisposto, purtroppo, anche una certa chiusura verso il brutto mondo
esterno – il nuovo lavoro dei Non Voglio Che Clara dice
una cosa molto semplice. Cioè che meglio di così, per
quanto riguarda il recupero di quella stagione fondativa, è assai difficile fare, perché se è vero come ci dice
12
Fabio De Min, leader e mente scrivente dei bellunesi,
che la ripresa dei Sessanta è avvenuta perché Tenco e
compagnia “sono grandi autori e il paradosso è che contemporaneamente non interessano più ai discografici, al
mondo dell’industria musicale, se non per farne qualche
stucchevole special televisivo” è altrettanto vero che
stucchevole sta diventando l'insistito ricorrere a quelle
atmosfere, ultimamente magari rimescolate a qualche
ironica pruderia d'oltralpe (che Serge Gainsbourg fortunatamente è anche molto altro) o alle luci da gran
varietà del sabato sera.
I Non Voglio Che Clara invece hanno fatto quello che
prima di loro e insieme a loro avevano fatto in tanti,
ovvero far convogliare due alvei in un unico fiume: la
tradizione italica da una parte e gli ascolti più o meno
giovanili dall'altra, soprattutto quelli d'oltreconfine,
ciascuno la propria destinazione quali viaggiatori della
provincia ai margini dell'impero musicale poi scopertasi intrisa di parabole importanti. E questa cosa in
Dei cani l'hanno fatta ad un livello alto, molto alto, e
con deviazioni tanto brevi quanto decisive seppur in
un'omogeneità straordinaria.
C'è il mood spectoriano in Dei cani, comune a tante recenti uscite e che per La mareggiata del '66 li porterà ad
un fin troppo facile accostamento ai Baustelle, paragone che a De Min “sembra un po’ forzato, e del resto si
cita Spector, quindi finiamo col riferirci al 'suono spectoriano dei Baustelle' e mi sembra un po’ un non-sense”. Ma
ci sono anche gli Smiths e soprattutto i Flaming Lips
e Brian Wilson in Secoli, un Morricone quantomai fantasmatico ne Gli anni de l'università e ancora l'elettronica, non tantissima ma determinante in un brano come
Il tuo carattere e il mio che per i Clara è ora fregola da
approfondire e motivo di ospitate inattese: “Abbiamo
cominciato a lavorare con l’elettronica fin da subito ma
con un approccio analogico, penso a Tu, la ragazza l’ami?
(brano poi non inserito nel disco ma consegnato alla
rete come succulento antipasto, ndr) dove utilizzo uno
stratagemma per il suono del pianoforte a la maniera di
John Cale, o La stagione buona dove suono dei vecchi
sintetizzatori e applico i loop su strumenti acustici. E ad
un certo punto ci è venuta voglia di coinvolgere Port Royal e Giulio (Favero, ndr) che hanno messo del proprio.
Sintetizzatori e samplers compaiono ora anche dal vivo e
per un po’ siamo sicuramente intenzionati ad utilizzarli”.
Certo, non si fa tutto questo se alla base non c'è la scrittura di canzoni che è retorico ma veritiero definire da
brivido, una serie di tracce meritevoli ereditiere dei loro
padri putativi, per asciuttezza linguistica, concisione e
densità emozionale, in ultimo ma non per ultimo afflato melodico tradizionalista eppure ancora sottocuta-
neo: “Quando si è trattato di scegliere i brani da portare
in studio mi sono accorto che questi potevano rientrare
in un unico corpo narrativo, formando una storia che poi
ho frammentato scomponendo la scaletta. La narrazione
in prima persona fa pensare ad un diario, così come il fatto di svilupparsi in un arco di tempo definito”. A De Min
e compagni potrebbe essere rivolta la stessa accusa
di piagnisteo di cui sopra, l'obbligarsi a cantare quasi
sempre sottovoce, se però non fossimo di fronte a liriche che hanno la forza universale e al contempo individualista del vero rancore, del vero dolore, della vera
(livida) speranza. Ne risulta un profilo di straordinaria
coerenza che diventa vera e propria narrazione, il diario
di una stagione della vita tra biografismo e invenzione.
Un amore che finisce male, molto male, la vita che ricomincia, le colpe che per questioni di educazione e cultura diventano le uniche lenti attraverso cui guardare
il mondo mentre il mondo là fuori entra nelle case, nei
letti, li invade e li soffoca. «Ma se mi chiederanno / se ti
verrò a cercare / io con parole nuove / gli saprò spiegare
/ che ognuno corre per sé / e che la fatica per riaverti qui
/ non conta niente / io amo la terra / e ho da correre fino
a stancarmi / per dormire bene» . Oppure: «A luglio diedi
il cane ad un canile / in cambio di una libertà maggiore
/ e ad agosto fra botte e sassaiole / per via della rivolta
sindacale / restai solo senza cane e lavoro / restai solo con
in bocca un gusto amaro».
Facile a questo punto capire il significato di una citazione da Garibaldi contenuta nel booklet, ferma nel
prendere posizione seppur in toni che dai Clara non ti
aspetteresti e sfondo perfetto di una storia che è ambientata nell'oggi sciagurato del nostro Paese (“Non
voglio accettare in nessun tempo il ministero odioso,
disprezzevole e scellerato di un prete, che considero
atroce nemico del genere umano e dell'Italia in particolare”): “Il fatto che Dei cani sia stato pensato, scritto
e realizzato in un tempo piuttosto lungo ha fatto si che
durante le lavorazioni la mia attenzione si focalizzasse su
piani e prospettive di volta in volta diverse, alcune sono
finite in primo piano, altre sono rimaste a fare da sfondo
alla storia che racconto. Ma il rapporto del protagonista
con la società circostante, l’etica e la morale imperanti li
ho voluti ricercare in più di un episodio. Riguardo l’espressione in sé, non credo ci sia molto da aggiungere se non
sottolinearne la grandissima attualità”.
E a questo punto? A parte l'inevitabile e atteso tour,
dove l'impianto orchestrale delle canzoni vivrà un'importante verifica (“Fin dalla stesura dei brani abbiamo
cercato di porre maggiore attenzione alla loro resa dal
vivo di quanto non avessimo fatto in passato“) è già interessante da ora capire cosa saranno i Non Voglio Che
Clara da qui in poi. Alcuni segnali, succulenti, ci sono
già (l'elettronica, l'apertura al “politico”). Sarà comunque inevitabile da qui in poi staccarsi da un immaginario sonoro che hanno contribuito a recuperare e
rivitalizzare, perché il tempo lo richiede e quel rinnovamento della nostra canzone d'autore di cui da anni
si va discorrendo anche. Chissà se un giorno vedremo
questa prima parte del percorso dei Non Voglio Che
Clara come una fase interlocutoria verso un qualcosa
di ancora migliore, più personale e dunque ancor più
definitivo. Da parte nostra, presa conferma dell'enorme talento, saremo gli ultimi a fare sconti.
13
Tune-In
Giancarlo
Onorato
—Non chiamatelo cantautore—
Testo: Fabrizio Zampighi
14
Non ci siamo fatti sfuggire l'occasione di intervistare
Giancarlo Onorato, anche alla luce di un Sangue
bianco ennesima dimostrazione della classe di un
profilo artistico quasi unico
L
'opera per il suo autore: Sangue bianco, recita il titolo del quarto disco di Giancarlo Onorato. Tanto
per rimarcare che la musica è parto corporeo e sofferto
di chi la compone, ma anche entità a sé stante capace
di abbandonare i limiti fisici per darsi in pasto. In un dibattere di note e parole a volte descrittivo, a volte – è il
caso dell'ultima opera del cantautore milanese – spinto sui crinali di un sentire evocativo e lontano dai facili
dualismi da cantautore classico.
Ha un che di vagamente oracolare il discorso di Onorato. Lo status di “classico” per un autore che invece
classico non si ritiene. Risultato di un approccio alla
materia serissimo ma non accademico, in cui si respirano vent'anni di onorata carriera nell'underground
musicale e letterario di casa nostra ma anche la voglia
di restare umile. Oltre alle esigenze di un profilo poco
propenso a farsi catalogare, borderline come sa esserlo
chi la propria arte non la delega a nessuno: non ai presenzialismi gratuiti, non ai fuochi fatui delle tendenze,
non alle sirene di una notorietà effimera. E pazienza se
un disco come il qui presente o magari come il precedente – bellissimo - Falene rimarrà materia per pochi:
è il prezzo da pagare per restare liberi di ascoltarsi e
di forgiarsi. In una contemporaneità che parla un'altra
lingua e da cui magari ci si sente anche un po' fuori,
pur con la voglia di non lasciarsi sfuggire occasioni di
confronto e di crescita personale.
Sono passati cinque anni da Falene, un disco riconosciuto dai più come il punto più alto della tua
produzione musicale. In cosa Sangue bianco rappresenta un passo in avanti rispetto a quell'opera?
Sangue bianco è principalmente un disco di musica.
Un disco in cui anche le parole vogliono essere parte
della musica. Questo lo distanzia da tutto quanto io abbia sinora prodotto, per il semplice fatto che non si tratta di un'opera narrativa come era Falene bensì essenzialmente musicale. Le parole di Sangue bianco non
sono meno importanti di quelle degli altri miei dischi,
ma sono incarnate nelle composizioni e vivono della
musica di cui fanno parte. Una simbiosi che non vuole
più essere canzone nel senso solito. Io sono al contempo regista e autore della colonna sonora di un'opera la
cui visione scorra nella mente di chi ascolti.
Cinque studi di registrazione, venticinque musicisti
coinvolti e un'attenzione particolare per il suono e
gli arrangiamenti. L'idea che ci si fa è quella di aver
di fronte un disco importante e su cui si è ampiamente riflettuto. Insomma, un prodotto slegato
dalla contemporaneità musicale da fast-food a cui
siamo abituati...
Il passare del tempo tra una pubblicazione e l'altra è
dato dalla necessità di un rapporto intenso con la disciplina musicale, dopo anni di autentico apprendistato.
Ci sono alcuni aspetti del mio operato che differiscono
profondamente da quello di molti altri autori, uno di
questi è l'assoluta indifferenza per le “esigenze di mercato”. Questa posizione, lungi dall'essere una questione
di superiorità, risiede in due punti essenziali: il primo è
che per pubblicare è necessario avere qualcosa da dire,
individuando il modo migliore per dirlo. Ci vuole tempo e lavoro. Molto lavoro. Da ciò consegue il secondo
punto: solo con la massima serietà nella produzione si
può contribuire a limitare l'esagerato proliferare di musica non esattamente imperdibile di cui soffre il settore.
Pubblicare meno dischi ma di più alto valore sarebbe
un buon traguardo.
Sul tuo sito internet, nelle note allegate all'opera,
si legge che la musica contenuta in Sangue bianco
“prende del tutto le distanze dalla cosiddetta canzone d'autore”. Eppure tu vieni universalmente riconosciuto come un cantautore. Da dove nasce, dunque,
questa contrapposizione?
Oltre a non apprezzare il termine, so di essere quanto di più distante vi possa essere in questo paese da
un “cantautore”. Lo dimostrano il senso, la direzione e
il contenuto delle mie composizioni. E Sangue bianco, per la sua natura intrinsecamente trasgressiva fuori
dalle consuetudini, dai modi, dagli stili, funge da ulteriore separatore da quel tipo di identificazione. Il termine “cantautore” è nato per definire una produzione che
non ha niente a che vedere col sentire libero da generi
e cliché della musica moderna. Molti tra i dischi più potenti, trasgressivi e “rock” della storia sono dischi realizzati voce e chitarra o voce e pianoforte. Talvolta sussurrati. Io cerco la potenza nel rapporto tra la musica e
il suo mescolarsi simbiotico con parole che diventano
15
sostanza sonora e significante. Non conosco nessuno
che lavori alla mia maniera. Il più delle volte ascolto
testi incollati ad una struttura precostituita, scatole di
montaggio. La musica per me è un'altra cosa. Probabilmente prima o poi farò opere di sola musica o magari
opere di sola parola suonante. Questo Sangue bianco
è già un passo verso la colonna sonora delle cose che
ci toccano dentro.
Oltre ad essere un musicista sei anche un romanziere (Il più dolce delitto, Filosofia dell'aria). Quanto
l'emotività immediata che un disco porta con sé può
replicare l'immaginario narrativo di un romanzo? E
in che maniera l'essere scrittore influenza il lavoro
del musicista?
La musica può ispirare e influenzare la produzione
letteraria, ma credo che non vi sia contatto più di tanto tra le due discipline. Un romanzo, nel migliore dei
casi, è un sentimento esteso e meditato; la canzone è
qualcosa che vive in un mondo a sé. Tutta la musica si
basa su altri fattori. E' il modo in cui ci arriva a renderla
altro e tale da non potersi replicare. Cerco di allontanare i due momenti creativi - musica e narrativa - perché
pur essendo dimensioni complementari suonerebbe
retorico e inutile forzarne il bacio. Tuttavia, siccome il
mio immaginario è lo stesso quando scrivo canzoni
così come quando affronto un romanzo, accade che ci
siano passaggi di significato tra una forma e l'altra. E'
anche vero che i miei romanzi non sono storie nel senso ordinario, ma piuttosto una sequenza di momenti
interiori. La mia narrativa è psichica, dunque assai più
vicina ad una composizione musicale che ad una storia
con precisi personaggi e avvenimenti. Si potrebbe dire
che nella mia produzione una forma è la continuazione
dell'altra.
Nella poetica che contraddistingue il tuo immaginario ricopre una grande importanza la materialità
dei corpi, la sessualità. Penso al tuo ultimo romanzo, a opere pittoriche autografe come Dio distribuisce e Etica ed estetica – per citarne solo un paio - o ai
frequenti riferimenti alla dimensione corporea che
si ritrovano nei tuoi testi. Come lo spieghi?
Se ciò che ci ha generati non è l'argomento degli argomenti, non ne vedo altri. Io sono un astronauta delle
carni, l'universo a portata di mano.
In una vecchia intervista ai tempi di Io sono l'angelo
parlavi della tua canzone come della “canzone del
dubbio”. Che cosa intendevi sottolineare con quella
definizione?
Probabilmente che l'opera vuole essere un concetto
aperto a diverse soluzioni, imprevedibile e anche imprecisa, come la vita. Le cose più belle sono imprecise.
16
Hai all'attivo varie produzioni di altri musicisti.
Cito, tra i tanti, l'esordio di Davide Tosches o Tutta
la dolcezza ai vermi di Pane. Quanto è difficile per
l'Onorato solista – con l'immaginario fortissimo che
si porta appresso – scendere a patti con la musica di
altri artisti?
Meno difficile di quanto possa sembrare dall'esterno.
Produrre un altro artista vuol dire capirne la dimensione, visto che il tipo di collaborazione che metto in atto
non è mai prettamente tecnica ma soltanto di pura
regìa. Io non faccio che entrare il più possibile in sintonia con la persona, preoccupandomi di capire chi è
e di far intendere chi sono io. Quali sono le mie ansie,
cosa voglio, cosa mi manca. Questo genera lentamente
un'apertura e un abbandono delle resistenze da parte di chi collabora con me ed è il modo migliore per
entrare in contatto, parlare la stessa lingua. Ma ci sono
persone e persone, quindi una produzione artistica
è come un percorso di psicoterapia in cui il soggetto
è chiamato ad essere fortemente sè stesso con tutti i
propri contenuti, buoni e cattivi, Ogni disco produce
un nuova situazione con cui fare i conti. Per questo
posso permettermi di produrre artisti - purché inclini al
confronto – stilisticamente diversissimi tra loro.
Stiamo vivendo un momento di riscoperta della
canzone d'autore. Nuove leve si affiancano a nomi
storici. Pensiamo a 33 Ore, Dente, Baustelle, Amor
Fou, Lele Battista, Non voglio che Clara, ma anche
l'ultimo Iosonouncane o quel Vasco Brondi de Le
luci della centrale elettrica che – volente o nolente
– ha segnato col suo Premio Tenco un punto a favore di tale riscoperta, quantomeno catalizzando
l'attenzione dei media sulla “scena”. Come coabita
con l'attualità uno come te che nell'ambiente circola ormai da vent'anni? Quale giudizio hai maturato
su questa “new wave” del cantautorato italiano?
Io sono e resterò sempre un neofita. Uno che ogni mattina ricomincia a vivere da capo. Non mi accorgo del
tempo che passa perché sono concentrato sui miei
traguardi. Ogni tanto, però, esco dalle mie cose e vado
incontro agli altri. Ammetto di sentirmi più a mio agio
accanto alle nuove leve, piuttosto che in compagnia
di chi spernacchia da anni le stesse cose. Inoltre sono
chiamato spesso a curare la direzione artistica di eventi
in cui gravitano buona parte delle personalità che si distinguono negli anni. Quindi ho condiviso di frequente
serate con diversi dei nuovi compagni di settore. Con
Vasco Brondi, ad esempio, c'è stato uno scambio molto utile per entrambi e ci siamo piaciuti. La stessa cosa
è successa con Beatrice Antolini. In linea generale, più
che farne una questione di categoria, direi che sono
portato a prestare attenzione a quelle proposte che
hanno più coraggio. Più di altri mi convince Samuel
Katarro, anche se penso che lui non si ponga il problema del coraggio ma faccia semplicemente ciò che gli
viene di fare. Ascoltiamo poco il lavoro altrui e io non
voglio più cadere in questo errore. Se c'è un artista che
mi incuriosisce, cerco di andare a sentirlo in concerto.
Sento il bisogno di mettere la mia mente in contatto
con quella degli altri, anche per capire chi sono io. Mi
piace chi è innovativo, non chi si crogiola negli errori di
chi l'ha preceduto senza alcun senso della storia. Non
mi piacciono gli opportunisti, i presenzialisti o quelli
che escono con un disco all'anno. Nessuno ha cose interessanti da dire in ogni momento e se non ti fermi a
nutrirti di ciò che accade intorno non puoi proseguire
nel tuo lavoro. Esprimersi è tutto in questo saper misurare il proprio rapporto col resto del mondo.
17
Bjørn Torske
—Norwegian hauntology—
Drop Out
Precursore space disco,
artefice della skrangle house e
divulgatore di tutti i verbi post E,
infine musicista elettroacustico
a raccontarci gli 80 come non li
sentirete mai da nessuna altra
parte
Testo: Edoardo Bridda
18
S
i è fatto un gran parlare della stagione ’90 ’92 ultimamente. Con
gli Orb, e il loro dignitoso Metallic Spheres in compagnia di David
Gilmour per l’ambient house, ma anche per quel Where Were You
In ’92, album manifesto di un certo revival ’ardkore ai tempi del
wonky. Inoltre si è parlato - e si continua a parlare - di Daniele Baldelli, della
riscoperta della cosmic disco e della tribale della Baia degli Angeli, della
space disco nordica, la disco music con Hot Chip e Scissor Sisters. Recentemente poi, gente come Francesco Tristano ha dato nuova linfa all’house “suonata” di gente come Claudio Coccoluto e Carl Craig portando studi
classici e jazz nei groove e nella cassa in quattro, dentro e fuori la deepness dell’anima. E non dimentichiamo il cavallone glo-fi che ha inondato
le orecchie di migliaia con quei ricordi Ottanta che con i primi Novanta,
vedi alla voce chill - 808 State e l’ultimo A Guy Called Gerald e compagnia
balearica - si sono sposati alla perfezione.
Proprio da questi stereo sulla piaggia, bpm rallentati, synth alla salsedine
ripartiamo. Fanno parte del DNA di Bjørn Torske la cui storia, dal 1991 in
poi, ripercorre praticamente tutti i crocevia indicati, intersecando mode e
subculture che in quest’ultimo lustro e più sono ritornate sotto forma di
citazione o come pura cornucopia. Torske, originario di Tromsø, presentatore radio fin dal 1987, e dj da allora, è stato il divulgatore, molto prima dei
compaesani Röyksopp, di tutto il buzz balearico, chill e synth vintagista di
marca nordica, ma anche di tutti i verbi che la rivoluzione E ha portato con
19
sé a partire, appunto, dalla mai dimenticata ambient, passando per l’ardkore che genererà la jungle, la techno ambientale pre e post Biosphere,
il revival Ottanta del padrino Per Martinsen/Mental Overdrive e prima la
sua techno di marca belga, l’idm ancora detroitiana di LFO e quella classica
warp-iana con i Boards Of Canada.
Il cuore di Bjorn Torske ha battuto molteplici ritmi: techno, house, disco,
dub. Generi che, sposandosi alla cosmica di Daniele Baldelli, hanno creato
un nuovo mix in 4/4, la skrangle-house, stile ibrido a base di percussioni di
cui il dj è stato capofila, nonché cordone ombelicale, di una seconda generazione di dj producer che a metà Duemila si sono proclamati Space Disco.
Parliamo di Prince Thomas, Lindstrøm, ragazzi che devono tanto e forse
tutto a questo pallido eroe, lui che oggi è già oltre la dance, oltre Cortina,
una strana bestia che negli anni zero si è cimentato in un sound incatalogabile che sa tanto di folktronica e avant folk, neo (neo neo) kraut, post-punk,
easy listening, hauntology house, 8 bit, e concretismi oramai spezia fissa
del menù.
Poche storie. La vicenda musicale di questo appartato ragazzo classe ’71
è un esaltante percorso per comprendere il suono norvegese (e non solo)
degli ultimi vent’anni. Precursore e anomalia all’interno di esso, Bjorn è già
un pezzo importante di storia, di tante storie dentro e fuori i Club, di generi
e stili assorbiti e diffusi. Non di meno, la sua storia s’accompagna a una
scenografia/produzione qualitativamente invidiabile, uno di quei film con
il lieto fine che è, appunto Kokning, il miglior album del Norvegese fino ad
oggi. L’ottimo snodo per le sonorità post-chill a venire nonché l’avamposto
con base fissa a Tromsø dove il creativo dj può narrare una perfetta trama
retro futurista infilandoci dentro di tutto dal progressive in poi, facendo
tappa fissa in quegli Ottanta che videro nascere l’hip hop e quelle fondamentali tecniche di campionamento, frammento e loop.
Le
radio indipendenti e l ’ambient house
La storia di Bjørn Torske inizia molto prima degli album a suo nome. Negli
anni ’80, l’allora quattordicenne Bjorn s’appassiona alle radio indipendenti
(“ci potevi sentire gli Yello, i Kraftwerk, Art Of Noise ecc.” ci racconta al telefono) e presto inizia ad acquistare album e strani 12’’. Soltanto due anni più
tardi, il ragazzo è già protagonista dell’etere, trasmette news e musica e
poco più tardi - è il 1988 - assieme ad un amico, registra su nastro a bobine
dei mix di due ore che vengono trasmessi ogni sabato in differita. Il programma non è il solo che il giovane Bjørn conduce. La domenica, con Geir
Janssen (Biosphere), va in onda un ambient show con una selezione che
comprende, tra gli altri, anche gli Orb.
Contemporaneamente, Torske e alcuni amici si divertono a re-editare, sempre su nastro, i loro brani techno preferiti. Facevamo un sacco di remix, ricorda appassionato, e mi ero fatto anche prestare dei synth e drum machine
così potevamo creare qualcosa di nostro. Quel qualcosa di nuovo sono delle
tracce atmosferiche su basi technoidi filiate dagli ascolti che il ragazzo, non
appena si sente sicuro, passa al buon Janssen, di qualche anno più vecchio,
e già in contatto con alcune etichette discografiche nazionali e straniere. A
Bjorn consiglia la SSR, etichetta belga che, dal 1988, produce roba hip-hop
ma anche techno e house.
Come molti artisti dance, l’allora ventenne si presenta sotto alias pensando
già di utilizzarne altri per differenziare la produzione e ottenere così altri
20
contratti discografici. Una pratica comunissima nell’elettronica anche soltanto per sopravvivenza economica e sotto l’alias di Alegria, Bjorn sforna
l’ambient house che da mesi stava producendo su nastro. Danger (It’s For
Real) è un prezioso contributo a una scena che l’anno successivo, il 1992,
compirà la sua parabola, e che ora è caldissima. La traccia suona fresca anche oggi, in equilibrio com’è tra Roland tecnoidi sotto sedativo e una tastiera da sogno ipno, albe e spiaggie desolate. Finirà in una compilation
commissionata dalla label belga chiamata T.O.S EP assieme a un’altra, Hipnotize, giocata su breakbeat Ottanta e scimmiotti Orbital sotto il nome di
Radikal Buzz. Il moniker, identificava questa volta un lavoro di coppia con
l’amico Ole Johan Mjøs, ma questo, come l’altro alias, durano giusto il lasso
delle citate incisioni.
I smistik . L’emancipazione
filo - warp del verbo
techno
La mossa successiva è un progetto più solido e duraturo. Sempre con Mjøs,
Bjorn intaglia groove ibizenchi in ritmi detroitiani, stampo imprescindibile
dal quale l’Europa e la scandinavia tutta cercano d’emanciparsi e, ancor prima, di professare.
Nascono gli Ismistik che in fatto di motori ritmici sono tanto spartani quanto decisi. La coppia trova immediatamente casa presso la Djax-Up-Beats,
una label olandese che ha in mano gente come Terrace, Trance Induction,
Board Of Wisdom. E’ un bel colpo per questi ragazzi del Circolo Polare cresciuti sotto l’ala del citato Geir Jennsen (Biosphere) e soprattutto di Per
21
to di emancipazione più interessante dei due però è un altro: l’influenza
maggiore - già pienamente assimilata - viene dal catalogo Warp dell’anno
precedente. Mentre Martinsen macina riff di piombo, in Feel The Drumbox
(Bounce!!) riff e tastiera sono le stesse utilizzate degli LFO e Tricky Disco,
bleep’n’bass levigata dalla ditta Torske/Mjøs che al fascino del phuturo trasforma il tocco Biosphere in ambiente chill e sguardo all’orizzonte verso
quel sole di mezzanotte per cui Trømso è famosa in tutto il mondo.
La seconda prova degli Ismistik si dimostra già un passo oltre. Suono e produzione sono più compatti e l’immaginario ibizenco, piegato su ritmi maggiormente pieni, quadra a dovere: Oasis suona già come un piccolo classico: tribal-house con groove giocato ai filtri sul principio, piccolo assolo di
piano e vibrafono e tocco ipnagogico à la Derrick May mezzo e, ciliegina, la
tipica nota sospesa che fa orchestra d’archi in provetta. Se non lo avete capito, è tutto ciò di cui si innamorerà il citato Tristano parecchi anni più tardi,
e i nostri all’epoca, proprio come lui oggi, sono abilissimi nel guardare oltre
il dancefloor in una zona che la gente comincia a riconoscere come IDM, un
campo d’azione che va dagli adorati Orbital (che ritornano in Object Code)
all’Aphex Twin di Flow Charts passando per i flavour dell’imprescindibile
compila brit Artificial Intelligence.
R ide
Martinsen noto come Mental Overdrive, pioniere assoluto dell’intera scena norvegese, nonché promulgatore dell’ambient (che diventerà chill) a
tutto campo che di lì a poco condizionerà tantissimo le sorti della musica
del Paese.
Prendendo spunto dagli Orb e 808 State, gli zii Geir e Per, con i Biosphere del primo a fare da caparra e garanzia di qualità, e gli Illumination e
Chilluminati del secondo a diffondere a macchia d’olio la febbre chill, influenzeranno in maniera decisiva i trend e il business elettronico scandinavo. Si arriverà al punto che in Greetings From Oslo, una compilation edita
da Universal nel 2001, troveranno posto praticamente tutti artisti stranieri
(Groove Armada, Jazzanova e un giovane Matthew Herbert). Questo disco
metterà la parola fine all’epopea commerciale che la chill pre-millennium
scandinava aveva coltivato in quegli anni (aprendone un’altra come vedremo più avanti), ma nel 1992, naturalmente, questo futuro ancora non è
stato scritto e non è nemmeno prevedibile. Techno e house sono materia
pulsante per le passioni e non sono certo affari di palazzo.
Bjorn, cresciuto nello stesso negozio di dischi della cittadina frequentato
dalla cricca, è infatti nella classica fase d’ortodossia techno dei diciotto/
ventenni che Per, a mo di Aphex Twin locale, cavalca da un paio di anni
sotto il nome di Mental Overdrive, con un taglio metallizzato tutto belga (12000 AD e The Second Coming, 1991, 1992). Lui, non a caso, pubblica
per la mitologica R&S, mentre Torske e Mjøs, sull’olandese Djax giocano su
computazioni 8 bit, smalti etno e progressioni tipicamente house se non
quasi italo (Slight Interrupt) sull’eppì d’esordio Bonus Bouncers. L’aspet22
on time .
I nizio
e fine del futuro dance
‘90
Nel frattempo, e siamo sempre nel fatidico 1992, Torske e Mjøs s’aggregano
a Rune Lindbæk e formano due progetti commerciali, anch’essi fuori dallo
sguardo degli zii: il primo, Open Skies, si occupa di ’ardkore 100% tagliato
per i rave, il secondo, Volcano, parla la lingua dell’house cantata che poco
più tardi diventerà standard dance per i club di tutto il mondo con destinazione chiaramente Club. Sono due operazioni molto volatili, specie per un
Torske più incline a cercarsi le proprie vie piuttosto che battere quelle degli
altri. Del resto, è un periodo veramente magico e troviamo soddisfazioni
anche qui, soprattutto con gli Open Skies, autori di due discreti 12’’ Ozone
Nights e Deep In Your Eyes pubblicati non a caso sulla prestigiosa Reinforced, l’etichetta dei 4 Hero.
Le rispettive title track sono tipici pezzi ’ardkore (battuta jungle, voci in elio,
pianola che più italo non si può), roba che Zomby, vi dicevamo, ha cannibalizzato, e che il trio plasma con colori e complicazioni da annali del genere.
Soprattutto da queste parti c’è Mellow Flow, un episodio cruciale per capire
la provenienza del sound di altre due personalità importantissime della vicenda di Tromso, Svein Berge e Torbjørn Brundtland in arte Röyksopp, due
pargoli protetti di Per già da questi anni che il motivetto sintetico di questo
brano lo devono aver imparato a dovere dato che nel riascoltarlo oggi ci
ritroviamo già un buon 60% del loro marchio di fabbrica.
Bravo Bjorn, deus ex machina di tantissime fila del suono scandinavo
e meno bravi sicuramente i Volcano, invecchiati male e dediti allora a
un’house cantata su tre pubblicazioni (per Olympic, Deconstruction e Exp)
dai titoli emblematici Let Your Body Be Free, More To Love e That’s The
Way Love Is di cui la seconda diventa una hit negli UK l’anno seguente.
Torske, del resto, già nell’ultima di queste pubblicazioni, una cover di Ten
City By The Way, con Sam Cartwright al canto, lascia il progetto ai soli Mjøs
e Lindbæk e fa benissimo. È un periodo in cui il biondissimo dj sta con il
cuore e con la testa da un’altra parte e questo è chiaro fin da 3rd Trace,
l’ultimo lascito di Ismistik datato 1993, un anno chiave per le evoluzioni del
23
mondo dance in cui la jungle spicca il volo e la scena inizia rapidamente a
frammentarsi in sottogeneri rompendo per sempre il sogno comunitario e unitario - tanto decantato dal coetaneo di Torske, Matthew Herbert. Da
lì in poi i ritmi s’accelereranno, i groove s’incupiranno e quello che i raver
vivranno sarà un vero e proprio incubo, anche sonicamente.
Il sogno s’era infranto e sul modo di interpretarlo forse Torske e Mjøs cominciano divergere: il primo vuole un sound now on (Linked Modules), il
secondo preferisce concentrarsi sul cuore ambient, e anzi, spinge dove può
sulla narrazione in note (Resynch). Passa un altro anno e gli Ismistik diventano un progetto in solitaria di Torske che, nel frattempo, si è spostato a Bergen ed è pronto a pubblicare un primo album lungo di quella che comincia
a diventare una poetica personale, l’arctic techno (come l’hanno chiamata
su discogs.com).
Remain, questo il titolo dell’ellepì, viene registrato in completo isolamento
nell’agosto del 1994 e rappresenta una sintesi tardiva eppure affascinante
della prima ondata post-techno europea in bilico tra l’eleganza Derrick May
e il calore diffuso house del discepolo di lui Carl Craig, uno che all’house suonata - e alla scena tutta - darà tantissimo. L’aspetto più importante
dell’album è comunque un altro: l’aria fredda che lo attraversa è quella norvegese e diventa protagonista di un suo disco di visioni ipnagogiche e psicologie ambient, allunaggi e nevicate. La tracklist, infine, continua le linee
tangenti agli LFO più meditativi. Il disco che chiude idealmente il cerchio
con la techno merita inoltre un sacrosanto ricollocamento negli archivi.
Ismistik terminerà qui.
The B ergen
buzz .
Il
(Smoke Detector Song) - momenti lounge e da spy movie (Lumb fu) e ancora, la migliore sci-fi di casa Warp (Eight Years). Il filo conduttore sembra
un’estasi cosmica da E ingoiati in campagna, lontano da tutto e tutti e la
cover dell’album, con Bjorn barbuto e tra i cespugli di uno scatto virato
sepia, a sintetizzarne perfettamente il mood.
Del resto, il biennio 1998-2000 è un periodo irripetibile per Bergen e il nuovo Bjorn: i seguenti singoli sono bombe per la nu disco Norvegese che nel
frattempo cresce a dismisura facendo quadrato attorno alla Tellé il cui primo singolo è anche un emblematico ritratto di famiglia. In Disco / Song For
Annie è Torkse, Erot e The Mundal Explosion ovvero Anders Moe e lo stesso
Torske, mentre l’anno seguente il singolo So Easy, è il prodromo della super
bomba che saranno i Röyksopp. Nel frattempo, Bjorn studia da vicino le
produzioni di Daniele Baldelli, una lezione fondamentale per comprendere tutta la nuova dance norvegese e il singolo Sexy Disco ne è una testimonianza inconfutabile: il dj taglia un’ottima funk house a basso bpm che, se
da un lato, filtra sui bassi come da scuola Daft, dall’altro richiama massicce
dosi di cosmic disco e tribale da Baia degli Angeli.
L’era della disco non ha mai smesso da parte mia. Si è soltanto trasformata in
differenti generi di club music. Se ascolti la musica degli ultimi vent’anni e la
paragoni ai quella dei 70s ti accorgi che è la stessa formula, soltanto divisa in
numerosi frammenti…. …Vedo la scena norvegese come una parte giovane e
vitale delle sonorità euro disco, specie se osservata da un angolo molto Giorgio Moroder-esco. (Family-house.net, 2007)
sogno norvegese
Trasferitosi nel piovoso capoluogo universitario di Bergen, cittadina alle
porte di una rivoluzione di cui ancora non sa (e tanto meno conosce la portata), Bjorn è pronto a rifarsi una vita. La città brulica di talenti, energie e
delle perfette sinergie. Una di queste s’attiverà portando in town Torbjørn e
Svein, nel frattempo diventati Röyksopp, l’altra conoscere Andreas Kroknes
ovvero Erot, un attivissimo dj, e la sua ragazza Annie, nonché un giovane,
Mikal Telle, che sta già pensando di aprire un negozio di dischi/label, proprio come aveva fatto a suo tempo la Warp al FON di Sheffield.
Passano altri due anni e il producer sfoga gli ultimi pruriti del passato
unendosi a Per Martinsen in un progetto ambient-techno: Anon (2), la
cui Moods compare nella pregevole compila Arctic Circles: A Selection Of
Sub Zero Soundscapes. E’ l’ultima parentesi. Bjorn Torske debutterà ufficialmente come se stesso l’anno seguente e il 1998, sarà anche, oltre che il
suo, l’anno della Tellé, l’etichetta chiave per lo sviluppo della scena dance
norvegese. Sotto la label inoltre esce l’ottimo Nedi Myra: un lavoro che ha
un altro passo rispetto a quanto fatto fin’ora, immerge il pallido sound scifi del passato in un’africa di percussioni e ritmi funk. Dall’ambient house
degli Alegria, il dj punta a un mix di synth ghiaccio e caldi Korg, percussioni
etno e cassa non sempre in quattro. Soprattutto meticcia un mix parecchio
suonato e 70s che è poi anche il suono now on degli illuminati della scena
su FBU Recollection in Rare Altitude, necessaria compila con Erot, Mental
Overdrive e altri.
Ricordiamolo, il 1998 è anche l’anno di Music Sounds Better With You. Si tagliano funk ’70 à la Daft Punk, o meglio Stardust (Expresso), si mescolano
breakbeat firmati Boards Of Canada - ma anche Röyksopp prossimi venturi
24
25
S krangle - house
La calda febbre disco delle produzioni di Bjorn e Erot contagia non solo
Bergen ma l’intera Norvegia. A Oslo nella venue Skansen, animata dal giro
The Idjut Boys, nasce il termine “skrangle-house” che viene presto affibbiato
alla magica coppia che risponde con singoli come Søppelmann, Aerosoles
(sulla svedese Svek) e Disco Members (su Tellé) che saranno le hit del movimento e la base per la next generation di producer space disco scandinavi.
La Skrangle house è una specie di inside joke, ammette Torske a The Wire. Si
riferisce a tutti quei suoni sciolti e vellutati della nu disco. E’ house music composta quasi come se fosse stata fatta nei 70s. Per me è una versione più dub e
unicamente strumentale dei suoni della disco sommersa di quel periodo rivitalizzata attraverso strumenti moderni… […] Più che cosmica è spaced-out
e emerge dall’incrocio di generi funk, jazz e rock che il progressive introdusse
negli anni Settanta, anche se forse tutto potrebbe essere iniziato con la nascita
della Roland Space Echo… (Family-house.net, 2007)
E la skrangle diventa quindi il sommerso/emerso delle star norvegesi del
mainstream europeo. E’ il 2001, l’anno di tanti cambiamenti belli (e dolorosi). Melody A.M. dei Röyksopp e Quiet Is the New Loud dei Kings Of
Convenience fanno due botti contemporaneamente: uno perché è il riassunto di quanto vi abbiamo detto finora sotto la chiave del pop; l’altro
per il cosiddetto NAM, il New Acoustic Movement, etichetta inventata dalla
stampa per raggruppare le nuove voglie folk del sottobosco europeo. Sono
esplosioni fragorose. Ed è pure l’anno della scoperta da parte della stampa
estera specializzata della Smallsound supersound di Oslo, dei lavori di Kim
Hiorthøy, e del lutto improvviso di Erot per un difetto al cuore congenito.
Se ascoltate Haribo di Erot nella compila FBU capirete perché quella morte
traccia inevitabilmente per tutti i protagonisti della scena una demarcazione definitiva. Il segno che le cose non potranno più essere le stesse. Il
secondo grande spartiacque di questa storia.
La
lo - fi disco, concretamente
80 s
Trøbbel (Tellé 2001) è il post per Bjorn, la sua risposta come autore, un
mondo nuovo. Il disco dell’oltre Bergen. E’ il primo album ad utilizzare field
recording come pure quello che preconizza il ritorno degli anni Ottanta. Per
la prima volta, il ragazzo di Trømso inizia a navigare in una terra di nessuno,
a fare quello che gli pare e nel farlo procedere in linea parallela con la nascente scena folktronica di Books, Four Tet e non ultimo l’amico Hiorthøy,
personaggio che lo influenzerà sempre di più nel corso degli anni proprio
per la microfonazione del frammento sonoro e per quel modo nordico leggi riverberato - di utilizzarlo.
Trøbbel è il primo lavoro di una mentalità nuova e rappresenta l’inizio di
lavori apparentemente svagati e easy listening, in realtà mossi da jam improvvisate e lunghi lavori in studio dove l’house è cucinata in casa (Brus)
ed è soltanto una piccola parte della proposta. La mentalità laboratoriale e
imprevedibile che sottende Bjorn ora prevede già da ora paiette e leggerezza ’80 come l’abbiamo intesa negli ultimi quattro anni (Don’t Push Me),
certo post-punk elettronico trattato con il consueto sguardo felpato (Hard
Trafikk), bassi dub e levare reggae/dance hall (Bobla) nonché giochetti in
bassa fedeltà (la techno sotto formalina di Knas e Knekkebrød che fanno
molto Mille Plateaux).
Non ho studiato - ci dice - e creare musica è per me come scolpire suoni oppure
26
come farsi un piatto di pasta. La mia preferita sono le penne all’arrabbiata.
Fai il soffritto, metti il sugo, aggiungi le spezie e mescoli. Allo stesso modo una
mia traccia nasce da un ritmo, dai claps, oppure da qualche suono catturato
strutturato in loop a cui aggiungo un sacco di delay…
I l gap e la seconda
L a space disco
ondata cosmica norvegese .
In pratica, quella dell’album è una tracklist in sintonia con la Smalltown
Supersound, l’etichetta per la quale l’amico Kim disegna anche le copertine
(quella di Kokning è sua) e dove Bjorn si accaserà sei anni dopo. Il motivo
del gap, il biondo, stando a quanto ci ha raccontato al telefono, lo attribuisce alla quasi banca rotta di Tellé, ma è molto più probabile che ci sia
dell’altro che non è dato sapere. La pausa di riflessione è tuttavia soltanto
a livello compositivo. Bjorn infatti compare in un’ottima compila come dj
curator. L’album s’intitola senza troppa fantasia Nordic Chill ed esce per la
serie World di Dj Magazine e, oltre ai consueti tocchi cosmic, troviamo un
interessante e piuttosto inedito taglio black (percussioni scure, hip hop)
che Torske ama fin dagli Ottanta. Ottanta vissuti veramente e a tutto campo i suoi, la cui riscoperta sta diventando la base per un giovane Prins Thomas le cui tracce qui presenti sono tra le prime da lui composte. Bjorn è
stato il primo talent scout della nuova, autoproclamata, scena space disco
che avrà in Lindstrøm, lo stesso Thomas, Todd Terje e Fenomenon il proprio
epicentro.
E basta sentirli quei dischi, quell’onda di felpata dance è senz’altro figlia di
Torske e si farà conoscere e riconoscere a livello internazionale molto di più
di quanto lui ed Erot erano riusciti a fare con la skrangle. Nel 2005, i producer Space Disco sforneranno una compila manifesto Prima Norsk 3 - The
Space Disco Edition e un primo long playing firmato dagli autori della situazione Lindstrøm e Prins Thomas con il primo, su un piano propriamente dancefloor, a diventare il più richiesto remixer del biennio 2005-2006
- M.A.N.D.Y. (I Feel Space, 2005 su Body Language Vol.1), LCD Soundsystem
(Tribulations, 12” su DFA, 2005) e Franz Ferdinand (I’m Your Villain 12” su
Domino, 2006).
In quel biennio Bjorn è assente, pubblica un 12” con Crystal Bois, As’besto
(Sex Tags Mania, 2006) ma è praticamente introvabile e una dichiarazione
di Prins Thomas apparsa su Fact Magazine in quel periodo riassume come
meglio non si potrebbe la situazione: “Se potessi cavarlo fuori dalla caverna
per un secondo, non ci penserei due volte a fargli pubblicare della nuova musica”.
H omebaked
house
Smalltown Supersound ha sempre avuto a cuore i talenti del suo Paese
e offre un contratto a Bjorn nel 2006. L’agognato seguito di Trøbbel, Feil
Knapp, esce l’anno seguente e quel trentenne che ha mancato di proposito l’intercity della space disco continua da dove lo abbiamo lasciato, da un
percorso personale fuori dalle mode e dagli schemi, eppure così tangente
ad essi; con un sound che tende ancor più alla soundtrack immaginaria di
Eno-iana memoria, ma invece di cercare la catarsi si fa collettivo.
L’opener del disco, Hemmeling Orkester, è pura glassa all’ananas (Synphonie) tra Kraftwerk e Michael Rother, lo stesso terreno in cui Be Invisible
Now, Jonas Reinhardt e Expo ’70 si muoveranno di lì a poco, lo stesso
27
krautismo virato cosmic parente di quell’altro che così tanto ha ispirato la
cricca DFA a inizio Duemila, quella stessa mentalità che Bjorn è pronto a
non trasformare in ortodossia.
Quando compongo spesso immagino dei personaggi immaginari di una band
suonare gli strumenti, e di ognuno creo le personalità a seconda degli strumenti che utilizzano. Può suonare un po’ schizofrenico, ma penso sia una buona idea per la dinamica della composizione. Essere soli nel processo creativo
è limitante, spesso mi rende cieco su quello che vorrei invece realizzare (The
Wire #321).
Come nel precedente lavoro, la tracklist è varia come non mai, spazia avanti
e indietro negli archivi della memoria, soprattutto ci si respira maggiore
organicità e spettro strumentale più variegato. Bjorn suona tutto da solo
ma si fa anche aiutare da alcuni amici come i Kaptein Kaliber (John Hegre,
David Aasheim) e Jørgen Træen (ovvero Sir Dupermann, Toy).
E’ come ‘aspetta un attimo sto registrando…’ e poi loro bussano di nuovo
dicendomi ‘ho portato un banjo posso unirmi?’ e io ‘ma certo!’
Lo spirito rilassato da comune hippie di flat mates è evidente negli amati
tagli dub di due tracce dal sapore hauntologico: la prima ironica e basata su un videogame per Commodore 64 (Spelunker), l’altra ancor meglio
- veramente eccellente - nel mescolare umori Ghost Town marca Specials
sciogliendoli in un motivetto soundtrack nostrano, piano, tromba, pizzichi
di corde e oculatissimi riverberi lunari (Kapteinens Skjegg). Grace Jones fondeva dub e disco come pochi negli Ottanta, ci dice Bjørn senza remore.
E lo scivolo spaziale? C’è ancora, ma è subliminale: Hatten Passer, sotto una
struttura Roland pop à la Inner City, nasconde l’exotica spaced out di Piero
Umiliani immersa in calde, concrete, percussioni post-Can. In questa traccia, in particolare, degno di nota è pure l’elemento kitsch, un liet motiv per
fischiettio da boyscout parente dei recuperi che Luke Vibert sta (ri)riportando alla ribalta nella scena elettronica proprio nello stesso periodo. Poi
c’è tutta la corrente summery e post-lounge novanta: Loe Bar, è pre-glo a
tutti gli effetti (ma perché è ambient house 92), Moliekalas, assaggia tropicalismi che diresti Vampire Weekend, God Kveld, si muove tra disco music
e svago eighties, Fembussen Hjem punta ancora sui sixties italiani.
Feil Knapp non è un album elettronico, sono soltanto due le tracce che
suonano tali e a ben vedere sono costruite su campionamenti e loop riconducibili alla folktronica (Tur I Maskinparken e Orkenrotta) o al sound di Toy,
il progetto dell’amico Træen. E’ sicuramente un album di vintagismo tasti
eristico, ma non è un’operazione citazionista come se ne sono viste tante
nei ’00, compresa l’ultima, deludente, fase di Mental Overdrive di Per Martinsen. E’ hauntology e lo sarà sempre più.
H aunted
quale l’elemento acustico e il suo riverbero diventano fondanti, dove c’è, se
vogliamo, più chitarra e l’essenzialità rappresenta il vero valore.
Più che negli album sono legato al suono dei 12’’ e dei vinili. Penso sempre a
come potrebbe suonare quello che sto facendo su vinile e Kokning è stato pensato su quattro lati di musica, dunque da due 12’’.
Dietro la calzantissima metafora del titolo dell’album - Kokning significa
cucinarsi il pesce appena pescato, ovvero farsi le cose da sé, slow food a
proprio modo - Bjorn ancora una volta è oltre se stesso, dentro il passato,
proiettato in un mondo parallelo che l’etichetta discografica si diverte a
catalogare come una versione disco di Moondog (il compositore-barbone
cieco che fa capolino negli intarsi della traccia finale Furu). Ugualmente si
potrebbe osservare l’album dall’angolazione hauntologica riferendola però
all’house, una modalità di rivivere il passato che ci rimanda anche al lavoro
di Ariel Pink sempre nell’epoca Reagan. Oppure come una narrazione tangente a certe eteree autorialità wave tipo Durutti Column.
Del resto, Torske ora è ancor più libero di pensare a sé, sicuro che le persone
che contano si sono accorte di lui. Sunburned Hand of the Man, Crimea X,
Big Robot gli chiedono remix. Lindstrøm pure e lo tratta come un maestro.
La sua musica è cercata per installazioni sonore e lui stesso si cimenta con
una band per suonare dal vivo e non più soltanto come dj. Bjorn Torkse
è un patrimonio indispensabile per chi ama la musica di confine. Quella
che non cerca clamori. Che si presentata in spoglie casual per scremare gli
avventori e non pensa di farti vedere una luna che, a ben vedere, da lassù
si vede eccome.
graffitti
L’aspetto più affascinante di Bjørn Torske è il lavoro di sintesi, quel distillare fascinazioni in maniera apparentemente svagata che da soundtrack
finiscono per diventare narrazione post-moderna, in pratica folk. Un unico
linguaggio dove tutti i nati a partire dai Settanta possono sentirsi a casa,
tanto al Nord quanto a al Sud del mondo, come fu per il rock per i loro padri. Un mondo ascritto e vissuto fin dalla nascita di suoni analogici e primi
videogame.
Il lavoro di ripresa delle sonorità con cui lo stesso Torske è cresciuto sublima
nel recente Kokning, album registrato in un seminterrato senza finestre nel
28
29
Coldcut
—We Love Ninja Tune—
Drop Out
Venti candeline da spegnere sulla
torta per i Coldcut, fondatori e
PR della bisnonna del panorama
underground-electro-hop UK
Testo: Marco Braggion
T
empo di anniversari, tempo di compleanno
ventennale in casa Ninja Tune. L’etichetta
simbolo del downtempo e dell’hip-hop underground britannico da mesi posta e-mail
con link a dischi, EP, singoli e paraphernalia per i fan
più incalliti, ma anche solo per i curiosi dell’ultima
ora. In più, da qualche mese circola un box commemorativo che non guarda al passato con inutili ristampe e lacrimucce di coccodrillo e fa il punto della
situazione now, presentando i nomi più innovativi
della scena. Sdoganata dal suo passato chill-out, la
Ninja con la Warp (che guardacaso proprio l’anno
scorso ha celebrato pure il suo ventennale) rimane
uno dei punti di riferimento per l’underground britannico che innova sul continuum del bbreaking.
Sia esso hip-hop, mesh, electro o techno. Abbiamo
inseguito i Coldcut - fondatori e padri nobili dell’etichetta - per un mese. Tra ritardi, misunderstandings
e contrattempi, siamo riusciti a sentire via telefono
Matt Black (che divide la paternità della label con Jonathan More) solo qualche giorno fa. Partiamo con
l’intervista fiume in esclusiva...
Mi piacerebbe partire dall’inizio. Ho letto
che il nome Ninja è stato inventato durante
un tour in Giappone. E' vero?
Sì. Era il 1990. Eravamo in tour con Norman Cook,
30
31
che sarebbe diventato di lì a poco Fatboy Slim. In Giappone è stato uno shock per
noi: abbiamo raccolto input e con il tour ci siamo fatti molta esperienza. Una sera
abbiamo visto alla TV un film di serie B pieno di stereotipi sui ninja. Non capivamo
nulla, guardavamo solo le immagini e ascoltavamo la musica. Poi abbiamo visto i
ninja anche su una rivista, così io e John abbiamo pensato di utilizzarlo come personaggio e simbolo. In seguito ci ha dato l’ispirazione per iniziare con la label.
Mr Scruff
Com’era lavorare in quegli anni? Era più difficile o più facile di oggi? Ci
si divertiva di più?
È una domanda impossibile (ride)! In qualche modo era più facile quando eravamo
ragazzi. D’altra parte va bene anche essere adulti. Penso che nella mia vita le cose si
siano sistemate per il meglio quando sono cresciuto... In quei giorni la vita era più
facile. Quando abbiamo iniziato a fare dischi come Coldcut non avevamo tastiere
o computers. Avevamo solo un mixer, due piatti, dei vecchi vinili e un registratore a
cassette. Quello era l’approccio minimalista dell’inizio degli anni Novanta.
Sì, ma già a quel tempo facevate anche dei bei video. Era strano fare
dei video basandosi sul break dell’hip-hop e sui pezzi di turntablizm
(penso al classico video con gli insetti di Natural Rhythm). Perché avete
iniziato a produrre clip?
©emma gutterdige
Era un settore nuovo ed eccitante per sperimentare. Abbiamo capito da subito che
potevamo utilizzare le stesse tecniche che usavamo per creare i suoni e applicarle
al video. L’esperimento era tutto lì: vedere quello che succedeva qualdo campionavi spezzoni televisivi, quando mettevi in loop pezzi di video, quando li processavi
e ci mettevi degli effetti. Quando mettevi più piani uno sopra l’altro, quando facevi
il mix di diversi video in multilayer e quando poi alla fine ci mettevi il suono. Credo
che potesse essere definito come hip-hop visivo.
Una delle cose che ci faceva andare avanti era appunto provare nuove soluzioni,
sperimentare con nuovi media. Tutti quei video sono stati fatti con un computer
Amiga, che era l’unica macchina a quel tempo che ti permetteva di giocare con i
video sul desktop. Io avevo un background informatico: negli anni Ottanta lavora-
vo come sistemista di computer graphics e ho programmato anche dei semplici
videogiochi. Il video di Atomic Dog di George Clinton in questo senso mi ha influenzato molto, perché mescolava riprese dal vivo con la grafica dei computer, ma
non erano effetti speciali super costosi, erano grafiche che sembravano venir fuori
da un gioco elettronico (la traccia sarà alla base anche del successo gangsta di
Snoop Doggy Dogg Doggystyle, una hit anni Novanta per chi è cresciuto con l’hiphop americano sparato in cuffia. ndSA). Mi piaceva molto l’idea di poter produrre i
video con un personal computer casalingo.
The Bug @ Ninja Tune XX
©emma catlady
Avete sempre avuto anche un approccio alle grafiche eccellente. Non
solo per i video, ma anche per il packaging dei vinili e dei CD (ad esempio le grafiche nei dischi di Amon Tobin o nello stesso Box commemorativo). Pensi che per promuovere la musica è importante anche curare la parte grafica?
32
Penso che sia fondamentale. La copertina del vinile è come una tela, grande abbastanza per disegnarci delle visuals. Anche se ora è cambiato tutto con il CD e il
downloading, noi veniamo da quel periodo, quando la copertina e anche la stessa
label erano delle superfici con cui potevi giocare per esprimere la parte visuale.
Molti degli artisti che ci piacevano avevano un’identità forte. Penso in particolare
alla On-U Sound, l’etichetta di Adrian Sherwood (il leggendario produttore dub
inglese, ndSA) che aveva un fortissimo look grafico in bianco e nero e un forte appealing per i collezionisti, con tutte quelle edizioni limitate di singoli dubplate.
La On-U Sound è stata un precursore della Ninja Tune per quanto riguarda il suo
stile e identità. Io e John avevamo entrambi un passato come visual artists, è stato
naturale combinare questo con la musica. Gran parte del successo della Ninja Tune
l’abbiamo ottenuto promuovendo un’identità visuale forte. All’inizio uno dei miei
migliori amici del college, Mark Porter ha disegnato i font della Ninja, poi Strictly
33
Kev (aka DJ Food) negli ultimi 15 anni ha curato l’immagine della nostra etichetta.
Lui ci ha dato la direzione e la visione per la grafica dello stesso ninja, che è mutata
negli anni in diverse forme e stili.
Dj Food @ Ninja Tune XX
Sono d’accordo. Guardare al futuro è più bello e divertente. Naturalmente siamo
ancora orgogliosi del nostro passato. Di artisti come Amon Tobin e Cinematic Orchestra oggi puoi vedere ad esempio l’evoluzione della loro proposta. Ci siamo
esaltati per la new wave di suoni elettronici inglesi di gente come Dorian Concept,
Flying Lotus, Floating Points, Zomby (4 dei miei preferiti). Vogliamo promuoverli, appoggiarli e creare associazioni con altri artisti. La Ninja è sempre stata una
label che ha guardato al futuro e si è presa i suoi rischi. Ha supportato suoni nuovi,
rudi, non raffinati, inesperti, alternativi e undergound.
Penso che il Box sia una delle migliori compilation che la Ninja abbia mai pubblicato fino ad oggi. Siamo riusciti a prendere al volo questa nuova onda di brutalità che
combina bellezza e asprezza: un approccio nuovo, utile e popolare. Personalmente
mi piace qualsiasi cosa di questi nuovi suoni, basta che non diventi una formula.
Lo scorso weekend sono andato a suonare a un festival in Polonia; parlavo con una
ragazza e mi diceva che ascolta molto funk. Mi sono sorpreso, perché ho pensato
che quella musica è così distante dal mio mondo. Quello che conta è che è stata
fatta da gente nera.
In questo senso anche noi paghiamo un grosso contributo all’eredità della black
music. Sono diventato un maniaco di quelle sonorità quando ero studente. Era
qualcosa in cui mi ritrovavo: la soulfulness. la ribellione, la bravura tecnica, e i sentimenti che che sono espressi dalla musica soul funk e reggae. Ninja Tune e Coldcut
non potrebbero esistere senza quelle musiche.
Poco tempo fa abbiamo intervistato Andreya Triana. Lei è una delle
promesse della vostra label e ci piace il modo in cui connette il soul alle
nuove sonorità dubstep (il remix di Mount Kimbie per A Town Called
Obsolete) o wonky. Ti piacciono il dubstep o il wonky?
Sì sì mi piacciono molto entrambi. Per me non sono stili che si escludono l’uno con
l’altro. Non sono qualcosa di limitato: dipendono molto dai loro riferimenti, così un
album può essere techno dubstep reggae; è possibile combinarli, dato che sono
strettamente correlati l’uno con l’altro. Non mi fanno paura tutte queste tag, non
sono limitanti. Il dubstep è stato eccitante negli ultimi anni: quel suono ‘wah wah
wah’ è già diventato una formula, probabilmente verrà riciclato e riusandolo verrà
reinventato ancora una volta come tutti gli altri geni.
Penso che i generi subiscano un’evoluzione genetica, che comprende sopravvivenza e mutazioni. Anche per il wonk è così. Il dubstep è una reazione alla musica
house, mentre il wonk è una reazione all’hip-hop: entrambi usano heavy bass e
produzioni massive, più libertà nella costruzione del suono e del ritmo in particolare. Quello che fa Flying Lotus con i beats una volta pensavamo fosse troppo fuori
di testa. Oggi niente è troppo fuori di testa per non essere considerato musicale. Il
dubstep e il wonk hanno portato un po’ di apertura verso la sperimentazione. Tutto
ciò si mette in relazione anche con Andreya Triana: quando riesce a mettere sullo
stesso piano umano e macchinico. La musica elettronica astratta e strana può essere sterile, ma quando ci aggiungi la voce - che è il primo strumento - e le parole,
34
©emma catlady
Parliamo un po’ del box per l’anniversario. Mi è piaciuto molto, perché non mi sembra che sia tanto una celebrazione delle glorie passate, quanto una cosa che punta al futuro. Avete inserito una valanga di nuovi artisti come Zomby, remix di nuove persone che stanno
emergendo dalla nuova scuola elettronica UK. State spingendo i limiti
dell’hip-hop e dell’elettronica?
allora porti la tutto su un altro livello.
Mi hai detto che ti piace Zomby. Il suo approccio ricorda anche la scena rave dei primi Novanta inglesi. Negli anni Novanta andavate ai raves? Te lo chiedo perché il critico musicale Simon Reynolds dice che voi
eravate la risposta chill-out alla generazione rave che si strafaceva di
ecstasy. È vero?
Puoi vedere l’intera storia della Ninja Tune come una guerra alla house music.
Quando la gente ha iniziato a parlare di super clubs e ‘super star DJs’ la musica che
seguiva questi slogan era tipo Mc Don’s . Mi spiego: se voglio mangiare bene non
vado da Mc Donald’s e se voglio buona musica non vado da Mc Don’s, perché quello che mi darà sarà merce industrializzata, una versione debole della ‘real thing’.
Allo stesso modo noi ci siamo ribellati. La musica house è una grande forza piena
di potere e io la amo ancor oggi, come amo James Brown. Sono diventato allergico
però al pagckaging con cui la confezionano.
Ho sempre preferito la chill out room alla main room, perché mi piace parlare con
la gente, mi piace prendere una tazza di chai, farmi una canna, guardare la gente
e sedermi, guardare i video. È un ambiente in cui mi trovo meglio. Quando vado
nella main room e ballo, dopo un po’ mi annoio se è sempre “dum dum dum”. Ninja
Tune si ribella a quella ripetizione e mette in discussione la monocultura nell’intrattenimento musicale. Facciamo una resistenza come l’Underground Resistance
di Detroit che si oppone al mainstream. Considero la Ninja come un’alternativa al
mainstream. Non siamo separati dal mercato, siamo anche noi parte del tutto, ma
è bene sapere che ci sono buone alternative.
L’anno scorso la Warp ha fatto il ventennale. Quest’anno tocca a voi.
Penso che siate le due etichette più importanti dell’underground elettronico inglese. Nei Novanta, Warp ha preso la strada dell'IDM, voi
35
quella del chill ambience. Nel Box c’è pure un remix degli Autechre. C’è
qualche connessione con i ragazzi di Sheffield?
Ho descritto la Warp come ‘la sorella cattiva’ della Ninja. Noi amiamo la Warp, e
pensiamo che queste due etichette siano i due attori principali nella scena elettronica inglese. Mi piacciono molto gli Autechre, e li conosco di persona. La scena
non è poi così grande, bene o male ci conosciamo tutti, quindi è facile passare da
un universo all’altro. Un altro artista che conosco personalmente è Aphex Twin.
Gli ho venduto dei sintetizzatori qualche anno fa. L’ho visto da poco a un party con
Stictly Kev e Mixmaster Morris. Alla fine ci troviamo negli stessi posti con la stessa
gente ed è bello condividere quei momenti insieme. Oltre a ciò, c’è anche un po’ di
competizione. La Ninja non ha mai fatto il successo della Warp, ci prendiamo meno
sul serio. Se fai un confronto tra i due ventennali, penso che noi siamo riusciti però
ad organizzare i party più belli. Stiamo guardando al futuro in modo sexy, rude e
forte come la Warp: entrambe le etichette stanno facendo musica nuova, quindi la
competizione ci sta. Una sorta di amore/odio salutare.
Cosa stai ascoltando adesso?
Low Limit sulla Numbers di Glasgow, Teebs su Brainfeeder (la label di Flying Lotus),
e la traccia dei Detroit Grand PuBahs Sandwiches.
Verrete in Italia come Coldcut o come Ninja Tune?
L’Italia non è mai stata un grande terriorio per la Ninja. Penso sia un peccato perché amiamo l’Italia. Le donne sono bellissime, il cibo è ottimo e sappiamo che c’è
molta gente che ascolta musica. Mandateci degli inviti, comprate la nostra musica
e verremo di sicuro!
Roots Manuva @ Ninja Tune XX
Ninja Pills
10 (+1) dischi imperdibili dal catalogo dei guerrieri del break
Bogus Order - Zen Brakes Vol. 1 (1990)
L’inizio di tutto. Dopo essere stati in tour in Giappone ed aver pubblicato alcuni remix in white label, i futuri Coldcut fanno uscire un vinile a nome Bogus Order. Parte così l’avventura immersa nel
breakbeat UK, vicina alle sperimentazioni da club in ossessione electro ma aperta ad esperienze
su altri pianeti. Molti cuts non sono ancora orientati verso il chill-out che caratterizzerà il suono
Ninja degli anni Novanta. Qui si possono invece respirare venti tribali (Zen In Africa), sonorità da
visionari in acido (il mito Goa in One More Summer Of Zen) e uptempo reggae che ci saluta con il
sorriso dei tramonti ibizenchi (Granny Zen). Un miscuglio che oggi sembra una polaroid adolescenziale, scattata in velocità, senza troppo preoccuparsi della definizione dell’immagine. Il big
bang da cui attingere in seguito è tutto in questi scazzatissimi 27 minuti. Keep it going, guys! DJ Food - Jazz Brakes Vol. 1 (1990)
Primo di una lunga serie di album (arriverà fino al quinto volume) costruiti apposta per i DJ e
i maniaci del turntablizm. DJ Food sfoggia loop sciccosissimi, grondanti funkytudine e fascino
acid-jazz: sonorità che in quegli anni avrebbero portato al successo internazionale di meteore del
calibro di Incognito e US Tree. In Inghilterra la Ninja apre una stagione per chi non si riconosce
più nell’ecstasy e guarda con ammirazione alla difficile arte del mescolare i dischi sballando più
comodamente con la beneamata cannabis. DJ Shadow, la scuola illbient americana, il ritorno di
fiamma del downtempo di Thievery Corporation e centinaia di altri illustri sconosciuti si sono
fatti i calli nel mixare le tracce strumentali del progetto Food (l’artista non è infatti un singolo
uomo, bensì incarna le anime dei Coldcut prima, di Patrick Carpenter e di Strictly Kev poi). Più che un disco, una palestra e
una fonte inesauribile di tattiche ritmiche (Beats & Pieces, appunto resterà il motto dei Coldcut). L’ortodossia dei nerd parte
anche da qui.
Up, Bustle and Out - The Breeze Was Mellow (As The Guns Cooled In The Cellar) (1994)
Le prime incursioni nei suoni world le sperimentano DJ Ein, Rupert Mould, Senor Cuffy e Dave
Cridge. Il loro è un jazz influenzato dall’atmosfera che circolava nei locali più cool dei Novanta,
cioè quel gusto finto chic tramutato senza volere in kitsch modaiolo ed effimero, le atmosfere da
clubbino indipendente con il bravo DJ che mette la musica per pochi adepti. Per la prima volta in
casa Ninja (anche se solo sussurrando rispetto agli altri album) gli UBO sembrano essere una nota
fuori dal coro, e invece portano tra le altre cose il primo pezzo tratto dal canone cubano che con
il passare del tempo evolverà in una scoperta a tutto tondo di sonorità inesplorate, preferendo
sempre e comunque il catalogo di ritmi sudamericani. Ancora oggi (proprio quest’anno è uscito
il loro undicesimo album Soliloquy) Ein e Mould non appendono gli strumenti al chiodo. La loro
proposta è la prima sfida off che la Ninja propone ai suoi fan. Uscendo dai binari monomaniacali della street culture. Ethnohop come ulteriore ago della bussola.
Funki Porcini - Hed Phone Sex (1995)
Il primo grossissimo colpo al cuore. Un disco che scardina gli argini del dub e che promette mondi di puro godimento sonico. Funki Porcini è James Braddell, il re del downtempo. Con questo disco porta il dub nello studio, lo pulisce, lo fa suo e scatena una cosa che non si sentirà più. Perché
il dub a seguire sarà magari più minimale, più sporco, più contaminato, più techno, ma non così
intimo: il suono di quest’uomo - che non ama apparire in pubblico e che ancor oggi manda in
giro per gli uffici stampa una sua foto in bianco e nero degli anni Novanta - è una cosa unica, che
in quell’anno travolge e fa proseliti, consegnando alla Ninja (grazie alla hit King Ashabanapal, edita anche in un singolo a parte) un piccolo grande classico. James tenterà poi di cambiare strada
(con il caos break-junglistico di Love, Pussycats & Carwrecks) o di ricostruire il capolavoro (con l’onirico Fast Asleep), ma l’ironia
e la precisione sonica del würstel bruciacchiato in copertina saranno impossibili da bissare. Over the top. 36
37
Amon Tobin - Bricolage (1997)
Jaga Jazzist - A Livingroom Hush (2002)
Il visionario che viene dal Brasile e per questo inserisce delle patch di suoni caldi nel continuum
inglese. Ma non è il solito downtempista da strapazzo. Amon Tobin piazza delle bordate break che
da qui in poi esploderanno in visioni sempre più arzigogolate, ereditate dalle sue prime mosse
nella diaspora post-pseudo-d’n’b col moniker di Cujo. Il basso di questo Bricolage è una cosa da
quintetto di Miles Davis tagliato in consolle, caldissimo, con gli scratch al posto giusto e con
quell’aria da fumo di sigaro che proviene dalla seconda patria inglese (Brighton) dell’uomo. Il
downtempo che trascina e che fa di questo esordio un biglietto da visita per le sue numerose
fuoriuscite dall’underground (una su tutte la colonna sonora del videogioco Splinter Cell). Sampling all’ennesima potenza per
Amon Adonai Santos de Araújo Tobin. Obrigado.
Ristampa acquisita dalla più piccola ma non meno importante Smalltown Supersound, il disco di
esordio del gruppo norvegese esplode come caso internazionale quando la BBC lo segnala come
album dell’anno. Preludio e conferma di una tendenza che da lì a poco scoprirà una miniera di
accostamenti interessanti e prolifici nel cosiddetto boom elettroacustico nordico: Kings Of Convenience, Röyksopp e Bjørn Torske. Un disco che ci fa capire come il fiuto dei Ninja non perda
mai la sensibilità necessaria per resistere al logorìo del tempo. Sempre pronti a tirar fuori dall’underground personaggi e sonorità di classe. Un miscuglio di bossa, cool jazz, chitarre à la Tortoise,
fiati e assoli bop che ricordano tra gli altri gli sciccosissimi Morphine (Airborne) e un calore che
affascinerà subito le platee di mezzo mondo. Il savoir faire che importa secoli di storia black e la filtra con un bianchissimo
tocco polar lounge.
The Cinematic Orchestra - Motion (1999)
La big band condotta da Jason Swinscoe e da Patrick ‘PC’ Carpenter (già membro del collettivo DJ
Food) con questo disco d’esordio fa il botto e da qui in poi diventa il nome di punta della label,
tanto che i suoi pezzi verranno pure suonati in numerosi spot e suonati in passerella. Anche se il
successo irride al combo mutevole, la qualità della proposta e la dedizione alla sperimentazione
non verranno mai meno con gli anni. Motion è l’esempio di come si possa fare dell’improvvisazione una pratica condivisibile anche dal grande pubblico. Un preludio a quello che in questi giorni
stanno facendo i Cobblestone Jazz con la techno. Kid Koala - Carpal Tunnel Syndrome (2000)
The Bug - London Zoo (2008)
Per chiudere degnamente la parziale carrellata non potevamo che scegliere il disco del pazzo
Kevin Martin. L’uomo dai milioni di alias (tra gli altri God, Techno Animal, Ice, Curse of the Golden
Vampire e Pressure) anticipa la moda mesh che pochi anni fa covava il botto imminente di M.I.A.,
Santigold e Major Lazer, oggi personaggi da copertina patinata più che da palco di festivalini
per iniziati. Dubstep mescolato al dancehall cupo e strafatto della Londra capitale delle sonorità
sempre e comunque avant. Un degno proseguio per le teorie millenaristiche di Tricky invasato di
techno e di sporcizia dissacrante. Disco del 2008 per l’influente rivista Wire. Segnatempo in divenire: da ballare, da sballare, per grandi e per piccini.
La lesson dei paparini Double Dee e Steinski nelle vene di Kid Koala. Lui è il nerd che accosta
sample inconsueti a una tecnica sorprendente (famoso per questo è il pezzo Drunk Trumpet, che
riesce a coniugare il suono melodico della tromba con le possibilità di modulazione ritmica del
giradischi). Eccellente video artist, cura le copertine dei suoi dischi con fumetti e video autoprodotti. Eric San prelude la cartoonizzazione dei Gorillaz dietro la sua mastodontica capacità di
utilizzare i samples e di alzare il giradischi a status di strumento musicale tout court. Non solo mix,
ma tool per creare nuovi suoni. Il degno erede di DJ Shadow e Cut Chemist. Maximum respect. Wagon Christ - Musipal (2001)
Tra le altre cose, Luke Vibert è passato anche per la Ninja. Con questo suo moniker sconsacrato
e irriverente esplora la dance con strumenti analogici, facendo del divertimento un imperativo
morale, vedi la dichiarazione d’intenti nell’intro The Premise: “I’m gonna fuck the whole world up!”.
Il miscuglio che solo in apparenza salta fra generi in modo spastico, lo consegna a un modo di vedere la musica che anticipa la grazia del frullato ‘00 wonky. Il suo mondo è quello dell’elettronica
che rende omaggio ai break di Squarepusher e Aphex Twin (suoi amici e conoscenti), alle visioni
Global Communication di Tom Middleton, alla sapiente arte del sampling, al drum’n’bass e alla
jungle - in quell’anno ormai solo un bel ricordo. Per molti non sarà un capolavoro, ma riascoltandolo oggi non ha niente da invidiare a chi cerca di costruire il beat perfetto con la più nuova release dell’ennesimo software
di sound engineering. Luke trova un modo intelligente di rimescolare l’hip-hop con atmosfere color pastello illuminate da
valvole e da calore soul. Anche lui per un attimo lunghissimo è human after all...
AA. VV. / Coldcut - Journeys By DJ - 70 Minutes Of Madness (2002)
Considerato da molti DJ e addetti ai lavori di musica elettronica come la più bella compilation
di tutti i tempi, questo disco riassume l’estetica di gusto sopraffino dell’etichetta e dei suoi fondatori. Difficile scegliere fra la sterminata produzione di Matt Black e Jonathan More, ma questo
capolavoro batte gli esperimenti visuali, i remix e le escursioni oltre i confini del break che i due
DJ hanno perseguito prima e dopo la pietra miliare. Settanta minuti che scappano velocissimi tra
amici ninja (Funki Porcini, Wagon Christ), mostri sacri dell’elettronica di ogni tempo (Mantronix,
Masters At Work, Plastikman e Photek) e le loro stesse rivisitazioni e remix. Senza tempo. 38
39
Recensioni
— cd&lp
highlight
AA. VV./Diplo - Blow Your Head Vol. 1: Diplo
Presents Dubstep (Mad Decent, Novembre
2010)
Genere: dubstep mesh
Diplo è il Dr. Dre degli anni ‘00. Nei Novanta era il rap
a farla da padrone, con tutta la sua pletora di catene
e dentoni dorati. Oggi, dopo quasi una decina d’anni
di underground, è proprio il dubstep che sbanca sulle
piste e sulle frequenze di mezzo mondo, sostituendosi
- per lo meno in Inghilterra - alla cultura americana da
strada. Diplo ci va di azione di ubermarketing massivo
producendo M.I.A., trasformandosi in cartone animato
con il suo progetto Major Lazer e tornando in solitaria
- sulla sua etichetta personale - per selezionare i nomi
più interessanti del panorama dubstep.
Tra i grandi: Zomby (con una Strange Fruit in visibilio
8-bit technoide) e Benga (con quel classico di basso
pesantissimo e laserato che è 26 Basslines); tra le nuove promesse Joker, Ginz e James Blake (già sentito in
numerosi EP e qui con degli stab da urlo su Sparing The
Horse). Non possono mancare poi le tamarrate di Rusko (il featuring da discotechina teen’n’bass di Amber
Coffman su Hold On ricorda tanto i Magnetic Man), di
Starkey (il vocoder nel remix per Rudy Zygadlo) e dello
stesso Diplo.
Un prodotto che fa il punto senza mix supertecnici
o figatine di produzione. Deciso a sbancare, Diplo ci
convince che è meglio battere il ferro quando è caldo. Le direzioni, i teoremi e le tesi di estetica le lascia a
qualcun’altro. Lui pensa a sfornare dischi e a farci ballare. E ci riesce di brutto. Se non l'avete ancora capito,
è uno dei personaggi chiave del suono now. Tenetelo
d'occhio.
(7/10)
Marco Braggion
Aedi - Aedi Met Heidi (Seahorse
Recordings, Novembre 2010)
Genere: folk rock
Dopo l'autoprodotto The Adventures Of Yellow del
2008 e l'apprezzato Polish EP dello scorso anno, gli
Aedi - un nome come minimo evocativo... - si accasano presso Seahorse e sfornano questo Aedi Met Heidi
40
A Classic Education - Hey There Stranger (Lefse, Settembre 2010)
Genere: psych pop
che in sostanza è il loro debutto ufficiale (se tale categorizzazione ha ancora un senso). Approccio fiabesco
e turbe indie, memorie punk che si sono fatte un giro
tra cartoon preadolescenziali, particelle art-folk sbocciate su praticelli spazzati da brezze wave, tutto un
giocherellare nel giardino di Kate Bush con balocchi
Cranberries e Mùm, ma con la serietà di chi a certi sogni ci crede.
Mantenendosi in equilibrio sul crinale tra affabilità e
bizzarria, tra delicatezza e veemenza (vi basti sentire
Geometric Plane e On The Second Floor), mescolando
carte con disinvoltura bjorkiana però addomesticata
Delgados, questo quintetto da Macerata prova a dire
la sua in un ambito relativamente inesplorato alle nostre latitudini (quali compagni di avventura ideali mi
vengono in mente solo i Grimoon). In bocca al lupo. (7/10)
Un canadese - chitarrista e cantante - più cinque italiani, col nido a Bologna ed il cuore sperso da qualche parte tra Londra e l'iperuranio pop che da sempre la circonda, dagli Zombies ai Clientele. Epperò
aperto a tutto un sentire british che aleggia sulle brume pazzarelle di Manchester e tra le fatamorgane
del Merseyside, con particelle Smiths e Teardrop Explodes a rendere cremosa la caligine extratemporale. Si chiamano A Classic Education e Hey There Stranger, il loro secondo EP, ci racconta un immaginario pop fatto di trepidazione e sussulti, di mistero sonnolento annidato tra i sogni, d'inquietudine
variegata dolcezza.
Il campionario semantico procede sul piano inclinato del vintage, ma non
si compiace anzi cavalca una bestiolina irrequieta che imbottisce d'urgenza le pur leggiadre I Lost Time e Gone To Sea, così come - per converso c'è pensosità obliqua nella post-wave trafelata di What My Life Could Have
Been. E perché non concedersi un goccio di french touch con la cover di
Toi, dal repertorio di Gilbert Becaud? Gli A Classic Education possiedono
una fragilità fiera e illuminata che per il momento significa stato di grazia.
(7.5/10)
Stefano Solventi
Stefano Solventi
Alex Cambise - Tre vie per un respiro
(Aipm, Novembre 2010)
Genere: rock melodico
Nasci a metà anni Settanta. Cresci negli Ottanta. Nei
Novanta ti appassioni alla chitarra elettrica e ti tocca
fare i conti con Yngwie Malmsteen, Kirk Hammett e tutta una pletora di musicisti tecnici fino all'inverosimile.
Percorso obbligato e questione di DNA. Come di DNA si
parla quando comincia a fare capolino tra i tuoi ascolti
quella tradizione italiana che fino al giorno prima magari bistrattavi. Ruggeri, Finardi, Renga, senza distinzioni. E poi il Ligabue che tutti conosciamo, quello
capace di sdoganare il rock da stadio politically correct
nel Belpaese - con Vasco Rossi, si intende - e al tempo
stesso di far credere a miriadi di musicisti nostrani che il
massimo dell'azzardo in musica sia far quello che fa lui.
Se poi cominci a collaborare con personaggi dell'area
overground (gente vicina a Tozzi, Alice, Paola Turci, Marco Ferradini) seguendoli sul loro terreno, il cerchio si
chiude e tu non puoi far altro che partorire un esordio
solista come Tre vie per un respiro. Un disco che assomiglia al lavoro di routine di un ufficio postale.
Il materiale è suonato in maniera impeccabile e ben
prodotto, in bilico com'è tra folk irlandese (La ragazza
di Longarone) e air guitar anni Ottanta (Fiori d'acciaio),
impennate vocali tipiche dell'ex front-man dei Timoria
(Oltre il tempo) e certi sogni di rock'n'roll in copia carbone
(S.r.l.). Radiofonico come lo vorrebbero ai piani alti della
discografia e melodico come richiede il popolo sovrano, con tanto di power drums e refrains al posto giusto.
Il problema vero, tuttavia, è che nei quaranta minuti di
programma non c'è una sola nota che non suoni prevedibile, rassicurante, istituzionale, conservatrice, paracadutata, standardizzata. In una parola, italiana. Occhi
chiusi sul mondo, testa bassa e nulla di più.
(4.5/10)
Fabrizio Zampighi
Amaury Cambuzat - The Sorcerer (Acid
Cobra, Settembre 2010)
Genere: kraut-elettronica
L'espressionismo muto di Friedrich Wilhelm Murnau
- chi si ricorda di Nosferatu il vampiro? - sembra essere particolarmente adatto alle sonorizzazioni postume.
E se qualche mese fa si parlava di una L'ultima risata
dei nostrani Drunken Butterfly soundtrack ipoteti-
ca dell'omonima pellicola murnauiana, ora tocca ad
Amaury Cambuzat (Faust, Ulan Bator) con The Sorcerer omaggiare il regista tedesco. Il soggetto questa volta è Tabù, film datato 1931 - nonché ultima produzione
del cineasta - e ambientato in Polinesia. Una riflessione
amara sul contrasto tra usanze tribali e sentimenti individuali nelle comunità arcaiche che in realtà diventa
metafora del peso che la società ricopre nell'influenzare
i rapporti affettivi e la morale comune.
Cambuzat non esita un momento a liberare la propria
vena evocativo-inquietante, collezionando nei quarantasette minuti del disco aperture strumentali che simulano lo shoegaze (South-Seas), citano il kraut sfilacciato
dei primi Faust (Palm Trees), abbracciano un ambient
onomatopeica ai confini con la psichedelia (Tropical
Waves, La nuit), cedono alle inevitabili fascinazioni percussive (Voodoo Doll). Un lavoro da certosino che più
che seguire pedissequamente le immagini a loro si ispira, compenetrando nella giusta maniera audio e video.
(7.1/10)
Fabrizio Zampighi
41
Andrea Belfi/Stefano Pilia/David Grubbs Onrushing Cloud (Drag City, Ottobre 2010)
Genere: post-rock
Fatto della pasta inequivocabilmente post-rock degli
indimenticati For Carnation (City Rats On A Mountain
Pass), umbratile come certi Gastr Del Sol e con
quell’espressione del viso stabile e concentrata, Onrushing Cloud è un disco fuori dal tempo, che catturerebbe anche i distratti.
Belfi / Grubbs / Pilia. Un trittico di nomi sinonimo di
qualità. Nel mezzo, uno dei principali traghettatori del
dopo hardcore verso le avanguardie, ai lati, forse i casi
più eccellenti del proseguimento di quella missione.
Epperò, lungi dall’essere eclatante, l’intersezione del
trio resta piacevolmente co-firmata e sospesa. Si sente Andrea Belfi nei ticchettii (delle dita sul tavolo in
Nitrated Out), l’inconfondibile melodia vocale di David
Grubbs nella title-track, la chitarra di Stefano Pilia
(Lightning Vault).
Onrushing Cloud non porta prigionieri, né conserva
conti aperti (da chiudere?) con il passato. Innegabile
che la sensibilità, espressa da due dei tre anche in altre forme e mosse musicali, non sia sostanzialmente
cambiata. Eppure, altrettanto evidente è il morbido
passaggio di consegne siglato da un disco che ci permette di guardare al genere che fu degli Slint non più
con gli occhi che vengono dal post-hc, ma con i filtri
dell’elettroacustica. Un cambio di prospettiva creato
negli anni, per iniziativa anche e soprattutto del trio
protagonista dell'album.
(7/10)
Gaspare Caliri
Apart - Digital Frame (Krysalisound,
Novembre 2010)
Genere: ambient
Francis M. Gri è un veterano della scena dark-ambient
internazionale ed è almeno noto per essere uno dei
membri fondatori del combo All My Faith Lost. Affrancatosi da quell'esperienza, che a giudicare da quello
che si legge in Rete è ben presente nella memoria dei
seguaci, il musicista italiano ha continuato il proprio
percorso affidando le proprie composizioni a due progetti: Revglow, in collaborazione con la vocalist Lilium,
e, appunto, Apart, che qui aggiunge un nuovo tassello alla propria discografia dopo il doppio dello scorso
anno, Winter fragments, e lo fa sotto l'egida della neonata KrysaliSound, etichetta anch'essa totalmente gestita da Francis M. Gri. Le cornici digitali del titolo sono
sussurri elettronici, parchi tappeti di tastiere e timide
percussioni che fanno da culla a nove brani pianistici
42
di forte atmosfera malinconica. Tranne un'intrusione
di violoncello (Gate 12) e della voce della sodale Lilium
(per l'eccellente crescendo di New Day ed Exit Dream)
il disco è tutto qua. Vi si ritrovano le atmosfere eteree
della scena dark primeva, ma anche una certa ricerca di
immobilità e di prolungamento del sogno in sfumature di grigio che ricordano anche alcuni brani dei primi
Sigur Rós. Sul fronte pianistico, il cuore di tutte le composizioni di Francis M. Gri, siamo di fronte a un equilibrio elegante, fatto di minimalismo, i riferimenti agli
aeroporti di enoiana memoria e a una certa ricorsività
sonora che fa pensare anche al kraut-ambient inventato sempre da Eno con i Cluster.
Al termine dell'ascolto di Digital Frame si rimane avvolti da un languore sincero, segno che l'obiettivo di
Francis M. Gri è raggiunto in pieno e ci fa salutare con
piacere l'avvio della sua etichetta.
(7/10)
Marco Boscolo
Ash - A-Z Series Vol.2 (Atomic Heart
Records, Novembre 2010)
Genere: Indie rock
A questo punto abbiamo il quadro completo del progetto con cui, Tim Wheeler e compagni, hanno tentato
la loro faticosa operazione di rilancio.
Dopo un primo capitolo caratterizzato da felici anthem
a presa rapida (cosa che dimostrano di padroneggiare
ancora con maestria), gli Ash utilizzano questa seconda tranche per concentrarsi su brani dal respiro più ampio e dagli più obiettivi decisamente più ambiziosi.
Purtroppo dimenticano che, storicamente, magniloquenza e pathos mal si coniugano il loro sound eternamente teenageriale e che la loro forza sta nello sciorinare un pop punk fresco e senza pretese.
La maggior parte dei brani di Vol. 2 si ricollegano al brit
sound metallizzato del periodo Meltdown, con qualche pericoloso scivolone in zona Muse (Spheres). I tre
irlandesi sanno di aver già portato a casa il risultato
col precedente volume, così provano a battere nuove
strade con risultati alterni. Nei dieci minuti della suite
strumentale Sky Burial, danno vita ad un interessante
psycho pop rock che guarda allo spazio, ma è con gli
spasmi elettrici della febbricitante Embers che appaiono nelle loro vesti più consone.
Nel complesso la missione può dirsi compiuta, anche
se rimango convinto che, con una cernita oculata, da
tutti questi brani si sarebbe potuto tirare fuori un album singolo stellare.
(6/10)
Diego Ballani
Asmara All Stars - Eritrea's Got Soul
(Outhere, Ottobre 2010)
Genere: Africana
Dura incidere un disco in Eritrea. Stato autonomo da
un ventennio scarso e, dopo una guerra sanguinosa
con i vicini etiopi, s'era in precedenza visto dominare
da Mussolini e dagli inglesi. Oggi, un’indipendenza figlia di un referendum popolare è scivolata in dittatura,
nella quale ci si può però informare e scolarizzazione
e sanità sono garantite. Sotto la quale vive un popolo
anagraficamente tra i più giovani del globo e pervaso da enorme ottimismo. In tale contesto nasceva nel
2008 il progetto Asmara All Stars, organizzato dal produttore francese Bruno Blum (già a fianco del Serge
Gainsbourg infatuato della battuta in levare), recatosi
ad Asmara per collocare sotto i riflettori una scena locale d’antico retaggio.
Vi ricorda un certo Ry Cooder in trasferta cubana? Anche a noi, specie per l’entusiasmo palpabile che emerge dalle registrazioni e per l’alternanza tra giovani leve
- Faytinga, Temasgen Yared, Sara Teklesenbet - e i
padri spirituali Brkti Weldeslassie e Ibrahim Goret (la
sua scarna Safir Hilet apice del programma, con la sinuosa Inedir cantata dalla più verde ugola di Adam Hamid). Riuniti in un panorama che mescola la tradizione
con abbondanti dosi di reggae, soul e funk e che già ha
fatto parlare di eri-jazz. Noi lasciamo umilmente perdere, ritenendo i paragoni fuorvianti - ingiusti, anzi - laddove le radici si spingono fin dentro la notte dei tempi;
semmai, annotiamo un esito più del lecito “patinato”,
lontano dalle imprese degli Ex e dall’epocale Buena Vista Social Club. Diverse sia la vocazione che l’approccio,
d’accordo, ma la mano di Blum si sente eccome, e spinge a riferire di un biglietto da visita gradevole per capire cosa c’è a monte. Ad Asmara, probabilmente, non
aspettano altro.
(7/10)
Giancarlo Turra
Atlas Sound - Bedroom Databank vol.1, 2,
3 (Self Released, Novembre 2010)
Genere: bedroom nuggets
Stavolta non lo ha fatto per errore, come successe per
la prima versione di Logos. In un anno che ha visto la
sua band principale, i Deerhunter, fare un salto in alto
ulteriore verso l'empireo dell'indie, e forse qualcosa di
più, Bradford Cox non riesce comunque a concentrarsi
unicamente su di un progetto. Troppe le idee che gli
vengono in mente, troppe le suggestioni e le storie da
raccontare in musica. Così scopriamo dal suo blog che
mentre usciva Halcyon Digest e per tutto l'autunno,
quando avrebbe dovuto essere impegnato a promuoverlo, Cox ha riempito tutti i buchi liberi per chiudersi in cameretta e registrare una serie di brani che ora
ci arrivano gratuitamente nel lettore mp3. Il titolo dei
volumi, Bedroom Databank, esplicita già il senso
dell'operazione: nuggets-delia da cameretta, composta, suonata e registrata completamente in solitaria a
nome Atlas Sound, che nel frattempo sembra essere
diventato lo spazio dove poter rinchiudere tutto quello
che la pressione della band-madre non gli permette di
sperimentare.
E che cosa troviamo dentro a questi primi tre volumi
(ma c'è da scommettere che la storia non finirà qui)? Nel
primo, quello che si basa su sintetizzatore e computer,
Cox infila le cose più genuinamente d'ambiente, figlie
di quell'ambient-pop, com'è stato definito, che determina fin dall'inizio le coordinate del progetto. Vi fanno
capolino anche due cover, una di Kurt Vile (Freak Train)
e Bob Dylan (These Wheel's On Fire), e brani puramente
strumentali che sembrano veri e propri studi (come si
dice in ambito classico) sui suoni. Fossimo nell'Ottocento, parleremmo di un taccuino di viaggio, dove gli
appunti sono stralunati stralci di psichedelia-folk-gaze
e il viaggio è tutto contenuto da quattro mura.
Nei seguenti due volumi entrano invece più che altro canzoni vere e proprie, basate su una strumentazione più tradizionale, ma dove il lavoro sugli effetti è
determinante per il sound complessivo. A volte si ha
l'impressione che la volontà principale di Cox sia quella di catturare l'essenza di un'atmosfera, di uno stato
d'animo e di trasmetterla agli altri, in uno stato di bulimia compositiva che riflette un'altrettanto insaziabile necessità di esprimersi costantemente con le note.
L'intensa attività ce lo fa immaginare come dominato
da un'attitudine tipica del mondo del jazz, in cui le
registrazioni sono solamente una fotografia istantanea di un processo che non comincia e non termina
mai. Anche con Cox, sottoforma di Atlas Sound e di
Deerhunter, siamo di fronte a un flusso ininterrotto di
idee e brani che a volte finiscono nei dischi, altre volte
finiscono in queste tapes.
Non tutto è, ovviamente, a fuoco e all'altezza del resto
della produzione di Cox, ma la varietà degli stili raccontano meglio di qualsiasi discorso il piacere onnivoro
della musica che lo anima e all'ascoltatore, addetto ai
lavori o meno, restituisce un'immagine a tutto tondo di
un compositore con il quale bisogna fare i conti.
(6.7/10)
Marco Boscolo
43
Badly Drawn Boy - It's What I'm Thinking
Pt.1 Photographing Snowflakes (Edel,
Novembre 2010)
Genere: folk pop
Ma che bella implosione, Mr. Gough. Che bel ritorno.
Dopo i colpi di testa e le fittonate para-prog che facevano inarcare il sopracciglio di sorpresa però accadevano - come dire? - un po' fuori dalla tua giurisdizione.
Insomma, qualche pisciatina fuori dal vaso l'hai fatta,
caro Damon, condita dalle molte mattane, dai bruschi
sbalzi d'umore e quegli scazzi in sede di concerto che
ti hanno procurato non la fama di rocker maledetto
(e quando mai?) piuttosto quella di capriccioso attaccabrighe più bizze che talento. E sì che di talento hai
dimostrato d'averne, tanto tempo fa. Adesso il ritorno
all'indipendenza per la One Last Fruit e questo primo
capitolo d'una trilogia nientemeno. Alleluja per il ragazzo disegnato male!
Ok, a dire il vero la copertina klimtiana surreal/simbolista non fa ben sperare, però poi t'imbatti in un folkpop estoplasmatico/trepido/acustico su quel letto di
evanescenze elettrosintetiche, fondale emotivo più
che atmosferico, e in quegli approcci cameristici che
hanno il merito di ostentare più pensosità che enfasi
(vedi What Tomorrow Brings), e ciò vale anche quando
metti in piedi una baldanza Morrissey tipo il singolo
Too Many Miracles. Massì, devo dirtelo, sono davvero
contento. Ti trovo in forma, malgrado tutto. Certo, si
sente che ci vai coi piedi di piombo, che prendi la mira
con cura. Lontanissimo è l'estro soave di About A Boy
(a parer mio il tuo capolavoro) e ancor più l'incontenibile stravagante immediatezza del debutto The Hour
Of Bewilderbeast.
Tuttavia proprio di quest'ultimo - che poi fu il primo,
dieci anni fa cribbio! - il qui presente It's What I'm
Thinking Pt.1 - Photographing Snowflakes potrebbe
sembrare il figlioletto timido, con l'Elliott Smith obliquo di This Beautiful Idea, con le tenerezze springsteeniane di A Pure Accident, con la fragranza indolenzita
vagamente Eels di The Order Of Things, con la folk ballad a giri bassi - e slide contrita - della title track, con
l'up-tempo tra Al Stewart e Belle And Sebastian di I
Saw You Walk Away. Forse potevi risparmiarci gli esotismi afrocaraibici della piuttosto insulsa This Electric,
però non c'è arredamento senza qualche nota stonata,
quindi ok, le tue trepidazioni di mezza età mi sembrano buone, deliziosamente depresse e fuori fuoco. Del
resto non è facile fotografare fiocchi di neve, vero?
(7/10)
Stefano Solventi
44
Banana Pill - Watercolor (Jozik Records,
Settembre 2010)
Genere: psycho drones
Duo proveniente dal nord della Russia trapiantato a
Helsinki, dove gestiscono una label e organizzano un
festival e vari eventi di musica sperimentale, i Banana
Pill sono un piccolo microcosmo psycho drone generato da quella scena sperimentale finlandese sempre
attiva, sebbene da qualche anno lontana dai riflettori. I
punti di riferimento di Watercolor sono piccole sinfonie
per synth impazziti, voci trattate e chitarre sghembe e
spaziali vicine allo stile della Ikuisuus e in particolare a
quello di Uton, con il suo sguardo rivolto verso mondi
lontani. A sorprendere è però la scioltezza e la spontaneità con cui drones e melodie vengono fusi in piccole
jam semi improvvisate che sembrano quasi invocazioni
al pigro sole del nord. I suoni, coloratissimi, si evolvono
in delicati mantra dalle tinte pastello, a volte addolciti
da malinconiche melodie di violino, altre enfatizzati da
corde e piccole percussioni. Non manca un tributo alla
terra natale nella splendida reinterpretazione di una
folk song tradizionale russa rivestita da un inedito tocco caleidoscopico. (6.8/10)
Gemma Ghelardi
Banjo Or Freakout - Way Slow Volume One
(Lefse, Ottobre 2010)
Genere: Indie
Quello di Alessio Natalizia è un nome che può suonare
sconosciuto ai non addetti ai lavori ma di cui in realtà si
è fatto già un bel parlare, dapprima grazie alla fortunata esperienza nei Disco Drive e più recentemente con
l'esordio di Walls, già culto presso gli appassionati di
chill-wave di tutto il mondo. Tra un gruppo e l'altro c'è
stato tempo anche per un side-project oggi a un passo
dalla prima uscita ufficiale e in cui sono rintracciabili
tutte le sfumature della parola glo. Seguendo il modello reso celebre dai vari Lotus Plaza e Atlas Sound,
Banjo Or Freakout prende il via nel 2006 da una serie
di registrazioni domestiche condivise gratuitamente
su un blog e sporadicamente intervallate da qualche
uscita su cd-r e 7". Non stupisce quindi che sia ora la
Lefse Records (Neon Indian) a pubblicare questo EP,
primo di una serie che si propone di portare alla luce
il materiale rimasto nei cassetti degli artisti di volta in
volta coinvolti.
Nonostante Way Slow Volume 1 sia per sua natura destinato a un'utenza molto ristretta, la qualità complessiva
risulta comunque superiore alla media di questo genere di pubblicazioni. I solo-project dei due Deerhunter
highlight
Autumn Defense - Once Around (Yep Roc, Novembre 2010)
Genere: pop, folk rock
Andare oltre i Wilco, smarcarsi dal proprio passato e far finalmente quadrare il cerchio: il quarto full
lenght dell'ormai decennale side project di John Stirratt e Pat Sansone suona come un disco importante, solido, non come una semplice - e pur legittima - vacanza dal progetto
madre. Dove il precedente omonimo del 2007 appariva come un bel divertissement di classe, quasi innocuo nei suoi didascalismi west coast, Once
Around ingrana invece la marcia e parte sicuro e deciso: l'incipit decisamente Lennon/Harrison di Back Of My Mind è uno sfoggio di quel carattere
che sinora aveva latitato, o meglio covato sotto la cenere in attesa di circostanze favorevoli. Che sono arrivate con la determinante esperienza di
Seven Worlds Collide con Neil Finn & friends (2009; giova ricordare che da
lì è partito Wilco - The Album, nonché la vicenda solista di Phil Selway),
la scintilla da cui è scaturita la rinascita degli Autumn Defense: per quanto le atmosfere si mantengano
sempre mellow, c'è un'energia sotterranea e quasi febbrile che le percorre ed elettrizza, un sentimento
che gratta via la glassa dalla superficie e arriva dritto a toccare nel profondo.
Che si tratti di un lavoro ispirato, oltre che magistralmente realizzato (produzione e arrangiamenti sono,
inevitabilmente, al top), lo si avverte a primo ascolto, dalla costruzione dinamica e dalle armonie di Tell
Me What You Want, dalla Rickenbacker puramente Smiths di The Swallows Of London Town, dal sentito
omaggio ai Big Star di Don't Know eEvery Day, dalle rievocazioni Elliott Smith della title track fino al
soul di Allow Me; mentre il folk-rock di Huntington Fair pare rinverdire i fasti di Mermaid Avenue, The Rift
scomoda Simon & Garfunkel, Step Easy Neil Young e Jackson Browne e There Will Always Be A Way il
reverendo Al Green. Insomma si punta a una formula classica, senza tempo, a una precisa e nobile categoria del pop alla quale Stirratt e Sansone possono, adesso a pieno titolo, dichiarare di appartenere.
(7.2/10)
Antonio Puglia
sopra citati rimangono i paragoni più verosimili ma al
tempo stesso rappresentano modelli entro cui circoscrivere un gran numero di influenze, dalle jam psichedeliche degli Animal Collective riassunte nei tre minuti tribali di Over There allo space-rock di scuola Spiritualized
omaggiato nei coretti enfatici di Is That All?; fino a una
75 che pur nella sua semplicità tecnica (chitarra acustica
+ voce in delay) si candida come ballad imprescindibile
per l'autunno degli shoegazers in ascolto, forte del suo
girare intorno alla parola spleen senza abboccare mai
davvero. Degno di elogio anche il criterio di selezione
dei brani operato da Alessio, in un equilibrio perfetto
fra episodi ancora acerbi ed altri più compiuti: accanto
a ritmiche composte da un'unica nota di pianoforte, riff
di chitarra distorti e cantati prossimi al mugolio (0156)
trovano posto canzoni vere e proprie, voci in primo piano e melodie nitide (Vasto Beach).
La natura inevitabilmente sconclusionata dell'insieme
rende difficile mettere a fuoco il presente e conseguentemente il futuro di Banjo Or Freakout: sicuramente le carte
da giocare sono molte, si tratta di saperle organizzare e
sviluppare così una personalità necessaria a distinguersi
in un genere ormai inflazionato e in attesa di evoluzione.
(6.4/10)
Simone Madrau
Bellrays - Black Lightning (Fargo,
Novembre 2010)
Genere: soul-punk
Piace dei BellRays l’intensità con cui fondono il genuino
sudore di soul e street rock. Il fatto che da vent’anni l’ensemble guidato dalla fenomenale cantante Lisa Kekakula - una Tina Turner giovane, consapevole e incazzata - e dal chitarrista Rob Venunm faccia cosa sola di ciò
che consegnò Detroit alla Storia: da un lato la Motown
e le decine d’altre etichette indipendenti; dall’altro,
gente come MC5, Stooges, Rationals e Mitch Ryder
che black lo era dentro e senza nasconderlo. In mezzo,
George Clinton metteva ordine e anticipava un’ampia
fetta del futuro in cui vivono i BellRays.
45
Giunti con calma e fermezza dal fiero underground
(l’esordio su nastro In The Light Of The Sun; svariati 7”
ed e.p.; la militanza presso Alternative Tentacles) a tour
con Rocket From The Crypt e riconoscimenti sul territorio europeo eleggendo l’integrità a bandiera, donando ogni grammo d’energia sul palco e conservando
il proprio stile. Rendendolo anzi più ricco e vibrante
sino al maturo vertice del 2007 Have A Little Faith, cui
rispondevano l’anno seguente il più ruvido Hard, Sweet
And Sticky e oggi dieci composizioni che quadrano il
cerchio. E che hanno l’aria dello sforzo di qualità che
potrebbe regalare meritate soddisfazioni economiche:
parlano chiaro la scuderia di prim’ordine, una produzione puntuale e potenziali successi come Power To
Burn, una People Have The Power più tirata che si appaia
al calco dell’Iggy Pop anni ’90 Everybody Get Up.
Cose passabili e che faranno probabilmente storcere il
naso ai fan della prima ora, nondimeno assolvibili alla
luce di una The Way dritta dal ‘64, di una strepitosa Sun
Comes Down tra Isaac Hayes e Curtis Mayfield e del
resto che sposa disinvolto eleganza, foga, solidità (su
tutto la fumigante Close Your Eyes, il crescendo di Anymore, l’irruenza della title-track e di Living A Lie). Roba
da memorizzare e far ascoltare a chi ancora possiede
un’idea provinciale di certa musica.
(7.3/10)
Giancarlo Turra
Breathe Owl Breathe - Magic Central
(Hometapes Records, Ottobre 2010)
Genere: fantasy fok/pop
Immergersi in Magic Central è come tornare
piccoli, nascondersi dentro all'armadio della biancheria
in una grande casa di campagna mentre all'esterno infuria il temporale e, torcia in mano, coperta sulle spalle,
immergersi nella lettura delle Cronache di Narnia o in
un libro di Nail Gaiman. C'è tutta quest'urgenza di raccontare storie fantastiche, tipica della letteratura per
l'infanzia, in queste dodici tracce di pop zuccheroso e
giocoso, che hanno titoli come "La mascella del leone",
"Il drago" o "La casa d'oro".
Nella perfetta epica
indie americana, Micah Middaugh e Andréa MorenoBeals si sono conosciuti in un parcheggio nell'area rurale del Michigan. Con il loro impasto vocale maschile/
femminile, il violoncello di lei e la chitarra di lui, costruiscono intarsi delicati, spesso semplici (Dogwalkers of
The New Age) come le filastrocche dell'infanzia (Swimming), in qualche occasione supportate da una visione
jazz (Board Games). Il supporto attento e mai invadente delle percussioni di Trevor Hobbs risulta decisivo
nel creare e mantenere l'atmosfera incantata (Icy Cave
46
Dancers) e divertente/divertita (Parrots In The Tropical
Trees). Magic Central è l'ennesimo capitolo della saga,
cominciata nel 2004, ma con questa prova sembrano
aver trovato la quadratura del cerchio.
(7/10)
Marco Boscolo
Bryan Ferry - Olympia (EMI, Novembre
2010)
Genere: wave pop
La cosa migliore di questo disco è l'ostentazione quasi
sfacciata o se preferite narcisistica con cui Brian Ferry
mette in scena se stesso, patteggiando senza remore
col proprio passato (a partire dal glamour retro-attualizzato della copertina, featuring una patinatissima
Kate Moss). Ed è, come è facile immaginare, anche la
cosa peggiore. Ha fatto le cose in grande, coinvolgendo nomi altisonanti come David Gilmour e Jonny Greenwood oltre ai vecchi compagni d'avventura Brian
Eno, Phil Manzanera e Andy Mackay. Inevitabilmente
si è fatto un gran parlare di questa sorta di reunion discografica dei Roxy Music, dopo il pugno di concerti
tenuti dall'inizio dell'anno ed il tour annunciato per il
prossimo gennaio. Per quanto smentita dai diretti interessati, per quanto di sponda, nei fatti la reunion si
è consumata anche in studio. Certo, non era il caso di
sperare in un ritorno alle impudenti sperimentazioni
post-glam dei primi seventies. No: in Olympia il sound
staziona tra i languori patinati di Avalon e le febbricole
dance-wave-funk di Manifesto, e in un certo senso è
giusto così. Una formula comoda e senz'altro opportuna, o almeno priva di eccessive velleità. Tuttavia,
ammetto di aver provato un certo imbarazzo durante
l'ascolto, come sempre quando m'imbatto in una nostalgia che rincula in piacionismo giovanilistico.
Non è il caso di rimproverare a Brian Ferry di essere
Brian Ferry, ma tutto questo dandysmo fireo, a briglie
sciolte e fuori tempo massimo se da una parte ci restituisce un'icona rock in ottima forma, dall'altra finisce
per creare mostriciattoli come Heartache By Numbers
- epica Arcade Fire disinnescata Cock Robin - e una
versione di Song To The Siren sdolcinata fino alla nausea. Va un pizzico meglio coi Depeche Mode rifritti di
Shameless, mentre Reason Or Rhyme tenta con una certa dignità di riesumare i turgidi languori anni Ottanta.
Alla fine, l'unico episodio degno di nota è la conclusiva
Tender Is The Night, con la voce che s'immerge e riemerge tra i mesmerismi sintetici. Un po' poco, tenuto conto
dello strombazzamento.
(4.5/10)
Stefano Solventi
highlight
Daft Punk - Tron Legacy: Original Motion Picture Soundtrack (EMI, Dicembre
2010)
Genere: Elettronica
Senza aver visto il film è dura parlarne, ma quello che si carpisce ascoltando questa colonna sonora è
che probabilmente i due uomini col casco sono stati imbrigliati in percorsi non troppo consoni alla loro
potenzialità compositiva. Guy-Man e Thomas applicano infatti i topoi più conosciuti e stereotipati della
musica elettronica alla descrizione di immagini, mutandoli con le citazioni
che influenzano da sempre il background genetico di chi - come loro - ha
fatto dell’elettronica un credo: cavalcate e loop à la Tangerine Dream (The
Son Of Flynn), analogica da baffo Moroder (Solar Sailer), il ricordo di JeanMichel Jarre (Nocturne), qualche accenno al minimalismo di Philip Glass
negli archi di Outlands e tanto tanto Vangelis. In più (da contratto?) aggiungono una patina pomposa e barocca al tutto, costruita grazie all’aiuto
di ottoni, archi e di un’orchestra sinfonica da più di cento elementi che
propone un didascalismo pedante e mediamente noioso.
Le uscite dallo schema disneyano/hollywoodiano appaiono in poche tracce, fortunatamente vicine al
dancefloor: il già apprezzato singolo Derezzed (suoni da deep house in filtraggio espanso che fa gola ai
Justice), End Of Line con una lentezza di bpm à la Homework che pesca il suono di basso e di batteria
dall’analogica fine Settanta aggiungendo inserti di tastierine glitchate a 8 bit, la prosopopea di filtri di
Arena e Rinzler che cita i Chemical Brothers di Push The Button.
Il mood di questa ora scarsa di musica è inevitabilmente dark, come sarà il film. Un’oscurità che, per
la retrofilia anni Ottanta, si rifà a pietre miliari del calibro di Blade Runner (il synth di Arrival è plagio) o
Fuga di mezzanotte. Senza le immagini però la musica non riesce a reggersi bene in piedi ed è difficile
ascoltare il disco da cima a fondo con lo skip a portata di mouse.
Sono ormai cinque anni che aspettiamo un album dopo il sempreverde Human After All. Il silenzio, riempito comunque dagli impegni con il tour e dalla regia di Electroma, meritava forse qualche hit in più.
Tron Legacy è una parentesi che per i fan in visibilio house promette bene con pochi singoli da ballo,
ma per gli altri non verrà ricordata come un ennesimo exploit. Peccato.
PS: L’album esce anche in Deluxe Edition con un cd aggiuntivo di clip del film ed extra tracks.
(6.5/10)
Marco Braggion
Burns Unit (The) - Side Show (Proper,
Agosto 2010)
Genere: folk
Cresce con gli ascolti l'esordio dei The Burns Unit. E
pure inaspettatamente, visto che al primo passaggio
mostra un'anima poco equilibrata, con una What Is
Life che sembra occhieggiare in maniera inquietante a Shakira, certi richiami ai Low di una Future Pilot
A.K.C. decadente a malinconica, il Leonard Cohen gitano di You Need Me To Need This o i Belle & Sebastian
di Trouble. E' sufficiente recuperare i crediti del disco,
tuttavia, per comprendere che si tratta di un cosciente esperimento di global-folk-pop e non di mera presa
per i fondelli. Anzi di più. Di una sociologia da apparta-
mento tipo Grande Fratello applicata ai suoni. Con otto
musicisti provenienti da Scozia e Canada - oltre che da
precedenti esperienze agli antipodi - auto-richiusisi
materialmente in una casa a interagire.
Dall'ideale brainstorming da supergruppo in gita nasce
un disco che rispecchia la diversità di approccio degli
artisti coinvolti, nelle molteplici anime che lo compongono ma anche nel pedigree che lo accompagna.
Con la voce suadente di Emma Pollok (Delgados), lo
spoken word di Mc Soom T (sul dub-afro di Send Them
Kids To War e nella già citata What Is Life) e il cantato sognante di Karine Polwart (Helpless To Turn) a guidare
una coralità multisfaccettata in cui far convivere basso (Future Pilot A.K.A.), chitarra (Kim Edgar), tastiere
47
(King Creosote), synth, accordion (Michael Johnston)
e batteria (Mattie Foulds). Materiale che mette in mostra un gruppo di lavoro appassionato e una scrittura
pop cristallina, oltre a un pugno di desinenze tradizionali scozzesi/latine decisamente in linea con l'attuale
tendenza al crossover etnico.
(7.1/10)
Fabrizio Zampighi
Buzz Aldrin - Buzz Aldrin (Unhip Records,
Novembre 2010)
Genere: wave
Una storia folgorante, degna dei nostri tempi veloci.
Tre trentenni (non è uno scioglilingua) incrociano i loro
destini in quel di Bologna ad inizio 2009, scoprendo
un'intesa che in breve frutta un pugno di pezzi presto
spediti al mondo via myspace. Il resto viene quasi da
sé. Si apre la breccia dei concerti, attorno ai quali cova
un hype che monta fino all'inevitabile esordio, oggi,
per l'occhiuto tandem Unhip/Ghost Records. Album
omonimo, nove pezzi tesi, allucinati d'una wave battente che non può non ricordare i Wire via Liars o viceversa, il ghigno PIL nel gorgo nero Bauhaus, l'impeto
Killing Joke sclerotizzato da una teatralità Suicide. La
scrittura si limita ad essere pretesto di arrangiamenti
aggressivi e interpretazioni intense, cogliendo l'apice nella robotica Machine 2999,99 e nella spasmodica
White Church.
E' evidente quindi l'ossessione wave (e dintorni), ma
con meno veemenza che cognizione di causa: il loro
sound è progetto e calcolo, equilibrio di perturbazioni
soniche al servizio di marce ipnotiche e alienate, di scenografie sinistre e cavalcate visionarie, e questo segna
la distanza rispetto ad una moda a pronta presa risalente ormai a qualche stagione fa. Che comunque c'è
stata e - a causa dei ritmi vorticosi del presente - stende
sulla proposta il suo alone cupo, un senso di revival del
revival che ti prefigura la solita sindrome dei ritardatari
cronici, il solito cul de sac provinciale.
Non è detto che sia così. Magari ai Buzz Aldrin - nome
scelto in onore del secondo arrivato per antonomasia,
ed è forte la tentazione di argomentarci sopra - interessa solo seguire la propria traiettoria e affanculo le mode
e le scene. Personalmente, sono disposto a crederlo. In
ogni caso, possono vantare un'idea sonica ragguardevole, con pochi eguali dalle nostre parti. Per dei debuttanti, seppure stagionati, è una specie di prodigio.
(7.1/10)
Stefano Solventi
48
Crystal Fighters - Star Of Love (Zirkulo,
Ottobre 2010)
Genere: nu-rave mesh-pop
Lo spettro del nu-rave che si aggira per l’Europa musicale l’avevamo intravisto nelle proposte glo dei Delorean. L’affinità geografica e musicale con i barcellonesi
ritorna con l’esordio full-lenght di questa nuova band
basca (già vista su Kitsuné con il singolo Xtatic Truth,
qui riproposto): una cosa che pompa ricordi electro
wave dei primi MGMT e li mescola sapientemente
con la lezione Animal Collective, tenendo in sordina
un pedale ritmico che rispolvera le sudate minimal a
nome Soulwax. Come a dire mescoliamo grazia summer-pop con l’acidità da dancefloor e vediamo quello
che ne esce.
Quando ci fu il boom di Klaxons e CSS, di questi esperimenti ne sentimmo fino allo sfinimento, ma oggi si
è finalmente pronti ad andare oltre il floor pacchiano,
tagliando tutto con il massimalismo che gli animali collettivi e la summer wave ci hanno implicitamente costretto a percepire in qualsiasi album rock post-00. Ok,
citare nuovamente quei mondi musicali è un rischio. Ma
val la pena correrlo se si riesce a costruire un ibrido che
compone un’inaspettata raffica di singoli promettenti:
I Do This Everyday pesca dalla matrice trash Yeah Yeah
Yeahs inzuppata nella witch house a 8 bit, At Home gioca con le terze a cappella Ottanta delle Bangles, Swallow deborda nelle acidità dello UK bass, l’opener Solar
System è fidget mescolato a tagli balearici lo-fi degni
dei migliori Aeroplane, il tribalismo con le schitarrate
metal in I Do This Everyday, gli stop and go acustici dei
Pixies (band che ha da sempre un seguito esagerato
in Spagna) in Plage, la vituperata minimal di Miss Kittin in I Love London, la techno commerciale da stadio
con la voce wave dei Pains of Being Pure At Heart in
With You e per finire una consapevolezza che ammira la
tradizione, utilizzando strumenti della tradizione basca
sconosciuti come txalaparta, tabor e txistu.
Un piccolo grande colpo al cuore, ricco di sogni, mistero e psichedelia da ballo visionario. I combattenti di cristallo creano degli scompensi ormonali non da poco.
Attenzione, potreste innamorarvi.
(7.3/10)
Marco Braggion
Cyclobe - Wounded Galaxies Tap at The
Window (Phantomcode, Novembre 2010)
Genere: post-industrial
L’album precedente, Paraparaparallelogrammatica era
nato da una collaborazione con Nurse With Wound e
pertanto si discostava anche parecchio dalle produ-
zioni del duo verso lande death/concrete/collage tipicamente stapletoniane, Wounded Galaxies Tap at
The Window riparte invece da The Visitors (del 2001),
portando il suono post-industrial dei Cyclobe oltre la
consueta estetica ghostly.
Il nuovo corso si nutre quartomondismi, ritualità pagane e preghiere folk all'interno delle quali la percussività
etno diventa la base tanto delle pennate psych quanto di orchestralità (chiesiastiche/classiche) fantasma.
La terra è sia quella di un Jon Hassell virato al male
(i quartomondismi) sia quella del Peter Chistopherson
dei Throbbing Gristle attuali (l'etnica esoterica) o dei
Coil del passato (formazione, ricordiamolo, alla quale
il duo fu legato per un breve periodo).
The Woods Are Alive With the Smell of His Coming, 17 minuti di savana notturna tra droni, squarci cosmici e cabala è senz'altro la traccia simbolo dell'album. E' stata
esiguita in in sestetto con Thighpaulsandra ai synth e
al piano, John Contreras al violoncello, Cliff Stapleton
all’hurdy-gurdy e Michael J. York ai Duduk (e ai “tubi”)
e ha inoltre fatto parte della performance The Dark Monarch: Magick and Modernity in British Art, premiata meritatamente al Tate Gallery St. Ives.
Del resto, anche i sussurri dreamy in francese di Sleeper, immersi nelle note di piano atmosferico e glitch; o
l'avvolegente (noise) cosmic trip spiraloide per synth
analogici della traccia omonima sono ottime testimonianze della maturità e personalità raggiunta dal duo.
Davvero un ritorno di peso nel circuito post-industrial
orfano dei Throbbing Gristle.
(7.2/10)
Edoardo Bridda
Dance For Burgess - SSA (Mashhh!,
Ottobre 2010)
Genere: post-punk
Dance For Burgess significa un duo (Iacopo Bigagli e
Marco Da Collina) fortemente influenzato dal passaggio tra anni Settanta e Ottanta, dalle wave e dal superamento del punk. In SSA ci sono tutti i tasselli di quel
mosaico che abbiamo visto ricomporsi qualche anno
fa, grazie all’opera di Simon Reynolds e, ovviamente,
al revival impetuoso di nuove band, ristampe, temi.
Un’onda oggi al riflusso, è vero, ma anche ancora abbastanza fresca per dare ancora segni di vitalità e collegamenti vivi.
Bigagli e Da Collina ci offrono dieci tracce, molte delle
quali punk funk allo stato puro, di stampo post-no-wave, evidentemente modello Liars (I’m Wired, e il titolo
non può che far pensare all’ultima fatica dello stesso
Reynolds, oltre che al leggendario singolo dei The
Fall). In evidenza strategie no- e bad trip, atmosfere
che ricreano ambienti di quegli anni, chitarre scordate
e basso da manuale Rockerilla primi Ottanta, così come
funk da contorsionisti ma taglio diritto degli obiettivi:
andare dritto alla tensione psichica, non al corpo. E così
non può che essere cerebrale il dialogo tra drum machine, voce-basso e chitarre in Omgmj!, probabilmente
una delle migliori del lotto. Funziona meno il ricordo
Wire (Toxshop), forse a causa delle peculiarità dei protagonisti di quel cassetto della memoria, forse - e con
ciò pensiamo al design delle armonie e alla capacità di
creare colpi di scena nello stesso brano che in pochi
riescono a replicare.
Fatto dieci l’originale, la citazione non fa zero. Nel genere, e nel contesto dell’offerta italiana - di oggi come
di allora - Dance For Burgess superano la media, pur
insistendo su un seminato in cui certamente non è facile emergere.
(6.5/10)
Gaspare Caliri
Die Antwoord - $O$ (Cherrytree Records,
Ottobre 2010)
Genere: mesh/rave
La faccenda Die Antwoord è molto interessante e articolata, e per questo la svisceriamo a fondo in uno
spazio dedicato. Qui ci concentriamo su quello che ne
è l'output più tangibile, e forse anche quello meno importante.
L'album dei Die Antwoord esce solo adesso sulla sussidiaria della Interscope orientata alle nuove forme di
crossover, dopo un incredibile hype sul web portato
avanti con tattiche virali, dopo i primi concerti in Europa e Stati Uniti sotto l'ala protettrice del mesh che
conta (M.I.A., dopo un inutile EP di cinque pezzi pubblicato a luglio. Inutile perché il disco tutto lo conoscevamo già da mesi, essendo stato messo in free download sul loro sito ufficiale e reso disponibile per tutto il
2009. In effetti, per questo $O$ "edizione definitiva", i
Die rimaneggiano un po' la tracklist, tagliano via alcuni
pezzi troppo cazzoni (in uno la base era Orinoco Flow
di Enya), ne inseriscono tre nuovi, affidandone uno alla
produzione di una firma sicura come Diplo.
La sostanza però non cambia. Yolandi e la sua vocina
"twetty", Ninja e la sua valanga rap egotripica, le basi
che pescano tra urban UK, electro commerciale virata
underground (via residui industrial) e nu-rave, guidate da motivetti-tormentone facili facili, spesso al limite della filastrocca. Il pezzo con Diplo, Evil Boy, in salsa
videogame/epica mesh, è roba buona, e scopre una
volta per tutte, specialmente nella versione video, gli
49
intenti (auto)parodistici di questi specie di Rammstein
dell'hip hop sudafricano.
Il progetto nella sua interezza però, tenendo conto
di tutte le componenti (intenti supposti, visual, viral
marketing, exploit fuori patria, concerti, ecc.), ci sembra troppo comodamente ambiguo. E la musica, coerentemente, la vediamo come un mesh - a seconda
della prospettiva - troppo poco aggressivo, divertente,
parodistico, cattivo, comunque troppo poco forte per
convincere. Aspettiamoci a breve il film dei/sui Die Antwoord e un secondo disco, titolo Ten$ion, nel quale
"vogliamo rappare usando la lingua che parlano le guide turistiche, mantenendo così il nostro sapore tutto
sudafricano ma cercando allo stesso tempo di farci capire di più. Diciamo che sarà per un 95% inglese, con
giusto un pizzico di Afrikaans".
(5.8/10)
Gabriele Marino
Dirty Projectors - Bitte Orca Expanded
Edition (Domino, Novembre 2010)
Genere: Prog-pop
A distanza di poco più di un anno dall'uscita del disco,
tra le uscite più apprezzate dalla stampa nel corso del
2009, Bitte Orca ritorna disponibile sugli scaffali dei
negozi in una versione arricchita di alcune rarità. Evidentemente è un periodo di grande raccolto per la
band di Dave Longstreth, che già nel giugno scorso si
era concesso il lusso di uscire con un'autoproduzione
assieme a Bjork, per quel Mount Wittnberg Orca i cui
proventi erano destinati alla National Geographical Society americana.
In questa versione espansa del loro quinto lavoro di
studio, Longstreth e soci offrono un intero secondo
cd di memorabilie. Ci si ritrova un mini-live di cinque
brani indicati come "Live at Other Music", con l'equilibrio delicato di intrecci vocali sostenuti quasi esclusivamente da chitarra e basso. Si passa poi alla seconda
parte della scaletta che comprende i brani già presenti
sul loro ultimo 7 pollici (e scaricabili gratuitamente dal
loro sito): Ascending Melody è un brano allegro che sottolinea ancora di più gli accenti africani della musica
dei Dirty Progectors; Emblem of the World è un tipico
brano di Longstreth. A un remix tribalista (Stilness Is The
Move, curato da Lucky Dragon) fa coppia una cover di
Bob Dylan (As I Went Out One Morning, da John Wesley Harley del 1967). A condire il tutto una manciata
di b-sides dell'ultimo periodo, quello finora più proficuo, della band. Per completisti.
(6.5/10)
Marco Boscolo
50
Drums Of Death - Generation Hexed
(Greco-Roman, Luglio 2010)
Genere: Synth-Pop
Leggi il nome del progetto, guardi le foto su MySpace, e la prima associazione mentale che ti viene da fare
è quella con i Liars, un po' per le suggestioni evocate
e un po' per l'assonanza col loro Drum's Not Dead. Poi
l'occhio cade su Greco-Roman, l'etichetta di Joe Goddard degli Hot Chip per cui esce questo Generation
Hexed, e qualcosa inizia a non tornare. Infine ascolti e
ti rendi conto di quanto l'abito non faccia il monaco.
Niente isterie glo, niente tribalismi voodoo: cassa dritta, invece. Sì perchè Colin Bailey, alias Drums Of Death,
è di fatto un animale da party. O da Bloc Party, come
potrebbe in prima istanza osservare qualcuno nel ritrovare, in tracce come Won't Be Long o London Teeth, i
medesimi richiami techno primi anni '90 che caratterizzano la produzione recente del celebre quartetto.
Nel resto dell'album però trovano posto ritmiche più
elaborate e costruzioni meno prevedibili, e allora forse
il paragone era affrettato e quella timbrica vocale non
è quella del buon Kele Okereke ma quella di Tunde
Adebimpe dei più obliqui TV On The Radio (Science
& Reason). Il quadro si fa chiaro del tutto solo quando
tra strumentali 8bit (Creak) e funk convulsi alla Hudson
Mohawke (Everything All At Once) inizia a fare capolino
la parola wonky, la cui accezione di crossover di generi corrisponde di fatto alla filosofia su cui regge l'intero disco: non l'emulazione, più o meno volontaria, di
questo o quel gruppo quanto piuttosto una genuina
attitudine da club, dove intelligenza e profondità non
sono bandite ma coniugate in una non-etica di puro
divertimento. Così, quando Colin si fa più enfatico nel
cantare, l'immagine che prende forma è semplicemente quella degli stessi brani suonati dal vivo, con il pubblico che incalza sotto il palco in Modern Age per poi
sgolarsi nei cori di Voodoo Lovers.
Generation Hexed è un album tutt'altro che innovativo ma in qualche misura fresco e all'insegna di un disimpegno che ci rende il suo titolare estremamente
simpatico. Ottimo da suonare in un prossimo party
casalingo, e poco conta se già tra un mese balleremo
qualcos'altro.
(7.01/10)
Simone Madrau
Eraldo Bernocchi/Harold Budd Semetipsum (RareNoise, Novembre 2010)
Genere: Ambient
Metti una serata in compagnia di Harold Budd al
piano ed Eraldo Bernocchi alle elettroniche, all'inau-
highlight
Ebo Taylor - Love And Death (Strut Records, Ottobre 2010)
Genere: Africana
Strano scriverlo ma Love And Death è per il Vecchio Continente il debutto di un grande della musica del
Ghana. In circolazione sin dagli anni ’50 e ’60, all’epoca cioè dell’esplosione della highlife, Mr. Taylor si
faceva infatti le ossa nelle orchestre Stargazers e Broadway Dance Band, trasferendosi a Londra grazie
a una sovvenzione statale: similmente a Mulatu Astatke, studiava il jazz,
ne assimilava forme e “messaggio” e, tornato in madrepatria, cercava di
incorporarlo nella tradizione. Si guadagnava da vivere come arrangiatore
e produttore, decidendosi solo dalla seconda metà dei ‘70 a mescolare in
proprio il retaggio sonoro ghanese con afrobeat, jazz, funk.
Restando nelle retrovie, però affinando la miscela da farsi notare su alcune raccolte edite da Soundway e Analog Africa ed essere campionato dai
populisti hip-hop Usher e Ludacris nella multimilionaria She Don’t Know.
I tempi erano perciò assai maturi (il Nostro ha settantaquattro anni
) per
un nuovo album e l’occasione è stata colta al volo dalla Strut, recapitando tre quarti d’ora fenomenali
in toto e sovente venati di latinità allestiti con l’Afrobeat Academy, competente ensemble che srotola
ipnotici tappeti percussivi e fiati vigorosi sulla sensuale essenzialità degli arrangiamenti di Taylor. Due
suoi classici (Victory, Love And Death) e sei gemme di recente composizione ne spiegano il talento, lasciandoci quale unico rammarico la “scoperta” tardiva. Benvenuto, Ebo.
(7.5/10)
Giancarlo Turra
gurazione di un nuovo marchio di vino della cantina
di Michele Satta (Bolgheri, Toscana), e ottieni il master per un album di soffusa ambient e invisibili droni
che non aggiunge nulla alla carriera dei musicisti ma
che, senz'altro, rappresenta l'ideale compendio sonoro
per la casa vinicola.
In latino, il vino che dà il nome all'album significa "proprio se stesso" e sicuramente Budd, classe '36 e indimenticato protagonista di The Plateaux of Mirror e The
Pearl con Brian Eno, è proprio il pianista che conosciamo e che abbiamo visto rinascere nei 2000 grazie a una
serie musicisti che lo hanno spinto a continuare a suonare. Tra questi, ricordiamo David Sylvian (per il quale, su Samadhi Sound, ha inciso Avalon Sutra, che doveva essere il suo ultimo lavoro), Daniel Lanois, Robin
Guthrie, lo stesso Bernocchi e, non ultimi, gli U2, con i
quali ha registrato Cedars of Lebanon lo scorso anno.
Nelle sue note nessuna sorpresa, dunque, e neppure nell'accompagnamento di un quasi invisibile Eraldo Bernocchi. Del resto, l'audio è funzionale al vino e
agli scatti della video artista Petualia Mattioli. Il tutto al
costo 160 euro (acquistabile sul sito di Michele Satta).
Pondererei gli ultimi due fattori prima di tutto.
(6/10)
Edoardo Bridda
Erik Friedlander - Fifty: 50 Miniatures
For Improvising Quintet (Skipstone,
Novembre 2010)
Genere: avant jazz
Noto per la sua collaborazione con John Zorn, il violoncellista Erik Friedlander è un nome di punta della
scena avant-jazz newyorkese. Questo Fifty: 50 Miniatures For Improvising Quintet è frutto di un lavoro
originariamente commissionatogli dal San Francisco
Contemporary Jewish Museum. Ispirato ai 49 giorni di
meditazione imposti da Mosé al popolo d'Israele affinché potesse degnamente ricevere - nel cinquantesimo
giorno - le tavole dei Dieci Comandamenti, mette in
fila una scaletta di 50 mini-composizioni organizzate in
sette tracce o sezioni (le "settimane").
Ad interpretarle è chiamato un quintetto (violino, pianoforte, percussioni, contrabbasso e ovviamente violoncello) votato tanto alla frenesia impro che ad un
romanticismo pensoso, con immancabile retrogusto
klezmer ad insaporire la portata. Presentata così, è lecito attendersi una roba da post-nerd micragnosi e filosionisti, invece - detto che tali categorie potrebbero
effettivamente apprezzare - è un disco effettivamente
ispirato e a tratti geniale, la cui programmatica frammentarietà va a ricomporsi in un discorso sia estetico
51
che poetico coeso, unificato da un filo rosso di pensosa
passione, perciò capace di intrigare senza soluzione di
continuità.
(7.2/10)
Stefano Solventi
Evol/ve - Evol/ve (Off-set, Novembre 2010)
Genere: industrial-impro
FM Einheit: molla; mattoni; trapano; lastra di metallo;
laptop. Massimo Pupillo: basso elettrico; effetti. Basterebbero nomi e strumentazione per indicare da subito
le traiettorie e gli obbiettivi di Evol/ve, ennesimo progetto collaborativo che vede coinvolto un membro dei
nostri Zu in combutta con uno dei maestri indiscussi
del rumorismo di matrice industriale. Quel FM Einheit
co-fondatore degli Einsturzende Neubauten e vero e
proprio rielaboratore delle idee primigenie dell’industrial anglo-americano (da Monte Cazazza e Throbbing Gristle in poi) in nome di un anticonvenzionale
approccio materico al suono stesso. Noto per la sua
strumentazione autocostruita partendo spesso da materiale di recupero e da scarti della società industriale
- vera e propria industrial culture, altro che no - Einheit
non è un semplice percussionista ma un vero e proprio
sperimentatore “sul” suono e che trova in Pupillo un altrettanto valido e aperto indagatore del lato più sperimentale delle musiche estreme e improvvisate.
Clangori, borbottii, frattaglie sonore in generale, esplosioni e stasi, microparticelle sonore disaggregate e poi
riassemblate, prevalentemente in sede live. Questo
troverete nell’ora abbondante, in rigorosa modalità improvvisata a 360°, che il duo mette in scena in questo
omonimo esordio. E che stabilisce, se ce ne fosse ancora bisogno, lo spessore di artisti che credono fino in
fondo in quello che fanno, senza preoccuparsi di hype
o copertine.
(7/10)
Stefano Pifferi
Fabrizio Tavernelli - Oggetti del
desiderio (Lo Scafandro, Novembre 2010)
Genere: Pop rock
Ai meno giovani Fabrizio Tavernelli potrebbe ricordare
una stagione d'oro per la musica indipendente italiana,
quegli anni Novanta legati ai Dischi del Mulo, prima,
e al Consorzio Produttori Indipendenti, dopo. In quel
periodo, Fabrizio Tavernelli da Coreggio, provincia di
Reggio Emilia, era già attivo sulla scena italiana con un
progetto a nome En Marque D'Autre, ma è con la sua
band successiva, gli AFA, che raggiungerà la massima
visibilità. Un progetto non solo musicale, ma davvero
52
culturale: nomadismo, cultura cyber, sciamanesimo,
etnomusicologia, letteratura off che caratterizzavano
anche l'omonima rivista.
Di tutto questo c'è ben poco in questo esordio solista
firmato con il suo nome e cognome. Perché Fabrizio
Tavernelli è un onnivoro musicale, una vera spugna capace di prendere qualsiasi materiale sonoro e culturale
che lo incuriosisca e trasformarlo in qualcosa di personale. Succedeva con l'acid folk alleanza (questo il nome
per esteso del suo gruppo più noto) che si impregnava
tanto di folk italiano, di canti popolari, di esotismi cosmici, ritmi black, il trip hop, l'acid e tanto altro ancora.
Succede ancora oggi per i suoi lavori da dancefloor a
nome Ajello, per i suoi djset, per i suoi mille altri progetti, che si chiamano Groove Safari, Babel, Roots Connection. E succede anche dentro queste dieci tracce di
pop rock di facile presa melodica.
Si tratta di nove riflessioni ironiche, a volte amare, a
volte spietate, che incorniciano una realtà, quella degli
anni zero, dell'overload di informazione ma di scarne
comunicazioni; dei desideri più o meno bassi di essere qualcun altro e viverne la vita via reality show; della
natura messa in un angolo, mai esperita in pieno. E ci
sono anche i rifiuti, la monnezza, una delle cifre della
nostra Italia attuale, raccontata attraverso un brano di
Faust'O (Benvenuti tra i rifiuti) di lancinante attualità.
Benvenuto al nuovo progetto di Tavernelli e benvenuta alla nuova etichetta, voluta proprio da alcuni membri degli AFA.
(6.9/10)
Marco Boscolo
Fresh & Onlys (The) - Play It Strange (In
The Red Records, Ottobre 2010)
Genere: sixties-garage
Dichiarare di “farlo strano” e poi aprire con un pezzo
(Summer Of Love) che per titolo e suggestioni rimanda
al periodo aureo del sixties-pop, è per lo meno contraddittorio. In realtà, è strano di per sé che il sottobosco weird-garage in lo-fi, dai padrini Thee Oh Sees in
giù, si dedichi con tanta sensibilità e abnegazione alla
riproposizione del suono pop dei 60s. Quello tutto flower power, psichedelia soffusa, suoni solari e twangy e
fluenti chiome al vento, per intenderci.
Sia come sia, Play It Strange è il terzo album lungo in
nemmeno due anni per l’instancabile formazione di
San Francisco e le coordinate di cui sopra sembrano,
complice forse anche una registrazione avvenuta per
la prima volta in uno studio professionale, messe più
a fuoco.
Ci si muove su un versante spensierato e dreaming in
cui le aperture psych-pop dei sixties-via-Paisley vengono trattate alla maniera (proto)punk tipica del sottobosco garage specie californiano ma, al di là di questo steccato, le atmosfere vengono sporcate di deserti
morriconiani (Until The End Of Time, Waterfall), scheletriche oscurità pop post-Velvetiane (All Shook Up, Red
Light Green Light) o bizzarrie esotiche suonate con la
foga della band di John Dwyer (Who Needs A Man, la
fluviale Tropical Island Suite).
Ne esce una forma eclettica, personale e ancora in divenire del revival sixties e che, in fin dei conti, dà loro
ragione.
(7/10)
re Did My Duck Go su tutte), condite dai consueti testi
iperpersonali da eterno teenager timido e infoiato allo
stesso tempo (Mary, Cathy, Karen, Lisa, Linda, Diane; il
cast delle ossessioni femminili è il solito) e intervallate
come d’abitudine da una serie di brevi schegge strumentali ora lounge ora psych. L’effetto sull’ascoltatore è
sempre straniante: da mente irripetibile qual è, il genio
contorto di Wilson fonde comico e tragico con estrema
naturalezza, lasciandoti al contempo entusiasta, infastidito e parecchio confuso. Una lezione costante - e
inarrivabile - per tutti gli Ariel Pink e Of Montreal di
questo mondo.
(6.7/10)
Stefano Pifferi
Antonio Puglia
Gary Wilson - Electric Endicott (Western
Vinyl, Novembre 2010)
Genere: weird pop
Giobia - Hard Stories (Jestrai Records,
Novembre 2010)
Genere: garage psych
Pensate di conoscerlo davvero, Gary Wilson? Non ci
stupirebbe anzi se non lo conosceste affatto: nell’ideale classifica degli outsider di (stra)culto il suo nome occupa di diritto una posizione parecchio alta. In estrema
sintesi: un album completamente fatto in casa nel 1977,
You Think You Really Know Me, che mescolava senza remore funk, disco, punk, psych, avantgarde, new wave
e doo wop riprendendo e anticipando in misura diversa Prince, Flaming Lips, Beck, Steely Dan, Lou Reed,
Daniel Johnston, in una sorta di parodia residentsiana
che però si prendeva sul serio, eccome. A ciò si aggiunga un personaggio coi controfiocchi: enfant prodige
(scrive e incide nella cantina dei genitori sin dai dodici
anni di età), discepolo di John Cage (che gli avrebbe
suggerito: “se la tua performance non irrita il pubblico, non hai svolto il tuo compito”), musicista lounge
(attività che svolge ancora attualmente per sbarcare il
lunario), amante delle anatre (che alleva e cura come
animali domestici), terrorista live (i suoi show a base di
mise impossibili, sangue finto e farina sono ad oggi un
must).
Certi di avervi titillato a dovere, vi rimandiamo per il resto al documentario You Think You Really Know Me: The
Gary Wilson Story - oltre che ovviamente all’omonimo
disco, più volte ristampato - e veniamo al dunque: questo è il terzo album del clamoroso comeback di inizio
millennio, fortemente voluto dai fan più accaniti (Beck
in testa) e che ha già prodotto Mary Had Brown Hair
(2004) e Lisa Wants To Talk To You (2008), di fatto riprese musicali e tematiche del citato capolavoro weird del
‘77. Per quanto più coeso e omogeneo, Electric Endicott
ovviamente non sfugge alla regola: una festa camp di
nenie pop appiccicosissime e irritanti insieme (Whe-
Secondo disco per i Giobia da Milano, seconda tappa
di quella che pare essere a tutti gli effetti una magnifica
ossessione: per il garage psych dei sixties come si profilò in un formidabile e immaginifico gioco di rimbalzi
sulle due sponde dell'oceano, riverberando effetti collaterali surf e western, rigurgitando particelle mnemoniche vaudeville/folk col preciso scopo di farne additivi
per sfornare polpette stupefacenti. La mezz'ora di questo Hard Stories poco concede alla contemporaneità,
è uno sberleffo ucronico, un "fra parentesi" a tenuta
stagna.
Poco a che vedere con proposte tipo Jennifer Gentle,
che muovono da premesse simili per azzardare un indie mutante con attitudini progressive e tentativi (velleità?) d'inaudito. I Gioiba, invece, sembrano voler rendere conto solo a se stessi (alla magnifica ossessione di
cui sopra). Aprono lo scrigno e lo richiudono. Tutto qui.
Inevitabile chiedersi: perché spendere soldi e tempo
per un disco come questo se posso ripescare dal baule i vecchi Blues Magoos, Electric Prunes, 13Th Floor Elevator, Pretty Things o addirittura i primi Pink
Floyd? Me lo sono chiesto, infatti. E mi sono dato almeno tre risposte: perché i Gioiba scrivono belle canzoni;
perché le interpretano bene; perché hanno tutta l'aria
di divertirsi parecchio. A voi giudicare se sono buoni
motivi.
(6.9/10)
Stefano Solventi
Gregory & The Hawk - Leche (Fat Cat,
Ottobre 2010)
Genere: bedroom indie-folk
All'epoca del suo esordio del 2007, In Your Dreams,
53
highlight
Ex (The) - Catch My Shoe (Ex Records, Novembre 2010)
Genere: free-punk
Si scrive The Ex, si legge passione, radicalismo, antagonismo, terzomondismo, classe, impegno e chi
più ne ha più ne metta. Trenta e passa anni di palchi scomodi e fiere autoproduzioni, giri del mondo
su pentagramma e scouting fraterno e borderless (un esempio? Getatchew Mekuria e tutta la cricca
etiope) fanno della formazione olandese una istituzione per chiunque si approcci ad una idea anche
lontana di musica sinceramente indipendente.
Catch My Shoe, 25esima perla di una carriera florida e incompromissoria,
porta con sé una novità sostanziale a livello di formazione (l’ingresso del
neo-cantante Arnold De Boer al posto del dimissionario G. W Sok) ma il
meccanismo sonoro del quartetto non ne risente affatto. In perenne oscillazione tra ipnotico rock proteso al sud del mondo e post-punk scheletrico
e free, wave raffinatissima ed eclettica e punk attitudinale, il meticciato
degli olandesi è al solito eccitante connubio di rabbia e ricerca, esotismo
e trance viscerale. Un particolare apprezzamento va a Eoleyo (marziale e
scarna rendition post-punk del Gurage anthem di Mamhoud Amhed), al Konono-sound virato nervosismo fugaziano di Bicycle Illusion, all’incendiario procedere epilettico di 24 Problems, ma ogni singola
nota qui è al di sopra della media e pronta ad esplodere in mille rivoli diversi, inattesi, sorprendenti.
Non a caso il motto della formazione olandese è Forward, in all directions.
(7.2/10)
Stefano Pifferi
Meredith Godreau scelse il moniker Gregory and the
Hawk per non essere associata a quel female folk che
sapeva tanto di Novanta. Dopo l'esordio su Fat Cat nel
2008, con un disco, Moenie and Kitchi che faceva della
collaborazione con altri musicisti il punto di discontinuità con le vicende precedenti, per il terzo full lenght
si ritorna nella cameretta per dodici episodi in equilibrio tra folk e twee pop, dove la soavità e la zuccherosità sono elementi determinanti.
La prospettiva defilata è quella preferita dalla Godreau,
che scrive di aver voluto basare Leche sull'osservazione
di diversi luoghi e persone, "viaggiando, sia fisicamente
che psciologicamente, ma senza venire mai coinvolta". E
come tutti i viaggi che si rispettino, anche questo prevede una ricerca interiore speculare a quella esteriore
(Soulgazing), il lasciarsi ammaliare dal paesaggio (Landscapes) e il sogno (Dream Machine). Musicalmente, nonostante il tentativo di depistaggio
del moniker, siamo vicini al female folk di Mirah e alle
atmosfere eteree e bucoliche di Joanna Newsom, ma
giocate sempre con una inclinazione al ritornello appiccicoso che fa pensare, soprattutto negli episodi più
movimentati, come Olly Olly Oxen Free, ai Belle and
Sebastian. In Leaves fa capolino anche un po' di decadenza rock, rendendolo uno dei brani più riusciti del
54
lotto, con la voce della Godreau che mette in gioco una
sostanza inattesa e sembra quasi giocare sul modello
Lolita.
Leche suona bene e scorre meravigliosamente nel lettore, ma ha il limite di non conficcarsi mai definitivamente nella memoria, lasciando l'esperienza dell'ascolto avvolta in una nebbia monocroma.
(6.5/10)
Marco Boscolo
Houses - All Night (Lefse, Novembre 2010)
Genere: electro pop
Da Chicago alle Hawaii e ritorno: una parentesi necessaria per Dexter Tortoriello e Megan Messina, compagni nella vita e musicalmente. La loro non fu una vacanza ma una specie di ritiro sabbatico: si licenziarono
dalle rispettive occupazioni e via, sparire, rifugiarsi in
un altro mondo fuori dal mondo, lontano dalle traiettorie turistiche. A far cosa non è dato sapere con precisione, ma abbiamo oggi il privilegio di sentirne i frutti
con questo All Night, album desordio a nome Houses
targato Lefse (che ultimamente non ne sbaglia una). E'
un pop mesmerizzato d'elettronica che conserva fragranze acustiche tra arzigogoli glitch, votato - per così
dire - alla rappresentazione impressionista di nuances
riconducibili - forse, chissà? - a mattini silenziosi e crepuscoli solitari.
Un gioco di spazi reso splendidamente incerto da caligini e pioggerelle, di tempo che s'acquieta in un palpitante abbandono. Immaginatevi i Boards Of Canada
se li ipnotizzassero i Mazzy Star, un Dntel frugale o
addirittura un Aphex Twin contemplativo. Dieci tracce
che ti accompagnano in questo sogno che non puoi
permetterti davvero ma ti ci puoi immergere eccome.
Concrezioni cedevoli e armoniose, struggenti (Sleeping)
e briose (Reds, Soak It Up), suadenti (Endless Spring) ed
eteree (Medicine). Contro il logorio della vita moderna,
come diceva quel tale.
(7.2/10)
Stefano Solventi
How To Dress Well - Love Remains (Lefse,
Ottobre 2010)
Genere: errebì glo-fi
Tom Krell studia filosofia a Colonia e nel frattempo sforna EP a ripetizione distribuendoli attarverso il suo blogspot col nick name di How To Dress Well. Incantando
il mondo, o almeno quello disposto a farsi incantare da
questi incantesimi suadenti e malsani raccolti nell'album d'esordio Love Remains. Una patologia errebì
insopprimibile scritta sulla pergamena spiegazzata del
glo-fi, precarietà ed ossessione, intensità e languore, il
gusto della posa e la necessità dell'espressione.
Imprinting black quindi e prima di tutto, a tratti puoi
percepire particelle Erykah Badu (My Body) e persino
Michael Jackson (Mr. By & By), ma i miei parametri me
lo fanno collocare da qualche parte tra gli ultimi demo
di Jeff Buckley e lo Xiu Xiu meno aggressivo, coordinate fatte traballare da quel senso di tenerezza ineffabile
mentre vaporizza Patrick Wolf e Sigur Ros e persino
certa spiritualità Antony. Comunque è tutto molto basale, in un certo senso naturale per quanto alterato di
tecnologia, in un'ottica di trasfigurazione sintetica che
conserva l'impronta - la goffaggine - umana. Probabilmente non siamo troppo lontani dall'errare nutritivo
profetizzato da quel buontempone di Brian Eno, ma
non prendetemi troppo sul serio. Più certo mi sembra
che tra la glassa caliginosa di Lover's Start, l'evocazione
etno-soul di Decisions e la cassa in quattro di Walking
This Dumb passi un intero universo di vibrazioni e possibilità. E' proprio il caso di tenerlo d'occhio.
(7.4/10)
Stefano Solventi
Il Garage Ermetico - Pugni nell'aria EP
(Fumaio, Novembre 2010)
Genere: punk rock
Quattro album alle spalle smerigliando electro-folk finché non è rimasto che l'osso di un'urgenza (post) punk,
che trova infine attuazione in questo Pugni nell'aria
EP, sorta di punto e accapo per i bergamaschi Il Garage Ermetico. Spesi gli adeguati complimenti per
cotanta ragione sociale (ispirata ad un fumetto di Moebius) e per l'alltrettanto fumettistico artwork (a cura
di Francesco Betti), non resta che constatare lo slancio
ruvido e l'impetuosa pensosità che muove la proposta,
quell'impatto grezzo/impellente ma acuto e sensibile
che non può non rimandare alla calligrafia di Giorgio
Canali (si prenda la tesa John Cassavetes), foga che s'acquieta - ovvero si prende una vacanza d'irrequietezza con la ballad La classe operaia va al Bolgia, sintonizzata
su frequenze Marlene Kuntz.
La stringente alternanza di talkin nevrastenico e raffiche melodiche ti fa quasi pensare ad un Rino Gaetano
hardcore, oppure - tanto per restare alla cronaca recente - ad un Vasco Brondi che ha spezzato il cerchio greve della disillusione con robuste iniezioni di disperata,
struggente combattività rockista. In ogni caso, il minimo comune denominatore degli anni zero non demorde, non smette di contagiare. Se ne usciremo senza rinnegarli sarà anche grazie a dischi come questo.
(7.2/10)
Stefano Solventi
Inca Babies - Death Message Blues (Black
Lagoon Records, Novembre 2010)
Genere: post-punk / blues
Non verranno certo ricordati per questo Death Message Blues gli Inca Babies. Al massimo per essere stati un
discreto gruppo post-punk della Manchester di inizio
anni Ottanta, capace di sintetizzare certi liquami Birthday Party e le maniere grezze dei Cramps in quattro
dischi quattro. Un'avventura cominciata nel 1983 con
un caveiano Rumble e conclusasi nel 1987, agli albori
di quella Madchester chimica che imporrà canoni estetici di tutt'altro genere.
Risale al 2006 l'inaspettata reunion della formazione,
sulle ali di un Plutoniom best of edito dalla Cherry Red.
Tour successivo, qualche soddisfazione, l'idea di scrivere nuovo materiale. Poi l'improvvisa morte del bassista
Bill Marten a metà lavorazione, un evento che trasforma la pubblicazione di Death Message Blues in un
inevitabile omaggio all'amico scomparso.
Nel disco tutto si riduce a una raccolta di blues-rock
acido come lo avrebbero fatto gli Electric Prunes se
55
highlight
Leila Adu - Ode To An Unknown Factory Worker (Rai Trade, Novembre 2010)
Genere: jazz
Un “melting pot” vivente, Leila Adu. Origini ghanesi e passaporto neozelandese, ha sin qui conciliato
un’istruzione musicale di stampo accademico (sul muro una laurea specialistica in moderna elettroacustica, etnomusicologia e orchestrazione) con la passione per jazz ed elettronica. Dal 2003 ha recapitato
tre album di canzoni “trasversali” che, facendo leva sul pianoforte e una
voce di peculiare espressività, di quanto sopra cercano e sovente trovano
la quadratura del cerchio, giovandosi inoltre della presenza di Steve Beresford e Lol Coxhill, di Steve Albini ed ex membri Rip Rig & Panic. Non
contenta, Leila ha composto partiture per spettacoli di danza, per il teatro
e il cinema, e nei ritagli di tempo (!) tiene corsi di canto semi-improvvisato
per ragazzi. Alla faccia.
Giunta con il precedente Truth in The Abstract Blues - in trio con il chitarrista
Mike Cooper e il batterista Fabrizio Spera - su Rai Trade, la ragazza raddoppia con questo spartano e intenso Ode To The Unknown Factory Worker, sola davanti a tasti bianchi
e neri tranne quattro brani nei quali si aggiunge la batteria del bravo e misurato Daniele De Santis.
Ne risulta una manciata di acquerelli intimisti che fanno pensare a una Joni Mitchell traboccante melanina, a certe pagine di White Magic (Cigarettes & Circus Puffs) o a una Nico modernista che ha freudianamente rimosso il gotico (la splendida Fortuna). Uno spirito costantemente disposto a sbrigliare
emotività spigolosa (la title-track, Brazen Hussy) quanto lo è nel concedere alla stessa autocontrollo e
romanticismo mai banale (Martin Raft, Glass). Chiosando Bill Evans, sono conversazioni con se stessa
che - superata l’iniziale difficoltà - scopri divenire un abitudine. Discorsi che cancellano l’eccesso di vacuità e rumore di fondo che infesta certe nostre giornate.
(7.4/10)
Giancarlo Turra
fossero stati prodotti da dei Gun Club imbolsiti. E forse è proprio questa la vera notizia. Ovvero ascoltare
il gruppo parafrasare i bluesmen del delta in Tumblin'
Man, scimmiottare un crossover chitarristico dal vago
sapore Bad Seeds in The Miracle That Holds Me In Its
Hands o accostarsi a un soul à la Eric Burdon in Even
Lovers Drown, quando in realtà il passato della band sta
da tutt'altra parte. Il resto è verve da cinquantenni, lutti
che segnano, crisi di identità, ricerca poco convinta di
uno svecchiamento fuori dai soliti giri. Un altro mattone di una biografia borderline che per ora si mantiene
forzatamente borderline.
(5/10)
Fabrizio Zampighi
James - The Morning After (Mercury,
Settembre 2010)
Genere: pop
Dopo The Night Before, ovviamente The Morning After:
nel giro di pochi mesi i James di Tim Booth tornano con
un altro mini, otto canzoni per mezzora di durata in cui
56
espandono e danno ulteriore prova di quell’ispirazione
già testimoniata un paio d’anni fa dal sottovalutato Hey
Ma. Consapevoli del loro stato di meravigliosi reietti, i
mancuniani continuano dunque, com’è loro costume
da ormai una buona trentina d’anni, a fare musica per
orecchie selezionate ed attente: dai toni epici che sanno di celtico di Got The Shakes e Rabbit Hole (come dovrebbero suonare gli U2 oggi, se avessero ancora sangue al posto del cash) al tecno-pop di Tell Her I Said So
(New Order e Pet Shop Boys sugli scudi), dalle ballate
acustiche Kaleidoscope e Dust Motes (Coldplay e Echo
& The Bunnymen, toc toc) e i sentori notturni à la Eno
di Fear all’enfasi orchestrale di Lookaway (non troppo
lontana dal Morrissey solista dei primi tempi). Praticamente un inappuntabile compendio di stile, con gusto
e sentimento. Niente da fare, anche volessimo non riusciremmo a dirne male.
(6.9/10)
Antonio Puglia
James Blake - Klavierwerke EP (R & S
Records, Ottobre 2010)
Genere: chamber step
Una generazione di post-stepper under30 dà nuova
linfa al genere ammorbidendo i toni e diversificando il
suono tra richiami trip-hop, folk, glitch, new wave, suggestioni da colonne sonore e classica contemporanea.
I Mount Kimbie sono il primo nome da segnarsi. Il secondo, to be, quello di James Blake, un paio di lavori
sulla breve distanza alle spalle e un tag come "Modern
Classical" su discogs.com che spiega perfettamente da
quanti punti di vista diversi può essere guardata la faccenda.
Quattro pezzi soltanto in questo nuovo mini e un dubstep arty studiatissimo (tutto glitch decorativo tra bolle
e intarsi come di biglie di vetro, fantasmi trip-hop, piano tra l'austero e il romantico), immerso, come il titolo
lascia opportunamente intuire, in un'atmosfera che fa
tanto "musica da camera + Repubblica di Weimar".
(7/10)
Gabriele Marino
Jamiroquai - Rock Dust Light Star
(Mercury, Novembre 2010)
Genere: electro funk
Dopo cinque anni di silenzio, Jay Kay torna ancora una
volta col suo baraccone funky UK. La ricetta è quella
che ci serve sul piatto ormai da millenni, e anche se era
facile migliorare il disastro del precedente Dynamite,
la nuova fatica non fa altro che assestarsi sulle linee di
una sonorità ormai uber-sfruttata e ostentatamente
macchiettistica.
I Jamiri si rifanno il trucco ancora una volta e variano
di poco lo stile, ripescando le coordinate della blaxpoitation con gli assoli di sax o dei tastieroni analogici
d’obbligo (Smoke And Mirrors), ci apppuntano qualche
passaggio disco con i clap e i falsetti da febbre del sabato sera (White Knuckle Ride) che fa tanto fashion à la
Scissors Sisters, sanno spingere il ritmo con l’uptempo delle chitarrine funk e con i coretti in terza (All Good
In The Hood) e per finire ci impastano anche la hyperballad (Blue Skies) che ricorda le boys band dei Novanta
più che James Brown.
Un fiasco? Dopo qualche ascolto ripetuto, bisogna riconoscere come la patina vintage e la polvere del tempo
non stia proprio male sulla tuba esplosa di Jay, anche se
il divano su cui si adagia il suo gruppo ha ormai le molle rotte. Il disco si lascia ascoltare in sottofondo e ripete
un cliché consolidato, buono per un ascolto loungey
senza troppe pretese. E’ ora di ripartire e staccarsi dallo
space funk monolitico e patinato che da quel lontano
1993 (anno in cui è uscito il capolavoro Emergency On
Planet Earth) non ha per nulla variato gli ingredienti. La
tecnica c’è (basta ascoltare il groove di She’s A Fast Persuader), aspettiamo che arrivi anche la voglia.
(5/10)
Marco Braggion
Jason Collett - Rat At Tat (Arts & Crafts,
Ottobre 2010)
Genere: ultra-pop
Chissà se, oltre a prestare la chitarra ai connazionali e
padroni di casa discografica Broken Social Scene, Jason si diletta di pasticceria. Così fosse, potrebbe incanalare colà la propensione ai dolciumi pop dal basso
tenore calorico e dal gusto persuasivo come quelli qui
confezionati con i compagni di merende Zeus. Base
strumentale solida di un disco che nella penna omaggia il miglior Ray Davies (afflitto in Winnipeg Winds e
festante al confine tra Texas e Messico in Vanderpool
Vanderpool), che immagina Bob Dylan in abiti più del
solito eleganti (The Slowest Dance, Rave On Sad Songs)
e che pesca con intelligenza dal bagaglio dell’odierno
pop-writer (spinte adeguatamente, le discrete Long May
You Love e Love Is A Chain potrebbero andare lontano).
Autore consapevole della storia ma non prono di fronte agli stereotipi, Collett irrobustisce il John Lennon
acidulo del White Album in High Summer e Lake Superior; sereno, all’affanno dei “cugini” statunitensi e alle
apocalissi di Arcade Fire antepone l’arguzia figlia di
Jeff Tweedy che emerge da Bitch City e Cold Blue Halo.
Confermandosi figlio di Toronto, città decentrata a sufficienza per osservare le mode con distacco e leggerle
attraverso un vetrino insieme appassionato e sornione.
Soprattutto, dicendosi cavallo di razza meritevole di
attenzione.
(7.2/10)
Giancarlo Turra
Kanye West - My Beautiful Dark Twisted
Fantasy (Roc-A-Fella, Novembre 2010)
Genere: pop-hop baraccone
Il 2010 di Kanye è cominciato presto, con l'indifendibile
live VH1 Storytellers. Poi l'uomo si è dedicato massicciamente - con quelle mosse che solo lui sa e può - a promuovere questo quinto album, seguito della zuccherosa epopea autotunistica 808s & Heartbreak (2008). Lo
scacco matto, tutti al tappeto, il lancio sulla rete di quel
vero e proprio mini-"action movie filosofico" che è Runaway. Kanye, il migliore imprenditore di se stesso.
E proprio Runaway - in allegato come dvd nell'edizione
deluxe, in streaming ovunque sul web - è la perfetta
57
chiave di lettura del personaggio e un succo concentrato della sua visione del mondo, molto più del disco
in quanto tale (che è un ottimo disco di pop-hop now).
Runaway è un Bildungsroman mancato, la storia di un
incontro/scontro e di un rifiuto, la storia di un angelo
- la modella Selita Ebanks - caduto dal cielo che cerca di capire il nostro mondo e che, consapevole che
"anything that looks different you try to change", si vede
costretta a scappare e a fare ritorno alla propria dimensione celeste: neppure l'amore del suo Virgilio (Kanye
ovviamente, attore regista e quant'altro) potrà trattenerla.
Runaway è meravigliosamente ridicolo, è un'americanata superpatinata, compiaciuta, autoindulgente,
frutto dell'egosbornia sbrigliata del nostro, sempre più
convinto che la propria filosofia di vita ("No more drugs
for me, pussy and religion is all I need" dice in Hell Of A
Life) sia particolarmente profonda e dunque degna
di essere esposta al mondo con il massimo dispiego
di mezzi e tutte le pretese artistiche del caso: Vanessa
Beecroft come art director, citazioni cinefile e omaggi
musicofili, trucchi narrativo-registici come la Ringkomposition che lega inizio e fine, un uso estenuante del
ralenti che dà la stessa nausea dell'abuso dell'autotune
ai tempi d'oro. Tutto questo per veicolare la denuncia
dell'omologante cannibalismo esistenzial-materialista
di cui siamo vittime e carnefici. Insomma, quello che ne
viene fuori è davvero il trionfo del postmoderno come
confusione etico-estetica, come guazzabuglio e vuoto
decorativismo, per di più elevato al quadrato perché
asservito alle esigenze esagerate di quell'ego che ben
conosciamo: meravigliosamente ridicola la scena in
cui, novello sciamano-incantatore di serpenti, Kanye
attizza l'angelo/fenice suonando come un ossesso Power all'mpc.
La musica non è l'ennesima epifania promessa dal
guru Kanye, ma un ottimo esempio del suo coloratissimo mondo musicale fatto di orchestrazioni ed elettronica, ballad romantiche (quella pianistica con John
Legend), tamarrate che sono nuove forme di crossover
(la pompa uptempo e gli strombazzamenti di All Of The
Lights), funk&soul (i cori dell'intro, il pathos di Devil In A
New Dress), classic rock (i prestiti da 21st Century Schizoid Man e Iron Man), omaggi alle grandi figure della
black (se nel video c'è una parata con un megabusto
di Jacko, qui si chiude con un discorso paranoico di Gil
Scott-Heron). Mondo colorato condito da una quantità di ospiti delle più diverse estrazioni: Kid Cudi, Raekwon, Rihanna, Alicia Keys, Elton John, Jay-Z, Bon
Iver. Pochissimo autotune (la conclusiva, eccessiva e
divertente Lost In The World) e mezza scaletta almeno
58
con numeri impeccabili per efficacia, su tutti Runaway
(la canzone), dal grande appeal pop-rock, e Monster,
con le sue appiccicose atmosfere urban-tribal. (6.9/10)
Ma non bisogna perdere di vista contesto e progetto e
così il film non può essere scartato al momento di tirare
le somme. Il ridicolo lo possiamo anche promuovere,
ma solo quando lo avalliamo.
(5.9/10)
Gabriele Marino
Kid Cudi - Man on the Moon II: The Legend
of Mr. Rager (GOOD Music, Novembre 2010)
Genere: black / psych hop
Torna Scott Mescudi dopo un esordio con il botto. Man
on the Moon: The End of Day era un disco di buon livello,
ampiamente sopravvalutato in USA e UK (fa eccezione
Pitchfork che lo ha stroncato), accolto bene anche qui
da noi, con un giudizio su tutti da ricordare per oculatezza critica, quello di Eddy Cilìa, che pur citandolo tra
i dischi chiave dell'anno ne sottolineava la disomogeneità qualitativa.
Ora Cudi è cresciuto (non solo musicalmente, è tra i
protagonisti di How To Make It In America, il serial che
ha per sigla I Need A Dollar di Aloe Blacc) e gli si deve
riconoscere lo smarcamento tutt'altro che facile da definizioni pret-a-porter come "il pupillo di Kanye West"
e "quello di Day 'n' Nite" (ricordiamolo però che il remix bomba dei Crookers ha dato nuova vita e fatto
esplodere un pezzo tutt'altro che irresistibile). Questo
sequel (come il padrino Kanye, Scott ama sottolineare
il proprio gusto per la costruzione dell'impianto narrativo) è davvero una spanna sopra. Meno solare (lì numeri come il mascheramento GaGa-iano di Make Her
Say, qui una vena umbratile e bluesy che percorre tutta
la tracklist), meno elettronico ed effettistico, più misurato, soprattutto più personale nell'approccio blackneopsichedelico, più curato (contiamo 50 tra tecnici
del suono, ingegneri e produttori).
Cudi ha davvero fatto il salto di qualità. Tra numeri di
alto livello (su tutti, lo slo-rap della notturna e urbana
The End) e ottime prove di mestiere, sia per l'interpretazione che per le basi (ballad fumose, influenze musical,
tentazioni sperimentali - industrial, psych, addirittura
folk - tra indie e alt-hop), si fa perdonare un paio di numeri meno a fuoco, come il duetto enfatic college pop
con Kanye in Erase Me. E bravo Cudi.
(7/10)
Gabriele Marino
King Dude - Tonight’s Special Death
(Disaro, Settembre 2010)
Genere: Folk Noir
Liir Bu Fer - 3 Juno (Zeit Interference,
Ottobre 2010)
Genere: ambient-kraut
TJ Cowgill, l’ultimo adepto del culto del triangolo, è
un oscuro e barbuto individuo proveniente dalla periferia industriale del Nuovo Continente (leggi: Seattle)
che a differenza dei suoi congregati non armeggia con
elettronica casalinga, tutta sample, loop, synth e drum
machine, ma, al contrario, predilige lo strumento più
classico ed unplugged, la chitarra acustica.
Cento copie su CDr, Tonight’s Special Death è fatto di
ballad trad-apocalittiche immerse in simboli simil-satanici e paganeggianti (come già eloquentemente testimoniato dal singolo The Black Triangle su Clan Destine),
otto brani che alternano umori da folk antico (River Of
Gold) e moderno (Born In Blood), vedendo anche la partecipazione di un'altra reginetta del nero, Kendra Malia
dei White Ring (Slaves).Un ruvido e personale misto
di Death In June, Werkraum e :Of The Wand & The
Moon:, ma anche Dylan, Guthrie, Leonard Choen e tutta la scuola del cantautorato americano più intimista e
solitario. Una buona prima prova.
(7/10)
Difficile tracciare un percorso stilistico ben definito
quando si parla dei veronesi Liir Bu Fer. Certo è che il
terzetto ama crogiolarsi in una ricercatezza sonora cerebrale almeno quanto il moniker scelto per la ragione
sociale. Il che significa, nel caso specifico del loro disco
d'esordio 3 Juno, avere a che fare con un ambient filokraut che somma spazi aperti costruiti su un'elettronica
liquida (Esperanto) a una ricchezza timbrica suggestiva
e variegata.
Kalimba, pianoforte, loops, microfoni a contatto, armonica, flauto, ebow, musica concreta, suoni in reverse:
questo ed altro nelle corde di Nicola De Bortoli, Andrea Tumicelli e Marco Tuppo. Un campionario di landscapes descrittivi a cui si mescolano voci senza tempo (gli Ovo non sono poi così lontani dall'approccio al
cantato di Es) e veri e propri testi in bilico tra sacralità
ferrettiana e acutezze à la Stratos (Red Submarine).
Mancano un po' di pragmaticità e coesione, sacrificate
sull'altare di un'accuratezza formale prolissa, debordante e forse fin troppo pretenziosa.
(6.4/10)
Andrea Napoli
Fabrizio Zampighi
Laetitia Sadier - The Trip (Drag City,
Settembre 2010)
Genere: pop vintage wave
Certo il tempo è passato e dall'elegante francese non
ci si aspettano più miracoli o cambi di rotta particolari,
pur sapendo della pausa a tempo indeterminato dagli Stereolab e della chiusura del side-project vintage
pop Monade.
Batterie krautrock, ritmiche affidate a synth meccanici o
a chitarre altrettanto robotiche, arrangiamenti raffinati
e una voce sempre eterea e sofisticata. Gli ingredienti
non cambiano eppure una differenza si avverte: il volume del microfono è alzato e Laetita lascia trasparire un
velo d'emozione inedito specialmente nella malinconica ballata Statues Can Band e nella frizzante One Million
Year Trip, che parla del suicidio della sorella.
A render più umana la cantante contribuiscono le liriche
e una maggiore espressività, specie nelle due splendide cover Un Soir, Un Chien di Les Rita Mitsouko (dove
neppure il minimalismo elettronico tanto caro alla sua
vecchia band riesce a oscurare l'interpretazione vocale) e By The Sea di Wendy & Bonnie.
Il Trip musicale di Laetitia è lungi dall'essere concluso. (6.8/10)
Gemma Ghelardi
Lukid - Chord (Werk Discs, Ottobre 2010)
Genere: post-wonky
Se il wonky è ormai diventato un ‘affaire’ di definizione
dell’estetica electro post-00 lo dobbiamo a gente come
Lukid. Già con il suo precedente Foma ci aveva deliziato con inserti, sample e accostamenti che ereditavano
la sapienza del bbreaking attualizzandola con le mosse poetiche di Warp o Ninja Tune. Proseguire su quella
strada ormai quasi saturata dalle proposte è dura, ma
Luke Blair sa cosa fare al momento giusto e al posto
giusto.
La tattica per uscire dalla dispersività massimalista del
dopo-Flying Lotus è inserire qui e là citazioni da altri
mondi senza rovinare tutto con un inopportune uscite
fuori tema. Il ragazzo resta sempre nelle stanze bbreak
UK che caratterizzano il marchio di fabbrica Werk, ma
ci costruisce intorno un’impalcatura di suonini a 8 bit
(Rags), di loop Novanta illbient (Hair Of The Dog), field
sounds à la Coldcut (Child Of The Jago), tastierine analogiche, tagli acidi (Through Gritted Teeth) e altri accorgimenti che dicono e non dicono, che aprono possibilità restando piacevolmente sull’irrisolto.
Chiamiamolo ancora wonky, ma se vogliamo dirla tutta, questa è musica ambient per smanettoni, un piccolo mondo privato in cui rifugiarsi, sia esso il deboscio
59
post-party o la session di social network quotidiana cui
ormai siamo inevitabilmente condannati. Chord fa da
colonna sonora all’indeterminatezza del nostro presente con canzoni che non ricorderemo come singoli, bensì come una teoria di suoni da lasciare in loop melliflui
e ammiccanti. Non cancellatelo dalla playlist. Tornateci
ogni tanto e vedrete che lo apprezzerete sempre di più.
Quello che oltreoceano chiamano un grower.
(7.2/10)
Marco Braggion
Majeure - Timespan (Temporary Residence,
Novembre 2010)
Genere: synth revival
A.E. Paterra, batteria e synth, è personaggio noto a
chi bazzica nel sottobosco americano. Quando suona
in doppio col chitarrista Steve Moore (anche basso e
synth) si fanno chiamare Zombi e vanno di Goblinprog virato krauto ma sempre sul crinale delle musiche
estreme, incidendo per etichette come la Relapse. Ora
il drummer se ne esce in solitaria e accentua il versante
analogico del suono della casa madre.
Timespan si muove, infatti, completamente dentro al
revival cosmico che tanti cuori spacca ultimamente,
dagli Emeralds in giù: colonne sonore a furia montante di synth analogici e suoni vintage, con predilezione
per atmosfere semi-horrorifiche, accenti futuribili come
di un Vangelis periodo Blade Runner ed esposte in tre
fluviali tracce che si fanno ascoltare alla grande. Minimalismo moog-oriented e in modalità sci-fi applicato a
cavalcate post-Can in definitiva, in cui si apprezza l’alternanza tra la muscolarità live della batteria e le algide
distese di suoni elettronici.
Il disco esce in edizione vinilica, di cui esiste pure una
versione digitale limited: doppio cd con bonus di remix
del collega Steve Moore (la title track), dell’immancabile Justin K. Broadrick aka Jesu (Teleforce) e del produttore francese Black Strobe (The Dresden Codex).
(6.9/10)
Stefano Pifferi
Manuok - The Old Horse (Macaco Records,
Settembre 2010)
Genere: alt-folk
La ricchezza espressiva del precedente No End To Limitations viene ridotta in un battibaleno alla musica minimale, strascicata e malinconica di The Old Horse. In
un bagno primordiale di affetti persi (il nonno) e ricordi
rurali, andature svagate e cantato in controluce che si
accontenta di farsi guidare da una chitarra acustica, un
pianoforte, un batteria e poco altro. Parrebbe un difet60
to e invece è un pregio. Tanto che in questo più che
in altri dischi di Scott Mercado - alle spalle militanze
in Black Heart Procession, Devics e miriadi di collaborazioni, non ultima quella che lo ha visto ricoprire il
ruolo di produttore per il recente Super 8 dei Grimoon
- sembra emergere la reale virtù del polistrumentista
americano. Ovvero il saper fissare confini e obiettivi
precisi, anche quando si tratta di maneggiare - ed è il
caso soprattutto di questo terzo disco a nome Manuok
- quello che forse è il materiale più comune e malleabile sulla piazza: il folk.
In tanti ci provano, pochi riescono a gestire alla stessa
maniera lirismo e semplicità. Spacciando per naturali
melodie invece ricercate, artigianali e poco interessate
alle scene di riferimento. Su una scrittura che con l'approccio al lavoro dei sodali Pall Jenkins/Tobias Nathaniel ha più di un punto di contatto, a cominciare da
quell'attenzione maniacale riservata allo svolgimento
della parte musicale. Dettagli strumentali che segnano a fuoco - il Badly Drawn Boy sognante dell'iniziale
Cold Winter, la progressione sul piano di Salt In Water,
le cadenze marziali di Carcerate - dando spessore a un
album da consumare con lentezza.
(7.2/10)
Fabrizio Zampighi
Marlene Kuntz - Ricoveri virtuali
e sexy solitudini (Sony BMG Music
Entertainment, Novembre 2010)
Genere: rock
Spesso nel rock alla maturità segue una fase di recupero e rielaborazione del repertorio che talvolta assume
la forma di sbrigliato superamento di (o deviazione da)
esso. Quando accade, lo fa con la disinvoltura di chi si
è liberato dalla zavorra del dimostrare, del fare a fette
la cresta dell'onda che nel frattempo, ahilei, si è consumata. Ascoltando l'ottavo lavoro dei Marlene Kuntz,
parrebbe proprio il loro caso. Del resto, il precedente
Uno somigliava parecchio all'album della pienezza
espressiva, non certo l'apice della carriera però in qualche modo l'approdo al termine di un lungo percorso.
Da cui segue la possibilità di affrancarsi da esso, la conquista di una rinnovata libertà d'azione. Un disimpegno
che significa impegnarsi nuovamente, in modo nuovo.
Difatti, Ricoveri virtuali e sexy solitudini sembra il
futto di uno spasmo rock che se da una parte rivanga
l'estro sonico delle prime cose, d'altra parte - soprattutto - si concede all'immediatezza della canzone, alla
sua facoltà di graffi e carezze, urla e languori, ammiccamenti e strappi. Mai la calligrafia della band di Cuneo è
apparsa così diretta e concisa: se l'abito sonoro si disim-
pegna elaborato ma al contempo funzionale (produce
Howie B), i testi colgono l'occasione per togliersi un
bel po' di sassolini - più o meno "poetici" - dalle scarpe,
senza con ciò venir meno alla consueta intensità "letteraria" che nulla lascia al caso. Anzi: il disco è una specie
di concept sulla crisi innescata dal prevalere dei codici
della società iperconnessa, virtualizzata, webbizzata.
Di cui un aspetto importante - quello che, per tutta una
serie di motivi, ha fatto più rumore - è il rapporto tra
individuo e musica, dissestato da pratiche di download compulsivi e social network pervadenti (vedi la ghignante opening track Ricovero virtuale).
Non è questa la sede per approfondire lo sdegno apocalittico delle liriche, però è giusto sottolineare quanto
il loro entrare a piedi uniti sulla questione ringalluzzisca
il verbo kuntziano, fornendogli un'aggressività di cui
da tempo s'erano perse le tracce. Ed è tuttavia anche
l'aspetto più interessante della proposta, che nel complesso non va oltre una competenza ben lubrificata,
un sia pur turgido, ruvido e a tratti intrigante mestiere.
La bieca pulsazione trip-hop di Io e me, le ingannevoli
sinuosità di Oasi, il tiro power di Orizzonti, l'amarezza
rappresa in forma di ballad de L'artista, la nostalgia
post-glam di Paolo anima salva sono i momenti più
convincenti della scaletta, tutto sommato abbastanza
ispirata al netto di qualche comprensibile inciampo
(l'omelia raffazzonata di Vivo e l'adrenalina un po' gratis di Pornorima).
Doppiati i venti anni di carriera - anche se esordirono
con Catartica solo nel '94 - e dopo aver segnato un'intera generazione di indie band nostrane, i Marlene
Kuntz sembrano aver accantonato il piglio furibondo
e sperimentale assieme alle ambizioni da mainstream
(vagamente alternativo) per accettare lo status di buona rock band, non più in grado di sostenere il fuoco
della prima linea ma ancora capace di incursioni dirimenti in territorio "nemico".
(6.6/10)
Stefano Solventi
Martin Schulte - Silent Stars (RareNoise,
Novembre 2010)
Genere: Deep, ambient
L’aggiornamento laptop post-Mille Plateaux (dunque
field recording, noise e glitch) del filone techno dub
ambientale dal taglio artico, iniziato da gente come
Biosphere e traghettato nei Duemila nella forma che
conosciamo da Monolake, Pan American e Vladislav
Delay, non smette di regalarci sorprese e ottimi lavori. In
particolare, dall’America, negli ultimi due anni abbiamo
incontrato le ottime prove di Rod Modell - sia in solo sia
con DeepChord (Liumin) - mentre dalla Germania non è
certo una coincidenza s la febbre Basic Channel risvoltata ambient e riverberi è risalita a un Pantha Du Prince
(con Black Noise). E questo senza tralasciare la forza traino del progetto di Moritz Von Oswald.
In un terreno già caldissimo, dentro gli steccati di un verbo già abbondantemente espresso (e compiuto), oggi arriva sugli scaffali, via RareNoise, l'ultimo album di questo
ragazzo russo che tra tutti è sicuramente il più atmosferico e legato ai trucchetti clicks’n’cut (tra l'altro riscoperti
anche da gente come Mount Kimbie), nonché dj già in
possesso delle chiavi per dialogare con i maestri. Martin Schulte è il moniker dietro il quale si cela un appena
ventiduenne tartaro - vive a Kazan - che di nome fa Marat
Shibaev. Al suo attivo, dal 2006, ha già una serie di pubblicazioni in mp3 e anche due buoni album per la giapponese Lantern (Depth Of Soul e Odysseia). Silent Stars, tra
momenti di puro groove sciolto nei ghiacci e dub+echi
perfettamente intarsiati nel 4/4 techno, ambient di classe
e ottime viste a cannocchiale, lo farà conoscere anche da
noi e con il lavoro migliore senza dubbio.
(7/10)
Edoardo Bridda
Ministro (The) - Tempi Moderni (Enzone
Records, Dicembre 2010)
Genere: rock
Che l'immaginario sia importante per una band agli
esordi, è ormai opinione comune. Ricondurre la musica
a un'ispirazione totalizzante significa spesso favorirne
l'assimilazione e stimolare la curiosità di chi ascolta con
riferimenti ben precisi, prima che con i brani. Questo è
quanto fanno anche gli The Ministro con Tempi moderni, dedicando un'opera rassegnata e ironica (oltre
a una ragione sociale decisamente in tema) a una classe politica comica già di suo e quindi particolarmente
predisposta allo sfottò.
E allora cravatte e completi scuri incastonati tra il valzer
di Tutti al ministero e il tex-mex di Elezioni a Little Garden, lo swing di Comizio all'italiana e il reggae di Ponte
si ponte boh?!, il collage citazionista della title track e il
blues di Da domani smetto. In un accatastarsi di generi
e idee scoordinate in bilico tra il Marco Carena di Ciao
Paese, il Gaber di Io non mi sento italiano ed Elio e le
storie tese. Con le dovute differenze di peso specifico,
dal momento che il cantar disgrazie dei The Ministro
sembra più un lamentarsi goliardico un po' fine a sé
stesso che una critica affilata. Seppur suonato in maniera impeccabile.
(6.4/10)
Fabrizio Zampighi
61
highlight
Shackleton - (Fabric, Dicembre 2010)
Genere: bass sciamanico
Dopo che l’hanno sentito suonare dal vivo in una delle serate più acclamate della scorsa stagione, i
capocchia del Fabric gli hanno subito presentato il contratto per registrare la compilation sulla serie di
punta del locale londinese. Shackleton ha ovviamente accettato e ci ha messo dentro un set simile a
quello dello scorso Dissonanze. Roba da trip e tunnel vision, altro che pre-serata disco.
Questo disco di sole produzioni dell’uomo (un lusso concesso a Ricardo Villalobos, Omar S e pochi altri) più che un mix è una messa. Un rito sciamanico fatto di voci, suoni che passano velocemente da un
canale all’altro, una trance meditata, ricca di drones e di appigli a estetiche
da sabba. Siamo oltre l'estetica stepping londinese: il padrino dell’ormai
defunta Skull Disco (con l’amico Appleblim) si accosta alle estetiche berlinesi che puntano su percussività e sballi visionari alieni dalla cassa dritta della techno che oggi gente come Scuba innesta a man bassa. Quindi
niente cattiveria plastificata grime o cupezze da sobborghi londinesi.
Il magma sonico della compila ti avvolge nei misticismi dei Current 93
(Deadman), dei Can (Man On A String) o in queli goa sognati dai mid-thirty
di oggi (Busted Spirit) con i paradisi degli O.R.B. (Ice). Padri nobili e sottofondi mentali di qualche tempo fa che si incontrano anche dal punto di vista tecnologico con l’onnipresente elettronica pulita di Four Tet, amore per le percussioni orientali (New Dawn) o effetti dubby
da echo chamber à la Pole.
Perfezione certosina nel mixing, varietà negli accostamenti e oculatezza dei timbri ne fanno il miglior
regalo di Natale per chiunque ami la musica del desiderio. Una delle compilation dell’anno.
(7.5/10)
Marco Braggion
Moorder - Moorder (Novembre 2010)
Genere: fusion
I Moorder sono la creatura del bolognese Alessandro
Lamborghini, chitarrista acido e compositore che ha voluto attorno a sé questo ensemble di sei elementi per
dar vita ad una fusion calorosa dove l'hardcore si scozza
jazz e funk esponendosi a fregole etno ed effetti collaterali post. Chitarra e vibrafono sono gli estremi di un ventaglio sonico (tuba, sax, basso elettrico...) che si dipana
duttile, convulso e onirico, feroce e beffardo, come un
Frank Zappa un po' vanesio in un fantasy David Lynch,
uno spasmo elettrico per ogni fatamorgana tipo certo
intercalare June Of '44 oppure le ipotesi futuristiche
Tortoise tra strattoni Shellac e particelle mnemoniche
Weather Report.
Una versatilità tosta e coesa che azzecca l'apice con la
frenetica Captain's Boot e la vorticosa Ramalina fastigiana, per poi intorbidire la questione con la strada silenziosa (e gli scostanti tremori) di I Get Li. Programmaticamente fuori da ogni voga, però (perciò) degni di nota.
(7.1/10)
Stefano Solventi
62
Music For Eleven Instruments - Business
Is A Sentiment (Red Birds, Ottobre 2010)
Genere: toy-music
Al di là del numero degli strumenti, peraltro superiore
a undici, questo progetto fa in realtà capo al siciliano
Salvatore Sultano, già attivo con tali Flugge e qui intestatario di composizione, artwork e la quasi totalità
dell’esecuzione. Un altro uomo (quasi) solo nascosto
dietro un’entità di gruppo fittizia sebbene non l’ennesimo, considerando come, in un panorama assai prospero e ciò nonostante spesso stereotipato come il “nuovo
rock” italiano, questa sarabanda di filastrocche in bilico
tra l’estatico e lo stralunato possegga una certa personalità. Spiegata in mezz’ora che congiunge un’elettronica lieve e umanista - da Hood privati di tentazione
danzereccia, presi a modello e non copiati come da
noi suol fare la maggioranza - con un bric-a-brac sonoro che rintraccia in Pascal Comelade il referente più
prossimo.
Liberando sul resto, da una cameretta colma di balocchi e profumi primaverili, lo splendido valzer popolaresco My Sicilian Lover Is Foul, i gustosi babà di pop mu-
tante Alba Song, Happy Song (Part Two) e Fables About
Her, una Box-Body fragrante d’obliquo folk. Rimane da
chiarire se per Salvatore abbiano contato, in termini di
“attitudine” e talvolta anche di timbro vocale, più i vinili
di Syd Barrett del babbo o l’eventuale ascendente dei
Jennifer Gentle. Quesiti da cronista che non inficiano
minimamente la godibilità di Business Is A Sentiment.
(7/10)
Giancarlo Turra
N.E.R.D. - Nothing (Star Trak
Entertainment, Novembre 2010)
Genere: smooth soul hop
"L'economia fa schifo, le ragazze sono ancora belle.
Volevamo fare musica che riflettesse questo". Yeah, Pharrell, forte e chiaro. Il quarto disco della costola on stage del duo produttivo Neptunes (Pharrell Williams e
Chad Hugo più il sempre più impalpabile Shay Haley)
è il sottofondo perfetto per le chicks che ha in mente
il ragazzo, perfetto perché assolutamente trasparente, altro che vedo/non vedo, smooth soul d'oggi così
smooth che scivola via manco fosse la seta della prova
Silk-épil.
I due singoli acchiappa-hype ne sono stati una perfetta
introduzione: il piatto standard post-Timbalandiano
(vedi invece l'ottimo Pharrell 2008 al servizio di Madonna) con tanto di Nelly Furtado post-se stessa di
Hot'N'Fun e il buco nell'acqua firmato addirittura Daft
Punk di Hypnotize U. Nothing è now soul sporcato inevitabilmente di funky (Perfect Defect), poca elettricità
nell'aria, poca rappusità (la title track), ancora meno
elettronica (Party People, con dei goffissimi fiati appiccicati sopra), tantissima enfasi invece a un passo dal
musical di Broadway (Help Me, I've Seen The Light, Victory, con più di un richiamo, fin dai titoli, al Todd Rundgren appunto più soul).
Molto suonato, molto cantato (Pharrell in estasi da
sexy-falsetto in più punti) e molto cantabile (ma i motivetti saliscendi sono piuttosto scontati), insomma un
prodotto di black americana prodotto bene - benissimo anzi - dai Neptunes ma senza canzoni che restano. Sei i pezzi bonus su iTunes: ne vale la pena? Fin
troppo facile tirare in ballo il titolo del disco.
(4.6/10)
Gabriele Marino
Nicolas Joseph Roncea - News From
Belgium (I Dischi Del Minollo, Settembre
2010)
Genere: guitar-solo
Nicolas Joseph Roncea suona la chitarra per alcuni dei
gruppi fuoco & fiamme (Fuh e Io Monade Stanca) del
panorama dal Canalese di cui ci occupammo qualche
tempo fa.
La prima prova solista del ragazzo se ne discosta totalmente. Ripiega in se stesso, Roncea, come in fuga dal
massimalismo in overdrive del suo strumento nelle formazioni ufficiali e indaga il lato più intimo, personale e
introspettivo del proprio essere musicista. In punta di
plettro e con voce pulita, quasi fosse un Bob Corn più
magrolino e sbarbato, sfilano una serie di piccole gemme acustiche (In The Snow, A Cup Of Tea, la vagamente
beatlesiana Another Word) di tanto in tanto rotte da
fiati e archi mai invadenti (3-4, 3:20 Am) o da divagazioni tra jazz e bossa (Blue Eyes). Un procedere che ci
fa apprezzare un album mai sopra le righe, introverso
e poetico, non privo di buone intuizioni e potenzialità
da esplorare.
(6.5/10)
Stefano Pifferi
Numero 6 - I Love You fortissimo
(Supermota, Novembre 2010)
Genere: pop rock
Mancavano all'appuntamento con l'album da quattro
anni, ma non ne abbiamo sentito la mancanza. Cioè,
non ne abbiamo avuto il modo né il tempo, visti i due
buoni EP e la gustosa collaborazione con Enrico Brizzi che hanno tenuto in caldo il nome dei Numero 6.
Gli ex-Laghisecchi - se è lecito chiamarli così - si sono
mantenuti a ridosso della prima linea e oggi finalmente sferrano l'assalto. A testa bassa e accada quel che
accada. Con quella specie di sorriso a tagliare l'aria.
Verticalizzando melodie e concetti come ama fare da
buona mezzala Michele Bitossi, ben assistito dalle chitarre del sodale Stefano Piccardo, dal redivivo bassista
Andrea Calcagno e dal neoassunto polistrumentista
Tristan Martinelli.
I Numero 6 fanno, insomma, pop-rock. Versante indie,
se vogliamo. Con arguzia muscolare da cuginastri dei
Weezer. Costeggiando l'agro malanimo post-giovanile
dei Perturbazione tolta la pensosità a vantaggio d'un
piglio liberatorio. Prevedendo uno spasmo alla fine di
ogni cruccio, una sgroppata in fondo ad ogni meditazione. Una propensione che rende la loro proposta
immediata perché semplice, il che non significa facile
né tanto meno banale: c'è tutto un intrico di rimandi e
quintali di buoni ascolti ad esempio nell'impeto acidulo di 200 Mg o nella suadente inquietudine quasi Kinks
di Dell'inadeguatezza, una lunga e vasta metabolizzazione di - solo a titolo di esempio - R.E.M. e Ivan
Graziani, Husker Du e Lucio Battisti, gli anni sessanta
63
e i novanta senza disdegnare quel che sta nel mezzo.
Quanto ai testi, confermano quell'emotività brillante
e un po' incarognita, quel gioco di finte e passaggi filtranti, compresa qualche palla persa (ad esempio la similitudine un po' forzata col popcorn in Mutazioni) che
in una partita ci sta, soprattutto se condotta sempre sul
filo dell'agonismo.
I Numero 6 studiano per diventare un punto di riferimento della nostra scena geneticamente scalcagnata
ma sempre più volenterosa. Forse lo sono già.
(7.2/10)
Stefano Solventi
oOoOO - oOoOO EP (Tri Angle, Ottobre 2010)
Genere: Witch-Step
Uno dei nomi più clickati della novella compagine
witch-house arriva al primo traguardo su media distanza. Un atteso EP per la giovanissima Tri Angle di
Brooklyn in cui Christopher Dexter Greenspan rilascia
sei brani inediti che virano verso umori meno claustrofobici e più “classicamente” glo-fi /chill-wave.
Ancora qualche tinta color bruno (Mumbrai, Burnout
Eyess) ma sono i paesaggi junk-pop zeppi di iconografie eighties (Hearts) e di umori da primi luci dell’alba
(Plains Is Hot) a farla da padrone. Il mood da casa delle
streghe viene così smorzato in favore di composizioni più astratte e fluide, come già il compagno di roster
Balam Acab ha avuto modo di dimostrare nel debutto
di pochi mesi fa. Ora c’è solo da aspettare e capire che
piega prenderà questa ennesima micro-sensazione
sotterranea.
(6.8/10)
Andrea Napoli
Paramount Styles - Heaven’s Alright
(Konkurrent NL, Novembre 2010)
Genere: indie
Se Failure American Style deludeva non sarà certamente
questo Heaven’s Alright a risollevare le sorti del nuovo
progetto degli ex Girls Against Boys Scott McCloud e
Alexis Fleisig. Troppo vivo il ricordo della band madre,
urticante protagonista del sottobosco newyorchese
dei 90s, e troppo bruciante la insulsa svolta operata
col nuovo progetto per passarla liscia. Inoffensiva e a
tratti fastidiosa, la scelta è quella di ammorbidire fino
all’annacquamento il sound originario, declinandolo
verso una forma di cantautorato urbano e malinconicamente romantico che mal si addice a pedigree e
potenzialità. Ne esce un qualcosa che rimanda qua e
là ai dEUS meno ispirati (Come To Where You Are) o ad
una versione radio-friendly orribilmente synth-pop dei
64
GVSB (The Greatest), con tanto di cassabile ballatona
strappalacrime al piano (Steal Your Love).
Non manca soltanto la zampata graffiante e memorabile che ci si sarebbe aspettati da iene di vecchio corso,
ma proprio una idea di fondo in grado di attirare l’attenzione.
(5/10)
Stefano Pifferi
Pazi Mine - Pazi Mine (A Buzz Supreme,
Ottobre 2010)
Genere: rock rumoroso
I Pazi Mine sono Sara Ardizzoni (chitarra e voce, in passato con Pilar Tenera e Sorelle Kraus), Francesco Artioli
(basso e voce), Marco Beiato (chitarra e synth) e Alessio
Capra (batteria e percussioni, da Super Elastic Bubble
Plastic). Vengono da Mantova e Ferrara, sono all’esordio
ma in realtà si collocano in qualche posto a metà strada
tra la Seattle che fu e la Chicago di casa Touch’n’Go, con
una puntatina nella New York rumorosa del Lower East
Side e nella Louisville dove il post- ebbe inizio.
Piccolo girotondo geografico, rigorosamente primi
90s, per indicare i referenti generici di un suono chitarristico irruente e affilato, derivativo quanto si vuole ma
sorretto da una ritmica corposa e mobile e al servizio di
una voce, quella della Ardizzoni, sensuale e aggressiva.
Come si confà ad una chanteuse rock di prim’ordine,
per intendersi. Capace di prendere la scena senza strafare.
In soldoni, in Pazi Mine troviamo tensione da postrock slintiano e romantica decadenza, sensualità e aggressività strumentale, intarsi ritmici math e stratificate
trame massimaliste per 8 canzoni in grado di tirare in
ballo il chitarrismo dei Sonic Youth del medio periodo,
le melodie acidule made in Blonde Redhead e certe
elaborazioni formali targate Fugazi. Bell’esordio, davvero. Ora aspettiamo un passo oltre.
(6.9/10)
Stefano Pifferi
Piccola Banda Brigante - Certi ricordi
(loser's company, Novembre 2010)
Genere: cantautorato folk
Venendo dalla Romagna e chiamandosi Piccola Banda Brigante, ci si aspetta da un momento all'altro di
veder comparire all'orizzonte il cappello a tesa larga
del leggendario Passator Cortese da Bagnacavallo, che
a metà dell'Ottocento imperversava nei boschi sopra
Brisighella con le sue azioni da Robin Hood nostrano.
In realtà, Brigante è il cognome di Antonio, voce e chitarra di questo progetto che fa della sua voce e del suo
highlight
Shugo Tokumaru - Port Entropy (Souterrain Transmissions, Dicembre 2010)
Genere: folk/indie-pop
Questo gioiello di indie-pop solare e colto è il quarto episodio discografico per un artista classe 1980
che fa tutto da sè. Ogni suono prodotto per realizzare queste dodici tracce
è il frutto delle capacità polistrumentistiche di Shugo Tokumaru, che a
cinque anni ha cominciato a pestare i tasti del pianoforte e a diciassette
già componeva le canzoni per la sua prima band. Nei trentasette minuti di Port Entropy si cercano e si prendono, si toccano e si fondono due
tradizioni come quella giapponese, evidente nella strumentazione e nelle
atmosfere, e quella pop inglese, che emerge a più riprese e rende conto
di quella che sembra essere stata la sua prima passione musicale: i Clash.
Ma i riferimenti sono, in realtà, pressoché infiniti e si potrebbe riempire la
recensione solo citando le influenze più o meno manifeste. Quelli che non si possono tacere sono John
Lennon, che ci si aspetta da un momento all'altro arrivi per intonare Strawberry Field, la Yellow Magic
Orchestra, Robert Wyatt, che aggiunge quel tocco di Canterbury che rende il tutto anche bucolico.
A dispetto dei titoli, tutti in inglese, Shugo canta esclusivamente in giapponese, aggiungendo fascino
alle sue composizioni, che finiscono spesso per assomigliare a un film di Hayao Miyazaki: c'è nelle sue
canzoni l'agrodolce e perfetto equilibrio tra la gioia, ma mai urlata, piuttosto trattenuta, rimessa completamente al campo dello spirito, e la nostalgia candida del sogno. Tracking Elevator mette in campo
la coralità giapponese, ma immediatamente dopo, Linne si apre con Erik Satie che incontra i Jaga
Jazzist. Drive Thru è puro vaudeville, come se Neil Hannon suonasse con i Pavement e River Low mette
un crescendo post-rock/prog al servizio di un bozzetto da tempio shintoista, con tanto di campanelli e
strumenti giocattolo.
Probabilmente Port Entropy verrà snobbato da molti, perché in tempi di velocità e fretta è troppo faticoso lasciare che un disco si prenda il proprio spazio nei nostri ascolti. Ma se glielo lasciate prendere,
questo piccolo capolavoro di indie-pop entrerà nelle vostre classifiche di fine anno. Comincerete a recuperare i dischi precedenti e a seguire Shugo Tokumaru come uno dei novelli artigiani del pop, capace
di utilizzare un linguaggio abusato, per ricavarsi la propria voce personalissima.
(7.3/10)
Marco Boscolo
istrionismo il punto centrale.I riferimenti sono quelli di
un cantautorato tradizionale, che guarda tanto al folk e
alle ballate popolari, quanto alle sue forme più evolute
e moderne (in Un giorno in stazione c'è più di un eco di
Vinicio Capossela). Canzone del giorno e della notte è
un esempio di scrittura complessa e raffinata applicata
a un gioco di specchi tra sole e luna, mentre gli accenni
tex-mex di Un sabato di pace si adagiano su un valzerino
antico e tutto da ballare. Altrove si può intravvedere in
filigrana la canzone classica a là Domenico Modugno;
e il tumulto anarchico che ha attraversato la Romagna
per molti decenni e che ancora oggi non è del tutto
dimenticato viene dipinto in Canzone per una ragazza,
non senza ironia e affetto.
Nove quadretti più o meno realistici, a volte giocati sulla cronaca, altre sulla politica e la società, sono le fo-
tografie di quest'album d'esordio già maturo per scrittura e intenti della Piccola Banda Brigante. Si rimane
totalmente dentro alla tradizione, con gusto e una certa personalità, che in futuro potrebbe dare frutti ancor
più succulenti.
(6.6/10)
Marco Boscolo
Pond - Frond (A Hole In The Sky, Novembre
2010)
Genere: Psycho rock
Quello che si sta sperimentando oggi dalle parti di
Perth è un'idea comunitaria del rock che ha le sue radici nelle utopie hippy dei tardi 60s. Mink Mussel Creek era il moniker di un collettivo di
adolescenti che, nella prima metà degli anni Zero, spe65
highlight
Thus: Owls - Cardiac Malformations (Almost-Musique, Novembre 2010)
Genere: orchestral-pop
Ci sono diversi approcci possibili nei confronti di un lavoro complesso e articolato come Cardiac Malformations, e nessuno che possa spiegarne del tutto lo spirito sfuggente. C’entra forse la natura assai
eterogenea del progetto, figlio del sesto senso appartenente a Erika Alexandersson, cantante e compositrice d’estrazione classica (in saccoccia una nomination per i Grammy
nazionali con Josef Och Erika, attiva con un progetto di elettronica improvvisativa chiamato The Moth e infine da solista come eRika. ....) che
nella natia Svezia ha raccolto folkettari canadesi e jazziste progressive,
membri di Lonely, Dear e accompagnatori dei Koop.
Da queste canzoni, registrate nel 2008 e pubblicate una prima volta lo
scorso anno per un’etichetta indipendente di Goteborg, poteva sortirne
un minestrone buttato lì per stupire chi al sodo non bada, dai sapori tanto mal assortiti quanto buone erano le intenzioni di partenza; a differenza
di tanta “musica totale” contemporanea, nondimeno, in gioco ci sono un talento nitido e una voce conturbante (un po’ Bjork e un po’ Siouxsie, un po’ Kate Bush e un po’ P. J. Harvey; soprattutto se stessa),
una trama sonora sincretica, evocativa e ricca come raramente capita di trovare. Un panorama fosco e
rischiarato solo occasionalmente, nel quale arrangiamenti corposi eppure essenziali valorizzano scrittura e curiosità, la spinta a osare nell’ambito di un cantautorato femminile che è anticonvenzionale ma
trattiene un robusto senso per misura e ordine.
E perciò affascina come un volo libero a testa in giù, sapendo che l’acqua pronta ad accoglierti sarà scura e fredda ma di sottrarti ad essa non vuoi saperne. Questo l’effetto che restituisce il disco nel complesso e, facendo un torto al resto, episodi come l'astratta e tuttavia terrigna Yellow Desert e la trasparente
The Sun Is Burning Our Skin, il jazz favolistico Sometimes e l’inquieto flusso di coscienza di My Thoughts
Ain’t Lovely. Ombre che stregano, da vivere prima che capire. Certi che l’incantesimo rimarrà intatto. (7.6/10)
Giancarlo Turra
cui è stata affidata una Delorean puntata quarant'anni
nel passato. Non ha la minima idea di dove il viaggio lo
condurrà, ma osservarlo è uno spettacolo che vale la
pena di non perdere.
(7.3/10)
Diego Ballani
Public - Oracolo (Fosbury, Novembre 2010)
Genere: rock
Un nervosismo romantico e cupo attraversa tanto rock
indipendente italiano, quella parte almeno che si sbatte strattonata tra la disillusione totale indotta dai fatidici (cazzo di) anni zero e quel po' di vena melodico/
letteraria rimasta in piedi dopo le buriane wave. Il caso
dei Public è da individuarsi in quest'ultima casistica,
il verbo discendente con chiarezza dalle scorribande
poetiche di Paolo Benvegnù con qualche particella
residua Marlene Kuntz ed altre interferenze di varia
natura, dall'alternativo post-contemporaneo Radiohead ad una sanguigna inquietudine cantautorale di
stampo Folkstudio.
Il climax della loro opera seconda L'oracolo si compie
giusto nel cuore del programma, tra la infervorata title
track e la lirica Il lato magico della strada, passando da
quella Massacrarsi fino a perdere i sensi che rimanda a
certi sconcertanti languori Federico Fiumani. Disco
ben suonato e prodotto con l'ingegno del caso da Fabio De Min (Non Voglio Che Clara). L'ennesimo tassello d'un mosaico - il rock in italiano - che prima o poi,
chissà, vedremo nella sua splendida interezza.
(6.9/10)
Stefano Solventi
rimentava forme di psychedelia free form, prendendo
le mosse dall'hard blues lisergico dei Blue Cheer e dal
kraut più cosmico.
Quando i suoi membri decisero di porre fine a
quell'esperienza, per dar vita a nuove formazioni, la
collaborazione fra di loro non venne meno e quello dei
Mink Mussel Creek rimase il nucleo fondante di una
serie di realtà che oggi stanno fungendo da traino per
revival psichedelico in atto nella capitale dell'Australia
Occidentale. Quando la barra del comando è in mano
al perfezionista Kevin Parker, la creatura assume il
nome di Tame Impala, progetto ambizioso e cangiante, che abbiamo imparato ad amare grazie al recente e
spettacolare Innerspeaker. Al basso di quella formazione (ma in passato lo si è visto anche alla chitarra e
all'organo), c'è Nick Albrook. I Pond sono cosa sua, ed
in pratica costituiscono l'alter ego fun & funky degli Impala. Frond è il loro primo lavoro ad essere realizzato in
66
un vero e proprio studio di registrazione ed è una sorta
di grande tributo ai 70s, in tutte le loro caleidoscopiche
fogge.
Si parte con il chiassoso garage glam dell'opener Betty Davis e si finisce per librarsi negli infiniti spazi, sulla
coda strumentale dell'evocativa title track. In mezzo ci
si possono trovare frenetici gospel latini, tirate funkadeliche e stralunate jam che sembrano il frutto di un
amplesso incestuoso fra Kraftwerk e Ash Ra Tempel.
C'è anche il pop naif di Annie Orangetree e l'Elton John
in acido di Sunlight Cardigan: è facile individuarli come
i vertici espressivi dell'album, le frecce in grado di colpire al cuore anche chi maneggia con difficoltà la materia psichedelica.
La forza dell'album, in fondo, sta tutta qui: nella naturalezza innocente con cui Albrook e compagni affastellano idee, senza preoccuparsi di dar loro omogeneità;
con lo stupore primigenio di un bimbo di cinque anni a
Ray Davies - See My Friends (UMTV, Ottobre
2010)
Genere: rock reazionario
Dice il saggio che un bel silenzio non fu mai scritto. E
nemmeno inciso, se è per questo. La frase viene alla
mente all'ascolto di questo nuovo disco di Ray Davies,
l'autore di un pezzo di storia del pop-rock con i suoi
Kinks. Qui è alle prese con quattordici duetti che ripercorrono altrettante tappe della sua sterminata produzione.
Dopo la messa in naftalina del gruppo, Ray Davies aveva atteso tredici anni per pubblicare il suo esordio solista, Other People's Lives, in cui riprendeva l'abitudine
di raccontare storie in musica con la sua ironia british e
il suo talento. Quelle canzoni e quelle contenute nel seguito, Working Man's Café, non aggiungevano nulla al
personaggio, ma sembravano proprio un ritorno all'arte della canzone dopo che negli anni Novanta Davies
aveva sperimentato altre forme di comunicazione.
Come suona See My Friends? Inutile e a tratti imbarazzante. Inutile come tutti gli album di duetti, fatti per il
godimento di chi ci finisce dentro, magari coronando il
sogno di suonare con quello che considerano un maestro, e poco per le orecchie dell'ascoltatore. A tratti imbarazzante, perché gli episodi di Jon Bon Jovi, Ritchie
Sambora (insieme per Celluloid Heroes), i Metallica
(You Really Got Me), Billy Corgan (All Day and All the
Night/Destroyer) e Paloma Faith (Lola Ray) sono indifendibili. Vanno meglio quelli con Bruce Springsteen
(Better Things), Alex Chilton ('till the End of teh Day) e
Francis Black (This Is Where I Belong). Non che si incappi mai in canzoni imbarazzanti, perché la qualità è parte integrante degli originali e gli ospiti sono quasi tutti
di alto livello, ma non se ne sentiva davvero il bisogno.
In questa Waterloo del duetto, spiccano i Mumford
And Sons, che ci mettono il loro tocco folk/country e una coralità efficace (Day/This Time Tomorrow), e
Lucinda Williams, che mette a Long Way From Home
poco del suo, ma almeno ci regala una versione interessante.
(5/10)
Marco Boscolo
Regina Mab - Col sole in fronte
(Manzanilla, Luglio 2010)
Genere: folk
Non sarà la Compagna Teresa del Teatro degli Orrori la
Rita Rosani protagonista di questo disco-concerto dei
Regina Mab, ma può comunque vantare solide radici nell'identico immaginario. Quello della Resistenza
al femminile, sconosciuta ai più ma essenziale esattamente come quella al maschile nel determinare le sorti
di un conflitto come la Seconda Guerra Mondiale tra
1943 e 1945 in Italia. Con da un lato la Repubblica di
Salò sostenuta da fascisti e tedeschi e dall'altro i partigiani - tra cui, appunto, “la Rita” -, nel caso specifico
quelli che militavano nelle brigate attorno a Verona.
Con la scusa dell'inquadramento biografico i Regina
Mab ricostruiscono il tono generale del periodo, grazie a un disco capace di mescolare narrazione, musica,
dettagli storici e parti recitate. Il tutto in dodici capitoli
da far corrispondere ad altrettante parentesi suonate,
queste ultime valorizzate da brani autografi e cover
debitamente ricontestualizzate. A testimonianza, una
Teardrop dei Massive Attack in cui si accosta il beat coronarico del brano originale al momento della morte o
una My Generation degli Who il cui verso "I hope I die
before I get old" risuona macabro tra i partigiani confinati sul monte Comun e pronti ad affrontare le “People
67
try to put us down” in divisa. Metafora dell'attualità e
ricordo affezionato, documento storico indiretto e teatro, buon esercizio di folk e canzone d'autore, Col sole in
fronte ha la rara capacità di emozionare senza suonare
retorico e andando oltre prese di posizione ideologiche fini a sé stesse. Piccola gemma da tenersi ben stretta, in una contemporaneità dal revisionismo facile che
scambia troppo spesso e con scandalosa naturalezza
cause e conseguenze.
(7.1/10)
Fabrizio Zampighi
Rihanna - Loud (Def Jam Recordings,
Novembre 2010)
Genere: blackpop dance
Ostinandoci a parlare di album, il grosso problema della
musica pop è essere nata prima del trentatrè giri, nata
misurandosi con la logica del singolo one shot. "Album
pop" è quindi un concetto che comporta di per sé una
qualche "adulterazione" del prodotto (primi nomi che
vengono in testa, Beatles, Elvis Costello, XTC). Rihanna
fa pop2000, miscela succosa gommosa e lucidissima di
dance, black (r'n'b, hip hop) e pop song appunto, nulla
di strano che vada avanti a forza di singoli dall'impatto
studiatissimo e che condisca poi i dischi di riempitivi. Il
vero problema è quando questo meccanismo si inceppa e anche il singolo proposto come piatto forte è di
fatto un tappabuchi.
E' il caso di Loud, quinto album in cinque anni per la
bella maltrattata bajan e punto più basso della sua discografia. Misuriamo ad ampie spanne: l'ossessiva ficcante Pon De Replay dell'esordio (pollice in su), l'esplosione mondiale al quadrato con Umbrella nel 2007 (al
cuore di quel successo, l'intenso crescendo del chorus)
e adesso una seconda parte di Love The Way You Lie,
con quell'inciso molto Robbie Williams, che in realtà
è la semplice auto-cover a parti invertite del brano di
Eminem contenuto in Recovery.
Loud dice forte e chiaro che Rihanna si è appiattita su
una blackpop-dance midtempo senza incisività, su ballad zuccherose con aperture melodiche tutt'altro che
brutte ma semplicemente spersonalizzate, non sue.
Loud è un disco privo di qualsiasi specimen. E Cheers
campiona I'm With You di Avril Lavigne.
(3/10)
Gabriele Marino
Scorn - Refuse; Start Fires (Ad Noiseam,
Novembre 2010)
Genere: Doom step
A tre anni dal ritorno (Stealth) e otto dalla chiusura del
68
primo periodo (Plan B), Harris si ripresenta sugli scaffali
quasi in sordina puntando più sui tipici scenari scorniani che sull’effetto antemico della prova precedente.
Del resto è innegabile che se Stealth cercava di catturare l’attenzione della comunità dubstep rivendicandone - a diritto - la paternità, il quattordicesimo capitolo della saga si presenta come se ne facesse parte,
aggiungendo giusto un elemento live (un batterista
in carne e ossa, Ian Yan Treacy) in segno di coerenza
e magari equidistanza. Sul guado tra maniera e nuove
maniere acquisite però, salvo una potente Take Someones Eye Out (un perfetto connubio tra industrial e il lato
più combat di Milanese), l’ex Napalm Death commette
l’errore di raffinare troppo il dialogo tra i layer trovando
difficilmente l’ispirazione necessaria.
Boot It, Rained On Her Birthday e una manciata di altri
episodi dai titoli quasi parodistici sono piano sequenza
di gran maniera impossibili da amare e pure quando
Harris punta al mid tempo (Bear Felt Nowt) il confronto con gente come Terror Danjah è impietoso. Certamente consigliato ai neofiti, gli altri guardino a cose
più fresche
(6/10)
Edoardo Bridda
Secret (The) - Solve Et Coagula (Southern
Lord, Novembre 2010)
Genere: grind
Basta lentezze doomy e apocalittiche visioni al ralenti.
La Southern Lord sembra darsi da una bella smossa, e
per farlo va a pescare questi The Secret addirittura in
Italia. Il quartetto di Trieste, come nelle migliori o ormai
quasi dimenticate storie del r’n’r, si fa notare dall’etichetta di Los Angeles spedendo il proprio demo, con
quest’ultima che rimane talmente colpita da metterli
subito in catalogo col terzo album Solve Et Coagula.
Nulla di trascendentale o di inedito, secondo noi: un
corposo grind dal piglio hc alla maniera dei compianti
Nasum virati primi Converge, abbastanza screziato e
vario nelle sonorità più che negli sviluppi e che rallenta sapientemente i tempi in alcuni passaggi. Aiuta in
questo senso anche l’uso di uno strumento apparentemente fuori contesto come l’organo che carica i momenti più doomy (l’iniziale Cross Builder, un macilento
procedere limitrofo al black più astratto e atmosferico,
l’intro di Bell Of Urgency, lo sludge della conclusiva 1968)
di un senso di latente catastrofe. Buon disco di genere
che nulla aggiunge e nulla toglie, ma per immaginario
e credibilità solleticherà gli appassionati.
(6.6/10)
Stefano Pifferi
Selton - Selton (Antistar, Novembre 2010)
Genere: indie-tropical-beat
La fortuna non è un dettaglio da poco e i Selton ne
sono consapevoli. Loro, buskers brasiliani destinati a
qualche parco pubblico in quel di Barcellona e finiti
invece nei ranghi della trasmissione di Fabio Volo Italo-Spagnolo, ovvero l' MTV dei “giri giusti”. Un buon
esordio del 2008 come Banana à Milanesa per cui si
scomodavano Cochi, Renato e Enzo Jannacci e in cui
si rivisitava in un portoghese tropical-garagista l'avanspettacolo meneghino di E' A Vida, Vengo anch'io no tu
no, Eu Vi Um Rei, La Gallina, Canção Inteligente, Silvano.
E poi un secondo, omonimo, disco - il qui presente tra beat nostrano anni Sessanta (Be Water) e Beatles
pre-Revolver (Anima leggera), Os Mutantes (Testa quadrata) e Vampire Weekend (Passero), rock'n'roll anni
Cinquanta (Per favor dica il suo nome) e quella naturalezza spaesata dell'Enzo Jannacci nume tutelare (Nuoto nuoto e niente più).
Gli ospiti questa volta sono Dente, Tommaso Colliva
(già al lavoro con Calibro 35) e Massimo Martellotta:
il primo chiamato a curare l'adattamento in italiano dei
testi, il secondo e il terzo insediatisi nel ruolo di produttori. Segno anche questo di un'attenzione tutta particolare riservata al lavoro di Daniel Plentz, Eduardo
Stein Dechtiar, Ramiro Levy e Ricardo Fischmann,
oltre che involontaria cartina di tornasole di quel fascino vintage tra Vecchio e Nuovo Mondo che il quartetto
riesce a sprigionare a tutte le latitudini.
(7/10)
Fabrizio Zampighi
Shipping News - One Less Heartless To
Fear (Africantape, Ottobre 2010)
Genere: post-rock
Da supergruppo collaterale a unico reduce sopravvissuto dell’epoca d’oro del post-rock. Questo il bizzarro
destino del combo americano (ri)formato per l’occasione da gente del giro June Of ’44 (Jeff Mueller a voce e
chitarra), Rachel’s (Jason Noble, idem), Eleven:Eleven
(Kyle Crabtree dietro le pelli) e For Carnation (la new
entry Todd Cook al basso). One Less Heartless To Fear gran titolo, non c’è che dire - dispone sul piatto 7 originali e due riedizioni di vecchi pezzi (Axons And Dendrites e (Morays Or) Demon entrambe dal precedente
Flies The Fields), alcuni dei quali testati live nelle session
di rodaggio del nuovo album avvenute tra Louisville e
Tokyo.
Lo spirito e l’approccio della formazione non sembrano risentire dello iato quinquennale di forzata inattività (dovuta a weddings, fatherhood, serious illness, city
moves), né della risacca di un suono ormai irrimediabilmente datato. Padroni degli strumenti come dei canoni
di genere, i quattro mostrano freschezza compositiva e
pure capacità di uscire dal seminato, come dimostra The
Delicate, bell’esempio di rifferama shellachiano tirato e
nevrastenico, tutto stomp’n’roll e ossessività noise. Il resto è post-rock chitarristico virato "math": chirurgico e
squadrato, teso e vibrante pure sempre di gran classe.
In grado, cioè, di far dimenticare quanto frattanto passato sotto i ponti e rispedirci dritti verso Louisville.
(6.8/10)
Stefano Pifferi
Silver Rocket - Silver Rocket EP
(Autoprodotto, Novembre 2010)
Genere: wave noise
Ebbene sì, ci sono stati anche degli anni ottanta da cui
uscivi vivo, bene o male. Soprattutto se avevi quel certo
retroterra, un vaccino - chessò - Velvet Underground,
uno scossone Iggy Pop, la benedetta terapia new
wave, quel tanto bastante almeno per farti annusare
situazioni a lunga gittata. In primis la congettura noise
dei Sonic Youth, che i ferraresi Silver Rocket omaggiano battezzandosi come una traccia dell'imprescindibile
Daydream Nation. Qui sta il bello, o il trucco se preferite, che rende intrigante il loro omonimo ep d'esordio:
interpretare una fierezza - stavo per scrivere una nobiltà - alternativa, seguendo una sceneggiatura costruita
su un'erudizione che non sa per nulla di artificioso.
Un misto di impudenza e naturalezza li rende testimoni di un fare rock incandescente e appassionato, visionario e sanguigno (vedi la cavalcata Dream Syndicate
di Walked Away), e pazienza se intorno il mondo si balocca di patinature a perdere. Alla fine - per assurdo, ma
non troppo - il caracollare Pavement di A Prerogative
finisce per sembrare una preveggenza lo-fi, chiudendo
un bel cortocircuito con le premesse seventies di cui
sopra. A proposito di premesse, quelle per una band
interessante ci sono tutte.
(7.3/10)
Stefano Solventi
Sintomi di Gioia - L'animale EP
(Autoprodotto, Novembre 2010)
Genere: pop rock
A due anni dall'album di debutto Segnalibro, tornano
i Sintomi di Gioia, band alessandrina attiva da un decennio. Ci offrono un curioso segnale di vita con questo
L'animale EP, quattro tracce che alla title track - ballatina arty e minimale dall'incedere sghembo e stranamente evocativo - affianca ben tre cover. In ordine di
69
apparizione, una Arrivederci addio appena più rugginosa rispetto al verbo Perturbazione (ospite ai cori Tommaso Cerasuolo), la suadente e obliqua Era inverno dal
catalogo Le Orme (con Tony Pagliuca all'hammond) e
una Spazi Autogestiti che stempera in fiabesco il tosto
crossover Ritmo Tribale.
Piace questo contagio di elementi pop-rock, prog e
cantautorato, questo intrecciarsi di aciderie vintage, la
disinvoltura delle timbriche (archi ed elettricità, mellotron e sintetizzatori...) ed i preziozismi d'arrangiamento
senza ostentazione. Produce Fabio Magistrali, di per sé
una garanzia.
(6.8/10)
Stefano Solventi
Sore Eros - Know Touching (Agitated,
Novembre 2010)
Genere: lo-fi psych-pop
Band palindrome che si aprono al mondo. Partito
come progetto in solo di Robert Robinson (chitarra,
voce) e ora stabilizzatosi come quintetto con l’amico
e sodale Adam Langellotti (basso e tastiere) a far da
perno (completano Jeff Morkeski alla chitarra, Matt Jugenheimer alla batteria e Matt Brown al synth), Sore
Eros sforna quello che è a tutti gli effetti il disco più
intelligibile e compiuto. Fatta eccezione per l’omonimo di qualche anno fa - un cd-r casalingo di bozzetti
in lo-fi - e qualche singolo sparso in giro, era stato Second Chants ad attirare le attenzioni della label di culto
SHDWPLY e della critica online con un bel concentrato
di nighttime-bedroom-epic-dream-pop-chants. Roba
molto in linea col sostrato psych-pop di molti campioncini dell’underground con Woods su tutti, oltre a Atlas
Sound e Kurt Vile, a fornire ottimi punti di riferimento
e coordinate spicciole.
Ora Know Touching torna sul luogo del delitto con
maggiore consapevolezza nello screziare la psichedelia più soffusa e pop-oriented dei Sessanta (i soliti,
immancabili Velvet ma presi spesso in modalità semipastorale) in un guazzabuglio di dolcezza, innocenza
e melodie sognanti. Sarà per la frequentazione del
giro Ariel Pink - il nostro è stato membro dell’Haunted Graffiti per qualche tempo, oltre che “turnista” con
Panda Bear, Kurt Vile e Gary War - ma quel procedere
incerto e claudicante, malinconico e sconclusionato ci
fa apprezzare 12 gioiellini in bilico tra folk trasognato
e lo-fi da cameretta.
(6.8/10)
Stefano Pifferi
70
Teebs - Ardour (Brainfeeder, Ottobre
2010)
Genere: lounge/amazonwonky
Incredibile, ma questo giovanissimo (23 anni) pupillo
di Dublab prima e di Brainfeeder adesso suona esattamente come suonerebbe l'addizione Flying Lotus
+ Four Tet. Il wonky organico del primo con tutte le
sue suggestioni sensoriali (e Mtendere Mandowa aka
Teebs è pittore) fuso con le candide rarefazioni posthouse e minimal del secondo.
Ritmi spastici ma nessun blues e anzi atmosfere solari e
sognanti, suoni limpidi come porcellana, come rugiada
che rifrange la luce del primo mattino. Come un altro
esordiente coi fiocchi, dotato cioè di skills e tocco, chiamato Jules Chaz, il ragazzo fa ancora sentire troppo i
propri riferimenti, ma allo stesso tempo propone già
una cifra stilistica personale: scampanellii e cascatine
di arpeggi di piano/percussioncine intonate. Teebs devia solo in due casi da questa sua lounge/wonky amazzonica (lui newyorkese con le radici tra Malawi e Isole
Barbados), nelle sterzata J Dilla-hip hop di Why Like
This? e nel midtempo '90 di Autumn Antique.
L'impasto in generale e alcuni pezzi in particolare sono
ottimi, altri un po' troppo simili tra loro o troppo allienati su un mood "sottofondo (sofisticato)". Ma ascoltarlo è un piacere.
(7/10)
highlight
Warpaint - The Fool (Rough Trade, Novembre 2010)
Genere: ethereal dark-pop
Se un disco d’esordio - eccezion fatta per l’ep Exquisite Corpse, datato 2008 - porta il marchio Rough Trade, le origini californiane molto probabilmente sono solo una fortuita casualità. Regola non scritta cui
non sfugge questo quartetto all-female formato dalle apolidi chitarriste/cantanti Emily Kokal e Theresa
Wayman, dalla bassista Jenny Lee Lindberg e dalla batterista Stella Mozgawa. Gente non di primo pelo,
che si muove nel giro giusto della tentacolare LA (John Frusciante produceva l’ep d’esordio, l’attuale
chitarrista dei RHCP Josh Klinghoffer è stato il loro primo chitarrista e alcune di loro flirtano col cinema
mainstream) e con l’età ideale per rifarsi all’epoca d’oro della wave senza timore reverenziale o puzza di
artefatto opportunismo giovanile.
Trame post-punk tanto lievi quanto intricate, atmosfere dreaming ed ipnotiche spesso in bassa battuta, psichedelia soffusa e dal taglio evocativo,
vocalità umorale e stranita/straniante, The Fool è un concentrato bomba
di sonorità soffuse e fosche, romanticamente darkish, quasi che le quattro
volessero offrire il lato oscuro e notturno del california dreamin’. Ricordano
in questo approccio trans-oceanico la parabola dei God Machine, nati a
San Diego ma con cuore e testa nella Albione più oscura e deviante. Cure
imaginary, Siouxsie adolescente, il catalogo 4AD meno banale e più datato, le heavenly voices, un po’ di Cocteau Twins, un po’ di This Mortal Coil, ma a tornare in mente è
anche quella psichedelia candida e gloomy dei (fu) Young People e certe post-riot grrrls dedicatesi al
cantautorato di classe (da PJ Harvey a Cat Power) ma col piglio delle Raincoats.
Musica umorale, autunnale ed eterea, melanconica e sognante, che se ne fotte di marchi e mode, segue
il suo istinto e sorprende. Se ancora non si fosse capito.
(7.3/10)
Stefano Pifferi
Gabriele Marino
Tre Allegri Ragazzi Morti - Primitivi del
dub (La Tempesta Dischi, Dicembre 2010)
Genere: Dub
Ovvia conclusione di un percorso di avvicinamento dei
Tre allegri ragazzi morti ai ritmi in levare di stampo
giamaicano, Primitivi del dub altro non è se non una
collezione di remix - ovviamente in chiave dub - dell'ultimo disco della formazione di Pordenone Primitivi del
futuro. A dar nuova forma a materiale naturalmente
predisposto alle contaminazioni viene chiamata la
Alambic Conspiracy, collettivo vicino a quel Paolo
Baldini (B.R. Stylers, Africa Unite, Dub Sync) già produttore del disco originale.
Un gruppo di artisti - tra cui Rankin' Alpha e Mama
Marjas - che oltre a rimanere piuttosto fedele alle “rootz” del genere - Lee Perry in testa - ribadisce ulteriormente gli obiettivi che lo stesso Primitivi del futuro
si era prefissato, ovvero recuperare stili ritmici tipici di
altre culture (Giamaica e Africa su tutte). Il risultato non
dispiace affatto, nonostante la parte testuale sia stata
ampiamente sacrificata - come da copione “dub” - per
dare il giusto spazio alla musica. Segno della bontà di
una svolta - o magari di un'esplorazione temporanea tutt'altro che improvvisata e dalle basi solide.
(6.9/10)
Fabrizio Zampighi
Twin Shadow - Forget (4AD, Ottobre 2010)
Genere: synth pop
Il problema con certi dischi è capire quanto arrosto ci
sia dietro al fumo che li avvolge. Tanto più se il fumo
è quello colorato degli anni Ottanta, ovvero quel genere di produzione, quei suoni di batteria, la presenza
costante dei synth: tutte cose che in tanti lavori usciti
negli ultimi anni hanno rappresentato niente più di una
patina per nascondere una cronica assenza di idee e di
profondità.
George Lewis Jr., alias Twin Shadow, si dissocia da questi meccanismi. Lui è davvero innamorato di quell'epoca: di quel sound, certo, ma anche di quelle atmosfere.
Così il suo Forget riporta in auge queste ultime, e nella
fattispecie una melanconia che è diretta erede dei più
grandi nomi di quel periodo: su tutti gli Smiths, presenti un po' ovunque ma omaggiati palesemente in I Can't
Wait la cui chitarra deve tutto a Johnny Marr mentre
il finale tende verso l'epica delle varie There Is A Light
That Never Goes Out. A voler cercare bene si rintracciano
anche Cure (Tyrant Destroyed), Depeche Mode (Tether
Beat), U2 (Slow), ma è un gioco di rimandi perennemente avvolto nel fumo di trent'anni fa.
Non si tratta di mere ricalcature, anzi musicalmente si
cerca di destrutturare ciò che è già noto per poi rimodellarlo su basi moderne; così che, nel prendere lezione
dai grandi del passato, si finisce per impartirne, seppur
involontariamente, anche a tanti big di oggi. Nella seconda metà del disco infatti i ritmi aumentano e, se il
paragone con Chris Martin è evidentemente facilitato
da certe inflessioni della voce e dall'insistenza nel rimarcare alcune consonanti, una doppietta come At My
Heels e Yellow Balloon insegna di fatto agli ultimi Coldplay come si possa essere magniloquenti senza perdere un briciolo di creatività, laddove il singolo Castles
In The Snow e l'adrenalinica For Now lanciano occhiate
di sfida agli Hot Chip.
In tutto questo l'unico neo riscontrabile è il peso effettivo dei singoli brani: Forget è un disco che necessita di
71
ascolti ripetuti per mostrare il suo buon potenziale e
tutta la sua gradevolezza, ma anche in ultima analisi
mancano quei guizzi necessari quando si tirano in ballo punti di riferimento così importanti. Non che l'arrosto non ci sia, anzi. Semplicemente, è meno di quanto
potrebbero raccontarvi
(7/10)
Simone Madrau
Two People In A Room - Wrapped in Plastic
(A Crash at Every Speed, Novembre 2010)
Genere: ambient, shoegaze
Per rendere più reale l'atmosfera malinconica e sognante del disco svelo l'identità delle due persone nella stanza: Renè Margraff, alias Pillowdiver, che ci aveva deliziato lo scorso anno con Sleeping Pills, uscito
per 12K. In compagnia di Michelle, cambia il nome ma
non la sostanza, Wrapped in Plastic è un altro ottimo
lavoro, purtroppo disponibile nel solo formato tape,
così di moda e così poco adatto al flusso di chitarre lente e dolci del duo; a quelle melodie quasi fossero archi,
alle loro sinfonie urbane dalle tinte shoegaze in versione mitteleuropee, dove in lontananza si scorgono gli
echi degli Stars of the Lid di Music for Nitrous Oxi-
de. L'autunno berlinese ispira gli artisti tedeschi, che
ne ridisegnano l'atmosfera trasformando la foschia del
mattino in delicate pennellate di suoni riverberati. Le
foglie che cadono dagli alberi avvolte in fragili veli di
plastica, delays e distorsioni.
A inizio anno è prevista l'uscita di un nuovo lavoro su
Home Normal; per il momento godiamoci questo piccolo gioiello.
(7.2/10)
Gemma Ghelardi
Tyvek - Nothing Fits (In The Red Records,
Ottobre 2010)
Genere: Garage-punk
Ormai sfumato il polverone shit-gaze che aveva riempito le pagine dei media musicali solo due stagioni fa, arrivano al secondo full-length i Tyvek, questa volta per
la storica In The Red di Larry Hardy. Nel farlo i ragazzi
di Detroit abbandonano quasi totalmente la paranoia
demenziale che caratterizzava i primi singoli e l’omonimo album di debutto su Siltbreeze; calcano invece il
piede sull’acceleratore, sparando riff garage a velocità
al limite dell’hardcore, risultando in prima battuta quasi irriconoscibili.
Una folta schiera di pezzi si susseguono alla velocità
della luce lasciandoci un po’ interdetti e straniti, prima che lo stomp ossessivo di Outer Limits e le melodie
trascinanti di This One - That One facciano capolino, riportandoci indietro di un paio di anni, quando i Tyvek
rilasciavano schegge impazzite di garage-post-punk
imbevuto di malessere suburbano come May Ellen
Claims e Air Conditioner. A Nothing Fits la carica non
manca di certo, ma sembra girare un po’ a vuoto, sfogata in maniera poco mirata e, si sa, trovarsi rimpiangere i primi singoli dopo solo due album è qualcosa che
nessuno si augurerebbe.
(6.6/10)
Andrea Napoli
Unsense (The) - Il Pifferaio di Pandora
(Autoprodotto, Novembre 2010)
Genere: rock
La tipicità del suono wave è che può fare da tappeto
agli innesti successivi e da sostrato a un fare più generalmente rock. Riassumiamo così la strategia sposata
da The Unsense, combo attivo in Nord-Italia e Svizzera
dal 2004. Da lì (Contact Me, la title-track) viene la chimica basso-chitarra di Il Pifferaio di Pandora, nuovo album della band formata da Samuele Zarantonello, Alan
Stanzione, Paolo Pusterla, Matteo Berganton e Davide
Bressan, come punto di partenza per divagazioni che
guardano alla psichedelia più mainstream.
L’occhio lungo che maggiormente si nota guarda a
Oriente, secondo un paio di occhiali di marca CSI, specie nelle linee vocali di Zarantonello (Ritornerò E Brucerò). In generale, funziona meglio la lingua nostrana su
quella anglosassone, un po’ innaturale nei tessuti - pur
efficaci - di The Bitch Song Por Dios, non troppo lontani
dal procedere alla Cul De Sac, sia nel taglio psych (Crisalide), sia nella progressione del brano.
Un’indecisione che si riflette anche nel fuoco dei brani, che spaziano - senza a volte mantenere una rotta
- fino a toccare il blues più classico e meno ragionato
(LA Blues) e quindi toni da pub-rock all’italiana. Al netto
dell’intero album, il pericolo è comunque sventato, e,
fortunatamente, non è questa l’espressione più adatta
a Il Pifferaio di Pandora: ne denota forse la provenienza.
(6/10)
Gaspare Caliri
Young Gods - Everybody Knows (Two
Gentlemen, Novembre 2010)
Genere: techno-rock
Dopo un periodo di appannamento, sembra tornato a
72
pieno regime il progetto svizzero. Super Ready / Fragmenté di un paio di anni fa rimetteva in moto il trio
formato da Al Comet, Franz Treichler e Bernard Trontin
e ora Everybody Knows ne ribadisce forza e freschezza
riaccendendo il motore techno-rock di matrice cyberindustrial che tanti cuori catturò nei primi 90s.
Lontani dalle prove di gran classe dei primi passi - gli
inarrivabili Young Gods e L’Eau Rouge e il tributo weilliano Play Kurt Weill - i tre stabiliscono un ponte con l’onda
lunga del loro successo commercialmente più noto, TV
Sky: ritroviamo infatti il consueto mix di grunge futuribile e sintetico su matrici seventies rock (i Doors di Jim
Morrison venivano spesso tirati in ballo all’epoca come
punto di riferimento ideale) o più mediate (pensate ad
un pathos alla Eddie Vedder calato nei gelidi panorami
Ballardiani).
Avanguardistico e vintage, futuribile e classico, Everybody Knows vive di quelle stesse dinamiche muovendosi con classe tra una forma di cantautorato intimo
e alieno (Two To Tango), pop-songs da bassa battuta
(Blooming), minimal-ambient limitrofa al glitch (Miles
Away) e techno-rock music per i pronipoti della Matrix
generation (No Man's Land, Tenter Le Grillage). I tre sonic
architects, alchemists and diamond-cutters, come li definisce la press, sembrano essere tornati indietro di venti
anni sulla tabella di marcia.
(6.8/10)
Stefano Pifferi
Zack Hill - Face Tat (Sargent House,
Novembre 2010)
Genere: post-math
Il roboante circo zappiano di Zach Hill non poteva che
riprodursi in tutta la sua dirompente complessità, come
coacervo di voci che si accalcano in un brano come su
una carrozza di alcolizzati che vanno al lazzaretto. Zach
Hill, fin dagli Hella, ha lavorato su quella linea d’eccesso
che si sostiene da sé, per così dire, che investe l’ascoltatore e lo malmena su un ring, di fatto ipnotizzandolo
con effetti speciali.
Face Tat volge tutto questo all’entusiasmo, condizione
necessaria ma non sempre sufficiente. Si parte con la
travolgente carica circense - per l’appunto - di Memo
To The Man, e si continua cercando di mantenere alta
l’adrenalina, la carica, la disponibilità d’animo di chi
ascolta, cosa davvero difficile, con la qualità e quantità
di stratificazioni dimostrate. Si ha proprio l’impressione
che Zach componga alla batteria, e che l’imprendibile
poligonalità delle sue canzoni dipenda da questo. Gli
ospiti - provenienti da giri No Age, Devendra, come
dalle mille collaborazioni che Zach nel tempo ha colle73
zionato (i già citati Hella e i Prefuse 73) non mitigano
ma aggiungono, perché Face Tat, come Astrological
Straits e forse anche più, non lavora di cesello ma di
cazzuola, non toglie ma somma. Sebbene i brani abbiano concept chiari (Jackers, la finale Second Life,
l’interpretazione del tribalismo Mahjongg-iano in ExRavers) e durate tutto sommato brevi, non si crede
mai davvero che possano finire o chiudere il progresso
all’infinito.
Un fatto poi è molto evidente. Due anni fa, quando
l’album d’esordio di Hill solista faceva la sua comparsa,
il “genere” di riferimento aveva casi illustri che si erano prodigati ad aprire la pista. Oggi, i Battles non si
sono più fatti vedere, altri hanno cambiato strategia,
ma Zach continua nella missione di dare euforia alla
complessità post-math. È rimasto solo, il Nostro, e forse
per questo ha bisogno di farsi compagnia con la moltitudine sfacciata della musica. Nell’anno 2010 rimane
insomma l’evidenza di come valga la personalità del
personaggio, che non seguiva le mode, che ci è e non
ci fa, e ha un sacco di talento.
(7.3/10)
Gaspare Caliri
Zeitkratzer - Whitehouse Electronics
(Zeitkratzer Records, Novembre 2010)
Genere: avant-noise
Whitehouse Electronics è l’ennesima, extra-ordinaria
stramberia messa in atto dal collettivo berlinese negli
ultimi anni, a seguire le rielaborazioni/collaborazioni/
ripensamenti di e con Merzbow, Keiji Haino, il Metal
Machine Music di Lou Reed, John Cage e Zbigniew Karkowski.
Stavolta a finire sotto la lente deformante è quanto di
più distante dall’ensemble tedesco fondato e diretto da
Reinhold Friedl: mr. William Bennett, da tempo immemore noto per le efferatezze sonore col nome di Whitehouse. Primigenio eroe della sottocultura industrialnoise più harsh e no-compromises, Bennett - che qui
missa il tutto e benedice dall’alto - vede alcuni dei suoi
passaggi più recenti sottoposti ad un trattamento “in
acustico” che ne esalta screziature e dinamiche interne,
senza sminuirne la disturbante spregiudicatezza.
74
Gelide lande di ambient sconnessa (The Avalanche),
ammassi stratificati di noise libero (Muntisi Munkondi)
e avant-jazz deforme (Bia Mintatu) si alternano nelle
6 composizioni rielaborate che, si noti bene, seppur
senza l’ausilio di elettroniche varie hanno il pregio di risultare stranianti come e più degli originali. Merito del
lavoro “ideologico”, oltre che musicale, svolto da Friedl e dai suoi sodali, ormai una garanzia nel panorama
avanguardistico mondiale.
(7.2/10)
.com
Stefano Pifferi
Zeus - Say Us (Arts & Crafts, Marzo 2010)
Genere: indie-blues
Chissà cosa sciolgono nel caffelatte, gli Zeus, progetto
assurto a vita autonoma dopo essere servito a gruppo di supporto per il connazionale Jason Collett e
qui esordiente sulla lunga distanza. Dici Canada e, annotando l’etichetta, pensi ai Broken Social Scene, a un
pop corale e stratificato, sincretico e citazionista: sì e
no, poiché il quartetto - Mike O'Brien, Carlin Nicolson,
Neil Quin e Rob Drake: i primi tre autori, cantanti e polistrumentisti; Rob si accontenta della batteria - guarda
al lustro ’67-’72 e preferisce gli oppiacei naturali alla
caffeina.
Fattori che giustificano l’atmosfera di stordimento
agreste (simile agli Small Faces di Ogden’s Nut Gone
Flake o a certo Paul McCartney solista) e il gusto di caramello, la rilevanza delle tastiere e le trame “roots” da
Wilco sbilenchi e meno robusti. Insieme che funziona,
siccome latitano coloranti fuorilegge e la penna è di
brillantezza sopra la media, capace ad esempio di far
convivere ricordi Kinks e una E.L.O. ai minimi termini (How Does It Feel?, At The Risk Of Repeating) con dei
Quasi senza low-fi (You Gotta Tell ‘er), la The Sound Of
You da Zombies girati country con una ribalda Marching Through Your Head che beffa gli Of Montreal. A
dispetto della ridda di nomi, per qualcuno potrebbe rivelarsi la sorpresa pop dell’anno. Il 2010, tanto quanto
il ‘68 o il ‘72. (7/10)
Giancarlo Turra
75
Gimme Some
Inches #11
Nuovi vinili lunghi e corti in questo freddo mese invernale. A tenervi caldi a rpm di giradischi, Oneida e His Electro Blue Voice, //
Tense// e Wild Nothing, Io Monade Stanca e molti altri.
Le label italiane da un paio di lustri
a questa parte non temono rivali. Quelle che si son specializzate
in vinili, tanto meno. Ne è prova
tangibile la Xhol Recordings che
dopo aver dato alle stampe un 12”
della temibile Squadra Omega fa il
colpaccio infilando il nome degli
Oneida nel proprio catalogo. Sempre un 12” single-sided, serigrafato
col tema della copertina, per due
pezzi in formazione ormai stabilizzata a quintetto. Equinox offre il
consueto concentrato di psychedelia in salsa krauta preso di netto dal
minimalismo e ridotto ad un cencio maleodorante di paranoia urbana, mentre Last Hit risponde con
un prisma di suoni rumorosi nella
miglior tradizione sperimentale dei
newyorchesi. Se c’è un gruppo che
dimostra ad ogni uscita, minore o
maggiore che sia, di essere veramente composto da fuoriclasse,
quello sono gli Oneida.
Sempre rimanendo in ambito di
76
label italiche, uno dei due nomi
che firmano questa rubrica non si
diletta soltanto a pubblicare vinili
con la sua piccola ma apprezzata
label home-based Avant!, ma forma anche parte integrante di uno
dei progetti italiani più chiacchierati del momento. His Electro Blue
Voice, già premiati dallo sguardo
di SA in tempi non sospetti, pubblicano in contemporanea un 12” per
la nostrana Holidays e un 7” per Bat
Shit, mentre resta in rampa di lancio da troppo tempo un altro vinile lungo per Temporary Residence
e la partecipazione alla upcoming
compila manifesto web-only A
Guide to Grave Wave. Per ora accontentiamoci dei due pezzi del
7” – più post-punk oriented, urlati,
riverberati in modalità cavernosa
e dal mood vagamente gotico con
tanto flauto pan-horrorifico in coda
– e dei due che occupano il vinile
su Holidays. Un maxi-singolo, si sarebbe detto un tempo: Wolf sul lato
A si apre come fosse un pezzo punk
ossessivo a cassa dritta per evolversi verso una odissea reiterata come
degli Oneida weird (il flauto ipnotico), spacey (la catarsi da wall of
sound) e infine abbandonati a se
stessi (la coda da raffreddamento post-atomico. Sul lato opposto
Worm sembra invece la versione
droning di Wolf: flutto montante di
drones circolari e mantrici con una
chiosa affidata ad un organo malato. Possibili nuovi mondi? Staremo
a vedere.
Un’altra band italiana (e di conseguenza, un’altra label nostrana)
che si fa apprezzare all’estero, nello specifico oltralpe, è Io Monade
Stanca. Nel condividere un 12” in
vinile verde su AfricanTape col duo
francese Calva, i quattro del Canalese danno il loro meglio: Eravamo
Partiti Coi Piedi Per Terra è una lunga
suite da 20 minuti suddivisa in 3 sezioni e una miriade di sottosezioni
che ne esalta la patafisica follia strumentale, sempre sospesa tra postismi lousvilliani, elaborazioni math
e prog, aggressività noisy e sfattissimo cantautorato indie. Sul lato A i
due francesi offrono una muscolare
prova di noise elaborato, fratturato
e ossessivamente reiterato, sull’onda di Hella et similia e con un certo
fascino per svisate electro-synth
alla primi Six Finger Satellite. Senza però poter competere col nostro
quartetto in quanto a pazzia.
Spostandoci overseas, l’inarrestabile catalogo Captured Tracks ci regala (si fa per dire) l’ennesima uscita a base di dream pop, shoegaze
morigerato e ammiccanti melodie
C86. Parliamo di Golden Haze, il
nuovo Ep su 12 pollici degli ormai
noti Wild Nothing, la band di Jack
Tatum da pochissimo passata in
tour sul suolo italico. Trascinato da
una title-track che più catchy non
si può, il mini in questione presenta
sei nuovi brani che non si discostano affatto dal precedente full-length Gemini. Quindi ancora armonie
sfuocate e trasognate, voci lontane
e arpeggi di scuola dichiaratamente Johnny Marr. Spostandoci nel
sud degli States ci imbattiamo nel
nuovo singolo dei //Tense//, duo di
Houston più o meno arbitrariamente incorporato nella nuova moda
witch. Due pezzi di quell’industrial
dance/EBM tanto cara a label come
la Wax Trax!, con la title-track e l'altrettanto emblematica The Chain
per otto minuti di elettronica
smaccatamente anni ’80-’90, dove
pensanti beat meccanici reggono
innesti vocali cibernetici. L'edizione
digitale comprende ben cinque remix ad opera di Mater Suspiria Vision, Valis, Party Trash, White Car e
gli stessi //Tense//. Dieci e lode per
la copertina che omaggia/deturpa
i Village People!. Dalle freddi lande
canadesi arrivano invece i novelli
Contrepoison, e si sente. Il nuovo progetto solista di Pierre-Marc
Tremblay (già militante in altre tenebrose band locali) imbastisce
quattro esempi di una dark-wave
minimale e sofferta, scossa da un
canto angoscioso e addolcita da
synth mesti ma irresistibilmente
melodici. Cassetta autoprodotta
rilasciata in sole cento copie già
andate a ruba tra i freaks dei suoni
più neri di sempre. Cercatelo in rete
perché ne vale la pena. Chiudiamo
tornando in patria con l’uscita dello split tra due nomi caldi del post-
punk rock nostrano. Parliamo del 7
pollici condiviso tra i milanesi Cusack e i bolognesi Laser Geyser,
entrambi già con un precedente
singolo all’attivo. Due pezzi a testa
che citano tanto Hot Snakes e Drive
Like Jehu quanto Wipers e Husker
Du in una confezione di lusso con
copertina serigrafata, limitata a trecento esemplari. Meglio muoversi.
Stefano Pifferi, Andrea Napoli
77
Re-Boot
#10
Un mese di ascolti
emergenti italiani
Il segnale è chiaro: malgrado tutto, il sottosuolo ribolle di musica.
Voi non vi arrendete. Neanche noi.
Un po' di novità dalla Capitale, diversissime per stile e condizione: i
Piano For Airport sono un quartetto attivo dal 2007, dicono la loro
sul versante di un ex-post-rock che
ha reimparato la voglia, il gusto,
l'attitudine della tensione melodica. Another Sunday On Saturn
(Autoproduzione, 6.8/10) è il loro
primo full lenght, un dieci tracce
che alterna allarmato nervosismo
(Monkey Theorem, Tired Eyes) e palpitazioni atmosferiche (Just Done,
Ghost And Pillows), coprendo un
arco emotivo che prevede astrazioni elettro-pop e più o meno oblique inquietudini wave. Tra Death
Cub For Cutie, Notwist e Giardini
di Mirò, seguono un solco intrigante che - al netto di una pronuncia
che deve farsi più naturale - studia
per diventare significativo.
L'altro romano è Fabio Masciullo,
che nell'esistenza "normale" si prodiga come psicologo, mentre nella
veste dell'alter ego Gran Fondo ha
composto negli anni - così sostiene - circa mille (1112, per la preci78
sione) canzoni stipate nel famoso
cassetto della famosa cameretta.
Canzoni che ovviamente premono
per uscire. Sette di esse compongono questo Lettera, congiunzione, copula (Autoproduzione,
7.2/10), demo che dimostra versatilità febbrile e una capacità sintesi
che lo porta a mettere in cortocircuito Eels e CCCP (E ci rivedremo),
Wire e Faust'O (Effetto serra), Brian
Eno, Patrick Wolf e Notwist (la
splendida Elicottero), insomma lo
spettacolo d'arte varia d'un wave
rock tra l'isterico, l'atmosferico ed
il progressivo. Tu chiamala, se vuoi,
retroavanguardia
introspettiva
(qualunque cosa significhi). In ogni
caso, molto molto interessante.
Anche i Telepathics hanno Roma
nel dna, ma la situazione è ibrida
visto che il duo è composto dal
musicista e compositore capitolino
Cristiano Carosi (già nei Sea Dweller) e dall'illustratrice italo/svedese
Isabella Cotellessa. Hanno appena
sfornato un ep, Jungle Reaction
(Upside Down Recordings, 7.2/10),
nel quale danno vita ad un ultrapop
allucinato e radiante, mutazioni
kraut, wave e ambient, gli Human
League ipnotizzati da Terry Riley,
i Kraftwerk nella sala giochi New
Order tra nebbioline My Bloody
Valentine. Deliziosamente out of
time come una lampada di quarzo:
aspettiamoli sulla lunga distanza.
Ci piovono addosso da Caserta
invece The Secretaries, duo femminile dal fascinoso piglio indie
saturo di ombre e inquietudini PJ
Harvey. Esordiscono con l'ep Before The A (Autoproduzione, 6.8/10),
cinque tracce di tremori che si dipanano atmosferici per l'incrociarsi suggestivo di chitarra, tastiera e
voce. L'assenza di sezione ritmica
- tranne che nella languida Lost crea un bel senso di gravità zero,
su cui galleggiano i rigurgiti new
wave e le caligini quasi shoegaze.
La proposta, va da sé, non brilla per
originalità, ma le idee sono chiare,
il mood non cede di una virgola, il
suono - grazie anche all'aiuto del
compaesano DOPA - solletica deliziosamente i padiglioni.
Mark Lanegan, Woven Hand, ma
anche i nostri Donsettimo e Ce-
sare Basile. Fondamentalmente
blues, di quello oscuro, scheletrico,
acido, vergato da chitarra elettrica,
contrabbasso, batteria, lap steel,
banjo. Salvo Ruolo con il suo Vivere ci stanca (Autoproduzione,
6.5/10) riesce a costruire un disco
fascinoso e crepuscolare, slegato
dalle strutture rigide e teso verso
un indefinito stoned, lento e volutamente sfilacciato. Testi che optano per una resa incondizionata
alla musica, un cantato svogliato à
la Dulcamara e l'impressione che
il musicista sappia il fatto suo. Tra i
crediti del disco, anche lo snowdoniano Franco Beat.
Quel che più ci attrae dei brindisini
Lenula è invece la commistione di
generi alla base del loro omonimo
EP di esordio (Pelagonia, 6.2/10).
Una sorta di progressive totale che
riesce ad unire cantautorato stile
Tom Waits (Modellando la notte),
certa jazz-fusion di canterbouriana
memoria (All'interno) e una psichedelia spacey morbida e articolata
(Fondo). Il meglio lo si ascolta quando le trame si fanno più allentante
e coraggiose, mentre suonano fin
troppo disciplinati e ripetitivi i tem-
pi dispari e le parti strumentali più
debitrici verso la tradizione progressiva. Un buon punto di partenza, comunque.
The Sweating Room (autoprodotto, 6.8/10) è l’EP d’esordio dell’omonimo quartetto toscano , attivo da
un paio d’anni e ora arrivato alla
produzione di un disco. Indie rock e
powerpop con spiccata vena melodica ne rappresentano le principali
coordinate, con una interessante
voce femminile, quella di Giulia Salvi, a punteggiare e tenere insieme il
tutto. Otto brani cantati in inglese,
una discreta tenuta d’insieme e un
senso della melodia che ne rappresenta la principale risorsa sono tutti elementi che fanno ben sperare
per il loro proseguimento. Da tenere d’occhio.
Torniamo infine nella capitale,
dove sono attivi da tempo gli Junkie Storm, che si ripresentano con
un nuovo EP, No Headed Boy (autoprodotto, 6.8/10) che consiste
di due inediti (il pezzo omonimo
e Frontiers) e due brani dal precedente EP qui rivisitati. Alt rock tra
America e Inghilterra con durezze
e melodie, pezzi in inglese qua e là
sporcati da synth, tra Franz Ferdinand e tanto del cosiddetto “emulrock” che è stato. Il gruppo qui alla
sua terza autoproduzione ha ormai
una personalità ben definita frutto
del lavoro svolto sin qui.
Fabrizio Zampighi
Teresa Greco
Stefano Solventi
79
China underground#2
Jia Zhangke, vincitore del Leone d'oro nel 2006 con Still Life, torna in Italia per presentare il suo ultimo lavoro I Wish I knew presso il festival di cinema asiatico "AsiaticaFilmMediale"
Shanghai somiglia a un insieme di
immaginari sovrapposti, uno dei
volti più rappresentativi del Novecento cinese. Ha fatto da sfondo
a moltissime vicende, individuali
e collettive. I wish I knew è la storia di una città attraverso delle vite
raccontate, una fotocamera fissa sul
suo passato remoto e recente.
Una storia che ha senso raccontare oggi, come afferma il regista Jia
Zhangke, nell’anno 2010, lo stesso
in cui la città di Shanghai ha celebrato il futuro della Cina ospitando
la monumentale World Expo. Per ricordare che senza passato non può
esistere alcun futuro. Non è un’associazione scontata in un paese come
la Cina di oggi, dove la storia ha solo
una versione senza interpretazioni
alternative. Dove la memoria del dolore umano viene cancellata per un
interesse di partito o nel nome dello
sviluppo economico. Per questo è
importante rievocare storie sommerse, le fughe a Taiwan o a Hong
80
Kong della Cina “capitalista” all’indomani del 1949; o le repressioni durante la Rivoluzione culturale. Storie
di rivoluzione, scritte da chi è stato
sconfitto e da chi ne è figlio.
Jia Zhangke ha deciso di ascoltare diciotto testimonianze viventi,
ricordi e memorie che attraverso il
proprio vissuto individuale illuminano la storia di Shanghai dal 1933
ad oggi. Figli di generali nazionalisti e rivoluzionari comunisti, attrici e registi, fino a Han Han, classe
’82, scrittore e blogger più letto al
mondo. Le rievocazioni sono unite
da uno sguardo esterno, quello di
Zhao Tao, attrice musa del regista,
spettatrice smarrita delle trasformazioni di una città in continua transizione. Uno sguardo vagante lungo il
fiume Huangpu, staccato dalle vivide storie raccontate ma anche parte
di esse, unito a loro nell’osservare gli
effetti dello scorrere del tempo sulla
vita delle persone.
Le voci non ascoltate e quelle azzit-
Intervista
a Jia Zhangke
tite. Quasi una missione per quello
che è oggi tra i registi contemporanei più importanti in Cina. Jia Zhangke iniziò la sua carriera nel 1997,
Xiao Wu, Platform e Unknown
Pleasures sono i titoli che lo hanno
reso celebre all’estero. Film indipendenti, girati senza autorizzazioni e
di nascosto da occhi indiscreti. Film
senza distribuzione in Cina ma che,
arrivati a Cannes e a Venezia, hanno
incontrato un riconoscimento unanime da parte della critica internazionale. A colpire nelle prime opere
di Jia Zhangke era la veridicità della sua Cina, delle fotografie realiste,
quasi documentaristiche, di piccole realtà metropolitane tra gli anni
’80 e ’90. Una società particolare,
quella delle città di provincia cinesi
di allora. Passate d’improvviso dal
maoismo al mercato, di una gioventù sbandata, alienata ed emarginata dall’improvvisa legittimazione
dell’individualismo capitalistico.
Realismo sociale e storia, sono questi i punti di ritorno costanti dell’arte di Jia Zhangke. Il salto non è
però così grande come sembra, la
società e la storia sono unite dal fat-
to che entrambe racchiudono in sé
la trasformazione. La sensibilità di
Jia Zhangke è sempre votata alle
conseguenze, a volte drammatiche,
spesso alienanti, dei cambiamenti
sociali e politici sulle vite delle persone. Un film sulla storia di Shanghai
attraverso i racconti delle vite di alcune persone può sembrare strano
a un pubblico straniero, difficile da
penetrare nella sua ispirazione. Ma
le esigenze di Jia Zhangke sono
molto simili a ciò che lo aveva animato nei primi film da lui diretti.
"Per me era molto importante filmare una Shanghai che i cinesi non
conoscono. La mia principale intenzione era di rivolgermi a chi non è
familiare con la storia di Shanghai;
a chi non conosce i cambiamenti, i
movimenti, le guerre e le calamità
–politiche e create dall’uomo- che
vi sono avvenute dal 1933 ad oggi. E
poi l'influenza che hanno avuto sulla vita degli individui. Questi aspetti
in Cina sono sconosciuti, quello che
ho voluto fare è stato un lavoro di
riempimento di un vuoto, perché
molti degli eventi di cui parla il film
ufficialmente non possono essere discussi, non è consentito farli
emergere. Questo per me è un film
sovversivo, perché in passato nella
cultura cinese non ci sono state simili narrazioni, questa credo sia la
principale missione di questo film".
Il 2004 è un anno di cambiamenti
importanti per Jia Zhangke. Esce
The World, il suo primo film autorizzato dal governo cinese. Da allora il
regista ha girato altri tre film, ottenendo il Leone d’oro con Still Life
(2006), a cui è seguito 24 City (2008),
ambiziosa storia della chiusura di
una fabbrica statale di Chengdu, e I
Wish I Knew (2010). Film diversi dai
primi girati, che pur rivelando chiaramente l’anima del regista, evidenziano il passaggio dall’underground
alla luce. Jia Zhangke non ama le
allusioni ad un suo avvicinamento
al mercato. Quando gli viene chiesto
come sia cambiato il suo approccio
alla regia dopo il riconoscimento
delle autorità, è abituato a rispondere che a cambiare non è stato lui,
ma l’atteggiamento delle autorità
verso i suoi lavori. Gli ultimi film lo
hanno invece messo in contatto con
altri luoghi della Cina, allontanandolo dalla provincia d’origine dello
Shanxi, una “scenografia” reale che
era divenuto un segno distintivo del
suo cinema. Ma quelle contraddizioni sociali in cui era cresciuto e che
avevano suscitato il suo interesse si
sono costantemente riproposte nei
suoi spostamenti.
"In realtà non ho mai abbandonato
la mia vita passata, so costantemente quello che accade nello Shanxi.
Perché anche se dopo ho girato a
Chengdu, alle tre gole o a Shanghai
è perché al mio sguardo erano uguali allo Shanxi. L’unica cosa diversa è
che nello Shanxi non c’era la grande
diga delle tre gole o non ho trovato
la fabbrica che era a Chengdu. Ma in
realtà queste storie sono tutte uguali, perché sono dentro uno stesso
sistema. La società cinese dopo il
1949 è stata unificata, e in Cina unificare ha significato uniformare. Poi
nel tessuto sociale cinese senz’altro
ci sono stati cambiamenti. Ma il fatto è che io vivo in Cina e ogni giorno
sono colpito dai suoi cambiamenti, per cui questi cambiamenti non
possono abbandonarmi, so ancora
di che tipo di società si tratta, per
me non è come trovarmi davanti a
una persona sconosciuta".
Nei suoi film, quello con le autorità
cinesi è un rapporto non pronunciato. Le opere di Jia Zhangke non
sfidano il partito criticando direttamente il regime, ma dando voce a
versioni alternative al processo di
sviluppo cinese, spesso marginalizzate da esso: "Faccio questo tipo
di film perché in realtà in Cina non
si parla molto di queste vite, non
è permesso e non si è incoraggiati
a farlo, per cui mi interesso molto
a questo tipo di questioni. Inoltre
anch’io sono nato in questo genere di ambiente e credo anch’io di
appartenere a tutto ciò". Le parole
del regista però sono senza veli: nel
dibattito sociale e politico interno
alla Cina ritiene centrali le questioni
della democratizzazione e dei diritti umani, mentre la considerazione
dell’incessante sviluppo economico
cinese è tutt’altro che orgogliosa.
"Ovviamente il processo di sviluppo
ha una sua funzione giustificabile,
che è nella dedizione al rafforzamento dell’intera Cina, o nello sviluppo
delle grandi città. Ma noi che viviamo in Cina non ci identifichiamo
troppo nel fattore dei risultati economici, perché quelli dell’economia
cinese sono successi basati sulla
quantità. Il divario tra ricchi e poveri, ad esempio, è un problema della
nostra società; la ricchezza prodotta
non concede alle persone di ricevere profitto. In questi ultimi due anni
ho continuamente evidenziato il
problema della povertà in Cina, la
Cina di fatto non è ancora un paese
ricco. Le province settentrionali si
trovano ancora in una condizione di
estrema povertà. La Cina nell’insieme è molto grande, perciò ognuno
può identificarsi in una Cina diversa.
Io sono piuttosto preoccupato per
quella parte di Cina povera, perciò
non sono assolutamente d’accordo
nel dire che la Cina sia già un paese
dotato di un modello economico di
successo".
Spostando l’attenzione sul clima
culturale cinese, il suo tono non
cambia: se da un lato denuncia
l’appiattimento culturale nell’assoluta maggioranza dei centri urbani
cinesi, d’altro canto ha una grande
considerazione del fermento che si
81
respira a Pechino, ma ancora una
volta il principale valore è nell’indipendenza di vedute, con tutto
quello che questo può comportare, politicamente e materialmente:
"Credo che a Pechino esista una
cultura ribelle. Questo è l’aspetto
di maggiore valore, perché ci sono
ancora molte persone che adottano
un tipo di pensiero molto indipendente per manifestare i propri punti
di vista. Questi lavori subiscono diversi limitazioni e probabilmente
dal punto di vista materiale ed economico sussistono molte difficoltà;
ma il valore di Pechino è proprio nel
convogliare artisti di questo genere,
in grado di dar vita a questo tipo di
cultura. Le altre città non hanno la
stessa dimensione".
Il suo giudizio sul cinema cinese degli ultimi anni è invece maggiormente critico: malgrado il dinamismo ed
il recente fermento, stenta ad individuare prodotti di valore in grado
di emergere sugli altri; piuttosto che
ricondurre il problema all’assenza di
condizioni economiche, non esita
a parlare di questioni inerenti alla
"creatività" e all’incapacità da parte
dei nuovi prodotti cinematografici a
proporsi in modo "rappresentativo".
Il percorso formativo di Jia Zhangke ha mosso dal cinema sovietico
e giapponese per arrivare a quello
francese e al neorealismo italiano.
Cresciuto nella Cina post-maoista, la
componente sociale è nel suo stes-
so patrimonio genetico, personale e
professionale; tuttavia la sua opera
non vuole esaurirsi in un semplice
intento documentaristico, tra i registi che ama e hanno influenzato la
sua identità artistica egli indica non
solo De Sica, ma anche Antonioni
e Fellini.
A conferma di ciò, sostiene senza
sorpresa di considerare la funzione
descrittiva sociale e quella creativa artistica come complementari
all’interno della sua arte cinematografica: "Io ritengo che questi due
aspetti non siano né opposti né
contraddittori, ma due componenti di un’unità. Penso che i film che
voglio realizzare abbiano a che fare
con l’epoca in cui sono cresciuto,
poiché nel mio processo di formazione la Cina si è imbattuta in cambiamenti molto violenti, che hanno
influenzato molte persone differenti. Ma io sono un regista cinematografico e non un sociologo, tutte le
vedute che esprimo sulle persone e
sulla società devono fare ricorso ad
un procedimento estetico, devono
passare attraverso la pellicola per
poter prendere forma. È per questo
che sono alla costante ricerca di un
mio linguaggio cinematografico, in
grado di dare forma alla mia arte,
che possa esprimere ciò che più mi
sta a cuore. Penso che per un regista
questi due aspetti siano ugualmente importanti nel suo lavoro".
Infine cinema e musica, musica nel
cinema. Un rapporto complesso ed
essenziale che spesso risulta imprescindibile: "Credo che nel cinema la
musica sia in gran parte una forma
narrativa in grado di completare il
mondo interiore dei personaggi.
Ci sono molte cose che non si ha
modo di dire attraverso un copione
ma che puoi esprimere con la musica. È una prosecuzione, un’estensione dei sentimenti. Poi nei miei film è
anche il segno di un’epoca, perché
utilizzo molte canzoni che ricordano allo spettatore un periodo preciso. In Cina, dagli anni ’80 in poi, ogni
anno ci sono sempre state delle
canzoni pop strettamente legate ai
cambiamenti sociali cinesi, canzoni
che rappresentano quel tipo di società. Per cui si tratta di una parte
di memoria, il modo più facile per
restituire un ricordo, una chiave in
grado di aprire la memoria".
Filmografia:
*China Files è un’agenzia di stampa
composta da giornalisti, videomaker,
fotoreporter e sinologi di diverse nazionalità. Sfruttando il valore aggiunto della presenza sul territorio cinese
si proprone di ascoltare, osservare e
raccontare la Cina contemporanea
nella sua complessità, troppo spesso
ridotta ad interpretazioni in bianco e
nero. www.china-files.com
Mauro Crocenzi
Filmografia
Xiao Wu (小武, 1997)
Platform (站台, 2000)
Unknown Pleasures (任逍, 2002)
The World (世界, 2004)
Still Life (三峡好人, 2006)
24 City (二十四城, 2008)
I Wish I Know (海上奇, 2010)
82
83
Rearview Mirror
—speciale
I'LL REMEMBER
The Kinks
Wonderboy
Caro vecchio Ray: sai solo tu quanto ti adoro. Anche se da
troppo mi fai penare e ti sei chiuso in quello stesso passato
che hai creato col tuo Genio. Grazie lo stesso, Ray.
84
Testo: Giancarlo Turra
“A partire da Waterloo Sunset ho sempre pensato alle
canzoni in senso visuale, prendendo annotazioni sulle
scene.“ Ray Davies, 1983
Al numero 6 di Denmark Terrace, a Fortis Green, nel
quartiere di Londra nord chiamato Muswell Hill, c’era
una porta con su scritto “Davies”. Lì è nato Raymond
Douglas, settimo di otto figli - sei sorelle (una lo crescerà a suon di dischi) e il fratellino Dave, talento inevitabilmente minore e carattere ruvido - di una modesta
famiglia operaia. Verrà su, con tutto quel chiasso e quella folla attorno, da introverso che preferisce guardare le
cose dall’esterno e possibilmente in pantofole e quanto è perfetto tutto ciò per fungere da incubatrice al
prototipo di scrittore di mini-drammi (o commedie…)
che sarà. Perché di ciò si tratta: di un osservatore che,
come tutti i grandi scrittori o commediografi, cammina tra la gente e senza mescolarsi con essa ne cattura
pensieri e respiri, aspirazioni e sdegni. Stando chiuso in
casa a prendere nota dalla finestra come l’io narrante di
Waterloo Sunset, che vive malinconicamente una gioia
un po’ misantropa (che ci dici, Morrissey?) tramite gli
amanti Terry e Julie che scorge fuori dalla stazione della
metro. Uno senza il quale è impossibile pensare - anelli
di una dorata catena - gli Elvis Costello, i Paul Weller,
Andy Partridge e Damon Albarn che ne seguiranno
le orme.
Perché è qui che la musica inglese, mentre completa l’invasione di un’America che le fu maestra, inizia a
sposare testo e contesto e a “vivere” il pop nel contesto
sociale che lo genera e che a sua volta finisce per plasmare in qualche modo. Sta tutto nell’abilità di questo
amabile passatista, di una specie di “reazionario idealista” con in testa una Britannia che è cool senza neanche
volerlo, anzi si chiude dentro a un’Arcadia di tradizioni
- la provincia e i suoi lenti riti, la struttura sociale inamidata come i colletti degli impiegati ministeriali, le
colonie e l’amato Impero - idealizzata in modo di già
consapevole come via di una felicità in terra. E una via
di fuga dal sentirsi strozzato in una scelta, in quel Dead
End Street che nel ’66 canterà così amaramente a 45 giri:
scarpe da pallone o chitarra, George Best o John Lennon. E’ un cocciuto indicare che quegli anni non sono
poi così fab per tutti, di povertà dickensiana e disperata
si vive e si muore ancora ed è così che assume senso un
parallelo con Mark E. Smith, misuratosi egregiamente
con Victoria e continuatore della saga inacidendo del
Nostro il tagliente umorismo.
Un clichè, anche, che infine si sovrappone e genera, nel
sonno della ragione critica, i Liam Gallagher e Pete
Doherty del caso, ovvero i fantocci senza contenuto
che talvolta ci fanno così detestare quell’isola che viceversa amiamo, e dove piangi due volte. Quando arrivi e quando te ne devi andare. Sarà infatti poco e soprattutto all’inizio rock e poi tantissimo pop la creatura
Kinks al suo meglio, perché in quel mettere in mostra
plateale sentimenti e in quel raccontare storie c’è tutta
la differenza. Trovi il camminare sulla corda tesa tra la
dura realtà e la trasfigurazione “mitologica” della stessa
che ha per alcuni anni offerto magia indimenticabile e
che non ha smarrito potenza e seduzione. Abbastanza
da allestire seduta stante una Società per la Conservazione di Ray Davies, diventato vecchio in fretta perché
vecchio già lo era sin da ragazzo (al punto di voler regredire indietro fino alla scimmia in Apeman: era il ’70,
qualcosa vorrà senz’altro dire…), senza possibilità di
emergere tra un McCartney e un Jagger epperò talento di pari schiatta.
Chissà se avrebbe apprezzato quel tipo di successo:
probabile che oggi, nonostante il declino e un inverno cupo e pessimista, non lo scambierebbe con il suo
ruolo “storico”, cioè quello di un Noel Coward o un G.B.
Shaw prestato a (splendide) canzoni. Preparatevi alla
più lunga sequela di ovvietà mai apparsa su queste pagine e a rinunciare ai voti.
YOU REALLY GOT US
“Andavo a scuola e cantavo nel coro, poi arrivo la pop
music a liberare i giovani. La classe operaia ottenne una
voce, ma non c’ero soltanto io: c’erano John Osborne, Alan
Sillitoe, gli Angry Young Men; il teatro e il cinema.“ Ray
Davies, 2010
Nel cuore di quegli anni Quaranta che per l’Inghilterra furono soprattutto grigiore e bombe, c’è un’intera
generazione, diciamo quella dal 1940 al 1950, che dal
secondo conflitto mondiale e del suo dopo sa trarre
forza e incanalare la tragedia in una ricostruzione del
costume. Saranno costoro a porre - mai come in questo
caso involontariamente - le fondamenta di una rivoluzione culturale in cui i giovani prendono il potere, anzi
in essa nascono come categoria sociale e di mercato.
Ray è del giugno ’44 e il fratello di quasi tre primavere più giovane, dunque la trafila è la solita: se siete un
minimo avvezzi all’evoluzione del rock and roll, saprete
dunque che si cresceva con Elvis Presley, Chuck Berry e il blues per darne una versione ingenua ma utile
come palestra chiamata skiffle. Tenendosi da qualche
parte i crooner e un music-hall autoctono che sarà pre85
‘Til The End Of The Day, le prime avvisaglie di amarcord
(Where Have All The Good Times Gone, Ring The Bells),
per un favoloso 45 giri che da un lato irride la moda
(Dedicated Follower Of Fashion) e dall’altro commenta
la noia (Sittin’ On My Sofa). Servirà però una tegola sulla testa per tirare il fiato e approdare a un primo Capo
d’Opera: alla fine dell’estate, l’ennesima rissa sul palco li
bandisce dall’America per un quadriennio.
Stop alla mattanza del palco e via alla nostalgia, alla
creazione del piccolo mondo antico da parte di Ray, che
da questo - così rutilante, colorato e fors’anche vacuo è stato estromesso. Introspezione, acredine classista e
malinconia sono dunque gli ingredienti di Face To Face,
quattordici diamanti pop-art trainati dal successone
Sunny Afternoon, epitome della Londra che nel luglio
’66 swinga e si aggiudica i mondiali di calcio. Manifesto
del suo tempo tanto quanto è sempreverde, infila tra
l’ironia a rotta di collo di Party Line e gli struggimenti
amorosi di I’ll Remember i folk-beat elisabettiani Rosy
Won’t You Please Come Home e Too Much On My Mind, il
raga Fancy, la proto-psichedelia pastello (Rainy Day In
June). Non basta, poiché altrove volano le stilettate di
Dandy e l’omaggio Session Man, le berline di costume
e società borghesi alla Hogarth House In The Country
sto utilissimo nel mentre ci si butta a pesce su rock & roll
e soul, li si fraintende e se ne cava il beat.
Al pari di svariati altri colleghi, i Davies frequentano
nel ’62-‘63 il londinese Hornsey College Of Art e fanno
comunella con Peter Quaife, chitarrista subito dirottato al basso ed ecco che, in estate, col Pete Best della
situazione (Mickey Willet) alla batteria nascono i Ravens. Un loro demo plana sulla scrivania di Shel Talmy,
produttore americano sotto contratto per l’albionica
Pye. E’ il 1964 e la competizione già è durissima, per cui
tocca sbrigarsi: prima di firmare, ci si sbarazza di Willet
a favore del più solido Mick Avory e si cambia nome
come sappiamo. Il debutto, un 45 con la cover di Long
Tall Sally, non va da nessuna parte e idem il successore
You Still Want Me. Fatto è che Rolling Stones, Animals
e Beatles stanno su un altro pianeta e a nulla vale rifarsi
ai loro stilemi senza una scintilla che distingua. E che
giunge sotto forma di uno tra i riff più imitati di sempre
- dal punk all’hard passando per garage e power pop che libera centotrentaquattro secondi di angst giovanile. Imprime una svolta alla loro carriera e a quella della
musica leggera, You Really Got Me, salto in avanti quan86
(ciao, Blur!), Holiday In Waikiki e Most Exclusive Residence For Sale. Lasciando fuori un rauco inno da cantina
come I’m Not Like Everybody Else e accidenti se è vero.
Epoca d’oro per il mondo, il pop e Mr. Ray, che benché
si chiuda viepiù nella “Kinkdom” celebrata e racchiusa
- come pasticceria golosa da Afternoon Tea - nel successore Something Else, che rende un ‘67 ancor più formidabile. Scordatevi le tangenti acide e l’espansione della
mente, ché qui si narrano drammi quotidiani in sedicesimo che con il patetismo e il populismo nulla hanno a
che fare: tra la Death Of A Clown che è lascito trai i migliori del Dave e il meraviglioso acquerello Ibseniano
Two Sisters, le classifiche perdono i Kinks e l’evoluzione
della musica li raccoglie, nonostante un certo “Sergente Pepe” fosse da qualche mese nei paraggi. Il rock si
nasconde in un paio di passi mica male (la dylaniana
Situation Vacant) e il folk si incarna in marcette (Harry
Rag, Tin Soldier Man) a fianco di una bossanova (No
Return) e tutto s’avvolge di incantato, nebbioso stordimento (Lazy Old Sun, End Of The Season). Ad aprirlo l’invenzione dei Jam (David Watts) e a suggello il racconto
più fulgido del Raimondo (Waterloo Sunset).
Tornano verso fine decade nelle classifiche dei singoli, i ragazzi, benché l’interesse sia ormai verso l’album
tico dal trampolino di Louie Louie con un fuzz selvatico
che l’album d’esordio, fuori a ottobre ’64 per cavalcare
l’onda, non mostra.
The Kinks, singolo Capolavoro di cui sopra e una Stop
Your Sobbing che Costello deve aver mandato a memoria
escluse, si affida a un compitare Merseybeat con mano
acerba e a un errebì che non graffia. Suona a rimorchio
di mode velocissime, come un altro 7” che sbanca e
spacca seppur ricalcato sulla scansione di accordi che
li rende famosi anche negli U.S.A. A fine annata All Day
And All Of The Night si arrampica alla seconda piazza nazionale e gli americani lo spediscono alla settimana. In
tutto quel bailamme c’è tempo per buttar fuori e.p. a
ritmi industriali, accumulare esibizioni e incazzarsi tra
di loro. Ne risente Kinda Kinks, che a inizio 1965 mostra
un autore in cerca di sé, che fa numero attingendo dalla
Motown e insegue un’eterna adolescenza impossibile.
Regala nondimeno una Tired Of Waiting For You che è
Classico magari minore e ciò nondimeno con la maiuscola e l’incursione brasiliana Nothing In The World Can
Stop Me… Soprattutto, indica che non si è al cospetto di
un bluff e lo stesso Kontroversy e il beat da antologia di
87
come forma espressiva capace di soddisfare le velleità
autoriali del leader. Vendono bene e sono di ottima fattura sia le gioiose Autumn Almanac e Wonderboy che
la romantica sfoglia Days, nondimeno mente e cuore
stanno in The Village Green Preservation Society, dei
famigerati “concept” uno dei pochi davvero azzeccati
e giammai noioso; un’autentica mosca bianca in tal
senso e veramente rivoluzionario nel guardare indietro
mentre chiunque “vuole tutto e lo vuole adesso.” Spartano come si conviene e come Ray voleva, profuma di
semplicità e di campagna, di fondamentale minuteria
da microcosmo gozzaniano (il brano omonimo e la gemella meditativa Village Green, Starstruck, Picture Book),
di una penna fragrante e di arrangiamenti indovinati
(l’inquieta Wicked Annabella, l’agreste Sitting By The Riverside, una Phenomenal Cat col santino di Lewis Carroll
in tasca). Ci sono il vaudeville e la celebrazione, l’amarezza e l’amicizia (Do You Remeber Walter); c’è un’epica
pop, rock e finanche blues contenuta e imbrigliata che
fa gridare all’incanto, al secondo “masterpiece”. Tanto
per essere al passo coi tempi, esce sul mercato lo stesso
giorno del White Album e addio sogni di gloria. La Storia applaude, però, e noi le facciamo compagnia. Non
Peter Quaife, che non ne può più dell’insuccesso, se ne
va (morirà nel giugno 2010) e gli subentra John Dalton.
Agli sgoccioli del decennio termina anche il bando e il
quartetto può tornare sul suolo americano, non prima
però di aver messo mano alla “rock opera” Arthur (o il
declino e la caduta dell’Impero Britannico): chiamatemi
pure blasfemo o ignorante, ma la preferisco a Tommy
però cede la medaglia d’oro a S. F. Sorrow dei Pretty
Things, nel campo i primi e anche i migliori.
88
Consideratelo il concept esplicito dopo quello implicito
ambientato nel Villaggio Verde, siccome ci si abbandona a riflessioni su Albione e il suo trapasso nell’era moderna visti attraverso gli anti-eroi di ogni giorno. Quel
che spiace è un tono strumentalmente più appesantito
dagli esiti non spregevoli (Mr. Churchill Says, Australia)
e pur tuttavia opachi. Come se la leggerezza fosse scivolata sotto l’uscio, per cui tocca rinvenire i picchi nella
freschezza di ieri l’altro, ovvero nella celeberrima e irresistibile Victoria, nella mestizia devastante di Shangri
La, nella tenera Young And Innocent Days e nella baldanzosa Arthur. Il rimanente si colloca su buoni livelli, se no mostra stanchezza compensata col mestiere.
Nemmeno l’ingresso del tastierista fisso John Gosling
inietta nuova linfa, per quanto la sua prima apparizione sia con il singolo Lola, tenera istantanea di ingenua
confusione sessuale ripescata dalle Raincoats. Compare di nuovo in classifica su ambedue i continenti e
nel 1970 è tra i gioielli di Lola Versus Powerman And
The Money-Go-Round, Part One, imbevuto per il resto
di fiele e veleno scagliato contro lo showbiz e quando
mai una tale mossa può giovare alla musica, anonimamente rock ed eccessivamente chiusa nel proprio guscio salvo riaffiorare pura nell’Apeman che satireggia
esotico, nel rock quadratamene bluesato The Contenders, nella stonesiana Got To Be Free e in una This Time
Tomorrow da lirismo a squarciagola. Al di là del più che
dignitoso risultato, preoccupa un autore che soffoca il
mezzo con i messaggi. Che, esaurito il sarcasmo, va facendo il pieno di cinismo. Ne avrà bisogno: i Settanta
sono arrivati.
TIRED OF WAITING FOR YOU
“Scrivo canzoni perché mi arrabbio, e ora mi trovo a un
punto in cui spolverarle d’umorismo non basta più.” Ray
Davies, 1978
Lo spartiacque lascia inizialmente perplessi: Percy imita in approssimazione e vaghezza la pellicola di cui
fornisce commento e lo rammenti per God’s Children
e The Way Love Used To Be. In retrospettiva penseresti
che una band simile non possa sopravvivere alla nuova epoca ed è così, per quanto si debba restare ancora
di stucco: Ray consegna il proprio genio a un ultimo
disco e, salutata la Pye, varca la porta del colosso RCA
ripagato da un anticipo di un milione di dollari. Di fatto,
nel ‘71 Muswell Hillbillies risponde a glam e progressive cancellando l’Inghilterra dall’orizzonte sonoro e
volgendo le orecchie a Ovest. Chiude un cerchio splendidamente, raccontando di nuovo borghesia e suburra
in country (la title-track), jazz (Holiday, Acute Schizophrenia Paranoia Blues) e ballate. Inizia qui un lento declino, un appannamento della creatività che sa di ritirata
nel carapace delle ambizioni mal riposte sul quale non
mi dilungo: due anni dopo, Everybody's In Showbiz
mescola su un doppio brani in studio ed estratti live
che piazzano sulla graticola ancora il contorto rapporto con l’industria discografica. Ne ricavo parole lucide,
la seduta psicanalitica Sitting In My Hotel e più di tutto
Celluloid Heroes, la commovente elegia per i Miti che
non muoiono mai nonostante il tramonto della fama.
Frattanto il rapporto col fratello peggiora, in mezzo ci
si mettono il disincanto e la voglia di magniloquenza.
Dal triennio ’73-’76 e da un poker di dischi non si cava
nulla che banali e autocompiaciute “opere rock” che
son operine sbracate e inascoltabili, noia reiterata di
un’epoca noiosa.
Encefalogramma piatto per la coppia di volumi di Preservation Act, per Soap Opera e Schoolboys In Disgrace, sicché serve un risvegliarsi ai tempi che stanno
cambiando in un ‘76 importante per la porta sbattuta
in faccia alla RCA (si passa chez Arista) e, annusando un
punk alle porte che loro stessi hanno plasmato, vanno
di lifting “dando alla gente ciò che vuole”: rock duro e
tagliente, pochi orpelli e le grandi arene americane spalancate di fronte. E sia. Dalton se ne va l’anno seguente,
poco prima di Sleepwalker (tornerà poco dopo e poi
dirà basta del tutto), meritato successone negli States
dopo il deserto creativo di metà decade, per quanto
oggi sappia di vecchio ad eccezione di una Life On The
Road paradossalmente fresca perché antica. Misfits lo
replica in mezzo a un nuovo rimpasto di line-up necessario per tener botta negli stadi d’America. Frattanto i
giovani omaggiano Ray in modo più (Jam, Knack) e
meno (Clash) sfacciato e nell’onestà dei Pretenders
l’uomo troverà anche l’amore travagliato di Chrissie
Hynde. La musica prova a stare al passo a testa alta e
ci riesce Low Budget (1979, undicesimo posto in USA)
laddove Give The People What They Want (1981, numero quindici e disco d’oro) naufraga impietoso. Meglio, nell’83, State Of Confusion, trainato dall’ottima
Come Dancing, dall’azzeccato video - un cortometraggio - in rotazione sull’ancor verde MTV. Il maggiore dei
Davies imbocca qui un tunnel artisticamente triste e si
trascina per dieci stagioni e un quartetto di lp di reducismo e spossatezza spiacevoli.
Nel mentre il capobanda si cimenta con i musical, il declino è segnato da Word Of Mouth, Think Visual, UK
Jive e Phobia. In mezzo, se v’interessa, l’addio di Avory,
l’ingresso nella Rock And Roll Hall Of Fame, il passaggio alla Columbia. Poi un ultimo guizzo, l’autoprodotto
To The Bone che rilegge il repertorio glorioso in chiave
“unplugged”, in quegli studi Konk nel frattempo allestiti dai fratelli e che sono attualmente fatiscenti e all’asta.
Sarà merito sempre di omaggi e riscoperte cicliche, se
i Kinks tornano sotto i riflettori nell’estate del Brit-pop:
Ray Davies finisce in televisione a far da padrino a Blur,
Supergrass e Oasis e promuove una autobiografia, XRay, argutamente strutturata e concepita come un romanzo. Messa nel ‘96 la banda nel congelatore, si concentra su una pleonastica carriera solista: nel ‘98 tocca a
The Storyteller; più recentemente a un Other People's
Lives datato 2006, a Working Man's Café dell’autunno
2007 e a The Kinks Choral Collection nell’estate 2009.
Il secondo è addirittura entrato in classifica e Working
Man's Café ha dato la stura alla serie di riconoscimenti
e premi del caso per questo Grande senza un Time Out
Of Mind o un Ragged Glory all’orizzonte. Provateci voi
a dargli addosso, comunque, sapendo che nel gennaio
2004 gli hanno sparato a New Orleans durante un tentativo di rapina e che l’ultima mossa è un lavoro di collaborazioni e duetti, un See My Friends che sa di cronaca mediocre. Oggi scopri un uomo anziano paranoico
e amareggiato, forse incapace di reggere il peso del
tempo che passa e si porta via ogni cosa, inesorabile.
Compreso l’amico Quaife e, causa un infarto nel 2004,
quasi anche il fratellino, col quale peraltro comunica
soltanto via posta telematica.
Mi ricordo: un momento, durante il festival di Glastonbury del 2010, in cui dopo aver dedicato buona parte
della scaletta a Pete, Ray quasi scoppiava in lacrime durante Days. Mi ricordo: un momento, durante il Live At
Kevin Hall del 1968, in cui la folla di adolescenti intona Sunny Afternoon al suo posto. Una morsa mi serra il
cuore e infine capisco. Al numero 6 di Denmark Terrace
non trovate più scritto “Davies” sul campanello, o almeno suppongo. So però per certo che nessuna targa
spiega ai passanti chi sia nato lì quasi settanta anni or
sono. Sarebbe ora che ce la sistemassero: possibilmente d’oro zecchino.
89
(GI)Ant Steps #44
classic album rev
Miles Davis
Roxy Music
Bitches Brew (Columbia Records, Aprile 1970)
Avalon (Polydor, Maggio 1982)
Davis è uno che ha passato la vita ad accelerare il jazz, a
segnarne le tappe evolutive in maniera programmatica,
scientifica, aprendo nuove vie, fissando intuizioni altrui,
promuovendo rivoluzioni. Dopo Davis certe cose non sarebbe più state come prima. La nascita del cool con l’omonimo disco del 1950, la svolta modale codificata dal madreperlaceo Kind Of Blue (1959), l’elettrificazione degli
strumenti cominciata timidamente con Miles In The Sky
(1968; con le tastiere di Herbie Hancock, il basso di Ron
Carter, la chitarra di George Benson), proseguita in Filles De Kilimanjaro (1969) ed esplorata meticolosamente,
letteralmente dissezionata anzi, nel misterico In A Silent
Way (1969). Che non è solo il disco per antonomasia del
periodo elettrico, ma è anche e soprattutto il big bang di
due altri importantissimi specimen davisiani: la direzione
dell’improvvisazione (ecco spiegato il duplice significato di
un sovratitolo come “Directions in music by Miles Davis”) e
l’uso dello studio di registrazione come uber-strumento. Le
due cose sono strettamente collegate. Ai propri sidemen
dell’epoca, Miles più che istruzioni dà indizi: “Un’indicazione di tempo, qualche accordo, un abbozzo di melodia, un
suggerimento sul modo o sul tono”. Ogni take è un salto
nel buio, una sfida all’intuizione del momento, inseguendo
i capricci del maestro. Il produttore Teo Macero poi, novello demiurgo, gioca di post-produzione, sceglie i momenti
migliori, gioca di incastri, inserti, sovrapposizioni, smaterializzazioni. Se Davis compone la musica, è Macero che compone il disco.
Tutta la tensione sperimentale di questo Davis come sempre affamato di nuovo, ma sorprendentemente lucido e
ripulito dalle droghe, i suoi ascolti di James Brown, Sly &
The Family Stone e Jimi Hendrix, ma anche di Karlheinz
Stockhausen, la sua volontà di fondere assieme tutte
le suggestioni che lo ammaliano, di dare nuova linfa alla
musica afro-americana (“il jazz non esiste, è una parola inventata dai bianchi per i niggers“) attraverso la creazione
laboratoriale di una musica totale, tutto questo confluisce
nel grande affresco di Bitches Brew. Bitches Brew è il suo titolo, è quell’immagine lì (opera di Marti Klarwein, lo stesso
dell’Abraxas di Santana), è i suoi musicisti (la crema della
prima scuola fusion: Wayne Shorter, Joe Zawinul, Chick
Corea, John McLaughlin, Lenny White; Billy Cobham
e Airto Moreira nella bonus track cd Feio), è il sudore di
90
un tour de force
lungo tre giorni
nel torrido agosto newyorkese. Davis i musicisti li spremeva, ma la dedica
esplicita di un titolo come John McLaughlin ci racconta di
un dittatore capace anche di mettere i propri fidi sul piedistallo.
Bitches Brew è uno scorcio di quella torrida giungla. E una
fotografia dei Sessanta che trapassano nei Settanta. Inevitabilmente: essendo il battesimo di un jazz-rock che è già
fusion, e cioè fusione, all’interno delle strutture della jam
psiched\elica proprie dell’epoca (Davis vorrà dividere il
palco con gente come Grateful Dead e Santana), di jazz,
rock, elementi etnico-esotici e provenienti dalla classica
contemporanea (alle jam band americane si oppongono in
Europa esperienze come quella dei Can). Premesso ciò, per
l’orecchio veramente attento, questo disco non può non
suonare ancora come modernissimo, e quindi, in quest’epoca post-post, profondamente datato, noioso. Padre, Miles,
dopo questa primogenitura, di tanti di quei figli degeneri.
La decostruzione maceriana (essa stessa esposta in primo
piano, con le brusche pause, gli abbassamenti di dinamica,
gli strumenti che spariscono dal mixaggio nell’iniziale Pharaoh’s Dance; con la voce di Davis che dirige udibile nella
title track) diluisce i temi e sublima la pulsazione funk, crea
atmosfere umide e sospese, intensamente chiaroscurali,
per lunghe divagazioni dominate da una selva di intrecci
percussivi, con la tromba di Miles più ruvida e aggressiva
del solito. Fino alla conclusiva, elegiaca, Sanctuary.
Costruito per sfruttare i successi che andava raccogliendo questa nuova musica chiamata rock, il disco ebbe un
enorme successo di pubblico (vendette in poco tempo
mezzo milione di copie) e anche la critica lo accolse generalmente bene. In Italia qualcuno parlò di un “Davis
elettronico” (anche il luminare Arrigo Polillo, che mostrò
comunque di apprezzare questo Davis di confine) e il
vice-direttore di Rolling Stone, Ralph J. Gleason, accusò
Macero di avere addirittura ucciso il jazz con quella sua
cosmetica di studio. Tutto falso e tutto vero. Perché siamo
sicuri che la rivoluzione elettronica e il taglia e cuci digitale Davis li avrebbe apprezzati e anche molto.
Gabriele Marino
Qui bisogna tirare in ballo la memoria. Estate 1982. Ancora ubriaco di mondiale spagnolo e adolescenza sul punto
di sbocciare, attraversavo quelle calde settimane accompagnato da una dolce ossessione radiofonica. Neanche
sapevo chi fossero, i Roxy Music, e di cotanta ignoranza
More Than This ne guadagnava parecchio in esotismo. Era
come il richiamo di un passato vagheggiato e di un futuro dietro l'angolo, promessa di languori così imminenti
da rabbrividire eppure così inimmaginabili. Non potevo
saperlo, e ce ne ho messo a farmene un'idea, ma quella
canzone e quel disco dettavano - non certo in esclusiva - i
contorni di un universo estetico che avrebbe accompagnato gli anni formidabili e scellerati di lì a venire.
A pensarci bene, ora che possiamo farlo, i Roxy Music con
Avalon non facevano altro che restare fedeli a se stessi,
ovvero all'arte del raccolto art-pop. Dieci anni prima, dieci
anni che sembravano un secolo, tirarono le fila del "mainstream progressivo" - psych, glam, un pizzico di kraut,
premonizioni wave - apparecchiando un desco febbrile e
accattivante, quasi un controcanto cool all'ormai vetusto
banchetto degli straccioni di Stones e simili. Sembrava
spingerli una bramosia di futuro prossimo, un muoversi
con quell'attimo di anticipo che ti fa stare sulla mattonella
giusta al party dei fighi. Baciati in bocca dall'estro irrefrenabile di un Brian Eno mai più tanto giovane, Bryan Ferry
e compagni si disimpegnarono alla grande pure dopo la
sua dipartita, cavalcando con stile lubrico le fregole dance e wave, realizzando così un progressivo abboccamento sonico che li portò infine a bazzicare le zone alte delle
charts con Flesh And Blood (1980).
Nelle retrovie e in profondità accadevano fatti musicalmente più ingenti, certo, ma i Roxy annusarono i tempi e
quelli suggerirono d'interessarsi al fremito della superficie. Lo fecero così bene che Avalon rappresentò un cliché
irrinunciabile per tutto - tutto - l'addivenente new romantic, a cui si rifece in primis Ferry stesso per il suo Boys And
Girls (1985). E' al disimpegno arguto, lieve e struggente
del post-punk che guardarono quegli ultimi Roxy Music,
così come alle fregole etno riprocessate dai David Byrne
(via Eno) e dai Peter Gabriel, piegando il tutto alla strategia di decadenza atmosferica - celluloide d'appendice,
mitologie d'accatto, tabacco languido e abiti firmati - e
spasmi funk smussati.
Elaborarono un suono che evitava il trabocchetto ludico
del neo digitale per inventarsi un'artificiosità coerente,
eterea ma intensa, virtuale ma pregna d'umori: il sax di
MacKay un pastello fluorescente, la chitarra di Manzanera un cartiglio laser, le tastiere come cortine fumogene
aromatizzate. E' una soundtrack da interno notte, figure
sinuose nel buio, frenesia stilizzata e divanetti discreti, la
voluttà ansiosa di fingersi al centro di qualcosa che sta
accadendo, se mai accadrà. Musica-avatar per una generazione che ambiva provare l'ebbrezza della reinvenzione
di sé.
Forse proprio per questa sua marcata periodizzazione, o
perché non sono uscito vivo (non del tutto) dagli anni Ottanta, l'ascolto di Avalon oggi non mi scalda. Al netto dei
sussulti nostalgici, s'intende. Per lo stesso motivo tuttavia
non posso non ritenerlo, a suo modo, epocale. E un canto
del cigno perfetto.
(7/10)
Stefano Solventi
91
www.sentireascoltare.com