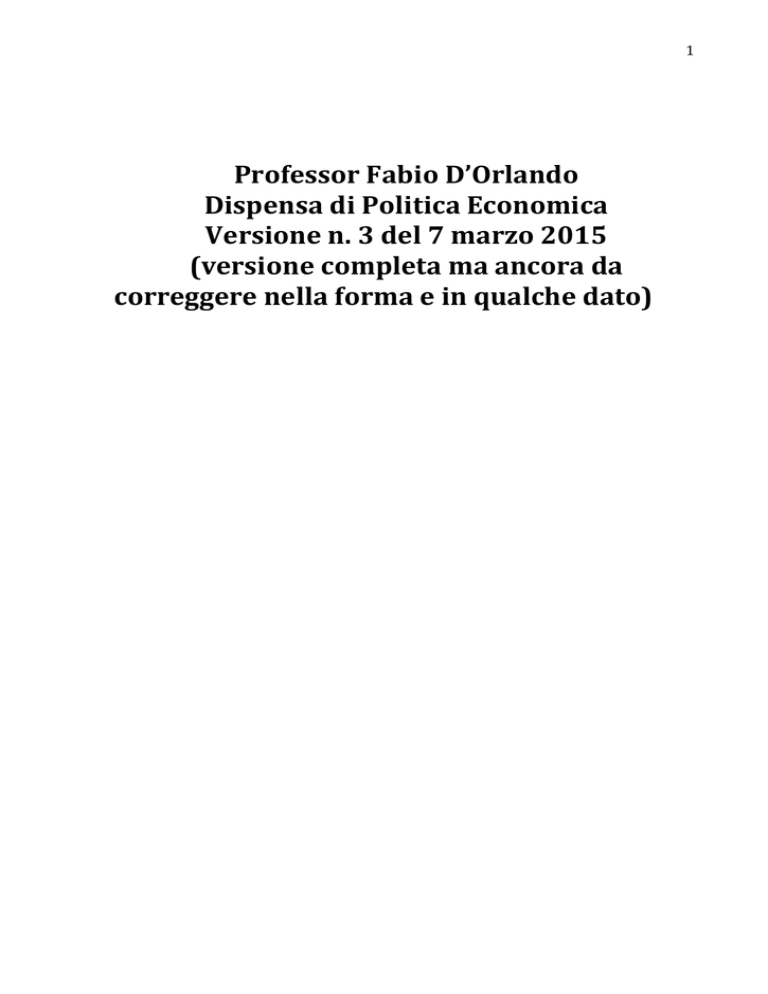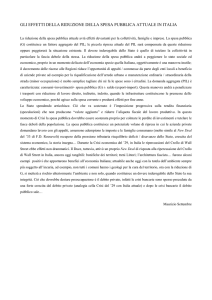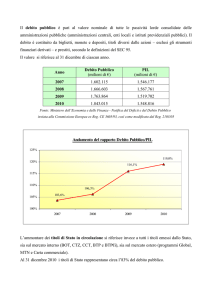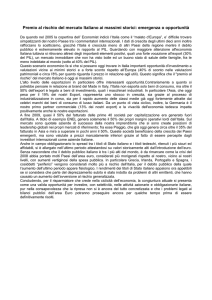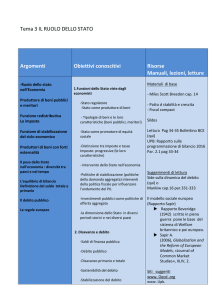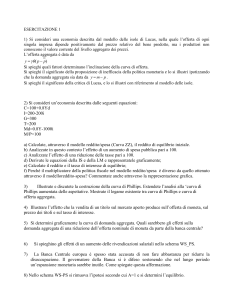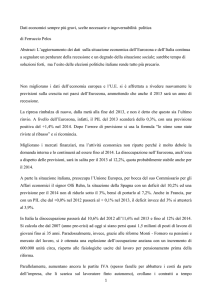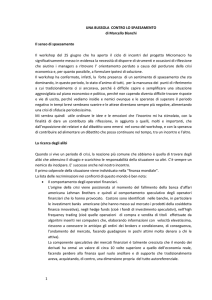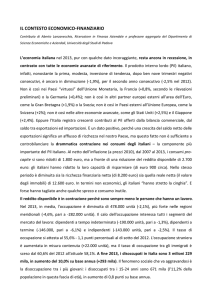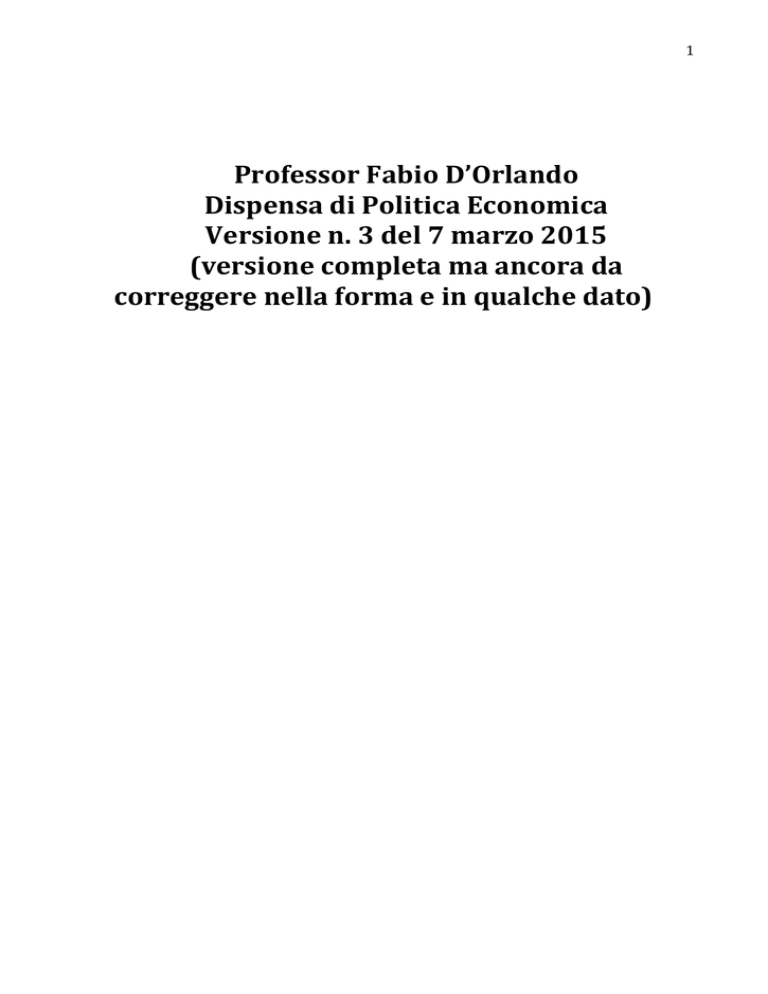
1
Professor Fabio D’Orlando
Dispensa di Politica Economica
Versione n. 3 del 7 marzo 2015
(versione completa ma ancora da
correggere nella forma e in qualche dato)
2
Introduzione
Credo sia evidente a tutti che l’Italia sta attraversando uno dei periodi più critici di
tutta la sua storia economica recente. Lo scopo di questo libro è quello di discutere le cause
che hanno condotto a questa situazione, l’effettiva utilità delle politiche sinora intraprese per
risolvere i problemi del nostro Paese, l’esistenza di strade alternative più efficaci per
conseguire i medesimi risultati nonché la praticabilità di queste strade alternative. Non è mia
intenzione svelare subito il nome dell’assassino, ossia anticipare le conclusioni cui perverrò,
ma poiché questo non è un libro giallo e il sottotitolo dell’opera è comunque uno spoiler
decisamente esplicito, può essere il caso di chiarire sin d’ora che le politiche sinora intraprese
non sono le più adatte a risolvere i molti problemi del nostro Paese (cosa che, d’altro canto,
dovrebbe essere chiaro anche al lettore meno addentro ai fatti dell’economia: siamo in
recessione praticamente dal 2007…), e che le politiche alternative, che pure esistono, sono
sostanzialmente impossibili da intraprendere per gli elevatissimi costi economici e politici che
implicano. Di qui le conclusioni pessimistiche, che comunque vanno interpretate: non significa
che torneremo ad esseri poveri; semplicemente, è assai probabile che non diventeremo più
ricchi, né recupereremo mai il benessere passato. Poi, naturalmente, tutto può succedere, e
magari domani troveremo in Basilicata il più vasto giacimento petrolifero mondiale, ma è
assai probabile che ciò non succederà, perché l’elenco dei problemi del nostro Paese è
talmente lungo e intricato che anche il petrolio potrebbe non essere risolutivo. Anche perché,
probabilmente, troveremmo parecchi buoni motivi per non sfruttarlo in maniera efficiente.
Per provare a dare una visione leggibile dei problemi del nostro Paese, in quest’opera
essi vengono distinti in due grandi categorie: quelli relativi alla bassa crescita e quelli relativi
alla carenza di domanda aggregata. Semplificando un po’ tematiche che saranno chiarite nei
primi due capitoli, bassa crescita significa che il nostro Paese non riesce a far aumentare la sua
capacità produttiva, ossia il numero e la produttività delle sue fabbriche, dei suoi stabilimenti,
dei suoi lavoratori; bassa domanda vuol dire invece che già oggi, con impianti che non
aumentano in numero né in produttività, non riusciamo a trovare acquirenti sufficienti per
comprare tutte le nostre produzioni, e siamo dunque costretti a produrre meno di quanto
potremmo, ossia meno della nostra capacità produttiva, con il risultato che un numero
crescente di lavoratori si ritrova disoccupato. In genere, o i Paesi hanno un problema di bassa
crescita, e quindi intraprendono politiche adatte a favorire la crescita ma dannose per la
domanda aggregata; oppure hanno un problema di bassa domanda aggregata, e quindi
intraprendono politiche atte a sostenere la domanda aggregata ma che possono essere
dannose per la crescita. L’Italia, invece, ha entrambi questi problemi. In forma assai grave,
soprattutto per quanto concerne la crescita.
I nostri problemi sono poi aggravati dal fatto che le politiche per il sostegno della
domanda aggregata ci sono quasi precluse sia dal contesto internazionale nel quale ci
muoviamo (l’Unione Monetaria Europea) sia dai pesantissimi vincoli di finanza pubblica,
mentre le politiche per stimolare la crescita sono assai dolorose dal punto di vista sociale,
politicamente poco praticabili e, inoltre, costose, ossia di nuovo difficilmente compatibili con i
vincoli della finanza pubblica.
Come siamo arrivati a tutto ciò? Proverò a raccontarlo nel prosieguo dell’opera. Qui
posso solo anticipare che, semplicemente, il nostro Paese si è crogiolato nell’illusione di poter
accrescere costantemente il proprio benessere attraverso l’indebitamento, ponendo in
secondo piano l’ammodernamento della propria struttura produttiva, facendo crescere i salari
molto più della produttività del lavoro, mentre gli altri facevano il contrario, e soprattutto, più
in generale, non riuscendo a capire quali fossero le implicazioni della globalizzazione, ossia
3
dell’ingresso sul mercato mondiale di concorrenti agguerriti che producono le nostre stesse
merci con forza lavoro a costo più basso e, purtroppo, oggi anche con tecnologie migliori delle
nostre. Con la globalizzazione tutto è cambiato, ma noi abbiamo chiuso occhi e orecchie e
invece di darci da fare abbiamo scelto di ignorare il fenomeno e continuare a goderci la vita
indebitandoci.
Il risveglio è stato brusco: si può vivere a credito solo finché il creditore è disposto a
prestarti altro denaro per pagare i debiti accumulati. Ma prima o poi chiede i soldi indietro e,
se crede ci sia il rischio che tu non li restituisca, sicuramente non te ne presta altri. E allora
come fai? Se nessuno ti presta il denaro per mantenere la tua bella vita, e non sei (più)
abituato a lavorare? Certo, puoi cercare qualche espediente per rinviare di qualche anno la
resa dei conti, ma poi essa, inesorabile, arriva. Così è arrivata per l’Italia, quando la crisi del
2007 ha colpito il mondo. Solo che gli altri Paesi da quella crisi sono usciti (con un paio di
rilevanti eccezioni), e infatti il mondo intero cresce; l’Italia in quella crisi c’è invece rimasta
impantanata.
Le opinioni sulle cause della crisi e sulle sue conseguenze sono naturalmente molte e
diverse, ma in quest’opera cercherò di essere realista: troppo spesso si sentono in giro
proposte di cure miracolose, semplici, che incrementerebbero il benessere di tutti se solo ci
decidessimo a realizzarle. È proprio quello che vorremmo sentirci dire, che dalla crisi
possiamo uscire in maniera rapida e indolore, ragion per cui tendiamo tutti ad accettare
questa interpretazione, a crederci, perché ci fa comodo, e ad accusare qualcun altro (mai noi
stessi) per non voler intraprendere queste semplici e rapide terapie risolutive. Purtroppo la
realtà è più complessa, e l’aver scelto sempre, in passato, le terapie meno dolorose ci ha
lasciati in questa situazione. Stavolta, terapie non dolorose proprio non ci sono. Possiamo
continuare a negare il problema, nascondendo la testa sotto la sabbia e accusando qualcun
altro (ancora, non noi stessi), ma stavolta gli espedienti sono finiti e siamo alla resa dei conti.
Che sarà, inevitabilmente, dolorosa; sarà la somma di tutti i piccoli dolori passati che non
abbiamo voluto patire. Soprattutto, stavolta potrebbe non bastare. Almeno, non per noi e per i
nostri figli.
Nessuna speranza, dunque? No, se continuiamo a voler nascondere la testa sotto la
sabbia e a non voler riconoscere la gravità dei problemi, le nostre responsabilità nell’averli
volutamente ignorati e la necessità di terapie drastiche. Se invece apriamo finalmente gli
occhi, superando pregiudizi ideologici e opportunismi personali, se capiamo la reale entità dei
problemi e accettiamo le cure necessarie come il male minore, allora una (piccola) speranza
c’è. Forse non per noi, ma per i nostri figli. E i figli dei nostri figli. Da questo punto di vista il
libro, soprattutto nei suoi capitoli conclusivi, può essere considerato come una sorta di menù
delle cose che si potrebbero fare, con la chiara indicazione dei risultati che si potrebbero
ottenere ma anche l’indicazione dei costi, economici, sociali e politici, che saremmo costretti a
pagare. Poi ognuno deciderà da sé se i sacrifici valgono il risultato.
Quest’opera avrà conseguito il suo obiettivo se farà prendere un po’ più di coscienza a
chi lo leggerà dei problemi del nostro Paese, delle loro cause e della necessità e dolorosità dei
rimedi da adottare. Poiché il libro è destinato a tutti, e non unicamente agli specialisti (anzi,
non è proprio destinato agli specialisti) non userò (quasi) mai il gergo degli economisti e
manterrò sempre la trattazione a un livello elementare, senza per questo evitare l’esposizione
di aspetti problematici e complessi: ritengo infatti che il rigore dell’esposizione possa
tranquillamente essere compatibile con la leggibilità e comprensibilità dell’insieme. Il lettore
valuterà, come sempre, la riuscita dell’intento.
Buona lettura!
4
PARTE PRIMA
CRESCERE NON BASTA, MA SI DEVE.
I. La crescita: come si cresce
5
I.1 Cos’è la crescita economica
Come avremo modo di vedere in dettaglio nei capitoli successivi, uno dei (due)
principali problemi che affliggono l’Italia è quello della bassa (in alcuni anni nulla, in altri
addirittura negativa) crescita economica. Prima di affrontarlo è però opportuno chiarire
brevemente cosa si intende per crescita economica, perché è importante e da cosa dipende. La
locuzione infatti è un po’ ambigua, e non significa esattamente ciò che molti potrebbero
pensare.
In generale, con “crescita economica” si intende un aumento della produzione
complessiva potenziale di un Paese, ossia, come si dice in gergo economico, del PIL potenziale
(perché il PIL è proprio la produzione complessiva - finale, ossia non destinata a essere usata
all’interno di altri processi produttivi - di un Paese). In parole povere, significa che la capacità
produttiva di una nazione, ossia la capacità di generare produzione dalle sue imprese e
reddito per i suoi abitanti, aumenta. Coerentemente con questa definizione, si cresce anche se
aumenta la produttività, ossia se riusciamo a produrre di più impiegando la stessa quantità di
risorse, ossia sostenendo gli stessi costi, in modo da ridurre il costo per unità di prodotto (se
spendendo sempre 100 euro passo da una produzione di 10Kg di gelato a una di 20Kg, il costo
di un Kg di gelato, ossia una unità di prodotto, si riduce passando da 10 euro a 5 euro) o, ma è
la stessa cosa, se possiamo produrre la stessa quantità di prodotto a un costo inferiore. La
crescita riguarda quindi la quantità complessivamente producibile da un Paese, e il reddito
complessivo, ma anche la sua produttività e quindi i suoi costi di produzione. In economia si
dice il lato dell’offerta.
Concentrando l’attenzione sull’incremento della produzione complessiva e del reddito
di un Paese, è importante rilevare che stiamo parlando di aumento della produzione e del
reddito potenziali, ossia del fatto che il Paese potrebbe produrre di più, perché ha predisposto
nuova capacità produttiva per farlo: ha costruito nuove fabbriche, nuovi uffici, nuove
macchine agricole, nuovi robot industriali… poi, se fabbriche e uffici rimangono vuoti e
inoperosi, e i lavoratori restano disoccupati, beh, la capacità produttiva potenziale sarà pure
aumentata, c’è stata cioè crescita, ma la produzione effettiva è rimasta molto al di sotto di
quella potenziale, con le conseguenze negative che si possono immaginare.
Quindi, affinché la produzione e il reddito di un Paese aumentino, è non solo necessario
che aumenti la capacità produttiva potenziale, il PIL potenziale, ma anche che la produzione
effettiva segua l’andamento della capacità produttiva potenziale. Il primo è un problema di
crescita economica, il secondo un problema di gestione della domanda aggregata. Questi
problemi l’Italia li ha entrambi.
Naturalmente il benessere di una collettività non si può misurare solo con la crescita
del PIL, potenziale o effettivo che sia: altre grandezze sono importanti, come la speranza di
vita alla nascita (cioè la durata media della vita), la tutela dell’ambiente, la sanità, l’equità nella
distribuzione del reddito, la percentuale di persone al di sotto della soglia di povertà, e il PIL è
stato infatti spesso criticato perché sarebbe una misura incapace di dar conto di tutti questi
aspetti. È d’altro canto assai raro che Paesi con livelli di PIL molto bassi abbiano alti livelli di
questi altri indicatori. Insomma, le critiche al PIL come misuratore di benessere hanno un
senso, ma sino a un certo punto, anche perché nulla di meglio è stato sinora inventato.
Passiamo ora alle strategie che un Paese può realizzare per far crescere il suo PIL
potenziale. Ci occupiamo quindi della crescita, lasciando al capitolo successivo il tema della
domanda aggregata. Raccomando però al lettore, soprattutto a quello più “politicizzato”, di
non trarre subito conclusioni da questo primo capitolo senza aver letto il secondo: perché,
tipicamente, le strategie per la crescita possono essere considerate “di destra” (facciamo
6
favori agli imprenditori), mentre quelle per sostenere la domanda aggregata “di sinistra”
(facciamo favori ai lavoratori). Entrambi i problemi possono essere contemporaneamente
presenti in un Paese, ed è quindi necessaria una strategia complessiva, ma non è consigliabile
prendere subito una posizione ideologica, tralasciando cioè uno dei due. Bisognerà poi anche
considerare quei problemi, e quelle politiche, nei diversi casi concreti prima di poter
esprimere una opinione ragionata. In ogni caso, se ce la fate, non indignatevi per il primo
capitolo, ma neppure entusiasmatevi: leggete prima il secondo, che giunge a conclusioni
opposte! Poi, faremo una sintesi, e con quella potrete essere d’accordo o no.
I.2 Come si cresce
I.2.1 Investimento in capitale fisico
Dopo aver definito la crescita come aumento del PIL potenziale, non è particolarmente
complicato capire quali siano le strade percorribili per far crescere un Paese: è infatti
necessario che aumenti il numero e/o la dimensione delle sue fabbriche, dei suoi uffici, ecc., o
il numero dei lavoratori; oppure è necessario che, a parità di numero e dimensione, le sue
fabbriche, uffici, ecc., nonché i singoli lavoratori, producano di più, perché è migliorata
l’organizzazione interna della produzione, perché i lavoratori esistenti lavorano di più a parità
di salario o diventano più efficienti, o perché vengono adottate nuove e migliori tecnologie
produttive. O, più brutalmente, perché riduco i costi di produzione pagando meno imposte o
pagando meno i lavoratori.
Iniziamo dall’aumento del numero (e/o della dimensione) di fabbriche, uffici, ecc,
fenomeno studiato in particolare dai modelli neoclassici di crescita, noti anche come modelli di
crescita esogena (e in particolare dal premio Nobel Robert Solow e Trevor Swan nel 1956). In
economia si è soliti riferirsi a fabbriche, uffici, robot industriali, trattori, ma anche zappe e
martelli, come al capitale fisico (anche detto lo stock di capitale fisico) di un Paese. In
economia, infatti, per capitale non si intende un certo ammontare di denaro, bensì oggetti che
sono stati prodotti, che entrano nella produzione di altri beni (come ad esempio fa un trattore
nella produzione agricola), e che sono anche durevoli, ossia durano nel tempo, entrando in più
produzioni (come, appunto e ancora, il trattore). E sempre in Economia si è solito riferirsi
all’incremento dello stock di capitale fisico di un Paese come Investimento in capitale fisico,
anche in questo caso andando lontani dall’uso comune del termine investimento. Si noti che
solo gli imprenditori (privati o pubblici) possono effettuare un investimento così definito.
La prima, più semplice ricetta per incrementare il PIL potenziale sembra quindi facile:
effettuare investimenti in capitale fisico. Ossia, aumentare il numero e/o la dimensione delle
fabbriche, degli uffici, degli impianti produttivi, dei capannoni industriali, delle acciaierie, dei
robot industriali, delle zappe e dei martelli presenti nel Paese, costruendone di nuovi,
ingrandendo quelli esistenti o comprandone altri dall’estero. È abbastanza evidente che, pur
con tempi diversi, tutte le procedure che adottiamo per “crescere” richiedono parecchio
tempo: per questo motivo la crescita è considerata un fenomeno di lungo periodo.
Per chiarire la cosa con un esempio, pensiamo ad una gelateria artigianale. La nostra
gelateria artigianale realizza un investimento in capitale fisico quando acquista una nuova
macchina per produrre il gelato, oppure ne compra una più grande, o aumenta il numero dei
tavolini per i clienti. Tutti questi sono investimenti in capitale fisico. Possiamo dire che la
nostra gelateria, acquistando una macchina per fare il gelato più grande della precedente, o
nuovi tavolini, ha aumentato la sua capacità produttiva potenziale: se tutti gli imprenditori si
comportano così, dopo un po’ di tempo (poco per la gelateria artigianale che compra tavolini,
parecchio se devo costruire una nuova acciaieria) il PIL potenziale, la capacità produttiva
potenziale dell’intera economia aumenta. Stiamo crescendo! Poi naturalmente nulla
7
garantisce che ci siano clienti sufficienti per comprare la maggior quantità di gelati prodotti
dalla nostra gelateria, o per occupare tutti i nuovi tavolini, ma la capacità produttiva
potenziale è cresciuta. E’ il primo passo.
I.2.2 Investimento in capitale umano e in Ricerca e Sviluppo
Come abbiamo visto nella sezione precedente, si può avere crescita economica, ossia
incremento del PIL potenziale di un Paese, non solo se aumenta il numero e/o la dimensione
degli impianti produttivi, ma anche se, a parità di numero e dimensione, le fabbriche, uffici,
ecc., nonché i singoli lavoratori, producono di più, perché è migliorata l’organizzazione interna
della produzione, perché i lavoratori si impegnano di più o diventano più efficienti, o perché
vengono adottate nuove e migliori tecnologie produttive. Sia chiaro, questi incrementi di
produttività possono certamente essere ottenuti aumentando semplicemente lo stock di
capitale, perché un lavoratore con un computer produce di più rispetto a un lavoratore che
deve condividere un computer con uno o più colleghi, ma possono anche essere ottenuti a
parità di stock di capitale fisico. Qui ci occupiamo proprio di questo, ossia dei casi in cui,
sebbene non aumenti lo stock di capitale fisico del Paese, aumenta la produttività di quello
stock, cioè la quantità di beni (e servizi) che può produrre nell’unità di tempo coll’impiego di
un dato numero di lavoratori o, più in generale, coll’impiego di data una quantità di risorse.
Per ottenere questo incremento si può procedere in due modi, tra loro collegati ed
entrambi studiati dai modelli cosiddetti di crescita endogena (e in particolare, tra gli altri, da
Paul Romer nel 1986 e 1990 e da Robert Lucas nel 1988). Innanzitutto, si può migliorare la
formazione dei lavoratori, sia attraverso interventi privati sia attraverso interventi pubblici.
Ad esempio le imprese private possono far frequentare ai loro dipendenti corsi di formazione
e aggiornamento professionale, oppure il Governo può aumentare gli anni di istruzione
obbligatoria o modificare i programmi e gli insegnamenti impartiti dalla scuola pubblica.
Tutto ciò ha un costo, e queste spese rientrano nella categoria degli Investimenti in capitale
umano, perché sono spese sostenute per incrementare, appunto, il capitale umano, ossia la
formazione dei lavoratori, la loro preparazione, la loro bravura. Un lavoratore più “formato”
sarà più bravo, più veloce, più produttivo: produrrà cioè più beni in meno tempo, o beni di
qualità migliore nello stesso tempo. Fare investimenti in capitale umano vuol dire migliorare
la formazione di un lavoratore, rendendolo più produttivo. Non vuol dire, invece, come spesso
si sente dire, incrementare l’occupazione assumendo altri lavoratori. Soprattutto se dobbiamo
modificare l’istruzione di base (ad es. aumentare gli anni di scuola o modificare i programmi)
gli effetti di queste politiche sulla produttività si vedranno solo dopo molti anni.
Il secondo modo per incrementare la produttività riguarda il miglioramento della
tecnologia produttiva impiegata. Imprese private e governo possono infatti effettuare
investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S), ossia finanziare progetti di vario genere destinati a
migliorare le conoscenze scientifiche e tecnologiche del Paese. In genere i privati tendono più
a finanziare la ricerca applicata, ossia a migliorare le tecniche produttive esistenti, mentre il
Governo finanzia la ricerca di base, ossia quella che non ha ritorni immediati in termini di
capacità produttiva ma che, tra tanti progetti che si riveleranno inutili e costosi, può generare
le innovazioni più importanti e radicali (ad es. internet, che è il risultato di un progetto di
ricerca pubblica). Anche in questo caso, e soprattutto per la ricerca di base, i tempi perché le
spese sostenute abbiano un impatto sulla produttività sono molto lunghi.
Riassumendo sin qui: crescita vuol dire incremento del PIL potenziale; per far crescere
il PIL potenziale è necessario fare investimenti in capitale fisico, in capitale umano, in ricerca e
sviluppo. In tutti questi casi occorre parecchio tempo perché gli investimenti abbiano un
impatto sulla capacità produttiva, e resta confermato che la crescita è un fenomeno di lungo
periodo.
8
I.2.3 Politiche demografiche e Riforme istituzionali
Oltre agli investimenti in capitale fisico, umano e in ricerca e sviluppo, per far
aumentare la produzione potenziale di un Paese potremmo anche, semplicemente, far
crescere il numero dei lavoratori (ad esempio favorendo l’immigrazione), e finché si parla di
PIL potenziale ciò ha certamente un impatto positivo (non lo ha necessariamente per il PIL
effettivo: nulla infatti impedisce che quei lavoratori restino disoccupati), perché con più
lavoratori la capacità produttiva potenziale del Paese certamente aumenta. Ma poiché se
raddoppiano contemporaneamente il PIL (la produzione, il reddito) di un Paese e il numero
dei suoi abitanti ciascuno di noi sta come stava prima (se non peggio: congestione delle
strade, inquinamento…), in genere per crescita si intende la crescita del PIL potenziale procapite, ossia ottenuto dividendo il PIL potenziale per il numero di abitanti di un Paese: solo
così la crescita migliora (sempre potenzialmente, s’intende!) il nostro tenore di vita. E per
ottenerla, serve dunque un incremento degli investimenti, non basta aumentare il numero
degli abitanti/lavoratori. Addirittura, un aumento del numero dei lavoratori potrebbe ridurre
il PIL potenziale pro-capite: può ad esempio capitare che se ad esempio il numero dei
lavoratori raddoppia, il PIL cresce solo dell’80%, e quindi il PIL pro-capite si riduce.
Alternativamente, potremmo realizzare riforme tali da indurre gli abitanti del nostro
Paese a lavorare di più. Potremmo ad esempio aumentare l’orario di lavoro, eliminare i sussidi
di disoccupazione in modo che i lavoratori disoccupati debbano per forza di cose lavorare e
non possano anche scegliere di vivere con il sussidio, eliminare i sindacati che tendono a
ridurre la lunghezza della giornata lavorativa… (avevo anticipato che le politiche per la
crescita tendono a essere di destra!). Oppure, poiché non tutti gli abitanti di un Paese fanno
parte della forza lavoro (si pensi alle casalinghe), ed anzi quasi la metà (in Italia) non si offre
sul mercato del lavoro, realizzare riforme tali da indurre una quantità maggiore di coloro i
quali scelgono di rimanere disoccupati a lavorare (nel caso delle casalinghe, si potrebbero
creare asili nido gratuiti, o lo Stato potrebbe incentivare economicamente l’assunzione delle
colf, rendendo più facile per le casalinghe cercare una occupazione). Si tratta delle cosiddette
Riforme Istituzionali, in particolare le riforme che interessano le istituzioni del mercato del
lavoro. In economia, infatti, per istituzioni non si intendono cose come il Parlamento o la
Presidenza della Repubblica, bensì semplicemente quell’insieme di regole scritte e non scritte,
anche culturali, che determinano il comportamento dei soggetti: le istituzioni del mercato del
lavoro sono, appunto, regole scritte e non scritte che hanno un impatto sul comportamento
dei soggetti nel mercato del lavoro. L’idea in questo caso è modificare queste istituzioni per
indurre i lavoratori a lavorare di più.
Oltre alle riforme che inducono i lavoratori esistenti a lavorare di più, si possono
realizzare anche riforme istituzionali che inducano gli imprenditori ad investire di più: ridurre
i controlli, ridurre le imposte, rendere più snella la burocrazia, ridurre gli obblighi nei
confronti dei lavoratori. Si tratta però di interventi per favorire gli investimenti, che quindi
ricadono nell’analisi già sviluppata nei due paragrafi precedenti.
Le riforme istituzionali sono quindi un’altra strada per incrementare la capacità
produttiva potenziale di un Paese ma, come risulta già evidente dalla loro mera enunciazione,
molte di loro creano rilevanti problemi di tipo politico; inoltre, se possono avere un senso nel
lungo periodo, ossia con riferimento alla crescita, creano comunque problemi nel breve, con
riferimento alla domanda aggregata. Ma come sappiamo per parlare di domanda aggregata
dobbiamo aspettare il capitolo due…
I.2.4 Chi può investire?
È appena il caso di ricordare che non è assolutamente importante l’origine
dell’investimento, quanto la sua destinazione. Stiamo infatti parlando di accrescere la capacità
produttiva del Paese, ragion per cui è irrilevante chi lo fa, alla fine lo stock di capitale (fisico,
9
umano, tecnologico) del nostro Paese sarà comunque aumentato e la produzione potenziale
sarà cresciuta. Ciò nonostante, il tipo di investimenti è in genere legato alla tipologia
dell’investitore, con le imprese più interessate a una resa immediata e i Governi più
interessati a interventi di maggior respiro, che avranno un impatto solo a lunghissimo
termine.
È però importante rilevare che, se l’investimento è effettuato da imprese private, la
collettività non dovrà partecipare alle spese sostenute per realizzarlo, sebbene questi
investimenti facciano crescere la capacità produttiva potenziale del Paese, generando cioè un
effetto positivo per tutti (più produzione, più occupazione, più reddito). È chiaro però che i
privati investiranno solo se riterranno di poter realizzare un profitto, nel senso che si
aspettano di guadagnare: confrontano costi e ricavi attesi e investono solo se i ricavi attesi
sono maggiori dei costi. Al contrario il Governo può realizzare investimenti anche nel solo
interesse della collettività finanziandoli però a spese della collettività, con l’imposizione
fiscale o l’indebitamento pubblico.
In situazioni particolarmente critiche, soprattutto nel caso di Paesi molto poveri dove
né gli imprenditori nazionali né il Governo sono in grado di finanziare rilevanti investimenti, o
nel caso di Paesi (e imprenditori) molto indebitati, può essere utile che siano gli imprenditori
stranieri a realizzare gli investimenti. Si tratta dei cosiddetti Investimenti Diretti Esteri (IDE),
con i quali un’impresa straniera costruisce impianti nel nostro Paese, assume e forma i
lavoratori che le servono, introduce nuovi criteri produttivi e nuove tecnologie. Anche in
questo caso l’impresa estera che investe ha una finalità di profitto, non viene certo per farci un
favore, vuole cioè guadagnarci, ma se ben gestito l’investimento diretto estero è un ottimo
affare per il Paese ricevente. Gli IDE infatti non solo generano un incremento nello stock di
capitale fisico del Paese (e sono quindi coerenti con i modelli di crescita esogena di Solow e
Swan), ma incrementano anche il livello tecnologico del Paese ricevente, con l’introduzione di
nuove tecnologie produttive, così come il capitale umano, con la formazione dei lavoratori (e
sono quindi coerenti con i modelli di crescita endogena di Romer e Lucas). Se infatti
consideriamo una impresa che realizza un nuovo impianto produttivo con nuove tecnologie in
un Paese, o in una zona del Paese, che ha un basso livello di istruzione/formazione, sarà
costretta ad istituire dei corsi di formazione per i lavoratori; inoltre, i lavoratori “impareranno
facendo” (learning by doing), nel senso che man mano che diventano pratici di una attività
lavorativa la loro efficienza migliora. In seguito, quegli stessi lavoratori, ormai formati e molto
più produttivi di prima, potranno essere impiegati in altre imprese o mettersi in proprio,
accrescendo la produttività del Paese. Gli IDE tendono dunque a generare quelli che sono noti
come spillover, effetti esterni di accrescimento della produttività e della competitività. La Cina
è diventata la Cina anche grazie agli IDE: non aveva tecnologia, né lavoratori formati, né
fabbriche all’avanguardia, se le è fatte costruire dagli stranieri. È il caso di ricordare che la
produzione in Cina delle aziende straniere è produzione cinese, i lavoratori assunti sono
cinesi, le eventuali esportazioni sono cinesi, e spesso anche i profitti restano in Cina e non
rientrano nel Paese di origine degli IDE (in genere, per motivi fiscali). Nulla quindi distingue
questa attività di investimento da quella di un privato residente, se non l’alto livello di
tecnologia. E non pensiate che per attrarre gli imprenditori servano bassi salari e
sfruttamento dei lavoratori: negli Stati Uniti anche la Silicon Valley attira molti investimenti
esteri, che cercano un ambiente favorevole per produrre. Poi, certo, c’è l’ideologia: “le imprese
straniere vengono per sfruttarci”. Ma, appunto, è solo ideologia: se non abbiamo il denaro o la
tecnologia necessari, l’alternativa è incentivare gli IDE in ingresso o rassegnarci a decrescere.
La più compiuta teoria che si è occupata di Investimenti Diretti Esteri è il cosiddetto
approccio OLI (Ownership, Location, Internalization: Proprietà, Localizzazione,
Internalizzazione), dovuta a John Dunning (1977). Poiché una multinazionale è una impresa
che possiede impianti produttivi in più di un Paese, per definizione gli IDE sono realizzati
10
dalle multinazionali, e dunque studiare gli IDE vuol dire studiare le multinazionali. Secondo
l’approccio di Dunning la scelta di una impresa di diventare una multinazionale realizzando
un investimento diretto estero e dunque costruendo un proprio impianto in un altro Paese,
invece di far produrre su licenza il proprio prodotto da una impresa estera, non dipende solo
dai vantaggi che il territorio di destinazione fornisce in termini di costo del lavoro, vicinanza
ai mercati di sbocco, imposizione fiscale, fonti di materie prime, ecc. Certo, questi elementi
sono importanti, e sono inclusi da Dunning nella componente Location, ma potrebbero essere
sfruttati benissimo anche accordandosi con una impresa locale per farla produrre su licenza.
L’elemento cruciale risulta invece la possibilità di sfruttare il vantaggio di Proprietà
(Ownership), ossia il fatto di disporre di una tecnologia produttiva, un assetto organizzativo,
un marchio, ecc., che può essere replicato a costo ridotto o senza costi in più unità produttive
locali, senza correre il rischio che esso sia espropriato. Infatti far produrre su licenzia espone
a una serie di rischi, principalmente che il prodotto, l’assetto organizzativo o la tecnologia
produttiva vengano copiati dall’impresa locale o dai suoi lavoratori. Ragion per cui quando
questo rischio è elevato appare preferibile la scelta di produrre in una propria unità
produttiva locale (internalization), mentre se il rischio è basso si può anche far produrre su
licenza.
In sostanza, le ragioni che spingono le multinazionali a realizzare Investimenti Diretti
Esteri non sono da ricercare solo nel costo del lavoro, nel regime fiscale favorevole o nella
vicinanza ai mercati, ma in un insieme più ampio di motivazioni che arrivano a includere la
tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
I.3 E se decrescessimo?
Recentemente ha acquistato parecchia importanza, soprattutto nei mezzi di
comunicazione di massa, la teoria della decrescita. Si tratta di un approccio eterogeneo, nato
essenzialmente in ambito filosofico, che a partire dalla constatazione (corretta) che il PIL
sarebbe un cattivo indicatore del benessere della collettività, e che dunque un aumento del
PIL non implica necessariamente un aumento del benessere, giunge alla conclusione (non
corretta) che una sua riduzione, accompagnata tra le altre cose da una più equa distribuzione
del reddito e da una migliore gestione delle tematiche ambientali, incrementerebbe il
benessere. A partire da queste basi viene quindi criticata l’impostazione consumistica attuale,
fondata su un aumento indiscriminato dei consumi, e viene proposto un approccio più
“intimista”, fondato su maggiore morigeratezza, su consumi che devono essere limitati a quelli
indispensabili, su un ritorno alla natura. Non dovremmo dunque perseguire un incremento
meramente quantitativo delle grandezze a nostra disposizione, ma un loro incremento
qualitativo; non devono essere valori come produttività e reddito gli elementi più importanti,
ma concetti di benessere più ampio che considerino anche i rapporti sociali e la tipologia di
consumi come indicatori di benessere. Non quantità, ma qualità.
L’approccio della decrescita, è bene chiarirlo subito, non propone certo la recessione
come soluzione dei problemi, poiché la vede come una riduzione di reddito incontrollata e
non strutturalmente capace di salvaguardare i consumi necessari rispetto a quelli voluttuari e,
soprattutto, certamente incapace di dar luogo a minori diseguaglianze sociali e minor impatto
ambientale, che sono altri due capisaldi della teoria. Ciò nonostante se si smette di
considerare il PIL come un indicatore di benessere, la sua riduzione non sarebbe in geenrale
un grave problema, perché non sarebbe necessariamente associata ad una riduzione di
benessere.
L’obiettivo politico della teoria della decrescita sarebbe l’abbandono dell’enfasi posta
sulla crescita del PIL e della produttività, incentivando una riduzione volontaria dei consumi,
11
soprattutto di quelli considerati voluttuari, riducendo l’orario di lavoro e incrementando il
tempo libero e la qualità della vita.
Non è sorprendente che sostanzialmente nessun economista sia tra i teorici della
decrescita. Si tratta infatti di un interessante dibattito filosofico che ha però poco a che fare
con la scienza economica, e soprattutto poco a che fare con tutti i principali risultati del
moderno approccio teorico che va sotto il nome di “economia della felicità”, happiness
economics. Gli economisti sono d’altro canto perfettamente consci della debolezza del PIL
come misuratore di felicità: quando il premio Nobel Simon Kuznets contribuì, negli anni ’30,
alla creazione del PIL, intendeva solo trovare un modo per scoprire se la produzione di un
Paese stava aumentando o diminuendo, senza dover ricorrere, com’era stato sino ad allora, a
misure indirette come il volume dei trasporti ferroviari, ecc. Lui stesso era assai scettico sulla
possibilità di utilizzarlo come indicatore di benessere. Nonostante ciò: 1) allo stato attuale
non esiste un indicatore migliore del PIL per misurare il benessere, perché la maggior parte
delle altre grandezze (non tutte, ma la maggior parte) sono correlate al PIL; 2) c’è enorme
evidenza empirica che quando aumenta il reddito (e il PIL) la felicità, il benessere, prima
aumenta poi smette di aumentare e si stabilizza a un livello costante, il che appunto
costituisce il “paradosso della felicità”, o “paradosso di Easterlin”, dal nome dell’autore che più
lo ha studiato, ma questo non vuol certo dire che se si riduce il reddito la felicità aumenta,
tutt’altro, perché è comunque sempre vero che i più ricchi non sono mai meno felici dei più
poveri; 3) c’è ulteriore evidenza, stavolta sia empirica sia teorica (si vedano i lavori del premio
Nobel Daniel Kahneman), dell’esistenza di effetti di dotazione, ossia della circostanza che un
soggetto attribuisce un valore maggiore a un oggetto che possiede rispetto a quanto sarebbe
disposto a pagare per acquistarlo se non lo possedesse, il che implica che ridurre il proprio
tenore di vita finisce necessariamente per avere effetti psicologici dannosi; 4) altrettanta
evidenza empirica e teorica si trova per la cosiddetta “avversione alla perdita” (sempre
Kahneman), ossia per la circostanza che i soggetti associano una riduzione di benessere molto
maggiore alla perdita di una certa somma di denaro rispetto al guadagno di benessere
associato al guadagno della stessa somma, dal che deriva che il danno psicologico causato da
una riduzione del reddito sarebbe rilevante anche se (cosa che non è) la felicità si riducesse
all’aumentare del reddito; 5) la disoccupazione ha un impatto psicologico negativo sui
soggetti anche quando si viene interamente sussidiati con un importo uguale al salario perso;
6) chi decide quali siano i consumi “virtuosi” da eliminare e quali quelli “non virtuosi” da
conservare? 7) infine, ma potremmo continuare, se si diffonde un atteggiamento
parsimonioso nella collettività, non si pone un problema di crescita ma di domanda aggregata,
nel senso che i minori consumi implicano minore domanda aggregata e, almeno nel breve
periodo, disoccupazione e licenziamenti: se molti cominciano a farsi i maglioncini da soli, i
lavoratori (italiani, indiani o pachistani che siano) che producono maglioncini nelle imprese
tessili vengono licenziati, anche se loro non avevano nessuna intenzione di decrescere (e il
danno che subiscono, per i punti precedenti, è assai rilevante).
In sostanza, la teoria della decrescita non tiene conto della maggior parte dei progressi
ottenuti dall’economia della felicità negli ultimi decenni, economia della felicità che è
certamente critica nei confronti della ricchezza come determinante del benessere, ma non
arriva mai a trovare alcune relazione negativa tra ricchezza e felicità: nel senso che migliorare
la distribuzione del reddito, l’impatto ambientale delle produzioni, l’equità, sono obiettivi il
cui perseguimento è prioritario, ma contestualmente a un aumento del reddito, non certo a
una sua riduzione. E la diffusione di simili idee, qualora messe in pratica, avrebbero la
spiacevole conseguenza di diffondere anche ulteriore recessione a causa del crollo di
domanda aggregata che generano.
I.4 Perché crescere non basta?
12
Come abbiamo già accennato nel capitolo precedente, crescere non basta. Potrebbe
infatti benissimo accadere che un Paese abbia fatto tutti gli investimenti necessari ad
incrementare il suo PIL potenziale, ma poi si ritrovi con tutti quei bei macchinari nuovi
inutilizzati, la forza lavoro disoccupata, l’economia depressa. Perché? Perché la crescita è
crescita del PIL potenziale, ossia della capacità produttiva disponibile, della quantità di beni
che potrebbe essere prodotta, ma non implica necessariamente che gli imprenditori vogliano
produrre effettivamente tutti quei beni: li produrranno, infatti, solo se credono di riuscire a
venderli. Se la mia gelateria artigianale, dopo tutti i miei bravi investimenti, ha una capacità
produttiva potenziale di 10.000 gelati al giorno, ma i miei clienti mi domandano solo 500
gelati, beh, io avrò anche una capacità produttiva stratosferica, ma produrrò solo i gelati che
mi vengono domandati dalla clientela, cioè 500. Per il resto del tempo i miei begli impianti
rimarranno inutilizzati.
Il problema cruciale è proprio qui: la crescita del PIL potenziale è il prerequisito perché
aumenti anche la produzione effettiva e il reddito, ma non è sufficiente: se voglio impiegare
tutta la capacità produttiva installata devo avere una domanda almeno equivalente alla mia
capacità produttiva, altrimenti quest’ultima rimarrà in parte inutilizzata.
Questo è appunto il ruolo della domanda aggregata, e soprattutto delle politiche per la
gestione della domanda aggregata: far sì che la domanda di beni sia tale da permettere il pieno
utilizzo della capacità produttiva installata e la piena occupazione di tutti i lavoratori.
II. La domanda aggregata: come si incrementa?
13
II.1 Cos’è la Domanda Aggregata
Qualunque sia il livello della capacità produttiva installata, gli imprenditori
produrranno solo quello che pensano verrà loro domandato, e se si accorgono di essersi
sbagliati, correggeranno subito i loro comportamenti, producendo di più o di meno a seconda
del fatto che si sono accorti di aver prodotto troppo poco o troppo. Se invece si accorgono che
la loro capacità produttiva potenziale è insufficiente perché la domanda è molto più alta di
quello che si aspettavano, e molto più alta di quello che i loro impianti possono produrre,
faranno investimenti, compreranno cioè nuove macchine, e allora saremo nel regno della
crescita. Purtroppo, però, non è questo il problema del nostro Paese: la capacità produttiva è
infatti bassa, e si sta pure riducendo, ma la domanda è ancora più bassa.
Se per un gelataio la domanda rilevante, per i ragionamenti appena fatti, è la domanda
di gelati, per un venditore di souvenir quella di souvenir, e per un’impresa automobilistica
quella di automobili, per il sistema economico nel suo complesso conta la domanda totale, che
altro non è se non la somma in valore (in soldi) di tutte le domande rivolte alle singole
imprese (di gelati, souvenir, automobili, ecc.). Per semplicità può essere utile ricomprendere
le singole voci di questa domanda in ampi aggregati omogenei, definiti a partire dalle
categorie di acquirenti dei beni e dei servizi: semplificando un po’, la domanda di beni e
servizi è esercitata dai consumatori privati, che domandano beni e servizi finali di consumo;
dalle imprese, che domandano beni di consumo intermedi e servizi intermedi, ossia necessari
per il processo di produzione (elettricità per far andare le mie macchine che producono gelati,
latte per produrre i gelati, cioccolata, nocciole, pistacchi di Bronte, il servizio del
commercialista…) e beni di investimento (nuove macchine per fare il gelato); dal Governo,
che domanda sia beni di consumo e servizi intermedi sia beni di investimento; dagli stranieri.
Considerando infine solo la domanda di beni e servizi finali, ossia sottraendo dalla domanda
totale la domanda di beni e servizi intermedi, otteniamo la domanda aggregata.
II.2 Come si stimola la domanda aggregata
Se c’è un problema con la domanda aggregata, ossia se è troppo bassa, e gli
imprenditori producono poco e assumono pochi lavoratori, è possibile operare su una delle
diverse categorie di acquirenti affinché aumentino i loro acquisti. Ricordando sempre che se
non hanno un reddito sufficiente per farlo è cosa buona e giusta finanziare gli acquisti con
l’indebitamento. In questo modo infatti avremmo una spesa aggiuntiva non limitata dal
reddito a disposizione. E tale spesa avrebbe un effetto moltiplicativo sul reddito: ad esempio il
Governo (ma vale anche per i privati) spendendo più di quanto incassa, ossia appunto
indebitandosi, domanda maggiori quantità di beni e servizi alle imprese private, le quali a loro
volta, in presenza di una domanda ampliata, aumentano la produzione. Ma per produrre di più
devono assumere, e retribuire, un numero maggiore di lavoratori, che ottengono quindi un
reddito che non avrebbero ricevuto in assenza della spesa del Governo, e spendono a loro
volta questo reddito aggiuntivo domandando beni e servizi alle imprese private, le quali
quindi devono ancora aumentare occupazione e produzione per soddisfare la maggior
domanda; e così via.
Tutta questa analisi, e in particolare il principio dell’effetto moltiplicativo che ha un
incremento di spesa sul reddito, è ispirata all’opera del più importante (e controverso)
economista del XX secolo, John Maynard Keynes, che con la sua opera del 1936, La Teoria
Generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, ha rivoluzionato la teoria economica
contemporanea.
14
Ma, concretamente, in presenza di una crisi economica su quali categorie di operatori
possiamo agire per indurli a incrementare la propria domanda?
II.2.1 I Consumi
La prima categoria di operatori sulla quale possiamo operare per incrementare la
domanda aggregata è costituita dai consumatori. Il problema è però che i consumatori
acquisteranno più beni solo se il loro reddito aumenta, e il loro reddito aumenta solo se
l’economia va bene e tutti hanno un impiego (e un reddito); se invece l’economia va male, e
gran parte della forza lavoro non percepisce un salario, o percepisce solo un sussidio di
disoccupazione di pochi euro, non possiamo contare molto su di loro come acquirenti delle
nostre produzioni. Insomma, il consumo è, come si dice, prociclico: segue il ciclo economico,
l’andamento dell’economia. Se l’economia va bene, il consumo aumenta; se va male, si riduce.
Quindi, quando l’economia va male non solo il consumo non ci aiuta, ma ci tira giù. Operare su
questa variabile in recessione è quindi difficile, a meno che qualcuno (il Governo?) non regali
ai consumatori parecchi soldi da spendere, oppure che sia in qualche modo possibile indurli a
indebitarsi massicciamente per consumare: due cose che, come vedremo, sono state entrambe
tentate, con diverso successo.
II.2.2 I Consumi intermedi e gli Investimenti
La seconda categoria di possibili acquirenti è costituita dagli imprenditori che
acquistano beni e servizi intermedi e beni capitale per le loro imprese. L’obiettivo degli
imprenditori, lo sappiamo, è il profitto, ossia ottenere, con la loro attività, una differenza
positiva tra quanto incassano (i ricavi) e quanto spendono per finanziare la produzione (i
costi). Poiché i ricavi attesi crescono se aumenta la quantità di beni che si aspettano di
vendere, anche qui abbiamo un problema simile al precedente, anzi anche più grave. Infatti, se
l’economia va male, e soprattutto se gli imprenditori pensano che continuerà ad andar male,
compreranno pochi beni di consumo intermedi perché vorranno produrre pochi beni. E se
pensano che continuerà ad andar male anche in un futuro più remoto, certamente non
compreranno nuova capacità produttiva, nuove macchine, nuovi impianti, ossia non
investiranno. A meno che non abbiano per qualche motivo una visione meravigliosa su come
andrà il futuro (voi ce l’avete, in Italia, una visione meravigliosa di come andrà il futuro?),
anche tutte queste spese sono procicliche. Inutili, per il nostro problema. Addirittura, anche se
il Governo regala loro denaro per realizzare gli investimenti è assai difficile che gli
imprenditori lo usino, ritenendo che la eventuale maggiore capacità produttiva installata
resterebbe inutilizzata per carenza di domanda. Così come è difficile che, se la crisi è
profonda, gli imprenditori siano particolarmente influenzati dalle politiche della Banca
Centrale che rende più facile l’indebitamento, chiedendo ad esempio meno garanzie, o
abbassando il tasso di interesse, ossia il costo del denaro per le banche (e, indirettamente, per
gli imprenditori: se le banche ordinarie possono prendere a prestito dalla banca Centrale a
poco interesse, presteranno agli imprenditori a poco interesse). È infatti probabile che la
riduzione di quelle che per le imprese sono costi non sia sufficiente se i ricavi attesi si
riducono ancor di più. Se invece l’economia non va tanto male, una riduzione del tasso di
interesse può incentivare gli imprenditori a fare investimenti, perché magari i costi scendono
più dei ricavi attesi e dunque i profitti attesi salgono. Ma se va male male, non c’è riduzione
dell’interesse che tenga.
II.2.3 La Spesa Pubblica
La terza categoria di potenziali acquirenti è un solo soggetto, il Governo, che realizza la
spesa pubblica. Il Governo può spender denaro traendolo da due fonti: le imposte e tasse che
incassa, e i prestiti che contrae. Poiché le imposte e tasse sono anch’esse procicliche (il loro
15
volume complessivo aumenta quando l’economia va bene e tutti dichiariamo al fisco un sacco
di soldi, si riduce quando l’economia va male, le imprese falliscono, i lavoratori finiscono
licenziati e non pagano le imposte), da qui ricaviamo poco. Più interessante e utile la seconda
strada: la spesa che il Governo effettua in deficit, ossia quando ha entrate inferiori alle uscite,
e quindi non ha denaro da spendere, ma se lo fa prestare, indebitandosi. Si parla in questo
caso di politica fiscale espansiva, o politica di bilancio espansiva, e non ci si riferisce alle
imposte o alle tasse, ma alla spesa pubblica: “politica fiscale” è una cattiva traduzione del
termine inglese fiscal policy, che indica generalmente tutte le politiche che incrementano la
spesa del Governo o riducono le imposte). A differenza di consumatori e imprenditori, che
devono essere convinti a spendere di più indebitandosi, e in tempi di crisi convincerli è
parecchio difficile, il Governo si convince da solo (tanto mica sono i politici poi che devono
restituire i prestiti…). Dal punto di vista pratico, per procurarsi il denaro il Governo emette
titoli del debito pubblico, ossia particolari obbligazioni pubbliche: chi le acquista presta
denaro allo Stato il quale dopo un po’ glielo restituirà (a seconda della durata del titolo, tra sei
mesi, un anno, due anni… anche trent’anni, in alcuni casi), e riceve ogni anno dal Governo un
interesse su quel prestito. Esempi di titoli del debito pubblico sono i BOT (a breve termine), i
CCT, i BTP (a lungo termine). Con questo denaro il Governo può incrementare la spesa
pubblica. Naturalmente, maggiore è il deficit di bilancio dello Stato, ossia le spese fatte
prendendo denaro a prestito, maggiore è la crescita della domanda aggregata ma anche del
debito pubblico. Un debito che, almeno in teoria, prima o poi il Governo dovrebbe restituire.
II.2.4 Le Esportazioni (nette)
L’ultima categoria di acquirenti che possiamo influenzare in qualche modo sono gli
stranieri, che acquistano le nostre esportazioni, ossia le merci che vendiamo all’estero. Le cose
sono in realtà un po’ più complicate, perché da ciò che vendiamo all’estero dovremmo
sottrarre ciò che dall’estero compriamo per vedere l’impatto sulla domanda aggregata
italiana, ma per ora tralasciamo questo aspetto (che però è importante: l’Italia, ad esempio,
compra all’estero grandi quantità di petrolio e gas naturale). Ma insomma, non andiamo molto
lontano dalla realtà concentrandoci solo sulle esportazioni. Se volete essere sofisticati, usate la
locuzione “esportazioni nette” (esportazioni meno importazioni) al posto di “esportazioni”:
nulla di sostanziale cambia e fate un’ottima figura! Come fare per far crescere la domanda di
merci del nostro Paese fatta dagli stranieri? In vari modi. Riducendone il prezzo,
aumentandone la qualità, concentrandoci sulla produzione di beni che nessun altro produce.
Poiché aumentare la qualità dei beni o produrre beni che nessuno produce è complicato e
richiede tempo, oltre che profonde trasformazioni del sistema produttivo, ricadendo quindi
nelle problematiche relative alla crescita, la cosa più rapida e facile è ridurne il prezzo. E per
ridurne il prezzo o i lavoratori si accontentano di un salario più basso, o gli imprenditori di
meno profitto, o la produttività del lavoro aumenta (ogni lavoratore produce di più) a parità
di salario e di profitto, o il Governo fa pagare meno tasse e contributi alle imprese. Oppure, a
parità di prezzo nella nostra valuta, gli stranieri riescono a comprare le merci spendendo di
meno nella loro valuta: questo accade in presenza di un deprezzamento del tasso di cambio.
Servono sempre 20 euro per comprare un chilo di gelato, ma mentre prima il tasso di cambio
tra euro e dollaro era uno, ossia serviva un dollaro per comprare un euro, e dunque a un
americano un chilo di gelato italiano costava 20 dollari, perché con 20 dollari comprava i 20
euro necessari per acquistare il chilo di gelato, adesso se il tasso di cambio è sceso a 0,5, come
si dice in gergo si è “deprezzato”, serve cioè mezzo dollaro per comprare un euro, un
americano può comprare un chilo di gelato italiano (che sempre 20 euro costa) con soli 10
dollari, perché con 10 dollari compra i 20 euro necessari per comprare il chilo di gelato. Come
conseguenza, tenderà a comprarne di più, magari riducendo la domanda di gelato inglese o
16
turco. Un deprezzamento del cambio, dunque, incrementa le nostre esportazioni e fa quindi
crescere la nostra domanda aggregata.
Può forse essere importante chiarire il ruolo cruciale che hanno le esportazioni per la
stessa sopravvivenza di un Paese. Ci sono infatti Paesi, anche nell’Eurozona, che per il proprio
sostentamento di base (cibo, energia) devono importare ingenti quantità di beni e servizi
dall’estero. Ora, se questi Paesi hanno qualcosa da offrire in cambio, ossia producono beni (o
hanno risorse) desiderati dalle altre nazioni, bene, importeranno ciò che gli serve esportando
ciò che serve agli altri. Ma se non hanno nulla di desiderabile da offrire, se non producono
niente da esportare, o se quello che producono è di bassa qualità o troppo costoso, non
potranno cederlo in cambio di ciò che serve loro per il sostentamento e sono destinati alla
miseria. È il caso, ad esempio, della Grecia: produce poco o nulla di beni esportabili, mentre le
sue importazioni sono ingenti ed essenziali per la sopravvivenza e il benessere dei residenti.
Finché sarà così, dentro o fuori l’Eurozona, il Paese è destinato alla povertà. E non si pensi che
il problema si possa risolvere dando moneta in cambio delle importazioni: un non residente
accetterà moneta greca in cambio solo se sa che con quella moneta potrà comprare qualcosa
in Grecia; se sa di non poter comprare nulla di utile, perché la Grecia non produce nulla di
utile, non la accetterà in pagamento, o le darà un valore prossimo allo zero. Naturalmente, se
la moneta che la Grecia dà in cambio sono euro, le cose cambiano, perché con gli euro posso
comprare beni anche in Germania, Francia, ecc., quindi li accetto più volentieri.
17
III Quindi: crescere non basta, ma si deve.
Alla luce di quanto abbiano visto sinora, un Governo accorto dovrebbe dunque
progettare una strategia capace non solo di creare i presupposti perché il Paese cresca, ma
anche fare in modo che la capacità produttiva così generata sia effettivamente utilizzata, ossia
scegliere politiche in grado di generare una domanda aggregata sufficiente ad utilizzare tutta
la maggiore capacità produttiva disponibile. Ad occupare, soprattutto, tutti i lavoratori che
desiderano lavorare al salario corrente.
Purtroppo, porre in essere le giuste strategie non è semplicissimo, e in alcuni casi è
anche politicamente problematico. Infatti (sebbene con una rilevante eccezione) le manovre
volte a sostenere la crescita di lungo periodo sono in genere poco utili per ottenere consenso
elettorale, perché i loro effetti benefici si vedranno solo tra qualche anno, dopo le prossime
elezioni: non a caso vengono considerate politiche di lungo periodo, mentre quelle volte a
sostenere la domanda aggregata sono considerate di breve periodo. Una circostanza che, per
motivi intuibili, rende i governi poco incentivati a realizzarle. Inoltre, spesso le politiche per la
crescita sono anche fortemente avversate da una parte del corpo elettorale: perché ad
esempio mirano ad ottenere maggior efficienza dall’apparato produttivo implementando
misure che vanno contro l’interesse di breve periodo dei lavoratori, come richiedere un
incremento dell’orario lavorativo o minori sussidi di disoccupazione. Succede così che spesso i
Governi pongono in essere solo strategie di breve periodo, cercando di sostenere la domanda
aggregata. Il problema è che, a forza di perseguire strategie di solo breve periodo per motivi
essenzialmente elettorali, il Paese smette di crescere. Poi possiamo spingere quanto vogliamo
sulla domanda aggregata, ma se la produzione potenziale non cresce anche la produzione
reale finirà col non crescere. Inoltre, c’è un preciso legame tra crescita e domanda aggregata:
come sappiamo crescere vuole anche (soprattutto) dire incrementare la produttività e ridurre
i costi di produzione investendo in capitale fisico, ricerca e sviluppo, formazione dei
lavoratori; ciò rende, nel lungo periodo, i miei prodotti di qualità migliore e meno costosi,
ossia maggiormente domandati dai residenti e dai non residenti. In sostanza, gli effetti della
crescita sono anche di stimolo alla domanda aggregata. Se invece non investo e non cresco, i
miei prodotti diventeranno di qualità peggiore e più cari rispetto a quelli dei miei concorrenti,
e non saranno domandati né dai residenti né dai non residenti, deprimendo la domanda
aggregata.
Quindi le due politiche andrebbero intraprese assieme, ma spesso i Governi
prediligono le politiche di breve periodo ed evitano quelle di lungo. L’unica eccezione,
ragionevole e importante, riguarda gli investimenti pubblici. Un Governo che effettua
investimenti pubblici per incrementare la capacità produttiva del Paese, ad esempio nei
settori della formazione, della ricerca e sviluppo, dell’istruzione, del miglioramento
tecnologico, delle infrastrutture, da un lato sostiene la domanda aggregata, quindi realizza
politiche valide per il breve periodo, dall’altro sostiene la crescita potenziale futura del Paese,
e quindi realizza politiche di lungo periodo. Il problema, naturalmente, è che per farsi amico
l’elettore è meglio garantirgli un posto pubblico dove lavora poco e guadagna tanto, oppure un
sussidio pubblico dove lavora nulla e guadagna abbastanza, piuttosto che fare investimenti
che nel breve periodo hanno solo effetti indiretti su di lui, perché lo fanno lavorare di più per
produrre di più e guadagnare di più. Quindi se i fondi disponibili sono scarsi, la maggioranza
parlamentare debole e la classe politica poco lungimirante, la strada peggiore vince spesso siu
quella migliore.
Nella realtà, pochi sono stati infatti i Paesi sviluppati che hanno fatto scelte valide
(anche) per il lungo periodo. La maggior parte dei Paesi, una volta raggiunto il benessere, si è
18
adagiata, si è accontentata della capacità produttiva potenziale installata e ha mirato, in vari
modi, non a farla crescere ma a portare la domanda aggregata al livello necessario per
impiegare tutta la capacità produttiva esistente. Con la conseguenza che altri Paesi, più
affamati, più disposti a sacrificare il benessere presente (che non avevano) per il benessere
futuro, hanno sorpassato i “vecchi” Paesi sviluppati.
Ma cerchiamo adesso di individuare quali siano state le scelte poste concretamente in
essere dai diversi Paesi, e dall’Italia, nell’affrontare il complicato rapporto tra crescita e
gestione della domanda aggregata.
19
PARTE SECONDA
COMBATTENDO LA BASSA DOMANDA: L’ECONOMIA PRIMA DELLA
CRISI
IV. Bolle, debiti e NeoMercantilismo
20
IV.1 Diverse strategie per sostenere la domanda aggregata
Come sappiamo, diverse sono le variabili sulle quali si può intervenire per sostenere la
domanda aggregata. In particolare, si può puntare sul sostegno alle esportazioni nette, sulla
spesa privata per consumi e investimenti, o sulla spesa pubblica. Le ultime due strategie
implicano indebitamento, privato o pubblico, se vogliono essere realmente efficaci.
Questo in generale. Con riferimento all’Europa, l’evoluzione della situazione rende per
alcuni Paesi le scelte quasi obbligate.
Prima dell’introduzione dell’Euro i principali Paesi europei erano in un regime a cambi
fissi, il Sistema Monetario Europeo. In un regime di cambi fissi il Paese che ha il tasso di
inflazione più basso, ossia quello che ha una crescita dei prezzi dei beni che produce inferiore
rispetto a quella degli altri Paesi, accumula progressivamente un vantaggio competitivo:
anche una piccola differenza annuale nel tasso di crescita dei prezzi, già su un intervallo
temporale relativamente breve, implica infatti un vantaggio competitivo difficilmente
colmabile. Nel caso dell’Europa, ad esempio, il Paese con il tasso di inflazione più basso è
sempre stato la Germania, che ha orientato la sua politica monetaria in modo da combattere
l’inflazione, ragion per cui un regime a cambi fissi conveniva sostanzialmente ai tedeschi.
Per chiarire questo concetto, ipotizziamo che le biciclette italiane costino 100 lire, le
biciclette tedesche 100 marchi, e il tasso di cambio (fisso) tra lira e marco sia pari a 1, ossia un
marco si scambia con una lira e viceversa. Con un tasso di inflazione pari al 4% in Italia e al
2% in Germania, semplificando un po’ i conti, dopo dieci anni il prezzo delle biciclette di
produzione italiana vendute in Italia è pari a 140 lire, quello delle biciclette di produzione
tedesca vendute in Germania è pari a 120 marchi; se lire e marchi si scambiano ancora alla
pari, in Italia le biciclette tedesche costano 120 lire, mentre in Germania le biciclette italiane
costano 140 marchi: è evidente che l’Italia ha problemi a vendere le sue biciclette, sia in
Germania sia in Italia. Fino al 1985, il regime di cambi fissi vigente in Europa, noto come
Sistema Monetario Europeo (SME), era però tale solo in parte. Infatti, quando per un Paese la
perdita di competitività diventava troppo rilevante, proprio a causa del differenziale
inflazionistico, e quel Paese si trovava a fronteggiare problemi insormontabili nel vendere
all’estero le sue produzioni, il tasso di cambio della sua valuta veniva svalutato, facendo
recuperare competitività alle sue merci. Nel caso del nostro esempio, se il cambio della lira
viene svalutato, e passa ad esempio a 2 lire per un marco, in Italia le biciclette italiane costano
sempre 140 lire, ma quelle tedesche passano a 240 lire, mentre in Germania le biciclette
tedesche costano sempre 120 marchi, ma quelle italiane costano solo 70 marchi. Una
svalutazione del cambio ha dunque un impatto cruciale sulla competitività estera, ed è
perfettamente in grado di controbilanciare un differenziale inflazionistico tra i diversi Paesi.
Se vogliamo utilizzare il gergo degli economisti, possiamo dire che la Germania
praticava una politica di disinflazione competitiva, perché teneva il suo tasso di inflazione più
basso rispetto a quello dei concorrenti, ma era esposta alla reazione di altri Paesi, come
l’Italia, che praticavano una politica di svalutazione competitiva, perché ribassava il suo tasso
di cambio quando la perdita di competitività era eccessiva. In qualche modo, questo strano
regime a cambi fissi teneva in equilibrio i diversi Paesi e il sistema nel suo complesso.
Però, dopo il 1999, con l’adozione dell’euro, ossia di un’unica moneta per tutti i Paesi
europei, le svalutazioni competitive sono diventate impossibili: se infatti i singoli Paesi che
compongono l’eurozona condividono la stessa valuta, tra di loro non c’è alcun tasso di cambio
e quindi nulla da poter svalutare; mentre tra l’Europa e il resto del mondo un tasso di cambio
c’è, ma il suo livello non dipende tanto dalle scelte di politica economica dei diversi Paesi
21
quanto, al limite, da quelle della Banca Centrale Europea, che è indipendente dai Governi e,
soprattutto, non persegue alcuna politica di svalutazione competitiva. Questo non vuol dire
che non si possa più sostenere la domanda aggregata attraverso l’incremento delle
esportazioni nette; anzi, i Paesi più lungimiranti d’Europa, come la Germania, ci sono
perfettamente riusciti, perfezionando la loro politica di disinflazione competitiva. Nel resto
del mondo, dove la moneta unica non c’è, il sostegno delle esportazioni è stato comunque di
maggior successo, continuando a sfruttare largamente lo strumento del cambio, come il caso
della Cina insegna. Cina, Germania, e tutti i Paesi che sostengono la domanda aggregata (e in
alcuni casi anche la crescita) col sostegno delle esportazioni nette sono comunque noti come
NeoMercantilisti.
IV.2 I Paesi neomercantilisti
IV.2.1 Cos’è il NeoMercantilismo
La locuzione “Neomercantilisti” richiama il Mercantilismo, ossia quell’approccio di
teoria economica diffuso tra il sedicesimo e il diciottesimo secolo che vedeva la prosperità di
una nazione dipendere dalla prevalenza delle esportazioni sulle importazioni la necessità di
orientare l’intervento pubblico per ottenere tale risultato. Con l’importante differenza che nel
vecchio mercantilismo il surplus commerciale serviva ad accumulare metalli preziosi, mentre
nel nuovo serve a sostenere la domanda aggregata. Naturalmente il Paese deve avere un
sistema produttivo che, per costi di produzione o peculiarità delle merci prodotte, attira una
forte domanda estera. È il caso dell’alta produttività e unicità qualitativa delle produzione che,
ad esempio, caratterizza la Germania, o del basso costo di produzione che, ad esempio,
caratterizza la Cina. Ma queste peculiarità non bastano, o non permangono nel tempo, se non
sono accompagnate da accorte politiche pubbliche, come i sussidi alle imprese esportatrici, la
promozione dell’innovazione tecnologica, la riduzione del costo del lavoro, la riduzione delle
imposte sulle imprese, attente politiche del cambio, ecc. Insomma, il successo di queste
politiche è più frutto di una strategia che del caso, e lega quasi sempre il sostegno alla
domanda aggregata al sostegno del PIL potenziale, ossia alla crescita.
IV.2.2 La Cina
La Cina costituisce uno degli esempi di maggior successo del processo di
globalizzazione, ma anche la dimostrazione che una apertura controllata dei propri mercati è
probabilmente più efficace, per il benessere di un Paese, rispetto a una apertura
indiscriminata. La Cina godeva infatti, e in gran parte gode tuttora, di alcune caratteristiche
strutturali che la hanno facilitata nell’aprirsi al commercio internazionale, ma gli interventi di
policy che ha realizzato le hanno permesso di sfruttare al meglio i propri vantaggi strutturali,
puntando sulle esportazioni per sostenere la propria domanda aggregata, e sugli investimenti
diretti esteri per sostenere la propria crescita economica.
Semplificando necessariamente un po’, possiamo dire che la strategia cinese è
riassumibile nei seguenti passaggi: 1) creare le condizioni per attirare gli investimenti diretti
esteri, grazie a un assetto normativo favorevole per le imprese che delocalizzano impianti in
Cina e al basso costo del lavoro; 2) sfruttare il combinato disposto di basso costo del lavoro e
nuove tecnologie giunte con le multinazionali straniere per far crescere le esportazioni ed
espandere così la propria domanda aggregata; 3) ricorrere ad una attenta politica del tasso di
cambio per mantenere la competitività delle esportazioni nel tempo.
Relativamente al primo punto, possiamo dire che le riforme dell’economia cinese che
hanno portato al suo attuale successo sono iniziate nei primi anni ottanta del ventesimo
secolo, con la creazione delle prime ZES, Zone Economiche Speciali (nella provincia del
Guangdong, nella provincia del Fujian e nella provincia di Hainan) e, subito dopo, con il loro
22
costante ampliamento numerico e dimensionale In queste aree le imprese straniere che
delocalizzavano gli impianti oltre a sfruttare il basso costo del lavoro, potevano accedere a
una serie di incentivi fiscali e normativi, che rendevano la delocalizzazione stessa
estremamente conveniente. Gli investimenti diretti esteri tendono a generare quelli che sono
noti come spillover, ossia a configurarsi non solo come investimenti in capitale fisico (la
costruzione delle fabbriche), ma anche come investimenti in capitale umano e in ricerca e
sviluppo, formando i lavoratori locali e importando nuove tecnologie che poi possono essere
copiate da manager e ingegneri locali. Quindi, evidentemente, le ZES sono coerenti sia con i
modelli di crescita esogena (investimento in capitale fisico) sia con i modelli di crescita
endogena (investimenti in capitale umano e in ricerca e sviluppo): non sorprende che la
crescita cinese sia stata così impetuosa.
Le nuove tecnologie si sono poi sposate assai bene con l’elemento strutturale più
importante della Cina, ossia il basso costo del lavoro. L’abbondanza relativa di manodopera ha
fatto sì che, almeno inizialmente, il costo del lavoro in Cina fosse molto basso. In particolare
l’eccesso di lavoratori nelle campagne, che sono troppi per la domanda di lavoro lì esercitata.
Viceversa nelle imprese industriali concentrate in alcune aree fortemente urbanizzate del
Paese, e soprattutto nelle zone economiche speciali, la domanda di lavoratori è elevata, poiché
le imprese devono soddisfare la domanda crescente di beni proveniente dall’estero ed hanno
dunque bisogno di un numero crescente di lavoratori. Qui i salari pagati tendono ad essere
bassi sì, ma superiori a quelli agricoli. Il differenziale salariale tra agricoltura e industria causa
uno spostamento di lavoratori dai settori a bassi salari agricoli a quelli a più alti salari urbani,
flusso che fa aumentare l’offerta di lavoro in città, rendendo più facile per le imprese trovare
lavoratori da assumere anche a bassi salari. In sostanza all’aumento della domanda di lavoro
da parte delle imprese urbane si contrappone anche un aumento dell’offerta, grazie ai
numerosi nuovi lavoratori giunti dalle campagne e disposti a lavorare per un basso salario. Ma
se domanda e offerta più o meno si equivalgono, il salario nelle imprese industriali cittadine,
pur rimanendo più alto rispetto a quello pagato dalle imprese agricole delle campagne,
rimane basso. Questo fenomeno è destinato a continuare sin quando continuerà il flusso di
lavoratori dalle campagne alle città; e il flusso continuerà sino a quando ci sarà abbondanza di
lavoratori nelle campagne. Terminata l’abbondanza di lavoratori nelle campagne a causa dei
fenomeni migratori, il gioco della domanda e dell’offerta farà salire i salari nelle campagne
riducendo progressivamente l’incentivo ad emigrare; a quel punto la riduzione dell’offerta di
lavoro in città determina anche qui un innalzamento dei salari. Questo fenomeno sta iniziando
ad accadere in Cina da un paio di anni, tanto che molti imprenditori cinesi si lamentano del
livello eccessivamente alto dei salari nel loro Paese, e iniziano a programmare
delocalizzazioni produttive in Vietnam, dove i salari sono ancora più bassi.
Ciò che abbiamo appena descritto corrisponde a quanto teorizzato, non con
riferimento alla Cina ma ad altri Paesi, da due diversi modelli di economia dello sviluppo: il
modello di W. Arthur Lewis (1954), che vede la determinante dello spostamento dei
lavoratori nel differenziale salariale, e quello di John R. Harris e Michael Todaro (1970), i quali
invece insistono sulla aspettativa di reddito nelle città (dove hanno una rilevanza anche i
differenziali di reddito atteso, ossia non solo il diverso livello di salario ma anche il rischio di
rimanere disoccupato dopo il trasferimento).
Sostenere la crescita grazie all’attrazione di IDE, e poi sostenere la domanda aggregata
grazie alla produzione e all’esportazione di beni a basso costo poteva incontrare un limite
qualora il tasso di cambio del renminbi (o yuan), la valuta cinese, si fosse eccessivamente
apprezzato, o qualora in Cina l’elevata domanda avesse generato pressioni inflazionistiche,
ossia un aumento del prezzo dei beni esportati. Tutto ciò non è accaduto grazie ad una attenta
politica del cambio. Infatti la Banca Centrale Cinese, di fronte ad una situazione in cui la
domanda di yuan sul mercato dei cambi era elevata (perché chi voleva comprare merce cinese
23
doveva prima procurarsi yuan, ed erano in tanti a voler comprare merce cinese…) è sempre
intervenuta vendendo yuan nella quantità necessaria per mantenere l’offerta sostanzialmente
uguale alla domanda non facendone salire il prezzo (che è, appunto, il tasso di cambio). La
Cina è ricorsa a una strategia nota come pegging unilaterale, nel quale un Paese, anche senza
accordi con gli altri, ancora il valore della propria valuta a quello di un’altra valuta
(formalmente, nel caso della Cina, prima al dollaro poi a un paniere di valute, ma poiché anche
nel paniere il dollaro pesava più delle altre valute, di fatto l’ancoraggio è sempre stato nei
confronti del dollaro, visto che gli Stati Uniti sono stati per lungo tempo il principale partner
commerciale cinese). Nel corso degli anni, dunque, le autorità monetarie hanno permesso che
il renminbi si apprezzasse solo moderatamente, non tanto quanto sarebbe stato necessario
per mettere a rischio la competitività delle esportazioni. Inoltre, vendendo yuan sul mercato
dei cambi la Banca Centrale Cinese acquistava dollari, incrementando così enormemente le
sue riserve valutarie; e con questi dollari da un lato comprava titoli di Stato statunitensi,
dall’altro li prestava al Fondo Sovrano Cinese che con essi acquistava banche, imprese, ecc.
utili alla politica cinese, in tutto il mondo.
Rimaneva però il rischio inflazione: gli yuan che la Banca Centrale stampava e vendeva
contro dollari (e altre valute) sul mercato dei cambi, infatti, venivano venduti a chi ne aveva
bisogno per acquistare merce in Cina, e dunque, in ultima istanza, finivano per tornare in Cina,
nelle tasche degli imprenditori cinesi che esportavano merci all’estero. Tutta questa liquidità
poteva generare inflazione e/o bolle, così la Banca Centrale cinese è ricorsa a procedure di
“sterilizzazione” della massa monetaria: vendendo propri titoli alle banche ordinarie cinesi,
ritira liquidità che quindi sottrae alla circolazione. Inoltre, impone alle banche stesse forti
restrizione sui crediti che possono erogare, sia nella forma di massimali sul credito sia nella
forma di elevato coefficiente di riserva obbligatoria (in Cina è il 20%, in Europa l’1%). Per
lungo tempo questa politica ha avuto successo, e tanto il cambio quanto i salari e l’inflazione
sono rimasti sotto controllo.
Ma assai importante è stata soprattutto l’adesione del Paese all’Organizzazione
Mondiale del Commercio (WTO), l’11 dicembre del 2001, che le ha fatto aprire parzialmente i
mercati al commercio mondiale: tra la fine del ventesimo e l’inizio del ventunesimo secolo il
Paese, grazie alle esportazioni, ha iniziato a vedere tassi di crescita del PIL mai inferiori al 7%
annuo e con punte del 12%.
Quindi, investimenti diretti esteri, capaci di apportare nuove tecnologie, combinati con
un basso costo del lavoro e una attenta politica del tasso di cambio, hanno permesso alla Cina
di crescere e anche di sostenere la domanda aggregata grazie alle esportazioni: con
l’eccezione di un paio di trimestri nel 2012 e nel 2014, la Cina ha sempre avuto surplus di
bilancia commerciale, ossia esportazioni maggiori delle importazioni. Ora però le cose si
stanno complicando. Da un lato, la fine del flusso di lavoratori dalle campagne verso le città
sta generando un significativo aumento nei salari; dall’altro, l’inflazione comincia a rialzare la
testa, perché la Banca centrale cinese riesce sempre meno bene a sterilizzare l’enorme
liquidità in circolazione, che spesso circola attraverso sistemi bancari ombra illegali, ma ha
ugualmente impatti inflazionistici sui prezzi; inoltre, si avverte il rischio, sempre derivante
dall’eccesso di liquidità in circolazione, che alcune bolle speculative immobiliari regionali
possano scoppiare. Tutti elementi critici, che però sinora non hanno intaccato l’enorme
sviluppo dell’economia cinese, ma nel 2014 hanno portato le autorità monetarie a pilotare un
deprezzamento dello yuan per non perdere eccessivamente competitività. Un rischio
maggiore può derivare dall’elemento demografico: la politica del “figlio unico” prefigura un
futuro nel quale pochi lavoratori produttivi saranno affiancati da molti pensionati
improduttivi: uno scenario critico per l’economia cinese.
A parte questo scenario negativo di lungo periodo, dal punto di vista economico la Cina
ha rappresentato, per molti Stati asiatici e non solo, un esempio da seguire.
24
IV.2.3 La Germania
Un altro Paese che ha fatto ricorso alle esportazioni per sostenere la propria domanda
aggregata è la Germania, oggi principale paladino di quel rigore economico che ritiene sia
stato all’origine del proprio successo e che vuole proporre come modello da imitare anche agli
altri Paesi. Proprio per l’idea che possa trattarsi di un “modello” da imitare può essere
particolarmente interessante capire i diversi passaggi che hanno portato la Germania ad avere
il ruolo, e il peso economico, che oggi ha.
Negli ultimi decenni la Germania ha sempre basato la sua economia sull’industria, su
un Welfare sviluppato ed avanzato, sulla co-gestione con i sindacati delle imprese principali,
sulla qualità e sull’efficienza delle sue produzioni. Per quanto invece concerne il sostegno
della domanda aggregata, anche qui la strategia tedesca è stata univoca negli ultimi
cinquant’anni: sostegno della domanda aggregata ottenuto attraverso la crescita delle
esportazioni. Infatti il Paese ha sempre presentato esportazioni maggiori delle importazioni,
ossia un surplus commerciale, con l’eccezione di due (due!) trimestri in cinquant’anni, e
questo surplus è andato crescendo nel tempo, soprattutto dopo l’ingresso nell’Eurozona, con
picchi di surplus commerciale oltre l’8% del PIL e minimi mai inferiori al 4%. Questo risultato
si deve da un lato alle specificità qualitative delle sue produzioni, dall’altro a prezzi interni che
crescevano meno di quanto crescessero i prezzi degli altri Paesi grazie a tassi di inflazione
particolarmente bassi. Possiamo così dire che la lotta all’inflazione sia nel DNA dei tedeschi
non solo per la drammatica esperienza dell’iperinflazione della Repubblica di Weimer, che
portò il paese al Nazismo, ma anche e soprattutto per molto più prosaici motivi economici
legati alla conquista di quote di mercato.
Se ci soffermiamo un attimo sul problema inflazionistico, notiamo come la politica
tedesca non sia affatto cambiata molto tra prima dell’ingresso nell’eurozona a dopo l’ingresso.
Era infatti basata sulla disinflazione competitiva prima (in contrasto con le politiche di
svalutazione competitive di altri Paesi suoi concorrenti), punta sul contenimento dei prezzi
oggi.
Con l’introduzione dell’euro, i concorrenti della Germania non possono più puntare
sulle svalutazioni competitive. Sembrerebbe un vantaggio per chi riesce a contenere i prezzi,
ma c’è un problema. La Germania entra infatti nell’Euro con una valuta fortemente
apprezzata, nel senso che le sue esportazioni, in euro, sono eccessivamente care. Inoltre, la
globalizzazione e l’emergere di nuovi concorrenti a basso costo del lavoro comincia a creare
problemi al Paese. Si giunse addirittura a parlare della Germania come “il grande malato
d’Europa”.
Il pessimismo si è però dimostrato infondato. La Germania, infatti, ha rapidamente
ristabilito le principali ragioni del suo successo, puntando su due elementi: il basso costo del
lavoro e la produzione di prodotti esclusivi ad alta tecnologia dove Paesi che potessero
competere con lei semplicemente non esistono.
Innanzitutto ha puntato sull’innovazione di processo e di prodotto e sull’unicità
qualitativa: chi altri nel mondo produce automobili simili a BMW, Mercedes, Audi, Porsche?
Invece di prodotti a basso costo e bassa tecnologia, dove è facile doversi scontrare con le
produzioni dei Paesi emergenti che possono sfruttare salari bassissimi, si è orientata a
produrre merci di alta qualità e ad alto contenuto tecnologico, sostanzialmente non imitabili
nel resto del mondo. In sostanza, l’Italia esporta le FIAT (un tempo, ora anche la FIAT sta
lasciando il Paese…), la Germania le Audi; l’Italia produce scarpe e magliette, la Germania treni
e aerei. Una prima, importante differenza è lì. Per far questo, è (stato) necessario un massiccio
investimento in ricerca e sviluppo, in formazione, un sistema scolastico efficiente, l’attrattività
di investimenti diretti esteri ma soprattutto immigrazione di qualità, richiamata dalle ottime
prospettive di lavoro e di salario: l’Italia importa badanti rumene, la Germania importa
25
ingegneri indiani. Soprattutto, l’ingegnere indiano viene occupato come ingegnere, non come
badante!
Ma la scelta di settori merceologici e di qualità produttiva al top non è stata l’unica
scelta cruciale dei tedeschi. Infatti il Paese, come abbiamo visto, si è trovato con un problema
di valuta sopravvalutata: i suoi prezzi, una volta entrata nell’eurozona, si sono rivelati troppo
alti, poco competitivi; e poiché la politica monetaria era comune a tutti i Paesi dell’eurozona,
sembrava non potesse contare su una politica monetaria nazionale restrittiva che le
permettesse di far crescere i propri prezzi meno di quanto crescessero quelli degli altri Paesi
e recuperare così competitività.
Sembrava. Perché qualcosa ha fatto la Germania per favorirsi, qualcosa hanno fatto gli
altri Paesi per favorirla. Infatti il Paese, resosi conto della poca competitività in termini di
prezzo delle proprie esportazioni (siamo tutti pronti a pagare un po’ di più l’alta qualità, ma
non a pagarla molto di più…), ha applicato una drastica politica di moderazione salariale. In
particolare, un po’ in accordo con sindacati lungimiranti, un po’ minacciandoli di delocalizzare
gli impianti produttivi nei confinanti Paesi dell’est europeo dove il costo del lavoro era una
frazione di quello tedesco, ha ottenuto importanti riduzioni salariali. Meglio, ha ottenuto un
aumento dell’orario di lavoro a parità di salario, che però altro non è se non una riduzione del
salario orario. Qualcuno potrebbe contestare questo dato dicendo che i salari tedeschi sono
mediamente più alti di quasi tutti gli altri salari europei, ma va rilevato che anche la
produttività degli operai tedeschi è più alta (grazie alla loro indole certo, ma soprattutto
grazie alla tecnologia che utilizzano) rispetto a quella degli altri Paesi. Quindi sì, pago un
operaio il 25% in più di quanto lo pagherei in Italia, e il doppio rispetto a quanto lo pagherei
in Polonia, ma mi produce il 50% in più di quanto produrrebbe un operaio italiano, e il triplo
di un operaio polacco. Inoltre, quando entro nell’Eurozona riduco, con l’accordo dei sindacati,
questi salari. E recupero così competitività mentre la produzione cresce.
Ma qualcosa, come dicevamo, hanno fatto anche gli altri Paesi per favorire la Germania.
Mentre infatti i tedeschi si concentravano su aumento della produttività e riduzione dei salari
orari, i Paesi periferici, Italia in testa (ma anche la stessa Francia), facevano l’esatto opposto:
proprio mentre la loro produttività ristagna, invece di ridurre i salari, li incrementavano;
invece di aumentare gli investimenti in tecnologia e formazione, per rispettare i vincoli
europei li tagliavano, perché è più facile ridurre i finanziamenti agli scienziati che abbassare i
salari dei dipendenti pubblici. Così, ad esempio, in Francia passa la legge delle 35 ore, che
riduce l’orario di lavoro a parità di salario, cioè l’esatto contrario di quanto fatto in Germania.
In questo modo è stato facile per la Germania recuperare rapidamente ciò che aveva perso con
l’ingresso nell’Eurozona: lei riduce i salari mentre aumenta la produttività, gli altri li
aumentano mentre la loro produttività si riduce (o aumenta di poco).
Per quanto ci interessa qui, comunque, anche la Germania, come la Cina, ha puntato
sull’innovazione tecnologica per la crescita e sulle esportazioni per il sostegno della domanda
aggregata. Con indubbio successo, anche se naturalmente non tutto è oro quel che riluce:
anche la Germania ha dei problemi, e riemergeranno. Per ora, però, può essere ragionevole
tralasciarli, visto che noi di problemi ne abbiamo assai di più, ed essere come la Germania, con
i suoi stessi problemi, sarebbe davvero un’ottima cosa.
IV.3 Debito e domanda aggregata
Come abbiamo visto, solo pochi Paesi hanno scelto di seguire la strada
NeoMercantilista, o sono riusciti a farlo. Gli altri hanno sostenuto la domanda aggregata in un
altro modo, ossia ricorrendo all’indebitamento, pubblico o privato. L’indebitamento è infatti
una delle strategie più efficaci per sostenere la domanda aggregata: se sono costretto a
indebitarmi vuol dire che sto già spendendo tutto quello che guadagno e voglio spendere
26
ancora di più… Inoltre, se almeno una parte della spesa che finanzio indebitandomi viene
destinata all’investimento, non solo garantisco l’aumento della domanda nel breve periodo,
quando i beni di investimento devono essere prodotti, ma anche l’aumento del prodotto
potenziale nel lungo periodo, quando i beni capitale risultanti da quell’investimento diventano
produttivi. È (quasi) irrilevante per la domanda aggregata se chi spende più del reddito sono i
Governi o i privati. Nel primo caso parleremo di Paesi del Debito, con i Governi che spendono
più di quanto incassano (in imposte e tasse), facendo spesa in deficit e creando così debito
pubblico. Nel secondo caso parleremo di Paesi della bolla, con i Governi che favoriscono con
particolari politiche l’indebitamento privato, rendendo ad esempio più facile prendere denaro
a prestito, e saranno allora i privati a indebitarsi e spendere più del loro reddito, generando
quella che si chiama una “bolla speculativa”.
IV.4 Dal debito pubblico al debito privato
La crisi del 1929 modificò l’idea, propria della teoria economica precedente, secondo la
quale il sistema economico non poteva essere caratterizzato da disoccupazione involontaria
persistente, poiché la flessibilità del salario - e più in generale dei prezzi - avrebbe fatto sì che,
in presenza di disoccupazione, i lavoratori si sarebbero offerti alle imprese ad un salario più
basso e le imprese li avrebbero assunti, in questo modo riducendo fino a farla scomparire la
disoccupazione. La ricetta degli economisti (la scuola dominante allora si chiamava
neoclassica) per superare la grande depressione era allora una sola: non intervenire. Ma il non
intervento portò alla crisi del 1929, con parecchi anni di recessione negli USA e nel mondo. Si
trattava di una crisi da carenza di domanda aggregata, che fu attenuata dall’intervento
pubblico realizzato con il New Deal di Roosevelt, un importante programma di spesa pubblica
destinato alla costruzione appunto di opere pubbliche e volto a riassorbire la disoccupazione
assumendo i disoccupati per fargli costruire strade, ponti, dighe, ecc. Questo programma non
giunse sino ad abbracciare il successivo famoso principio della spesa in deficit, ed era, in
quegli anni, privo di un sostegno teorico riconosciuto - anche se dietro l’opera di Roosevelt già
si intravedevano i suggerimenti di Keynes - ma sancì ugualmente la fine dell’idea che lo Stato
non dovesse intervenire in economia. Fu però solo nel 1939, con l’incremento delle spese per
il riarmo, che gli USA uscirono dalla grande depressione.
Il principio dell’intervento pubblico in economia realizzato per mezzo di spesa
pubblica finanziata in deficit riceverà una formulazione teorica compiuta solo nel 1936, con la
pubblicazione dell’opera di Keynes La Teoria Generale dell’occupazione, dell’interesse e della
moneta.
Fino agli anni Ottanta del secolo scorso la lezione della grande depressione era rimasta
ben chiara ai politici e agli economisti: il mercato, lasciato a se stesso, non porta affatto il
sistema in piena occupazione, ma anzi può causare crisi profonde; è quindi necessario un
massiccio intervento pubblico, meglio se realizzato in deficit, al fine di sostenere la domanda
aggregata e l’occupazione. Esso si è concretamente realizzato in diverse forme e con diversa
intensità nei singoli Paesi, ma è stato accomunato da un elemento: funzionava; i Paesi
crescevano, l’occupazione era elevata, i politici felici perché potevano regalare soldi alla gente
senza dover alzare le tasse, la popolazione sempre più ricca...
Poi le cose cambiano. Tra il 1973 e il 1980 il mondo deve fronteggiare quelli che
vengono chiamati i due shock petroliferi: la produzione di petrolio si riduce, facendo salire il
prezzo e mandando in crisi le economie dei più grandi Paesi industrializzati. I Governi tentano
di opporsi a questa crisi con gli stessi criteri utilizzati per contrastare le crisi precedenti, ossia
con ulteriore spesa pubblica espansiva, ma i risultati sono deludenti. Inoltre, decenni di
intervento pubblico nell’economia hanno dimostrato come questo intervento presenti non
solo aspetti positivi, ma anche negativi. In particolare il debito pubblico aumenta
27
pericolosamente, le imprese pubbliche si rivelano scarsamente efficienti, gli interessi di breve
periodo dei decisori politici (che mirano essenzialmente ad essere rieletti) incompatibili con
scelte di lungo periodo relative al benessere del Paese, l’inflazione (ossia il tasso di crescita del
livello generale dei prezzi) aumenta, le spese per l’assistenza sociale, sanitaria e pensionistica
cominciano ad andare fuori controllo, nuovi concorrenti iniziano a contendere ai tradizionali
Paesi industrializzati il loro ruolo, la crisi dell’Unione Sovietica porta dubbi sull’effetto di un
eccesso di intervento pubblico nell’economia.
Di particolare rilievo, con riferimento a questi temi, la scuola della Public Choice (il
premio Nobel James Buchanan e Gordon Tullock gli autori di riferimento), secondo i quali
anche i politici e i funzionari pubblici, come tutti i soggetti dei quali si occupa la teoria
economica, hanno un unico obiettivo: massimizzare la propria utilità. Ciò non è disdicevole,
perché la teoria economica assume che questa sia la motivazione di tutte le azioni, senza
alcuna eccezione, e se i politici e i funzionari pubblici non si comportassero così allora la
teoria sarebbe sbagliata! Ne segue che non possiamo aspettarci che questi soggetti facciano di
loro scelta gli interessi della collettività, ed è dunque opportuno: i) ridurre il ruolo dello Stato
dell’economia riducendo così la possibilità per i politici e i funzionari pubblici di fare i propri
interessi invece che gli interessi collettivi; ii) creare regole rigide alle quali politici e funzionari
pubblici devono senza eccezioni attenersi; iii)stabilire incentivi e disincentivi che facciano
corrispondere l’interesse personale di politici e funzionari pubblici con quello della
collettività.
Dopo gli shock petroliferi inizia così un percorso economico, politico e anche teorico
completamente diverso, quasi un ritorno alle origini. Si ritiene infatti che si sia esagerato con
l’intervento pubblico così come prima si era esagerato con la sua assenza, e che un giusto
equilibrio sarebbe stato più efficiente. Intendendo per giusto equilibrio una riduzione
considerevole della spesa in deficit. Rimane un dilemma: se i Governi smettono di indebitarsi
per spendere più di quanto incassano, chi sosterrà la domanda aggregata?
La risposta è implicita nelle strategie scelte, che mirano ad ottenere un aumento di
consumi privati, e quindi di domanda privata, ma soprattutto un incremento degli
investimenti privati: saranno i privati a spendere più di quanto guadagnano. E perché ciò
accade dovrà essere sempre più facile per loro indebitarsi. Di qui nasce una progressiva opera
di liberalizzazione dei mercati, soprattutto di quelli finanziari, che ha proprio questo scopo:
rendere più facile per i privati indebitarsi e spendere, per sostenere la domanda aggregata
(con i propri consumi) ma anche la crescita del PIL potenziale (con i propri investimenti). Le
nuove leggi permetteranno alle banche di prestare di più, richiedendo meno garanzie,
fondendosi e diffondendosi, utilizzando strumenti finanziari sempre più sofisticati, prendendo
a prestito in un Paese e prestando in un altro. Il processo è lungo e complesso, incontra
ostacoli, rallenta più volte, ma soprattutto negli Stati Uniti è apparentemente irreversibile e
dispiegherà totalmente i suoi effetti a partire dagli anni novanta. Altri Paesi, soprattutto
europei, saranno più lenti, o più restii, a seguire una strada che implica anche una riduzione
del ruolo e della dimensione dello Stato sociale, dell’assistenza ai bisognosi, dei sussidi ai
lavoratori e ai disoccupati. Ma, apparentemente, negli Stati Uniti la cosa funziona. L’economia
cresce, e cresce anche la domanda, il reddito e l’occupazione, mentre negli altri Paesi la
crescita è più lenta, più contrastata. Si parla così del modello americano, e del suo successo.
A questa progressiva liberalizzazione dei mercati si affianca, cronologicamente, il
fenomeno della globalizzazione, che però di tale liberalizzazione è anche concausa e, per gli
aspetti più importanti, conseguenza.
28
IV.5 La Globalizzazione
La globalizzazione è un fenomeno complesso, che ha implicazioni non solo economiche
ma anche sociali, culturali e politiche, e un’evoluzione articolata su un lasso di tempo
plurisecolare. Semplificando molto, ed enfatizzando soltanto gli aspetti più specificamente
economici del fenomeno, possiamo dire che la globalizzazione è la fase più avanzata di un
processo che vede un rilevante incremento degli scambi commerciali tra Paesi (soprattutto
grazie a una progressiva riduzione delle barriere che ostacolavano questi scambi), un
incremento della circolazione dei capitali e dei movimenti migratori (grazie a una sempre
maggiore integrazione dei mercati), nonché la possibilità di articolare i processi produttivi su
scala multinazionale, frammentando la catena di produzione, ossia svolgendo una parte del
processo produttivo in un Paese e un’altra parte (altre parti) in un altro Paese (altri Paesi).
Quest’ultimo aspetto è il più rilevante, ed è conosciuto come supply chain o global value chain.
Di qui, evidente, il legame stretto tra globalizzazione e liberalizzazione dei mercati: sono due
fenomeni che vanno, per così dire, “a braccetto”.
La causa principale della globalizzazione è da ricercarsi nelle innovazioni tecnologiche,
che hanno determinato una rilevante riduzione dei costi di trasporto, e nella progressiva
eliminazione delle barriere protezionistiche, ossia delle tassazioni che i diversi Paesi
imponevano sulle importazioni da altri Paesi, che costituivano un ulteriore elemento di costo
per chi esegue transazioni commerciali. Inoltre, lo sviluppo delle nuove tecnologie
dell’informazione ha permesso una maggiore integrazione dei mercati internazionali dei
capitali, ossia dei flussi finanziari (compravendita di titoli esteri, prestiti internazionali,
acquisto di immobili e/o di aziende all’estero, apertura di conti correnti su banche estere,
ecc.) tra i diversi Paesi.
Gli economisti sono sostanzialmente concordi nell’enfatizzare i vantaggi della
globalizzazione, e lo sono dai tempi della teoria classica (David Ricardo, 1817) e neoclassica
(Eli Heckscher, 1919, e Bertil Ohlin, 1933) del commercio internazionale. Queste teorie
economiche ritengono che l’apertura commerciale migliori il livello di benessere di tutti i
Paesi coinvolti, indipendentemente dal loro livello di reddito iniziale, permettendo il consumo
di una maggior quantità di prodotti, un uso più efficiente delle risorse possedute e un
guadagno per i consumatori, che ottengono i beni a prezzi inferiori.
Si tratta però di un processo che avviene nel tempo. Nel senso che un Paese, quando si
apre alla concorrenza internazionale, scopre di dover modificare la propria specializzazione
produttiva, spostandosi dai settori nei quali è meno efficiente a quelli nei quali è più efficiente.
Detto così, è molto asettico. Nella realtà questo comporta chiudere imprese e licenziare
lavoratori in alcuni settori, e solo poi, nel più lungo periodo, riassorbire i dipendenti nelle
nuove imprese che nascono nei settori più competitivi. I costi sociali sono dunque elevati, a
volte di lunga durata, e possono essere tanto forti da creare violente opposizioni al processo
stesso.
Queste teorie presentano anche un’altra rilevante implicazione, proposta nel 1948 dal
Premio Nobel Paul Samuelson e nota come livellamento del prezzo dei servizi dei fattori della
produzione (terra, lavoro e capitale). Limitandoci al solo lavoro, la teoria ritiene di poter
dimostrare che in conseguenza dell’apertura al commercio internazionale il salario dovrà
tendere a divenire uguale nei diversi Paesi, aumentando quindi là dove è più basso, ossia nei
Paesi meno sviluppati, e riducendosi là dove è più alto, ossia nei Paesi più sviluppati. Inoltre,
nei Paesi di più antica industrializzazione la riduzione salariale toccherebbe soprattutto i
lavoratori meno qualificati (unskilled), e questo perché i Paesi meno industrializzati
tenderanno a specializzarsi soprattutto nelle produzioni a più alto contenuto di lavoro poco
qualificato, che in quei Paesi è abbondante e quindi costa poco, facendo così concorrenza alle
29
produzioni dello stesso tipo presenti nei Paesi di più antica industrializzazione, dove invece il
lavoro poco qualificato costa di più. Il differenziale del costo del lavoro in questi settori è così
alto che i Paesi di più antica industrializzazione non possono reggere lo scontro, e dunque
vedono le imprese fallire e i disoccupati aumentare, con conseguente riduzione salariale (pur
di lavorare i disoccupati accettano salari più bassi).
Inizialmente le previsioni della teoria economica sono sembrate smentite dalla realtà:
la globalizzazione appariva infatti soltanto un processo nel quale i Paesi più ricchi, quelli del
Nord del Mondo, sfruttavano quelli meno ricchi, quelli del Sud. Poi, però, le cose sono in gran
parte cambiate. In particolare, è effettivamente accaduto che in molti Paesi (il caso più
eclatante è certamente la Cina, ma prima ancora la Corea del Sud) l’apertura al commercio
internazionale abbia permesso una rilevante crescita del PIL e del benessere della
popolazione, anche se in alcuni casi questo si è comunque ripercosso sulla distribuzione del
reddito, aumentando le diseguaglianze (in Cina i poveri sono diventati un po’ meno poveri, ma
i ricchi sono diventati molto più ricchi). Gli stessi salari, che nei Paesi emergenti sono rimasti a
lungo estremamente bassi a causa dell’abbondanza di manodopera (eccesso dell’offerta di
lavoro sulla domanda, prezzo del lavoro, cioè salario, basso), hanno recentemente iniziato a
salire, mentre la riduzione dei salari dei lavoratori meno qualificati nei Paesi di più antica
industrializzazione è un fenomeno oggi all’ordine del giorno. Confermando così la teoria del
livellamento del prezzo dei servizi dei fattori.
Potremmo quindi concludere che la globalizzazione sta avendo un impatto negativo sui
Paesi più industrializzati, perché la modifica della specializzazione produttiva provoca crisi
industriali che, almeno nel breve periodo, causano disoccupazione; perché riduce i salari,
soprattutto dei lavoratori meno qualificati; perché modifica la distribuzione internazionale
della ricchezza a vantaggio dei Paesi emergenti. Va però rifiutata l’idea che sia il basso costo
del lavoro dei Paesi emergenti a portare fuori mercato le produzioni dei Paesi di più vecchia
industrializzazione, che non riuscirebbero a confrontarsi con salari così bassi: la Germania ha
un livello salariale tra i più alti d’Europa, certamente superiore a quello di Grecia, Irlanda,
Italia, Spagna e Portogallo, eppure regge benissimo la concorrenza. Il problema, alla fine, non
è salariale, ma di produttività. I salari possono rimanere alti se lo è anche la produttività del
lavoro.
La globalizzazione ha dunque un ruolo importante nel giustificare il progressivo
cambiamento di quella che gli economisti chiamano la distribuzione del reddito. Con questa
locuzione si intende la quota di reddito che va alle diverse categorie sociali: quando cambia la
distribuzione vuol dire che qualche categoria guadagna una fetta maggiore del totale e
qualche altra una fetta minore. Nel caso in questione nei Paesi di vecchia industrializzazione
l’abbassamento dei salari dei lavoratori meno qualificati sposta la distribuzione a vantaggio
dei più ricchi. Il problema è che in genere chi ha un reddito più elevato tende a consumarne di
meno e a risparmiarne di più, mentre chi ha un reddito inferiore tende a consumarlo quasi
integralmente. Lo spostamento della distribuzione del reddito a vantaggio dei più ricchi
implica quindi una riduzione della quota dei consumi e un aumento di quella dei risparmi, e
dunque una contrazione della domanda aggregata con effetti negativi nel breve periodo.
Ma, naturalmente, c’è una alternativa. Se gli appartenenti alle classi reddituali più basse
sono incentivati a imitare i comportamenti di spesa degli appartenenti alle classi reddituali
più alte - ed è a questo che servono, dopo tutto, consumismo e pubblicità... - e se la
liberalizzazione dei mercati finanziari permette loro di indebitarsi facilmente, allora la
domanda aggregata può crescere ugualmente, perché anche i più poveri possono finanziare i
consumi che non potrebbero permettersi attraverso il ricorso all’indebitamento. Ed è
esattamente ciò che accade. Dal debito pubblico si passa al debito privato. Stavolta sono i
privati, indipendentemente dal fatto che siano consumatori o imprenditori, ricchi o poveri, a
30
spendere più di quanto guadagnano e a sostenere la domanda aggregata e la crescita con i loro
consumi e investimenti.
Alcuni Paesi però, di fronte alla carenza della domanda aggregata, a strutture
produttive poco adatte alle liberalizzazioni, a elettori poco favorevoli a sacrificare il sostegno
pubblico all’economia e i privilegi acquisiti, puntano decisamente e ancora sulla spesa
pubblica per superare momenti di crisi. Altri puntano eccessivamente sulla domanda privata.
Iniziamo da questi ultimi.
IV.6 I paesi della bolla
IV.6.1 Le bolle speculative
In generale il prezzo di un bene dipende da domanda e offerta: se la quantità del bene
complessivamente domandata da chi desidera acquistarlo è maggiore di quella offerta da chi
desidera venderlo, il prezzo aumenta; viceversa, se la quantità offerta è superiore alla quantità
domandata, il prezzo si riduce. Bene, le bolle speculative sono situazioni nelle quali la
domanda è talmente alta che il prezzo aumenta continuamente, e man mano che il prezzo
cresce sempre più persone desiderano acquistare il bene proprio perché pensano che il
prezzo aumenterà ancora. E se tutti vogliono acquistare il bene perché pensano che il prezzo
aumenterà, l’aumento della domanda farà effettivamente aumentare il prezzo.
Ci si potrebbe domandare perché mai l’aspettativa che un certo bene aumenti di prezzo
dovrebbe portare qualcuno a cercare di acquistarlo. Per rispondere, vediamo cosa accadeva in
Spagna sino a pochi anni fa. Gli spagnoli contraevano prestiti, in particolare mutui immobiliari
- ossia garantiti dall’immobile acquistato, che diventava di proprietà della banca che
concedeva il mutuo in caso di insolvenza del mutuatario - e compravano abitazioni; ma non lo
facevano per andarci a vivere, tutt’altro. Una volta acquistato l’immobile, aspettavano. E
siccome tutti si comportavano così, tutti cioè domandavano sul mercato appartamenti, il
prezzo delle abitazioni aumentava nel tempo. Dopo un anno o due il nostro spagnolo può
quindi rivendere l’appartamento a un prezzo molto maggiore rispetto a quello al quale lo ha
acquistato, restituire il prestito (interessi compresi) e rimanere con un bel gruzzoletto, che
potrà utilizzare come anticipo nella richiesta di un nuovo mutuo immobiliare destinato
all’acquisto di un altro appartamento, o spendersi tutto in viaggi e ristoranti. La singolarità è
che, se tutti fanno così, la domanda di immobili è costantemente più alta dell’offerta, i prezzi
salgono sempre... e tutti diventano ricchi!
Fantastico no? Questo è il bello di una bolla speculativa. A un certo punto tutti pensano
che si possa diventare ricchi facilmente. E, per un po’, è proprio ciò che accade.
Le bolle, però, non si limitano a far arricchire le persone, ma presentano anche una
caratteristica spiacevole: prima o poi, scoppiano. Sempre, senza eccezioni. Prima o poi nuovi
acquirenti - che sono indispensabili per far salire il prezzo - non se ne presentano più, il
prezzo smette quindi di salire, e il nostro spagnolo previdente si trova in mezzo a un brutto
guaio: per comprare l’appartamento ha contratto un prestito di 100.000 euro, che dovrà
ripagare assieme agli interessi, e lo ha fatto convinto che in breve tempo avrebbe potuto
estinguerlo rivendendo l’appartamento a 200.000 euro, ma dopo un anno quello vale sempre
solo 100.000 euro... Inoltre, lo spagnolo comincia a sospettare che forse si è giunti all’apice
della bolla, e i prezzi degli immobili potrebbero in futuro addirittura ridursi. Ma se si
riducono, la situazione per sarò una catastrofe, perché se il valore del suo appartamento
diverrà inferiore al valore del finanziamento ottenuto, e lui non saprà proprio come ripagare il
mutuo. Se sospetta una riduzione imminente dei prezzi, per perdere il meno possibile è quindi
indispensabile che venda subito, prima che i prezzi crollino. Ma se tutti ragionano come lui, e
cercano di vendere, mentre nessuno compra, è proprio per questo che il prezzo crolla.
31
Le bolle speculative possono riguardare (quasi) qualsiasi bene. In Olanda, tra il 1634 e
il 1637, si sviluppò una bolla speculativa per i bulbi di tulipano! E, come tutte le bolle, anche
quella dei tulipani prima si gonfiò, poi scoppiò. Le bolle speculative scoppiano perché c’è un
intervento pubblico (in genere questo intervento viene effettuato dalla Banca Centrale), un
cambiamento di aspettative degli speculatori, oppure, semplicemente, perché a un certo
punto non c’è più nessun nuovo compratore sul mercato. Di tutti questi aspetti si sono
occupati i teorici delle bolle speculative, e in particolare Hyman Minsky, Friedrich Von Hayek,
Charles Kindelberger e il premio Nobel Robert Shiller. In particolare Hayek riteneva che la
bolla si gonfiasse a causa della “complicità” della banca centrale, che teneva i tassi di interesse
troppo bassi e sosteneva con le sue politiche una eccessiva crescita del credito bancario; e
riteneva che scoppiasse quando la banca centrale, spaventata dall’inflazione causata
dall’eccessiva domanda, alzava i tassi e riduceva l’erogazione di credito, determinando così un
crollo della domanda e dei prezzi, con l’insolvenza di chi si era indebitato contando su prezzi
in costante ascesa. Shiller invece indaga i comportamenti psicologici (irrazionali) che portano
al gonfiarsi di una bolla. Secondo lui il principio di funzionamento di molti mercati finanziari è
il “beauty contest” di Keynes, ossia il concorso di bellezza presente su alcuni giornali, dove si
vinceva indovinando non la più bella, ma quella che la maggior parte dei lettori avrebbe
indicato come la più bella. Allo stesso modo nel mercato finanziario si vince comprando non
l’attività finanziaria, o gli immobili, o i beni migliori, ma quelli che la maggior parte degli
operatori considererà come migliori. Perché questa attività, questi immobili, questi beni
saliranno di prezzo se tutti li comprano, e se salgono di prezzo e li ho comprati anch’io,
guadagno. Può essere anche il titolo di un’azienda che sta per fallire, o un immobile in un’area
degradata, ma se tutti stanno comprando e continueranno a farlo il prezzo sale e posso poi
rivendere guadagnandoci.
Il problema fondamentale con le bolle speculative è che nessuno sa quando
scoppieranno. Entrare nel gioco della bolla troppo tardi, o non entrarci affatto, vuol dire
rinunciare a dei guadagni consistenti (i miei vicini sono diventati ricchi comprando ieri e
vendendo oggi a un prezzo maggiorato bulbi di tulipano, perché io dovrei essere così fesso da
non fare altrettanto?), ma rimanerci troppo a lungo vuol dire rischiare di trovarsi con bulbi di
tulipano acquistati a caro prezzo e che adesso valgono molto meno perché il prezzo è crollato,
ma soprattutto con un sacco di debiti contratti per comprarli. L’irrazionalità, nella bolla, sta
nel fatto che tutti ritengono di essere abbastanza furbi da vendere i bulbi di tulipano un
attimo prima che la bolla scoppi. E in genere non lo sono.
IV.6.2 Gli Stati Uniti e la politica “una casa per tutti”
Passando dalla teoria (e dalla storia) all’attualità, una bolla speculativa immobiliare, la
cosiddetta bolla subprime, inizia a gonfiarsi negli Stati Uniti nel 2001 e rappresenta la causa
più prossima della recessione attuale. La bolla subprime è assai simile a tante altre precedenti,
ma una serie di elementi ne amplificano enormemente l’impatto sull’economia mondiale.
Questi elementi sono la deregolamentazione - o liberalizzazione - dei mercati, la modifica
della distribuzione del reddito, la politica “una casa per tutti” portata avanti
dall’amministrazione USA, la politica monetaria espansiva della Banca Centrale Statunitense,
l’aumento del risparmio che giunge negli USA dalla Cina, lo sviluppo di nuovi strumenti
finanziari, il comportamento delle banche e delle agenzie di rating. Tutte concause, di
maggiore o minore rilevanza, dell’enorme bolla speculativa che inizia a gonfiarsi nel 2001 e
scoppia nel 2007.
Gli Stati Uniti arrivano al 2001 in una situazione molto particolare. E questo non tanto,
o almeno non solo, per gli attentati dell’11 settembre, ma soprattutto perché nel 2001 scoppia
un’altra bolla speculativa, quella sui titoli tecnologici, che aveva fatto aumentare
ininterrottamente il PIL statunitense per quasi dieci anni a un tasso medio di quasi il 4%
32
all’anno, e, come tutte le bolle, alla fine era scoppiata, mandando il sistema in recessione. Gli
attentati dell’11 settembre saranno quindi solo un pretesto in più per il Governo degli Stati
Uniti a intervenire pesantemente nell’economia per sostenere la domanda aggregata
(soprattutto) favorendo l’indebitamento privato.
Questa strategia raggiunge il culmine con la politica di “una casa per tutti” perseguita
per parecchi anni dalle amministrazioni statunitensi, sia democratiche sia repubblicane. Con
questa politica si cerca di incentivare la concessione di prestiti per acquistare una abitazione
anche a chi ha un basso “merito di credito”, ossia è considerato poco affidabile perché ha un
basso reddito o perché già in passato ha “dimenticato” di pagare le rate di qualche prestito.
Questi soggetti sono subprimer, hanno cioè un merito di credito inferiore al livello prime (negli
Stati Uniti esiste un punteggio che fornisce il merito di credito, si diventa subprimer con un
punteggio inferiore a 640); quando i subprimer ottengono un prestito, o un mutuo, questo
prestito è detto subprime.
L’idea di base parrebbe condivisibile: dare la possibilità a tutti, anche ai più poveri, di
acquistare una casa di proprietà, naturalmente non in contanti ma grazie a un prestito, un
mutuo ipotecario. A questo fine le autorità modificano l’assetto normativo in modo da rendere
più facile l’indebitamento privato, facendo sì che le banche possano chiedere meno garanzie
(guadagnando ugualmente) a chi richiede un prestito immobiliare. Il mio precedente libro,
“Recessione”, tratta in dettaglio queste pratiche. Qui basti dire che le banche possono prestare
con meno rischi perché diviene possibile assicurare più facilmente (e più economicamente) il
mutuo concesso presso società di assicurazione pubbliche come la Federal Housing
Administration (se il mutuatario non restituisce i soldi paga la FHA); e perché possono
vendere il mutuo concesso, guadagnandoci (ho prestato 100.000$, rivendo il mutuo a
120.000$) a società semi-pubbliche come Fannie Mae e Freddie Mac, che hanno lo scopo
istituzionale di ricomprare i mutui concessi dalle banche. In entrambi i casi si libera del
rischio che il mutuatario non ripaghi le rate. Si giunge addirittura a sanzionare le banche che
prestano troppo poco.
Anche la Banca Centrale Statunitense, La Federal Reserve (FED), ci mette poi del suo
nel far gonfiare le bolla. Coerentemente con quanto previsto da Hayek.
IV.6.3 La politica monetaria della FED
La Banca Centrale. La Banca Centrale è un’istituzione pubblica che può perseguire
diversi scopi, a seconda di quanto previsto dal suo statuto - molto diverso da Paese a Paese ma che sostanzialmente opera per tenere sotto controllo l’inflazione, per assicurare il regolare
funzionamento del sistema finanziario - semplificando un po’, per garantire l’operatività delle
banche private - e per favorire la crescita del reddito e dell’occupazione. Sebbene sul fatto che
anche l’ultimo punto sia di competenza della Banca Centrale non vi sia affatto unanimità tra
gli economisti, nel senso che secondo molti la Banca Centrale non dovrebbe affatto avere
questo tra i suoi obiettivi, storicamente le banche centrali si sono sempre occupate anche di
tali tematiche. La Banca Centrale comunque ha il compito principale di stampare e mettere in
circolazione la moneta, facoltà che è stata sottratta ai Governi perché in tutti i casi nei quali
l’hanno tenuta per loro ne hanno sempre largamente abusato, stampando molta più moneta
del necessario e generando micidiali fenomeni inflazionistici (i prezzi tendono a crescere in
maniera rilevante quando la quantità di moneta in circolazione aumenta).
Il controllo dell’offerta di moneta è dunque una variabile cruciale per l’economia, che si
è ritenuto opportuno affidare a una autorità indipendente dal Governo proprio per contenere
i pericoli inflazionistici. E le Banche Centrali hanno acquisito ancor più indipendenza dopo i
fenomeni inflazionistici - anche se non iper-inflazionistici - del periodo che va dal 1973 al
1985.
33
La moneta, però, non genera solo effetti negativi sull’economia. Se la Banca Centrale
aumenta (moderatamente) l’offerta di moneta vuol dire che fornisce più moneta alle banche
ordinarie, le quali possono ottenerla in prestito pagando un interesse e dando opportune
garanzie (si chiamano collaterali, generalmente titoli di Stato di proprietà delle banche
ordinarie: se queste non ripagano il proprio debito, i titoli diventano di proprietà della Banca
Centrale), oppure possono ottenerla come pagamento per aver venduto alla Banca Centrale
titoli, generalmente di Stato. Una volta che le banche ordinarie hanno ottenuto liquidità
(moneta) dalla Banca Centrale, a loro volta la prestano alle imprese o ai privati che ne hanno
bisogno. Quindi, quanto maggiore è la quantità di moneta che la Banca Centrale mette in
circolazione, tanto più alta sarà la quantità di prestiti che le banche ordinarie effettueranno e
quindi tanto più rilevante la spesa per investimenti e consumi privati finanziata con quei
prestiti. Un effetto simile si realizza quando la Banca Centrale fa pagare un interesse più basso
alle banche ordinarie nel prestar loro denaro contro collaterale, perché se si riduce il tasso
che pagano le banche ordinarie per prendere a prestito dalla Banca Centrale, si ridurrà anche
il tasso di interesse che le banche ordinarie fanno pagare ai privati nel concedere loro i
prestiti, e aumenterà quindi la domanda di prestiti dei privati, attratta dal minor costo. E
dunque, anche in questo caso, i privati si indebiteranno di più e spenderanno di più.
Con la bolla subprime accade esattamente tutto ciò: la Banca Centrale degli Stati Uniti
aumenta in maniera consistente l’offerta di moneta e abbassa il tasso di interesse, al di sotto
dei livelli già bassi raggiunti, a partire dal 2001. Lo fa perché nel 2001 l’economia statunitense
è in recessione, e quindi vuole incentivare i consumi e gli investimenti per sostenere la
domanda aggregata e la crescita; ma lo fa anche perché, grazie alla globalizzazione, che ha
ridotto i prezzi di molti beni (si pensi a tutta l’elettronica, al tessile, ecc.), il pericolo
inflazionistico connesso a un aumento dell’offerta di moneta sembra scongiurato.
Naturalmente questo comportamento favorisce l’indebitamento, e dunque il gonfiarsi
della bolla.
IV.6.4 Le banche e la cartolarizzazione (securitization)
In un contesto quasi totalmente liberalizzato, nel quale prestare è molto facile, è
possibile assicurare o vendere i mutui concessi, esiste una rilevante fornitura di liquidità a
bassi tassi da parte della FED, e soprattutto si è in presenza di un esplicito intervento
governativo che incentiva la concessione di prestiti immobiliari anche agli americani più
poveri, le banche hanno potuto incrementare fortemente i loro profitti ricorrendo a una serie
di importanti innovazioni finanziarie.
Al fine di capire bene come ciò sia possibile, e di evidenziare i rischi già inizialmente
insiti nell’intera procedura, è opportuno fare un passo indietro e porsi alcune domande che ai
più appariranno banali, ma che in realtà tanto banali non sono: Cos’è una banca? Come
funziona? Soprattutto: perché esistono le banche?
In estrema sintesi, possiamo dire che la banca svolge il ruolo di intermediario tra i
soggetti che possiedono denaro e desiderano prestarlo, come ad es. i risparmiatori, e i soggetti
che non possiedono denaro e hanno bisogno di prenderlo a prestito, come ad es. gli
imprenditori. La presenza di un intermediario è necessaria perché i primi desiderano
impiegare il loro denaro a breve termine (se voglio, devo poterlo recuperare rapidamente e
senza costi), in impieghi a basso rischio, mentre i secondi hanno bisogno di prestiti a lungo
termine (un finanziamento per un investimento che restituirò in dieci anni) e con maggiore
rischiosità, dato che le imprese possono fallire. La banca quindi raccoglie denaro a breve
termine e fornisce robuste garanzie di restituzione, per poi prestarlo a lungo termine a
soggetti che danno meno garanzie. Il compenso per questa attività è il differenziale tra i tassi,
nel senso che il tasso di interesse che la banca paga a chi le presta denaro è inferiore rispetto
al tasso di interesse che fa pagare a chi ottiene da lei denaro in prestito.
34
Le banche ordinarie ricavano il denaro da tre fonti diverse: i depositi dei correntisti; il
ricavato dall’emissione di obbligazioni e dalla loro vendita sul mercato; eventuali
finanziamenti ottenuti dalla Banca Centrale. Si tratta sempre di denaro non loro, che dovranno
restituire. Nel caso in cui i prestiti effettuati dalle banche con quel denaro non rientrassero,
perché ad esempio gli imprenditori ai quali hanno erogato il credito sono falliti, la banca
rimborserà chi le ha prestato il denaro attingendo al suo capitale, ossia alle somme stanziate
inizialmente dagli azionisti e immobilizzate dalle banche stesse proprio a tal fine. Per questo
motivo spesso le normative impongono che sia bassa la leva finanziaria, ossia il rapporto tra
quantità di prestiti che la banca può concedere e capitale. Si tratta di un rapporto comunque
sempre maggiore di uno: posso ad esempio prestare 400 milioni se ho un capitale di 100
milioni, ed ho dunque leva 400/100=4. Più la leva è bassa, più è solida la banca, perché
possiede molto capitale a fronte di pochi prestiti erogati, e quel capitale dovrebbe dunque
essere sufficiente per fronteggiare tranquillamente le eventuali insolvenze; ma più la leva è
bassa meno la banca è redditizia, perché la banca guadagna dai prestiti che effettua, e bassa
leva significa pochi prestiti. Che senso avrebbe, d’altro canto, raccogliere 1.000 milioni di
depositi dei correntisti se poi posso prestarne solo 400 perché ho 100 di capitale e la legge
impone una leva pari a 4? Così mentre le leggi pre-liberalizzazione cercavano di garantire la
stabilità del sistema finanziario imponendo basse leve finanziarie, gli istituti di credito
tentavano in ogni modo di alzare la leva per realizzare più profitti, magari salvaguardando in
qualche modo la loro solidità. Con discreto successo negli Stati Uniti dove, prima della crisi, la
liberalizzazione dei mercati finanziari, unita alla creazione di nuovi strumenti finanziari, ha
permesso di alzare parecchio il rapporto di leva apparentemente senza rischi.
I nuovi strumenti finanziari permettono infatti non solo di alzare la leva “effettiva” ma
anche di scaricare su altri i rischi di insolvenza dei mutuatari attraverso il meccanismo della
“cartolarizzazione” (securization). In pratica la banca eroga il mutuo, poi recupera il denaro
che ha prestato (ed elimina il rischio connesso alla possibile non restituzione del prestito)
vendendo il mutuo a un’altra società finanziaria, detta “società veicolo”, che appartiene alla
stessa holding della banca, oppure a Fannie o Freddie; e queste società, che non hanno un vero
e proprio capitale, finanziano l’acquisto, e si mettono al riparo dal rischio, emettendo titoli
obbligazionari particolari, noti come Mortgage backed Securities, MBS, che pagano interessi
molto alti se tutto va bene, ma non danno luogo a rimborsi se i mutuatari non pagano; a sua
volta le società finanziarie che hanno comprato questi titoli, per finanziarsi e coprirsi dal
rischio, ne emettono altri, noti come Collateralized Debt Obligations (CDO), composti sia da
MBS sia da altri titoli più sicuri, titoli tra l’altro omaggiati di tripla A da parte delle agenzie di
rating, e quindi vendibili ad alto prezzo. E così via, emettendo CDO al quadrato (CDO composti
da CDO) e altri titoli “esotici”. Il rischio si diluisce nel sistema: alla fine ogni risparmiatore che
possiede una CDO garantisce una minima parte, un centesimo diciamo, del mutuo originario.
Così, se qualche mutuatario fallisce, l’impatto del fallimento è minimo. Certo, se invece sono in
molti a fallire possono esserci dei problemi… Ma mica falliranno tutti, no?
Grazie ai nuovi strumenti finanziari, e alla cartolarizzazione, le banche modificano il
loro tradizionale comportamento, noto come “originate to hold” (erogare un mutuo per
tenerlo presso di sé), che le portava a valutare accuratamente la qualità dei mutuatari prima
di concedere loro un prestito, perché se le rate non venivano pagate la banca perdeva soldi. Il
nuovo comportamento è noto come “originate to distribuite” (erogare un mutuo e rivenderlo),
e le porta a prestare senza dar troppo peso al merito di credito dei mutuatari, poiché il
prestito comunque non rimarrà nei loro bilanci. Così facendo, tra l’altro, incrementano
notevolmente i profitti. Infatti quando la banca concede un prestito a un soggetto rischioso, ad
esempio un subprimer, richiede il pagamento di un interesse più elevato, proprio perché il
soggetto è rischioso. Il valore del mutuo è dunque maggiore, anche se è maggiore anche il
rischio. Ma lei quel rischio lo cede subito ad altri, quindi ottiene un profitto maggiore, proprio
35
perché il valore del mutuo è maggiore, senza subire le perdite (potenziali) derivanti dal
maggior rischio.
IV.6.5 La bolla subprime
Tutto ciò porta al gonfiarsi di una bolla nel settore immobiliare: incentivati dalla
politica governativa e dalla disponibilità di prestiti a basso costo, gli statunitensi si indebitano
per acquistare abitazioni. La domanda di abitazioni cresce, e con l’aumento della domanda di
abitazioni aumenta anche il loro prezzo. E qui si innesca un meccanismo che ormai dovremmo
conoscere bene, ma che assume un aspetto del tutto peculiare, perché le banche, dopo aver
finanziato - e guadagnato finanziando - i prestiti per acquisto di immobili destinati ai soggetti
ad alto e medio reddito, per incrementare ulteriormente i loro profitti iniziano a coinvolgere
anche i soggetti più rischiosi, quelli a reddito più basso, quelli che non sembrano avere i mezzi
per ripagare il prestito. Tanto: 1) la banca è protetta dal meccanismo della cartolarizzazione,
se le cose vanno male lei non ci perde; 2) il mutuatario, anche se non riuscisse con il suo
reddito a ripagare le rate del mutuo, potrà sempre contare sul fatto che il gonfiarsi della bolla
farà aumentare rapidamente il valore del suo immobile, e pagare le rate con un nuovo
finanziamento garantito proprio da quell’incremento di valore (“la mia casa valeva 100.000, la
ho ipotecata e mi hai concesso un prestito di 100.000$; ora vale 200.000$, ho le garanzie per
farmi prestare altri 100.000$ con una seconda ipoteca”); 3) se le cose vanno male male, il
mutuatario potrà dichiarare insolvenza, mettere le chiavi dell’appartamento in una busta e
restituirle alla banca, che diventerà proprietaria di un immobile che cresce di valore nel
tempo, e il subprimer non avrà altri obblighi. Ma quest’ultimo scenario è assai improbabile,
proprio perché il prezzo degli immobili sta aumentando, dato che tutti domandano immobili,
e quindi è facile ottenere sempre nuovi prestiti garantiti dall’incremento di valore degli
immobili e con quelli non solo ripagare le rate del primo finanziamento, ma anche comprare
una macchina nuova, farsi una crociera, godersi la vita... Perché mai dovrebbe preferire fallire?
La politica “una casa per tutti”, dunque, funziona. Tutti comprano casa, tutti
rifinanziano il mutuo, tutti utilizzano il rifinanziamento non solo per pagare le rate del vecchio
mutuo ma anche per aumentare la domanda aggregata, l’economia degli Stati Uniti va come un
treno: tra il 2001 e il 2007 il PIL cresce in media tra il 3% e il 4% all’anno. L’intera costruzione
si regge però sull’idea che sia sempre possibile pagare le rate del mutuo precedente
contraendo un nuovo mutuo. E poiché si può contrarre un nuovo mutuo garantito
dall’incremento di valore dell’immobile solo se il prezzo degli immobili continua a salire, tutto
si regge, in ultima istanza, sul fatto che il prezzo degli immobili continui a salire.
Indefinitamente. Cosa che, come sappiamo, non succederà: tutte le bolle, prima o poi,
scoppiano.
IV.6.6 La Gran Bretagna
Gli Stati Uniti non sono l’unico Paese che sostiene la domanda aggregata con
l’innovazione finanziaria, il nuovo comportamento delle banche (originate to distribute) e, in
ultima istanza, la bolla. Anche in Gran Bretagna la situazione è simile. Il paese, infatti, non fa
certamente parte dei NeoMercantilisti, poiché il contributo alla domanda aggregata fornito
dalle esportazioni nette è costantemente negativo: almeno a partire dalla fine degli anni
ottanta, e con una parziale eccezione a metà dei novanta, i deficit commerciali sono sempre
rilevanti e sistematici. Quindi, crescita di bolla. Proprio in Gran Bretagna è accaduto, anche se
in un mercato diverso dall’immobiliare, che una società emittente carte di credito a rimborso
rateale abbia revocato le carte ai clienti che pagavano regolarmente le rate, proprio perché il
suo vero guadagno non derivava da questi pagamenti, ma dagli ulteriori prestiti concessi ai
clienti insolventi, prestiti che potevano essere venduti con profitto ad altre società finanziarie.
36
Ed evidentemente un cliente che paga regolarmente non ha bisogno di nuovi prestiti, quindi è
un pessimo cliente!
Grazie alla bolla anche la Gran Bretagna riesce a far aumentare il suo PIL a tassi medi
annui, tra la metà degli anni ’90 e il 2004, a tassi medi annui superiori al 3%. È una crescita in
gran parte derivante dal settore terziario, in particolare finanziario, sostenuta in una prima
fase (fino al 2000) dall’investimento privato, soprattutto immobiliare, poi anche dal
contributo dell’investimento pubblico. Grazie alla bolla la disoccupazione quasi scompare,
scendendo al 5%, al di sotto di tutti i grandi Paesi europei, Germania compresa (dove è al 9%);
anche il debito pubblico è molto basso, attorno al 45% del PIL nel 2007, ma come in tutti i
Paesi della bolla quello privato è particolarmente alto, superiore sempre nel 2007 al 180% del
PIL.
IV.6.7 L’Irlanda
Più interessante la situazione Irlandese, che ci riguarda maggiormente perché L’Irlanda
fa parte dell’Unione Monetaria Europea, ossia adotta l’euro come moneta, mentre la Gran
Bretagna non ne fa parte, e utilizza ancora la sterlina.
L’Irlanda era, sin quasi alla fine del secolo scorso, un Paese che presentava elevati tassi
di emigrazione e un’economia depressa. Poi, però, intraprende una politica di sostegno alla
domanda aggregata (e di crescita) basata sull’attrattività degli Investimenti Diretti Esteri. In
pratica, cerca di indurre le multinazionali straniere a localizzarsi sul suo territorio. Il Paese già
aveva alcune caratteristiche capaci di attrarre le multinazionali, come una discreta dotazione
infrastrutturale (porti, strade, ferrovie), la lingua inglese parlata dalla popolazione, una forza
lavoro giovane e ben istruita. Le politiche intraprese aggiungono a questi elementi un mercato
del lavoro fortemente liberalizzato, con la possibilità di assumere e licenziare senza
particolari problemi, e soprattutto una fiscalità di favore, ossia tasse societarie molto basse
per le imprese che avessero deciso di localizzarsi in Irlanda. Quest’ultima strategia, ossia il
tentativo di attrarre Investimenti Diretti Esteri attraverso un drastico abbassamento delle
imposte societarie, è nota come dumping fiscale.
La strategia irlandese ha successo. Desiderose di collocare “teste di ponte” all’interno
dell’eurozona, e attratte dalla fiscalità di favore e dagli altri elementi di vantaggio offerti
dall’Irlanda, molte multinazionali estere, in particolar modo statunitensi, localizzano le
proprie sedi societarie - e in alcuni casi anche i propri impianti produttivi, soprattutto per le
imprese che fornivano servizi - in Irlanda.
Quando una multinazionale si installa in un Paese, ha bisogno innanzitutto di una sede,
ossia un immobile; ma poi avrà bisogno, o almeno i propri dipendenti e dirigenti avranno
bisogno, di ulteriori immobili residenziali per alloggiare, di ristoranti, di pub, di lavanderie,
ecc. In sostanza, la localizzazione di una multinazionale in un Paese piccolo come l’Irlanda solo 4,5 milioni di abitanti - ha un impatto notevole sulla domanda di immobili e di servizi. Se
poi le multinazionali che si insediano in loco sono molte, l’impatto è moltiplicato.
Sappiamo già come va la storia. La domanda di immobili cresce, il prezzo degli
immobili aumenta, e si gonfia una bolla speculativa finanziata dalle inizialmente piccole
banche locali. Gli irlandesi iniziano quindi ad acquistare immobili, terreni, opzioni su terreni,
finanziandosi con il ricorso al credito immobiliare fornito generosamente dalle banche, con la
finalità di rivendere questi immobili a prezzi maggiorati dopo poco tempo. Per parecchi anni
la cosa funziona, e l’Irlanda smette di essere un Paese povero: i suoi abitanti diventano
sempre più indebitati, ma oltre a investire comprando immobili consumano, incrementando
così la domanda aggregata e facendo crescere produzione e occupazione. Da un Paese di
emigrazione, l’Irlanda inizia ad essere un Paese di immigrazione, con una gran quantità di
lavoratori che affluisce dal resto d’Europa per lavorare nei servizi di supporto alla crescita
finanziata dall’arrivo delle multinazionali (ristoranti, alberghi, servizi alle persone, ecc.). Tra
37
l’altro le multinazionali producono e esportano (servizi, ma non solo) facendo crescere
enormemente anche le esportazioni nette: dalla metà degli anni ottanta le esportazioni
irlandesi superano le importazioni, ma il dato diventa significativo per dimensione
soprattutto alla fine del secolo, con surplus commerciali imponenti e crescenti, mai inferiori al
10% del PIL. Nel 2001, addirittura, le esportazioni irlandesi superano il 100% del PIL,
generando un surplus commerciale ben oltre il 15% del PIL! PIL che cresce a sua volta a tassi
elevatissimi: il 10% all’anno tra il 1995 e il 2000, il 5% dopo, fino al 200. Con il PIL cresce il
prelievo fiscale, rendendo particolarmente floride le finanze dello Stato, tanto che il rapporto
debito pubblico/PIL dell’Irlanda nel 2007 è pari al 25%: un risultato eccellente, migliore ad
esempio della Germania, che nello stesso anno ha un rapporto debito pubblico/PIL pari al
65%. Le cose sono però diverse se guardiamo al debito privato, che nel 2007 è superiore al
250% del PIL. In ogni caso, si parla dell’Irlanda come di un modello da seguire, e per il suo
altissimo tasso di crescita il Paese viene chiamato “tigre celtica”, a ricordare i Paesi orientali
che crebbero tantissimo sino al 1997, noti come “tigri asiatiche” (Corea del Sud, Hong Kong,
Singapore, Taiwan).
IV.6.8 La Spagna
La situazione spagnola è parzialmente simile a quella irlandese, con meno investimenti
diretti esteri, con poco coinvolgimento col sistema bancario anglosassone e moderato uso dei
nuovi strumenti finanziari. Anche in questo caso è drammatica la situazione delle esportazioni
nette: da sempre la Spagna importa infatti più di quanto esporta, sperimentando quindi
sistematici deficit commerciali, e con l’ingresso nell’Eurozona la situazione peggiora
ulteriormente. Nonostante questo la performance del Paese sembra per lungo tempo
invidiabile, con un PIL in continua crescita e debito pubblico contenuto. Questo grazie al
gonfiarsi di una bolla speculativa molto tradizionale: i prezzi degli immobili crescono, gli
spagnoli tentano di sfruttare la situazione acquistando immobili per rivenderli a prezzi
maggiorati, l’aumento di domanda di immobili ne fa crescere ancora di più il prezzo, le banche
finanziano queste acquisizioni immobiliari, il settore dell’edilizia prospera costruendo sempre
più immobili, l’occupazione nell’edilizia aumenta, e aumentano anche i redditi prodotti nel
settore, tanto che il Governo sposta l’imposizione fiscale in gran parte proprio sugli immobili.
Anche se il sistema industriale spagnolo è debole e le esportazioni si mantengono depresse, la
bolla immobiliare permette al Paese di far aumentare il PIL a tassi costanti e molto alti (quasi
il 4% annuo tra il 1995 e il 2005), riducendo del 5% il tasso di disoccupazione. Tasso di
disoccupazione che rimane comunque eccezionalmente alto, come è tradizione in Spagna a
causa dell’allora generosissimo sussidio di disoccupazione e della conseguente diffusione del
lavoro nero (meglio lavorare in nero e tenermi il sussidio che regolarizzarmi e perdere il
sussidio…). Anche questo Paese arriva alla crisi con un basso rapporto debito pubblico/PIL,
pari al 36% nel 2007. Il debito del settore privato è però altissimo, superiore al 210% del PIL
nel 2007.
IV.6.9 L’Islanda
L’Islanda, un piccolissimo Paese di 320.000 abitanti che non fa parte dell’Unione
Economica e Monetaria Europea, sino agli anni novanta del secolo scorso aveva un’economia
basata principalmente sulla pesca e sulla lavorazione di metalli non ferrosi (in particolare,
alluminio). A partire dagli anni novanta il Paese gode di una crescita tumultuosa del settore
finanziario, che diviene da quel momento il più importante dell’intera economica, arricchendo
gli islandesi grazie al gonfiarsi una bolla speculativa immobiliare e finanziaria assai simile a
quella irlandese, ma con alcune specificità. Infatti il sistema finanziario islandese è oggetto,
alla fine degli anni ottanta, di una importante politica di liberalizzazione, mentre le banche
prima di proprietà pubblica presenti nel Paese vengono privatizzate vendendole a
38
imprenditori islandesi e poste in competizione tra loro: chi riuscirà a crescere di più acquisirà
o marginalizzerà le altre. Inizia così una competizione tra le banche per espandersi il più
possibile, all’interno e all’estero, soprattutto sui mercati anglosassoni, mentre la Banca
Centrale chiude benevolmente entrambi gli occhi e, nel tentativo di combattere l’inflazione,
alza il tasso dell’interesse fino all’incredibile livello del 15%. E le banche ordinarie, nel
tentativo di attrarre depositanti per ingrandirsi, offrono anch’esse interessi sempre più alti a
chi deposita presso di loro (anche perché al 15% di interesse non possono certo farsi prestare
denaro dalla Banca Centrale).
L’innalzamento del tasso di interesse, però, attira capitali dall’estero, ponendo il Paese
al centro del meccanismo cosiddetto del carry trade: prendo a prestito denaro dove il tasso di
interesse è basso, e dunque prendere a prestito conviene (tipicamente: in Giappone) e
impiego il denaro dove il tasso di interesse è elevato, e dunque comprare titoli obbligazionari
conviene (tipicamente: l’Islanda). Grande guadagno con poca fatica. Questo ingente flusso
finanziario in ingresso, in un Paese così piccolo, viene impiegato per comprare titoli e
immobili, ne fa salire il prezzo facendo gonfiare sempre più la bolla.
Le banche, nel frattempo, nella loro crescente concorrenza, riescono ad attirare gli
ingenti capitali esteri, a finanziare gli acquisti di immobili, a sostenere la bolla; ma per
superare le altre banche non è sufficiente, bisogna rischiare di più, attirando sempre nuovi
capitali grazie ad elevati tassi di rendimento. Ma per fornire rendimenti elevati a chi deposita
denaro presso di loro devono a loro volta riuscire a spuntare alti rendimenti sull’impiego di
quel denaro. Così iniziano a investire pesantemente sul mercato dei titoli subprime
statunitense, mercato che come sappiamo rende molto, anche se è un tantino rischioso...
Ancora non basta, però. Devono crescere. Per crescere, hanno bisogno di depositi, ossia di
gente che depositi presso di loro il proprio denaro. Così, aprono filiali in Olanda e, soprattutto,
in Gran Bretagna. In particolare, la Icesave, una controllata online della Landsbanki, la più
importante banca islandese, offre agli inglesi e agli olandesi conti correnti ad altissimo
rendimento, circa il doppio di quello offerto dalle altre banche inglesi e danesi. Il successo è
immediato, soprattutto in Gran Bretagna, dove 230.000 correntisti depositano circa 10
miliardi di sterline su quei conti. È importante comunque sottolineare che Icesave è una
branch di Landsbanki: ossia una filiale che, per legge, tutela i depositanti con la normativa di
assicurazione dei depositi del Paese di origine, l’Islanda, e non con quella del Paese di
installazione della filiale, la Gran Bretagna (e l’Olanda). Si tratta di una distinzione cruciale,
perché appellandosi a quella l’Islanda potrà ottenere condizioni molto più favorevoli quando,
come vedremo, arriveranno i problemi.
Perché che i problemi arriveranno è scritto nelle cose: l’enorme liquidità che giunge in
Islanda fa gonfiare una bolla enorme, che come tutte le bolle, aspetta solo una spinta per
scoppiare. Sino ad allora, però, tutti felici e contenti: anche qui l’economia va come un treno!
Nel decennio tra il 1999 e il 2008 il PIL aumenta, in media, del 3% all’anno; ma prima della
crisi, nel 2007, il debito privato viaggia verso il 450% del PIL.
IV.7 I paesi del debito
39
IV.7.1 La Grecia
Il Paese che più di ogni altro è diventato l’emblema del sostegno alla domanda
aggregata attraverso politiche di intervento pubblico nell’economia finanziate con
indebitamento, e che più di ogni altro ne ha pagato le conseguenze, è la Grecia, spesso additata
come l’esempio più significativo di “lassismo fiscale”, ossia di politica di bilancio fuori
controllo. Fino al 1997 era un Paese poverissimo, con un settore pubblico inefficiente,
infrastrutture deboli, rilevante quota di economia sommersa, forte evasione fiscale, che
presentava i tassi di crescita più bassi d’Europa e un settore esportatore estremamente
debole. Quest’ultimo elemento è particolarmente significativo: la Grecia ha sempre avuto,
almeno dal 1980, un rilevante deficit commerciale, ossia importazioni molto maggiori delle
esportazioni. Questo deficit commerciale era pari a circa il 5% del PIL nel 1980, poi peggiora
ancora, giungendo attorno al 10% nel 2000 e andando quasi al 15% nel 2008! In sostanza, la
Grecia non riesce ad esportare niente ed importa tutto o quasi quello che consuma. Una
situazione assai preoccupante. Poi, a partire dal 1997, quando le viene affidata
l’organizzazione dei Giochi Olimpici del 2004, il Paese inizia una massiccia politica di spesa
pubblica espansiva, sia per costruire gli impianti necessari a ospitare i Giochi, sia per
incrementare il livello di benessere della popolazione. E questa politica funziona: il tasso di
crescita del PIL triplica, la disoccupazione si riduce, il benessere aumenta. Nel 2008 la Grecia
supera, per PIL pro capite (ossia PIL diviso per il numero di abitanti), la stessa Italia! La spesa,
però, è finanziata in deficit: il debito, quindi, cresce. Inoltre, con l’aumento del reddito i greci,
che continuano a non riuscire a esportare quasi nulla, consumano di più e, dunque, sono
costretti a importare di più. Il deficit commerciale peggiora ancora. E come fanno a comprare
questi beni di importazione, se non possono pagarli esportando? Molto semplice, facendosi
prestare il denaro. Anche per questa via il debito, in questo caso con i non residenti, cresce.
Semplificando un po’, funziona così: il Governo spende denaro che non ha, e per
procurarselo vende titoli, ossia si indebita, all’interno del Paese ma soprattutto all’estero; chi
incassa i soldi spesi dal Governo (i dipendenti pubblici, le imprese che costruiscono le strade
finanziate con spesa pubblica, i pensionati pubblici, ecc.) compra beni, che sono quasi sempre
prodotti all’estero. Possiamo quindi dire che il debito finanzia le importazioni. Il debito
pubblico inoltre cresce, e poiché una quota significativa dei titoli di quel debito è stata
venduta all’estero, aumenta anche il debito estero.
Bisogna anche dire che la Grecia si allarga un po’ nel cercare di migliorare il benessere
della popolazione: il numero dei dipendenti pubblici aumenta enormemente, alle figlie dei
dipendenti pubblici nubili o divorziate è garantita una pensione mensile di 1.000 euro, è
spesso previsto un premio in denaro per chi arriva puntuale al lavoro, la quattordicesima
mensilità comprende anche l’indennità estiva... insomma, una versione molto generosa di
Stato Sociale. Soprattutto, senza altre risorse per mantenerla se non i debiti. Inoltre il livello
dei salari, e quindi dei prezzi, va aumentando più di quanto non aumenti negli altri Paesi
europei, rendendo ancora più difficile vendere le (scarse) produzioni greche all’estero.
Anche se con ritardo rispetto alla maggior parte degli altri Paesi, nel 2001 la Grecia
entra a far parte dell’eurozona, e adotta l’euro come moneta. Questo evento determina
ulteriori opportunità per i Greci, ma anche potenziali problemi.
Per quanto concerne i problemi, è da ricordare che la permanenza nell’eurozona
impone il rispetto di un trattato noto come Patto di Stabilità e Crescita, secondo il quale i Paesi
devono mantenere un rapporto tra deficit e PIL inferiore al 3%, pena pesanti sanzioni.
Evidentemente la Grecia, se vuole sostenere la domanda aggregata in maniera massiccia, non
può limitarsi a una spesa in deficit pari al 3%, ma deve andare oltre (di fatto arriverà al
15,4%). Come conciliare questa esigenza con il rispetto del Patto? Niente di più semplice,
40
basta truccare i bilanci dello Stato! E la Grecia lo fa, sia con manovre di sofisticata ingegneria
finanziaria - ricorrendo all’assistenza di alcune importanti banche della City londinese-, sia in
maniera più rozza, imponendo all’ufficio nazionale di statistica di scrivere cifre inferiori al
reale quando comunicava il deficit di bilancio ad Eurostat, l’ufficio statistico europeo.
Per quanto invece concerne le opportunità, l’appartenenza all’eurozona permette alla
Grecia di finanziare il proprio debito a tassi di interesse molto bassi, perché inizialmente si
credeva che i Paesi dell’eurozona non potessero fallire. I mercati, quindi, ritenevano i titoli
Greci quasi altrettanto sicuri dei titoli tedeschi, e quindi non richiedevano il pagamento di
interessi più alti per fronteggiare il maggior rischio. Il fatto che non si conoscesse l’esatto
livello del debito greco, a causa dei trucchi contabili, e la circostanza che prima della crisi
finanziaria USA nessuno fallisse, rendendo tranquilli i prestatori, fanno sì che fino al 2009 la
Grecia possa finanziarsi sul mercato con grande facilità e a basso costo. Nessun problema,
quindi, anche per comprare merce all’estero, alla Grecia si fa credito con facilità. Nel 2009,
prima della crisi, il debito pubblico “ufficiale” del Paese Grecia è al 115% del PIL.
IV.7.2 Il Portogallo
Una situazione intermedia tra quella Spagnola e quella Greca, senza però i bilanci
truccati, caratterizza il Portogallo, un Paese nel complesso povero, anche se con tassi di
aumento del PIL - almeno sino al 1997 - superiori a quelli della Grecia. Il problema sono
sempre le esportazioni nette: il Portogallo importa tanto e non esporta (quasi) nulla. Dal 1970
le importazioni sono sempre maggiori delle esportazioni, e questo divario cresce col tempo.
Come sostenere, quindi, la domanda aggregata? Facendo spesa pubblica in deficit, e
finanziando quest’ultimo ricorrendo all’indebitamento pubblico. E come pagare le
importazioni? Facendosi prestare denaro dall’estero, esattamente come la Grecia. Al debito
pubblico e al debito estero si somma in questo caso la spesa privata finanziata ricorrendo al
credito bancario, col risultato che crescono costantemente tanto il debito privato quanto
quello pubblico (quest’ultimo parte da livelli bassi, inferiori ad es. a quelli tedeschi, ma poi,
quando il sostegno all’economia diventa massiccio, si impenna). Con l’aggravante che in
Portogallo le banche non solo hanno concesso ingenti prestiti ai residenti, ma hanno anche
contribuito a finanziare la bolla speculativa spagnola. Sia le finanze pubbliche portoghesi, sia il
sistema bancario, sono quindi molto fragili: nel 2007 il debito pubblico raggiunge il 65% del
PIL, mentre il debito privato, sempre nel 2007, supera il 220% del PIL. Ma come sempre, fino
alla crisi, le spese finanziate indebitandosi hanno grandiosi effetti sul benessere della
collettività: i tassi di disoccupazione sono inferiori a quelli di Italia, Francia, Grecia, Gran
Bretagna e persino Germania. Rimane l’assenza di esportazioni e l’impossibilità di ricorrere in
eterno all’indebitamento per sostenere la domanda aggregata: come fare se non ci prestano
più i soldi? Soprattutto, come fare se li rivogliono indietro.
IV.7.3 L’Italia
Infine, l’Italia. Non solo per patriottismo, l’Italia merita una trattazione più dettagliata,
per la quale rimandiamo al capitolo successivo.
41
V. l’Italia prima della crisi
V.1 L’Italia nell’ultimo trentennio
Sino ai primi anni novanta del secolo scorso, la politica economica italiana è stata
caratterizzata da un costante sostegno della domanda aggregata realizzato attraverso il
combinato disposto di svalutazioni competitive e spesa pubblica finanziata in deficit. Poi la
possibilità di ricorrere alle svalutazioni competitive si è progressivamente attenuata, il debito
pubblico è aumentato a causa dell’eccesso di spesa in deficit e attorno al 1994 il Paese ha
anche smesso di crescere. Con l’ingresso nell’Eurozona, nel 1999, la possibilità di ricorrere a
svalutazioni competitive è scomparsa del tutto, mentre il rilevante debito pubblico ha reso
sempre più evidenti gli effetti negativi dell’indebitamento, senza però che riuscissimo
realmente a ridurlo, anzi. Abbiamo quindi sia problemi di domanda aggregata sia problemi di
crescita, oltre al debito pubblico più alto d’Europa.
Per quanto concerne la domanda aggregata, le opzioni a disposizione del Paese si erano
ridotte già alla metà degli anni ottanta, quando si era cercato di limitare il ricorso alle
svalutazioni competitive perché si riteneva potessero favorire fenomeni inflazionistici, ma il
cambiamento epocale è con l’ingresso nell’eurozona, visto che come sappiamo da quel
momento le svalutazioni diventano impossibili, e le nostre esportazioni nette ne risentono
sempre più. Formalmente limitato dagli accordi europei, ma di fatto meno problematico, è
invece l’uso della politica di bilancio espansiva: il Paese si ritrova infatti con il livello di debito
più alto d’Europa, sia in percentuale sia in valore assoluto, e incrementarlo per sostenere la
domanda aggregata sembrerebbe fuori discussione, perché l’Europa fa del debito il nemico
pubblico numero uno. Ma sotto questo aspetto l’ingresso nell’eurozona ha avuto invece effetti
assai diversi, dato che i mercati hanno inizialmente assegnato ai titoli del nostro Paese un
livello di rischio prossimo a quello dei Paesi più affidabili d’Europa, permettendoci di
collocarli con facilità sul mercato pagando interessi inferiori rispetto a quelli pagati in
precedenza; e con un debito che raggiunge nel 1999 il 114% del PIL è un bel risparmio.
Avremmo così potuto destinare le minori spese per interessi alla riduzione del debito o al
finanziamento della crescita, ma in realtà il massimo che siamo riusciti a fare è sfruttare la
facilità ed economicità del collocamento dei titoli sul mercato per incrementare (non ridurre,
incrementare) il ricorso alla spesa pubblica improduttiva realizzata in deficit, al solo fine di
compensare l’impatto negativo sulla domanda aggregata derivante dalla riduzione delle
esportazioni nette, riuscendoci tra l’altro solo in parte. Con il risultato che il debito, pur se
finanziato a tassi molto bassi, è aumentato, attirando su di noi i rimproveri europei e
portandoci a basarci sempre più sull’incremento delle imposte e un po’ meno sull’incremento
del debito per finanziare l’incremento di spesa pubblica (perché di ridurla neanche a
parlarne). Creando così, con le maggiori imposte, ulteriori problemi alla competitività delle
nostre imprese.
Per quanto invece riguarda la crescita, il suo progressivo rallentamento è dovuto al
progressivo rallentamento del tasso di crescita della produttività del lavoro, che in alcuni anni
è addirittura diventato negativo. Meno produttività rispetto al nostro passato dunque, ma
anche meno produttività rispetto agli altri Paesi europei e molta meno produttività rispetto ai
Paesi extra-europei, Stati Uniti soprattutto. E l’ingente spesa pubblica era indirizzata solo in
minima parte ad investimenti infrastrutturali, o in ricerca, o in formazione, che avrebbero
modernizzato il Paese e contribuito a superare il problema della bassa produttività. Mentre
stringenti vincoli politici ed elettorali impedivano ai nostri Governi di realizzare quelle
riforme che sarebbe stato necessario realizzare vent’anni prima, ma erano impopolari per un
42
Paese abituato a vivere al di sopra dei propri mezzi e che avrebbe senza dubbio punito un
Governo che lo avesse fatto tornare con i piedi per terra.
Passiamo ora ad analizzare in maggior dettaglio le cause di questa situazione,
scomponendole come usuale tra quelle che hanno determinato una bassa crescita e quelle che
hanno invece avuto un impatto negativo sulla domanda aggregata, anche per individuare le
possibili soluzioni ai nostri problemi e la loro praticabilità. Fermo restando che in questo
capitolo la descrizione di ciò che è accaduto si arresta prima della crisi, che sarà trattata
invece nel successivo capitolo VII.
V.2 Le cause della bassa crescita italiana
V.2.1 Investimenti carenti e bassa crescita
Come sappiamo dal capitolo I, per crescere si possono porre in essere diverse strategie:
investire in capitale fisico, investire in capitale umano, investire in ricerca e sviluppo o
riformare le istituzioni; questi investimenti (e/o queste riforme) possono essere portate
avanti dal Governo, dai privati residenti e/o dai privati non residenti. Non è quindi
sorprendente che la bassa crescita che ha caratterizzato l’Italia sino alla crisi sia ascrivibile
anche (non solo, ma anche) a insufficienti investimenti e/o riforme, ed è cruciale, anche in
prospettiva futura, individuare le cause di questa mancanza di investimenti e riforme. Si tratta
però, come sarà subito evidente, di un elenco sterminato che rende assai complesso puntare
su rapidi interventi, soprattutto nelle attuali contingenze.
L’Italia partiva da una modesta dotazione di capitale fisico, umano e tecnologico, e
dunque da poco produttività, ma aveva anche bassi salari, più bassi di molti nostri partner
europei. Questi bassi salari compensavano la bassa produttività e permettevano di mantenere
competitive le nostre produzioni, anche grazie alle svalutazioni competitive. Poi, però,
abbiamo lasciato crescere i salari più di quanto crescessero quelli degli altri Paesi europei,
abbiamo lasciato crescere la produttività meno di quanto crescesse negli altri Paesi e abbiamo
perso le svalutazioni competitive. Col risultato di ridurre progressivamente la competitività
delle nostre produzioni. A quel punto avremmo dovuto, se volevamo mantenere la crescita
salariale, far crescere la produttività più degli altri Paesi investendo più di loro, e comunque
più di quanto stavamo facendo. Avremmo cioè dovuto innescare un importante processo di
crescita economica. O avremmo almeno dovuto interrompere la crescita salariale. E invece
sino al 1995 abbiamo investito addirittura meno degli altri, recuperando qualcosa solo dopo il
1995, e abbiamo continuato a lasciar crescere i salari, avvicinandoci sempre più ai livelli
retributivi dei Paesi “ricchi” dell’Europa.
Insomma, per permetterci la crescita salariale che abbiamo realizzato avremmo dovuto
investire di più. Non lo abbiamo fatto. La causa della nostra situazione attuale, in una cruda ed
estrema sintesi, è questa.
È importante rilevare come la carenza di accumulazione di capitale nel nostro Paese
interessi certamente il capitale fisico (impianti produttivi, fabbriche, robot industriali), ma
anche e forse soprattutto il capitale umano e tecnologico. Ossia proprio quegli elementi che
contribuiscono di più alla produttività. Quindi non solo avremmo dovuto investire di più, ma
avremmo dovuto indirizzare una quota maggiore dell’investimento verso ricerca e sviluppo,
formazione, innovazione tecnologica. E invece no. Abbiamo fatto, certamente sino alla crisi
(ma anche dopo, per un po’), l’esatto contrario: pochi investimenti, e di quei pochi
investimenti la maggior parte è stata indirizzata quasi esclusivamente verso settori
tradizionali e non verso l’innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione.
Il basso livello degli investimenti, così come la loro errata tipologia, ha interessato
tanto gli investimenti pubblici quanto quelli privati. Particolarmente grave è stato il basso
livello degli IDE in ingresso: in assenza di investimento autoctono in ricerca e sviluppo,
43
tecnologia e formazione, la delocalizzazione produttiva operata dalle multinazionali sarebbe
infatti una soluzione ottimale, se ben gestita, che permette di trarre vantaggio dalle
innovazioni senza aver contribuito a finanziarle. Ma se non ci sono IDE, non ci sono spillover.
V.2.2 La dinamica degli investimenti privati e le sue cause
Tra il 1961 e il 1970 gli investimenti in Italia crescono in media del 5,1% all’anno; tra il
1971 e il 1980 del 2,7%; tra il 1981 e il 1990 del 2,2%; tra il 1991 e il 2000 dell’1,3%; tra il
2000 e il 2010 si riducono dello 0,4%. Si tratta di dati quasi sempre inferiori alla media
europea, statunitense e giapponese. Dimostrando come gli investimenti siano costantemente
stati troppo bassi per recuperare il ritardo di accumulazione di capitale che caratterizzava il
Paese, e soprattutto troppo bassi (e in settori troppo tradizionali e a basso livello tecnologico)
per permetterci di aumentare la produttività in maniera sufficiente a compensare l’aumento
dei salari. Questa debolezza degli investimenti ha interessato tanto la componente privata,
quanto quella pubblica, ma poiché le cause delle due debolezze sono in parte diverse, può
essere opportuno trattarle separatamente. Dobbiamo quindi innanzitutto domandarci perché
gli imprenditori italiani investono poco e, soprattutto, perché gli imprenditori stranieri non
voglio investire nel nostro Paese, ricordando sempre che chi investe lo fa per guadagnarci,
non per farci un favore.
Nella maggior parte dei casi, le cause del basso investimento italiano sono anche cause
indipendenti di bassa crescita: ad esempio la carenza di infrastrutture scoraggia gli
investimenti ma riduce anche direttamente la produttività del Paese. In (pochi) altri casi,
invece, le cause della bassa crescita non sono anche causa di un basso investimento. Per
semplicità, nel lungo elenco che segue eviteremo questa complicazione, considerando anche
questi casi (in realtà, esplicitamente, si tratta di un solo caso, il n. 9) come situazioni nelle
quali l’impatto è sugli investimenti.
Parlavamo di un lungo elenco. Infatti, secondo la maggior parte degli economisti che si
sono occupati del problema il basso livello dell’investimento privato in Italia, tanto realizzato
da residenti quanto da non residenti, può essere imputato ai seguenti fattori:
1. Eccessivo livello di imposizione fiscale. Tanto gli imprenditori italiani quanto quelli
stranieri non trovano conveniente investire nel nostro Paese perché il livello di
imposizione fiscale è troppo elevato: nel 2014, ad esempio, la tassazione media
sulle imprese era del 31,4% in Italia contro il 12,5% in Irlanda e il 22% in Gran
Bretagna, due Paesi che attraggono parecchi investitori.
2. Eccessivi livelli del salario rispetto alla produttività. Sebbene rispetto ai principali
Paesi europei il livello dei salari italiani non sia elevato, essi sono elevati rispetto
alla produttività, nel senso che i lavoratori degli altri Paesi prendono ad esempio, a
parità di mansioni, un salario più alto del 40%, ma producono l’80% in più; anche
in questo caso gli imprenditori preferiscono non investire in Italia ed investire in
altri Paesi dove tale rapporto è più favorevole.
3. Troppo bassi livelli del salario rispetto alla produttività negli altri Paesi. Il punto
precedente può essere, ed è stato, letto anche in maniera radicalmente diversa: una
concausa dei nostri problemi sarebbe la politica di dumping salariale praticata da
alcuni Paesi nostri concorrenti, Germania in testa. Queste nazioni avrebbero
intenzionalmente ridotto i loro salari, o aumentato la loro produttività, o comunque
fatto crescere la produttività rispetto ai salari, per farci una concorrenza sleale. Il
risultato è identico rispetto al punto 2, ma le implicazioni politiche (e le possibili
soluzioni del problema) sono assai diverse.
4. Eccessiva burocrazia. La quantità di adempimenti burocratici necessari per aprire
nuove attività imprenditoriali è in Italia molto più rilevante, e quindi implica un
44
impiego di tempo e risorse economiche molto superiore rispetto agli altri Paesi
(Europei e, soprattutto, extra-europei).
5. Infrastrutture carenti. Le infrastrutture, tanto fisiche (strade, porti, ferrovie, ecc.)
quanto virtuali (internet), sono in Italia decisamente carenti. Ciò incrementa i costi
per le imprese e riduce la produttività.
6. Eccessiva rigidità del mercato del lavoro. Poiché, come abbiamo detto prima e come
è naturalmente intuibile, gli imprenditori realizzano gli investimenti per
guadagnare, non per fare un favore al prossimo, cercano di evitare un mercato del
lavoro eccessivamente rigido, dove non è possibile licenziare facilmente un
lavoratore assunto a tempo indeterminato quando esso è poco produttivo o non più
adatto alle esigenze aziendali.
7. Eccessiva lentezza della giustizia civile. Le imprese sono particolarmente sensibili
alla velocità ed efficienza della giustizia civile, perché frequentemente esse devono
ricorrervi, ad esempio per recuperare un credito o impedire la contraffazione della
loro merce. Bene, in Italia i tempi medi di risoluzione della tipica controversia
dell’inadempimento contrattuale sono di 1200 giorni, contro i 300 degli USA, i 394
della Germania e i 389 della Gran Bretagna.
8. Eccessiva conflittualità sindacale. Sino al 2008, anno della crisi, in Italia non solo il
ruolo del sindacato era rilevante, cosa d’altro canto comune ad altri Paesi europei
(ad es. la Germania), ma questa presenza ha portato ad una notevole conflittualità,
quasi ad avere un gioco delle parti nelle quali chi protestava di più e più a lungo alla
fine aveva l’attenzione (e l’appoggio) del Governo e otteneva ciò che chiedeva, con
l’ovvio risultato che tutti erano incentivati a protestare di più. Naturalmente avere
una forte conflittualità sindacale nelle proprie aziende non è uno dei principali
desideri degli imprenditori.
9. Costo eccessivo del credito bancario e, soprattutto, livello eccessivo di garanzie
richieste per ottenere un finanziamento. Questo elemento ha impedito alle banche
italiane di andare incontro alle stesse difficoltà di quelle Statunitensi o Inglesi, ma
ha reso anche difficoltoso per le imprese finanziarsi, e poiché il credito bancario
serve per effettuare gli investimenti, in ultima istanza ciò ha un effetto depressivo
sul volume degli investimenti privati.
10. Scarso ruolo del mercato borsistico. L’Italia è un Paese banco-centrico, nel senso
che oltre il 50% delle imprese tende a finanziare i propri investimenti attraverso il
credito bancario, e non dunque emettendo titoli obbligazionari e collocandoli in
borsa (come ad esempio fanno gli USA, dove il finanziamento bancario riguarda
solo il 27% delle imprese). Comunque, anche nell’ambito di un’Europa tutta bancocentrica la dimensione del mercato borsistico italiano appare troppo contenuta. La
Borsa infatti non solo garantirebbe un’importante fonte di finanziamenti alternativi
al credito bancario, attraverso il collocamento delle obbligazioni, ma soprattutto
rappresenta “il gendarme dell’efficienza”: se un’impresa quotata in borsa è mal
gestita, e fa pochi profitti, o è in perdita, il suo valore di borsa crolla, e diviene
quindi poco costoso per altri imprenditori più capaci rilevarla, incrementandone
poi l’efficienza. Infatti il valore di un’impresa dipende dai profitti che fa: se è mal
gestita, e fa pochi profitti, vale in borsa ad es. 100, ma un imprenditore capace sa
che, con una gestione più oculata, sarebbe in grado di incrementarne i profitti
portando il valore dell’impresa a 200; così, può acquisirla per 150, rendendo la
transazione conveniente sia per chi vende (che vende a 150 una impresa che per lui
vale 100) sia per chi compra (che compra a 150 un’impresa che varrà 200 una volta
meglio gestita) sia per la collettività, che vede un incremento dell’efficienza
complessiva del sistema.
45
11. Elevata criminalità in alcune zone del paese ed eccessivo livello di corruzione. La
criminalità incrementa i costi per le imprese (che, ad es., devono pagare il “pizzo” o
assumere personale di vigilanza), così come la corruzione.
12. La riforma dualistica del mercato del lavoro. La progressiva riforma del mercato del
lavoro, iniziata con la legge Treu del 1997 e proseguita con la legge Biagi del 2003,
ha creato anche in Italia (come già in altri Paesi) un mercato del lavoro dualistico, in
cui una parte dei lavoratori, assunta a tempo indeterminato (in genere
corrispondente ai lavoratori più anziani contrattualmente) è molto tutelata contro i
licenziamenti, mentre un’altra parte (in genere corrispondente ai più giovani),
assunta con contratti temporanei di vario genere, gode di tutele molto inferiori. A
questo indebolimento contrattuale è corrisposto anche un indebolimento
stipendiale: poiché le imprese non si dichiaravano disposte ad assumere lavoratori
a tempo indeterminato se non in casi eccezionali, in presenza di elevata
disoccupazione pur di lavorare i disoccupati hanno finito coll’accettare condizioni
occupazionali sempre peggiori sia in termini retributivi sia di tutele contrattuali;
tutto ciò è coerente con una spiegazione in termini di domanda e offerta (o accetti
di diventare precario o resti disoccupato), ma è paradossale perché sarebbe logico
che i lavoratori a tempo indeterminato, che godono di maggiori tutele contrattuali,
accettino salari più bassi, compensati dall’assicurazione implicita contro il
licenziamento, mentre i lavoratori che godono di minori tutele dovrebbero essere
compensati da salari più alti. In Italia non è stato così. Con la conseguenza che le
imprese hanno potuto sfruttare una manodopera in genere di bassa qualità, ma a
costi e tutele scarsissime. Cosa c’entra tutto ciò con i pochi investimenti in capitale
fisico? C’entra, perché in molti casi le imprese hanno preferito assumere lavoratori
poco produttivi ma pochissimo retribuiti e facilmente licenziabili in caso di
congiuntura avversa invece di incrementare lo stock di capitale. In pratica, se
cinque lavoratori immigrati assunti “in nero” o con contratti occasionali fanno
crescere la produzione di 100 e mi costano 50 ogni anno, mentre l’acquisto di un
trattore fa crescere ugualmente la produzione di 100 ma implica un costo di 60
all’0anno per dieci anni per ripagare il prestito bancario che ho dovuto richiedere
per comprarlo, l’impresa preferirà assumere gli extracomunitari. Con il risultato
che l’impresa farà più profitti di breve periodo, ma non investirà e quindi lo stock di
capitale non aumenterà, abbattendo le possibilità di crescita di lungo periodo.
13. Basso livello di concorrenzialità dei mercati. In Italia è forte la presenza di elementi
non concorrenziali, con posizioni dominanti, cartelli, accordi più o meno taciti che
incrementano la forza di alcune lobby riducendo l’efficienza dei servizi,
aumentandone i costi per gli utenti e incrementando le rendite: non solo i tassisti,
ma i piloti degli aerei, i ferrovieri, gli stessi commercianti che si oppongono
all’apertura di nuovi supermercati… con il risultato di creare barriere all’ingresso di
nuove imprese, magari capaci di introdurre innovazioni tecnologiche (si pensi a
quanto accaduto negli ultimi anni – dopo la crisi – con servizi di trasporto quali
Uber o car2go o enjoy), e di incrementare i costi che deve preventivare una impresa
che volesse investire in Italia.
14. Bassa tutela della proprietà intellettuale. Secondo le più accreditate teorie sugli
investimenti diretti esteri (in particolare l’approccio OLI), un elemento chiave che
le imprese considerano quando devono delocalizzare un impianto in un Paese è la
tutela della proprietà intellettuale: se la tutela è elevata, possono affidare ad una
impresa locale la produzione e distribuzione della loro merce, se è bassa
preferiscono costituire un impianto di loro proprietà in quel Paese per minimizzare
46
il rischio di vedere copiati i propri prodotti e la propria tecnologia, se è nulla
rinunceranno a qualsiasi attività produttiva nel Paese.
15. Basso livello di istruzione e di formazione professionale della popolazione. Il livello
di istruzione medio in Italia è particolarmente basso, e tanto gli anni di
scolarizzazione quanto la percentuale di laureati sulla popolazione sono
largamente inferiori sia alla media europea sia, soprattutto, al livello degli altri
grandi Paesi d’Europa, Francia e Germania in testa. Tanto per dire, abbiamo circa il
15% di laureati rispetto alla popolazione contro il quasi 30% della Grecia, il 30% di
Germania, Spagna e Francia, il 40% della Corea del Sud, dell’Irlanda, del Regno
Unito e degli Stati Uniti, il 50% del Giappone. Ciò implica la carenza di skill, di
competenze, di capacità professionali, ossia in ultima istanza di produttività della
popolazione e dunque, ancora, un disincentivo ad investire in un Paese con una
manodopera poco produttiva.
16. Scarsa qualità dei docenti. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, e persino i
professori Universitari, hanno dovuto fronteggiare una progressiva perdita di livelli
reddituali e di prestigio sociale. Con il risultato che i migliori laureati hanno visto
l’insegnamento come una soluzione di ripiego, da intraprendere solo come ultima
soluzione, e hanno scelto altre strade, lasciando spazio al personale meno
qualificato.
17. Carenza di formazione scientifica. La formazione pubblica, in particolare
l’istruzione pubblica, è sempre stata principalmente orientata alle lettere piuttosto
che alle scienze, dal che deriva una bassa capacità scientifica agli alti livelli, e una
scarsa formazione professionale di base ai bassi livelli. Quindi non solo studiamo
poco, ma studiamo anche cose che servono a poco.
18. Ignoranza lingue straniere. È chiaramente un elemento connesso alla scarsa
formazione scolastica, ma è un elemento cruciale: uno dei punti di forza dell’Irlanda
nell’attrarre investimenti diretti esteri risiedeva proprio nella lingua inglese parlata
dalla popolazione (oltre al basso livello di fiscalità per le imprese, alle infrastrutture
adeguata e alla forza lavoro, appunto, di alto livello).
19. Assenza di skill premium. Lo skill premium è il vantaggio, in termini di retribuzione,
che può ottenere un lavoratore formato/istruito rispetto a un lavoratore non
formato / non istruito. Questo concetto è particolarmente importante se riflettiamo
bene su cosa si intenda per investimento in capitale umano: non sono soltanto le
imprese che finanziano un corso di formazione per rendere i propri lavoratori più
produttivi; o il Governo che finanzia corsi di formazione pubblici; ma sono
soprattutto i singoli soggetti, e/o le loro famiglie, che decidono di investire del
denaro (per acquistare i libri di testo, per pagare ad esempio le tasse universitarie,
per pagare l’alloggio del proprio figlio fuori sede…), e/o di rinunciare a un salario
per tutti gli anni destinati alla formazione / istruzione (questo è un costo
opportunità, ma va conteggiato nelle spese), al fine di acquisire degli skills, delle
competenze, che porteranno a un maggior salario. Se il differenziale salariale,
appunto lo skill premium, tra chi ha impiegato denaro e tempo per la
formazione/istruzione, e chi invece è andato subito a lavorare, è basso, beh, si
riduce la convenienza dell’investimento, spendere tutti quei soldi è inutile. E quindi
meno gente deciderà di acquisire una adeguata formazione, riducendo il capitale
umano del Paese. Bene, in Italia lo skill premium è basso, rendendo poco
conveniente per le famiglie investire in formazione per i propri figli. Tanto per dire,
in Italia un laureato guadagna in media circa il 50% in più di un diplomato; negli
USA guadagna il 90% in più; nella media dei Paesi OCSE il 57%. Non un gran
divario, ma un divario.
47
20. Basso livello di meritocrazia, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato.
Questo punto è strettamente connesso allo skill premium di cui abbiamo appena
parlato: se l’andamento della mia carriera è slegato dal merito effettivo, a che pro
cercare di avere le qualifiche più alte possibili?
21. Problemi culturali, normativi, politici. Per ragioni in alcuni casi valide, in altre meno
valide, quelle che gli economisti chiamano “istituzioni” in senso lato, ossia regole di
comportamento scritte e non scritte, leggi, cultura, religione, costituiscono spesso
in Italia un ostacolo agli investimenti in alcuni settori. Si pensi alle tecnologie che
provocano possibili danni ambientali, come il fracking (la tecnica di estrarre
petrolio e gas naturale frammentando le rocce), che è altamente inquinante ma ha
fatto diventare gli Stati Uniti un Paese esportatore di petrolio da importatore che
era: in Italia si tratta di una tecnologia proibita, quindi nessun investimento in quel
settore ci sarà mai. O la rinuncia all’energia nucleare, che ha naturalmente impedito
gli investimenti, nazionali ed esteri, in quel settore. O la curiosa circostanza che, in
un Paese votato al turismo come il nostro, rende sostanzialmente illegale la pratica
del nudismo, tranne in pochissime aree, mentre la Spagna, la Francia e la Croazia
investono pesantemente nel settore, portandoci via clienti potenziali. Si potrebbe
continuare con gli OGM, gli inceneritori, le prospezioni petrolifere, ecc. Sono solo
esempi, e ciascuno può ritenere naturalmente giustificate le proibizioni di dette
attività, ma nel complesso, dal punto di vista economico, si tratta di una riduzione
del potenziale di investimenti per la nostra economia, e quindi di un danno
economico. È importante che la scelta sia consapevole.
22. Alto costo dell’energia. Il costo dell’energia, al pari dei costi di trasporto, è un
elemento importante nella determinazione del costo di produzione delle imprese,
ed una sua riduzione si configura come una politica dal lato dell’offerta che
incrementa la competitività delle imprese. Per l’assenza di materie prime
energetiche, per l’opposizione all’energia nucleare e ad altre forme energetiche
alternative al petrolio e al gas naturale, l’Italia sconta un costo dell’energia elevato,
che da solo contribuisce pesantemente al costo delle nostre produzioni.
23. “Nanismo” delle imprese italiane. Il sistema produttivo italiano è formato
principalmente da piccole e medie imprese, che hanno grosse difficoltà
nell’accedere al credito bancario e, soprattutto, al mercato di borsa, e non possono
quindi finanziare né ingenti spese in formazione né investimenti rilevanti in ricerca
e sviluppo. È importante rilevare come le cause che hanno portato alla ridotta
dimensione delle imprese italiane tendano ad aumentare di rilevanza nel corso del
tempo. Possiamo citare, a solo titolo di esempio: la difficoltà di ottenere
finanziamenti dalle banche, che attuano politiche molto “conservative” nella
concessione dei prestiti; la circostanza che mentre in altri Paesi, soprattutto
anglosassoni, è facile per le imprese, anche di piccole dimensioni, finanziarsi
emettendo titoli obbligazionari e collocandoli in borsa, in Italia non è affatto facile,
ma complesso e costoso; la mentalità imprenditoriale italiana, che tende a non far
crescere la dimensione dell’impresa per non doversi affidare a manager esterni,
perdendone così il controllo; lo statuto dei lavoratori, che pone vincoli per i
licenziamenti alle imprese che hanno più di 15 dipendenti; l’assenza di un mercato
di borsa sviluppato, che rende più complicato per imprenditori innovatori acquisire
il controllo di imprese piccole; la specializzazione del Paese in produzioni dove le
dimensioni non sono rilevanti; ecc. Tutti questi elementi non fanno crescere le
imprese, e quindi abbattono gli investimenti; inoltre, imprese piccole investono
poco.
48
24. La perdita di rilevanza dei distretti industriali. I problemi derivanti dal “nanismo”
delle imprese italiane sono stati per lungo tempo compensati dalla forza economica
dei distretti industriali. Un distretto è un insieme di piccole (e/o medie) imprese
indipendenti, concentrate geograficamente e specializzate ciascuna in una fase
diversa di uno stesso processo produttivo. Evidentemente le singole imprese che
compongono il distretto non sono in grado di investire, innovare e formare
lavoratori come una grande impresa, che sfrutta le economie di scala interne
all’impresa (man mano che aumenta il volume della produzione il livello dei costi
unitari si riduce perché si possono sfruttare tecnologie più efficienti, ad es. la catena
di montaggio), ma nel loro complesso possono cooperare per sfruttare le economie
di sala interne al distretto (ad es. cofinanziando un centro di ricerca), attenuando o
anche superando così i vincoli derivanti dalla loro dimensione. I distretti industriai
in Italia, prima della crisi, erano quasi 200, ed erano estremamente dinamici tanto
nella produzione quanto nelle esportazioni, specializzati soprattutto nel made in
Italy (prodotti ad uso ripetuto per la cura della persona e della casa). Inoltre, la
circostanza che spesso i distretti hanno secoli di vita, e che chi vi lavora fa quella
professione da generazioni, e che tutti si conoscono tra loro, crea un importante
incremento di produttività rispetto alle attività non distrettuali, soprattutto grazie
alla maggiore fiducia e conoscenza reciproca. Si parla, in questo caso, di “capitale
sociale” che i distretti possiederebbero, ossia di una rete di relazioni amicali, di
parentela e conoscenza tra i soggetti che incrementa la produttività. Nel tempo,
progressivamente, il ruolo dei distretti è andato riducendosi, anche se rimangono
importanti nell’ambito dell’economia italiana. Le imprese hanno preferito
delocalizzare le produzioni per ridurre il costo del lavoro, l’impossibilità di
sfruttare le economie di scala interne si è rivelato compensabile solo in parte
ricorrendo alle economie di scala distrettuali, lo stesso tessuto distrettuale è andato
progressivamente disfacendosi, incorporando elementi estranei e distruggendo
così l’elemento di capitale sociale. Con la conseguenza che l’unico elemento capace
di attenuare la ridottissima presenza in Italia di grandi imprese ha perso
importanza, e siamo rimasti col problema del nanismo industriale.
25. La globalizzazione. Se da un lato gli elementi che abbiamo elencato hanno reso
l’Italia poco attrattiva per gli investimenti, dall’altro sul mercato si sono affacciati
concorrenti agguerriti che hanno fatto di tutto per rendersi attraenti, garantendo
ad esempio l’assenza dei sindacati, bassi salari e libertà di licenziare (dumping
sociale), standard di tutela ambientale assai laschi (dumping ambientale) e
soprattutto basse imposte societarie (dumping fiscale). Quindi non solo l’Italia è
diventata sempre meno attrattiva, ma altri Paesi lo sono diventati sempre di più.
V.2.3 La dinamica degli investimenti pubblici e le sue cause
L’investimento pubblico italiano è progressivamente diminuito nel tempo: era infatti in
media sempre superiore al 3% del PIL all’anno sino al 1991, è sceso sotto il 3% tra il 1992 e il
2001, per scendere sotto al 2% nel 2002 e poi stabilizzarsi poco sopra il 2%. Dati sempre
inferiori alla media europea, seppur di poco, e molto inferiori a quella degli USA. Il problema,
anche qui, è che avremmo avuto bisogno di più investimenti pubblici della media, per
recuperare lo svantaggio nell’accumulazione di capitale, e invece ne abbiamo realizzati di
meno, anche se pochi di meno. Il basso livello di investimenti pubblici rispetto al necessario è
dipeso da numerose cause, riconducibili sia a scelte di politica economica sia a vincoli esterni,
che indichiamo di seguito.
49
1. L’elevato livello raggiunto dall’indebitamento pubblico. Il debito pubblico italiano si
è progressivamente accresciuto nel corso del tempo: era il 42% del PIL nel 1971,
diventa il 57% nel 1980, il 95% nel 1990, il 109% nel 2000, il 118% nel 2010, e oggi
è superiore al 130%. Questo elevato debito non costituisce un problema in sé, ma
diventa un problema quando i mercati cominciano a divenire scettici sull’effettiva
possibilità che quel debito sia restituito e iniziano a chiedere tassi di interesse
sempre più alti per sobbarcarsi quello che ritengono essere un rischio crescente.
Ma maggiori tassi vogliono dire maggior deficit per ripagarli, maggior deficit vuol
dire maggior debito e quindi, ancora, maggiore scetticismo dei mercati, ossia tassi
ancora più alti. E così via, sino a quando il debito diventa effettivamente
insostenibile. Per evitare questa dinamica abbiamo ritenuto necessario tagliare la
spesa pubblica, ossia ridurre una delle cause del deficit e del conseguente debito
(l’altra è la spesa per interessi sul debito). In genere non ci siamo riusciti, ma ci
abbiamo provato. E poiché tagliare gli investimenti provoca meno opposizione
sociale e sindacale rispetto a ridurre, ad esempio, gli stipendi dei dipendenti
pubblici, si è finito per ridurre i primi proprio quando avremmo dovuto
incrementarli. E ciò è accaduto soprattutto nel comparto della ricerca di base (gli
scienziati non scendono in piazza se tagliamo loro i finanziamenti…), quella ricerca
che non ha un ritorno immediato ma che crea le innovazioni più rilevanti e
rivoluzionarie. Essa infatti richiede tempi lunghi, finanziamenti a pioggia (perché è
assai difficile capire in anticipo quali siano i settori più promettenti o quelli che
svilupperanno tecnologie più rivoluzionarie) e, in generale, il contributo della
ricerca pubblica e delle Università.
2. I vincoli derivanti dall’appartenenza del Paese all’Unione Economica e Monetaria.
Con l’ingresso dell’Italia nell’Eurozona, nel 1999, sono divenuti stringenti alcuni
vincoli europei, e in particolare l’obbligo di rispettare il Patto di Stabilità e Crescita
del 1997, che impone ai diversi Paesi di rispettare un tetto massimo del 3% nel
rapporto tra deficit di bilancio e PIL. Poiché gli investimenti pubblici implicano
spesa pubblica, e quindi generano deficit di bilancio, a meno che non si riducano nel
contempo le altre spese pubbliche, e poiché le altre spese pubbliche sono
difficilmente comprimibili, finiscono coll’essere loro ad essere sacrificati, come
scritto al punto precedente. È evidente che questo punto è legato al precedente, ma
vincoli europei e vincoli derivanti dai mercati finanziari non sono la stessa cosa,
poiché gli uni possono essere stringenti indipendentemente dagli altri, e viceversa,
e i secondi sono in genere meno eludibili dei primi.
3. La riduzione dell’intervento pubblico in economia. La progressiva diffusione, a
partire dagli anni ottanta del secolo scorso, dell’idea che le imprese private fossero
più efficienti di quelle pubbliche, meno burocratizzate, più propense
all’innovazione, ha ridotto l’intervento pubblico in economia, il numero delle
imprese pubbliche e la crescita dimensionale di queste, riducendo quindi anche gli
investimenti pubblici. In sostanza, si è creato un clima ideologico di scetticismo nei
confronti dell’operatore pubblico, che ha contribuito a rendere meno praticabili gli
investimenti.
4. Il Mezzogiorno. La progressiva rinuncia ai piani di industrializzazione massiccia (e
forzata) del Mezzogiorno attraverso la localizzazione di imprese pubbliche ha
contribuito a ridurre l’investimento pubblico complessivo.
V.3 Le cause della bassa domanda italiana
50
V.3.1 Dalla teoria alla pratica: il sostegno alla domanda aggregata e l’Italia
Se dai problemi di crescita passiamo ai problemi di domanda aggregata la situazione
non migliora, perché un Paese che ha problemi di crescita finirà generalmente con lo
sperimentare problemi di domanda aggregata (e viceversa). E questo non solo perché per
crescere è necessario investire, ossia incrementare una delle componenti della domanda
aggregata, ma soprattutto perché alcuni degli elementi che disincentivano gli imprenditori
dall’investire, come ad es. gli alti costi e la bassa produttività del lavoro, rendono le produzioni
nazionali poco appetibili e quindi poco richieste dal mercato (interno e internazionale),
deprimendo quindi la domanda aggregata. Conformemente a quanto abbiamo fatto per la
crescita, anche qui esaminiamo gli ostacoli alla crescita della domanda aggregata, partendo
dalla classificazione proposta nel capitolo secondo: consumi, investimenti, spesa pubblica,
esportazioni nette.
V.3.2 I consumi
La stagnazione dei consumi in Italia è oggi un problema rilevante, ma non era
altrettanto rilevante prima della crisi: nel periodo 1961-1970 il consumo pro-capite cresce ad
una media annua del 6,4%, che scende al 3,9 nel periodo 1971-1980, al 2,6% nel periodo
1981-1990, all’1,7% nel periodo 1991-2000, allo 0,4% nel periodo 2001-2010. L’incremento
iniziale permette al nostro consumo pro-capite di divenire superiore alla media Europea, poi
dal 1991 c’è la caduta. In genere infatti questa variabile dipende da due elementi: il reddito
dei consumatori e la fiducia dei consumatori. Se infatti il reddito disponibile cresce, i
consumatori tenderanno a incrementare le proprie spese; allo stesso modo se divento più
ottimista per il futuro, e quindi credo che il reddito crescerà ancora, o almeno non si ridurrà,
in futuro, o che la mia ricchezza aumenterà (perché ad esempio aumenta il valore dei titoli che
possiedo), e/o che non dovrò pagare più tasse o far fronte a spese impreviste, anche in questo
caso tenderò a consumare di più, magari indebitandomi. Il primo approccio, che lega il
consumo al reddito disponibile dei soggetti, è un approccio che si ritrova nel pensiero di
Keynes; il secondo approccio, che lega il consumo al cosiddetto reddito permanente di un
soggetto (ossia a ciò che mi aspetto di guadagnare in futuro, nel corso della mia vita
lavorativa) e lo porta ad indebitarsi oggi se crede che domani guadagnerà di più, nonché alla
sua ricchezza, si deve ai premi nobel Franco Modigliani (teoria nota come ciclo vitale del
consumo e del risparmio) e Milton Friedman (teoria del reddito permanente). In genere la
teoria empiricamente meglio fondata è la prima, ma in determinate circostanze le aspettative
ottimistiche o pessimistiche sul reddito futuro, o sul valore futuro della ricchezza, diventano
prioritarie: se l’economia è in crisi e credo che aumenteranno le tasse sul mio salario o
ridurranno la mia pensione, tendo a consumare di meno e risparmiare di più per ogni
evenienza.
Bene, in Italia la crescita del reddito progressivamente rallenta, tanto che possiamo
dire che a partire dai primi anni novanta, tranne brevi e sporadici periodi, si entra in una
sostanziale stagnazione: se nel decennio 1961-1970 il PIL cresce in media del 5.7% all’anno,
nel decennio 1971-1980 cresce solo del 3,8%, in quello 1981-1990 del 2,4%, per crollare
all’1,6% nel decennio 1991-2000 e allo 0,1% tra il 2001 e il 2010. L’elemento reddito nel
sostegno dei consumi è dunque assai debole, e solo l’elevata spesa pensionistica e l’elevato
monte salari dei dipendenti pubblici permette di sostenere un minimo i consumi. L’elemento
aspettative è però rimasto a lungo positivo, perché anche dopo l’ingresso nell’Eurozona gli
italiani non sono stati in grado di realizzare che il mondo era cambiato e la situazione per il
Paese si andava pesantemente deteriorando. Poi, però, i tagli alle spese della pubblica
amministrazione sono divenuti evidenti, così come i problemi delle nostre esportazioni e la
51
riduzione nella crescita dei salari, e alla riduzione del reddito si è sommata la progressiva
diffusione di aspettative negative nel frenare i consumi.
V.3.3 Gli investimenti
Poiché gli investimenti sono rilevanti tanto per la crescita quanto per il sostegno alla
domanda aggregata, per loro vale il quadro a tinte fosche tratteggiato nella sezione V.2, alla
quale rimandiamo. Per non sprecare inutilmente un paragrafo, può comunque essere utile un
dato diverso dal tasso di crescita usato nella sezione V.2, ossia la percentuale di investimenti
rispetto al PIL. Anche questo dato conferma il trend negativo: se nel periodo 1960-1970 e
1971-1980 gli investimenti rappresentavano oltre il 25% del PIL, negli anni novanta sono
scesi stabilmente sotto il 20%, per attestarsi in seguito attorno a quella cifra. È quindi
confermato che ne servirebbero sempre di più per recuperare il gap con gli altri Paesi, e noi
ne facciamo invece sempre di meno.
V.3.4 La spesa pubblica
La spesa pubblica è uno dei due elementi che assieme alle esportazioni ha permesso
l’imponente crescita del PIL italiano nel secondo dopoguerra. Da allora le esportazioni hanno
visto ridursi il loro ruolo nel sostegno alla domanda aggregata ma la spesa pubblica lo ha
mantenuto: era il 41% del PIL nel 1980, il 53% nel 1990, scende sotto il 50% tra il 1998 e il
2008, risale sopra il 50% dal 2009. Sempre mediamente più alta degli altri Paesi europei,
Grecia compresa…
In linea teorica, la spesa pubblica dovrebbe incontrare due importanti limiti.
Il primo è l’indebitamento. Perché funzioni sul serio, la spesa pubblica deve essere
effettuata in deficit; ma effettuare spesa in deficit significa incrementare prima il debito
pubblico. Oltre un certo livello i mercati percepiscono come troppo alto l’indebitamento
pubblico, e richiedono tassi di interesse sempre più alti per comprare titoli di Stato, poiché
temono di non vedersi restituire il prestito e vogliono un “premio” per il maggior rischio.
L’aumento degli interessi pagati, soprattutto in presenza di elevato indebitamento, accresce il
deficit, e quindi l’indebitamento, in un circolo vizioso che dovrebbe disincentivare il ricorso
alla spesa pubblica. Secondo la teoria economica dunque un Paese, quando vede crescere i
tassi di interesse che deve pagare sul debito, capisce di aver esagerato e riduce il suo ricorso
all’indebitamento, ossia alla spesa pubblica.
Bisogna dire che l’Italia questo primo limite lo ha sostanzialmente ignorato. Tra l’altro,
con l’ingresso nell’eurozona i mercati hanno per qualche anno ritenuto che i titoli del debito
dei Paesi deboli dell’eurozona fossero in qualche modo garantiti anche dai Paesi forti, ossia in
sostanza che se l’Italia avesse avuto problemi a far fronte al proprio debito sarebbe
intervenuta la Germania… Nessuna garanzia del genere naturalmente esisteva, ed anzi la
Germania ha voluto smentirla più volte, ma per un po’ tutti sono stati convinti del contrario.
Con la conclusione che l’Italia (ma anche gli altri Paesi periferici dell’eurozona) hanno visto i
tassi di interesse che pagavano sui propri titoli scendere drasticamente. Di fronte
all’improvviso basso costo dell’indebitamento, l’Italia non si è tenuta, ed ha incrementato
massicciamente spesa pubblica, deficit di bilancio e, dunque, debito. Che come abbiamo già
visto passa dal 42% del PIL del 1971 al 118% del 2010.
Quindi il limite teorico all’indebitamento non ha funzionato. Rimaneva però un altro
limite: i Paesi dell’eurozona devono rispettare il Patto di Stabilità e crescita, che impone
sanzioni in caso di deficit pubblico superiore al 3% del PIL. Bene, questo limite è stato spesso
violato dall’Italia, che lo ha rispettato solo nel periodo 1997-2000, nel 2002, nel 2007 e nel
2008.
Quindi l’Italia, di fronte alla crisi degli altri strumenti di sostegno della domanda
aggregata, ha optato per la spesa pubblica espansiva, esattamente come fatto dagli altri Paesi
52
del debito: puntare sulle bolle era infatti complicato, anche perché il sistema bancario era (ed
è tuttora) molto conservatore e dunque mancava il meccanismo del prestito facile e con poche
garanzie che ha assistito il gonfiarsi delle bolle negli altri Paesi.
Certo, naturalmente restava la possibilità di comportarsi come un Paese
neomercantilista, ossia puntare sulle esportazioni per sostenere la domanda aggregata: dopo
tutto, l’Italia è sempre stata fortemente esportatrice, una economia di trasformazione che
sulle esportazioni oltre che sulla spesa pubblica ha/aveva costruito il suo successo. Ma, come
sappiamo, con l’ingresso nell’eurozona e la fine delle svalutazioni competitive questa opzione
è divenuta sempre meno praticabile.
V.3.5 Le esportazioni (nette)
Un elemento cruciale per il successo del nostro Paese nei decenni passati è stata la
partecipazione agli scambi internazionali: l’Italia dal secondo dopoguerra ha accentuato la sua
vocazione ad essere una economia di trasformazione, che importava materie prime e
semilavorati e, grazie a un importante settore industriale, li trasformava in prodotti finiti per
l’esportazione. Le esportazioni hanno dunque costituito un elemento di traino imprescindibile
per la domanda aggregata, assieme alla spesa pubblica: erano il 12% del PIL nel 1960, il 16%
nel 1970, il 21% nel 1980, il 19% nel 1990, il 27% nel 2000, il 26% nel 2005, il 25% nel 2010.
Insomma, un aumento costante che, dalla metà degli anni novanta, ha portato le esportazioni
a pesare un quarto del prodotto complessivo del paese.
La competitività delle nostre esportazioni era garantita inizialmente dall’efficienza del
sistema produttivo e dal basso costo del lavoro, oltre che dall’iniziale assenza di Paesi esteri
che potessero competere con le nostre produzioni. Poi, man mano che i salari italiani hanno
iniziato a salire più della produttività, facendo salire anche i prezzi dei beni esportati, il
vantaggio di costo per le nostre esportazioni ha iniziato a scemare, proprio mentre si
affacciavano sul mercato internazionale concorrenti agguerriti che operano nei nostri stessi
settori merceologici. Nonostante questo il Paese ha potuto mantenere per due decenni la
propria competitività internazionale grazie alle svalutazioni competitive (volute o subite).
Nella prima fase di appartenenza al Sistema Monetario Europeo, tra il 1979 e il 1985, infatti,
l’Italia ha fatto ricorso per ben cinque volte a svalutazioni competitive: nel marzo e
nell’ottobre del 1981, nel 1982, nel 1983, nel 1985. Recuperando così ogni volta “con un tratto
di penna”, in un istante, tutta la competitività persa a causa dell’eccessiva dinamica
inflazionistica; poi, a partire dal 1985, quando apparentemente ha rinunciato a realizzare
svalutazioni competitive preferendo combattere l’inflazione, l’evidente incapacità del Paese di
passare da una strategia di svalutazione competitiva ad una di disinflazione competitiva ha
scatenato la speculazione internazionale contro la lira, che ci ha costretti a svalutare
pesantemente la nostra valuta nell’estate del 1992 e a uscire dal regime a cambi fissi. n
sostanza, anche l’attacco speculativo ha finito col risolversi in una nuova svalutazione
competitiva, la sesta in 13 anni. L’ultima, però.
A questo punto, nel 1999, l’Italia è entrata nell’Eurozona, ragion per cui le svalutazioni
competitive non sono più state possibili: non sono state possibili per definizione nei confronti
degli altri Paesi europei, che condividevano la nostra stessa moneta, e non sono state possibili
nei confronti degli altri Paesi, perché la Banca Centrale Europea non ha mai avuto né il
mandato né lo scopo né la volontà politica di svalutare l’euro. L’Italia ha però avuto la fortuna
di entrare nell’eurozona con un cambio fortemente deprezzato, 1936,27 lire per ogni euro, un
retaggio della crisi del 1992. Grazie a questo cambio deprezzato i primi tempi della
permanenza nell’Eurozona hanno visto l’Italia continuare ad esportare in maniera rilevante. E
quindi le esportazioni hanno continuato a sostenere la domanda aggregata.
Nonostante l’apparente perdurante successo, i fattori critici rimanevano inalterati, e
anzi si aggravavano: per i motivi che abbiamo visto nella sezione v.1 i tassi di crescita della
53
produttività del lavoro si riducevano costantemente, ed anzi in alcuni anni hanno anche
assunto un valore negativo; i salari continuavano a crescere, assieme a imposte e contributi
sociali, aumentando il costo del lavoro per le imprese; il combinato disposto di bassa
produttività e salari in aumento ha portato all’aumento del costo del lavoro per unità di
prodotto, e dunque un’inflazione superiore rispetto a quella degli altri Paesi europei e,
soprattutto, a un eccessivo aumento di prezzo per le merci che esportavamo, facendo così
perdere progressivamente competitività internazionale al Paese, in un contesto in cui le
svalutazioni competitive non erano più possibili; inoltre, il nostro Paese ha scoperto di essersi
specializzato in produzioni “sbagliate”, nel senso che sul mercato internazionale erano apparsi
concorrenti temibili, specializzati nelle nostre stesse produzioni a bassa tecnologia e basso
costo del lavoro (tessile, ecc.), ma capaci di mantenere salari e imposte, e dunque in generale
costi di produzione e prezzi all’esportazione, molto inferiori ai nostri; così la scelta adottata,
ossia di puntare sempre più sulla riduzione di costo e di qualità dei prodotti, si è rivelata
perdente, perché sul costo del lavoro non potevamo assolutamente competere con questi
Paesi.
Non sorprende dunque che già qualche anno dopo l’ingresso nell’eurozona siano
emersi gravi problemi: le esportazioni, tra il 2000 e il 2007, anno della crisi, si mantengono
sostanzialmente stabili, oscillando tra il 25% e il 29% del PIL; le importazioni, invece, tendono
ad aumentare, passando dal 24% del 2003 al 29% del 2007. Il risultato è che il saldo tra le due
voci, ossia il saldo della bilancia commerciale, la domanda netta rivolta al nostro Paese
dall’estero, scende rapidamente, anno dopo anno, dal picco raggiunto nel 1996 (quando aveva
raggiunto quasi il 5% del PIL) e diventa negativo a partire dal 2005. Quindi il contributo della
domanda estera al sostegno della domanda aggregata e del PIL diventa un contributo
negativo, nel senso che deprime la domanda invece di sostenerla.
Poi arriva la crisi, che però affronteremo nel capitolo VII.
V.4 Le conseguenze della bassa domanda: compensiamo! E cresce il debito
pubblico…
Come abbiamo visto, quindi, i margini di manovra che aveva l’Italia per sostenere la
domanda aggregata si sono progressivamente ridotti. In particolare, dei due strumenti
maggiormente utilizzati in passato, ossia le esportazioni e la spesa pubblica, uno sembrava
soggetto a un progressivo declino (le esportazioni), mentre l’altro (la spesa pubblica)
appariva fortemente limitato dai mercati e dai vincoli europei. Ma mentre il declino delle
esportazioni nette è stato effettivo, i vincoli alla spesa pubblica sono stati assai meno
stringenti, perché l’Italia con l’ingresso nell’Eurozona ha scoperto che il costo del
finanziamento del debito, ossia il vincolo rappresentato dal mercato, era quasi scomparso.
Rimaneva il vincolo normativo rappresentato dai trattati, e in particolare dal Patto di stabilità
e crescita: alcuni Paesi, come la Grecia, sceglieranno di ignorarlo del tutto; altri, come l’Italia,
di rispettarlo in alcuni anni e di sforare, anche se di poco, in altri.
In sostanza il nostro Paese, di fronte alla perdita di controllo degli altri strumenti atti a
sostenere la domanda aggregata, ha scelto di utilizzare l’unico rimasto a disposizione, ossia la
spesa pubblica espansiva, e dunque l’indebitamento pubblico; ma ha anche scelto di non
violare o di violare di poco i trattati, quindi di ricorrere a questo strumento solo poco più del
consentito. Ma così facendo da un lato non ha sostenuto adeguatamente la domanda aggregata
(per farlo sarebbe stata necessaria una spesa pubblica molto maggiore), dall’altro ha
comunque fatto crescere eccessivamente il debito (per non farlo sarebbe stata necessaria una
spesa pubblica molto minore). Col risultato che dal 2001 il Paese sostanzialmente non ha visto
crescere la domanda aggregata e dunque il reddito, ma ha ugualmente visto crescere il debito
pubblico dal 109% del PIL del 2000 al 134% di oggi.
54
PARTE TERZA
LA CRISI
55
VI. La fine dei giochi (la crisi)
VI.1 Scoppia la bolla subprime USA
Già nel corso del 2006 il sostegno alla domanda aggregata USA garantito dalla bolla
subprime inizia ad affievolirsi. Le banche hanno infatti concesso prestiti a soggetti sempre più
rischiosi, generando in questo modo un aumento delle insolvenze (col rifinanziamento
preferisco godermi la vita, non certo ripagare il mutuo...); il che implica un aumento degli
immobili che diventano proprietà delle banche e vengono da queste immediatamente messi
nuovamente in vendita. Poi, l’aumento del prezzo degli immobili ha incentivato l’attività delle
società edilizie, portandole a costruire sempre più abitazioni. Sia le insolvenze sia l’aumento
delle costruzioni accrescono l’offerta di immobili, con effetti depressivi sul prezzo. Ma non
finisce qui. Perché nel mondo il prezzo del petrolio aumenta, e negli Stati Uniti si cominciano
ad avvertire dinamiche inflazionistiche più accentuate; con il risultato che la Federal Reserve,
per contrastare l’inflazione, aumenta il tasso di interesse. Il problema è che i mutui subprime
dopo i primi anni, e i mutui di rifinanziamento subito, sono a tasso variabile, cioè pagano rate
che aumentano e sono meno sostenibili se la FED aumenta i tassi di riferimento. L’aumento
del tasso FED, quindi, genera un aumento delle insolvenze. Quando aumentano le insolvenze
altri immobili tornano alle banche, e vengono rimessi sul mercato, aumentando l’offerta e
determinando una ulteriore riduzione del prezzo.
A questo punto il panico si diffonde: la Banca Centrale ha fatto scoppiare la bolla,
coerentemente con il modello di Hayek. Il prezzo degli immobili crolla e, di fronte
all’impossibilità di rifinanziarsi, i mutuatari dichiarano massicciamente insolvenza. Tra l’altro
il valore del mutuo che dovrebbero pagare è diventato molto maggiore rispetto al valore
dell’immobile, ragion per cui anche ai più ricchi in queste circostanze conviene dichiarare
insolvenza invece che pagare l’abitazione più di quanto valga.
Con le insolvenze il valore di tutto il castello di carte (letteralmente…), ossi di tutti i
titoli basati su quei mutui, dalle MBS alle CDO; e chi li ha acquistati va incontro a perdite molto
elevate.
Questo non dovrebbe rappresentare un problema per le banche: attraverso la
cartolarizzazione hanno diffuso il rischio di credito, allontanandolo da loro stesse, e quindi
non dovrebbero andare incontro a problemi. E invece non va affatto così. Innanzitutto perché
le banche non hanno cartolarizzato tutti i prestiti, molti ne hanno tenuti in portafoglio. Inoltre,
hanno in cassaforte anche molte MBS e CDO, che hanno acquistato, o mantenuto, perché non
hanno saputo resistere all’alto rendimento, o per segnalare al mercato che credevano nella
bontà delle proprie emissioni. Spesso non si sono neppure coperte dal rischio di questi titoli,
tanto tutto andava bene e nessuno falliva. Inoltre, in molti casi istituzioni finanziarie non
particolarmente speculative, e addirittura fondi pensionistici, hanno acquistato MBS e CDO
perché ritenevano che fossero titoli sicuri, visto che le agenzie di rating li avevano qualificati
con la tripla A. E ritenendo si trattasse di titoli sicuri, neppure loro si sono coperti contro il
rischio. Ma evidentemente le agenzie di rating si erano sbagliate, ed anche titoli con tripla A
diventano carta straccia, avvicinando al fallimento anche operatori molto prudenti. Ancora,
quando le società finanziarie veicolo, una volta comprati i mutui dalle banche, provano a
emettere MBS, scoprono che nessuno le vuole, così come nessuno vuole rinnovare quelle
scadute, o le acquista solo a prezzi irrisori, e quindi si trovano improvvisamente in una grave
crisi di liquidità; a questo punto chiedono finanziamenti alle banche che, sebbene abbiano un
bilancio separato, fanno parte comunque della stessa holding e in molti casi intervengono per
salvarle. In questo modo trasferiscono alle banche i loro problemi e le trascinano con loro
56
verso l’insolvenza. Poi ci sono Fannie e Freddie, che non appartengono a nessuna holding e
dunque non sanno a chi chiedere aiuto (toccherà al Governo, in quanto società semipubbliche). Infine, le società che hanno assicurato i mutui si trovano a dover fronteggiare un
volume di insolvenze, e dunque di risarcimenti da pagare, enormemente superiore rispetto
alle loro più pessimistiche previsioni, non hanno liquidità sufficiente e anche loro vanno verso
l’insolvenza. Insomma, con le insolvenze dei mutuatari aumentano le perdite delle banche, e
anche di molte società di assicurazione e società finanziarie di vario genere, fondi pensione
inclusi. Il problema è che si riduce anche il capitale che dovrebbe ripagare quelle perdite,
perché si riduce il valore dei titoli che le società finanziarie hanno in portafoglio, visto che
improvvisamente nessuno vuole comprarli. Sul mercato, infatti, appena comincia la crisi, il
valore delle azioni delle banche, delle società finanziarie in genere, nonché di tutti i titoli
“innovativi” da esse emessi, crolla, visto che nessuno si fida della loro solvibilità, e dunque
tutti cercano disperatamente di vendere, mentre nessuno compra. Ma se il capitale si riduce,
rischia di non essere più sufficiente per ripagare le perdite, che aumentano sempre più. Le
società possono d’altro canto fallire non solo se diventano insolventi, ossia se il loro capitale
non è più sufficiente a coprire le perdite, ma anche se diventano illiquide, ossia se il capitale
sarebbe sufficiente a coprire le perdite, ma non è liquido, perché magari consiste di titoli,
immobili, ecc., che le società non riescono a trasformare rapidamente nel denaro necessario ai
pagamenti, soprattutto nella situazione di sfiducia sulla reale qualità dei titoli che si diffonde.
Anche se sono solvibili, l’illiquidità momentanea, se nessuno presta loro denaro, può portare
ugualmente al fallimento.
Ora, il fallimento di una piccola banca è un problema per chi ha aperto un conto
corrente presso di lei, per chi ha emesso obbligazioni emesse da lei, per i suoi proprietari,
ossia gli azionisti, nonché per la banca centrale e per le eventuali altre banche che le avessero
prestato liquidità. Tutti costoro perdono il loro denaro, che forse (forse…) in parte
recupereranno nel più lungo periodo, quando verranno vendute le proprietà della banca per
provare a risarcire qualcuno. Ma è una banca piccola, non fa tanti danni. Il fallimento di una
banca grande è invece un problema per l’intera economia, perché quando una banca grande
fallisce e non restituisce grandi quantità di denaro ad altri operatori, anche questi finiscono
per fallire. E così via, in una serie di fallimenti a catena. Le imprese stesse si vedono revocare
le linee di credito e rischiano di fallire a loro volta, proprio mentre i consumi e gli investimenti
si contraggono per la minore disponibilità finanziaria di chi ha perso il proprio denaro nella
catena di fallimenti. Per questo motivo i Governi in genere intervengono per prevenire il
fallimento delle banche grandi. Il problema è che le banche grandi lo sanno, e prendono rischi
eccessivi nelle loro attività proprio perché sanno che se va bene, faranno un sacco di profitti,
ma se va male il Governo sarà costretto a salvarle. Si chiama moral hazard, azzardo morale, un
fenomeno studiato inizialmente con riferimento al mercato assicurativo: per il fatto di essermi
assicurato (ad esempio contro il furto) modifico i miei comportamenti prima prudenti e ne
assumo di più rischiosi (ad esempio: non chiudo più a chiave la porta di casa), tanto sono
assicurato…
L’illiquidità massiccia delle banche si verifica negli Stati Uniti nell’estate del 2007, e
sfocia nel blocco del mercato interbancario o mercato monetario. In tempi normali le banche si
prestano quotidianamente denaro tra di loro per far fronte a temporanee esigenze di liquidità:
oggi devo pagare 100, domani incasserò 200, prestami 100 a ventiquattro ore, te li ridò
sicuramente domani quando incasso… Nel 2007, improvvisamente, questo meccanismo di
prestito tra banca e banca si blocca. Non ti presto 100 innanzitutto perché non so se sei o
meno sull’orlo del fallimento; poi, non so se domani incasserai sul serio 200, magari chi te li
deve dare sta fallendo; infine, poiché in questa situazione nessuno presta niente a nessuno,
preferisco tenermi il denaro liquido che possiedo, senza prestarlo, perché un domani
57
potrebbe servirmi e potrei non riuscire a procurarmelo in altro modo, appunto perché
nessuno presta più niente a nessuno.
In questa situazione, anche una crisi di liquidità diventa facilmente una crisi di
insolvenza, e le banche si avviano al fallimento se qualcuno non interviene a rifinanziarle. Nel
tentativo di recuperare denaro ovunque è possibile farlo, le banche riducono allora i prestiti e
cercano anche di ottenerne la restituzione anticipata, quindi tagliano il credito alle imprese.
Ma così facendo le imprese entrano in enormi difficoltà, e molte finiscono per divenire esse
stesse insolventi, il che implica che non riescono a restituire i prestiti ottenuti dalle banche e
creano ulteriori problemi alle stesse banche. Inoltre, visto che chi ha contratto un mutuo
ipotecario si è improvvisamente trovato a non poterlo più rifinanziare, nessuno può
impiegare una parte del secondo (o terzo, o quarto) mutuo, quello ottenuto dando a garanzia
l’incremento di valore dell’immobile, per sostenere i consumi, ed anzi deve (dovrebbe)
risparmiare per ripagare i prestiti ottenuti. Quindi da un lato le imprese si trovano in difficoltà
perché la domanda dei loro prodotti crolla, dall’altra perché le banche riducono loro i
finanziamenti... il fallimento diviene un’opzione frequente. Ma se le imprese falliscono non
solo creano ulteriori problemi alle banche, ma licenziano i lavoratori, e i lavoratori licenziati
domandano meno beni perché non hanno più un reddito, e la crisi si diffonde ulteriormente.
Inoltre, da crisi finanziaria diventa crisi reale, che causa disoccupazione, riduzione del reddito
e fallimenti per le imprese.
Sebbene, come abbiamo visto, le prime avvisaglie della crisi si possano far risalire al
2006, se volessimo indicare una data simbolica, capace di evidenziare come non si fosse di
fronte a una semplice recessione ma a qualcosa di molto più profondo, probabilmente questa
data sarebbe il 15 settembre del 2008, con il fallimento di Lehman Brothers Holdindgs Inc., una
banca grande anche se non enorme. È infatti dall’inizio del 2008 che questa istituzione
finanziaria subisce ingenti perdite (alla fine il suo debito sarà accertato essere superiore ai
600 miliardi di dollari) e un costante crollo nel suo valore di borsa, elementi che hanno reso
problematica qualsiasi prospettiva di acquisizione da parte di altre società finanziarie: in
particolare, Barclays si rifiuta di acquistare la banca in mancanza di una garanzia pubblica, che
sarà invece fornita in altri casi e per altre società finanziarie. La garanzia pubblica, per motivi
mai effettivamente chiariti (Lehman Brothers non aveva rapporti sufficientemente stretti con
il Governo degli Stati Uniti? Ha prevalso l’idea di punire una banca per curare l’azzardo
morale, rendendo esplicito che le banche devono assumersi le loro responsabilità? I policy
maker si sono semplicemente sbagliati, sottovalutando l’enorme rete di connessioni che
Lehman aveva con tutte le altre banche e guardando solo la dimensione apparente?), non è
giunta, e Lehman è fallita. L’impatto di questo fallimento sul restante sistema finanziario, e
sull’economia reale, è stato devastante, sia per i suoi effetti diretti sia per quelli indiretti sulle
aspettative del mercato, dando inizio al periodo più buio della crisi. Proprio per questo
accorgersi tardivo dell’impatto devastante di un fallimento bancario i successivi interventi
posti in essere dagli Stati Uniti per contrastare la crisi saranno molto più sistematici, rapidi,
incisivi e imponenti, come vedremo nel capitolo VII. In quel momento, però, il fallimento di
Lehman marca il momento peggiore della crisi statunitense.
VI.2 La crisi passa l’Oceano e arriva in Europa
La crisi non si limita a però a colpire solo gli Stati Uniti, ma progressivamente si
estende ad altri Paesi. In particolare, varca l’oceano e giunge in Europa.
In realtà, in Europa di crisi ne arrivano due: quella finanziaria e quella reale.
La crisi finanziaria colpisce gli istituti di credito che hanno investito nei titoli
statunitensi e quelli che hanno avuto un problema simile nel loro Paese, ossia una bolla
speculativa.
58
Poi c’è la crisi reale, che invece danneggia l’intera Europa, perché la recessione degli
Stati Uniti ha ridotto il reddito degli statunitensi, i quali hanno di conseguenza ridotto i loro
consumi e, tra questi consumi, hanno soprattutto ridotto le importazioni, ossia il consumo di
merci prodotte all’estero. E una parte di queste importazioni altro non sono che le
esportazioni europee. In sostanza le imprese europee si sono viste improvvisamente ridurre
drasticamente gli ordinativi di merci provenienti dagli Stati Uniti, con le usuali conseguenze:
riduzione della domanda, riduzione della produzione, riduzione dell’occupazione, ossia
licenziamenti… anche la crisi reale si estende dunque all’Europa.
Ma l’Europa è assai diversa, per struttura economica, rispetto agli Stati Uniti, e la crisi
che arriva dall’Oceano non rappresenta altro che il detonatore di una situazione europea già
molto deteriorata che, con ogni probabilità, avrebbe comunque dato origine in tempi brevi a
una crisi economica devastante. I Paesi europei sono infatti profondamente differenti tra loro,
e sebbene anche gli Stati che compongono gli USA presentino forti diversità, l’Europa non
possiede quelle peculiari caratteristiche che permettono invece agli Stati Uniti di
ammortizzare efficacemente tali diversità. La diversità in sé non è un problema, ma voler
comprimere Paesi tanto diversi all’interno del contesto di una stessa moneta, senza nel
contempo dotarsi di una costituzione federale, di un Governo centrale e di mercati
liberalizzati e integrati è sempre stato considerato un errore foriero di probabili catastrofi
dalla maggior parte degli economisti, che si richiamavano alla teoria delle Aree Valutarie
Ottimali (Optimum Currency Areas). L’idea dominante tra gli economisti è infatti sempre stata
che l’Europa non fosse un’Area Valutaria Ottimale. E questo implica che introdurre una
moneta unica tra i diversi Paesi presenta più costi che vantaggi.
La teoria delle Aree Valutarie Ottimali, od Ottime, è dovuta ad autori come il premio
Nobel Robert Mundell, nonché ad importanti economisti come Ronald McKinon, Peter Kenen,
Marcus Fleming, Paul De Grauwe e, in qualche modo, anche il premio nobel Milton Friedman.
Risale ad alcuni decenni fa, e sebbene sia piuttosto variegata, identifica alcune caratteristiche
che dovrebbero essere rispettate perché a diversi Paesi convenga l’adozione di una moneta
unica. Senza entrare nei dettagli tecnici, i Paesi devono essere sufficientemente simili tra loro,
i mercati integrati, prezzi e salari devono essere flessibili, la mobilità dei fattori della
produzione elevata. Quindi, tanto per dare un’interpretazione pratica di questi concetti
teorici, oltre alla similitudine delle strutture produttive, i salari devono ridursi in presenza di
disoccupazione, così come i prezzi in presenza di eccessi invenduti di produzione, deve esserci
la possibilità di assumere e licenziare lavoratori senza vincoli e i lavoratori stessi devono
potersi spostare liberamente da un Paese all’altro quando non trovano una occupazione. Se
questi (e altri) requisiti sono riscontrati nella realtà, allora i diversi Paesi costituiscono
un’Area Valutaria Ottima e dall’adozione di una moneta unica hanno solo da guadagnare; se
invece non è così, allora ai singoli Paesi non conviene adottare una moneta unica.
Perché non conviene? Perché se un Paese rinuncia alla propria moneta, esso rinuncia
anche alla Politica Monetaria e alla politica del tasso di cambio. Può farlo solo se la politica
monetaria comune va bene anche a lui (similitudine dei Paesi), oppure se della politica
monetaria se ne fa poco perché il suo mercato è così concorrenziale (flessibilità di prezzi e
salari, mobilità dei fattori) che è in grado di recuperare spontaneamente la piena occupazione,
senza bisogno di interventi deliberati, quando subisce uno shock. Altrimenti, per compensare
la mancanza della politica monetaria finirà per intervenire con la politica di bilancio, ossia
facendo spesa pubblica espansiva in deficit, e accumulando così debito pubblico, oppure farà
gonfiare bolle speculative.
Sul fatto che l’Europa non costituisse un’Area Valutaria Ottima ci sono sempre stati
pochi dubbi. E allora, perché? Perché si è costituita l’Eurozona? Le teorie al riguardo sono
molte, e non ha un gran senso esaminarle tutte, soprattutto perché poi, alla fine, la moneta
unica è stata introdotta. Possiamo però richiamare le principali.
59
Innanzitutto, secondo alcuni, la politica monetaria non è così importante, perché il
sistema tenderebbe comunque spontaneamente alla piena occupazione e gli interventi
espansivi della Banca Centrale sarebbero inutili, comunque inefficaci e non farebbero altro
che creare inflazione. Quindi, se invece di fare gestire la lotta all’inflazione (l’unico obiettivo
che, secondo questi autori, dovrebbe essere perseguito dalla Banca centrale) a diverse
autorità monetarie nazionali, spesso controllate da Governi lassisti e tendenzialmente pronti a
inflazionare l’economia, la politica monetaria viene centralizzata in un’unica istituzione
europea con esplicita vocazione anti-inflazionistica, disegnata su modello della Bundesbank
tedesca, l’economia ne può solo trarre giovamento. Questa linea di pensiero viene proposta
dai premi Nobel Robert Lucas e Thomas Sargent, ispiratori a partire dalla metà degli anni
settanta della cosiddetta Nuova Macroeconomia Classica, e si diffonde soprattutto grazie
all’opera di Robert Barro e David Gordon, che sviluppano un modello teorico capace di
giustificare una banca centrale di tipo “tedesco”. Da lì discende lo statuto della Banca Centrale
Europea.
Una seconda linea di pensiero ritiene invece che i diversi Paesi dell’Eurozona, pur non
costituendo un’AVO, avrebbe acquisito le caratteristiche che mancano loro col tempo, grazie
alla progressiva integrazione dei mercati realizzata dalle normative europee e dal condividere
un’unica moneta. Questo punto di vista è ad esempio condiviso da teorici delle Avo come
Jeffrey Frankel e Andrew Rose.
Lo stesso ispiratore, nonché autore principale della teoria AVO, il premio Nobel Robert
Mundell, che nel 1961 aveva sostenuto l’importanza per i diversi Paesi di avere una politica
monetaria (e del cambio) indipendente, enfatizzando i costi dell’adesione a una moneta unica,
nel 1973 cambia idea, ritenendo che le novità derivanti dalla globalizzazione, e soprattutto
dalla liberalizzazione finanziaria, sono tali da rendere poco utile, quando non
controproducente, l’indipendenza di politica monetaria.
Ma probabilmente l’interpretazione più convincente è quella proposta da Luigi
Zingales qualche anno fa. Secondo questo autore, tanto gli economisti quanto i politici
dell’Eurozona erano perfettamente consci della circostanza che i Paesi Europei, alla data di
creazione dell’euro, erano troppo diversi tra loro perché gli convenisse condividere un’unica
moneta (e soprattutto un’unica Banca Centrale); ed erano altrettanto consci della circostanza
che le riforme necessarie per far sì che la moneta unica divenisse conveniente, ossia le riforme
necessarie per creare un’AVO dove non c’era, a partire dalla liberalizzazione del mercato del
lavoro, erano troppo impegnative e dolorose per essere politicamente realizzabili in
circostanze normali. Ma se nonostante tutto fosse stata realizzata l’unificazione monetaria i
Paesi più deboli, non potendo più disporre della politica monetaria, e soprattutto del tasso di
cambio e dello strumento della svalutazione competitiva, si sarebbero trovati in difficoltà
crescenti, che avrebbero permesso ai Governi, invocando le circostanze eccezionali e il rischio
di tracollo per il Paese, di adottare quelle dolorose riforme che non potevano realizzare in
tempi normali.
Sia come sia, l’unificazione monetaria in Europa viene realizzata, senza che l’Europa
stessa costituisca un’AVO, e senza che lo diventi negli otto anni successivi. Così quando la crisi
USA arriva nel vecchio continente lo shock è violentissimo.
VI.3 I cinque “maiali”
Coerentemente con la constatazione delle forte diversità dei diversi Paesi che
costituiscono l’Eurozona, la crisi finanziaria USA colpisce l’Europa in maniera fortemente
disomogenea: ci sono banche europee che hanno in portafoglio quote significative di MBS e
60
CDO statunitensi, ma ce ne sono d’altro canto anche molte altre non particolarmente
coinvolte.
La caduta delle esportazioni europee è invece più generalizzata e dunque fa danni
meno selettivi, con la conseguenza che la parte reale della crisi colpisce tutti. Il problema è
che, come abbiamo visto, la situazione di alcuni Paesi europei è già molto delicata. In
particolare cinque sono i Paesi considerati, a ragione, come i più deboli: Portogallo, Irlanda,
Italia, Grecia e Spagna. Per questi Paesi la stampa anglosassone ha coniato un poco piacevole
acronimo, che evidenzia l’esistenza di alcune caratteristiche comuni: l’acronimo è PIIGS, a
richiamare la parola inglese pigs, maiali. Le loro caratteristiche comuni sono la bassa crescita
del PIL e la bassa produttività del lavoro; un elevato debito pubblico (anche se questo non è
del tutto vero per la Spagna, e non è stato certamente la causa della crisi per l’Irlanda, ma
semmai la conseguenza); un notevole deficit di bilancio (anche se per l’Italia non è così); un
tasso di crescita dei salari, e quindi dei prezzi, più alto del resto d’Europa; una debolezza,
spesso marcata e di lungo periodo, nelle esportazioni nette. Questi Paesi sono colpiti dalla
crisi in maniera particolarmente violenta.
Inoltre, anche in Europa si blocca il mercato interbancario, perché le banche, non
sapendo bene quale sia l’effettiva situazione patrimoniale delle controparti, ossia quanti titoli
tossici abbia in portafoglio la banca che sta chiedendo loro un prestito, e il loro grado concreto
di tossicità, non si fidano, e non prestano ad altre banche. Inoltre, non avendo informazioni
sufficienti sull’effettiva solvibilità delle singole istituzioni creditizie, tutti cercano di vendere le
azioni e i titoli che esse hanno emesso, facendone crollare il prezzo. Ma questi titoli sono
anche - anzi soprattutto - posseduti dalle banche, le quali si trovano a veder diminuire il
proprio capitale. E qui prende il via il solito circolo vizioso: un capitale in diminuzione deve
coprire perdite sui prestiti in aumento. Oltre a non prestare più sull’interbancario, quindi, le
banche limitano il credito anche all’economia reale. Creando così problemi alle imprese e
facendo aumentare le insolvenze di queste ultime. E propagando la crisi all’economia reale. In
sostanza, viene replicata la stessa situazione che si è verificata negli Stati Uniti.
Tutto ciò ha un impatto violento sui PIIGS, in particolare sui Paesi che hanno
sviluppato bolle speculative al loro interno e su quelli che hanno un rilevante indebitamento
pubblico. Ma ha anche un impatto violento su un piccolo Paese che sebbene non faccia parte
dell’Unione Economica e Monetaria Europea ha una discreta importanza nella dinamica della
crisi, l’Islanda. Iniziamo da questa, per poi passare ai PIIGS che hanno sviluppato bolle.
VI.4 La crisi e i Paesi della bolla
VI.4.1 La crisi in Islanda
Quando nel 2008 crolla Lehman Brothers, e a seguire tutto il castello di carte della
securitization statunitense, le banche islandesi Kaupthing, Glitnir e Landsbanki si ritrovano
con perdite ingentissime sul mercato dei subprime: erano banche piccole, cresciute a
dismisura grazie all’afflusso ingente di fondi da investitori esteri e dai correntisti (come
sappiamo, anche dai correntisti inglesi) ma con una base di capitale alla quale attingere in
caso di perdite assai contenuta. Così, quando viene giù il mercato dei titoli subprime e si
sparge la voce che le banche islandesi sono pesantemente compromesse con quel mercato,
tutti cercano di spostare i propri capitali fuori dalle banche islandesi e, più in generale, fuori
dall’Islanda. Come sempre, i più rapidi ce la fanno, gli altri no. Soprattutto, quando una banca
ha perdite che eccedono il capitale, e dunque non può far fronte a quelle perdite rimborsando
chi le ha prestato il denaro (obbligazionisti e correntisti), e se per di più tutti i suoi depositanti
stanno scappando, il fallimento è inevitabile.
A questo punto succedono varie cose. Innanzitutto, il Governo islandese, per fermare la
fuga massiccia di capitali dal Paese, impone un blocco alla circolazione dei capitali (tuttora in
61
vigore: un islandese che voglia lasciare il Paese non può portar con sé il suo denaro), anche se
prima che ciò accada la fuga di capitali ha già causato un deprezzamento del tasso di cambio
della corona islandese dell’80%. Poi, cerca di intervenire per evitare il fallimento delle sue
banche, che manderebbe sul lastrico anche gli islandesi che hanno depositato denaro in quelle
banche.
Ma come si salva una banca? Come sappiamo dalla sezione IV.6.4, una banca fallisce se
non le vengono rimborsati così tanti prestiti da lei concessi che il suo capitale non è più
sufficiente a restituire il denaro a chi glielo ha prestato (obbligazionisti, correntisti, Banca
Centrale). Per salvarla dal fallimento è quindi necessario integrare la sua dotazione di capitale
e renderla maggiore delle perdite che sta subendo, o farla acquisire da una entità più grande
che si farà carico col suo capitale delle perdite. Questo possono farlo gli azionisti, soggetti
privati esterni o soggetti pubblici, tipicamente il Governo. È infatti in genere difficile
convincere dei privati, siano essi gli stessi azionisti della banca o soggetti esterni, a mettere
del denaro in una entità che sta fallendo o a rilevarla, soprattutto perché non è mai chiaro se
quel denaro sarà sufficiente, dato che ci vuole tempo per scoprire la reale entità delle perdite.
Nel caso islandese, gli azionisti non erano in grado di immettere sufficiente liquidità nelle
banche, nessun privato aveva intenzione di farlo e acquirenti proprio non se ne vedevano.
Tocca quindi al Governo.
Il Governo può limitarsi a rifinanziare una banca, concedendole un prestito, se lo scopo
è solo quello di guadagnare tempo per trovare acquirenti o finanziatori privati; garantire una
parte delle perdite, sempre per guadagnare tempo, magari in attesa che la banca si risollevi da
sola; o nazionalizzare la banca, ossia rilevare la proprietà e farsi carico di (…pagare)
integralmente le perdite. In tutti i casi serve denaro; negli ultimi due, inoltre, i debiti della
banca diventano debiti del Governo, e dunque si accresce il debito pubblico.
Il Governo islandese punta sulla nazionalizzazione, ma è subito evidente che il crack
bancario, superiore agli 80 miliardi di dollari, quindi oltre sei volte il PIL dell’Islanda che è di
12, è assolutamente insostenibile per le finanze pubbliche: se le banche fossero
nazionalizzate, e se il governo dunque se ne accollasse interamente le perdite, il default del
Paese sarebbe inevitabile. Per evitare ciò, il Governo da un lato chiede un prestito al Fondo
Monetario Internazionale, che in cambio di rigide misure di austerità elargisce al Paese, tra il
2008 e il 2011, circa 5 miliardi di dollari; dall’altro nazionalizza le banche ma accompagna alla
nazionalizzazione l’indennizzo solo parziale dei correntisti e il non indennizzo degli
obbligazionisti, strategia nota come bail-in, ossia salvataggio della banca facendo ricadere i
costi sugli azionisti, sugli obbligazionisti e sui correntisti, che perdono in tutto o in parte il
loro denaro. Il bail-in è in sostanza un salvataggio realizzato da soggetti interni alla banca,
mentre il bail-out è un salvataggio realizzato da soggetti esterni, molto spesso il Governo.
Nei confronti dei correntisti, in particolare esteri, nel corso del tempo ci sarà un
cambiamento di strategia. Se inizialmente l’idea era di rimborsare integralmente i depositanti
esteri, in particolare quelli della filiale inglese Icesave di Landsbanki, progressivamente, anche
per l’intervento di due successivi referendum popolari, la strategia muta. Infatti, quando
Landsbanki e dunque Icesave falliscono, di fronte al rischio che questo fallimento possa
spargere il panico tra i correntisti anche di altre banche inglesi e olandesi, spingendoli a
ritirare i propri depositi, la Gran Bretagna e l’Olanda decidono di indennizzare
immediatamente e generosamente i correntisti inglesi e olandesi di Icesave, convinte di poter
poi chiedere il rimborso al Governo islandese, dato che la nazionalizzazione aveva fatto
divenire Landsbanki di proprietà pubblica. L’indennizzo viene dunque effettuato da Gran
Bretagna e Olanda con fondi del Governo inglese e Olandese e sulla base della nuova, generosa
forma di assicurazione dei depositi in vigore dal 2009 in Europa, che risarcisce circa il 50%
delle perdite complessive e il recupero totale del proprio denaro per chi ha depositi di
ammontare inferiore ai 100.000 euro.
62
Purtroppo per la Gran Bretagna e l’Olanda, però, l’iniziale idea di chiedere indietro il
proprio denaro all’Islanda, se inizialmente viene accolta dalle autorità di quel Paese, poi viene
sottoposta a due referendum popolari e bocciata. L’Islanda, inoltre, fa ricorso alla corte di
Giustizia dell’Efta (European Free Trade Association) sostenendo che Icesave era una branch di
una banca islandese, e che dunque come per tutte le branch dovrebbe valere la normativa di
tutela dei depositi del Paese di origine della banca, molto meno generosa nei confronti dei
correntisti rispetto alle normative inglesi e olandesi (l’indennizzo totale era previsto sotto i
40.000 e non sotto i 100.000 euro). Questo implica che avrebbe dovuto rimborsare ai Governi
di Olanda e Gran Bretagna molto meno di quanti questi avevano speso e pretendevano
indietro. Il resto inglesi e olandesi lo avrebbero avuto, se si fosse trovata disponibilità
sufficiente, dalla liquidazione delle proprietà delle banche fallite, che avrebbe naturalmente
richiesto tempo e non avrebbe certo portato al rimborso integrale. Di qui l’ira di Olanda e
Gran Bretagna, che quasi giungono a minacciare guerra all’Islanda!
Per la cronaca, l’EFTA nel marzo del 2013 darà poi ragione all’Islanda che, ad oggi, ha
sostanzialmente integralmente pagato ciò che l’EFTA ha stabilito dovesse pagare. Col che i veri
perdenti dell’intera procedura sono stati i Governi Inglesi e Olandesi, i correntisti inglesi e
olandesi oltre i 100.000 euro, che hanno perso una parte del loro denaro, i contribuenti
islandesi che hanno subìto una recessione e un drastico incremento delle imposte per pagare
quanto dovuto a Inghilterra e Olanda, chi possedeva obbligazioni delle banche, che perde
tutto, così come gli azionisti, mentre i correntisti con depositi inferiori a 100.000 euro sono
riusciti a recuperare il proprio denaro.
La peculiarità dell’esperienza islandese è il ricorso a procedure di salvataggio bancario
realizzate con un bail-in, ossia un salvataggio “interno” nel quale partecipano alle perdite,
nell’ordine ma in diversa misura, gli azionisti, gli obbligazionisti e anche i correntisti, e non di
bail-out, ossia un salvataggio “esterno” nel quale il Governo si fa carico delle perdite della
banca e i costi ricadono sui contribuenti e/o accrescono il debito pubblico.
VI.4.2 La crisi in Irlanda
Secondo un vecchio adagio, tutte le tigri finiscono, prima o poi, in pellicceria. E così è
stato anche per l’Irlanda, la tigre celtica. Quando scoppia la bolla subprime le piccole banche
irlandesi, che tanto piccole non sono più, scoprono di aver prestato una gran quantità di
denaro a mutuatari che sarebbero stati solvibili se il prezzo degli immobili fosse aumentato,
ma che adesso solvibili non sono, e non riescono a restituire alle banche i prestiti ottenuti. Le
banche scoprono anche che il loro capitale è assolutamente insufficiente per coprire le
perdite. Scoprono, di fatto, di essere insolventi.
A questo punto interviene il Governo irlandese, che tenta di salvare le banche dal
fallimento rifinanziandole, garantendo lui i loro debiti o, nei casi più gravi, nazionalizzandole,
come accaduto alla Anglo Irish Bank e alla Allied Irish Bank. Il Governo sottovaluta però di
parecchio il costo totale dell’operazione, perché i passivi bancari si riveleranno molto
maggiori di quanto inizialmente si pensasse, e per reperire questi fondi si trova costretto a
realizzare deficit di bilancio che eccedono di parecchio il 3% del PIL previsto dal Patto di
Stabilità e Crescita (si giungerà ad un massimo del 31% nel 2010), con immediate
conseguenze sul debito pubblico. Il rapporto debito pubblico/PIL, che come abbiamo visto era
al 24,9% nel 2007, aumenta progressivamente: dal 44,3% del 2008 al 65,2% del 2009 sino al
94,9% del 2010 (supererà il 100% nel 2011). L’Irlanda, a questo punto, taglia gran parte
della sua spesa sociale, quella destinata al welfare e all’assistenza ai bisognosi, ma non basta.
Prosciuga il fondo per le pensioni, ma ancora non è sufficiente. Soprattutto, l’incremento del
debito preoccupa i mercati, che chiedono tassi di interesse sempre più alti per comprare i
titoli irlandesi. Nel 2010, quando questi tassi diventano così alti da essere considerati
63
insostenibili per il Paese, l’Irlanda dovrà chiedere assistenza finanziaria alle autorità europee
e al Fondo Monetario Internazionale.
La crisi irlandese ci ha insegnato due cose importanti. La prima è che anche Paesi dalle
finanze pubbliche floride, con poco debito pubblico, possono andare in crisi in presenza di
bolle speculative. La seconda è una conferma, dopo il caso USA: il debito privato tende a
diventare debito pubblico quando i privati non lo ripagano alle banche che lo hanno concesso
e i Governi intervengono per salvare le banche che altrimenti fallirebbero.
VI.4.3 La crisi in Spagna
In Europa le bolle tendono a scoppiare tutte assieme, e dunque poco dopo l’Irlanda è la
volta della Spagna. In questo Paese i problemi iniziano a divenire rilevanti alla fine del 2008,
quando la bolla scoppia, il PIL si contrae e inizia una lunga recessione. In particolare nel caso
spagnolo il crollo della domanda e del prezzo degli immobili porta alla crisi del settore
dell’edilizia, che trainava l’economia spagnola, con licenziamenti di massa, recessione,
fallimento delle imprese edili che non restituiscono i prestiti alle banche, insolvenza degli
spagnoli che avevano acquistato immobili con un mutuo contando di rivenderli a prezzo
maggiorato, e quindi problemi ulteriori per le banche che vedono i prestiti erogati diventare
inesigibili.
Il Governo spagnolo interviene per sostenere l’economia, e in particolare il settore
dell’edilizia, finanziando soprattutto opere pubbliche e infrastrutture. La spesa pubblica
cresce in maniera massiccia: è il 38% del PIL nel 2006, il 39% nel 2007, sale al 41% nel 2008,
per schizzare al 46% nel 2009 e 2010. L’impatto sul deficit di bilancio è immediato, e il
rapporto deficit/PIL supera subito il 3% imposto dal Patto di Stabilità e Crescita: è infatti del
9,6% sia nel 2010 sia nel 2011, e supera il 10,5% nel 2012. Delle banche, inizialmente, non ci
si preoccupa, perché sembrano meno a rischio di quelle irlandesi. Si scoprirà però quasi
subito che non è così, e che ogni Paese che sviluppa una bolla porta i propri istituti di credito
verso l’insolvenza. In ogni caso, almeno in una prima fase, il Governo spagnolo realizza una
politica anticiclica - cerca cioè di contrastare il ciclo economico, in questo caso la recessione finanziando spesa pubblica espansiva, e per questo peggiora i propri conti pubblici: nel 2010
il debito pubblico era il 62% del PIL, diventa il 70% nel 2011 e l’86% nel 2012. Nel 2012 però
la crisi bancaria è diventata evidente, con 171 miliardi di potenziali perdite per gli istituti di
credito, mentre i mercati chiedono tassi di interesse sempre più alti per comprare i titoli del
crescente debito spagnolo. Il Governo capisce che la quantità di denaro che dovrebbe
prendere a prestito per rifinanziare le banche è talmente elevata che spaventerebbe i mercati
e farebbe quindi salire i tassi a livelli insostenibili, ed è costretto a richiedere l’aiuto europeo e
intraprendere una politica di bilancio restrittiva per ottenerlo.
Può essere appena il caso di ricordare qui, ma vale in generale, che la recessione ha un
impatto positivo su uno dei problemi principali dei PIIGS (o, almeno, della maggior parte di
essi): la carenza di esportazioni nette. La recessione in un Paese, infatti, riduce i consumi di
quel Paese, e quindi anche le importazioni di beni; e poiché le esportazioni nette sono il saldo
tra esportazioni e importazioni, in ultima istanza la recessione incrementa le esportazioni
nette e migliora il saldo commerciale. Lasciamo al lettore valutare se si tratti effettivamente,
però, di un dato totalmente positivo.
VI.5 La crisi e i Paesi del debito
VI.5.1 La crisi in Grecia
Tra i Paesi del debito il primo e più rilevante caso di crisi conclamata riguarda la
Grecia. Infatti le elezioni politiche del 2009 vengono perse dalla coalizione di centrodestra
sino ad allora al potere e vinte dal Pasok di George Papandreou, il quale dopo pochi mesi di
64
governo annuncia il reale stato delle finanze del Paese: il deficit passa così dal 6% a quasi il
14% del PIL, mentre il rapporto debito/PIL schizza al 115%. Questa situazione spaventa i
mercati, che dopo la crisi finanziaria USA del 2007 sono diventati tra l’altro assai meno
condiscendenti nei confronti dell’indebitamento (pubblico e privato), col risultato che tutti
diventano molto più prudenti nel concedere prestiti, e mettono esplicitamente in conto la
possibilità che anche i Paesi possano non ripagare il proprio debito, ossia fallire, anche se
appartiene all’Eurozona. Se poi un Paese ha anche truccato i propri conti pubblici per
mostrare una situazione migliore di quella reale, i mercati ritengono che prestare a quel Paese
sia molto rischioso, e lo fanno solo se il tasso di interesse che viene loro pagato è tanto alto da
compensare il rischio.
Improvvisamente la Grecia si trova dunque ad operare in un mondo del tutto diverso
rispetto al precedente, costretta a pagare tassi di interesse sempre più alti. E più sono elevati i
tassi che deve pagare, maggiore la sua spesa e quindi maggiore il suo deficit; e più alto il
deficit, più rilevante la quantità di prestiti che deve richiedere, ossia di titoli del debito che
deve emettere, per finanziarlo; e più prestiti chiede più i mercati si pongono dubbi sulla
sostenibilità del debito greco e impongono tassi maggiori per finanziarlo: è il cosiddetto
effetto palla di neve, che finisce per travolgere le finanze pubbliche del Paese.
Anche la Grecia è alla fine costretta a chiedere l’aiuto europeo. Aiuto che però le sarà
dato a condizioni inizialmente poco favorevoli, perché il fatto di aver truccato i conti pubblici
non sarà propriamente considerato una nota di merito. In ogni caso, nel maggio del 2010 i
Paesi dell’Eurozona e il Fondo monetario Internazionale le concedono un prestito di 110
miliardi di euro (rispettivamente 80 e 30 miliardi). Il prestito è a cinque anni a un tasso di
interesse del 5,2%, alto ma comunque inferiore a quanto avrebbe probabilmente dovuto
pagare collocando titoli sul mercato. Il prestito è subordinato alla realizzazione di un rigido
piano di contenimento della spesa pubblica e di liberalizzazione dei mercati, che però sarà
realizzato solo in parte a causa degli alti costi sociali che implica.
Nonostante questo primo pacchetto di aiuti, la Grecia non riesce ad uscire dalle sue
difficoltà e, come vedremo in maggior dettaglio nel capitolo VIII, nel 2012 sarà costretta a
dichiarare insolvenza.
VI.5.2 La crisi in Portogallo
Una situazione in gran parte simile rispetto a quella greca si verifica in Portogallo: il
Paese, pur non avendo truccato i propri conti come la Grecia, si trova ad avere un rilevante
deficit di bilancio e un debito pubblico fuori controllo, non tanto per il suo valore assoluto
quanto per la rapidità della sua crescita: il rapporto debito/PIL è infatti il 66% nel 2008,
diventa il 77% nel 2009, il 94% nel 2010, il 108% nel 2011. Inoltre, molte banche sono
coinvolte nel finanziamento della bolla immobiliare spagnola, e si ritrovano quindi in grande
difficoltà quando questa scoppia. Infine, il Paese esporta sempre di meno, con un deficit
commerciale costantemente superiore al 10% del PIL. La somma di elevato debito pubblico,
elevato debito privato e debolezza delle esportazioni, in un contesto come quello successivo
alla crisi statunitense, con i mercati improvvisamente divenuti molto meno generosi, porta il
costo dell’indebitamento per il Portogallo a crescere oltre il tollerabile, il Paese non riesce più
a farvi fronte e nel marzo del 2011 deve dunque richiedere anch’esso l’aiuto internazionale.
VII. La Crisi in Italia
65
VII.1 La crisi del 2009
Un discorso più ampio merita l’impatto della crisi sul nostro Paese, impatto che è
apparso meno eclatante rispetto a quello che si è avuto su Grecia, Irlanda o Portogallo, solo
perché l’Italia non ha chiesto l’aiuto internazionale, ma è stato probabilmente più profondo,
più grave e di durata maggiore.
La crisi giunge in Italia nel 2009, e lo stato precario delle nostre finanze pubbliche ci
impedisce di realizzare spesa pubblica in deficit per contrastare la riduzione della produzione
e dell’occupazione, come ad esempio ha fatto la Francia, o la stessa Spagna. La recessione del
2009 è quindi stata durissima, con il PIL del Paese che cade, tra il 2008 e il 2009, del 6,5%. E
comunque, anche senza politiche controcicliche, lo stato delle nostre finanze pubbliche è
peggiorato. Uno dei principali indicatori della solidità delle finanze pubbliche è infatti il
rapporto deficit/PIL, e la recessione non solo riduce il PIL, facendo inevitabilmente salire il
rapporto, ma innesca anche i cosiddetti stabilizzatori automatici, in particolare incrementa la
spesa per i sussidi di disoccupazione (in Italia soprattutto cassa integrazione e mobilità) e
riduce il prelievo fiscale, perché quando scende il reddito diminuisce anche il prelievo,
incrementando il deficit. E il deficit è finanziato emettendo titoli, ossia accrescendo il debito
pubblico. Quindi non solo non abbiamo potuto contrastare adeguatamente la recessione con
spesa pubblica espansiva, per non incrementare il già alto livello del debito, ma il deficit e il
debito sono aumentati ugualmente, trasmettendo così ai mercati un segnale di debolezza della
nostra finanza pubblica che ha portato a un incremento degli interessi che paghiamo quando
cerchiamo di indebitarci emettendo titoli, con gli usuali ulteriori effetti di accrescimento di
deficit e debito.
La crisi del 2009 comunque, per quanto grave, appare un fenomeno passeggero, e
viene (erroneamente) giudicata più come un “contagio” della crisi statunitense che come una
vera problematica europea: l’idea è che, in un contesto globalizzato, crisi di alcune aree
geografiche abbiano impatti globali. Da contrastare sì, ma senza preoccuparsene troppo. Non
è infatti un caso che la risposta europea sia in ordine sparso, con alcuni Paesi che
intervengono con spesa pubblica espansiva, altri, come l’Italia, che accettano passivamente la
recessione, data la situazione problematica delle finanze pubbliche, e le istituzioni europee
che non attuano una vera e propria politica di intervento.
Tra l’altro, quando questa prima lettura del problema appare superata, si passa ad una
seconda lettura, altrettanto parziale e fuorviante: la crisi sarebbe una crisi dei debiti sovrani,
nel senso che i mercati, spaventati dalla crisi statunitense e dalla catena di fallimenti privati
che ne sono derivati, mostrano un improvviso scetticismo nei confronti della solvibilità non
solo dei privati, ma soprattutto degli Stati altamente indebitati. Col risultato che è molto più
complicato per questi Paesi collocare titoli di Stato sul mercato, e quando ci riescono devono
pagare tassi di interesse sempre più alti, generando l’effetto “palla di neve”. La crisi europea
sarebbe dunque colpa dei paesi “lassisti”, che hanno accumulato debiti pubblici eccessivi e ora
debbono ridurli al fine di riguadagnare la fiducia dei mercati e tornare a potersi indebitare a
condizioni ragionevoli.
Questa seconda lettura della crisi è tanto fuorviante quanto propagandata, e tuttora il
“lassismo fiscale” è spesso indicato, soprattutto a livello politico e giornalistico, come causa
della crisi e il debito pubblico come problema cruciale. In realtà, come sappiamo, la crisi non è
una crisi da debito pubblico (come testimonia la circostanza che essa ha colpito duramente
anche Paesi con indebitamento pubblico quasi nullo, come Spagna e Irlanda), ed il debito,
pubblico o privato che sia, è solo una conseguenza delle diverse strategie che alcuni Paesi
hanno adottato per sostenere la domanda aggregata quando la crisi di produttività e crescita è
66
diventata drammatica e le svalutazioni competitive non sono più state possibili.
Particolarmente spiacevole è la circostanza che anche le autorità e gli economisti che avevano
perfettamente chiara la vera ragione della crisi abbiano continuato, per fini che saranno
evidenti tra breve, a narrare la favola della crisi da lassismo fiscale, che poteva essere risolta
solo riducendo drasticamente la spesa pubblica per combattere l’indebitamento. Una strategia
che come vedremo avrebbe avuto (ha avuto) come conseguenza una drastica riduzione,
probabilmente permanente, del tenore di vita di molti Paesi europei, adottata sulla base della
convinzione che gli elettori non fossero in grado di capire la natura del problema e accettare
le politiche necessarie per risolverlo.
Sia come sia, la crisi non sarà affatto passeggera, anzi.
VII.2 La crisi del 2012
Passato il primo crollo, quello del 2008-2009, nel 2010 il PIL dell’Italia, come quello di
molti Paesi europei, riprende a crescere. Ma è solo un breve momento di pausa prima che la
crisi precipiti. Infatti, sotto la spinta propagandistica di una crisi causata dal debito pubblico,
suffragata tra l’altro dall’evidenza empirica di tassi di interesse sempre più alti richiesti dal
mercato per acquistare i titoli del debito di Paesi dei quali si temeva una possibile insolvenza,
le politiche europee, così come quelle dei singoli Paesi e della Banca Centrale, diventano
improvvisamente restrittive: se il problema è il debito, e se il debito è generato da un eccesso
delle spese pubbliche sulle entrate pubbliche, per risolvere il problema è necessario tagliare
drasticamente le spese e/o aumentare le entrate, ossia le imposte. La malafede sta nel fatto
che tutti già allora sapevano perfettamente (così come tutti sanno perfettamente oggi) che il
problema non è il debito, e che anche qualora lo fosse stato la soluzione intrapresa sarebbe
stata sbagliata, perché queste politiche lo avrebbero fatto aumentare e non ridurre.
L’obiettivo, in realtà, era un altro: recuperare la competitività delle esportazioni con
l’abbassamento dei salari e le riforme del mercato del lavoro rese politicamente accettabili
grazie alla diffusione di disoccupazione di massa, che avrebbe fiaccato la resistenza di
sindacati e lavoratori sino a costringerli ad abbandonare la difesa dei diritti acquisiti negli
ultimi decenni.
In ogni caso, le politiche europee diventano improvvisamente quasi tutte restrittive, e
dunque non è sorprendente che i Paesi più deboli dell’Eurozona, in assenza di sostegno alla
domanda aggregata, ed anzi in presenza di politiche di restrizione della spesa, vedano
improvvisamente crollare la domanda aggregata e il PIL. In sostanza, attorno al 2012 questi
Paesi piombano in una nuova crisi, stavolta indotta dalle politiche economiche intraprese e
non ereditata da oltre oceano.
In particolare il PIL italiano torna a ridursi, e continuerà a farlo sostanzialmente per
tutti i trimestri successivi, sino al 2015: -2.5% nel 2012, -2% nel 2013, - 0,4% nel 2014…
Sulla spinta di questa nuova crisi, e della perfetta conoscenza da parte delle autorità
europee delle sue cause profonde, la Banca Centrale Europea nell’estate del 2011 invia a
Roma una lettera nella quale chiede con urgenza la realizzazione di riforme strutturali per
rilanciare la crescita, con la riduzione dei salari, la liberalizzazione di alcuni servizi pubblici,
l’innalzamento dell’età pensionabile e importanti tagli di spesa pubblica. Che le riforme
strutturali fossero e siano indispensabili non è in dubbio, ma che esse potessero essere
realizzate mentre il Paese andava in recessione a causa dei tagli imposti è meno scontato; più
probabile che i tagli servissero a creare una recessione capace di portare i sindacati e i partiti
di opposizione a opporsi di meno…
A queste pressioni delle autorità europee si aggiungono le pressioni dei mercati,
spaventati dall’apparente incapacità dei Governi italiani di rendersi conto della situazione e di
approntare politiche adeguate: a causa dei vincoli politici i Governi italiani, infatti, tagliano le
67
imposte e limitano per quanto riescono la spesa pubblica, causando recessione e
disoccupazione, ma non riescono ad intraprendere effettive politiche di riforma. Anche
perché, a differenza ad esempio della Grecia, l’Italia è un Paese grande e discretamente ricco,
che può utilizzare i risparmi accumulati in passato dalle famiglie per fronteggiare la crisi, e
dunque sopportare più a lungo la recessione prima di essere costretto ad accettare le
necessarie e dolorose riforme che rilancerebbero la produttività e la crescita. Quindi, niente
riforme strutturali, e ci teniamo il problema consumando i risparmi passati.
Inoltre, il taglio principale della spesa pubblica non riguarda tanto le spese correnti,
che anzi continuano ad aumentare, ma quelle per investimento, formazione, istruzione,
ricerca e sviluppo. Ossia tagli politicamente più accettabili (gli scienziati non scendono in
piazza…) ma che hanno un impatto negativo anche sulla crescita di lungo periodo. Ottenendo
dunque risultati diametralmente opposti a quelli necessari. Non sorprende allora che i
mercati ci considerino incapaci di affrontare la situazione, e vedano il Paese precipitare verso
il fallimento: il 9 novembre 2011 lo spread, la differenza di tasso di interesse pagato, tra i BTP
decennali italiani e i corrispondenti titoli tedeschi raggiunge il 575 punti base, ossia un titolo
tedesco rende quasi il 6% in più rispetto a un titolo italiano.
Sotto questa pressione Silvio Berlusconi rassegna le proprie dimissioni e viene
nominato Presidente del Consiglio il senatore a vita Mario Monti, il quale ha sostanzialmente
lo scopo di trasmettere ai mercati il messaggio che l’Italia è in grado di realizzare le riforme
necessarie e che finalmente era stato nominato un Governo competente capace di ignorare le
esigenze politiche di breve periodo e di privilegiare le esigenze di lungo periodo, superando la
resistenza dei sindacati e delle opposizioni: un messaggio che, se recepito, come è stato,
avrebbe permesso al Paese di collocare i propri titoli di Stato sul mercato a tassi di interesse
molto minori, e dunque di poter realizzare le necessarie riforme in un contesto di finanza
pubblica meno critica.
In ogni caso, non erano in dubbio le politiche da intraprendere: politiche di riforme
strutturali e liberalizzazioni per la crescita, politiche restrittive per la domanda aggregata;
dove le politiche restrittive, che pur danneggiano la crescita di lungo periodo, sono giustificate
dalla finalità di far accettare agli italiani le riforme. In sostanza, ci avrebbe pensato la
recessione e la disoccupazione a convincerci della ineludibilità delle riforme, che implicavano
tra le altre cose minori tutele sul mercato del lavoro e salari più bassi.
VII.3 L’impatto sulla crescita e sulla domanda aggregata
VII.3.1 effetti temporanei ed effetti irreversibili
La “lunga crisi” che ha colpito l’Italia a partire dal 2009, e che nel momento in cui
questo libro va in stampa non è ancora realmente terminata, non si è limitata ad avere un
impatto recessivo temporaneo, ossia a colpire negativamente la domanda aggregata e dunque
il PIL, ma ha avuto, e sta avendo, un impatto devastante sulla crescita di lungo periodo. E
mentre l’effetto sulla domanda aggregata è temporaneo e reversibile, sebbene il costo sociale
ed umano sia elevato, l’effetto sulla crescita è irreversibile, con una massiccia distruzione di
capacità produttiva installata, il fallimento di migliaia di imprese, l’emigrazione o la perdita di
competenze di una quota massiccia di lavoratori.
VII.3.2 L’impatto sulla crescita
Secondo molti economisti neoclassici le crisi recessive possono essere un bene per
l’economia, perché servono a ripulire il mercato dalle imprese scarsamente efficienti che in
tempi di “vacche grasse” rimangono in piedi, mentre in tempi di “vacche magre” falliscono ed
escono dal mercato. Certo, il costo sociale di questi fallimenti è elevato, poiché implicano non
solo perdite per l’imprenditore, ma anche perdite di reddito e di posti di lavoro. Ma la teoria
68
neoclassica ritiene che i lavoratori disoccupati troveranno facilmente lavoro altrove e gli
imprenditori impareranno dai loro errori e ricreeranno imprese più efficienti.
Purtroppo, quando la recessione è di lunga durata, colpisce l’economia nel suo
complesso ed è accompagnata da un credit crunch, ossia da una contrazione dell’offerta di
credito, anche le imprese più efficienti ne sono coinvolte. Infatti in una simile situazione, come
previsto, le imprese male amministrate falliscono; ma anche quelle bene amministrate (i) non
realizzano investimenti, ossia non accrescono o ammodernano la capacità produttiva, perché
una volta compreso che la crisi sarà di lunga durata non pensano, ragionevolmente, che vi
sarà domanda abbondante per i loro prodotti in futuro; (ii) per le stesse ragioni rinviano a
tempi migliori le spese in ricerca e sviluppo, poiché non ha senso sviluppare nuovi prodotti in
fasi di “stanca” del mercato; (iii) anche se volessero effettuare investimenti, avrebbero
difficoltà a finanziarsi sul mercato; (iv) infine, se anche avessero i fondi per realizzarli, non li
realizzerebbero nel nostro Paese ma all’estero; e infine (v), gli IDE in ingresso nel nostro
Paese già erano scarsi per i motivi visti in precedenza, con la crisi si riducono ulteriormente.
Tanto per dire, nel 2012 gli investimenti si sono contratti dell’8,3%; l’anno dopo, di quasi il
6%.Niente investimenti, però, niente crescita di lungo periodo.
Per quanto invece riguarda i lavoratori, lunghi periodi di disoccupazione causano una
obsolescenza delle competenze, oltre a danni psicologici e materiali rilevanti; l’emigrazione
della forza lavoro più qualificata, che viene persa per il Paese; la riduzione dello skill premium,
portando i giovani a non investire in formazione. Tutti questi elementi hanno impatti negativi
sulla produttività del lavoro e sulla crescita di lungo periodo.
Infine, poiché la crisi del 2012 è stata causata anche (soprattutto?) dalle politiche
pubbliche restrittive, il taglio della spesa da parte dello Stato ha avuto un impatto negativo
soprattutto sugli investimenti pubblici, tanto fisici quanto in formazione e ricerca e sviluppo
Il combinato disposto di tutto ciò, in un Paese dove già la dotazione infrastrutturale è
scarsa e limitata la spesa in ricerca e sviluppo, è una drastica riduzione delle potenzialità di
crescita del Paese.
VII.3.3 L’impatto sulla domanda aggregata
Se andiamo a considerare gli impatti della recessione sulle diverse componenti della
domanda aggregata, notiamo subito come la crisi comprime il reddito dei soggetti, e dunque
riduce i consumi, che dipendono dal reddito. Inoltre, quando la crisi si prolunga le aspettative
sul futuro da parte dei consumatori diventano pessimistiche, così il risparmio precauzionale
aumenta (metto qualcosa in più da parte per il futuro, perché non si sa mai…) e anche per
questo motivo i consumi si riducono. Poi, i disoccupati consumano molto meno degli occupati,
soprattutto se nel frattempo si mettono in essere misure per ridurre i sussidi di
disoccupazione o il ricorso alla cassa integrazione. Infine, i consumi si riducono a causa
dell’aumento delle imposte per far fronte all’incremento della spesa pubblica in sussidi di
disoccupazione e spese sociali. Quindi la recessione peggiora sicuramente la componente
consumi della domanda aggregata.
Della componente investimenti abbiamo già detto occupandoci della crescita, al
paragrafo precedente: la recessione la peggiora, sia nella componente pubblica sia in quella
privata, sia nella componente interna sia in quella estera.
In recessione toccherebbe quindi alla spesa del Governo sostenere la domanda
aggregata: sia nella componente spesa pubblica (costruisco strade e ferrovie in modo da
assumere disoccupati e contrastare così la riduzione dei consumi, oppure aumento
direttamente l’occupazione pubblica), sia nella componente sussidi, soprattutto relativa ai
cosiddetti “stabilizzatori automatici” (tipicamente, i sussidi di disoccupazione: la spesa
erogata in sussidi di disoccupazione aumenta infatti automaticamente quando, con la crisi,
aumenta la disoccupazione, e dunque più gente vi fa ricorso). Purtroppo però l’elevato debito
69
pubblico, e i vincoli che ci siamo imposti sottoscrivendo prima il Patto di Stabilità e Crescita e
poi il Fiscal Compact ci impediscono di fare la spesa pubblica che sarebbe necessaria per
contrastare la recessione. Possiamo anche dire di più: poiché la recessione riduce il reddito
nazionale, i singoli soggetti, avendo meno reddito, pagano anche meno imposte su quel
reddito (semplificando un po’, la percentuale di imposte che pagano è - quasi - la stessa, ma se
il loro reddito si è ridotto anche le imposte che pagano si sono ridotte), il Governo incassa di
meno e dunque i problemi di finanza pubblica, e in particolare il deficit e il debito, aumentano,
rendendo necessarie ulteriori riduzioni di spesa pubblica. Non solo non possiamo aumentare
la spesa del Governo per contrastare la recessione, ma anzi dobbiamo ridurla!
Rimarrebbe la componente esportazioni, ma se la crisi è anche di molti Paesi esteri
(non di tutti, ma di molti), questi domanderanno sempre meno merci, e anche meno merci di
nostra produzione; inoltre, non possiamo svalutare il cambio per recuperare competitività;
infine, senza riforme e investimenti niente recupero di competitività e niente riduzione dei
prezzi. Dalla componente esportazioni, dunque, possiamo aspettarci poco. Molto di più,
invece, possiamo aspettarci dalle esportazioni nette, che come sappiamo con la recessione
migliorano, perché si riducono le importazioni. È però un ben doloroso e poco desiderabile
miglioramento…
VII.3.4 L’impatto sul debito pubblico
Ma almeno, le politiche restrittive che hanno determinato la seconda recessione
italiana del ventunesimo secolo, sono riuscite a conseguire il loro obiettivo, ossia ridurre il
debito pubblico del nostro Paese, da molti indicato come “il” nostro problema (anche se
abbiamo visto più volte come il debito sia più una conseguenza dei problemi che la causa)? La
risposta è negativa.
Infatti le politiche restrittive realizzate non hanno avuto un impatto positivo sul debito
pubblico. Può però essere utile distinguere l’andamento assoluto del debito dal suo
andamento relativo.
Iniziamo dall’andamento assoluto. Sebbene ci sia stato un importante contenimento di
alcune voci di spesa, altre sono inevitabilmente aumentate, come tutte le forme di sussidio più
o meno diretto ai disoccupati, mentre la riduzione del reddito ha comportato un minor gettito
fiscale e quindi minori entrate per il Governo: maggiori spese e minori entrate rendono
necessario procurarsi maggiori fondi, e dunque il debito aumenta invece di ridursi. 2.000
miliardi di euro nel 2012, 2.100 nel 2013, quasi 2.200 nel 2014…
Per quanto invece riguarda l’andamento relativo, l’unica misura realmente significativa
del debito non è il suo valore assoluto, ma il rapporto debito/PIL: e se il debito aumenta,
mentre il PIL si riduce, come è durante le recessioni, il rapporto ha due motivi per aumentare,
e diventa veramente complicato ottenere successi da queste misure. Infatti in Italia il rapporto
debito/PIL aumenta costantemente: è il 120% nel 2010, il 121% nel 2011, il 127% nel 2012, il
132% nel 2013, il 134% nel 2014…
È finita? No, perché se anche riuscissimo, attraverso drastici contenimenti di spesa
accompagnati da aumento delle imposte, a ridurre il deficit di bilancio, questa riduzione di
spesa del Governo in piena recessione aggraverebbe ulteriormente la recessione, sia perché
meno spesa pubblica e/o più imposte vuol dire meno domanda aggregata, sia perché gli
imprenditori si spaventano delle prospettive future (chi domanderà mai i miei prodotti?) e
delocalizzano le produzioni in altri Paesi, aggravando la disoccupazione e dunque la
recessione, con ulteriori riduzioni di reddito. In sostanza il reddito si riduce non solo perché
c’è la recessione, ma perché le manovre attuate aggravano quella recessione.
Insomma, tanto il debito quanto il rapporto debito PIL, invece di ridursi, sono stati
aumentati dalle politiche restrittive intraprese. Che non servono dunque neppure a
conseguire gli scopi per i quali sono state (ufficialmente) proposte.
70
Possibile che di questo economisti e politici europei non si rendessero conto, e per di
più perseverassero man mano che le politiche fallivano sistematicamente? No, non è possibile.
Molto più ragionevole è quindi pensare che l’obiettivo delle politiche fosse invece proprio
quello di aggravare la crisi, per costringere i Paesi deboli, Italia in testa, a fare le riforme
necessarie.
71
PARTE QUARTA
POLITICHE CONTRO LA CRISI. ORTODOSSE E ALTERNATIVE
72
VIII. Combattendo (?) la crisi: le politiche del rigore (ma anche
no)
VIII.1 Le diverse politiche intraprese all’arrivo della crisi
La crisi, come abbiamo visto, colpisce prima gli Stati Uniti, poi l’Europa, ed entrambe le
aree geografiche pongono in essere politiche atte, nelle intenzioni, a contrastarla. Si tratta
però di politiche che nelle prime fasi mostrano scarsa coerenza, come se le autorità non
avessero ben chiara la reale natura dei problemi che si trovano a dover affrontare e,
soprattutto, non avessero elaborato una strategia definita alla quale attenersi. Poi, però, la
natura della crisi sembra divenire progressivamente evidente, e si chiariscono anche le
diverse linee di intervento adottate dai policy maker: da un lato, negli Stati Uniti, massiccio
intervento pubblico di sostegno alla domanda aggregata, sia con spesa pubblica espansiva sia
con un rilevante intervento della Federal Reserve; dall’altro, in Europa, timidi tentativi iniziali
di alcuni Stati, in particolare quelli meno indebitati, di sostenere la domanda aggregata con
spesa pubblica espansiva, poi drastica virata sul “rigore”, con politiche di bilancio
pesantemente restrittive, tentativi variamente riusciti di realizzare riforme strutturali
tendenti a liberalizzare i mercati e ridurre i salari, interventi della Banca Centrale Europea
tardivi, contrastati e comunque mai massicci come quelli della FED.
Prima di esaminare in dettaglio le politiche intraprese sulle due sponde dell’Oceano,
evidenziando l’enorme differenza di filosofia economica che le ispira, è però necessario
anticipare che almeno in parte la diversità delle politiche di intervento trova giustificazione
nella diversità della crisi Statunitense rispetto a quella Europea: la prima è una crisi
essenzialmente da carenza di domanda aggregata, che può quindi essere affrontata con
strumenti di sostegno della domanda aggregata; l’altra è un mix di crisi da carenza di
domanda aggregata e bassa crescita, aggravata da rilevanti problemi strutturali e debitori di
alcuni Paesi, che avrebbe tratto un giovamento solo parziale da interventi sulla sola domanda
aggregata. Lo stesso (apparente o reale che sia) successo delle politiche intraprese negli Stati
Uniti può così essere solo parzialmente citato come prova empirica dell’opportunità di
adottare simili politiche anche in Europa proprio a causa della diversa natura della due crisi.
Ciò nonostante, appare difficilmente controvertibile che la filosofia ispiratrice degli interventi
statunitensi ed europei è stata, ed è tuttora, profondamente diversa; ed appare altrettanto
difficilmente controvertibile che le politiche statunitensi hanno avuto successo, per quanto
parziale e forse destinato al solo breve periodo, mentre quelle europee non hanno avuto
altrettanto successo, ed anzi hanno probabilmente contribuito ad aggravare, o almeno a
rendere più lunga e dolorosa, la crisi.
VIII.2 Le politiche intraprese negli Stati Uniti
VIII.2.1 Le politiche del Governo USA
Come abbiamo visto nel capitolo VI, quando nel 2007 la crisi colpisce gli Stati Uniti
l’impatto è particolarmente violento prima sulle banche e sulle società finanziarie, poi
sull’economia reale, con un drammatico crollo della domanda aggregata, del reddito e
dell’occupazione. Gli interventi delle autorità degli Stati Uniti per contrastare la crisi sono stati
di vario genere, realizzati sia dal Governo sia dalla Banca Centrale.
Innanzitutto, dopo aver visto l’enorme impatto del fallimento di Lehman Brothers
sull’economia reale, si è cercato di impedire l’insolvenza delle banche. A questo fine è
necessario innanzitutto renderle di nuovo liquide, ossia prestar loro denaro a breve per
73
evitare che crisi di liquidità divengano crisi di insolvenza; ma soprattutto aumentare il
capitale di cui dispongono e ridurre le perdite che affrontano.
La FED innanzitutto interviene per risolvere il problema di liquidità delle banche
prestando loro illimitatamente moneta a tasso praticamente zero. Poi il Governo, tra i diversi
piani di intervento intrapresi, non solo compra dalle banche azioni di nuova emissione senza
diritto di voto (per evitare l’accusa di nazionalizzazione: negli USA non si fa, è socialismo!), ma
soprattutto acquista a prezzo maggiorato, diciamo a 70 dollari, titoli che in quel momento
valgono meno, supponiamo 30. Di fatto regala soldi alle banche. Le quali, tra l’altro, fanno
anche resistenza: perché avere il Governo nel capitale, anche se senza diritto di voto nei
Consigli di amministrazione, quindi praticamente senza alcun potere di controllo, non fa
piacere; e perché dopo tutto i titoli che vendono a 70 loro li hanno pagati magari 100 dollari, e
un domani potrebbero anche risalire di prezzo, e se non proprio a 100 forse a 90 arrivano.
Poi il Governo interviene in aiuto di singole istituzioni ritenute, per dimensioni e ruolo,
di rilevanza “sistemica”. In concreto ricordiamo il salvataggio della compagnia di assicurazioni
AIG, che aveva emesso numerosi titoli a copertura del rischio di fallimento di banche e
imprese, e quando banche e imprese cominciano a fallire dovrebbe pagare chi si è assicurato,
ma se tutti falliscono i fondi non le bastano… Il salvataggio di AIG avviene grazie ad un
prestito di 85 miliardi da parte della FED e all’acquisto da parte del Tesoro (ossia da parte del
Governo degli Stati Uniti) della maggioranza delle azioni della compagnia. Vengono anche
salvate Fannie Mae e Freddie Mac, mentre come sappiamo Lehman Brtohers viene lasciata
fallire. Alcune importanti istituzioni finanziarie sono costrette a fondersi, o ad essere
acquistate da altre, o a trasformarsi da banche di investimento in banche commerciali per
approfittare delle maggiori garanzie pubbliche (come Goldman Sachs e Morgan Stanley). A un
certo punto però si ritiene che gli interventi diretti a singole imprese siano inadeguati e si
adottano piani più sistematici. Questi piani sono il Troubled Asset Relief Program (TARP),
finanziato con uno stanziamento iniziale di 700 miliardi di dollari e diretto non tanto alle
banche in particolare quanto alle aziende USA in generale, che prevede sia forti investimenti
in esse (quasi un programma di nazionalizzazioni) sia ingenti aiuti; il Targeted Investment
Program (TIP) progettato per il salvataggio di Citigroup, finanziato con 20 miliardi di dollari di
fondi TARP e diretto all’acquisto di azioni privilegiate; poi il Term Asset-backed Securities Loan
Facility (TALF), realizzato dal Dipartimento del Tesoro assieme alla FED, finanziato con 20
miliardi di dollari che la FED avrebbe dovuto mettere a leva (ossia usare come garanzia) per
ottenere 200 miliardi di dollari di prestiti sul mercato atti a comprare ABS.
Il Governo degli Stati Uniti fronteggia dunque la crisi finanziaria con interventi
massicci. Ma anche la Banca Centrale ha un ruolo cruciale.
VIII.2.2 Le misure non convenzionali della FED
Le politiche seguite dalla Banca Centrale statunitense per confrontarsi con la crisi
finanziaria sono state particolarmente incisive e, soprattutto, innovative rispetto al
tradizionale comportamento seguito dalle banche centrali a partire dalla metà degli anni
ottanta del secolo scorso, che vedevano come prioritaria la lotta all’inflazione e non la difesa
di occupazione e crescita.
Inizialmente le scelte sono abbastanza convenzionali, fondate principalmente
sull’abbassamento del tasso di interesse (Federal Funds Rate) dal 5,25% del luglio 2007 a
quasi zero. A partire dalla fine del 2008 a queste misure si sono accompagnate quelle che sono
note come misure “non convenzionali”.
Prima di vedere in dettaglio cosa ha fatto la FED, può a questo punto essere opportuno
chiarire cosa si intende per misure “convenzionali” e “non convenzionali”.
74
Le misure “convenzionali”, adottate con grande successo dopo la fiammata
inflazionistica degli anni settanta-ottanta del secolo scorso, sono basate essenzialmente sulla
manovra del tasso di interesse a breve termine da parte della Banca Centrale, che lo abbasserà
per contrastare una recessione in atto con un aumento di investimenti privati e quindi di
domanda, e lo alzerà se il problema è invece l’inflazione ed è necessario ridurre gli
investimenti privati al fine di ridurre la domanda e quindi il suo impatto al rialzo sui prezzi (se
la domanda è maggiore dell’offerta i prezzi salgono). Sebbene la Banca Centrale considerasse
nelle sue scelte sia la recessione sia l’inflazione, il conseguimento dell’obiettivo antiinflazionistico faceva sempre premio su quello anti-recessivo, fondamentalmente perché le
recessioni erano sempre piccole e di breve durata. Sino ad allora.
Le misure non convenzionali implicano invece una strategia basata non solo sulla
riduzione dei tassi, anche perché una volta portati allo zero per cento con scarsi risultati lì non
c’è molto di più da fare, ma soprattutto su altri strumenti, con l’obiettivo esplicito di
contrastare una recessione lasciando in secondo piano la lotta all’inflazione. Queste misure
sono numerose, e hanno avuto varie definizioni, ma qui ne possiamo descrivere
principalmente cinque: il Quantitative Easing, ossia l’acquisto a titolo definitivo (o comunque
senza una scadenza prefissata di rivendita) di titoli obbligazionari sul mercato secondario,
acquisto che comporta la contemporanea stampa e messa in circolazione della nuova moneta
necessaria per quell’acquisto e l’accrescimento del bilancio della Banca Centrale perché vi
devono essere inclusi i nuovi titoli comprati; il Qualitative Easing, ossia il cambiamento della
tipologia di titoli che la Banca Centrale acquista (ad esempio il passaggio dall’acquisto di titoli
pubblici all’acquisto di titoli privati, o da titoli pubblici a titoli privati), acquisto che però non
fa cambiare la quantità di moneta in circolazione perché realizzato comprando titoli della
nuova tipologia e vendendo un importo equivalente di titoli della vecchia tipologia; il credit
easing, ossia l’alleggerimento delle condizioni alle quali la banca centrale presta liquidità alle
banche ordinarie e l’incremento di questi prestiti; il cambiamento delle controparti, ossia la
modifica degli intermediari dai quali la banca centrale compra titoli (ad esempio, visto che i
problemi sono nelle società finanziarie e non solo nelle banche, andando a comprare titoli
dalle, e dando così liquidità alle, società finanziarie con le quali usualmente le banche centrali
non trattano); infine, gli effetti-annuncio, ossia reiterati e credibili annunci delle autorità per
orientare il mercato (ad esempio, annuncio che la banca centrale manterrà per due anni
politiche di Quantitative Easing). L’elenco naturalmente non finisce qui, ma quelle indicate
sono le manovre principali.
Nel caso specifico statunitense, la FED ha innanzitutto realizzato politiche di
Quantitative Easing, note come Large Scale Asset Purchase (LSAP) e costituite da più interventi
successivi: il primo Quantitative Easing è iniziato nel 2008 con l’acquisto di 100 miliardi di
dollari di debito di imprese private con supporto governativo (Fannie Mae e Freddie Mac) e
500 miliardi di MBS; è proseguito l’acquisto di 300 miliardi di Titoli di Stato a lungo termine
(mischiandosi quindi col Qualitative Easing, perché in genere le banche centrali acquistano
titoli a breve termine); è stato rinnovato nel quarto trimestre del 2010, con l’acquisto di 600
miliardi di dollari di titoli a lungo termine del Tesoro e titoli garantiti da ipoteca; è stato
radicalmente modificato nel settembre 2012, quando si è passati a un programma di acquisti
di titoli pari a 85 miliardi di titoli al mese; sino a giungere al cosiddetto tapering, ossia la
riduzione progressiva degli acquisti, annunciata nel maggio del 2013 e iniziato nel dicembre
dello stesso anno. Complessivamente, con queste operazioni dal 2008 a oggi la Banca Centrale
Statunitense ha iniettato sul mercato, comprando titoli, qualcosa come 3.900 miliardi di
dollari. A queste misure si è accompagnata la modifica delle controparti, con la Banca Centrale
che si dedica (anche) alla fornitura di liquidità a breve termine alle istituzioni finanziarie non
bancarie, che avevano difficoltà a procurarsi liquidità sul mercato e rischiavano quindi di
divenire insolventi.
75
L’obiettivo di tutti questi interventi è duplice: da un lato impedire l’insolvenza delle
istituzioni finanziarie, garantendo loro una provvista adeguata di liquidità e la possibilità di
liberarsi dei titoli “tossici” presenti nei loro bilanci vendendoli alla Banca Centrale; dall’altro
sommergere le istituzioni finanziarie di liquidità a costo praticamente zero, liquidità che
quelle stesse istituzioni finanziarie presteranno massicciamente e a tassi bassi all’economia
reale sostenendo così l’indebitamento privato e dunque consumi e, soprattutto, investimenti.
Insomma, un programma di intervento sia per salvare la finanza sia per salvare l’economia
reale garantendo investimenti, sostegno della domanda aggregata e crescita.
VIII.3 La politica europea del “rigore”
VIII.3.1 Perché il rigore
Le politiche realizzate in Europa dopo il 2008 sono completamente diverse da quelle
realizzate negli Stati Uniti: mentre queste ultime sono decisamente espansive, le prime sono
invece massicciamente restrittive, fondate appunto sul “rigore” di bilancio, ossia sulla
riduzione della spesa pubblica, sull’incremento delle imposte, sulla riduzione dei salari, sulle
privatizzazioni e sulla liberalizzazione dei mercati, in particolare di quello del lavoro. Prima di
esaminare in dettaglio le diverse politiche europee è forse opportuno domandarsi le ragioni
che sono alla base di questa radicale differenza.
La prima spiegazione addotta per le politiche del rigore è basata sull’idea che causa
della crisi sia il lassismo fiscale, ossia il comportamento irresponsabile di alcuni Paesi che
hanno sostenuto la domanda aggregata ricorrendo in maniera dissennata alla spesa pubblica
finanziata in deficit, portando così il debito pubblico fuori controllo. Se la crisi è stata causata
da un eccesso di spesa pubblica, e quindi di deficit di bilancio pubblico, la soluzione starebbe
nel tagliare la spesa pubblica, aumentare le imposte e ridurre così il deficit. Come dovrebbe
ormai essere chiaro al lettore, questa interpretazione della crisi è decisamente debole: alcuni
paesi Europei (Spagna e Irlanda) avevano infatti conti pubblici in perfetto ordine, con livelli di
indebitamento bassissimi; inoltre, i Paesi con elevato debito pubblico hanno fatto ricorso alla
spesa pubblica espansiva come ultima possibilità residua per sostenere la domanda aggregata
in un contesto di bassa produttività e alti salari, e ridurre la spesa non risolve cero i loro
problemi, anzi; infine, in tutti i Paesi in cui è stata messa in pratica la politica del rigore ha
incrementato il debito pubblico, non lo ha ridotto… Si tratta quindi di una spiegazione o
sbagliata o, più probabilmente, proposta per motivi propagandistici.
La seconda spiegazione è più sofisticata. Secondo alcuni economisti, in particolare
Alberto Alesina e Silvia Ardagna, un taglio dei deficit di bilancio, realizzato preferibilmente
attraverso una riduzione della spesa pubblica, avrebbe un effetto espansivo sia sulla domanda
aggregata sia sulla crescita. Sulla domanda aggregata, perché il maggior rigore di bilancio
convincerebbe i soggetti che in futuro le imposte non aumenteranno e soprattutto che la
finanza pubblica sarà sostenibile, nel senso che il Governo non dichiarerà default, con la
conseguenza che i mercati richiederanno un tasso di interesse più basso per comprare titoli
pubblici, il che potrebbe portare a una riduzione del tasso di interesse per l’intera economia,
incrementando i consumi e gli investimenti privati; sull’offerta aggregata, perché la riduzione
della spesa pubblica ridurrebbe i salari e l’occupazione nel settore pubblico, aumenterebbe la
disoccupazione, renderebbe più difficile trovare un nuovo impiego anche nel settore privato e
quindi convincerebbe i lavoratori, pur di essere assunti, ad accettare salari più bassi,
incrementando così i profitti e la competitività delle imprese e inducendo gli imprenditori ad
investire pesantemente nel Paese. Tutto ciò tra l’altro accadrebbe nel breve periodo, nel senso
che una politica restrittiva provocherebbe solo brevi episodi di contrazione della produzione
e dell’occupazione ma subito dopo rilancerebbe la domanda aggregata, il PIL, l’occupazione e
la crescita. Per quanto più robusto, e considerato una giustificazione teorica valida per le
76
politiche del rigore, anche questo approccio sconta un problema rilevante: le politiche del
rigore applicate ai Paesi europei hanno sostanzialmente sempre causato, almeno nel breve
periodo, una contrazione della domanda aggregata, del PIL, dell’occupazione e della crescita,
oltre a incrementare il debito pubblico ed avvicinare i Paesi al default invece di allontanarli. Se
poi nel lungo periodo funzioneranno, beh… Keynes era solito sostenere che nel lungo periodo
saremo tutti morti, quindi in realtà ci interesserebbe poco.
Coerente con i suggerimenti di Alesina e Ardagna, anche se non teorizzata da loro, è la
pressante richiesta di liberalizzazione del mercato del lavoro sempre presente nelle politiche
del “rigore”. La conseguente/correlata riduzione dei salari che la accompagnerà dovrebbe
infatti da un lato far scendere i costi per le imprese e far recuperare loro competitività
internazionale, incrementando le esportazioni, dall’altro incentivare gli imprenditori,
nazionali ma soprattutto stranieri a investire nel Paese, sostenendo in questo modo sia la
domanda aggregata sia la crescita. Per ottenere questi risultati la liberalizzazione del mercato
del lavoro e la riduzione drastica dei salari è fondamentale, e può essere ottenuta in due modi:
o con un accordo, con i sindacati che spontaneamente accettano la riforma; o con una
profonda recessione che genera disoccupazione di lunga durata e, dopo un lasso di tempo di
lunghezza variabile, fiacca la resistenza di lavoratori e sindacati costringendoli ad accettare
condizioni lavorative molto meno tutelate. La prima strada è meno dolorosa, la seconda più
dolorosa. Ma la seconda potrebbe essere anche quella politicamente più facile da percorrere,
nonostante gli elevatissimi costi sociali che implica. D’altro canto, un effetto collaterale del
taglio della spesa pubblica e dell’incremento delle imposte richiesti dalle politiche del rigore è
proprio la generazione di una profonda recessione. Come si vede, tutto si lega, all’interno di
una complessa strategia che ha un suo senso e un suo scopo, ma che causa tanto inutile dolore
sociale. E, soprattutto, che non è affatto detto abbia successo. Quindi si potrebbe trattare di
dolore inutile. Ma su questo torneremo.
È ora opportuno esaminare l’articolazione concreta della politica del rigore,
descrivendo prima gli interventi delle istituzioni europee e dei Governi dei diversi Paesi, poi
quelli della Banca Centrale Europea.
VIII.4 Le politiche delle istituzioni europee
VIII.4.1 Il Fiscal Compact
La strategia del rigore implementata dalle istituzioni europee ha senza alcun dubbio
come elemento culminante il cosiddetto Fiscal Compact, al quale però si giunge dopo una serie
di passaggi intermedi rappresentati dal Six Pack, dal Two Pack e dal Patto Euro Plus. Il Six
Pack, che prende il nome dal numero di atti legislativi che lo compongono (cinque regolamenti
e una direttiva, alcuni validi solo per i Paesi dell’eurozona, altri per tutti i paesi dell’Unione
Europea, ossia anche per i Paesi europei che non adottano l’euro come moneta, ad esempio la
Gran Bretagna e la Danimarca), approvato dal Parlamento Europeo nell’ottobre del 2011 ed
entrato in vigore il 12 dicembre 2011, ha l’obiettivo di modificare il patto di Stabilità e
Crescita introducendo vincoli più rigidi al deficit di bilancio e al debito pubblico, nonché un
sistema sanzionatorio più stringente e quasi automatico. Il Two Pack, entrato in vigore nel
maggio del 2013, che prende anch’esso il nome dal numero di atti legislativi che lo
compongono, ha integrato il Six Pack con due proposte di regolamento, l’una destinata a
creare una procedura di vigilanza rafforzata per i Paesi che sembrano presentare
caratteristiche di rischiosità di bilancio, l’altra finalizzata a richiedere un maggior
coordinamento e monitoraggio dei programmi di bilancio a medio termine dei singoli Paesi,
anche creando un ente apposito destinato al controllo dei bilanci. Infine, il Patto Euro Plus,
concluso nel marzo del 2011, mira a rafforzare il coordinamento delle politiche economiche
77
dei diversi Paesi e, soprattutto, a dettare linee guida per incentivarne produttività e
competitività.
Tutti questi atti intermedi conducono al Fiscal Compact, o Trattato sulla stabilità,
coordinamento e governance nell'unione economica e monetaria, entrato in vigore il primo
gennaio del 2013 e sottoscritto subito da quasi tutti i Paesi che fanno parte dell’Unione
Europea (quindi non dai soli paesi dell’Eurozona). Oltre all’obbligo di introdurre le nuove
regole nella legislazione nazionale, preferibilmente a livello di costituzione, e di continuare a
rispettare il vecchio Patto di Stabilità, che imponeva un rapporto deficit/PIL massimo pari al
3%, il Fiscal Compact prevede principalmente due interventi a carico dei singoli Paesi: il
raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale e la riduzione del debito pubblico. Poiché,
però, anche il pareggio di bilancio strutturale è funzionale al contenimento del debito,
quest’ultimo è sostanzialmente l’obiettivo prioritario del Fiscal Compact.
Per quanto riguarda il pareggio di bilancio strutturale, vengono considerati in regola i
Paesi che presentano un rapporto massimo deficit/PIL strutturale pari allo 0,5% (1% per i
Paesi con un rapporto debito pubblico/PIL inferiore al 60%). È evidente che se il rapporto
deficit/PIL è pari allo 0,5% (o all’1%) il bilancio dello Stato non è propriamente in pareggio,
anzi rimane in deficit, e il debito pubblico continua a crescere, perché per coprire il deficit i
Paesi devono indebitarsi. L’idea però non è diminuire il debito in assoluto, ma rispetto al PIL,
ossia ridurre il rapporto debito pubblico/PIL: a questo fine, se il debito sale di poco (come
accade se il deficit è solo allo 0,5% del PIL), è sufficiente un aumento modesto del PIL per
ridurre il rapporto. Quando il Paese è in recessione la regola diventa meno stringente e un
incremento del deficit è tollerato: in gergo tecnico si dice che lo 0,5% (o l’1%) va calcolato sul
PIL strutturale, ossia quello che si avrebbe se il sistema fosse in piena occupazione.
Poi c’è la regola sul debito: ogni Paese deve ridurre il proprio debito pubblico di un
ventesimo della differenza tra il suo rapporto debito pubblico/PIL effettivo e un rapporto
debito pubblico/PIL pari al 60%. Ad esempio se l’Italia ha un rapporto debito pubblico/PIL
del, diciamo, 140%, nel primo anno dovrebbe ridurlo di un ventesimo dell’80% (la differenza
tra il nostro rapporto debito pubblico/PIL e un rapporto del 60% è appunto l’80%: 140%60%=80%), ossia del 4%; il secondo anno il rapporto debito pubblico/PIL sarà diventato pari
al 136%, la differenza sarà il 76% (136%-60%=76%) e la riduzione sarà di un ventesimo del
76%, ossia del 3,8%; e così via.
L’enfasi è dunque sul debito, che deve ridursi (almeno rispetto al PIL). E per ridurre il
debito si deve ridurre il deficit. E per ridurre il deficit la strategia suggerita è ridurre la spesa
pubblica e/o aumentare le imposte, facendo crollare la domanda aggregata e peggiorando così
la recessione.
VIII.4.2 I fondi “Salva Stati” e il salvataggio dei PIGS
Per i Paesi in seria difficoltà, soprattutto quelli che non riescono a finanziarsi a tassi
ragionevoli sul mercato, è previsto un programma di assistenza finanziaria specifica. Nel 2010
i Paesi dell’Eurozona hanno infatti istituito un fondo temporaneo, l’EFSF (European Financial
Stability Facility), finanziato dai singoli Paesi, che aveva il compito di fornire capitali di
emergenza ai Governi in difficoltà. Inoltre, l’Unione Europea ha istituito, sempre nel 2010, un
altro fondo, con meno dotazione finanziaria, l’EFSM (European Financial Stabilisation
Mechanism). I due fondi sono stati sostituiti, l’8 ottobre del 2012, da un fondo permanente,
l’ESM (European Stability Mechanism), il cui utilizzo è unicamente riservato ai Paesi che
abbiano sottoscritto il Fiscal Compact. La funzione di questi fondi è quella di sostituirsi al
mercato: se un Paese incontra difficoltà a finanziarsi emettendo titoli del debito pubblico, nel
senso che il tasso di interesse che i mercati gli richiedono è eccessivamente elevato (diciamo,
a puro titolo di esempio, il 15%), tanto da mettere a rischio la sostenibilità del suo bilancio,
può richiedere prestiti ai Fondi salva-Stati. I Fondi emettono titoli propri, che nel caso
78
dell’ESM sono garantiti da un capitale pari a 700 miliardi di euro, dei quali 80 miliardi
effettivamente versati dai diversi Paesi. Questo permetterà all’ESM di emettere un massimo di
500 miliardi di euro (il resto rimane come garanzia) di titoli sicuri e capaci di essere collocati
sul mercato a tassi bassi (diciamo, a puro titolo di esempio, il 2%). Il denaro incassato
vendendo questi titoli verrà poi girato al Paese in difficoltà, direttamente come prestito, come
prestito destinato a rifinanziare le istituzioni finanziarie in difficoltà, o comprando sul
mercato secondario o in casi eccezionali anche primario, titoli del debito pubblico di quel
Paese. I tassi che il Paese dovrà pagare all’ESM (diciamo, sempre a puro titolo di esempio, il
4%) sono inferiori rispetto a quelli che il Paese avrebbe pagato finanziandosi sul mercato, ma
superiori a quelli che deve pagare l’ESM per finanziarsi. In questo modo il Paese può
intraprendere le misure necessarie per ristrutturare la sua economia senza rischiare
l’insolvenza a causa dei tassi di interesse troppo elevati che fronteggia, e i Fondi ne ricavano
anche un margine di guadagno. È importante rilevare come i prestiti concessi dall’ESM siano
senior, vadano cioè ripagati prima di ogni altro prestito ottenuto dal Paese in difficoltà,
similmente ai prestiti concessi dal Fondo Monetario Internazionale (che però devono a loro
volta essere rimborsati prima di quelli concessi dall’ESM).
La concessione di finanziamenti da parte dell’ESM è condizionata alla sottoscrizione, da
parte dei Paesi che chiedono assistenza, di un impegno (memorandum) a mettere in atto una
serie di interventi di Politica economica. Questi interventi sono tutti coerenti con l’idea che la
crisi sia la conseguenza di un eccessivo lassismo fiscale. Le politiche richieste prevedono
dunque un taglio drastico della spesa pubblica, la riduzione del troppo generoso welfare,
vendita di imprese e patrimonio dello Stato - ossia privatizzazioni -, incrementi delle entrate
fiscali, liberalizzazioni dei mercati, ecc. La maggior parte di questi interventi, è appena il caso
di notarlo, hanno come conseguenza di breve periodo un peggioramento della recessione e un
aumento della disoccupazione.
I fondi salva-Stati sono sinora intervenuti per dare assistenza a Grecia (a partire dal
secondo piano di salvataggio), Irlanda, Portogallo, Spagna e Cipro.
VIII.4.3 Il rigore all'opera: Grecia, Irlanda, Spagna, Portogallo
Come abbiamo visto, gli aiuti concessi alla Grecia nel maggio del 2010 sono stati
concessi con prestiti bilaterali dei Paesi Europei e del Fondo Monetario Internazionale, quindi
il primo Paese a ottenere assistenza finanziaria dai fondi Salva-Stati è stata la tigre celtica,
l’Irlanda, tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011: per il salvataggio irlandese intervengono
infatti EFSF, EFSM, e Fondo Monetario Internazionale. L’Irlanda firma il Memorandum of
Understanding, ossia un accordo col quale si impegna ad attuare rigide politiche restrittive:
ridurre la spesa pubblica, aumentare le imposte, ridurre i salari dei dipendenti pubblici,
liberalizzare il mercato del lavoro, ridurre i salari minimi… ottenendo in cambio un prestito di
circa 70 miliardi di euro, che possono apparire pochi in assoluto ma costituiscono oltre il 30%
del PIL Irlandese. Il debito pubblico del Paese, a questo punto, va evidentemente alle stelle,
superando il 100% del PIL nel 2011 e il 120% nel 2013. I tagli al welfare e la contrazione dei
salari in Irlanda sono massicci, ma il Paese sembra trarre un qualche blando giovamento dalla
politica del rigore: infatti, a dicembre 2013 l’Irlanda esce dal piano di aiuti e da allora il Paese
torna a vedere una pur modesta crescita.
Ma perché in Irlanda il rigore ha in qualche misura funzionato? La risposta risiede nella
particolare crescita irlandese prima della bolla, basata sull’attrarre gli Investimenti Diretti
Esteri in maniera massiccia, sfruttando un mercato del lavoro flessibile, l’appartenenza
all’eurozona, la lingua inglese parlata dai suoi abitanti, e soprattutto, livelli di imposizione
fiscale bassissimi. Bene, la strategia non cambia dopo la crisi, e gli strumenti neppure:
l’Irlanda combatte infatti strenuamente e con successo con le autorità europee per ottenere di
poter mantenere le agevolazioni fiscali alle multinazionali. La strategia per crescere è dunque
79
la stessa che ha portato alla bolla, anche se più prudente, figlia dell’essersi resi conto che una
politica come quella precedente poteva essere replicata solo evitando di commettere i due
errori che erano stati all’origine della crisi: lasciar crescere eccessivamente e senza controllo
banche troppo grandi per essere salvate, e intervenire con fondi pubblici per salvare quelle
stesse banche, trasformando così il debito privato in debito pubblico. Per evitare il primo
errore servono più controlli, ma la crescita che ne risulta sarà più contenuta; per evitare il
secondo errore, invece, serve una modifica della strategia europea, che sarà realizzata dopo la
crisi cipriota col passaggio dal bail-out al bail-in.
Molto meno efficaci le politiche attuate in Portogallo, che nella primavera del 2011
chiede anch’esso assistenza finanziaria ai Fondi Salva Stati, ottenendo un prestito di 79
miliardi di euro. Le usuali manovre restrittive richieste col Memorandum of Understanding
provocano una lunghissima recessione, della durata di almeno trenta mesi, e le finanze
pubbliche del Paese restano comunque tuttora ad altissimo rischio. D’altro canto, con i prestiti
si tampona la situazione, ma tagliando la spesa pubblica si impediscono gli investimenti in
infrastrutture, tecnologia e formazione, unica strada per risolvere realmente i problemi di
produttività che affliggono le (poche) imprese esportatrici portoghesi: ridurre un po’ i salari
non basta certo. Ciò nonostante, nel maggio del 2014 il Paese è ufficialmente uscito dal piano
di assistenza finanziaria, anche se non esiste alcuna garanzia che non debba tornarci in tempi
brevi. Anzi.
Le cose non vanno meglio per la Grecia. Non molto sorprendentemente le politiche
restrittive imposte al Paese col “salvataggio” del maggio 2010 riducono la domanda aggregata
e quindi tanto il reddito del Paese quanto le entrate fiscali, incrementando invece di ridurli il
deficit di bilancio e il debito pubblico. Mentre, come per il Portogallo, non viene realmente
risolto nessuno dei problemi strutturali di un Paese che ha perso anche le poche imprese
esportatrici che aveva, e anzi i tagli di spesa pubblica quei problemi li acuiscono. Così nel
marzo del 2012 si rende necessario un secondo programma di aiuti, pari a circa 130 miliardi,
finanziati dal Fondo Monetario Internazionale e, soprattutto, dall’EFSF. Questo secondo
salvataggio è importante soprattutto perché alla Grecia viene permesso di operare una
pesante ristrutturazione del proprio debito pubblico: chi possedeva titoli di Stato greci deve
cederli ottenendone in cambio altri (in parte greci, in parte dell’EFSF) che valgono, includendo
le minori cedole, circa il 70% in meno, con una perdita complessiva attorno ai 100 miliardi di
euro. Solo alcune categorie di titoli sono esentati da questa conversione, ad esempio quelli
comprati da ECB nell’ambito dei suoi diversi programmi di intervento. Poiché qualsiasi
modifica dell’importo restituito o delle scadenze di un titolo costituiscono default, siamo in
presenza del più grande fallimento sovrano (ossia di uno Stato) della storia! La Grecia cancella
infatti circa la metà del suo debito pubblico. È da rilevare che, poiché la maggior parte dei
titoli Greci sono posseduti da banche greche, l’EFSF deve anche intervenire per ricapitalizzare
queste ultime, che altrimenti andrebbero incontro a insolvenza certa: a questo è infatti
destinata una buona parte dei 130 miliardi dei nuovi prestiti concessi alla Grecia.
Nonostante il default, il problema del debito, così come il problema della bassa
domanda e della bassa crescita, non si risolve neppure stavolta, anzi. Nell’accettare l’aiuto
europeo la Grecia deve infatti sottoscrivere l’usuale memorandum of understanding colmo di
politiche restrittive. E anche stavolta gli effetti sono una riduzione del PIL, un aumento della
disoccupazione, un incremento del deficit di bilancio e del debito pubblico (d’altro canto, se ti
cancello debiti per 100 miliardi e poi ti presto altri 130 miliardi il tuo debito aumenta, mica si
riduce…).
Infine, la Spagna. Quando la bolla scoppia il Paese non sembra rendersi subito conto di
dove siano i problemi (ossia nelle banche), e per un po’ tenta di porvi rimedio con politiche di
sostegno alla domanda aggregata, puntando sulla spesa pubblica nel settore dell’edilizia. Poi
la crisi bancaria emerge con prepotenza, e tra il novembre e il dicembre del 2012 il Paese è
80
costretto a chiedere un prestito all’appena costituito ESM per ricapitalizzare le proprie banche
senza affrontare i tassi proibitivi che le avrebbe richiesto il mercato. L’ESM autorizza 100
miliardi di euro di finanziamento, ma la Spagna ne richiederà effettivamente solo 41 per le sue
quattro principali banche: BFA/Bankia, Catalunya Banc, Ncg Banco e Banco di Valencia.
Il piano di sostegno finanziario, naturalmente, viene accompagnato dalle usuali
richieste di rigore di bilancio e liberalizzazioni, che la Spagna però rispetta solo in parte. In
particolare, a fronte di una feroce liberalizzazione del mercato del lavoro, con conseguenti
licenziamenti massicci e tagli salariali altrettanto massicci, e pur in presenza di ingentissimi
impegni di riduzione della spesa pubblica soprattutto nel campo del welfare, il Paese ha
mantenuto un deficit di bilancio al di sopra del 3% del PIL per parecchi anni. Così, non
possiamo sapere se la timida ripresa iniziata nel 2014 va attribuita al sostegno alla domanda
aggregata ottenuto con il deficit di bilancio o alla liberalizzazione dei mercati che ha attirato
nuovi investitori stranieri che, attratti dal basso costo del lavoro hanno delocalizzato le loro
produzioni nel Paese, o al combinato disposto delle due cause.
Insomma, le politiche del rigore nei confronti dei quattro Paesi che hanno chiesto
assistenza finanziaria ai Fondi Salva Stati fino al 2013 sono andate incontro o a un tuttora
perdurante insuccesso, come nel caso di Grecia e Portogallo, o a un modestissimo successo,
come nel caso dell’Irlanda e, con molta maggiore prudenza, fors’anche della Spagna. Senza
nessuna garanzia che la timidissima ripresa che sembra interessare gli ultimi due Paesi sia più
che effimera e, soprattutto, con costi sociali ed economici (in termini di distruzione di capacità
produttiva) elevatissimi.
VIII.4.4 Dal bail-in al bail-out: il caso Cipro
Un salvataggio particolare operato dai Fondi Salva Stati è stato quello di Cipro, che ha
rappresentato il punto di svolta nella strategia europea in tema di salvataggi bancari, con il
passaggio dal bail-out al bail-in al fine di spezzare il meccanismo noto come doom-loop. Il
doom loop esprime una circolarità, un’interdipendenza, un effetto di ritorno: come sappiamo,
l’eccesso di debito privato e i fallimenti bancari che lo accompagnano costringono a bail-out, a
salvataggi da parte dei Governi, che accrescono il debito pubblico; ma se cresce troppo il
debito pubblico i mercati cominciano a temere che i Governi non siano in grado di ripagarlo, e
cercano di liberarsi dei titoli di Stato in loro possesso, vendendoli a prezzi stracciati; ma le
banche hanno in portafoglio anche titoli di Stato, contabilizzati ai prezzi di mercato, e la
riduzione del loro prezzo implica ingenti perdite (ho comprato titoli per 10 miliardi, ora
valgono 7, ho perso 3 miliardi); tutto ciò può portare le banche all’insolvenza, rendendo
necessari nuovi bail-out pubblici; e così via.
Ma torniamo a Cipro. La parte greca di questa isola era diventata, nel corso degli anni
novanta, un centro finanziario estremamente sviluppato piazzato al centro del Mediterraneo
e, grazie alle pressioni della Grecia, nel 2007 aveva anche ottenuto l’ingresso nell’eurozona,
adottando dunque l’euro. Anche in questo caso una cattiva supervisione del sistema bancario
aveva fatto crescere eccessivamente il settore creditizio, attirando ingenti flussi di capitali
stranieri, principalmente russi e britannici, ma dopo il 2010 anche i depositi dei correntisti
greci in fuga dalle banche del loro Paese. Le banche cipriote, di fronte a questi ingenti flussi
finanziari, hanno iniziato a volersi espandere e ad attirare nuovi capitali, ma per farlo
dovevano offrire tassi di rendimento sui depositi sempre più elevati; e tassi di rendimento sui
depositi sempre più elevati si potevano offrire solo impiegando il denaro ricevuto in deposito
in investimenti finanziari sempre più rischiosi. Per antica fratellanza, similitudine di interessi
e alti rendimenti che si potevano ottenere, le banche cipriote hanno avuto tra le tante cattive
idee di investimento finanziario per il loro denaro anche un’idea assolutamente pessima: non
solo speculare sul mercato immobiliare, ma soprattutto acquistare massicciamente titoli di
stato Greci. Così, quando la Grecia ha fatto default le banche cipriote si sono trovate in cassa
81
titoli che avevano acquistato diciamo a 100, impiegando i 100 ricevuti in deposito dai loro
correntisti, e che ora, dopo il default, valgono diciamo 30, perdendo dunque 70. A quel punto,
per coprire la perdita di 70 e restituire così i 100 ai correntisti avrebbero dovuto utilizzare il
loro capitale. Ma il loro capitale era insufficiente (diciamo 20? In realtà, meno). Le banche
cipriote quindi dichiarano insolvenza.
Siamo nella primavera del 2013. Inizialmente l’idea del Governo di Cipro è lasciar
fallire le banche (private) insolventi, e tanti saluti. Poi ci si rende conto che: 1) anche i
correntisti ciprioti avrebbero perso il denaro depositato in banca; 2) Cipro sosteneva quasi
esclusivamente la sua economia grazie al settore finanziario, la scomparsa del quale avrebbe
fatto ripiombare il Paese nella povertà. Quindi, il Governo decide di nazionalizzare le banche.
Ma per farlo, vista l’enorme dimensione delle perdite bancarie, avrebbe dovuto farsi prestare
un ammontare di denaro pari all’intero PIL di Cipro, portando però il debito pubblico oltre il
150% del PIL: un livello che i mercati avrebbero considerato insostenibile e che avrebbero
finanziato solo facendo pagare al Paese tassi di interesse tanto alti da portarlo rapidamente al
default. Né il problema si sarebbe potuto risolvere chiedendo un prestito all’ESM, perché un
prestito, anche se concesso dall’ESM, è comunque debito e avrebbe aumentato il debito
pubblico di un pari ammontare.
Dopo vari tentennamenti si decise di adottare, per la prima volta nell’Eurozona, la
strategia del bail-in: chi avrebbe pagato per il fallimento delle banche, perdendo
definitivamente il proprio denaro, sarebbero stati, nell’ordine, gli azionisti delle banche (che
perdevano tutto), gli obbligazionisti delle banche, anche quelli garantiti (che perdevano tutto),
i correntisti (che perdevano una parte, attorno al 30%, dei loro depositi eccedenti i 100.000
euro, in cambio di azioni delle banche). Si salvavano invece i depositanti sotto i 100.000 euro,
perché questo è il limite al di sotto del quale i depositi sono garantiti dall’assicurazione dei
Governi nell’eurozona. Poiché il denaro ottenuto in questo modo non bastava, Cipro ottiene
anche un prestito dall’ESM (e, per un decimo dell’importo, dal FMI) pari a circa 10 miliardi di
euro (pochi soldi in generale, ma più della metà del PIL della piccola Cipro), e le viene imposto
di adottare le usuali misure di contenimento della spesa.
Da quel momento in poi è diventato chiaro a tutti che depositare denaro in banca,
soprattutto in conti correnti eccedenti i 100.000 euro, equivaleva a prestarlo alle banche, e
dunque correre dei rischi che rendevano necessaria una attenta scelta della banca nella quale
accendere un conto corrente. Ed è diventato altrettanto chiaro che rendimenti più alti sui
conti correnti si potevano ottenere solo accettando una maggiore rischiosità.
Nel frattempo, ossia mentre le operazioni di salvataggio erano in corso, le banche
cipriote sono state chiuse, per evitare che i correntisti ritirassero i loro depositi prima di
essere “tosati”, con un limite giornaliero di 100 euro per i prelievi dai bancomat, blocco (in
gran parte tuttora in vigore) della circolazione dei capitali da e per l’isola, impossibilità per chi
emigra di portare con sé denaro, supermercati e negozi che hanno smesso di accettar
pagamenti con assegni o carte di credito. E, per finire, una drammatica recessione accentuata
dalle politiche restrittive messe in atto per ottenere il prestito dell’ESM.
Sebbene si affermò allora che “Cipro è unica”, da quel momento nell’Eurozona si
passerà a politiche di salvataggio delle banche basate sul bail-in e non più sul bail out.
VIII.5 Le politiche della Banca Centrale Europea
VIII.5.1 Le politiche per curare: gli interventi di ECB
Mentre le istituzioni europee e i singoli Governi dell’Eurozona hanno più o meno
volontariamente (e più o meno rapidamente) abbracciato le politiche del rigore, la Banca
Centrale Europea si è mossa, soprattutto sotto la gestione Draghi, in maniera non del tutto
82
allineata. In sostanza, pur condividendo nelle dichiarazioni ufficiali la filosofia del rigore, ECB
ha operato con grande autonomia e tempestività, forzando spesso la lettera del suo Statuto
rigorista con manovre espansive di consistente ammontare. L’idea di base era far guadagnare
tempo ai governi affinché si accordassero su decisioni finalmente risolutive, ma il risultato
finale è stato spesso il sostituirsi alle (assenti, tardive o errate) manovre delle istituzioni
europee. La ECB ha sinora messo in atto numerosi interventi, tra i quali i più importanti sono
probabilmente stati: la politica dei tassi, il passaggio ad aste a tasso fisso con piena
aggiudicazione degli importi, il Securities Markets Programme (SMP), le Long Term Refinancing
Operations (LTRO), le mai realizzate ma ugualmente fondamentali Outright Monetary
Transactions (OMT), le Targeted Long Term Refinancing Operations (LTRO), il programma di
acquisto di Asset Backed Securities e il Quantitative Easing.
Il primo intervento realizzato dalla Banca Centrale Europea per contrastare la crisi è
stata la riduzione dei tassi di interesse. Fino a pochi anni fa (meglio: fino alla crisi…) si
riteneva che la manovra dei tassi di interesse fosse il più importante strumento di intervento
a disposizione delle banche centrali. Nel caso specifico della Banca Centrale Europea, i tassi di
interesse controllati sono tre: quello sui depositi, ossia il tasso di interesse che la Banca
Centrale paga alle banche ordinarie che depositano denaro presso di lei (per le banche
ordinarie l’alternativa, costosa e rischiosa, al deposito presso ECB di ciò che non prestano ai
clienti è tenere il denaro in contanti in cassaforte…); quello sui prestiti, ossia il tasso di
interesse che le banche ordinarie pagano alla Banca Centrale quando richiedono un prestito a
brevissima scadenza a ECB dimostrando di avere titoli (principalmente di Stato) che possono
usare come collaterale, ossia come garanzia; e infine il tasso di interesse sulle operazioni di
rifinanziamento principale, note anche come operazioni di mercato aperto, ossia il tasso di
interesse che le banche ordinarie pagano quando ottengono denaro da ECB cedendole titoli
dei quali rientreranno in possesso dopo 15 giorni, quando obbligatoriamente restituiranno il
denaro (a differenza del tasso sui prestiti, in questo caso i titoli, anche se solo per 15 giorni,
cambiano proprietario). Se i tassi si riducono le banche ordinarie sono incentivate a
depositare meno denaro presso ECB e soprattutto a prenderne a prestito una quantità
maggiore dalla Banca Centrale, perché sanno che per loro sarà più facile prestare al pubblico
una quantità maggiore di denaro se lo possono fare a un tasso inferiore. E se i tassi di
interesse che le banche praticano al pubblico si riducono, gli imprenditori vorranno prendere
a prestito una quantità maggiore di denaro per realizzare gli investimenti, e dunque gli
investimenti aumenteranno e così sia la domanda aggregata sia la crescita saranno stimolate.
Nel caso specifico, però, all’inizio della crisi ECB non si rese affatto conto di cosa stava
accadendo, e addirittura alzò, nell’aprile e nel luglio del 2011, i tassi… poi, fortunatamente, si
rese conto dell’errore, abbassando drasticamente i tre tassi di riferimento e portando
addirittura quello sui depositi in negativo, in modo da rendere costoso per le banche ordinarie
tenere denaro presso ECB (in sostanza: o prestate i soldi, o pagate!). L’effetto non è stato
risolutivo, sia perché le banche hanno preferito tenere denaro presso di loro per ogni
evenienza anziché prestarlo, sia perché le imprese, nonostante i tassi bassi, non avevano
alcuna intenzione di fare investimenti: perché aumentare la capacità produttiva se non penso
che la domanda aumenterà? Le uniche imprese che richiedevano prestiti alle banche erano
quelle che stavano per fallire, e a loro le banche non avevano alcuna intenzione di prestare
denaro!
Se la politica di abbassare i tassi durante una recessione è nel complesso
convenzionale, il passaggio alle aste a tasso fisso con piena aggiudicazione degli importi inizia
invece a configurarsi come il riconoscimento dell’insufficienza degli strumenti tradizionali e la
sperimentazione di strumenti nuovi. In particolare, di fronte alla difficoltà delle banche di
ottenere prestiti da altre banche, e dunque di fronte alla loro illiquidità, la Banca Centrale si
sostituisce al mercato interbancario, ossia al mercato dei prestiti tra banche, nel prestare
83
denaro. Lo fa modificando i criteri con i quali effettua le operazioni di mercato aperto. Infatti,
fino a ottobre 2008 queste erano vere e proprie aste, ossia la Banca Centrale portava sul
mercato un certo ammontare di liquidità, diciamo 100 milioni, fissava un tasso di partenza,
diciamo il 2%, e dava inizio all’asta: chi offre di più? Una banca offre il 2,1%, una il 2,2%, una il
2,5%... aggiudicato al 2,5%! Chi vince l’asta si aggiudica l’intero importo (o un importo
inferiore, se ha bisogno di meno liquidità), cede 100 milioni in titoli a ECB e ottiene in cambio
100 milioni, che dovrà restituire, maggiorati dell’interesse, dopo 15 giorni, quando riavrà
indietro i titoli. Dopo l’ottobre del 2008, poiché le banche non riescono più a farsi prestare
denaro dalle altre banche, ECB si sostituisce al mercato interbancario e le aste cambiano
radicalmente, tanto da non poter più essere assimilate ad aste se non per convenzione:
stavolta ECB fissa un tasso, diciamo sempre il 2%, e a quel tasso fornisce tutta la liquidità di
cui le banche hanno bisogno, a tutte le banche che la richiedono, senza limiti (naturalmente, le
banche devono possedere e cedere per 15 giorni a ECB un uguale controvalore in titoli). Il
cambiamento delle aste è dunque una strategia per (provare ad) ovviare al blocco del mercato
interbancario e alla carenza di liquidità delle banche ordinarie.
Ma la crisi europea non è solo, come la crisi statunitense, una crisi bancaria. È infatti
anche una crisi di alcuni degli Stati che compongono l’Eurozona, con elevati debiti pubblici la
cui gestione è problematica, perché i mercati richiedono tassi di interesse sempre più alti per
finanziarli. Per calmierare questi tassi ECB interviene con il Securities Markets Programme
(SMP). L’SMP è (è stato) un programma di acquisto di titoli pubblici dei Paesi in difficoltà
iniziato nel maggio del 2010 e terminato poco più di un anno dopo, soprattutto a causa delle
resistenze di alcuni Paesi, Germania in testa. Prima di descrivere il programma, è importante
premettere che lo Statuto della Banca Centrale Europea le impedisce di acquistare titoli dai
Paesi membri dell’eurozona, ossia di prestare denaro direttamente ai Governi comprando
titoli del debito pubblico sul mercato primario (quel mercato nel quale chi vende titoli è
l’emittente). L’unica cosa che può fare è comprare titoli sul mercato secondario (ossia quel
mercato sul quale chi vende titoli non è l’emittente, ma chi ha comprato quel titolo
dall’emittente - o chi ha comprato da chi ha comprato dall’emittente…): l’idea è che se presto
ai Governi questi potrebbero prenderci gusto, e iniziare a finanziare spese folli, “tanto poi ci
pensa la ECB…”, facendo aumentare enormemente la domanda e quindi i prezzi dei beni, con
esiti inflazionistici.
Con l’SMP la ECB ha comprato sul secondario e, soprattutto, ha sterilizzato l’intervento,
ossia da un lato ha comprato titoli dei Paesi in difficoltà e messo in circolazione moneta
(quando compra titoli cede infatti moneta in cambio), dall’altro ha venduto titoli, che aveva
comprato precedentemente, degli altri Paesi, e quindi ritirato moneta (quando vende titoli
ottiene in cambio moneta). Con gli interventi sterilizzati la quantità di moneta resta invariata
e non ci sono rischi inflazionistici.
L’obiettivo dell’SMP era quello di ridurre i tassi di interesse pagati dai Paesi periferici e
lo spread, la differenza di tasso di interesse pagato dai titoli di diversi Paesi. Infatti le banche
saranno più tranquille nell’acquistare titoli dei Paesi in difficoltà sul primario se sono certe
che potranno subito dopo, in caso di problemi, venderli alla ECB sul secondario. E se sono più
tranquille, non richiederanno un tasso di interesse particolarmente elevato per acquistarli. E
dunque si ridurranno interessi e spread. L’SMP è però rimasto limitato all’acquisto di titoli a
breve scadenza (ad esempio BOT a sei mesi, o a un anno), non è stato massiccio quanto
sarebbe stato necessario che fosse e ha riempito le casse di ECB di titoli di cattiva qualità. Sia
per questo motivo, sia perché si pensava che l’abbassamento dei tassi pagati avrebbe potuto
portare alcuni Paesi in difficoltà a finanziare con troppa facilità spese pubbliche eccessive, alla
fine le rimostranze tedesche hanno portato alla chiusura del programma.
Se l’SMP era diretto al sostegno dei Governi in difficoltà, le le Long Term Refinancing
Operations (LTRO), o Operazioni di Rifinanziamento a Lungo Termine, hanno invece obiettivi
84
misti, sia di contenimento dei tassi di interesse pagati dai Governi, sia di aiuto alle banche in
difficoltà, sia di sostegno all’economia reale con l’incremento della concessione di prestiti agli
imprenditori. ECB ha effettuato due LTRO, una a dicembre 2011 e l’altra a febbraio 2012. Si
tratta di operazioni di prestito a tre anni, al tasso di interesse dell’1%, destinate alle banche
ordinarie. Gli istituti di credito che accedono a questi prestiti devono fornire titoli in garanzia
come collaterale (nel senso che, se non restituiscono il prestito, la ECB diventa proprietaria di
questi titoli), e la ECB ha scelto di accettare con questo ruolo anche titoli di cattiva qualità.
L’idea è che, se le banche hanno parecchia liquidità in cassa, corrono meno rischi di fallire;
inoltre, avendo ottenuto questa liquidità a un tasso dell’1%, avranno convenienza a finanziare
le imprese, che pagano tassi di interesse molto superiori all’1%, rilanciando così gli
investimenti, la domanda aggregata e la crescita. E se proprio va male, e non prestano agli
imprenditori, perché hanno paura che questi ultimi possano fallire, almeno potranno
acquistare titoli dei Paesi in difficoltà, che rendono ben più dell’1%.
L’LTRO è stato un intervento importante, poiché la ECB ha messo in circolazione circa
1.000 miliardi di euro, e non è stato subito sterilizzato; ma essendo un prestito a tre anni, nel
senso che dopo tre anni la moneta messa in circolazione rientra in ECB, i rischi inflazionistici
sono comunque molto contenuti.
Se l’LTRO ha avuto successo nel sostenere le banche, e anche nell’indurre le banche
stesse a prestare ai Governi, molto meno successo ha avuto nel finanziare le imprese che,
come abbiamo visto prima, non avevano in generale alcuna intenzione di fare investimenti e
richiedevano denaro solo quando stavano per fallire: e alle imprese che stanno per fallire le
banche non prestano, a qualunque tasso di interesse. Il credit crunch di cui soffre l’Europa
non è stato dunque intaccato da queste operazioni.
Nell’estate del 2012, di fronte all’aggravarsi della crisi, la ECB mette in campo uno
strumento nel complesso non particolarmente utile, che non verrà mai usato e che sarà
osteggiato da molti Paesi, ma i cui “effetti collaterali” salveranno l’euro. Si tratta delle Outright
Monetary Transactions (OMT), Operazioni Definitive Monetarie in italiano, note anche come
“Scudo anti-spread”, un nuovo piano di acquisto sul secondario di titoli di Stato. L’acquisto è
limitato ai titoli di scadenza compresa tra uno e tre anni e, come per l’SMP, è sterilizzato
vendendo altri titoli in portafoglio di ECB; a differenza dell’SMP, però, l’acquisto è illimitato e
deve essere esplicitamente richiesto dal Paese. Per richiederlo è però preliminarmente
necessario accedere al programma di assistenza finanziaria fornita dal fondo ESM, firmando il
relativo memorandum of understanding e avviando le riforme richieste; quindi, ma solo se lo si
desidera, accedere allo “scudo”. Se il Paese non si comporta in accordo con il programma, o
cessa di farlo, la ECB può interrompere l’acquisto di titoli.
Paradossalmente, sebbene le OMT siano state uno strumento il cui utilizzo non è mai
stato neppure richiesto da alcun Paese, la presenza della locuzione “acquisti illimitati” ha
permesso a Mario Draghi, Presidente di ECB, di fondare su qualcosa di solido il famoso
discorso col quale, di fatto, ha salvato l’euro. Infatti, il 26 luglio del 2012, a Londra, Draghi ha
testualmente affermato “la Banca Centrale Europea è pronta a fare tutto ciò che è necessario
per salvare l’euro. E credetemi, sarà abbastanza”. Di fronte a questa affermazione i mercati,
colmi di liquidità e desiderosi di poter tornare a utilizzarla con tranquillità anche per
comprare titoli europei, hanno creduto (vero o no che fosse) che ECB fosse pronta a
intervenire veramente con ogni mezzo per sostenere l’euro; detto in altri termini, e pur se la
cosa è vietata dai trattati, si è diffusa l’idea che ECB in caso di emergenza sarebbe potuta
intervenire illimitatamente addirittura sul mercato primario, acquistando i titoli in asta, ossia
all’emissione, dai Governi. E se ECB interviene illimitatamente, può acquistare senza problemi
tutti i titoli emessi, portando lo spread a zero e eliminando ogni problema di finanziamento
dei debiti pubblici. Ciò avrebbe pesanti conseguenze inflazionistiche, ma in realtà non serve
che ECB intervenga sul serio: se gli operatori sono convinti che ECB lo farà, compreranno il
85
prima possibile titoli, convinti che la manovra di ECB farà salire il prezzo di quei titoli e loro
potranno rivenderli lucrando la differenza. Ma, appunto, se i titoli li comprano i privati, non
serve più che li compri ECB… È dunque sufficiente che i mercati credano “sul serio” che ECB è
pronta a intervenire. E così è stato. La frase di Draghi ha tranquillizzato i mercati, che sono
tornati ad acquistare massicciamente i titoli di Stato dei Paesi in difficoltà rendendo più facile
e meno costo per questi Paesi finanziarsi sui mercati.
L’attenuarsi delle difficoltà dei diversi Paesi nel finanziarsi sui mercati non ha però
risolto i problemi europei: il debito pubblico infatti, come sappiamo, è solo una conseguenza
di altre patologie, e d’altro canto rifinanziarlo con maggiore facilità non vuol certo dire
eliminarlo; e le banche non prestano alle imprese perché hanno paura dell’insolvenza di
queste ultime, non perché non hanno liquidità a disposizione. La Banca Centrale Europea è
stata così costretta a intervenire nuovamente nel settembre del 2014, e lo ha fatto con tre
strumenti, il primo dei quali costituito dalle Targeted Long Term Refinancing Operations
(TLTRO), prestiti quadriennali concessi da ECB alle banche dell’eurozona a un tasso
particolarmente favorevole. A differenza delle LTRO si tratta di prestiti finalizzati, nel senso
che le banche che non dovessero utilizzare questa liquidità a basso costo per effettuare
prestiti alle imprese dovrebbero restituirla pagando un tasso penalizzante. Le prime di queste
operazioni si sono svolte tra il settembre e il dicembre del 2014, riscuotendo però uno scarso
successo.
Gli altri due strumenti annunciati nel settembre del 2014, ossia l’acquisto sul mercato
di ABS (Asset-Backed Securities Purchase Programme, ABSPP) e Covered Bonds (Covered Bond
Purchase Programme, CBPP3) sono poi confluiti nel programma di Quantitative Easing
annunciato nel gennaio del 2015, quindi possiamo concentrarci direttamente su quest’ultima
misura.
Il Quantitative Easing di ECB è un programma di acquisto sul mercato secondario di
titoli pubblici e privati per 60 miliardi al mese, che durerà almeno sino a settembre 2016. Ciò
comporterà l’aumento dell’offerta di moneta nell’Eurozona di oltre 1.100 miliardi. In
particolare, oltre all’acquisto di titoli pubblici il programma comprende l’acquisto di titoli
privati, appunto ABS e Covered Bonds. Degli ABS ci siamo già occupati nell’ambito della crisi
statunitense. Nel caso dell’Eurozona si tratta di titoli emessi dalle banche e che hanno come
sottostante prestiti concessi alle imprese: in sostanza le banche concedono prestiti alle
imprese e mettono sul mercato obbligazioni garantite da questi prestiti, ottenendo così la
liquidità necessaria per concedere il prestito e scaricando sugli acquirenti dei titoli il rischio
connesso alla possibile insolvenza dei debitori. Se ECB entra pesantemente sul mercato
acquistando questi titoli diventa molto più facile per le banche venderli, e dunque le banche
stesse dovrebbero essere incentivate a concedere prestiti alle imprese (tanto poi otterranno i
fondi e scaricheranno i rischi sulla Banca Centrale Europea). Una logica simile guida l’acquisto
di covered bonds, titoli obbligazionari che sono caratterizzati da basso rischio perché chi li ha
emessi ha già “messo da parte”, cedendola ad una società terza, una frazione del suo attivo
patrimoniale (titoli o crediti) a garanzia del prestito.
Quindi la politica monetaria di ECB non può certo essere considerata, in generale,
restrittiva; lo diventa solo se la pietra di paragone è la politica massicciamente espansiva delle
altre banche centrali, come la FED Statunitense o la Bank of England Inglese o la Banca
Centrale del Giappone. E ECB avrebbe un ottimo motivo per comportarsi come queste Banche
Centrali: infatti, in presenza di una grave crisi come quella europea, dove la domanda è bassa
e non si trovano compratori per i beni prodotti, i prezzi tendono a scendere. Quando i prezzi
scendono si parla di deflazione, ossia inflazione negativa. Ora, in presenza di deflazione il
rapporto debito/PIL, a parità di altre condizioni, cresce, peggiorando drammaticamente la
situazione per i paesi in difficoltà: infatti il valore dei titoli del debito pubblico emessi in
passato non varia (i prezzi sono quelli di emissione), ma il PIL si muove con i prezzi, e quindi
86
si riduce in presenza di deflazione, aumentando il rapporto Debito/PIL. Così la politica di ECB,
nel tollerare un tasso di inflazione negativo nei Paesi più colpiti dalla crisi genera un
incremento del rapporto debito/PIL e mette ulteriormente a rischio la stabilità dell’Eurozona,
e viene anche meno al suo obiettivo statutario che prevede inflazione al 2%.
Perché ECB si comporta in questo modo? L’idea è che, se realizzasse una politica
monetaria fortemente espansiva, sul modello della FED o della Banca del Giappone, per porla
in essere dovrebbe comprare massicciamente titoli di Stato sul mercato secondario,
facendone salire il prezzo e inducendo così anche i mercati a comprarli massicciamente sul
primario (per lucrare sul previsto incremento di prezzo), rendendo più facile per gli Stati
indebitarsi a basso costo. Detta così, sembrerebbe una buona cosa. Ma l’idea dei “rigoristi” è
che, se per gli Stati è facile e poco costoso indebitarsi, invece di porre in essere le necessarie
politiche di riforma strutturale sosterranno la domanda aggregata con spesa pubblica
finanziata indebitandosi. In sostanza, l’innalzamento dei tassi e dello spread per i Paesi
periferici sarebbe una buona cosa, perché costringerebbe questi Paesi a indebitarsi di meno
sui mercati, visto che è troppo costoso farlo, e dunque a ridurre la spesa pubblica e realizzare
in sua vece le riforme strutturali necessarie. Gli alti tassi come strumento di disciplina del
comportamento dei Governi, dunque.
VIII.5.2 Le politiche per prevenire: L’Unione Bancaria Europea
Sebbene le cause profonde della crisi europea vadano ricercate, come sappiamo, in
problemi strutturali che ostacolano la crescita e in problemi di domanda aggregata, la
principale manifestazione esteriore di questa situazione è stata l’incremento del debito
(pubblico e/o privato) dei diversi Paesi. Questo incremento di debito, oltre a rappresentare un
problema in se stesso, che si somma agli altri, ha dato origine alla dinamica esplosiva nota
come doom loop. Proprio per combattere il doom loop si è passati dal bail-in al bail-out e si è
realizzata una più stretta vigilanza bancaria che impedisca, o almeno ostacoli fortemente,
politiche bancarie eccessivamente rischiose. Ciò è stato fatto con la cosiddetta Unione
Bancaria Europea (Banking Union), che accentra a livello europeo tanto la sorveglianza sulle
singole banche, sinora gestita (assai male) dai diversi Paesi, quanto il meccanismo di
risoluzione delle crisi, con il passaggio appunto al bail-in.
Si tratta di un progetto nato nel 2010 che coinvolge obbligatoriamente i Paesi
dell’Eurozona, lasciando agli altri Paesi appartenenti all’Unione Europea la possibilità di
aderirvi volontariamente. L’Unione Bancaria prevede tra le altre cose l’istituzione di un’unica
autorità di vigilanza centralizzata, regole uniformi tra i diversi Paesi, un meccanismo comune
di risoluzione delle crisi bancarie, un regime unificato di assicurazione dei depositi.
Per quanto concerne il meccanismo unico di vigilanza (Single Supervisory Mechanism)
questo è gestito dalla ECB, con il sostegno a livello nazionale dell’EBA (European Banking
Authority), ed è limitato alle circa 130 banche di rilevanza cosiddetta sistemica, mentre la
vigilanza sulle altre banche, circa 6.000, rimarrà affidata alle autorità nazionali e all’EBA, pur
rispettando le linee guida comunitarie. La ECB controllerà quindi funzioni bancarie cruciali
quali l’autorizzazione all’esercizio, la verifica dei requisiti patrimoniali, l’intervento in caso di
irregolarità, la conduzione di stress test, le richiesta di informazioni e le ispezioni, ecc.
Per quanto concerne invece il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie
(Single Resolution Mechanism), questo coinvolge tutte le 6.000 banche e prevede appunto il
passaggio al bail-in, coinvolgendo inizialmente azionisti e possessori di obbligazioni non
garantite; se non è sufficiente, si passa ad obbligazionisti garantiti e correntisti (sopra i
100.000 euro); se non basta ancora, e gli interventi precedenti hanno comunque raggiunto
l’8% delle passività, interverrà un fondo unico europeo costituito con i contributi delle banche
stesse, il Single Resolution Fund (Srf), che andrà a regime nel 2025 e avrà una dotazione di
87
circa 60 miliardi di euro, coprendo le perdite ulteriori, fino a un ulteriore 5% delle passività;
infine, in caso questi interventi non bastassero, sarà possibile autorizzare il Governo a
intervenire richiedendo un finanziamento erogato dall’ESM. In questo modo dovrebbe ridursi
fortemente il pericolo che le banche corrano rischi eccessivi, perché gli azionisti saranno
maggiormente responsabilizzati sapendo che, in caso di problemi, non sarà il Governo a
intervenire per salvarli ma perderanno il loro capitale.
Infine, è previsto un meccanismo di assicurazione obbligatoria dei depositi che
garantisca il rimborso totale, in caso di fallimento delle banche, per tutti i correntisti che
abbiano depositi inferiori a 100.000 euro, con rimborso entro 20 giorni lavorativi. Lo scopo
principale è impedire la corsa agli sportelli per prelevare denaro in caso di problemi di una
banca. Si è molto discusso se questa garanzia dovesse essere nazionale e sovranazionale,
circostanza quest’ultima che avrebbe infuso alla garanzia stessa molta maggiore credibilità,
ma i Paesi più forti si sono opposti, nel timore di dover poi essere costretti a pagare per i
fallimenti dei più deboli.
Nel complesso si tratta di un insieme di innovazioni che hanno un senso, ma si
prestano a numerose critiche: l’esiguità dei fondi che potranno essere stanziati dal SRF, 60
miliardi contro spese complessive per i salvataggi bancari che, dal 2008, hanno superato i 600
miliardi; i tempi lunghi per la sua complessiva entrata in vigore; l’assicurazione dei depositi
garantita dal Governo, col rischio che qualora una crisi bancaria fosse ingenerata da una crisi
sovrana (ad esempio se l’Italia dovesse dichiarare default le banche italiane fallirebbero,
avendo in portafogli ingentissime quantità di titoli di Stato) l’assicurazione governativa
sarebbe poco credibile. Rimane poi il problema cruciale, ovvero il fatto che tutte queste
normative, per quanto utili, trascurano la circostanza che la crisi europea non è una semplice
crisi bancaria, come ad es. quella statunitense, ma una crisi strutturale, di produttività, e di
domanda aggregata, tutte circostanze certamente aggravate ma non certo causate dai
problemi delle banche, se si escludono forse i casi irlandese e cipriota.
VIII.6 Le vere finalità della politica del rigore
Da tutto ciò che abbiamo visto sinora appare evidente che il debito, tanto quello
pubblico quanto quello privato, rappresenta una conseguenza di problemi strutturali
preesistenti e più gravi. Che poi sia diventato un problema a sua volta, generando inoltre il
fenomeno del doom loop, è un dato di fatto, ma non muta la sostanza: la lotta contro il debito,
o contro il doom loop, è destinata comunque al fallimento se non si colpiscono alla radice le
cause di quel debito.
L’origine del debito è nella circostanza che i Paesi periferici dell’eurozona e dell’Unione
Europea si sono trovati a confrontarsi con un problema di bassa domanda, e per fronteggiarlo
alcuni (Gran Bretagna, Spagna, Irlanda, Cipro) hanno prodotto bolle speculative che
inizialmente hanno sostenuto un prepotente sviluppo ma poi sono scoppiate, portando il
Paese in recessione, e rendendo necessari salvataggi bancari che hanno generato il debito
pubblico; altri (Italia, Grecia, Portogallo) hanno invece effettuato massicci interventi di
sostegno pubblico dell’economia, anch’essi capaci di promuovere una crescita sostenuta del
PIL ma anche, e stavolta direttamente, un ingente debito pubblico. In entrambi i casi, poi, i
Paesi sono stati incapaci di indirizzare le maggiori spese, pubbliche o private che fossero,
verso investimenti tali da sostenere la crescita nel lungo periodo, preferendo impieghi
improduttivi, spesso guidati dalle esigenze politiche di ottenere consenso elettorale.
Apparentemente, però, le politiche europee sono tutte destinate a combattere il debito,
sia quando (spesso) imputano la situazione attuale al lassismo fiscale di alcuni Paesi, sia
quando (più raramente) la colpa è invece fatta ricadere sul sistema bancario e
sull’indebitamento privato. In realtà, come sappiamo, le politiche europee, sebbene abbiano la
88
convenienza di enfatizzare il ruolo del debito e del lassismo di bilancio nella situazione attuale
europea, sono perfettamente coerenti con una interpretazione più ampia, anche se assai
ideologicamente orientata, della lunga crisi che ha colpito l’Europa. Questa interpretazione
più ampia riconosce che la crisi è una conseguenza dei divari di produttività tra i diversi Paesi,
nonché dell’andamento non coerente delle retribuzioni reali con quei divari di produttività
(nei Paesi dove la produttività è cresciuta meno i salari sono aumentati di più), il tutto in un
contesto di cambi fissi prima e moneta unica poi che ha impedito il ricorso a svalutazioni
competitive. Una simile interpretazione, sebbene non condivisa da tutti, è comunque ritenuta
corretta dalla maggior parte degli economisti; dove invece le opinioni sono assai più
contrastanti è sull’utilità delle politiche del rigore per risolvere i problemi indicati.
L’idea alla base delle politiche del rigore è di stampo strettamente liberista, incentrata
sull’ipotesi che la scarsa competitività dei Paesi periferici sia causata da un eccesso di
regolamentazione residua dei mercati e quindi possa essere risolta solo con ulteriori,
massicce liberalizzazioni che dovrebbero interessare soprattutto, anche se non solo, il
mercato del lavoro, cercando di determinare una riduzione salariale sufficiente a ridurre i
costi di produzione e quindi i prezzi dei beni, rilanciando così le esportazioni e attirando
investimenti diretti esteri. Questo approccio ha l’obiettivo di conseguire gli stessi effetti di un
deprezzamento del cambio senza che il cambio sia toccato (i Paesi periferici un tasso di
cambio loro proprio non ce l’hanno). Si chiama deprezzamento del tasso di cambio reale.
Dopo tutto, se la Germania è riuscita a crescere incrementando le sue esportazioni, che sono
aumentate perché i prezzi in Germania sono saliti meno di quelli degli altri Paesi grazie alle
politiche di contenimento salariale, lo stesso potrebbero fare tutte la nazioni in difficoltà.
Ora, per ottenere un deprezzamento del tasso di cambio reale è necessario che i prezzi
dei beni esportati si riducano. E affinché si riducano i prezzi dei beni esportati è necessario,
anche se non sufficiente, che i costi di produzione per gli imprenditori si riducano. E per
ridurre i costi di produzione si devono ridurre uno o più di uno degli elementi di costo
rappresentati dai salari, dalle imposte, dai costi di trasporto, dai costi della pubblica
amministrazione, dai costi dell’energia, ecc. In genere l’enfasi delle politiche del rigore è su
riforme del mercato del lavoro che portino a riduzioni salariali, mentre la riduzione delle
imposte rappresenta un punto più controverso, anche se sovente indicato, poiché la fobia per
il debito pubblico che rallenterebbe la crescita rimane una costante del pensiero liberista,
ragion per cui si potrà avere una riduzione delle imposte solo dopo una riduzione della spesa
pubblica.
Quindi, liberalizzazione del mercato del lavoro non per aumentare l’occupazione
nell’immediato (l’idea è che l’occupazione aumenterà in seguito, quando ripartirà la crescita
economica), ma liberalizzazione del mercato del lavoro per far scendere i salari e far
recuperare competitività internazionale al Paese. Per ottenere questa liberalizzazione del
mercato e questa riduzione salariale si può operare attraverso una politica di riforme, che
riduca il potere del sindacato e liberalizzi il mercato, come viene richiesto sempre in sede
europea; oppure, se i sindacati e/o il Governo non accettano di farsi caro di riforme
impopolari, allo stesso risultato si perviene attraverso una profonda recessione che, se
duratura, fa aumentare talmente tanto e per tanto tempo la disoccupazione da far scendere
lavoratori (disoccupati) e sindacati a più miti consigli, accettando condizioni salariali e
lavorative che non avrebbero accettato in tempi normali.
Questo spiega perché le politiche restrittive continuino ad essere applicate anche se, in
tutta evidenza, non riescono a conseguire l’obiettivo che dichiarano dia vere, anzi: esse infatti
invece che ridurre il debito pubblico lo hanno incrementato. Un risultato che però non è né
imprevisto né sorprendente, neppure per chi suggerisce tali politiche. Per vedere perché,
partiamo dal rapporto debito pubblico/PIL. La situazione migliora, ossia il rapporto si riduce,
se il debito pubblico si riduce o se il PIL aumenta (o per particolari combinazioni delle
89
variazioni delle due grandezze). Perché si riduca il debito è necessario che un Paese spenda
meno di quanto incassa - e utilizzi quei risparmi per ridurre il debito -, ossia che sia non in
deficit sul bilancio dello Stato, ma in surplus. Perché aumenti il reddito serve o un aumento
della produzione reale del Paese, oppure un aumento dei prezzi, visto che il PIL non è appunto
altro che la produzione finale reale (cioè la quantità di beni finali prodotta) moltiplicata per i
prezzi dei beni. Ora, una politica volta a ridurre la spesa pubblica e incrementare il prelievo
fiscale, come appunto quella suggerita dalle autorità europee, serve certamente a portare
verso il surplus il bilancio dello Stato, o almeno a ridurre il deficit, ma sconta due importanti
effetti collaterali. Innanzitutto, la riduzione della spesa pubblica riduce la domanda aggregata,
e se questa scende, diminuisce la produzione, ossia il PIL, e dunque tende a far aumentare il
rapporto debito pubblico/PIL perché diminuisce il denominatore. Inoltre, la riduzione del PIL
innesca gli stabilizzatori automatici, fa cioè lievitare le spese dello Stato in sussidi di
disoccupazione e limita le entrate fiscali, entrambi elementi che tendono a far crescere il
deficit, e quindi il debito. Se poi la politica restrittiva scatena aspettative negative nella
popolazione, che contrae ulteriormente i propri consumi perché teme che in futuro avrà
redditi più bassi o dovrà pagare imposte maggiori, e dunque pensa che sia meglio risparmiare
di più oggi, la riduzione della domanda e del PIL è ancora maggiore. Aggiungendo a tutto
questo politiche volte a ridurre i salari, ecco che i consumi si riducono ulteriormente, facendo
avvitare l’economia in una spirale recessiva drammatica, con tagli che generano recessione
che genera deficit che accresce il debito e impone altri tagli, com’è successo in Grecia.
Le politiche restrittive, dunque, non funzionano; ma vengono intraprese lo stesso.
Perché? Perché il loro obiettivo non è ridurre il deficit e il debito, o almeno non è quello il loro
obiettivo principale. Il loro vero obiettivo e ridurre il Paese ad uno stato di prostrazione tale
da rendere accettabili riforme radicali del mercato del lavoro, riducendo il potere dei
sindacati e tagliando i salari con poca opposizione. Possiamo così dire che le politiche del
rigore hanno successo non tanto se riescono a ridurre (almeno rispetto al PIL) debito e deficit,
ma se creano le condizioni per riforme drastiche e radicali del mercato del lavoro.
Inoltre la recessione non solo rende politicamente più accettabili le politiche di
liberalizzazione dei mercati, ma crea un eccesso della produzione sulla domanda, con grandi
quantità di prodotti invenduti che ne fanno scendere i prezzi, processo rafforzato dalla discesa
dei costi di produzione per gli imprenditori grazie alla riduzione salariale causata dalla
disoccupazione di massa e dalla riduzione del potere sindacale, oltre che dalle già citate
riforme del mercato del lavoro. La discesa dei prezzi dei beni prodotti costituisce la cosiddetta
“deflazione interna”, che permetterebbe ad un Paese, grazie alla riduzione dei prezzi dei beni
che esporta, di recuperare competitività internazionale e quindi di vedere aumentare la
componente esportazioni della sua domanda aggregata. Che poi sia difficile incrementare le
esportazioni quando il mondo è in recessione, e che dunque la deflazione interna funzioni sino
a un certo punto, è un’altra storia, della quale le autorità europee si occupano poco.
Ma non finisce qui. Infatti i teorici del rigore sono perfettamente consci del fatto che
tagliare i salari non è sufficiente: è necessario aumentare la produttività, attrarre investimenti
diretti esteri, rilanciare gli investimenti interni… Ritengono però che un Paese che da un lato
liberalizza il mercato del lavoro e dall’altro taglia la spesa pubblica attirerà investitori tanto
nazionali quanto esteri, attratti sia dai minori costi del lavoro sia dalla prospettiva di minori
imposte in futuro (perché una minor spesa pubblica oggi vuol dire meno debito domani e
quindi, sempre domani, meno imposte per gli imprenditori grazie al minor debito da
ripagare), sostenendo così tanto la domanda aggregata quanto la crescita.
Questo insieme di riforme può essere realizzato per volontà politica guidata da
lungimiranza, come si ritiene sia accaduto in Germania dopo l’ingresso nell’eurozona, o può
essere accettato passivamente come ultima soluzione grazie a una profonda recessione
protratta per anni e accompagnata da disoccupazione di massa e disordini sociali.
90
Chiaramente la lungimiranza politica sarebbe la soluzione migliore, ma poiché se in passato
avessero avuto lungimiranza i Paesi periferici non sarebbero finiti nelle condizioni in cui sono,
è più probabile che le riforme debbano essere imposte con lunghe recessioni.
Quindi l’effetto collaterale della politica del rigore, ossia il prolungarsi e l’acuirsi della
recessione, non deve necessariamente essere visto come tale, ossia come un effetto
collaterale: in certe circostanze e per certi Paesi, è proprio l’obiettivo che si vuole perseguire.
VIII.7 Potrebbe funzionare? No.
Anche se molti concordano sull’individuazione di quali siano i problemi dei Paesi
periferici dell’eurozona, solo pochi economisti ritengono che le politiche del “rigore” possano
rappresentare la soluzione per questi problemi. In particolare, sebbene sia quasi
unanimemente riconosciuto che una maggiore flessibilità del mercato del lavoro vada
incontro alle esigenze delle imprese, rendendole più competitive, e che una riduzione dei
salari incrementi la loro competitività, così come una riduzione delle imposte, quasi nessuno
crede che ciò sia sufficiente per rilanciare la domanda aggregata e, soprattutto, la crescita.
Infatti, la dimensione della riduzione salariale necessaria per recuperare il gap di
competitività potrebbe essere troppo rilevante e quindi socialmente insostenibile o
indesiderabile, e dunque, accanto alla riduzione dei salari e alla riforma del mercato del lavoro
serve un incremento della produttività del lavoro, più tecnologia, migliore formazione dei
lavoratori, una riduzione delle imposte, una riduzione dei costi della pubblica
amministrazione e un aumento della sua efficienza, un incremento dell’efficienza della
giustizia civile, un miglioramento nella dotazione infrastrutturale dei Paesi, migliori reti di
distribuzione dell’energia, trasporti più efficienti, ecc. Tutti elementi che richiedono
investimenti pubblici (in capitale fisico e infrastrutturale, in capitale umano, in ricerca e
sviluppo); inoltre, gli stessi imprenditori privati, tanto nazionali quanto stranieri, sono attratti
oltre che dai diversi elementi citati sin qui, dai bassi salari alla riforma della pubblica
amministrazione, anche da un Governo che garantisca un sostegno alla domanda aggregata,
perché la garanzia (assurance) che i decisori pubblici faranno di tutto per assicurare alta
domanda alle mie produzioni è un elemento cruciale per invogliare gli imprenditori ad
investire. I Paesi in difficoltà dovrebbero dunque aumentare la loro spesa, non ridurla,
facendo investimenti pubblici (e/o privati) capaci di ristrutturare i sistemi economici; al
limite, il problema sarebbe quello di assicurarsi che questi Paesi effettivamente indirizzino la
spesa verso impieghi produttivi, e non verso il semplice acquisto di consenso elettorale come
hanno fatto sinora. Una politica europea fatta di tagli massicci di spesa rischia comunque di
aggravare la crisi, non di risolverla. Inoltre, le pur necessarie liberalizzazioni (alcuni Paesi,
come ad esempio la Grecia, hanno un mercato talmente ingessato che gestire attività
imprenditoriali innovative è quasi impossibile) andrebbero accompagnate con politiche
espansive, sia per mitigarne gli effetti sociali di breve termine, sia per ridurre l’impatto dei
licenziamenti sulla domanda aggregata.
Quindi, abbassare i salari non basta, è necessario (almeno) incrementare la
produttività e rilanciare la domanda interna, e questo si può fare solo affiancando alle
liberalizzazioni tutta una serie di riforme e di investimenti che necessitano della mano
pubblica, oltre a un importante sostegno alla domanda aggregata.
Esistono poi linee di pensiero più radicali, ma scarsamente fondate, secondo le quali i
problemi sarebbero in realtà stati enfatizzati e i Paesi periferici non avrebbero alcun deficit
significativo di produttività. Ritengo che tale approccio sia però proprio quello che ha portato
l’Italia e gli altri PIIGS a non porre in essere per tempo quelle politiche atte ad affrontare i
cambiamenti che il mondo ha subito, dalla rivoluzione digitale alla globalizzazione, portandoci
al disastro attuale. Che poi siano politicamente più comode, perché tendono a dire che in
91
realtà le colpe sono “degli altri” (della Germania, dei mercati, degli speculatori…), non fa che
renderle più rischiose, dando ai molti che sanno poco di economia un comodo alibi per
mantenere la testa nascosta sotto quella stessa sabbia dove l’hanno tenuta negli ultimi
vent’anni. Solo che tra poco, se manterremo ancora la testa sotto la sabbia, ci renderemo
conto che non sarà più possibile uscirne e moriremo soffocati.
IX. Le alternative
92
IX.1 Politiche dal lato dell’offerta e dal lato della domanda alternative al
“rigore”
In qualche modo le alternative alla politica del rigore sono già implicite in quanto
abbiamo discusso nel capitolo precedente: da un lato, politiche di bilancio e/o monetarie
espansive per sostenere la domanda aggregata; dall’altro non limitare le politiche dal lato
dell’offerta alla liberalizzazione dei mercati ma affiancarci politiche di investimento pubblico
in infrastrutture, formazione, ricerca e sviluppo. Più complicato è valutare come questi
principi generali possano essere messi in pratica nella realtà europea, con i vincoli di finanza
pubblica di cui tener conto e, soprattutto, le imprescindibili considerazioni in merito alla
fattibilità politica delle diverse opzioni.
In questo capitolo esaminiamo partitamente la fattibilità pratica delle diverse opzioni:
il sostegno pubblico alla domanda aggregata, da un lato, le politiche dal lato dell’offerta in
generale (quindi sia quelle sulle quali già punta la politica del rigore, sia quelle irriconducibili
al rigore), dall’altro. Distinguendo, in entrambi i casi, tra le politiche che possono essere
realizzate dai Governi e quelle che, invece, possono essere realizzate dalle istituzioni europee,
Banca Centrale compresa. Nelle ultime due sezioni del capitolo esamineremo, invece, le due
opzioni più radicali a disposizione dei Governi, ossia l’uscita dall’eurozona e la dichiarazione
di default.
IX.2 Le politiche (alternative) di bilancio e monetarie
IX.2.1 Le politiche di bilancio
In presenza di una recessione è usuale che i Governi sostengano la domanda aggregata
con politiche di bilancio espansive, finalizzate sia a sostenere la domanda aggregata
contrastando così la recessione, ed a questo fine qualsiasi tipo di spesa pubblica è utile, sia ad
attenuare l’impatto della crisi sulle categorie più deboli, in particolare i disoccupati, con
sussidi di vario genere. Entrambe le politiche sostengono la domanda aggregata, ma mentre la
seconda è rivolta solo a categorie specifiche, la prima ha un impatto generale.
Ora, una politica di bilancio espansiva da parte dei Governi nel corso di una recessione
ha, in genere, tre controindicazioni. La prima sono i vincoli imposti, dai mercati e dalle
istituzioni europee, alla finanza pubblica. La seconda è un problema di azzardo morale. La
terza il danno alla crescita che, secondo alcuni economisti, un eccesso di indebitamento
pubblico provocherebbe.
Iniziamo dal primo vincolo, che è quello più stringente: la spesa pubblica espansiva
deve essere finanziata, e finanziarla alzando le imposte ne riduce grandemente l’efficacia
(perché da una parte il Governo aumenta le sue spese, dall’altra i privati riducono le loro a
causa dell’aumento delle imposte). Quindi perché sia realmente efficace è opportuno che sia
finanziata in deficit. Ma il finanziamento in deficit incontra tanto i limiti del Patto di Stabilità e
Crescita e del Fiscal Compact, quanto i limiti dei mercati che, di fronte a un incremento di
deficit e quindi di debito considerano il Paese a maggior rischio di insolvenza e richiedono
tassi di interesse più alti per compare titoli pubblici. Ne segue che anche consentire a un Paese
di sforare il Fiscal Compact e il Patto di Stabilità non sarebbe necessariamente una soluzione
ottimale, perché rimarrebbe il vincolo dei mercati; serve dunque un finanziamento esterno, o
almeno una garanzia esterna sull’indebitamento del Paese. Difficile da ottenere, se non per
importi limitati, soprattutto se le spese sono finalizzate non alla crescita ma al sostegno della
domanda aggregata tout court.
93
Qui infatti sovviene il secondo vincolo, quello dell’azzardo morale. L’idea di molti
politici e di qualche economista è che i Paesi periferici dell’Unione siano giunti alle condizioni
nelle quali sono perché in passato, invece di utilizzare la spesa pubblica finanziata in deficit
per effettuare investimenti in infrastrutture, formazione, ricerca e sviluppo, la hanno
destinata essenzialmente al sostegno di breve periodo all’economia, incrementando così il
debito ma non la crescita. E ingenerando nella popolazione l’illusione che anche i privati non
dovessero investire in formazione, capitale fisico, ecc. perché tanto il Governo sarebbe
comunque intervenuto a sostenere la domanda aggregata. Quindi lasciar sforare a questi Paesi
il Patto di Stabilità, o dare una garanzia europea a queste spese, vorrebbe dire continuare a far
percorrere a questi Paesi la stessa strada che li ha condotti alla mancata crescita,
deresponsabilizzandoli.
Infine, secondo alcuni economisti, un eccesso di indebitamento deprime la crescita
futura dell’economia, e quindi fare spesa pubblica in deficit è assolutamente deleterio. In
particolare gli economisti che si sono occupati del problema, primi fra tutti Carmen Reinhart e
Kenneth Rogoff, hanno constatato che storicamente il tasso di crescita dei Paesi con un debito
pubblico superiore al 90% del PIL è inferiore di circa un punto percentuale (poco più del 2%
contro poco più del 3%) rispetto al tasso di crescita dei Paesi con un rapporto debito/PIL
inferiore al 90%. Il lavoro di Reinhart e Rogoff è stato molto criticato, poiché conteneva alcuni
gravi errori di calcolo, ma anche chi lo ha critica, in particolare Thomas Herndon, Michael Ash
e Robert Pollin raggiunge conclusioni molto simili (2,2% contro 3,2%). Il metodo dei due
autori può dunque essere discutibile, così come discutibile è stabilire un nesso di causazione
tra il debito e la crescita (non può essere il contrario? Che la bassa crescita abbia generato il
debito?) o accomunare Paesi molto diversi tra loro per epoca storica e collocazione geografica,
ma rimane comunque un supporto teorico contro l’indebitamento.
E allora? Come sostenere la domanda aggregata senza incorrere in questi vincoli?
Chiederemmo a questo punto al lettore di pazientare sino alla sezione IX.3, dove
proveremo a mostrare che si può sostenere tanto la domanda aggregata quanto la crescita, ed
evitare accuse di azzardo morale, se solo c’è la volontà comune di farlo. Cosa che, a ben
guardare, assieme alla reciproca fiducia, è il vero problema europeo…
IX.2.3 Le politiche monetarie
Si può sostenere la domanda aggregata anche con una politica monetaria espansiva,
che tra l’altro presenta numerosi vantaggi: non genera debito pubblico, favorisce gli
investimenti privati, può determinare un deprezzamento del tasso di cambio che incrementa
le esportazioni… anche la principale controindicazione di questa politica, ossia il rischio di
generare inflazione, è basso in presenza di una recessione e, soprattutto, se accadesse
presenterebbe comunque il vantaggio di ridurre il rapporto debito/PIL, come abbiamo già
visto nel capitolo VIII. Dopo tutto, gli Stati Uniti sono usciti dalla crisi proprio grazie a una
simile politica monetaria, e oggi vantano tassi di aumento del PIL invidiabili. E allora, perché
non replicare la stessa esperienza in Europa? Soprattutto, che senso ha una politica non
espansiva, che mantiene basso l’andamento dei prezzi, facendo scivolare alcuni Paesi in
deflazione? Per i Paesi in difficoltà sarebbe tra l’altro meno doloroso e più facile tagliare la
spesa pubblica se nel frattempo il PIL crescesse grazie alla politica monetaria. Insomma, se
priviamo i Paesi della politica di bilancio espansiva e li costringiamo a farla restrittiva, poi non
possiamo anche privarli della politica monetaria espansiva: sarebbe un masochismo inutile.
In questa direzione, fortunatamente, si sta muovendo ECB con le politiche di
Quantitative Easing del 2015. Rimane comunque la fastidiosa impressione che sia ancora
troppo poco, e troppo tardi, con l’enfasi rimasta sull’inflazione e non su domanda aggregata e
crescita. Certo, la crisi europea è profondamente diversa da quella statunitense e il problema è
anche (soprattutto) un problema di bassa produttività – alti salari, contro il quale le politiche
94
monetarie possono poco. Ma possono essere indispensabili per garantire un adeguato
sostegno alla domanda aggregata e all’occupazione, senza pesare sul debito, mentre vengono
intraprese le indispensabili riforme strutturali; e anche per ovviare alla distruzione di capitale
umano e capitale fisico associato alla recessione, che danneggia gravemente la crescita.
IX.3 Le politiche (alternative) dal lato dell’offerta
IX.3.1 Le politiche dei Governi e delle istituzioni europee
Veniamo al punto cruciale: ci sono politiche alternative dal lato dell’offerta che
sarebbero migliori rispetto a quelle intraprese sino ad ora? Politiche praticabili e che
potrebbero magari anche sostenere la domanda aggregata?
La risposta è affermativa.
Le tipiche politiche economiche dal lato dell’offerta sono quelle che puntano alla
liberalizzazione dei mercati, soprattutto del lavoro e finanziari, alla riduzione delle imposte
alle imprese, alla riduzione del ruolo dello Stato nell’economia, alla facilitazione dell’iniziativa
imprenditoriale privata, all’attrattività degli investimenti diretti esteri. Si può così pensare che
implichino, tutte, un maggior ruolo per il mercato e un minor ruolo per lo Stato. In realtà, non
è così. Infatti, a stretto rigore, le politiche dal lato dell’offerta sono quelle che incrementano la
produttività e/o riducono i costi di produzione per le imprese; ma per ottenere questo
risultato un ruolo importante può essere rivestito anche dallo Stato.
Infatti per incrementare la produttività del lavoro può certamente essere importante
l’attività di formazione dei lavoratori effettuata dai privati (e quindi, ad esempio, gli spillover
derivanti dagli Investimenti Diretti Esteri), ma altrettanto se non più utile è l’attività di
istruzione scolastica fornita dal Governo. Allo stesso modo l’attività di ricerca di base delle
strutture pubbliche è cruciale per le grandi innovazioni rivoluzionarie, quelle che inizialmente
non sembrano avere applicabilità pratica ma poi cambiano il mondo. E le stesse infrastrutture
di trasporto e comunicazione, cruciali per ridurre i costi delle imprese, raramente possono
essere fornite dai privati. Sono questi (e altri ne potrebbero agevolmente essere trovati) tutti
elementi il cui potenziamento si configura come una politica dal lato dell’offerta, che
incrementa la produttività e/o riduce i costi per le imprese, e la cui produzione può, o in molti
casi deve, essere affidata allo Stato.
Quindi, una vera politica dal lato dell’offerta, utile per far crescere il Paese nel lungo
periodo incrementandone la capacità produttiva potenziale, non può prescindere
dall’investimento pubblico in formazione, istruzione, ricerca scientifica di base, infrastrutture
di trasporto e comunicazione, ecc. E una politica di massiccio investimento pubblico in questi
settori non solo incrementa l’offerta aggregata potenziale futura, e dunque favorisce la
crescita, ma sostiene anche la domanda aggregata nel breve periodo, incrementando da subito
la produzione e l’occupazione.
Potrebbe sembrare che però anche in questo caso rimanga il problema del
finanziamento della spesa pubblica, ossia il vincolo dei mercati e delle istituzioni europee. In
realtà, molte delle obiezioni verrebbero a cadere se l’incremento di spesa pubblica, e dunque
di deficit prima e di debito poi, fosse interamente destinato al finanziamento non di spesa
“improduttiva”, ma di investimenti indispensabili per incrementare la capacità produttiva del
Paese, e dunque la crescita di lungo periodo. Un simile risultato può essere conseguito in due
modi (alternativi o complementari). Il primo criterio potrebbe consistere nel permettere al
Paese di sforare i vincoli del Patto di Stabilità e del Fiscal Compact solo per finanziare progetti
di investimento puntualmente individuati dalle autorità europee e ritenuti di importanza
cruciale per la crescita, avendo l’accortezza di finanziare una quantità di progetti
sufficientemente ampia per rilanciare sia la crescita sia la domanda aggregata, e non dunque
le briciole di cui si parla. Se così si facesse i mercati non dovrebbero richiedere un interesse
95
più alto nel finanziare il maggior debito del Paese perché avrebbero la garanzia che le spese
effettuate, contribuendo alla crescita futura, aumenterebbero il PIL nel tempo e dunque
renderebbero più sostenibile quello stesso indebitamento. Se però si ritenesse
eccessivamente rischioso il ricorso ai mercati per finanziare il maggior debito nazionale, o se
questa procedura si rivelasse eccessivamente costosa in termini di aumento del tasso di
interesse, si potrebbe pensare al potenziamento dell’istituto dei “project bond”, ossia titoli
messi sul mercato dalle istituzioni europee, o addirittura dall’ESM, per finanziare specifici
progetti di investimento dei singoli Paesi.
È importante sottolineare che, anche in quest’ultimo caso, la spesa non deve essere
simbolica, ma dovrebbe configurarsi come un vero e proprio nuovo “Piano Marshall” per
l’Europa, con diverse centinaia di miliardi di investimenti finanziati all’anno.
Certo, i controlli dovrebbero essere accurati, e la buona fede provata oltre ogni
ragionevole dubbio, ma non è particolarmente difficile ideare adeguati strumenti di controllo
e gestione, se esiste la volontà politica di farlo. Soprattutto, se superando l’egoismo
nazionalistico i Paesi più ricchi accetteranno senza problemi l’implicita necessità che la
maggior parte dei finanziamenti sia destinata ai Paesi deboli, non a loro. Probabilmente una
simile scelta richiederebbe, però, una qualche evoluzione verso un Governo unico
dell’eurozona, verosimilmente in forma almeno federale, atto appunto a superare gli egoismi
nazionalistici. Richiederebbe poi fiducia dei più ricchi verso i più poveri, e la fine dei
comportamenti opportunistici dei più poveri, con probabili cessioni di sovranità. Siamo pronti
a questo? Se sì, c’è speranza. Altrimenti andrà sempre peggio, ma l’economia c’entrerà poco.
IX.4 Dichiarare default
Molto spesso si sostiene, soprattutto a livello di mass media, che una soluzione per i
problemi di alcuni Paesi periferici dell’Eurozona possa essere proprio dichiarare default sul
debito pubblico. Default è il termine attuale con il quale ci si riferisce al fallimento di uno Stato
o di un privato, ossia alla dichiarazione di insolvenza; in passato per i fallimenti sovrani si
preferiva il termine consolidamento, mentre ristrutturazione del debito è un modo meno
esplicito di intendere lo stesso concetto. Quando un Paese dichiara default, esso decide di non
pagare i suoi debiti, cioè di non rimborsare alla scadenza, in tutto o in parte, il valore dei titoli
di Stato emessi. Se la scelta è di non pagarli in parte, si parla di haircut, taglio di capelli, in
genere associando questa locuzione alla percentuale di debito che il Paese ha deciso di
rinnegare.
Viene generalmente considerata come un default sovrano ogni scelta politica che
modifichi l’ammontare o le scadenze temporali della restituzione inizialmente pattuita; quindi
anche se un Paese dichiara che pagherà i suoi titoli con 15 giorni di ritardo, o che restituirà
quanto prestato ma non pagherà gli interessi, queste pratiche sono considerate come un
default.
È chiaro che, dopo un default, il debito pubblico di un Paese non esiste più (o è
fortemente ridotto, nel caso di un semplice haircut). La cosa potrebbe sembrare invitante, e
apparentemente in grado di risolvere parecchi problemi, ma ci sono almeno due categorie di
(gravi) conseguenze negative di un default che vale la pena segnalare.
Innanzitutto, dichiarare default vuol dire che chi ha comprato titoli del debito pubblico
di quel Paese ha perso interamente (o parzialmente, in caso di haircut), il suo denaro. Se i
titoli sono detenuti in larga misura da risparmiatori nazionali, come ad esempio succede in
Italia, si pone un delicatissimo problema politico: ben pochi Governi sarebbero in grado di
applicare un default totale sul debito posseduto dai residenti, e d’altro canto un default
parziale sul solo debito detenuto dai non residenti sarebbe poco incisivo e di complicata
96
realizzazione. Esiste d’altro canto una marcata tendenza delle banche nazionali ad acquistare
principalmente titoli di debito pubblico del proprio Paese. Le banche italiane, ad esempio,
possiedono una quota rilevante del debito pubblico italiano. In caso di default la perdita, per
queste banche, sarebbe molto elevata, tanto da portarle all’insolvenza: è il doom loop, del
quale ci siamo già occupati. Come sappiamo i dissesti bancari hanno poi la spiacevole
caratteristica di generare gravi recessioni. Se infine, come nel caso italiano, la quantità di
debito pubblico esistente risulta molto rilevante in termini assoluti, è probabile che il default
di uno Stato porti al fallimento anche la maggior parte delle banche straniere, generando
tracolli a catena e una recessione globale; questo problema non si pone, invece, se il debito
pubblico del Paese è grande rispetto al PIL del Paese ma piccolo in assoluto, come ha
dimostrato la Grecia.
La seconda categoria di problemi riguarda l’accesso ai mercati. Dopo aver dichiarato
default, il Paese non troverà nessuno disposto a prestargli ulteriormente denaro. Questo
comporta, qualora il Paese non abbia una sua banca centrale (perché le cose cambiano se il
Paese ha una sua valuta e una sua banca centrale), come nel caso dei Paesi dell’eurozona, che
il Governo non avrà alcuna possibilità di effettuare spese superiori alle sue entrate. Diventa
dunque cruciale, per un Paese che dichiara default, avere un bilancio dello Stato almeno in
pareggio, meglio in surplus, una volta scorporati dal calcolo del deficit gli interessi sul debito
(perché, se dichiaro default, assieme al debito spariscono anche gli interessi sul debito).
Poiché il saldo del bilancio dello Stato calcolato escludendo gli interessi si chiama saldo
primario, prima di dichiarare default sarebbe quindi preferibile avere un saldo primario in
avanzo, ossia in surplus, o, come si dice anche, un surplus primario. L’Italia ad esempio ha un
primario in surplus, e potrebbe quindi dichiarare default, ma facendolo porterebbe al
fallimento le banche nazionali e parecchie banche europee, oltre a ridurre sul lastrico tutti i
risparmiatori nazionali che detengono BOT e BTP e li vedrebbero diventare carta straccia: è
probabile che qualcuno di questi risparmiatori che hanno perso tutto, o dei correntisti che
avevano conti correnti nelle banche fallite, cercherebbe di incontrare il Ministro
dell’Economia che ha preso una simile decisione per spiegargli amichevolmente le proprie
ragioni...
Rimane però un aspetto assai più significativo che tende a sconsigliare il ricorso al
default (o almeno, il ricorso al solo default): il debito pubblico è una conseguenza dei problemi
strutturali dei Paesi deboli dell’eurozona, non la causa di questi problemi. Cancellando il
debito certamente si vive meglio, ma se la struttura produttiva di un Paese non esiste più,
dopo la cancellazione del debito non ricomparirà certo magicamente. D’altro canto la Grecia
ha già dichiarato default nel 2012, con un pesante haircut sul valore dei propri titoli, ma non
per questo ha risolto i suoi problemi. Anzi, poiché abbiamo sostenuto che per risolverli è
necessario fare deficit di bilancio per sostenere una spesa pubblica in infrastrutture, ricerca,
formazione, istruzione, ecc., e dopo un default è sostanzialmente impossibile fare deficit di
bilancio perché i mercati non prestano più nulla al Paese che ha ripudiato il suo debito, beh, il
default ha un sapore vagamente masochistico. A meno che non sia accompagnato da un’altra
strategia: la vendita del nuovo debito pubblico a una nuova Banca Centrale nazionale,
costretta per statuto ad acquistarlo. Ma per far ciò è necessario avere una Banca Centrale
nazionale che non rispetta i vincoli di ECB e stampa una propria moneta. È necessario, cioè,
abbandonare l’eurozona.
IX.5 Uscire dall’eurozona
97
IX.5.1 Costi sottovalutati e vantaggi sopravvalutati
E veniamo a quella che, sottovalutandone i rischi e sopravvalutandone i benefici, molti
considerano la vera panacea per tutti i mali: l’abbandono dell’eurozona. Come sappiamo la
scelta di aderire all’Unione Economica e Monetaria, e di adottare l’euro come moneta comune,
ha trovato a suo tempo parecchia opposizione tra gli economisti, che ritenevano non essere
l’Europa un’area valutaria ottima e quindi la consideravano incapace di sostenere la moneta
unica. Ciò nonostante l’idea di tornare alle monete nazionali incontra forti resistenze proprio
tra gli economisti, anche tra quelli a suo tempo contrari all’adesione all’eurozona: perché?
Abbandonando l’euro, e tornando alle monete nazionali, i Paesi periferici dell’eurozona
si troverebbero ad avere una propria valuta e una propri banca centrale, recuperando la
politica monetaria e la politica del cambio. Ciò permetterebbe loro innanzitutto di deprezzare
il tasso di cambio, riducendo i prezzi in euro o nelle altre valute straniere delle loro
esportazioni, e quindi recuperare almeno la loro competitività estera. Se un simile escamotage
permettesse una ripresa delle esportazioni nette, il Paese vedrebbe crescere la domanda
aggregata, il PIL e l’occupazione. Inoltre, il recupero della politica monetaria permetterebbe di
aumentare l’offerta di moneta e abbassare i tassi di interesse, stimolando gli investimenti
privati; ma permetterebbe anche, al limite, di far acquistare alla Banca Centrale i titoli del
debito pubblico, finanziando così in modo più agevole i deficit del bilancio dello Stato senza
subire i ricatti dei mercati finanziari. Infine, l’abbandono dell’eurozona affrancherebbe i Paesi
dal rispetto del Patto di Stabilità e Crescita e del Fiscal Compact, permettendo loro di fare
spesa pubblica espansiva senza dover rispettare i limiti di deficit e debito imposti dall’UEM,
vendendo poi i titoli (o una parte di essi) alla Banca Centrale. Se la spesa fosse indirizzata
verso investimenti produttivi tutto ciò, assieme a un tasso di cambio deprezzato, rilancerebbe
anche la crescita del Paese.
Purtroppo, però, l’abbandono dell’euro presenta parecchi costi, alcuni considerevoli, ed
altri attualmente non quantificabili, e non necessariamente si risolverebbe in un recupero
delle esportazioni nette. La rilevanza di questi costi spiega la riluttanza degli economisti nei
confronti di tale strategia.
IX.5.2 La conversione dei depositi e dei debiti
Prima di proseguire con l’analisi puntuale di costi e benefici dell’abbandono
dell’eurozona è opportuno chiarire perché contestualmente all’uscita sarebbe opportuno
effettuare anche la conversione dei depositi bancari e del debito pubblico (e fors’anche
privato) nella nuova valuta.
La conversione dei depositi è sostanzialmente scontata perché i depositi sono moneta,
anzi costituiscono la stragrande quantità della moneta in circolazione (avete più banconote
nel portafogli o denaro sul conto corrente?). Alcuni economisti, pochi in verità, la pensano
diversamente, ma avere contemporaneamente due monete in un Paese ha sempre portato
solo guai. La conversione del debito ha invece bisogno di qualche spiegazione in più.
Chiariamo il punto ricorrendo ad un esempio. Ipotizziamo che l’Italia abbandoni
l’eurozona e introduca una nuova valuta, la lira, inizialmente con un cambio alla pari rispetto
all’euro: un euro per una lira. Ciò comporta che un salario di, ad esempio, 2.000 euro viene
subito convertito in un salario di 2.000 lire, e un conto corrente di 10.000 euro viene
convertito in 10.000 lire. Però, subito dopo l’introduzione della nuova valuta, questa si
deprezzerà fortemente nei confronti dell’euro. Perché si deprezzerà? Per vari motivi, alcuni
belli complicati, ma soprattutto per uno facile e assai interessante: perché chi la detiene pensa
che gli altri pensino che si deprezzerà. Non è uno scioglilingua. Provate a mettervi nei panni
di un risparmiatore al quale hanno appena convertito 100.000 euro dei risparmi che aveva sul
98
suo conto corrente in 100.000 lire, e al quale è data la possibilità di cambiarli nuovamente sul
mercato, se vuole, in 100.000 euro perché al momento il cambio è ancora una lira per un euro.
Costui si guarda intorno. E si fa l’idea che gli altri risparmiatori nelle su condizioni pensino che
la lira si deprezzerà. Perché? Perché il Governo si è ripreso il cambio proprio (al limite, anche)
per farlo deprezzare e esportare di più. Ma se si fa questa idea, il nostro risparmiatore crederà
anche che gli altri venderanno le lire che hanno il prima possibile per comprare euro, in modo
da sfruttare il cambio una lira per un euro finché dura, non perdendo denaro quando la lira si
deprezzerà. Ma se tutti faranno così, pensa sempre il nostro, tutti vorranno vendere lire e
comprare euro, l’offerta di lire (e la domanda di euro) andrà alle stelle e sarà questo a far
deprezzare subito il cambio della lira, diventando ad esempio due lire per un euro. Così, se il
nostro risparmiatore ha esitato a convertire le su lire in euro, si troverà con 100.000 lire che
valgono, dopo il deprezzamento, 50.000 euro, mentre chi ha convertito subito ora possiede
100.000 euro che se vuole può cambiare in 200.000 lire. Insomma, ha perso una marea di
soldi. Sapendo che le cose rischiano di andare così, voi che fareste? Lui farà come tutti gli altri:
venderà subito, prima che il cambio cambi, prima di tutti gli altri, se ci riesce, le lire e
comprerà gli euro. Ma se tutti si comportano così, il cambio crollerà all’istante.
Okay, ora torniamo alla conversione del debito pubblico in lire. Se l’Italia aveva, ad
esempio, 100 miliardi di euro di debito pubblico, e lascia il debito in euro, dopo il
deprezzamento quei 100 miliardi di euro varranno 200 miliardi di lire, mentre il PIL in lire
inizialmente non cambierebbe. In sostanza, l’Italia raddoppierebbe il suo debito e, soprattutto,
il rapporto debito/PIL. Se invece lo converte in lire, deve restituire solo 100 miliardi di lire e il
suo rapporto debito/PIL resterebbe invariato. L’incremento del rapporto debito/PIL
costituisce dunque un primo motivo per convertire nella nuova valuta il debito pubblico.
Un secondo motivo per convertire il debito ha a che fare con quello che è noto come
“peccato originale” (original sin). Se manteniamo il debito in euro, dovremo ogni anno
procurarci sui mercati una quantità di euro sufficiente per rimborsare i titoli che vengono a
scadenza e pagare gli interessi, e per farlo saremo costretti ad esportare massicciamente.
Finiremmo in sostanza impiccati alla ricerca disperata di valuta estera, destinando a questo
fine tutte le risorse nazionali, mentre come abbiamo visto nel capoverso precedente il nostro
rapporto debito/PIL si impenna. L’original sin è stato d’altro canto all’origine dell’insolvenza
di molti Paesi in via di sviluppo indebitati in dollari, che a un certo punto non riuscivano più a
procurarsi i dollari necessari a pagare il debito e gli interessi su quel debito.
Quindi, convertire sia i depositi sia il debito pubblico appare sostanzialmente
inevitabile. E vedremo che andrà fatto a sorpresa, senza lasciare il tempo ai soggetti di
liberarsi di titoli e depositi. Poi, se il debito, come nel caso della Grecia, è quasi interamente
posseduto da stranieri o da istituzioni finanziarie internazionali, e ho un surplus del bilancio
primario, posso anche dichiarare esplicitamente default. Sapendo però che la conversione
nella nuova valuta del debito pubblico di per se stesso rappresenta un default parziale.
Rimane il problema del debito privato: convertirlo o no? Se lo converto in lire, faccio un
enorme favore alle imprese, che producono e vendono in lire, e che a quel punto potranno
facilmente pagare in lire i propri debiti, ma rischio di far fallire le banche se queste sono a loro
volta indebitate in euro e vengono pagate in lire. Anche qui, ricorriamo ad un esempio. La
banca Bianca ha preso a prestito, ad esempio emettendo obbligazioni sul mercato
lussemburghese, 150 milioni di euro, che ha a sua volta prestato ad alcuni imprenditori
italiani; se i 150 milioni di euro di debito vengono convertiti in lire, gli imprenditori dovranno
restituire solo 150 milioni di lire, che dopo il deprezzamento del cambio, come sappiamo
dall’esempio precedente, valgono 75 milioni di euro al nuovo cambio. La Banca Bianca ha
preso a prestito 150 milioni di euro, ne ha prestati altrettanti ma se ne è vista restituire solo
75, mentre sempre 150 deve restituirne: ha perso la metà del valore del prestito. Sono cifre
più che sufficienti per portare all’insolvenza qualsiasi banca. D’altro canto, se non converto il
99
debito privato in lire, gli imprenditori dovranno restituire 150 milioni di euro, ma poiché loro
quando vendono incassano lire deprezzate, si troveranno a doversi procurare una cifra in lire
molto maggiore (300 milioni, ad essere precisi) per restituire il loro debito, e dunque sono le
imprese che stavolta rischiano l’insolvenza. E il problema non sarebbe solo per le imprese,
perché tutti coloro i quali hanno debiti in euro, anche i singoli individui, li vedrebbero
crescere in proporzione al deprezzamento. Se ad esempio ho comprato casa contraendo un
mutuo di 100.000 euro con una banca, e mi restano appunto 100.000 euro da restituire, col
nuovo tasso di cambio dovrò alla banca (e non è particolarmente rilevante se sia una banca
nazionale o una banca estera) 200.000 lire. Se avevo un salario di 2.000 euro, ora ho un
salario di 2.000 lire: prima mi servivano 50 mensilità per ripagare il debito, ora 100.
Scegliere tra le due alternative (convertire o non convertire il debito privato nella
nuova valuta) costituisce un bel problema, che non vorremmo essere chiamati a dover
affrontare…
Ma questa era solo una premessa, per delineare chiaramente lo scenario; torniamo ora
ai costi dell’uscita.
IX.5.3 I costi della transizione
Tra i costi di transizione connessi all’uscita dall’eurozona vanno innanzitutto citati i
costi necessari per ripristinare la piena funzionalità di una banca centrale nazionale, stampare
la nuova moneta, distribuirla, modificare formalmente i sistemi di pagamento, ecc. Sono oneri
non trascurabili, ma non dissimili da quelli a suo tempo già sostenuti per passare dalle valute
nazionali all’euro. Non rappresentano dunque un problema apprezzabile.
Molto più rilevante una seconda tipologia di costi di transizione, che da sola
rappresenta l’ostacolo principale all’abbandono dell’eurozona. Infatti, appena si diffonderà la
notizia, o anche solo l’aspettativa della notizia, che il Paese sta per abbandonare l’euro,
introducendo una nuova valuta nazionale, chi possiede depositi bancari in euro cercherà di
ritirarli, chi possiede titoli denominati in euro cercherà di venderli e comunque nessuno
comprerà più titoli del debito pubblico in euro che il Paese dovesse emettere. Come sappiamo,
ci si attenderà infatti che tanto i depositi bancari quanto i titoli del debito pubblico siano
convertiti immediatamente in valuta locale, probabilmente con cambio inizialmente alla pari
(un euro per una nuova lira) e poiché la valuta locale si deprezzerà rispetto all’euro, anche il
valore dei depositi bancari o dei titoli del debito ora in nuove lire si deprezzerà. È importante
enfatizzare che tutto questo accadrebbe molto prima dell’effettiva conversione: basta che i
sondaggi indichino la vittoria elettorale per il partito che vuole abbandonare l’euro ed ecco
che nessuno comprerà più titoli del debito del Paese e tutti correranno a ritirare i propri
depositi. Ma poiché le banche non hanno in cassa liquidità sufficiente a restituire tutti i
depositi – ricordiamo che la banca impiega i depositi per concedere prestiti, e quindi ne
mantiene presso di sé solo una minima parte -, fallirebbero per illiquidità se dovessero
restituirli. Questo è ad esempio successo alle banche greche, che pur se virtualmente fallite
con l’insolvenza del 2012 sono state tenute in piedi dai prestiti straordinari di BCE; prestiti
che non sarebbero però concessi a un Paese che dichiarasse (o stesse per dichiarare) di voler
lasciare l’eurozona. Per ovviare al problema è quindi immaginabile una chiusura degli
sportelli bancari per lungo tempo, da effettuarsi non solo molto prima della conversione, ma
molto prima che se ne diffonda l’idea, ossia prima che inizi il run, la corsa agli sportelli; oppure
l’imposizione di un limite rigido quotidiano ai prelievi, come è stato a Cipro e in Grecia,
sempre da attuarsi prima della diffusione dell’idea dell’uscita. E, come a Cipro e in Islanda, al
fine di impedire che i più scaltri tra voi, quelli che sono stati abbastanza rapidi da prelevare i
depositi per tempo, ottengano un guadagno, è necessario il blocco alla esportazione di capitali
per alcuni anni. È facilmente immaginabile l’impatto di una chiusura prolungata delle banche
sull’economia nazionale e sul benessere della popolazione. Ed è altrettanto facilmente
100
immaginabile l’impatto dell’impossibilità di indebitarsi del Governo sulla gestione della cosa
pubblica, con stipendi e pensioni non pagati per lungo tempo. Mentre il blocco della
circolazione dei capitali vuol dire, semplicemente, niente più investimenti diretti esteri, come
è successo in Islanda, con grave danno alla crescita del Paese. E ripeto, tutto questo molto
tempo prima dell’uscita dall’eurozona. Al limite, tutto ciò succederebbe anche se il Paese alla
fine non uscisse: è infatti sufficiente che la gente creda che potrebbe uscire.
È chiaro, si tratta di costi transitori: una volta superata la fase di passaggio, che
potrebbe però essere assai lunga, la situazione si stabilizzerebbe. Con alcuni chiari perdenti:
chi aveva depositi bancari in euro, o titoli del debito pubblico, se li vedrebbe convertiti in una
nuova moneta che varrebbe meno, fors’anche il 30-40% meno. Quindi chi possiede depositi
bancari e titoli di Stato non sarebbe particolarmente contento di una misura che, di fatto,
equivarrebbe alla somma di un default parziale sul debito e un prelievo forzoso sui depositi
bancari.
IX.5.4 L’inflazione e le esportazioni
Anche l’inflazione, se non l’iperinflazione, sarebbe una probabile conseguenza
dell’abbandono dell’euro. Stiamo parlando infatti di Paesi che hanno rilevanti problemi di
bilancia commerciale, ossia che importano relativamente tanto e esportano relativamente
poco. La maggior parte delle importazioni di questi Paesi riguarda prodotti energetici, o
materie prime, o prodotti non producibili dal sistema economico nazionale. Questi beni
devono quindi essere comunque acquistati all’estero, prima dell’uscita come dopo. Se il tasso
di cambio si deprezza, il prezzo di questi prodotti aumenta in proporzione. Ma se aumentano i
prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, lievitano di conseguenza i costi di
produzione delle imprese, e quindi i prezzi dei loro prodotti. Si innescherebbero dunque
fenomeni di inflazione causati da un aumento del prezzo delle materie prime importate.
Secondo molti economisti nel più lungo periodo l’aumento dei costi di produzione, e quindi
dei prezzi, sarà tale da rendere non competitive le nostre esportazioni nonostante il tasso di
cambio deprezzato; saremo cioè costretti, per continuare ad esportare, a deprezzare
nuovamente il tasso di cambio nominale, generando però in questo modo altra inflazione, e
così via. Se va bene, in una situazione simile a quella italiana pre-1985, quando l’effetto
positivo sulle esportazioni di una svalutazione competitiva durava pochi mesi, poi serviva una
nuova svalutazione, e l’inflazione era al 20% all’anno; se invece va male, saremo in una
situazione simile a quella argentina pre-1991, con inflazione al 5.000% all’anno e quindi la
necessità di continue svalutazioni del cambio per restare sui mercati.
Inoltre, non è affatto sicuro che il Paese riprenderà a esportare, dopo il ritorno alla
moneta nazionale. Intanto, alcuni Paesi periferici non hanno un settore esportatore
sufficientemente sviluppato, nel senso che non producono nulla, o producono molto poco che
possa essere esportato. Oppure esportano beni la cui domanda trarrebbe poco vantaggio dalla
riduzione del prezzo. Oppure hanno visto la crisi spazzar via, facendole fallire, molte imprese
esportatrici. In Grecia, ad esempio, durante la crisi gli imprenditori hanno trasferito gran
parte delle loro imprese in Bulgaria, dove il costo del lavoro era inferiore. E, semplificando un
po’, non è certo aumentando le esportazioni di feta, di yogurt o di olive, che la Grecia uscirà
dalla recessione.
IX.5.5 La monetizzazione del deficit e l’inflazione
Con l’abbandono dell’eurozona ci sarebbe però probabilmente una nuova e diversa
fonte di inflazione rispetto a quella causata dall’aumento del prezzo delle materie prime
importate. Infatti, sia se il Paese ha dichiarato default, e dunque non riuscirebbe a finanziarsi
sui mercati perché nessuno si fiderebbe a prestar denaro a uno che non lo restituisce; sia se
non lo ha fatto ma ha convertito in debito in valuta locale e quindi deve pagare interessi
101
elevatissimi se vuole vendere titoli sui mercati internazionali (mentre i residenti non hanno
scelta, devono comprare titoli nazionali, perché il blocco della circolazione dei capitali gli
impedisce di comprare titoli stranieri e l’elevata inflazione gli sconsiglia di tenere moneta
liquida che perderebbe valore), la spesa pubblica può essere finanziata solo vendendo titoli di
Stato alla Banca Centrale. Ma in questo modo, soprattutto se lo fa in misura rilevante, la Banca
Centrale introduce molta liquidità nel sistema, cedendola al Governo in cambio dei titoli. E se
aumenta la liquidità del sistema aumenta anche l’inflazione. D’altro canto, dopo anni di
recessione la tentazione di sostenere la domanda aggregata per migliorare il tenore di vita
della collettività senza subire il ricatto dei mercati sarà fortissimo. Quindi è verosimile che la
nuova Banca Centrale abbia uno statuto molto diverso da quello di ECB, permettendole
l’acquisto dei titoli del debito pubblico sul primario e, soprattutto, ponendola sotto il controllo
dell’esecutivo. Con l’inevitabile conclusione di inflazionare l’economia.
IX.5.6 Allora, perché abbandonare l’eurozona?
Come abbiamo visto, i guadagni che si otterrebbero abbandonando l’eurozona sono
dubbi, o temporanei, o inesistenti, mentre i costi sono certamente elevati inizialmente e assai
incerti, ma probabilmente almeno altrettanto elevati, nel più lungo periodo. Nonostante
questo, non è possibile concludere che abbandonare l’eurozona, sebbene sia eccezionalmente
costoso, non convenga. Infatti, qualora i costi della permanenza divenissero troppo elevati, in
termine di recessione e distruzione di capacità produttiva, anche una scelta così catastrofica
potrebbe divenire l’unica soluzione possibile.
Sapendo però con chiarezza che ci saranno dei perdenti: l’unico modo per mantenere
la competitività internazionale guadagnata col deprezzamento del cambio, in assenza di
riforme strutturali e di investimenti in capitale fisico e umano, consiste infatti nel mantenere
invariati i salari mentre i prezzi salgono. Ossia, nel ridurre il potere di acquisto dei lavoratori,
che pagheranno il prezzo più alto di tutti in ogni caso, sia restando nell’eurozona e applicando
al mercato del lavoro le politiche del rigore, sia uscendo e facendosi distruggere il potere di
acquisto dall’inflazione. Infatti, se i sindacati ottenessero aumenti salariali proporzionali
all’inflazione le imprese avrebbero nuovamente costi salariali troppo alti, perderebbero
competitività internazionale e saremmo punto e da capo. Quindi i lavoratori sicuri perdenti,
assieme a chiunque abbia un conto corrente e chiunque possieda titoli di Stato. Il Governo e le
imprese probabili vincitori. Il Paese, beh, dipende…
Ci si potrebbe a questo punto domandare come mai ci siano stati così pochi problemi
nel passare dalle valute nazionali all’euro, e come mai ce ne sarebbero invece così tanti nel
percorso inverso. Il problema cruciale risiede nel fatto che le divise nazionali, nel passaggio
all’euro scomparivano, mentre l’euro continuerebbe ad esistere, apprezzandosi rispetto alle
valute nazionali e creando i problemi che abbiamo indicato. Comunque, in presenza di
problemi economici sottostanti, il cambio di una valuta non è mai risolutivo, come dimostra il
caso dell’Argentina, che ha sostituito la propria moneta, ha dichiarato default, ma non ha
assolutamente risolto i suoi problemi, e anzi si avvia verso una nuova, grave crisi.
In sintesi, abbandonare l’euro potrebbe essere necessario per recuperare
competitività, ma i costi di un tale abbandono sono così alti da indurre a riflettere assai bene
prima di intraprendere una scelta tanto radicale.
102
PARTE QUINTA
PERCHÉ L’ITALIA NON CE LA FARÀ
103
X. Cosa dovrebbe fare l’Italia e perché non lo farà
X.1 Dall’Europa all’Italia
Nei due capitoli precedenti abbiamo discusso in dettaglio le strategie per combattere la
crisi adottate dalle autorità europee, e le possibili alternative a quelle strategie. Ciascun Paese
presenta poi dei problemi specifici che possono richiedere soluzioni altrettanto specifiche e
rendere più o meno agevole la soluzione della crisi indipendentemente dalle politiche comuni.
È in particolare questo il caso dell’Italia, che come sappiamo dal capitolo V presenta un lungo
elenco di problematiche che, sebbene in parte comuni ad altri Paesi, richiederebbero
interventi puntuali capaci di declinare nei particolari termini nazionali le politiche, ortodosse
od alternative che siano, intraprese in sede europea. Per valutare in dettaglio cosa dovrebbe
fare l’Italia, e discutere della fattibilità pratica di queste strategie, è opportuno partire
dall’elenco di problematiche individuate nel capitolo V e valutare come potrebbero essere
risolte, distinguendo tra problemi di crescita e problemi di domanda aggregata. Esamineremo
quindi l’effettiva praticabilità, tanto economica quanto politica, di queste soluzioni, mostrando
non solo come per metterle in atto serva un disinteressato aiuto europeo che appare assai
complicato ottenere, ma soprattutto come alcune di esse, le più importanti, siano
politicamente impraticabili.
Iniziamo dalla strategie di sostegno della crescita.
X.2 Le strategie per la crescita che dovremmo realizzare e perché non le
realizzeremo
Sappiamo che la crescita dipende dall’Investimento (in capitale fisico, in capitale
umano, in ricerca e sviluppo), e abbiamo individuato, nel capitolo V, una serie di criticità
capaci di impedire, o almeno ridurre fortemente, tanto gli investimenti in Italia dei residenti
quanto gli investimenti diretti esteri. Riprendiamo quindi quell’elenco valutandone punto per
punto la fattibilità nel contesto dei limiti oggettivi, nazionali ed internazionali, cui siamo
sottoposti. Vedremo che i limiti sono di tre tipi: quelli imposti dalle autorità europee, quelli
imposti dai mercati, quelli imposti dalle particolari condizioni politiche ed economiche del
Paese. Partiamo quindi dall’elenco del capitolo V, accorpando però i diversi tipi di
investimento (pubblici, privati, in capitale fisico, in capitale umano, ecc.) per snellire la
trattazione.
1. Ridurre l’eccessivo livello di imposizione fiscale. Facile a dirsi, molto più difficile a farsi.
La riduzione delle imposte, infatti, implica un aumento del deficit di bilancio, cosa che
si scontra tanto con i vincoli del Patto di Stabilità e del Fiscal Compact, quanto con i
mercati che penalizzerebbero l’emissione di titoli di un Paese che fa crescere il suo
debito. Quindi si tratta di una strategia che si potrà intraprendere solo con il sostegno
europeo, ossia con un allentamento dei vincoli imposti ai diversi Paesi o con la
contemporanea riduzione della spesa pubblica, che oltre ad essere altrettanto difficile
a farsi, ridurrebbe la domanda aggregata e aggraverebbe la recessione (tra l’altro, la
nostra spesa pubblica non è superiore a quella degli altri Paesi, quindi ridurla non ha
un gran senso, magari renderla più efficiente). La leggenda del combattere l’evasione
fiscale per ridurre le imposte è, poi, appunto una leggenda, o un po’ di fumo negli occhi
dei creduloni: è infatti assai difficilmente praticabile e ricca di controindicazioni.
Aumenterebbe infatti l’equità del sistema, cosa di per se stessa giusta, ma avrebbe
effetti economici non necessariamente positivi. Dovrebbe infatti essere esplicito il
104
2.
3.
4.
5.
6.
legame con la riduzione delle imposte, perché se cresce il recupero di fiscalità evasa o
elusa, senza che si riducano contestualmente le imposte, si ottiene unicamente un
incremento del prelievo fiscale e un peggioramento della recessione: più pagamenti da
fare allo Stato, meno consumi, meno domanda aggregata, meno produzione, meno
occupazione. Non è infatti importante chi sia a ridurre i propri consumi, se evasori o
persone oneste, quel che è rilevante è il fatto che comunque i consumi diminuiscono.
Ridurre l’eccessivo livello del salario rispetto alla produttività. Per ottenere questo
risultato o si riducono i salari, o si incrementa la produttività. Ridurre i salari presenta
evidenti costi sociali, oltre a impatti negativi sulla domanda aggregata, ed appare
politicamente complicato. Incrementare la produttività richiede investimenti in
formazione, capitale fisico e capitale umano, che si scontrano, ancora e di nuovo, con i
vincoli di finanza pubblica. Liberalizzare il mercato del lavoro rendendo meno difficile i
licenziamenti può contribuire al conseguimento di entrambi gli obiettivi, cioè ridurre i
salari e aumentare la produttività, senza apparenti costi, ed è per questo che
rappresenta la strategia principe di intervento suggerita dall’Europa; ma oltre ad
essere politicamente assai complicata come strategia, senza investimenti serve a poco.
Aumentare il livello dei salari rispetto alla produttività negli altri Paesi.
Alternativamente rispetto al punto 2, potrebbero essere gli altri Paesi nostri
concorrenti ad incrementare i loro salari e/o a ridurre la loro produttività. Il lettore
può giudicare da solo sulla praticabilità di una simile strada, che implicherebbe
l’ammissione, da parte di questi Paesi, Germania in testa, dell’errore passato,
riconoscendolo come concausa della crisi. Una adeguata pressione politica può
certamente contribuire a raggiungere parzialmente l’obiettivo, ma sarebbe comunque
difficile da estendere ai nostri concorrenti extra-europei.
Ridurre la burocrazia. Riforma apparentemente a costo zero, ma in realtà
sostanzialmente impossibile da realizzare per il Paese: la tendenza sembra infatti
quella di introdurre sempre nuove norme per tutelare la salute della collettività,
proteggere la privacy, certificare la non collusione con la mafia delle attività
produttive, attestare che non si inquina l’ambiente, che si tutelano i diritti sindacali,
ecc. ecc. Tutto giusto e legittimo, per carità, ma che implica un incremento della
burocrazia, non una riduzione. Servirebbe un cambiamento di mentalità che in Italia
appare ben lontano dall’essere possibile.
Incrementare la dotazione infrastrutturale. Investimento indispensabile per sostenere
la crescita, presenta però costi ingentissimi. In questo momento, con i vincoli di finanza
pubblica che abbiamo, si tratta di spese insostenibili per il Paese.
Ridurre la rigidità del mercato del lavoro. Passando da un sistema con protezione “on
the job” (sostanziale impossibilità di licenziare) a un sistema con protezione “on the
market” (maggiore libertà di licenziamento e sussidi per i disoccupati) implicherebbe,
inizialmente, un incremento della disoccupazione, perché le imprese si libererebbero
istantaneamente di tutta la forza lavoro della quale non si sono potute liberare prima, e
costi rilevanti per lo Stato che dovrebbe pagare i sussidi. Incremento della
disoccupazione e incremento dei costi dello Stato appaiono, ad oggi, difficilmente
sostenibili politicamente ed economicamente. Per evitare equivoci, può essere
importante rilevare come le riforme del mercato del lavoro realizzate recentemente in
Italia rappresentino solo un timido passo nella direzione necessaria. Nonostante ciò
hanno avuto una grande opposizione. Una radicale riforma del mercato del lavoro
avrebbe dunque una opposizione molto più violenta. Ciò nonostante, l’elevata
disoccupazione ha ridotto grandemente le possibilità di resistenza dei sindacati, e
l’evoluzione futura sarà inevitabilmente caratterizzata da mercati del lavoro più
flessibili (e salari più bassi per i lavoratori a bassi skill).
105
7. Migliorare l’efficienza della giustizia civile. Per ottenerla, servono investimenti
massicci, che si scontrano con i limiti della finanza pubblica; serve maggiore efficienza
del personale, ottenibile con premialità ma anche licenziando i dipendenti pubblici
improduttivi, cosa politicamente difficile; ci si scontra con la lobby degli avvocati, che
sulle lungaggini e le complessità dell’amministrazione della giustizia fondano il loro
reddito.
8. Ridurre la conflittualità sindacale. In parte questo è già stato ottenuto con la
recessione, che ha generato disoccupazione di massa e dunque riduzione del potere dei
sindacati. Ciò che sarebbe necessario, però, è un cambiamento radicale della
contrattazione sindacale, che dovrebbe passare a livello decentrato per garantire una
maggior attenzione dei lavoratori agli interessi dell’azienda nella quale lavorano.
Qualche timido passo in questa direzione si sta compiendo, ed altri inevitabilmente ne
seguiranno.
9. Semplificare il finanziamento bancario e ridurne il costo. Servirebbero banche più
attente a premiare la bontà dei progetti di investimento e meno la disponibilità di
garanzie reali. La direzione in cui ci si sta muovendo è invece opposta, condizionata
dalla circostanza che la bolla statunitense, così come quella islandese e irlandese, è
stata causata da eccessiva liberalizzazione dei mercati. Le banche del nostro paese,
però, hanno sempre prestato con estrema riluttanza, e solo a chi aveva solide garanzie:
non è un caso che in Italia la bolla non ci sia stata. Un po’ di maggiore aggressività
creditizia sarebbe auspicabile. Ma capovolgere il combinato disposto delle nuove, più
rigide, regole europee e della naturale attitudine dei banchieri italiani, assai prudenti e
poco innovativi, è sostanzialmente impossibile.
10. Incrementare il ruolo del mercato borsistico. A questo fine servirebbero leggi che
premiano il risparmio e il suo investimento in borsa. In Italia la tassazione sul
risparmio sta però aumentando sensibilmente e non riducendosi, disincentivandolo.
Anche l’idea di favorire la creazione di Fondi pensionistici privati da affiancare alla
tradizionale pensione pubblica, che avrebbe rafforzato i Fondi e quindi incentivato il
loro convogliare le risorse accumulate verso la borsa, si è scontrata con un progressivo
incremento di tassazione e con una scarsa percezione dell’utilità di una pensione
integrativa per gli italiani, che ancora non hanno capito come, con la riforma
pensionistica, l’entità delle loro pensioni si ridurrà di quasi il 50%. Servirebbe quindi
un cambiamento di mentalità e di politiche che andasse nella direzione opposta
rispetto a quella in cui si sta andando. E invertire la rotta è sempre complicato.
11. Ridurre la criminalità e la corruzione. Servono investimenti massicci nelle forze
dell’ordine, che si scontrano contro i vincoli di finanza pubblica. Inoltre, servirebbe un
cambiamento di mentalità, coerente con la “teoria delle finestre rotte”, secondo la
quale anche un piccolo elemento di degrado (appunto, una finestra rotta) finisce
coll’attirare ulteriore degrado, criminalità, connivenza. Gli italiani dovrebbero quindi
combattere anche i piccoli episodi di illegalità, dal parcheggio in doppia fila ai venditori
ambulanti senza autorizzazione che non pagano le imposte. Sembra difficile.
12. Riformare la riforma dualistica del mercato del lavoro. Le riforme Treu e Biagi sono
passate da un po’, lì c’è poco da fare… sul mercato del lavoro futuro valgono comunque
le considerazioni del punto 6. E rimane la dannosissima interazione tra abbassamento
dei salari e scarso investimento in capitale e tecnologia.
13. Incrementare la concorrenzialità dei mercati. Introdurre regole a favore della
concorrenza implica abbattere i prezzi, favorire i consumatori e rilanciare la crescita
ma anche colpire determinate categorie sociali: i supermercati e i centri commerciali
contribuiscono ad abbattere i prezzi, riducendo il ruolo degli intermediari e sfruttando
le economie di scala, ma portano alla chiusura dei piccoli e inefficienti esercizi a
106
gestione familiare; l’abolizione delle barriere protezionistiche esterne implica la
possibilità di acquistare prodotti agricoli a più basso prezzo all’estero, quindi ancora
incrementando il benessere dei consumatori, ma danneggia gli agricoltori italiani;
liberalizzare le licenze per i taxi riduce i prezzi del servizio ma provoca perdite
importanti nei tassisti; e così via. Le (più o meno legittime) opposizioni delle singole
categorie all’incremento del benessere complessivo dei consumatori sono violente, e
spesso hanno facile presa perché ammantate di tematiche etiche (difendiamo le
famiglie dei piccoli negozi a gestione familiare, difendiamoci dai cibi di bassa qualità
provenienti dall’estero, iniziamo colpendo i grandi e non i piccoli…). Sinora queste
categorie sono riuscite a impedire la totale liberalizzazione dei mercati, che sarebbe
positiva per i consumatori ma dolorosa per le singole categorie. Non sembra che
queste opposizioni possano effettivamente essere superate in futuro, se non in minima
parte.
14. Incrementare la tutela della proprietà intellettuale. Apparentemente di facile
attuazione, è una delle riforme più difficili da realizzare: richiede l’efficienza della
giustizia nel sanzionare la violazione della proprietà intellettuale, ma anche e
soprattutto la modifica della mentalità della popolazione che è abituata a considerare
accettabile fotocopiare un libro, scaricare illegalmente musica, acquistare borse e capi
di abbigliamento contraffatti. Prima di annoverarle tra le cose fattibili, domandatevi se
avete mai commesso uno dei reati appena descritti (perché si tratta di reati). Se
ritenete si tratti di infrazioni minime, tornate al punto 11 e alla teoria delle finestre
rotte.
15. Incrementare il livello di istruzione e di formazione professionale della popolazione. La
chiave di volta della crescita futura. Richiede però l’incremento massiccio della spesa
per l’istruzione, che si scontra con i noti limiti di finanza pubblica, ma richiede anche
l’introduzione di un atteggiamento competitivo nei discenti (tipo: sono promossi i 20
alunni sui 30 componenti la classe che prendono il voto più alto, non quelli che
raggiungono la sufficienza) e una identica selezione qualitativa dei docenti. Non
sembra coerente con i desiderata profondi della popolazione.
16. Migliorare la qualità dei docenti. Per farlo è necessario rendere più attraente,
economicamente ma anche socialmente, la figura dei docenti, ossia pagarli molto di
più. Il che si scontra con gli usuali vincoli finanziari pubblici (e l’istruzione privata non
può sopperire, perché attualmente serve altri scopi: in molti casi infatti è
essenzialmente dedita al recupero degli studenti meno dotati). Fatto questo, è
necessario effettuare una selezione meritocratica, sottoponendoli al giudizio dei
discenti, valutandoli sulla base dei risultati di apprendimento conseguiti e licenziando
o penalizzando economicamente i non meritevoli. Crediamo non sia necessario
rimarcare la difficoltà della cosa.
17. Migliorare la formazione scientifica. Richiede la volontà politica (e culturale) di
sottrarre spazio ad altre materie che “aprono la mente” e “migliorano la nostra cultura”
ma non incrementano la nostra produttività. Difficile da realizzarsi nel breve termine,
anche per la prevalenza di diplomati e laureati nelle discipline letterarie nelle classi
dirigenti attuali.
18. Incrementare la conoscenza delle lingue straniere. Implica costi elevati, perché i
docenti preparati semplicemente non esistono, e anch’essa si può realizzare solo
sottraendo spazio alle materie che “aprono la mente”. Si veda quindi il punto
precedente.
19. Incrementare lo skill premium. Molto complicato, in un Paese che vede l’affermarsi di
pulsioni populistiche volte a ridurre anziché incrementare i differenziali salariali. Si
veda comunque il punto successivo.
107
20. Incrementare la meritocrazia. Molto complicato, perché esiste un problema di
consenso: in un Paese in cui la maggior parte della popolazione ha bassi skill e occupa
la posizione che occupa per amicizie o peggio, da chi arriverebbe il consenso per una
simile riforma? Dai pochi che hanno alti skill? Non basta.
21. Ridurre la rilevanza, o addirittura eliminare, le barriere culturali, normative, politiche.
Necessita un cambiamento di mentalità della popolazione, perché attualmente è
rilevantissima e in crescita l’influenza delle lobby degli ambientalisti (che impediscono
la costruzione di oleodotti, le prospezioni petrolifere, il fracking, l’energia nucleare,
ecc.), degli animalisti (che si oppongono alla ricerca scientifica con sperimentazione
animale), dei difensori di costumi morigerati (che si oppongo all’apertura di resort
nudisti), dei conservatori antiscientifici (che si oppongono agli OGM), ecc..
Indipendentemente da cosa ciascuno di noi pensa di queste tematiche, sono tutti
elementi che ostacolano la crescita del Paese.
22. Ridurre il costo dell’energia. Ridurre il costo dell’energia ridurrebbe i costi di
produzione per le imprese e incrementerebbe la loro produttività, ma si scontra con la
carenza di fonti energetiche nel Paese e l’opposizione ambientalista nei confronti di
tecnologie come il fracking e l’energia nucleare (a volte anche contro le pale eoliche,
che deturpano il paesaggio…).
23. Incrementare la dimensione delle imprese. Serve cambiare la mentalità degli
imprenditori, che temono di perdere il controllo delle proprie aziende se divengono
troppo grandi; rendere più facile e meno costoso il finanziamento bancario degli
investimenti; eliminare la ormai solo simbolica (ma i simboli hanno un peso)
distinzione normativa in termini di licenziamenti tra imprese con più e meno di 15
dipendenti; favorire il finanziamento di borsa. Tutte cose assai complicate e in parte
già discusse nei diversi punti precedenti.
24. Ripristinare/potenziare il ruolo dei distretti industriali. Fermo restando che i distretti
non bastano per la crescita del Paese, e servono anche imprese di grandi dimensioni,
potrebbe essere innanzitutto opportuno ripristinare la dotazione di capitale sociale
distrettuale, facendo una grande attenzione a come si modifica il tessuto sociale ed
anche etnico locale: si tratta naturalmente di una strategia di retroguardia, assai
lontana dall’apertura che contraddistingue la globalizzazione dei mercati, ma è la
stessa struttura distrettuale ad essere di retroguardia. È poi necessario un importante
sostegno pubblico, che ovvi con iniezioni di tecnologia e formazione ai limiti
dimensionali del distretto.
25. Smettere di contrastare la globalizzazione. Il problema qui è culturale, quindi quasi
irresolubile: gli italiani devono rendersi conto che con la globalizzazione il mondo è
cambiato, e che non tornerà mai più come prima (anzi, potrebbe cambiare ancora…). A
quel punto sarà più facile accettare i dlorosi cambiamenti che ciò implica.
26. Ridurre l’indebitamento pubblico. Più correttamente, si dovrebbe dire ridurre il
rapporto debito/PIL, ossia ridurre il debito e/o aumentare il PIL. Le politiche di
riduzione del debito, sinora, si sono rivelate fallimentari, ed anzi controproducenti,
perché i tagli di spesa, come sappiamo, hanno acuito la recessione e incrementato
invece di ridurlo il deficit di bilancio; le politiche di crescita sono ferma al palo, e i loro
limiti li stiamo vedendo adesso; le politiche per far crescere il PIL in termini nominali,
ossia grazie all’inflazione, in passato sono state addirittura osteggiate dalla ECB (siamo
stati persino in deflazione, quindi il PIL nominale si riduceva invece di crescere…).
Potremmo ripiegare sull’imposta patrimoniale, cosa che probabilmente sarà comunque
inevitabile ma presenta forti controindicazioni, tanto per cambiare. Un’imposta
patrimoniale infatti, realizzata per importi elevati, una tantum e non ripetuta, avrebbe
probabilmente effetti recessivi limitati e ridurrebbe significativamente il debito
108
pubblico. Prima di entusiasmarci, però, è opportuno anche andare a verificare quale sia
la ricchezza effettivamente tassabile. Scopriremmo infatti che la ricchezza finanziaria
liquida delle famiglie, ossia quella facilmente espropriabile, ammonta a poco più di
1.000 miliardi di euro: una cifra importante, ma non risolutiva. Inoltre, non illudiamoci
che sia sufficiente tassare i super ricchi, che sono pochi e con la ricchezza ormai da
tempo all’estero: per ottenere effetti significativi sul debito la base imponibile
dovrebbe essere ampia, arrivando a tassare anche i piccoli e piccolissimi patrimoni, e
soprattutto dovrebbe colpire ciò che non è nascondibile. In altri termini, un’imposta
patrimoniale, in Italia, colpirebbe immobili e titoli. Una sorta di super-IMU, insomma.
Dopo tutto, l’IMU è tecnicamente proprio un’imposta patrimoniale. Una simile tassa,
infine, avrebbe un gettito elevato, ma si parla comunque di 100-150 miliardi, cioè
meno di un decimo del nostro debito, e se sui quattro spicci dell’IMU c’è chi si è quasi
giocato le elezioni, figuriamoci la super-IMU! Stesso discorso per le dismissioni di
patrimonio pubblico. Non ne resta più tantissimo, e la maggior parte di esso a qualcosa
serve, ragion per cui prima dovremmo dismetterlo e poi affittarlo dai privati,
spendendo in genere di più (gli esempi di questo tipo si sprecano). Inoltre, non è certo
questo il momento più adatto per vendere, poiché sul mercato non troveremmo
compratori generosi, e come sappiamo se proviamo a venderlo tutto insieme aumenta
l’offerta, e il prezzo si riduce.
27. Eliminare o ridurre i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità, dal Fiscal Compact o dalle
altre normative europee. Implica convincere la Germania (buona fortuna!), o uscire
dall’eurozona (con tutti i problemi che, come abbiamo visto, questo causerebbe).
Difficile che l’Italia ci riesca.
28. Incrementare l’investimento in capitale fisico delle imprese pubbliche. Anche questo si
scontra con i vincoli di bilancio del settore pubblico, e con la ormai diffusa tendenza a
liberalizzare e privatizzare. È un’ottima cosa che le imprese private investano al posto
delle pubbliche, ma è masochista tagliare gli investimenti pubblici quando anche quelli
privati sono crollati.
29. Affrontare i problemi del Mezzogiorno d’Italia. Non con l’intervento pubblico diretto,
che si è rivelato fallimentare. Come, allora? Non è questa la sede per fornire ricette
vincenti, visto che in un secolo e mezzo non si è riusciti ad affrontare il problema. Pur
rischiando l’impopolarità, vorrei solo sussurrare che forse la mobilità territoriale,
quella stessa mobilità territoriale che ci ha dato il Miracolo Economico degli anni
cinquanta e sostiene la crescita statunitense, andrebbe incoraggiata e non scoraggiata:
l’emigrazione deve perdere la connotazione negativa, legata ad una obsoleta
concezione della famiglia e della territorialità, ed essere vista come un’opportunità.
Anche qui, però, si predica nel deserto.
30. Incrementare gli investimenti diretti esteri. Facile a dirsi, impossibile a farsi: implica
risolvere la maggior parte dei punti indicati qui, che valgono per gli investimenti in
generale e dunque anche per quelli esteri, dal livello eccessivo delle imposte
all’inefficienza della giustizia civile, passando per l’eccessiva burocrazia, la qualità dei
trasporti e il costo dell’energia.
31. Investire pesantemente in ricerca e sviluppo e formazione. L’Unica possibilità per
recuperare il nostro ritardo tecnologico è investire pesantemente in ricerca e sviluppo
e formazione, in modo da incrementare sia la produttività del lavoro sia la qualità dei
prodotti. Ma andava fatto prima, adesso probabilmente è troppo tardi. Inoltre, gli
ostacoli all’investimento in ricerca, sviluppo e formazione sono gli stessi che valgono
per gli investimenti in generale, ossia i punti da 1 a 28…
109
Così come è sterminato l’elenco dei problemi, è altrettanto sterminato l’elenco degli
ostacoli alla possibilità di risolverli. A ben vedere, questa è la principale criticità: i problemi
sono troppi. Un programma effettivo di riforme richiederebbe un cambiamento radicale di
mentalità e un enorme impiego di risorse, due cose che non siamo in grado di ottenere.
Inoltre, le riforme dal lato dell’offerta, fatte per sostenere la crescita di lungo periodo, sono
spesso dolorose nel breve periodo, quindi politicamente poco praticabili per un governo che
voglia essere rieletto. Non è sorprendente che i Paesi centrali dell’eurozona abbiano pensato
che per cambiare la mentalità dei Paesi periferici e indurli a porre in essere le necessarie
riforme fosse necessario un forte shock; molto più discutibile la possibilità di realizzare
queste importanti riforme senza il supporto di adeguati finanziamenti, pubblici o privati che
siano.
X.3 Le strategie per sostenere la domanda aggregata e perché, pur volendo,
non le metteremo in atto. O forse sì…
Le difficoltà politiche e l’impatto sociale negativo spariscono se passiamo dalle
politiche atte a sostenere l’offerta aggregata, e quindi la crescita di lungo periodo, a quelle atte
a sostenere la domanda aggregata. Anche se con una rilevante eccezione i vincoli, in questo
caso, pur con una rilevante eccezione non sono politici, ma essenzialmente di bilancio
pubblico, o esterni, attinenti alle normative europee. Vediamoli partitamente, suddividendoli
nei quattro aggregati che compongono la domanda: consumi, investimenti, spesa pubblica ed
esportazioni nette.
X.3.1 I consumi
Poiché i consumi dipendono dal reddito disponibile e dalle aspettative per il futuro, il
loro incremento passa per un miglioramento delle aspettative per il futuro e/o da un
incremento del reddito disponibile.
Il miglioramento delle aspettative si può ottenere migliorando le prospettive di
crescita del Paese, ossia intraprendendo le difficili riforme indicate nella sezione X.2; oppure
garantendo un incremento della spesa pubblica (ma con quali soldi?) e del reddito nazionale
(magari!) in futuro; o riducendo l’indebitamento, e dunque rendendo plausibile una riduzione
delle imposte future. Mi pare evidente che si tratti di eventi molto complicati da realizzare e,
nel complesso, altamente improbabili.
L’incremento del reddito disponibile, invece, si può ottenere riducendo le imposte sul
reddito e/o incrementando il reddito. La prima strategia è complicata da ottenere in un
contesto di forte deficit di bilancio ed elevato indebitamento pubblico: ce ne siamo già
occupati. La seconda strategia coincide col suo risultato: se vogliamo ottenere un aumento del
reddito nazionale attraverso un incremento dei consumi dobbiamo evidentemente
incrementare i consumi, ma per farlo serve proprio un incremento del reddito… Beh, ci
troviamo in una circolarità che non ci porta da nessuna parte.
Iniziative come sussidi ad alcune classi reddituali (gli 80 euro elargiti dal Governo
Renzi nel 2014) possono avere successo se destinate alle classi reddituali che spendono quote
elevate del proprio reddito e risparmiano poco, ossia quelle con maggiore propensione al
consumo, in genere i più poveri; ma soprattutto se nel contempo non vengono elevate altre
imposte che riducono il reddito disponibile e se non ci si aspetta un loro incremento in futuro,
perché altrimenti il maggior reddito disponibile finisce in risparmi precauzionali e non in
consumi. Cosa accaduta appunto in Italia con gli 80 euro.
È quindi assai improbabile contare su un aumento dei consumi come strumento per far
crescere la domanda aggregata.
110
X.3.2 Gli investimenti
La seconda strada per sostenere la domanda aggregata sono gli investimenti privati,
effettuati da residenti e da non residenti.
Dimentichiamoci subito gli IDE: conosciamo i motivi per i quali non vengono effettuati,
e le irrealizzabili soluzioni per ovviare alla loro carenza sono state indicate nel lungo elenco
della sezione X.2.
Discorso analogo per gli investimenti dei residenti. Anche ammettendo che, per motivi
incomprensibili, gli imprenditori dovessero investire proprio nel nostro Paese e non altrove,
dove magari il costo del lavoro e le imposte sono più bassi, servono aspettative positive sulla
crescita della domanda in futuro e un elevato credito bancario a bassi tassi. I bassi tassi ci
sono, il resto no: le imprese hanno difficoltà a finanziarsi in banca a causa del credit crunch,
mentre il mercato borsistico in Italia non funziona, le aspettative su una ripresa della
domanda nazionale futura sarebbero assai poco realistiche e prospettive di vendita all’estero
delle maggiori produzioni derivanti dagli investimenti (dove pure la domanda non è così
vivace come servirebbe) non ci sono a causa degli alti costi di produzione che si troverebbero
a fronteggiare nel nostro Paese.
Quindi, a meno che non si risolvano la maggior parte dei problemi indicati nella
sezione X.2, anche dagli investimenti c’è poco da aspettarsi.
X.3.4 La spesa pubblica
In situazioni critiche come quella attuale, con bassi consumi e ancor più bassa tendenza
all’investimento privato, tocca in genere alla spesa pubblica sostenere la domanda aggregata.
L’intervento pubblico non solo sosterrebbe direttamente il reddito, ma migliorerebbe le
aspettative per il futuro, incrementando consumi e investimenti privati: infatti un maggiore
reddito corrente e la prospettiva che il Governo sosterrà nel tempo la domanda aggregata
porta i consumatori a ridurre il risparmio precauzionale e quindi aumentare i consumi, e
porta gli investitori a realizzare investimenti per soddisfare la maggior domanda futura attesa
di beni di consumo.
Bene, tutto questo in Italia non si può più fare: in passato lo abbiamo fatto spesso e
siamo troppo indebitati per farlo ancora, almeno sistematicamente. A meno che,
naturalmente, non otteniamo la possibilità di eccedere i limiti del deficit di bilancio sanciti dal
Patto di Stabilità e dal Fiscal Compact, mantenendo nel contempo la clemenza dei mercati che
dovrebbero continuare a credere nella nostra solvibilità e dunque continuare a prestarci
denaro a bassi tassi; oppure che abbandoniamo l’eurozona e, miracolosamente, continuiamo
ad avere la fiducia dei mercati, che ci permetterebbero ancora di indebitarci; oppure, ancora,
che usciamo dall’Eurozona, facciamo spesa pubblica espansiva e la finanziamo vendendo titoli
alla banca centrale senza (miracolosamente!) scatenare una inflazione elevatissima. Tutto
molto bello, almeno nel breve periodo, ma tutto concretamente irrealizzabile.
Resta un’altra opzione. La spesa dello Stato potrebbe essere rimodulata, tagliando
quella indirizzata a trasferimenti (pensioni, sussidi di disoccupazione, sussidi alle imprese) e
destinando la parte risparmiata a investimenti pubblici. L’effetto sarebbe lievemente
espansivo, perché il denaro sottratto a pensioni e sussidi sarebbe stato in parte risparmiato,
mentre il Governo lo spende tutto, e si sosterrebbe anche la crescita. Ma la strategia di tagliare
i sussidi ai più bisognosi in un momento di crisi, oltre ad essere palesemente iniqua, sarebbe
politicamente poco difendibile e, soprattutto, avrebbe un impatto minimo (dopo tutto, lo Stato
spende di più, ma i privati ai quali ho tolto il sussidio spendono di meno…).
Quindi, anche per questa via è difficile poter sostenere la domanda aggregata.
111
X.3.4 Le esportazioni (nette)
L’ultima strada per sostenere la domanda aggregata passa per l’incremento delle
esportazioni nette. Un incremento che richiede l’aumento della competitività delle nostre
esportazioni, producendo beni diversi, con maggiore qualità o minori prezzi, oppure
l’incremento del reddito e della domanda mondiale di beni, in modo che aumenti anche la
domanda dei beni prodotti dal nostro Paese. In realtà c’è una terza strada, meno virtuosa:
poiché le esportazioni nette sono la differenza tra esportazioni e importazioni, per
incrementarle può anche bastare ridurre le importazioni, cosa che avviene spontaneamente
quando un Paese è in crisi e consuma di meno anche dei beni importati. Fare la fame non è
però in generale una grande strategia…
La domanda mondiale, naturalmente, non dipende da noi. Dipende però dalle scelte
degli altri Paesi e delle Banche Centrali, Banca Centrale Europea in testa. Infatti se ad esempio
la Germania si imbarcasse in politiche di spesa pubblica fortemente espansiva, o la ECB
realizzasse le massicce politiche di Quantitative Easing annunciate, la domanda aggregata e il
reddito estero crescerebbero, aumentando anche la domanda di beni di produzione nazionale.
Quindi non dobbiamo semplicemente sperare e aspettare, ma provare a modificare la politica
restrittiva delle istituzioni europee può aiutarci sul serio.
Per quanto invece riguarda la competitività delle nostre esportazioni, torniamo sulle
usuali problematiche viste nella sezione X.2: sarebbe necessario, per ridurne i prezzi, ridurre i
salari, ridurre l’imposizione fiscale sulle imprese, ridurre i costi di trasporto… oppure
aumentare la produttività del lavoro, ma anche la qualità dei prodotti. Tutte circostanze che
richiedono riforme radicali difficilmente proponibili e, soprattutto, e ancora, investimenti.
Che, per i motivi detti, sono complicati da realizzare.
X.4 Riassumendo: la soluzione c’è, ma non dipende (solo) da noi
L’analisi sin qui svolta in merito alla situazione italiana può, con un po’ di inevitabile
semplificazione, essere riassunta nei seguenti punti: 1) l’elenco dei nostri problemi è lungo e
complesso, ed è impossibile identificare una singola riforma come prioritaria, il che rende la
soluzione assai complicata da realizzare, costosa e realizzabile solo in tempi lunghi; 2)
l’elevato livello del debito pubblico non è un problema rilevante in sé, ma costituisce un
ostacolo difficilmente sormontabile per la realizzazione delle necessarie strategie di crescita e
sostegno alla domanda aggregata; 3) l’assetto istituzionale italiano, fatto di regole scritte e
non scritte, cultura, mentalità, preparazione della classe politica, comportamenti sindacali,
livello di istruzione della popolazione, religione, sensibilità alle tematiche ecologiche, ecc.,
rappresenta un formidabile ostacolo ai cambiamenti necessari, che in molti casi appaiono
dunque politicamente improponibili; 4) un imprescindibile contributo alla soluzione dei
nostri problemi dovrebbe venire dall’esterno, con allentamenti dei vincoli europei,
finanziamento massiccio di investimenti infrastrutturali, sostegno alla domanda aggregata da
parte dei nostri partener europei e da ECB… ma la sfiducia di queste istituzioni nella nostra
capacità (nonché in quella degli altri Paesi deboli dell’Eurozona) di modificare il nostro
assetto istituzionale e realizzare le necessarie riforme impedisce questo fondamentale
contributo. Se vi diamo i soldi, è il refrain europeo, siamo sicuri che li spenderete per
incrementare l’efficienza del vostro sistema produttivo? O non piuttosto in spese
improduttive e politicamente più paganti, come avete fatto sinora? Poi, naturalmente, i singoli
Paesi europei fanno anche i loro interessi, quindi non aspettiamoci aiuto disinteressato.
La soluzione, in realtà, esiste. Sono gli investimenti. Massicci investimenti
infrastrutturali, in tecnologia, in formazione, in ricerca e sviluppo, nei Paesi periferici
112
finanziati con project bond europei, ossia con fondi reperiti sul mercato ma garantiti
dall’Unione; investimenti indicati dai singoli Paesi ma approvati dalle autorità europee, per
impedire che si spacci per un investimento in formazione il viaggio “di studio” a Formentera;
investimenti che da un lato sostengono la domanda aggregata e dall’altro costruiscono le basi
per la crescita di lungo periodo dei Paesi periferici dell’Unione; investimenti preceduti da
“vere” riforme, anche quelle politicamente dolorose; investimenti però anche accompagnati
da maggiore flessibilità di bilancio, perché se ad es. introduco la libertà di licenziare mi
servono i sussidi di disoccupazione, che costano; investimenti soprattutto destinati ai Paesi
periferici, ma garantiti da tutti (nel senso che il finanziamento è sul mercato, con titoli
acquistati dai privati, ma la garanzia è necessariamente di tutti i Paesi europei). Se poi i Paesi
del Nord Europa, tipicamente la Germania, aumentassero i loro salari e la loro spesa pubblica,
riducendo la competitività delle loro produzioni e incrementando la loro domanda aggregata,
e quindi riducendo le loro esportazioni ed incrementando le loro importazioni, ossia le nostre
esportazioni, beh, meglio ancora!
Ma siamo veramente pronti a tutto ciò? Noi a cambiare la nostra mentalità, loro a
cambiare la loro? Ad accettare licenziamenti senza regole anche se con il sussidio, le
prospezioni petrolifere nel Mediterraneo, gli OGM, l’energia nucleare, il passaggio del
trasporto merci dalla gomma al ferro, la contrattazione sindacale ridotta a livello aziendale, la
riduzione dei diritti, l’incremento dell’orario di lavoro, la licenziabilità dei dipendenti pubblici
(con le inevitabili ingiustizie che ne conseguirebbero), l’inceneritore vicino casa, il campo
nudista nella spiaggia che frequentiamo, le imposte ridotte per le multinazionali che si
installano nel Paese, la chiusura dei licei classici e di molte facoltà umanistiche, il fracking?
Siamo veramente pronti a tutti questi cambiamenti, o anche solo ad alcuni di essi (molti,
altrimenti servono a poco)? E i tedeschi sono pronti a garantire per investimenti fatti in Italia
e non in Germania, fidandosi di noi? Voi vi fidereste?
Alla fine, il problema è questo: da soli, non ce la possiamo fare. Ma oltre a non essere
affatto scontato che gli altri partner europei ci aiuteranno, non è neppure così scontato che
siamo effettivamente pronti a fare ciò che dobbiamo fare noi. Se fossimo effettivamente
pronti, si tratterebbe solo di convincere gli altri. Difficile, ma possibile (non probabile, solo
possibile). Se invece non siamo pronti, sarà pressoché impossibile convincere i nostri partner
europei e, anche qualora ci riuscissimo, non servirebbe comunque a nulla.
XI. Sommario, e conclusioni: perché l’Italia non ce la farà?
113
Nei capitoli precedenti abbiamo visto come la crisi del 2007, per quanto grave in se
stessa, abbia avuto anche l’effetto collaterale di far detonare una serie di problematiche da
lungo tempo presenti nell’Unione Monetaria Europea. I Paesi dell’Eurozona infatti, pur
condividendo un’unica moneta, e dunque una Banca Centrale comune e un’unica politica
monetaria, sono profondamente diversi tra loro, e non possiedono neppure le caratteristiche
di mobilità dei fattori produttivi e flessibilità di prezzi e salari che ne farebbero un’Area
Valutaria Ottima. Non è affatto sorprendente che queste profonde differenze abbiano portato
all’accumularsi di tensioni economiche che i singoli Paesi non hanno più potuto compensare
una volta persa la flessibilità del tasso di cambio e lì indipendenza di politica monetaria. In
questo consiste, secondo alcuni, il cosiddetto “shock da euro” che avrebbe complito i Paesi
periferici dell’Eurozona.
Paesi che, è opportuno ricordarlo, erano già stati colpiti da un altro shock, lo “shock da
globalizzazione”, con l’improvvisa comparsa sui mercati internazionali di nuovi agguerriti
concorrenti, rappresentati da Paesi emergenti operanti nei loro stessi settori merceologici ma
con costi del lavoro e vincoli normativi enormemente più bassi, capaci inoltre di attirare una
massiccia delocalizzazione produttiva. I più lungimiranti hanno fronteggiato questa
improvvisa nuova concorrenza riducendo i salari, aumentando (in genere però poco) la
produttività del lavoro grazie agli investimenti in nuove tecnologie ma soprattutto puntando
decisamente a divenire quasi monopolisti su alcune produzioni di qualità e su alcune
eccellenze: Audi, BMW, Mercedes, Porsche sono solo degli esempi di come la diversificazione
merceologica abbia permesso a questi Paesi di cavalcare senza particolari problemi il
fenomeno della globalizzazione. Mentre i meno lungimiranti non si sono resi conto, o non
hanno voluto rendersi conto, di come il mondo fosse improvvisamente cambiato, e invece di
puntare sull’incremento di produttività, sulla tecnologia e sulla formazione, hanno preferito
difendere il loro tenore di vita presente a spese delle generazioni future. Infatti per un po’ i
Paesi periferici dell’Eurozona hanno vissuto al di sopra delle loro effettive possibilità, sia
recuperando con le svalutazioni competitive la competitività che stavano perdendo, sia
finanziando il benessere con l’indebitamento pubblico o privato e dunque spendendo denaro
che le generazioni successive sarebbero state costrette a restituire. Entrati nell’Eurozona e
perso lo strumento del cambio, sono passati al solo indebitamento pubblico o privato per
sostenere la domanda aggregata. Il che avrebbe anche avuto un senso se queste spese fossero
state almeno in parte destinate agli investimenti per sostenere la crescita futura: la crescita
avrebbe infatti permesso di ripagare il debito, o almeno di non trovarsi a doverne contrarre
altro per mantenere il tenore di vita acquisito. E invece la maggior parte delle spese non sono
state finalizzate all’investimento produttivo, ma al benessere corrente della popolazioni:
trattamenti pensionistici generosi e soprattutto non correlati ai contributi versati, un settore
pubblico ipertrofico utilizzato come dispensatore di reddito, crescenti e sempre più costose
prestazioni di welfare, l’illusione che anche i più poveri potessero permettersi case di
proprietà o potessero arricchirsi con la speculazione finanziaria… tutto ciò ha in varia misura
interessato il mondo intero, ma massicciamente solo i Paesi del debito e i Paesi delle bolla,
mentre gli altri si sono prima o poi, per scelta o per caratteristiche della propria economia,
tirati fuori dall’illusione, accettando di vedere il mondo com’era e di competere. Poi, non è
detto che la competizione abbia avuto successo, e parecchi Paesi non del debito e non della
bolla hanno fatto scelte comunque poco congruenti o di scarso successo, ma senza dubbio i
meno lungimiranti sono stati i più colpiti. Così, quando la crisi è arrivata, c’è stato un brusco
risveglio e si è cercato di correre ai ripari. Ma per qualcuno è stato troppo tardi, perché il
sistema produttivo era ormai compromesso, l’indebitamento fuori controllo, la popolazione
114
ormai assuefatta a vivere bene grazie alla spesa pubblica e non intenzionata a cambiare i suoi
comportamenti.
Tra tutti i Paesi che hanno vissuto al di sopra delle proprie possibilità un posto
preminente spetta all’Italia, che vantava il secondo settore manifatturiero dell’Eurozona e
tassi di crescita del PIL, nel secondo dopoguerra, elevatissimi. Siamo stati infatti tra i primi a
puntare con decisione sulla spesa pubblica finanziata in deficit per mantenere il da poco
acquisito benessere, coltivando l’illusione di poter continuare a crescere agli stessi tassi del
passato e dunque di poter sostenere senza problemi il maggior debito. E invece il mondo stava
cambiando, e non abbiamo voluto vederlo. Ancor oggi in molti non si vogliono rendere conto
che la globalizzazione ha cambiato tutto.
Improvvisamente ci siamo accorti che il Paese non cresceva più, che la produttività
stagnava, che i salari erano cresciuti troppo rispetto a quelli dei nostri concorrenti e rispetto
alla produttività dl lavoro, danneggiando gravemente le nostre esportazioni, che eravamo
specializzati proprio negli stessi settori merceologici nei quali erano specializzati i nostri
nuovi e aggressivi concorrenti, con ulteriori problemi per le esportazioni, che l’ingresso nella
moneta unica ci aveva precluso lo strumento della svalutazione competitiva e fortemente
limitato il ricorso alla spesa pubblica espansiva, che il debito stava andando fuori controllo e
costituiva un nuovo limite alla spesa, ecc. Un osservatore disinteressato si sarebbe a questo
punto reso conto che l’elenco dei problemi da fronteggiare era sterminato, e che la loro
soluzione richiedeva due cose: investimenti massicci, tanto pubblici quanto privati, in settori
cruciali della nostra economia, come infrastrutture, formazione, tecnologia; e un cambio
radicale di mentalità, con la presa di coscienza che il mondo era cambiato e che il tenore di
vita che sino a quel momento avevamo considerato come a noi dovuto ora dovevamo
conquistarcelo, senza poterlo neppure chiedere più al Governo.
Dalla consapevolezza di queste problematiche discende l’idea proposta in questo libro,
ossia che l’Italia non possa farcela, sia con riferimento agli investimenti sia con riferimento al
cambiamento di mentalità.
Con riferimento agli investimenti, l’elenco degli interventi da realizzare è sterminato, e
impegnerebbe una quantità di risorse tale da portare il deficit di bilancio al di sopra dei
parametri europei per almeno un decennio. Oltre ad essere incompatibile con il Patto di
Stabilità ed il Fiscal Compact si scontrerebbe anche con la possibile opposizione dei mercati,
che si rifiuterebbero di finanziare un debito pubblico in nuova e significativa crescita. L’unica
alternativa praticabile sarebbe l’emissione, da parte di una autorità europea, di project bond,
ossia titoli del debito pubblico europeo, o almeno garantito dall’Europa, i cui proventi
andrebbero a finanziare specifici interventi di investimento nei Paesi periferici, segnalati dai
singoli Stati ma decisi a livello europeo. Stiamo però parlando di un intervento massiccio, non
simbolico come quelli allo stato proposti. Soprattutto, un intervento difficilmente realizzabile
nelle modalità necessarie. Infatti stiamo in pratica chiedendo ai Paesi “forti” dell’Eurozona di
garantire spese effettuate nei Paesi “deboli”, nel senso che toccherebbe a loro pagare nel caso
in cui i Paesi deboli non restituissero il denaro ricevuto in prestito. E perché mai un Paese che
ha realizzato i propri investimenti e le proprie riforme negli ultimi anni, a sue spese,
faticosamente, sacrificando il benessere immediato delle popolazione nel breve periodo per la
prospettiva di crescita di lungo periodo, come ad esempio la Germania (si badi, non è
importante che sia vero, è importante che i governanti di quel Paese la pensino così) dovrebbe
finanziare gli (o garantire il finanziamento degli) stessi progetti realizzati nei Paesi periferici,
ossia in Paesi che hanno scelto in passato di non fare sacrifici e spendersi tutto per godersi la
vita? Ci sarebbe inoltre un chiaro problema di azzardo morale, perché a quel punto un Paese
in ritardo di crescita non avrebbe alcun incentivo nel finanziarsi da solo i propri investimenti
infrastrutturali, gli converrebbe invece spendersi tutti i soldi che ha in spesa pubblica
improduttiva e poi chiedere il finanziamento europeo per gli investimenti. Questo spiega
115
perché quest’unica possibilità concreta di finanziare gli investimenti in Italia non sia al centro
dell’agenda e, soprattutto, quando lo è stata lo è stata per importi irrisori. Ma gli importi
irrisori non bastano, servono a meno che poco, qui parliamo di centinaia di miliardi di euro di
investimenti solo nel nostro Paese. Che l’Europa non concederà mai. Anche perché poi li
chiederebbero la Grecia, l’Irlanda, il Portogallo, la Spagna, la Francia… Interventi al margine,
di poche decine di miliardi, servirebbero solo a impedire un’ulteriore riduzione di capitale
fisico, umano e tecnologico, rinviando solo di qualche anno la resa dei conti. Quel che serve è
invece un nuovo piano Marshall per l’Italia e per parte dell’Europa.
Qualcuno potrebbe dire: bene, possiamo finanziare questi nuovi massicci investimenti
uscendo dall’Eurozona, in modo da non essere più sottoposti alla disciplina di bilancio
europea, e facendo quindi un’imponente spesa in deficit finanziata con debito. E se i mercati
non ce lo permettono, chiedendoci tassi di interesse proibitivi per acquistare i nostri titoli, con
l’uscita dall’Eurozona abbiamo recuperato anche l’indipendenza di politica monetaria e
possiamo quindi obbligare la nostra nuova Banca Centrale a comprare i nostri titoli.
Conosciamo però ormai bene l’esito finale di una simile politica: massiccio finanziamento del
debito con base monetaria equivale a generare massiccia inflazione. Che poi sia iperinflazione
argentina o inflazione del tipo italiano pre-euro al 20% nessuno oggi lo può dire, anche perché
non sappiamo se, una volta recuperata la capacità di indebitarci, ci limiteremo a farlo per
sostenere la crescita o ci lasceremo tentare dalla possibilità di spendere qualcosa per aiutare,
che so, i pensionati, i disoccupati, gli indigenti, i bassi redditi, i terremotati, gli alluvionati, i
giovani, gli anziani, ecc. ma soprattutto i nostri elettori… Crediamo però di sapere come
andrebbe a finire.
Perché alla fine il problema è proprio questo: il secondo punto di ciò che sarebbe
necessario fare, la presa di coscienza collettiva della nuova realtà nella quale viviamo. Presa di
coscienza fattiva, non semplicemente dichiarata. Gli italiani hanno effettivamente capito che il
mondo che esisteva prima non esiste più? Che la globalizzazione ha stravolto tutto?
Soprattutto: sono effettivamente pronti a trarre le necessarie conclusioni da questa
consapevolezza, ossia che nulla più ci sarà garantito ma tutto dovrà essere conquistato? Che i
salari dovranno scendere e/o la produttività aumentare? Che dovrà essere più facile
licenziare? Che fotocopiare libri, scaricare musica senza pagarla o acquistare magliette
contraffatte della nostra squadra del cuore dovrà essere perseguito sul serio? Che i mercati
dovranno essere liberalizzati, con buona pace dei tassisti? Che non possiamo più permetterci
l’assistenza sanitaria universale gratuita? Che le pensioni saranno proporzionate (in realtà, già
lo sono, ma gli italiani mica lo hanno capito…) ai contributi versati, e non al reddito che
avevamo prima di andare in pensione? Che se vogliamo energia a basso costo dobbiamo
scegliere se accettare l’energia nucleare o le prospezioni petrolifere? Che meritocrazia vuol
dire essere premiati per quello ciò che valiamo realmente, non per ciò che pensiamo di
valere? Che i diritti vanno conquistati di nuovo, e solo se lavoreremo abbastanza per poterceli
permettere? Magari non serve prendere coscienza di tutti questi punti, certo, ma sicuramente
di molti tra essi.
E invece no. Gli italiani la loro mentalità non sembrano averla ancora mutata, parlano
di globalizzazione ma non ne hanno affatto comprese le implicazioni. In molte elites si sta
rafforzando una tentazione di chiusura: se c’è crisi, dobbiamo tornare a farci i maglioncini a
mano, a comprare i regali di Natale dall’artigiano sotto casa, a consumare prodotti a km 0.
Detta in altri termini, se maglioncini, regali di Natale e prodotti alimentari li compriamo
dall’estero, perché i nostri non sono competitivi, verosimilmente perché troppo cari o di
qualità troppo bassa, né sui mercati esteri né in quelli del nostro Paese, dobbiamo mettere
una seria barriera protezionistica, o semplicemente cambiare le nostre abitudini, e “comprare
italiano”. Ecco, con questa mentalità la globalizzazione ci spazzerà via: diventeremo una
grande Cuba, senza però la musica, il Mar dei Caraibi e Fidel Castro! La nostra volontà
116
dovrebbe infatti essere opposta, cercare di capire perché non riusciamo a vendere all’estero i
maglioncini, intervenire per riuscirci, con innovazioni tecnologiche, sacrifici, riduzione del
costo del lavoro, e lottare per riconquistare i mercati. Va poi anche combattuta la cultura del
basso profilo, “piccolo e bello” e del “povero è bello”, che ci ha portato a produrre automobili
di bassa qualità e basso prezzo, mentre i tedeschi conquistavano il mondo con Audi, BMW e
Mercedes. Dobbiamo produrre eccellenze, non vergognarsene, farle meglio degli altri e farle
pagare di più. Retribuendo anche adeguatamente chi lo fa, valorizzando lo skill premium e la
meritocrazia. La stessa diffusione del culto del risparmio pubblico è positiva se serve a
rilanciare l’efficienza della pubblica amministrazione, ma negativa quando contrae la
domanda aggregata. Un po’ come va combattuta la politica del rigore in sede europea, va
combattuta anche la politica della parsimonia, e del piccolo e povero è bello, in sede italiana.
Ma che gli italiani cambino sul serio mentalità è almeno altrettanto complicato che
ottenere fondi europei, anche nella forma di project bond, per i nostri investimenti. Anzi, a ben
vedere le due cose sono collegate: i Paesi più forti dell’Eurozona, infatti, sono assai restii a
finanziarci perché credono, non del tutto a torto, che non siamo cambiati e cercheremo tutti i
trucchi possibili per utilizzare quei fondi non per trasformare il Paese ma per spesa
improduttiva.
Così, è difficile che l’Italia possa vincere la sfida della globalizzazione. Non impossibile,
ma difficile. Di qui il pessimismo del titolo. Ciò non vuol dire che vivremo in miseria.
Semplicemente, vuol dire che non torneremo più ad essere un Paese ricco. Potremo avere
qualche alto e qualche basso, in futuro. Ma pian piano scenderemo. Piano piano. Ma
scenderemo.
Glossario
117
Abenomics
La Politica Economica intrapresa dal Primo Ministro del Giappone Shinzo Abe a partire dal
dicembre del 2012. Consiste in tre “frecce”: una politica monetaria fortemente espansiva,
basata su Quantitative e Qualitative Easing, che ha l’obiettivo di raddoppiare la base
monetaria, portare il tasso di inflazione al 2% (il Giappone è stato per lungo tempo in
deflazione) e deprezzare il cambio dello yen; una politica di bilancio espansiva, per sostenere
la domanda aggregata; una politica di liberalizzazione e apertura al commercio internazionale
che ha l’obiettivo di stimolare la crescita di lungo periodo. La terza freccia è quella che ha
incontrato maggiore opposizione e non è stata ancora realizzata.
Area Valutaria
Si ha un’area valutaria quando diversi Paesi adottano tassi di cambio fissi tra di loro.
Area Monetaria
Sinonimo di Unione Monetaria. Si ha un’Area Monetaria quando diversi Paesi adottano
un’unica valuta, condividendo un’unica Banca Centrale e una politica monetaria comune.
Area Valutaria Ottimale
Un’Area Valutaria o Monetaria è Ottimale, od Ottima, quando i Paesi che ne fanno parte
presentano caratteristiche tali da rendere conveniente per tutti l’adozione di una moneta
unica o cambi irrevocabilmente fissi tra le diverse valute. Le principali tra queste
caratteristiche sono le seguenti: il sistema economico dei diversi Paesi deve essere
sufficientemente simile, ma diversificato all’interno di ciascuno di essi, prezzi e salari devono
essere flessibili, la mobilità dei fattori della produzione elevata, l’interscambio commerciale
nell’area significativo. Secondo molti economisti, solo se valgono almeno alcune di queste
condizioni un Paese ha convenienza a rinunciare ad una politica monetaria indipendente,
ossia alla sua valuta e alla sua banca centrale, e aderire ad una valuta unica con un’unica
Banca Centrale.
Avanzo (o surplus) di bilancio
L’eccesso delle entrate annuali del Governo (che sono principalmente composte da imposte e
tasse) sulle sue spese annuali.
Avanzo Primario o Surplus Primario (di bilancio)
Una situazione in cui, escludendo dal calcolo gli interessi sul debito pubblico pregresso
(quindi facendo come se non esistessero), le entrate annuali del Governo superano le sue
uscite annuali.
Azioni
Quote di proprietà di aziende. A differenza delle obbligazioni non pagano alcun interesse, ma
danno diritto a una quota corrispondente degli eventuali profitti dell’impresa. Si può anche
ottenere un guadagno comprando una azione quando il suo prezzo di borsa è basso e
rivendendola quando è alto, ma si va incontro a una perdita se accade il contrario.
Azzardo morale (moral hazard)
Situazione che si verifica quando un assicurato cambia i propri comportamenti, assumendone
di più rischiosi, proprio per il fatto di essersi assicurato, ossia di non dover pagare di tasca
propria per le conseguenze dei suoi comportamenti.
118
Bail-in
Procedura di salvataggio “interno” delle Banche ordinarie realizzata facendo partecipare alle
perdite di una eventuale insolvenza, nell’ordine, azionisti, obbligazionisti e correntisti.
Bail-out
Procedura di salvataggio “esterno” delle banche ordinarie realizzata ricapitalizzandole con
fondi pubblici o privati o, al limite, nazionalizzandole e trasferendo così in capo al Governo i
debiti.
Banca Centrale Europea (ECB)
L’istituzione pubblica che gestisce la Politica Monetaria dell’eurozona e determina la quantità
di euro in circolazione.
Bolla speculativa
Siamo in presenza di una bolla speculativa quando la domanda un’attività finanziaria (o di un
bene), generalmente titoli azionari o immobili, aumenta in maniera massiccia perché ci si
attende un incremento del prezzo, e dunque si vuole speculare comprando adesso per
rivendere quando il prezzo sarà salito; poiché questo incremento di domanda fa crescere il
prezzo, le aspettative sono confermate e nuovi speculatori intervengono su quel mercato,
facendo aumentare ancora la domanda e il prezzo, sino a portarli a valori del tutto
irragionevoli. Prima o poi la bolla scoppia, facendo crollare il prezzo.
Carry Trade
Pratica finanziaria con la quale si prende a prestito denaro nei Paesi ove il tasso di interesse è
basso, e dunque prendere a prestito costa poco, e lo si impiega nei Paesi dove il tasso di
interesse è alto, e dunque comprare titoli obbligazionari rende molto.
Cartolarizzazione (securitization, in inglese)
Un processo attraverso il quale un flusso di cassa futuro - ad esempio il pagamento delle rate di un
mutuo - viene ceduto in cambio di denaro oggi, o meglio ancora, in cambio di un titolo (carta,
appunto, da cui cartolarizzazione) negoziabile sul mercato, e quindi scambiabile contro denaro.
Collateralized Debt Obligations (CDO)
Detti anche “titoli salsiccia”, sono composti da un insieme di titoli di tipologia diversa; il loro
valore dipende dal valore dei titoli che compongono l’insieme.
Covered bond
Titoli obbligazionari caratterizzati da basso rischio perché chi li ha emessi ha già “messo da
parte”, cedendola ad una società terza, una frazione del suo attivo patrimoniale (titoli o
crediti) a garanzia del prestito.
Credit crunch
Contrazione dell’offerta di credito da parte delle banche, che riducono la concessione di
prestiti alle famiglie e alle imprese mettendo in crisi l’economia.
Credit Default Swap (CDS)
È un titolo che permette di assicurarsi contro l’insolvenza di un altro titolo anche senza
possedere quest’ultimo.
119
Debito Pubblico
Quando il Governo effettua spese che eccedono le sue entrate (spesa in deficit) per poterle
finanziare deve indebitarsi, e lo fa vendendo titoli del debito pubblico, un tipo di obbligazioni.
Poiché molti di questi titoli sono a lunga scadenza, nel senso che verranno rimborsati tra dieci
o vent’anni, il debito pubblico tende ad accumularsi nel tempo se i deficit di bilancio
persistono.
Debito Sovrano
È il debito dei Sovrani, ossia dei Governi. È un sinonimo di debito pubblico.
Default
Sinonimo di fallimento: quando un Paese dichiara default non paga più i suoi debiti, o ne paga
solo una parte, o ne modifica la scadenza.
Deficit di bilancio
L’eccesso delle spese annuali del Governo sulle sue entrate annuali.
Deficit Primario o Disavanzo Primario (di bilancio)
Una situazione in cui, escludendo dal calcolo gli interessi sul debito pubblico pregresso
(quindi facendo come se non esistessero), le uscite annuali del Governo superano le sue
entrate annuali.
Deflazione
Una situazione in cui il tasso di inflazione è negativo, ossia i prezzi si riducono. Generalmente
si verifica in presenza di bassa domanda, ossia di recessione, ed ha parecchie conseguenze
negative, la prima tra tutte quella di incrementare, a parità di altre circostanze, il rapporto
Debito/PIL (perché il PIL è misurato in prezzi correnti, e se questi scendono si riduce anche il
PIL).
Deflazione interna
Una riduzione dei prezzi dei beni prodotti dal Paese allo scopo di aumentarne la competitività
internazionale. Si realizza riducendo i costi di produzione delle imprese, soprattutto quelli
salariali.
Deprezzamento del tasso di cambio
Riduzione della quantità di valuta estera necessaria ad acquistare una unità di valuta
nazionale. Quando accade la valuta nazionale perde valore e ciò può far crescere le
esportazioni nette. Il termine è utilizzato se il cambio è determinato liberamente dal mercato,
ossia in cambi flessibili; in cambi fissi si parla di svalutazione.
Disinflazione competitiva
Politica che ha l’obiettivo di far crescere i prezzi interni meno rispetto a quanto crescano
quelli degli altri Paesi miei concorrenti, in modo da esportare di più e importare di meno.
Doom Loop
Il legame reciproco tra insolvenze bancarie e insolvenze sovrane. L’eccesso di debito privato e
i fallimenti bancari che lo accompagnano costringono a bail-out, a salvataggi da parte dei
Governi, che accrescono il debito pubblico; se cresce troppo il debito pubblico i mercati
cominciano a temere che i Governi non siano in grado di ripagarlo, e cercano di liberarsi dei
titoli di Stato in loro possesso, vendendoli a prezzi stracciati; ma le banche hanno in
120
portafoglio anche titoli di Stato, contabilizzati ai prezzi di mercato, e la riduzione del loro
prezzo implica ingenti perdite; tutto ciò può portare le banche all’insolvenza, rendendo
necessari nuovi bail-out pubblici; e così via, in un circolo vizioso che rischia di portare al
default tanto le banche quanto i Paesi.
Dumping fiscale
La politica economica volta a facilitare la localizzazione di imprese straniere sul proprio
territorio concedendo particolari agevolazioni fiscali, tipicamente un’imposta sulle società
molto più bassa rispetto a quella praticata dagli altri Paesi.
Esportazioni
La vendita all’estero dei beni prodotti da un Paese. Un aumento delle esportazioni implica
maggiore domanda di beni per le imprese nazionali, maggiore produzione e maggiore
occupazione.
Eurobond
Titoli del debito pubblico garantiti congiuntamente da tutti i Paesi dell’eurozona: si tratta di
un’ipotesi, che esiste in varie versioni, e non è ancora stata realizzata, anzi è avversata da
molti Paesi, soprattutto quelli con basso debito (che dovrebbero garantire anche per quelli
con alto debito).
European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM)
Era il “vecchio” fondo salva-Stati dell’Unione Europea, ossia anche dei Paesi europei che non
adottavano l’euro ma mantenevano una propria valuta, come la Gran Bretagna e la Danimarca.
È stato sostituito dall’ESM.
European Financial Stability Facility (EFSF)
Era il “vecchio” Fondo Salva-Stati provvisorio dell’Eurozona: prestava denaro ai Paesi in
difficoltà dietro la stipula di un rigido memorandum contenente una serie di prescrizioni di
politica economica cui il Paese doveva conformarsi. Finanziava i propri prestiti emettendo
titoli obbligazionari. Cessa l’attività di concessione prestiti il 1° luglio del 2013, passando il
testimone all’ESM.
European Stability Mechanism (ESM)
Ha sostituito l’EFSF e l’EFSM come fondo salva-Stati definitivo dell’Eurozona. Ricalca le
modalità di funzionamento dell’EFSF, ma ha un capitale realmente versato di 80 miliardi di
euro, un capitale complessivo di 702 miliardi e una capacità di prestito di 500 miliardi.
Eurostat
Ufficio Statistico Europeo.
Eurozona (detta anche Eurolandia)
I 19 Paesi europei che adottano l’euro come valuta comune: Austria, Belgio, Cipro, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna. Sinonimo di UEM o UME.
Fannie Mae e Freddie Mac
Società semi-pubbliche che hanno lo scopo istituzionale di ricomprare i mutui concessi dalle
banche alle famiglie statunitensi. Durante la crisi subprime il Governo USA è dovuto
intervenire per evitarne l’insolvenza.
121
Federal Reserve (FED)
Il Sistema della Riserva federale, la Banca Centrale degli Stati Uniti.
Fiscal Compact
L’accordo che impone ai Paesi dell’Eurozona che lo firmano una rigida strategia di
contenimento del deficit di bilancio e del debito pubblico. Solo chi aderisce al Fiscal Compact
potrà poi accedere ai prestiti dell’ESM.
Fiscal Devaluation (svalutazione fiscale)
Riduzione delle imposte alle imprese al fine di ridurre i costi di produzione, e dunque i prezzi
dei beni prodotti, recuperando così competitività.
Fondo Monetario Internazionale, FMI (International Monetary Fund, IMF, in inglese)
Organizzazione sovranazionale che interviene offrendo assistenza finanziaria ai Paesi in
difficoltà. L’assistenza è concessa dietro un preciso impegno da parte del Paese ricevente di
mettere in atto riforme economiche concordate con il Fondo.
Grande bazooka
Politica di intervento della Banca Centrale Europea che compra sul mercato primario titoli del
debito pubblico dei Paesi europei in difficoltà finanziaria. Attualmente è proibita dai trattati e
non è dunque mai stata realizzata.
Grande Depressione
La profonda recessione che colpisce gli Stati Uniti tra il 1929 e il 1938.
Haircut
“Taglio di capelli”, la quota di debito che un Paese cancella se dichiara un default parziale.
Importazioni
Gli acquisti effettuati da un Paese di merci prodotte all’estero.
Imposte
Gli incassi del Governo dalla collettività, in genere commisurate al reddito dei soggetti o ad
altri indicatori di capacità contributiva. A differenza delle tasse non sono il corrispettivo di
alcun servizio particolare erogato.
Inflazione
Incremento continuativo del livello generale dei prezzi.
Interbancario
Mercato sul quale le banche si prestano denaro tra di loro.
Investimenti
Realizzati esclusivamente dagli imprenditori, consistono nell’incremento dello stock di
capitale (impianti, macchine, capannoni industriali, martelli, trattori, ecc.) delle imprese, e
dunque dell’intera economia.
Investimenti Diretti Esteri (IDE)
122
L’attività delle multinazionali che costruiscono (o acquistano) impianti produttivi in un Paese
straniero, assumendo lavoratori locali e portando nel Paese, assieme agli impianti, nuovi
prodotti, nuove tecnologie e nuove modalità di produzione, che poi potranno essere imitate
dai residenti nel Paese (spillover).
Iperinflazione
Una situazione in cui il livello dei prezzi sale a un ritmo superiore al 50% al mese.
Keynesiano
Approccio di teoria economica che propugna l’intervento del Governo nell’economia al fine di
far crescere il PIL e l’occupazione. Si ispira alle opere dell’economista inglese John Maynard
Keynes.
Lassismo fiscale
Eccesso di spesa pubblica che genera deficit di bilancio e debito pubblico.
Liberalizzazioni (deregulation)
Politica di ispirazione neoclassica che ritiene necessario, per incrementare l’efficienza del
sistema economico, ridurre il controllo del Governo sui mercati.
Liberisti
Propugnano la liberalizzazione dei mercati. È quasi un sinonimo di approccio neoclassico.
Long Term Refinancing Operations (LTRO)
Operazione realizzata dalla Banca Centrale Europea tra fine 2011 e inizio 2012. Attraverso
essa sono stati concessi circa 1.000 miliardi di euro di prestiti a lungo termine (tre anni) alle
banche ordinarie a tassi particolarmente vantaggiosi (l’1%).
Memorandum of understanding
L’accordo che firma un Paese per ottenere un prestito dalle istituzioni finanziarie
internazionali (ESM, IMF) e che subordina la concessione del prestito ad una serie di misure,
generalmente molto restrittive, di politica economica.
Mercantilismo
Teoria economica che vedeva il benessere di un Paese dipendere dalla prevalenza delle
esportazioni sulle importazione e quindi dall’accumulazione di metalli preziosi, che all’epoca
(XVI-XVII secolo) costituivano la valuta internazionale.
Mercato primario
Mercato dei titoli obbligazionari in cui chi vende il titolo è l’emittente (il Governo, se si tratta
di titoli del debito pubblico).
Mercato secondario
Mercato dei titoli obbligazionari in cui chi vende il titolo non è l’emittente, ma qualcuno che ha
comprato il titolo dall’emittente (o da un privato che non è l’emittente).
Mortgage Backed Securities (MBS)
Sono titoli obbligazionari garantiti da mutui. In caso di insolvenza dei mutui sottostanti
possono non essere rimborsati.
123
Neoclassico
Approccio di teoria economica che ritiene il mercato perfettamente in grado di autoregolarsi e
di raggiungere la piena occupazione. L’intervento pubblico sarebbe quindi inutile, inefficace e
dannoso.
Neomercantilismo
Politica economica che ha l’obiettivo di far crescere la domanda aggregata di un Paese facendo
aumentare le sue esportazioni.
Ninja
Acronimo dell’inglese No income, no job or asset: indica prestiti concessi senza chiedere a
garanzia il possesso di un reddito, di un lavoro o di qualche altra garanzia finanziaria. Per
estensione indica i soggetti che non hanno reddito, occupazione o proprietà.
Obbligazioni
Dette anche, semplicemente, titoli. Le obbligazioni non sono altro che la ricevuta di un
prestito: l’emittente ha l’obbligo (da qui il nome) di restituire quel prestito dopo un certo
periodo di tempo, a seconda della durata del titolo, pagando anche un interesse. Se l’emittente
non fallisce, alla scadenza la cifra restituita è quella scritta sull’obbligazione; l’obbligazione
può però anche essere comprata (e venduta) sul mercato secondario prima della scadenza, e
in quel caso il prezzo può cambiare, essendo determinato da domanda e offerta. Le
obbligazioni possono essere emesse dai Governi, e allora sono titoli del debito pubblico, o da
imprese private.
OMT (Outright Monetary Transactions, Operazioni Definitive Monetarie)
Procedura di acquisto illimitato di titoli di Stato, realizzata sul mercato secondario dalla Banca
Centrale Europea al fine di innalzare il prezzo dei titoli e ridurne il rendimento (e lo spread).
Si attua su richiesta di un Paese che abbia già richiesto, e ottenuto, assistenza finanziaria dal
fondo ESM firmando il relativo memorandum of understanding. Sinora non sono mai state
realizzate.
Original sin (peccato originale)
Elevato indebitamento in valuta estera di un Paese. Per ripagare il suo debito, e gli interessi su
quel debito, il Paese dovrà procurarsi sui mercati la valuta estera necessaria, e per questo
motivo dovrà impegnarsi ad avere rilevanti surplus commerciali, sacrificando la produzione
per il consumo interno. Un apprezzamento del tasso di cambio della valuta estera, così come
una riduzione del prezzo internazionale delle produzioni esportate, possono portare il Paese
all’insolvenza.
Patto di Stabilità e Crescita
L’accordo, stipulato nel 1997, secondo il quale il rapporto deficit di bilancio / PIL di ciascun
Paese dell’Eurozona non dovrebbe superare il 3%, pena sanzioni pecuniarie.
PIIGS
Acronimo di Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna, i Paesi deboli dell’eurozona. È usato in
senso dispregiativo perché richiama l’inglese pigs, maiali.
Politica Fiscale (Fiscal Policy)
Corrisponde alla Politica di Bilancio: il Governo interviene con politiche espansive (che cioè
tendono a far crescere il PIL e l’occupazione) aumentando la spesa pubblica o riducendo le
124
imposte; o con politiche restrittive (che invece riducono il PIL e l’occupazione) aumentando le
imposte o riducendo la spesa pubblica.
Politica Monetaria (Monetary Policy)
Insieme di operazioni, dalla variazione dei tassi di interesse alla modifica della quantità di
moneta in circolazione, attraverso le quali la banca centrale influenza il finanziamento
dell’economia e dunque, indirettamente, il PIL e l’occupazione. Può essere espansiva, volta
cioè ad incrementare PIL e occupazione, o restrittiva, con obiettivi opposti.
Prestatore di ultima istanza
Un prestatore di ultima istanza è l’istituzione, Banca Centrale o Governo, che ha il ruolo di
salvare dall’insolvenza altre istituzioni, tipicamente banche e imprese finanziarie. Può anche
essere una entità sovranazionale che ha il compito di evitare l’insolvenza di interi Paesi.
Privatizzazioni
Politica volta a reperire fondi vendendo proprietà (e soprattutto imprese) pubbliche ai
privati. Può essere usata anche con la finalità di ridurre il ruolo di controllo del Governo
sull’economia o, più banalmente, di reperire risorse finanziarie.
Prodotto Interno Lordo (PIL)
La produzione complessiva di un Paese in un anno. La definizione tecnica è un po’ più
complessa, poiché include solo i beni finali (quelli consumati, esportati, investiti o accantonati
come scorte), all’interno dei confini del Paese e al lordo degli ammortamenti.
Rating
Valutazione sulla probabilità che un titolo sia ripagato alla scadenza, e quindi anche sulla
solvibilità finanziaria dell’emittente, fornito da apposite agenzie, dette appunto di rating.
Recessione
Riduzione del PIL per due trimestri consecutivi. Generalmente causa anche l’aumento della
disoccupazione.
Run (corsa agli sportelli)
Si realizza quando i correntisti cercano in massa di recuperare il denaro detenuto nei loro
conti correnti bancari. Poiché le banche hanno impiegato gran parte di quel denaro per
concedere prestiti, diventano illiquide e, se non vengono aiutate dalla Banca Centrale o dal
Governo, possono fallire.
Saldo di bilancio pubblico
La differenza annuale tra incassi (principalmente imposte e tasse) e spese del Governo. Se ha
segno positivo abbiamo un surplus, se ha segno negativo un deficit.
Saldo Primario
La differenza tra entrate annuali e uscite annuali del Governo, calcolata senza includere gli
interessi sul debito (quindi facendo come se non esistessero).
Securities Markets Programme (SMP)
Programma di acquisto sul mercato secondario di titoli del debito pubblico dei Paesi europei
in difficoltà realizzato dalla Banca Centrale Europea. Iniziato nel maggio del 2010 è terminato
125
poco più di un anno dopo. Il suo obiettivo era rendere meno costoso l’indebitamento per i
Paesi in difficoltà, riducendo il tasso di interesse pagato e lo spread.
Sistema Monetario Europeo (SME)
Il sistema di cambi fissi che esisteva tra le diverse valute europee prima che venisse introdotta
la moneta unica. Entra in vigore il 13 marzo del 1979, e rimane in vigore sino all’introduzione
dell’euro. L’Italia ne esce nel 1992.
Speculazione
Attività che ha l’obiettivo di realizzare profitti comprando quando il prezzo è basso e
vendendo quando il prezzo è alto.
Spesa pubblica
La spesa del Governo per acquistare beni e servizi.
Spread
Differenza tra il tasso di interesse pagato su una certa tipologia di titoli del debito pubblico di
un Paese e quello pagato sulla stessa tipologia di titoli del debito pubblico di un altro Paese. Si
calcola in genere con riferimento al Paese più solido dell’area (in Europa, la Germania), ed è
espresso in punti base, con ciascun punto base che corrisponde a un centesimo dell’un per
cento (in sostanza, se vogliamo calcolare lo spread tra titoli tedeschi e italiani, e la Germania
paga un interesse del 2%, mentre l’Italia del 4,5%, la differenza è pari al 2,5%, quindi a 250
punti base, e dunque lo spread è 250). È calcolabile quotidianamente sui titoli venduti sul
mercato secondario, ma nulla impedisce di calcolarlo anche sui titoli venduti sul primario (in
questo caso il calcolo può però essere fatto solo il giorno in cui il Paese va in asta, cioè emette
il titolo, non quotidianamente).
Stabilizzatori automatici
Imposizione fiscale progressiva e sussidi di disoccupazione: in presenza di una recessione le
imposte si riducono, perché si riduce il reddito, e i sussidi aumentano, perché cresce la
disoccupazione, attenuando l’impatto della crisi sull’economia. Al contrario, in presenza di
inflazione ed economia in forte espansione le imposte aumentano e i sussidi si riducono,
ostacolando la dinamica inflazionistica.
Stagflazione
Contemporanea presenza di inflazione elevata e disoccupazione elevata.
Stagnazione
Situazione, protratta nel tempo, di modesto o quasi nullo incremento del PIL.
Subprime
Negli Stati Uniti esiste un punteggio che fornisce il merito di credito: si diventa subprimer con
un punteggio inferiore a 640, che identifica un soggetto con bassa capacità di restituire il
finanziamento. Quando i subprimer ottengono un prestito, o un mutuo, questo prestito è detto
subprime. L’insolvenza dei subprimer ha fatto scoppiare la bolla speculativa immobiliare negli
Stati Uniti nel 2007, che è appunto stata definita bolla subprime.
Svalutazione del tasso di cambio
Riduzione della quantità di valuta estera necessaria ad acquistare una unità di valuta
nazionale. Quando accade la valuta nazionale perde valore e ciò può far crescere le
126
esportazioni. Il termine è utilizzato quando viene modificato il cambio nei casi di cambi fissi,
ossia all’interno di un accordo, altrimenti si parla di deprezzamento.
Svalutazione competitiva
Politica economica che ha l’obiettivo di ottenere un deprezzamento del tasso di cambio al fine
di far aumentare le esportazioni. È riferito al caso di cambi fissi, o comunque amministrati.
Targeted Long Term Refinancing Operations (TLTRO)
Un tipo particolare di LTRO (vedi) in cui la concessione di prestiti di elevato importo e basso
tasso da parte della banca centrale alle banche ordinarie è subordinato all’uso che quelle
stesse banche ordinarie faranno del denaro, nel senso che dovranno a loro volta prestarlo
all’economia reale, pena sanzioni finanziarie.
Tasse
Incassi ottenuti da un Governo in cambio di un servizio (tasse scolastiche, tassa sui certificati,
ecc.).
Tasso di cambio
Il prezzo di una valuta in termini di un’altra. Nel caso dell’euro, numero di unità di valuta
estera necessari per comprare un euro: se servono due dollari per comprare un euro, il tasso
di cambio tra dollaro ed euro è, appunto, due.
Tasso di interesse
L’interesse pagato da obbligazioni e titoli del debito pubblico. Se il titolo è molto appetito dal
mercato, perché l’emittente è affidabile, potrà pagare un tasso basso; se viceversa nessuno lo
vuole comprare, per invogliare i compratori dovrà pagare un tasso alto. La Banca Centrale è in
grado di influenzare il tasso di interesse, soprattutto per quanto riguarda i titoli pubblici.
TROIKA
Nome informale per l’insieme di Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea,
Commissione dell’Unione Europea. I rappresentanti di queste tre istituzioni generalmente
trattano con il Paese per la concessione di aiuti subordinati alla firma di un memorandum of
understanding.
Troppo grande per fallire (too big to fail)
Imprese il cui fallimento causerebbe talmente tanti danni ed effetti a catena sull’economia che
il Governo interverrà certamente per salvarla. Le imprese too big to fail sfruttano quindi
l’azzardo morale, ossia la garanzia implicita di salvataggio, per effettuare operazioni
finanziarie rischiose: se va bene fanno parecchi soldi, se va male non pagano di tasca propria
col fallimento ma le salva il governo.
UEM (o UME)
Unione Economica e Monetaria Europea (o Unione Monetaria Europea), ossia Eurozona.
Unione Bancaria
Nuovo meccanismo di prevenzione e cura delle crisi bancarie, entrato (parzialmente) in
vigore nel 2014 e basato sull’accentramento della sorveglianza bancaria presso ECB e su un
meccanismo di salvataggio bancario basato sul bail-in.
Unione Europea (UE)
127
Unione di 28 Paesi europei che garantiscono la libera circolazione di merci, persone e capitali
all’interno di un’area protetta da una comune barriera protezionistica e coordinano le
rispettive politiche economiche, ambientali, commerciali. Questi Paesi sono: Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 19 di questi Paesi
costituiscono l’Eurozona ed adottano anche una moneta unica, l’euro; gli altri conservano
invece le rispettive valute e la propria Banca Centrale.
Unione Monetaria
Si ha una Unione Monetaria quando diversi Paesi adottano una valuta comune e si affidano ad
un’unica Banca Centrale comune per la gestione della politica monetaria.
Welfare State
L’idea, messa in pratica da molti Paesi europei, che lo Stato debba intervenire per garantire il
benessere dei cittadini erogando assistenza sanitaria, previdenza sociale, sussidi di
disoccupazione, istruzione pubblica gratuita, ecc.
128
Introduzione
PARTE PRIMA
CRESCERE NON BASTA, MA SI DEVE.
I. La crescita: come si cresce
I.1 Cos’è la crescita economica
I.2 Come si cresce
2
5
5
6
I.3 E se decrescessimo?
10
II.1 Cos’è la Domanda Aggregata
13
I.4 Perché crescere non basta?
II. La domanda aggregata: come si incrementa?
II.2 Come si stimola la domanda aggregata
III Quindi: crescere non basta, ma si deve.
PARTE SECONDA
COMBATTENDO LA BASSA DOMANDA: L’ECONOMIA PRIMA DELLA CRISI
12
13
13
17
IV. Bolle, debiti e NeoMercantilismo
20
IV.3 Debito e domanda aggregata
25
IV.6 I paesi della bolla
30
IV.1 Diverse strategie per sostenere la domanda aggregata
IV.2 I Paesi neomercantilisti
IV.4 Dal debito pubblico al debito privato
IV.5 La Globalizzazione
IV.7 I paesi del debito
V. l’Italia prima della crisi
V.1 L’Italia nell’ultimo trentennio
V.2 Le cause della bassa crescita italiana
V.3 Le cause della bassa domanda italiana
20
21
26
28
39
41
41
42
50
V.4 Le conseguenze della bassa domanda: compensiamo! E cresce il debito
pubblico…
53
PARTE TERZA
LA CRISI
VI. La fine dei giochi (la crisi)
VI.1 Scoppia la bolla subprime USA
VI.2 La crisi passa l’Oceano e arriva in Europa
VI.3 I cinque “maiali”
55
55
57
59
129
VI.4 La crisi e i Paesi della bolla
60
VII.1 La crisi del 2009
65
VI.5 La crisi e i Paesi del debito
VII. La Crisi in Italia
VII.2 La crisi del 2012
VII.3 L’impatto sulla crescita e sulla domanda aggregata
PARTE QUARTA
POLITICHE CONTRO LA CRISI. ORTODOSSE E ALTERNATIVE
VIII. Combattendo (?) la crisi: le politiche del rigore (ma anche no)
VIII.1 Le diverse politiche intraprese all’arrivo della crisi
VIII.2 Le politiche intraprese negli Stati Uniti
VIII.3 La politica europea del “rigore”
VIII.4 Le politiche delle istituzioni europee
VIII.5 Le politiche della Banca Centrale Europea
VIII.6 Le vere finalità della politica del rigore
VIII.7 Potrebbe funzionare? No.
IX. Le alternative
63
65
66
67
72
72
72
75
76
81
87
90
92
IX.1 Politiche dal lato dell’offerta e dal lato della domanda alternative al “rigore”
92
IX.2 Le politiche (alternative) di bilancio e monetarie
92
IX.5 Uscire dall’eurozona
97
IX.3 Le politiche (alternative) dal lato dell’offerta
IX.4 Dichiarare default
PARTE QUINTA
PERCHÉ L’ITALIA NON CE LA FARÀ
X. Cosa dovrebbe fare l’Italia e perché non lo farà
X.1 Dall’Europa all’Italia
94
95
103
103
X.2 Le strategie per la crescita che dovremmo realizzare e perché non le
realizzeremo
103
X.3 Le strategie per sostenere la domanda aggregata e perché, pur volendo, non
le metteremo in atto. O forse sì…
109
X.4 Riassumendo: la soluzione c’è, ma non dipende (solo) da noi
XI. Sommario, e conclusioni: perché l’Italia non ce la farà?
Glossario
111
113
117