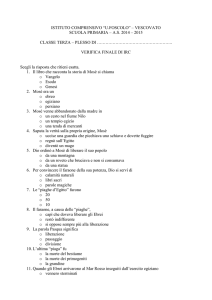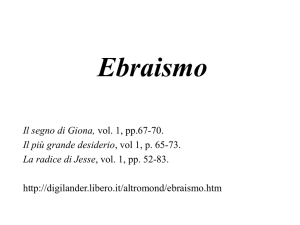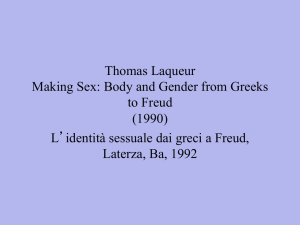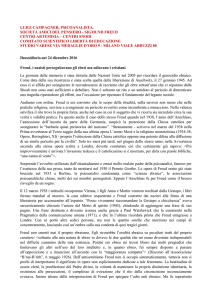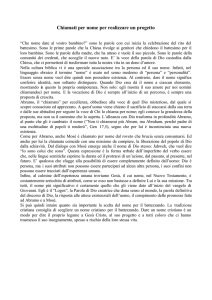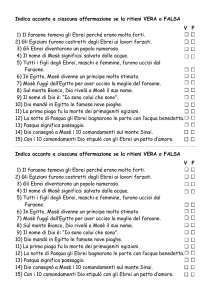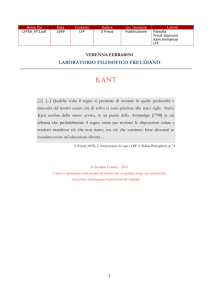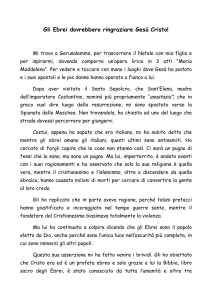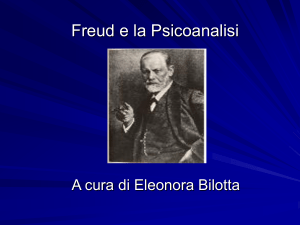3 Maggio 2011
Kultur, religione e guerra nel pensiero di Sigmund Freud
a.a. 2010/2011
Immaterialità di Dio e disincarnazione della Legge:
Freud e il monoteismo giudaico
Raffaella Colombo
Nel mio intervento cercherò, avendo come punto di riferimento il testo di Freud L'uomo Mosè e la
religione monoteistica, di comprendere il rapporto tra Dio e Legge all'interno dell'ebraismo e che
cosa renda così particolare il monoteismo giudaico e, per estensione, il carattere stesso
dell'ebraismo.
Prima di cominciare preciso soltanto una cosa: citerò in alcune occasioni una conferenza che Leo
Strauss, filosofo ebreo tedesco nato in Germania nel 1899 e morto negli Stati Uniti nel 1973, tenne
nel 1957 proprio sul Mosè di Freud. Trattandosi di un filosofo sostanzialmente poco conosciuto,
ritengo necessario presentare brevemente il suo pensiero attraverso quelli che possono essere
considerati come i due punti fondamentali da cui muove tutta la sua speculazione: in primo luogo,
la critica straussiana si rivolge al razionalismo moderno e alle sue declinazioni politiche considerati
responsabili della degenerazione delle moderne democrazie liberali (è evidente il rimando al
fallimento della Repubblica di Weimar e alla successiva affermazione del nazismo). Per Strauss,
infatti, la fine del diritto naturale classico (cioè di una forma di diritto basata, prima di tutto, sui
doveri del singolo nei confronti della comunità) e la rottura di ogni legame con una morale
normativa, hanno lasciato il posto al crescente riconoscimento di diritti individuali particolari e a un
pensiero politico incapace di garantire il benessere e la sicurezza della società nel suo complesso. In
secondo luogo, queste prime considerazioni spingono Strauss a ripensare la questione teologicopolitica per superare la contrapposizione autodistruttiva tra ragione e fede. Atene e Gerusalemme,
poli di questa opposizione, devono riscoprire la tensione che ha costituito e permesso, secondo il
filosofo tedesco, la vitalità dell'Occidente. Non si tratta di ricercare una sintesi tra filosofia e
rivelazione (o, sul piano sociale, tra politico e teologico) ma, piuttosto, di comprendere la loro
reciproca irriducibilità senza permettere che uno dei due elementi annulli l'altro.
Come è facile capire non si tratta di un pensiero progressivo e, del resto, Strauss è stato ed è ancora
considerato come uno dei padri filosofici del movimento neo-conservatore americano. La religione,
per l'ebreo Strauss spesso sospettato di ateismo, rimane un'illusione che deve avere un'avvenire
poiché i non filosofi, vale a dire gli individui non guidati dalla sola ragione e non capaci di
sopportare il peso della verità o della sua totale assenza, avranno sempre bisogno di trovare conforto
e guida nei precetti della religione. In particolare nei precetti ebraici, nella Legge ebraica che
insegna in modo stabile, in sostanza, ciò che la filosofia politica pone come una questione
eternamente problematizzabile: la ricerca della giustizia e il bene collettivo, l'umiltà e la
moderazione come virtù sociali.
L'ebraismo in Germania tra XIX e XX secolo
L'uomo Mosè e la religione monoteistica è stato letto e considerato da molti come una sorta di
autobiografia psicologica di Freud, come una resa dei conti tra il padre della psicoanalisi e i suoi
padri; una resa dei conti condotta con le armi della psicoanalisi stessa.
Eppure, anche se i motivi individuali non possono essere completamente taciuti, si devono
considerare prima di tutto le intenzioni consapevoli, consce, che hanno guidato Freud e che devono
portare a giudicare quest'opera del 1937, prima di tutto, come un pubblico intervento su questioni
fondamentali, specie in quel particolare e tragico momento storico, come la genesi del giudaismo, la
natura della storia ebraica e, più in generale, come un contributo alla comprensione dell'identità
ebraica e alle ragioni della sua sopravvivenza attraverso i secoli.
Da questo punto di vista, allora, L'uomo Mosè e la religione monoteistica rappresenta, come ricorda
Yosef HayimYerushalmi nel suo saggio Il Mosè di Freud – Guidaismo terminabile e interminabile
(1991), un esempio personalissimo del moderno storicismo ebraico, vale a dire della ricerca sul
significato del giudaismo e della sua identità attraverso un attento e critico riesame del passato e
delle sue fonti.
Per capire la genesi di questo nuovo atteggiamento verso la tradizione e per capire il clima culturale
(filosofico, politico e religioso) che accompagna gli ebrei di lingua tedesca tra XIX e primi decenni
del XX secolo, occorre risalire almeno alla seconda metà del XVIII secolo quando Moses
Mendelssohn diede vita a quello straordinario movimento intellettuale che va sotto il nome di
haskalah (dall'ebraico sekhel che significa “ragione”, “intelletto”), noto anche come “illuminismo
ebraico”. Mendelssohn era giunto a Berlino nel 1743 attraverso la porta Rosenthal (la porta della
cinta muraria di Berlino da cui transitavano esclusivamente gli ebrei e il bestiame) come giovane
povero e in grado di parlare quasi esclusivamente l'ebraico ma capace, pochi anni più tardi, di
incarnare il modello di un nuovo ebreo aperto alla migliore cultura europea. Se da un punto di vista
religioso Mendelssohn proclama l'ebraismo “religione della ragione”, da un punto di vista politico
auspica l'instaurazione di uno Stato illuminato e fondato sulla tolleranza. Il suo esempio di filosofo
e letterato ebreo capace di assimilare a fondo il mondo tedesco e di stringere amicizia profondo con
alcuni dei più importanti esponenti della cultura settecentesca (basti ricordare il legame con Lessing
e l'influenza che questo rapporto ebbe su una delle opere più famose e significative di Lessing, vale
a dire Nathan il saggio), rappresenta al meglio la tensione tra conservazione delle proprie origini e
assimilazione delle forze migliori della filosofia, della politica e dell'arte tedesche ed europee. Con
assimilazione e assimilazionismo non intendo, ovviamente, un processo passivo ma, al contrario,
fusione e contributo attivo, quando non fondamentale, a queste forze. Mendelssohn, in sostanza,
colma per primo l'abisso che separava ebrei tedeschi e tedeschi, mostra una possibilità che, almeno
per tutto l'800, avrebbe accompagnato le speranze della maggioranza degli ebrei, di quella
maggioranza non ortodossa e politicamente liberale o socialdemocratica che costituisce forse
l'essenza dell'ebraismo tedesco del XIX secolo.
Tuttavia, questa grande spinta illuminista conosce anche il ciclico ritorno di ondate antisemite e,
specialmente dopo la sconfitta nella I guerra mondiale e l'umiliazione generata dalle condizione
imposte alla Germania dai trattati di pace, le promesse ottocentesche lasciano spazio a una grande
tensione (tra tedeschi ed ebrei e all'interno dell'ebraismo stesso).
Questo stato di crisi conduce, tra le molte cose, alla nascita di movimenti giovanili tedeschi che si
rifanno a una retorica romantica di ritorno alla terra e alla cultura popolare e che guardano agli ebrei
con antiche diffidenze e nuovi stereotipi: l'ebreo è ora associato alla decadenza della vita cittadina e
all'idea di un uomo debole fisicamente, poco virile, troppo intellettuale, colto e viziato, per poter
essere considerato come una risorsa utile per la società. L'aspetto curioso è che questi movimenti
“ariani” (ma vicini al più generale clima di ribellione dei giovani europei nei confronti del mondo e
dei valori borghesi ottocenteschi), trovano una forte corrispondenza in quei movimenti giovanili
ebraici che, cantando le gioie di un'esistenza lontana dalle città e il recupero della tradizione,
contribuiscono a generare un senso di allontanamento dai tentativi di emancipazione e assimilazione
del XIX secolo.
Il cosiddetto movimento volkish, insomma, affascina anche i giovani ebrei allontanandoli da
quell'ideale di Bildung che aveva accompagnato l'esistenza e la costruzione di una nuova identità,
pur con diversi esiti e prendendo diverse direzioni, dei loro padri e delle loro madri.
Sarebbe impossibile addentrarsi ora nei molti gruppi, movimenti, confraternite che, a Berlino come
nella Paga di Kafka, danno forma a questo disagio dei giovani ebrei e, ancora di più, sarebbe
impossibile intraprendere un discorso esauriente e non superficiale sulla distanza tra la diffusa
propensione all'assimilazione ottocentesca e il sionismo nascente proprio verso la fine di quel
secolo. È semplicemente importante non pensare alla comunità ebraica tedesca e, più in generale,
europea, come a una realtà monolitica guidata da un unico sentire. La frammentazione e la
confusione in quel periodo di passaggio e, ancora di più, nei difficili anni del '900 che precederanno
il nazismo, sono forti come in altri gruppi e comunità. Si tratta di un momento di transizione e di
crisi che apre a molte soluzioni e a molte sconfitte e che trova un denominatore comune in ciò che
spesso accompagna e caratterizza i momenti di crisi, vale a dire il bisogno di ripensare e valutare,
con maggiore e minore scientificità, la propria origine, la propria storia, il significato della propria
identità e la possibilità o la volontà di salvarla e di conservarla.
Una delle posizioni più significative in questa direzione è quella che, fin dal XIX secolo, va sotto il
nome di “scienza del giudaismo”: questo movimento nasce in Germania con l'idea di applicare i
metodi della critica storica alle fonti ebraiche (il Talmud, la Midrash, la letteratura ebraica
medievale e, anche se con maggiore cautela, la Bibbia ebraica stessa) ma si diffonde anche in altri
paesi con diversi istituti e pubblicazioni. Particolarmente importante è l'Accademia per la Scienza
del Giudaismo fondata a Berlino per volontà di Franz Rozensweig e Hermann Cohen (fondatore,
come è noto, della Scuola neokantiana di Marburgo) e attiva fino al 1933. Scopo generale
dell'Akademie è incentivare studi obiettivi e non apologetici, studi non dogmatici che, per questo,
incontrarono spesso l'opposizione delle componenti più ortodosse dell'ebraismo. Il risultato è una
continua interrogazione che la ragione muove alla fede, che l'ebraismo muove alla sua tradizione,
che il filosofo, ebreo ma, ancor prima o immediatamente dopo, filosofo, muove alle proprie origini.
Cercando così una sintesi tra religione e ragione (come in Cohen) o chiedendo invece che i due
termini, ragione e fede, ricerca filosofica e religione, si guardino a distanza senza cercare di
sopprimersi o di sintetizzarsi (come nel caso di Strauss).
Il ruolo di Mosè
È evidente che la figura di Mosè diviene, in questo contesto, una figura emblematica, il simbolo di
un processo che raccoglie le tradizioni più antiche dell'ebraismo e le riconsegna in una forma nuova
e pura nel giudaismo più maturo. Una figura che può e deve essere interrogata anche nella sua realtà
storica, con devozione ma anche con spirito chiaramente scientifico.
I precedenti, nella storia dell'esegesi o della critica aperta alla religione, non mancano: dal Mosè di
Spinoza ricostruito nel Trattato teologico-politico (la posizione di Spinoza può essere riassunta nel
modo seguente: per prima cosa, Mosè non può essere l'autore dei primi cinque libri della Torah e,
aspetto più importante, Mosè deve essere essere considerato come un capo politico che cercò di
governare un popolo ancora rozzo e assuefatto alla schiavitù attraverso una religione capace di
invadere ogni aspetto della vita quotidiana, in modo che il popolo «facesse il suo dovere non tanto
per timore quanto per devozione», vale a dire non attraverso il comando bruto ma attraverso una
passione derivata, la devozione appunto, che è composta da amore e ammirazione, capace quindi di
spingere a una forma di obbedienza “spontanea”), ad altre teorie che propongono, con grande
anticipo rispetto a Freud, l'origine egizia di Mosè. Basterebbe a questo proposito ricordare l'opera
del filosofo libertino John Toland che, nel 1709, scrisse L'origine degli ebrei in cui si sosteneva
l'origine non ebraica del fondatore del monoteismo giudaico. Ma, prima ancora di Spinoza e Toland,
non è possibile non nominare Machiavelli e il suo Mosè.
Machiavelli legge la Bibbia con lo stesso spirito con cui legge i classici, uno spirito né scettico, né
dogmatico: la Bibbia è semplicemente un documento da cui si possono ricavare elementi importanti
per la formazione di una tesi universale sulla nascita e la fine delle nazioni e per giungere a
prescrizioni politiche pratiche. Nei ritratti biblici spesso brutali di ribellioni, guerre, lotte
all'autorità, Machiavelli trova un precedente per i suoi giudizi politici e, nel Mosè del Pentateuco,
un modello ideale di eroe, un caso unico di uomo in cui convivono la figura del fondatore di una
nuova religione e quella del legislatore che fonda, di fatto, una nuova comunità. Un eroico
liberatore e un violento conquistatore, dunque, contraddistinto da un'ambiguità iniziale che si
trasforma in forza e determinazione. La duplicità del carattere di Mosè, che Freud collegherà ai due
Mosè (quello madianita collerico e legato al culto del demone Yahweh e quello egizio votato a un
ideale spirituale puro), è letta da Machiavelli semplicemente come la naturale incertezza di un uomo
chiamato a un'impresa enorme: Mosè ha paura, non sa se sarà in grado di fare ciò che Dio gli
chiede, non confida nelle sue capacità; in altri momenti Mosè è invece sicuro, abbandona l'umiltà e
si dimostra pronto, vendicativo, dotato di feroce determinazione. La sua forza e la sua debolezza, la
sua virtù (intendo con virtù ciò che Machiavelli intendeva: valore, virilità, intelligenza) e la sua
umiltà sono qualità positive e negative che possono naturalmente convivere all'interno di un uomo
ma che si risolvono poiché, in Mosè come in tutti i grandi condottieri e principi, virtù e fortuna,
riunite insieme, permettono al suo piano di rivelarsi vittorioso. Senza l'occasione, anche la virtù più
cristallina e sicura sarebbe comunque destinata alla sconfitta.
Mosè non è semplicemente il profeta di una nuova alleanza con Dio; Mosè è il “profeta armato”, il
liberatore e capo politico che non fallisce proprio perché, contro i nemici e contro le ribellioni del
suo stesso popolo, non si mostra indifeso. Ecco cosa scrive nei Discorsi: «chi legge la Bibbia
sensatamente vedrà Moisè essere stato sforzato, a voler che le sue leggi e gli suoi ordini andassero
innanzi, ad ammazzare infiniti uomini, i quali, non mossi da altro che da invidia, si opponevano ai
disegni suoi». Quindi: Mosè è stato costretto a uccidere, a trasformare la sua umiltà, la sua iniziale
debolezza, in arroganza brutale, dai pericoli che correva continuamente a causa della sua posizione
preminente. L'invidia del popolo è molto più pericolosa dei nemici esterni; l'insipienza del suo
popolo è molto più pericolosa del mondo esterno.
La pericolosità dell'invidia degli amici e dei fratelli non è certo un tema estraneo alla Bibbia: la
storia di Giuseppe o quella di Giobbe ci ricordano continuamente, come Girard ha mostrato con
grande chiarezza, che i preferiti dai padri o i migliori all'interno della società rischiano
continuamente di fare una fine poche piacevole o, almeno, di essere accusati di aver compiuto atti
blasfemi e di aver peccato contro Dio. Questa pericolosità viene letta da Machiavelli. Così come
viene tracciata una grande distanza tra lui e il suo popolo. Mosè, nei passaggi a lui dedicati nel
Principe e nei Discorsi, è circondato dalla solitudine del leader: c'è uno scarto non riducibile tra lui
e la comunità che lo guida. Quella stessa distanza tra l'individuo che indica una nuova strada e la
massa che lo segue senza capirlo davvero che ritroviamo, con una vigore e una tragicità sicuramente
maggiori, nel Mosè di Freud.
Credo che Leo Strauss si riferisse a questo quando, nella conferenza del 1957, afferma di aver
trovato molte somiglianze tra il Mosè di Freud e quello di Machiavelli promettendo di tornare su
questo argomento in futuro. Non mi risulta che Strauss l'abbia fatto, che abbia ripreso il confronto
tra Machiavelli e Freud su questo argomento, tuttavia penso che il punto di contatto che aveva
riconosciuto tra i due stesse in questo: tanto il Mosè di Machiavelli, quanto quello di Freud, sono
esposti alla violenza del loro stesso popolo, esposti al possibile fallimento causato dalla rivolta,
dall'incomprensione, da quelle rinunce pulsionali così difficili da tollerare per la massa. Mosè è, per
entrambi, il modello dell'eroe liberatore esposto alla mancanza di equilibrio del popolo, alla sua
irrazionalità, alla sua gioiosa adesione al cambiamento che è sempre pronta a trasformarsi, quando
avanzano le prime difficoltà, in condanna di questo cambiamento e sedizione.
Detto questo, credo che l'analogia tra il Mosè di Machiavelli e quello di Freud termini qui. Come
dicevo, non so fino a dove volesse spingersi Strauss quando sosteneva la vicinanza fra i due ma, per
quanto mi riguarda, ritengo che il testo di Freud abbia ragioni e scopi ultimi molto lontani da quelli
che guidavano Machiavelli quando si rifaceva alla storia di Mosè ponendola accanto a quelle di
Ciro, Romolo e Teseo.
La prospettiva di Machiavelli rimane esclusivamente politica e il suo legame con la religione è
funzionale a questa prospettiva: così si spiegano l'opposizione alla “debolezza” cristiana e
l'esaltazione della virilità e della natura guerriera di Mosè e, più in generale, di molte storie
dell'Antico Testamento. Freud che, inutile dirlo, scrive quattrocento anni dopo, ha certamente
ribadito che la religione è uno strumento utile, ma ha anche ormai decretato che questa illusione è
giunta alla fine o che a questa illusione si deve porre fine. Come scrive nell'Avvenire di un'illusione:
«L'uomo non può rimanere sempre bambino, deve alla fine avventurarsi nella “vita ostile”. Questa
può venir chiamata l' “educazione alla realtà”». È evidente che siamo di fronte a un realismo ben
diverso da quello di cui è maestro in politica Machiavelli. Qui non si tratta di prendere atto della
natura ferina e immutabile degli esseri umani chiedendo alla politica di adottare strumenti adeguati
a questo pessimismo antropologico, strumenti capaci, anche con l'aiuto della religione, di
neutralizzare l'imprevedibilità delle masse e degli eventi. Qui, cioè nel caso di Freud, siamo di
fronte alla richiesta di una presa di coscienza sulla realtà, di un'educazione alla realtà delle cose,
prima di tutto alla realtà e al funzionamento dell'individuo e poi, per analogia, alla realtà e al
funzionamento delle masse, per segnare un progresso della ragione e della civiltà.
In ogni caso, rispetto alla figura di Mosè si deve notare che, dove Machiavelli saluta con entusiasmo
i tratti più feroci, guerrieri, vendicativi di Mosè, Freud sente invece il “bisogno” di scindere in due
Mosè: da un lato il vero Mosè, quello egizio e nobile che cerca di educare il popolo al monoteismo
compiuto; dall'altro il Mosè che adora un dio vulcanico, si abbandona alla magia e che, come il suo
dio, conserva qualità telluriche opposte all'aurea apollinea che circonda il primo Mosè assassinato
dalla sua comunità.
Inoltre, e questo è probabilmente il punto decisivo, Freud, in quanto ebreo vissuto tra XIX e XX
secolo e in quanto padre della psicoanalisi, è mosso da un'esigenza che Machiavelli, per ragioni
auto-evidenti, non poteva sentire: come afferma Yerushalmi nel testo già citato, il vero filo
conduttore del libro di Freud, spesso non compreso perché l'attenzione viene catturata dagli aspetti
più rivoluzionari (l'origine egizia di Mosè e la sua uccisione per mano degli ebrei), è la questione
della tradizione e della sua continuazione. “Che cosa diede al monoteismo tutto il suo potere sugli
ebrei?” e, soprattutto, “cosa permise a questa tradizione di continuare nonostante la storia”? Ecco
cosa scrive Freud in una lettera del 1934: «di fronte alle nuove persecuzioni ci si domanda di nuovo
in che modo gli ebrei siano diventati quel che sono e perché si attirino questo odio imperituro. Ho
scoperto in fretta la formula: gli ebrei furono creati da Mosè. Dunque ho intitolato la mia opera,
L'uomo Mosè – un romanzo storico».
Freud comincia la sua opera con queste parole: «privare un popolo dell'uomo che esso celebra come
il più grande dei suoi figli non è qualcosa che si compia volentieri o con facilità, tanto più quando si
appartiene a quel popolo. Ma nulla ci deve indurre a sottomettere la verità a presunti interessi
nazionali, se dal chiarimento di uno stato di cose possiamo aspettarci un progresso della nostra
conoscenza».
Leo Strauss, sempre nella conferenza di cui si diceva, riprende con tono polemico questo inizio
affermando che l'atto di Freud di “privare un popolo dell'uomo che esso celebra come il più grande
dei suoi figli” è un atto di auto-privazione e un atto di tradimento contro l'interesse nazionale. Prima
di tutto un atto di tradimento contro gli ebrei che erano ormai già entrati nel periodo più tragico
della loro storia. Ecco cosa dice esattamente Strauss: «La giustificazione di Freud è che questo è
fatto per il bene della verità. Nasce la domanda, è la verità una parte dell'interesse nazionale? Il vero
interesse nazionale conduce necessariamente alla verità? Ciò si rivolge ai solo ebrei o a tutti i
popoli? A ogni modo, Freud sembra suggerire qui qualcosa di fondamentale: che la verità è più
importante della società e che conoscenza della verità e proclamazione della verità vanno di pari
passo. Ma questo è giustificabile solo se la verità è essenzialmente salutare. Sarebbe così se la
conoscenza della verità ci rendesse uomini o cittadini migliori. Ma se questa verità fosse
essenzialmente edificante o salutare, allora non si comincerebbe un discorso con “privare”».
Non è possibile affrontare ora tutte le implicazioni filosofiche e politiche che si potrebbero ricavare
da questo breve passaggio della conferenza di Strauss, né analizzare quanto di Strauss ci racconti
questo insistere sulla distanza tra conoscenza della verità e proclamazione della verità e tra verità e
salvaguardia della società. Basterà notare che il vero allievo di Machiavelli appare qui Strauss e non
certo Freud. Quello che a noi interessa è che Strauss rilancia, a quasi 20 anni dalla pubblicazione
del libro e dalla morte di Freud, una delle accuse principali all'Uomo Mosè (accusa di cui lo stesso
Freud era consapevole quando diceva “so che molti ebrei si sentiranno offesi”), vale a dire l'accusa
di aver leso gli interessi degli ebrei in un momento già terribile privandoli di Mosè (o almeno
facendo di Mosè uno straniero) e accusandoli di averlo ucciso.
Davanti a tutto questo, la verità è davvero così importante? La stessa verità storica intorno a Mosè o
il provare che sia mai realmente esistito è davvero più importante di ciò che la tradizione ha
trasmesso? La risposta per Freud è sì. La verità è più importante se questa “umiliazione” inflitta al
narcisismo umano conduce a un aumento di conoscenza. E la verità è più importante se dal suo
accertamento possiamo restituire alla tradizione stessa una purezza e un grado di astrazione che non
soltanto la ripagheranno di ciò che le si sarà chiesto di sacrificare ma, soprattutto, ripagheranno il
popolo che su di essa vive e che in essa si riconosce: «è onore bastante per il popolo ebraico aver
conservato tale tradizione e aver espresso uomini che se ne fecero banditori, anche se il primo
incitamento era venuto dall'esterno, da un grande straniero». Infatti, anche se genericamente egizio,
il monoteismo è storicamente ebraico poiché gli ebrei lo hanno conservato. Come scrive Martin
Bergmann in un testo su Freud: «Freud privò gli ebrei della scoperta del monoteismo, ma restituì
loro una posizione centrale sul piano psicologico: solo fra gli ebrei, infatti, il rimosso riemerse, con
conseguenze fatidiche per la storia dell'umanità». Si potrebbe dire che gli ebrei siano stati eletti due
volte: la prima volta dallo straniero Mosè che li sceglie come custodi della rivoluzionaria religione
di Eknaton e la seconda volta poiché solo tra di loro il rimosso tornò alla coscienza.
La questione del ritorno del rimosso è affrontata da Freud in questi termini: il monoteismo egizio di
Mosè restituisce agli ebrei il Padre. Questo primo ritorno del rimosso equivale alla rivelazione
biblica con cui Mosè consegna la Legge al popolo e sancisce l'alleanza tra l'unico Dio Padre e i figli
di Israele. In seguito, stanchi delle rinunce a cui sono costretti dalla rigidità e dall'alta moralità della
nuova religione, gli ebrei uccidono Mosè e comincia così un periodo di latenza lungo alcuni secoli
(le vicende di Amenofi IV e di Mosè sono collocabili tra il XVI e XV secolo ma la datazione è
incerta come incerta è la stessa realtà storica dell'Esodo, almeno per come è raccontato nella Bibbia)
che si conclude con il ritorno del rimosso nell'insegnamento dei profeti tra VII e V secolo. Qui
l'insegnamento del Padre torna con forza maggiore anche se non torna il ricordo dell'omicidio.
Perché un'anamnesi di questo genere possa avvenire, è necessaria una terza ripetizione. Questa
ripetizione coincide con l'uccisione di Gesù, nonostante questa non sia esattamente la ripetizione
dell'omicidio fondatore ai danni del Padre. Ecco cosa scrive Freud: «la reintroduzione del padre
primigenio nei suoi diritti storici fu un grande progresso, ma non poteva essere l'ultimo. Anche le
altre parti della tragedia preistorica premevano per il riconoscimento. Che cosa abbia messo in moto
questo processo, non è facile indovinarlo. Sembra che un crescente senso di colpa si sia impadronito
del popolo ebraico, precorrendo il ritorno del contenuto rimosso. Fino a quando un uomo venuto da
questo popolo ebraico, per legittimare un agitatore politico-religioso, fornì l'occasione con cui una
nuova religione, quella cristiana, si distaccò dall'ebraismo. Paolo, un ebreo romano di Tarso,
recuperò questo senso di colpa e lo ricondusse alla sua fonte originaria. Chiamò questa il “peccato
originale” (cioè l'omicidio del padre) e disse che poteva essere espiata solo con la morte. Con il
peccato originale la morte era giunta nel mondo».
Che cosa significa? Che Paolo, per molti vero fondatore del cristianesimo poiché per primo
riconosce l'importanza e il valore salvifico della passione di Cristo, fa della morte di Gesù un
simbolo non del ricordo dell'omicidio paterno ma del suo desiderio di espiazione. Un senso di colpa
grava sul popolo ebraico o, dice Freud, forse sull'intero mondo civile di quel tempo. Come
sollevarlo? Ecco che la “fantasia dell'espiazione” trova nella vicenda di Cristo un modello perfetto:
un innocente che si era lasciato uccidere per redimere l'umanità dai suoi peccati. In quel gioco delle
parti di cui parla Freud a proposito della tragedia preistorica, Gesù non rappresenta più il Padre ma
il Figlio. Più precisamente: il capo della banda di fratelli che aveva assassinato il padre. L'eroe
ribelle della tragedia che, alla fine, deve essere fatto a pezzi per espiare la colpa. Il “redentore”
redime e può redimere proprio per questo: perché sua è la colpa (è sua la colpa nella coscienza
collettiva, nella fantasia della massa) ed è dunque sua la possibilità di portare via i peccati con la
sua morte.
Quindi per Freud, con Cristo, avremmo la riproposizione di un segmento della tragedia preistorica:
il giudaismo aveva imparato a sopportare il senso di colpa per l’omicidio del padre, accettando la
severità della legge paterna. Il cristianesimo, invece, dà corpo alla fantasia di espiazione, al
desiderio di allontanare da sé il senso di colpa.
Ora, anche se René Girard ha affermato che il cristianesimo ha, proprio attraverso la morte di Cristo
che dichiara la sua realtà di vittima, di innocente sacrificato come capro espiatorio, demitizzato il
mondo o almeno la cultura occidentale, appare degna di considerazione l'idea, freudiana ma non
solo, che il cristianesimo abbia rappresentato un ritorno a buona parte del bagaglio mitico e pagano
che il severo monoteismo mosaico aveva eliminato. Se è vero che Cristo urla la sua verità,
radicando la violenza nel cuore degli uomini che l'hanno condotto alla morte, è anche vero che
Cristo, come il capro che veniva abbandonato nel deserto, prende su di sé i peccati del mondo per
allontanarli, ancora una volta, dal mondo. Il rito stesso della comunione, con la ripetizione
quotidiana della condivisione del corpo e del sangue di Cristo, si richiama a una materialità, a una
forma di comunicazione con il divino e di condivisione del divino che il giudaismo, sempre nella
sua forma più pura e spiritualizzata, aveva non solo abbandonato ma respinto duramente attraverso
la proibizione dei sacrifici e, ancora di più, attraverso il divieto di raffigurare in alcun modo Dio.
L'iconoclastia giudaica si perde in una religione, quella cristiana, che trova un tramite tra gli uomini
e il Dio Padre nell'immagine del Figlio, nell'immagine di un uomo rappresentato nella sua massima
umanità, vale a dire nel momento del dolore e della morte. L'assoluta differenza di Dio rispetto al
mondo, che costituisce invece uno dei punti del monoteismo biblico pienamente maturo, viene
sostituita da un ritorno a una forma di compattezza mitica tra divino e umano nell'idea
dell'incarnazione di Dio nel Figlio. Il Verbo non è più soltanto volto di Dio poiché il Verbo si è
incarnato, secondo la teologia cristiana.
Questo aspetto è particolarmente importante, se non fondamentale, per comprendere il significato
del monoteismo mosaico e l'essenza del giudaismo, cioè per comprendere due dei motivi, almeno
due dei motivi consci come si diceva all'inizio, che spingono Freud a scrivere L'uomo Mosè e la
religione monoteistica.
Difficoltà nel Mosè di Freud
Credo che questo testo, almeno nella I e nella II parte, possa lasciare perplessi per alcune ragioni.
Freud vorrebbe muoversi come uno storico ma non lo è. Si rifà al testo di Sellin del 1922 e ad
alcune intuizioni personali. Cerca di far valere l'analogia tra psicologia individuale e psicologia
delle masse piegando i fatti storici e aggrappandosi a pochi passi biblici che sembrano confermare,
come altri avevano già sostenuto, l'assassinio di Mosè da parte degli ebrei. Il passo a cui si riferisce
anche Freud è quello contenuto nel Libro del profeta Osea, libro in cui vengono ricordati molti dei
peccati di Israele contro Dio e contro le sue leggi. In particolare vi troviamo scritto: «Per mezzo di
un profeta il Signore fece uscire Israele dall'Egitto e per mezzo di un profeta lo custodì. Efraim
provocò Dio amaramente, il Signore gli farà cadere addosso il sangue versato e lo ripagherà del suo
vituperio».
Ora, è possibile che questo passo si riferisca effettivamente all'uccisione di Mosè da parte del suo
popolo. Chi rimprovera a Freud di non aver tenuto conto del fatto che l'Antico Testamento è
attraversato da rimproveri e minacce di Dio agli ebrei per i loro peccati e quindi si chiede per quale
ragione la bibbia avrebbe dovuto tacere un peccato così grande come l'omicidio del più grande
maestro ebraico, dimentica che, in questo caso, siamo di fronte a un peccato del tutto particolare:
alla ripetizione dell'omicidio del padre primigenio, a qualcosa che non appartiene a un'esplosione
occasionale di rabbia conscia, ma alla psicologia collettiva che, come quella individuale, si basa da
un lato sulla coazione a ripetere un fatto traumatico e, dall'altro, all'elusione che impone, al
contrario, «che nulla sia ricordato e nulla sia ripetuto». Il fatto, dunque, che l'ipotetico omicidio di
Mosè sia taciuto (o rivelato soltanto con pochi indizi che non bastano per dare la certezza), può
essere facilmente giustificato da Freud ricorrendo alla natura stessa di questo fatto traumatico: la
tendenza a ripetersi e la tendenza a essere dimenticato o coperto.
Tuttavia, come dicevo, il testo di Freud contiene, a mio avviso, molti punti deboli: tornando alla
posizione di Strauss e alla sua conferenza, bisogna ammettere che il filosofo tedesco a vita facile nel
dimostrare che l'origine del nome di Mosè o le ambiguità o l'ambivalenza del suo carattere, sono
prove che, di fatto, non provano nulla. L'argomentazione di Freud, da questo punto di vista, è
debole e occorre un atto di fede più che uno sforzo della ragione per seguirlo e stare dalla sua parte.
Per salvare Freud è fondamentale allora tornare a ciò che si diceva all'inizio: l'importanza del suo
testo non sta nei singoli elementi, non sta negli aspetti più sensazionalistici che rivela ma sta in ciò
che ci racconta circa l'essenza del monoteismo giudaico e la sua capacità di conservarsi nel carattere
e nell'identità ebraica.
In cosa consistono questa essenza e questo carattere? Credo che le stesse parole di Freud possano
avvicinarci al cuore della questione: «poiché ero ebreo fui sempre pronto a passare all'opposizione e
a rinunciare all'accordo con la maggioranza compatta».
Freud, come molti altri ebrei, era ebreo “per negazione”: non lo era per religione, non lo era per
nazionalismo, non lo era per lingua (anche se conosceva l'ebraico a differenza di ciò che sosteneva
pubblicamente). Eppure rimaneva ebreo e rimaneva ebreo in ciò che potremmo definire come
un'istintiva natura antiautoritaria. Comprendere la natura di questa “vocazione” basandoci sul Mosè
di Freud è comprensibile solo in modo limitato: Freud ci rimanda alla grande purezza e
all'universalismo del monoteismo instaurato da Amenofi IV e alla sua ripresa da parte del Mosè
egizio. Eppure, questo è un monoteismo che si oppone all'autorità politica, che si oppone alla
maggioranza, solo nel momento in cui la rivoluzione di Amenofi fallisce in Egitto e viene salvata da
Mosè attraverso il popolo ebraico liberato dall'Egitto stesso. Ma, all'origine, il dio unico di Amenofi
è dotato di un universalismo che va di pari passo all'imperialismo politico. Potremmo dire che il dio
unico è l'equivalente religioso di un potere politico che tende all'unificazione e al controllo di tutto.
Da questo punto di vista, la rivoluzione di Amenofi IV è una rivoluzione parziale rispetto al
precedente sistema religioso egizio: certo, viene eliminato e proibito il culto delle altre divinità ma
rimane qualcosa del precedente politeismo in due aspetti fondamentali: Aton è ancora legato al
Sole, vale a dire è ancora legato all'elemento religioso mitico che assegna a ogni divinità un ruolo
ben preciso all'interno del cosmo e un'incarnazione precisa in un elemento cosmico-naturale e, in
secondo luogo, Amenofi IV rimane rappresentante di Aton sulla terra. Si proibiscono le immagini, il
dio non può essere rappresentato o riprodotto, eppure mantiene un'incarnazione terrena nella figura
del faraone. Una mediazione di questo genere è assente dal monoteismo giudaico maturo ed è
assente dal genere di alleanza con Dio di cui l'Antico Testamento ci parla attraverso la vicenda di
Mosè. Questa mediazione e questo diretta unione tra teologico e politico nella storia li ritroveremo
invece nel monoteismo cristiano e in quello islamico. Come scrive Jan Assmann, egittologo tedesco
che ha scritto molto, proprio partendo dalle considerazioni freudiane, sul legame tra Egitto e Israele
e sulla rivoluzione monoteistica: «L'idea dello Stato come rappresentante del dominio divino sulla
terra, nata in Egitto, poté essere reintrodotta nelle religioni monoteistiche (cristianesimo e
islamismo), e il monoteismo poté riconciliarsi con la necessità di obbedire a un sovrano e venerarlo
in quanto rappresentante di Dio». E, si deve aggiungere, anche dove l'assoluta divisione tra Stato e
Chiesa è posta con fermezza, il Dio cristiano rimane un Dio della presenza.
Il Dio del monoteismo giudaico, invece, il Dio che dà forma all'etica stessa del giudaismo e
all'identità ebraica, è un Dio dell'assenza. Un Dio, come scrive anche Freud, altamente
spiritualizzato, che non si manifesta più nelle natura, nel mondo e nelle immagini ma attraverso
qualcosa di nuovo, attraverso la Legge, attraverso gli insegnamenti della Torah rivelati, secondo la
tradizione, a Mosè sul Monte Sinai.
La Torah, come è noto, è composta dai primi cinque libri della Bibbia (Genesi-Esodo-LeviticoLibro dei numeri-Deuteronomio). L'intero corpus della bibbia ebraica, chiamato tanakh, è
completato dai Profeti e dagli Scritti. Accanto alla Torah scritta troviamo, nella tradizione ebraica, la
Torah orale, cioè l'insieme delle riflessioni sulla Torah stessa che si suppone sia stata comunicata
solo oralmente di generazione in generazione fino alla sua codificazione scritta nella Mishnah e nel
Talmud dopo la distruzione del Secondo Tempio. Le parole contenute nell'Esodo: «Poi Hashem
disse a Moshè: «Scrivi queste parole, perché sul significato di queste parole io ho stipulato
l'Alleanza con te e con Israele»», vengono spiegate con una felice definizione secondo cui le parole
sarebbero i precetti della Torah scritta e il “significato” delle parole sarebbe l'interpretazione di
queste parole, cioè dei precetti. E l'alleanza non è fondata sulle parole ma sul significato, vale a dire
sull'interpretazione, di queste parole.
Cosa ha permesso questo scarto tra il prima e il dopo, tra un paganesimo della pienezza e della
compresenza del divino e dell'umano, tra il legame con Dio che si manifesta, anche nel monoteismo
di Amenofi IV, nella vista, nel vedere Dio, fosse anche solo nel cielo, nel Sole, e questo nuovo Dio
che si rivela nella Parola? Nella Parola ascoltata da un solo uomo, Mosè, e poi consegnata per
sempre alla memoria e all'interpretazione degli esseri umani? A una Parola che è Legge ma Legge
che deve essere interiorizzata e compresa e non soltanto vissuta nelle azioni? In sostanza, cosa ha
permesso questo “progresso nella spiritualità”, questa capacità di «posporre la percezione
sensoriale alla rappresentazione astratta» e cosa li ha reso stabili?
Come già si è detto, mentre il cristianesimo trovò conforto nel sacrificio espiatorio del Figlio, il
giudaismo rimase una “religione del Padre”, una religione vincolata da un senso di colpa mai risolto
all’omicidio del Padre primigenio e, soprattutto, all’omicidio del Padre Mosè e alla sua teologia
politica così potente e capace di pervadere, come già Spinoza aveva sostenuto nel Trattato
teologico-politico, ogni aspetto dell’esistenza. Questo senso di colpa, potenzialmente paralizzante,
divenne invece la risorsa fondamentale del popolo ebraico poiché «fu messo al servizio di
imperativi morali sempre più rigorosi».
Tuttavia, questa posizione presenta alcune difficoltà: per prima cosa, Freud dà per scontata l’idea
che il monoteismo si presenti già in tutta la sua purezza nell'eresia di Eknaton e che ritorni, dopo un
periodo di latenza di circa seicento anni più forte di prima e, in secondo luogo, suggerisce che
questo senso di colpa inespresso e, di conseguenza, questo carattere “ebraico”, si ripetano di
generazione in generazione, filogeneticamente secondo Freud, senza soluzione di continuità.
Insomma, come scrisse Hanns Sachs nel suo libro Freud, maestro e amico : «sembra quasi che
Freud camminasse intuitivamente e inconsciamente sulle orme dei suoi antenati e seguisse una delle
tradizioni ebraiche più antiche: la credenza che tutti gli ebrei, nati o ancora da nascere, fossero
presenti sul Monte Sinai e che lì si fossero accollati per sempre “il giogo della Legge”». Per quanto
queste considerazioni di Sachs possano aiutarci a intuire la nota affettiva e autobiografica che
accompagna il lavoro di Freud su Mosè, è importante cercare di fare chiarezza su alcuni elementi
per non rischiare che le ipotesi più radicali e, apparentemente, meno scientifiche, indeboliscano o
possano indebolire l’impianto generale dell’impresa freudiana.
Per questa ragione, torno ora al lavoro di Assmann e alla sua maggiore accuratezza storica nella
ricerca dei molti motivi che si intrecciano in quella complessa esperienza racchiusa sotto il nome di
monoteismo giudaico.
Mosè come traccia della memoria
Assmann, prima di tutto, riconosce l'eccezionalità dell'eresia di Amenofi IV, il suo presentarsi come
una rivoluzione rispetto al paganesimo precedente ma, come già si è detto, riconosce anche che
questo monoteismo non presenta ancora quel carattere di rottura radicale tra Dio e mondo che sarà
proprio del monoteismo giudaico. In secondo luogo, fa di Mosè non un personaggio storico ma un
personaggio, o un prodotto, della memoria. Un simbolo, potremmo dire, che racchiude le molte
tracce lasciate da un lungo processo storico-politico.
Già nel XIX secolo, la reale esistenza di Mosè e la consistenza storica dei fatti narrati nell’Esodo
erano stati oggetto di discussione da parte della critica biblica. Si sosteneva, al più, che Mosè fosse
stato l’autore di un’alleanza tra Israele e un dio chiamato Yahweh ma che il monoteismo giudaico
fosse una tardiva creazione dei profeti dopo un passaggio graduale dal politeismo all'enoteismo.
Assmann si pone lungo questa linea quando afferma che il monoteismo giudaico, nella sua forma
più pura, è il frutto di un faticoso percorso di ricordo e rielaborazione, compiuto dai profeti, della
storia del popolo ebraico, della storia dei suoi contatti e dei suoi conflitti con i popoli vicini, nonché
l'esito finale di una serie di importanti traumi storici collettivi. Per questo scrive: «Mosè è una
traccia della memoria ma non della storia, laddove Eknaton è una traccia della storia ma non della
memoria». In sostanza: Eknaton visse realmente e realmente apportò un importante cambiamento o
una rivoluzione alla religione egizia (che poco dopo tornò nella sua forma originaria); Mosè non
visse realmente, o potrebbe non essere vissuto, ma nel suo nome, molti secoli dopo, prese forma il
vero monoteismo giudaico. Siamo comunque in presenza di una forma di latenza e di un ritorno del
rimosso che, nel caso di Assmann, non ha la forma dell'oblio e del ricordo della violenza compiuta
contro Mosè ma della stratificazione dei cambiamenti, dei traumi, degli avvenimenti vissuto dal
popolo ebraico, raccontata e codificata in un altro periodo altamente traumatico, vale a dire il
periodo che va dall'VIII-VII secolo al V, periodo in cui cadono anche la cattività babilonese e il
dominio persiano.
Il racconto dell'alleanza con il Dio senza immagine, con il Dio della distanza di cui si diceva prima
e del legame con la Legge e con la sua interpretazione che da quell'alleanza sorge, si sviluppa, nella
realtà storica, in un momento in cui il dispotismo politico e il rischio di una frammentazione
premono sul popolo ebraico spingendo i profeti, guide religiose e politiche insieme, a codificare e
canonizzare influenze che giungono dall’esterno (dall’Egitto ma anche dai trattati di vassallaggio
assiri che, secondo Assmann, si ritrovano nel “patto” politico tra Israele e Dio) per dare forma
definitiva a un’autorità assolutamente giusta e immutabile.
Un popolo deportato e oppresso, un popolo che conserva nella sua memoria, anche se forse in
maniera confusa, il ricordo di altre deportazioni e altre oppressioni, il ricordo di molti cambiamenti
legati alla mutevolezza e all'imprevedibilità del mondo umano e del mondo naturale, trova ora nel
racconto e nella trasmissione del suo legame con un Dio disincarnato e con una Legge che si pone
al di sopra di qualunque dipendenza da un sovrano e da un potere politico umano, una sublimazione
potentissima della sua richiesta di giustizia. Si genera, spostando questa genesi all'indietro,
all'interno di un passato normativo che dia eternità alle sue norme, la teologia politica
deuteronomica. Teologia che è sovversiva, scrive Assmann, sotto due punti di vista: poiché riduce il
re giudeo a un custode della legge divina e poiché sostituisce la dipendenza del popolo ebraico da
un sovrano (interno o straniero) con un'alleanza con Dio. La Torah, dunque, si pone come sostituta
dell’autorità umana e Dio sostituisce il sovrano sotto tre aspetti: 1) come legislatore; 2) come
interfaccia tra la legge e la storia; 3) come capo supremo di un'alleanza politica.
È bene precisare nuovamente che non si tratta di un cambiamento improvviso ma di un processo
lento, di un percorso di ricostruzione della storia del popolo ebraico attraverso molte tracce
mnemoniche raccolte e fissate per sempre dalle parole dei profeti. Un percorso che trova in Mosè il
fondatore “ideale” di questo processo di affrancamento dal mondo e di generazione di una Legge
così politica e umana eppure così radicata in un Dio definitivamente distante dal mondo.
La disincarnazione di Dio e della Legge
È da questo aspetto che si deve partire per ricavare alcune conclusioni e per riavvicinarsi al Mosè di
Freud. Ci troviamo di fronte a un dispositivo politico potentissimo, a un’autorità religiosa e civile
innalzata al livello, intoccabile, di un Dio senza volto e senza nome, un Dio che conosce, in
sostanza, il segreto della legittimità e della sopravvivenza nel tempo: sancire un’alleanza,
comunicare le proprie leggi e poi, progressivamente, rifugiarsi nell’assenza e nell’immaterialità.
Ecco, la formazione del carattere proprio e unico del monoteismo giudaico anche rispetto, come si è
visto, al successivo monoteismo cristiano, passa attraverso questo punto fondamentale, attraverso
ciò che si potrebbe riassumere nel concetto di disincarnazione: disincarnazione della tradizione
nella Legge, poiché la Torah, come scrisse il poeta ebreo tedesco Heine, si trasforma in una “patria
portatile” la cui validità e la cui sacralità prescinde dalla possibilità di eseguire riti all'interno di un
contesto proprio, famigliare. La Legge, in sostanza, rimane anche quando intorno niente o nessuno
ricordano il loro legame tangibile con quella Legge. Assmann afferma che si interrompe, con il
monoteismo giudaico, l’atteggiamento mimetico nei confronti della tradizione: cioè non si
appartiene più a quel popolo e a quella tradizione perché si imitano i comportamenti che si ritrovano
nel mondo circostante e negli altri. Ma vi si appartiene perché si interiorizza questa esperienza
religiosa e la sua portata normativa in qualunque tempo, luogo e situazione.
Ancora più importante è però l’aspetto della disincarnazione di Dio e della sua alleanza con il
popolo ebraico: la contrapposizione netta all'idolatria è la contrapposizione con cui il giudaismo si
distingue dal resto del mondo, che viene ora rappresentato come escluso e pagano. Il rifiuto di quasi
tutte le forme di comunicazione o contatto visivo, percettivo, con il divino, fecero sì che
l'esperienza e la pratica religiosa si concentrassero interamente sulle Scritture, sul loro studio, sulla
loro comprensione e interpretazione. Israele si trasforma in un “popolo di sacerdoti”, in un popolo
che trasferisce l'atteggiamento nei confronti delle immagini di culto alla Scrittura. Le immagini
sono false e profane, il linguaggio è kosher. Non sono gli occhi del fedele a essere rivolti a Dio ma
la sua mente, la sua capacità di interiorizzare la Legge e di accettarla all'interno di un principio che,
proprio perché fondato sul linguaggio, non può esimersi dall'essere anche dialogico, interrogativo,
filosoficamente rivolto alla verità come ricerca ininterrotta della verità.
Scrive ancora Assmann: «L'ebreo emigra nelle Scritture» e in questo modo si deve comprende il
passo biblico “Io sono straniero sulla Terra, non nascondermi i tuoi comandamenti”. Il mondo
intorno, conosciuto dal popolo ebraico fin dal principio in tutta la sua durezza e mutevolezza
politica e religiosa, diventa definitivamente straniero ma ora, a differenza del passato, il popolo
ebraico ha la Torah, la nuova patria, e un nuovo sovrano, il Dio senza volto posto al di sopra del
tempo e della storia.
Non si tratta, è evidente, di sancire la nascita di una mistica totalmente priva di rimandi alla realtà.
Al contrario. Si tratta, seguendo in questo anche Freud, di comprendere un processo che nasce,
indipendentemente dalla realtà storica dei suoi protagonisti e dalla corretta disposizione degli
avvenimenti nel tempo e nella storia, di un processo che nasce dai traumi che la collettività causa e
subisce, dalla violenza e dalla tragicità che sono proprie di ogni esperienza individuale e collettiva,
dalla richiesta di fuga e di giustizia che trovano, nella particolare storia del popolo ebraico, nella sua
genesi e nel suo sviluppo, un esito del tutto nuovo, un esito che prende forma in questo Dio senza
volto, in questo Dio che affida all'uomo la sua Legge ultrastorica (eppure aperta alla continua
comprensione e interpretazione legate, evidentemente, alla storia e ai cambiamenti del pensiero
umano) per poi allontanarsi. Questo Dio non è un dio che torna sulla terra, anche se in un altro
forma. Non è il Padre che manda il Figlio a testimoniare la possibilità di una nuova alleanza perché
quel patto è già stato posto una volta per sempre. Lo stesso messianesimo ebraico è, nel suo senso
ritenuto più vicino e fedele alla tradizione, un messianesimo definito “restaurativo”, non proiettato
verso un ritorno futuro ma verso un ritorno all’origine, a ciò che è già stato ed è già stato dato. Si
tratta dunque di una distanza che farà del ricordo il legante tra i membri del popolo ebraico. Un
ricordo capace di creare un’identità che supera la fede stessa in Dio. Riconoscersi come ebrei, nella
fede o oltre la fede, non è soltanto, come scrive Strauss, «non sfuggire al proprio destino»,
«accettare la Sparta che ti è stata data» ma riconoscersi in un processo interminabile di riflessione
che, in un'ultima analisi, coinvolge più che l'essenza del divino, l'essenza stessa di ciò che è umano
o, meglio, l'essenza di ciò che è tragicamente umano.
Il Dio d’Israele non accetta sacrifici e non si sacrifica per il mondo. Non sottrae al mondo i suoi
peccati e non li sottrae certo al suo popolo. Il Dio d’Israele lascia al mondo i suoi peccati e offre al
suo popolo le leggi e i mezzi per comprenderli o addirittura per giustificarli, anche quando, o
soprattutto quando, sono commessi contro di esso. Un dio curioso, un dio che dovrebbe generare
insofferenza, piuttosto che fedeltà. Ma, probabilmente, il senso ultimo di un dio che sancisce
l’alleanza per poi allontanarsi per sempre, lasciando solo la Legge all’uomo, è forse quello di un dio
che impone la responsabilità del male all’uomo stesso. Se Cristo, come vuole Girard, è vittima che
rivela la natura di tutte le vittime agli esseri umani, è però anche una vittima che ritorna al
sacrificio, che si lascia sacrificare, aprendo con questo la possibilità di nuovi sacrifici e nuove
assoluzioni. Il Dio ebraico, invece, abbandona il suo stesso popolo al suo destino ma lo rende anche
consapevole della necessità etica non soltanto di non compiere il male ma anche di non potersi più
liberare dal male attraverso una cultura sacrificale.
Da questo punto di vista, ciò che Freud scrive al termine dell'Avvenire di un'illusione: «di certo la
religione non ha reso gli uomini più morali nemmeno nel suo momento di massima forza: gli
uomini hanno sempre trovato il modo di esteriorizzare le prescrizioni religiosi vanificandone così
gli intenti. I preti li aiutarono in ciò. La bontà di Dio doveva trattenere il braccio della sua giustizia;
si peccava e allora si faceva un sacrificio o una penitenza e si era liberi di peccare di nuovo» non
può valere per l'ebraismo nella sua espressione più pura e Freud ne è consapevole. La rinuncia
pulsionale e l'interiorizzazione che accompagnano la sua evoluzione fanno dell’ebraismo una forma
particolare di “nevrosi universale collettiva” o, meglio, rendono l’ebraismo la forma più compiuta
di trasposizione del rapporto con il padre nella figura di un dio assolutamente potente, così potente e
lontano da dare valore normativo anche alle richieste più difficili e alle rinunce più dure. Eppure, si
tratta di un'obbedienza posteriore anomala poiché nell’interpretazione della Torah,
nell’interpretazione della Parola, gli ebrei conquistano inaspettati e progressivi spazi di libertà
individuale e di sviluppo intellettuale.
Per concludere, cercando di tornare al punto di partenza, vale a dire all'idea che il contributo su
Mosè di Freud vada letto prima di tutto come un contributo al dibattito sull'identità ebraica e alla
sua capacità di sopravvivere, faccio riferimento a un saggio che Lévinas scrisse a commento di un
breve testo, Yossl Rakover si rivolge a Dio (testo spesso considerato come un moderno salmo di
Giobbe, come il ritorno, nel momento più terribile per gli ebrei, di una domanda a Dio sul male e
sulla sua origine), in cui il filosofo afferma: «Sulla strada che porta al Dio unico c'è una stazione
senza Dio. Il vero monoteismo ha il dovere di rispondere alle legittime esigenze dell'ateismo. Un
Dio per adulti si manifesta per l'appunto attraverso il vuoto del cielo infantile. Momento nel quale
Dio si ritira dal mondo e nasconde il volto … Dio che nasconde il volto: non è, a nostro parare,
un'astrazione da teologo e neppure un'immagine poetica. Rappresenta l'ora in cui il giusto non trova
alcuna risorsa esterna, in cui nessuna istituzione lo protegge, in cui vien meno anche la
consolazione della presenza divina nel sentimento religioso infantile, in cui l'individuo non può
trionfare se non nella propria coscienza, vale a dire necessariamente nella sofferenza».
Significativamente, questo saggio è intitolato Amare la Torah più di Dio e credo che, pur da una
prospettiva così diversa, riporti a quanto è stato detto a proposito della genesi e dello sviluppo del
monoteismo giudaico: oltre le incertezze storiche, rimane l’esperienza di un popolo che si affranca
dal mondo attraverso l’assolutizzazione del rapporto con il Padre e con i suoi divieti fino al punto in
cui, grazie al ricordo e alla sua canonizzazione, questo rapporto si fa esclusivamente Legge. Legge
che mantiene la sua forza ma che si piega anche, come compensazione alla mancata espiazione del
senso di colpa provato, alla comprensione, allo sforzo intellettuale, alla sublimazione delle pulsioni
nella forma della conoscenza. Legge che pone l’unicità e l’onnipotenza di Dio ma che apre anche al
rischio del vuoto, del senso di abbandono nel bisogno, della ricerca di un senso che riconduce,
fatalmente, solo all’interiorità dell’essere umano poiché non si risolve, né si rinnova, nel sacrificio,
nella fantasia di espiazione che si concretizza.
In questo, in questa immaterialità di Dio che lascia agli uomini solo la sua assenza e la sua Parola da
comprendere, in questa illusione che apre all’interrogazione individuale più che al conforto, anche
l’ateo Freud continuò a sentirsi indelebilmente ebreo.