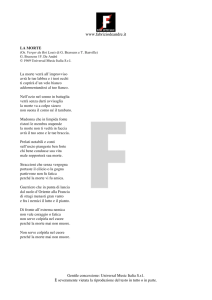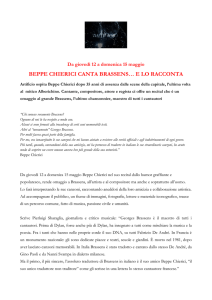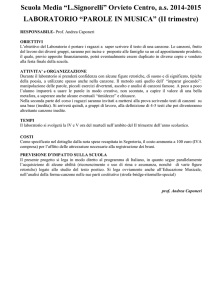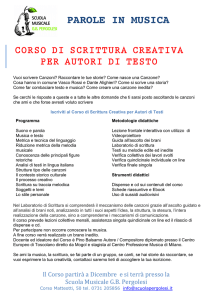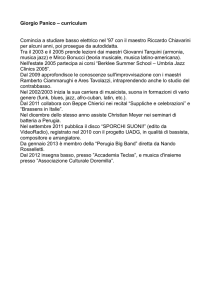STAGIONE 2016/ 2017
DEGNI DI NOTA
Tra Gaber e Brassens
Libretto di sala a cura di Claudia Braida
Venerdì 18 novembre 2016
Ore 21.00
Per me cultura è un "modo di interrogazione".
Posso dire che in me, esistenzialmente, l'interrogazione è centrale,
per capire di più di sé, del mondo. Il fascino di questo mestiere d'artista
è proprio avere dentro questa cosa, questa interrogazione.
Giorgio Gaber
Testi di: Alberto Patrucco, Antonio Voceri, Georges Brassens, Giorgio Gaber,
Sandro Luporini, Federico Monti Arduini
Regia di: Emilio Russo
Costumi: Pamela Aicardi
Luci: Mario Loprevite
Musiche di: Georges Brassens, Giorgio Gaber
Arrangiamenti e Direzione musicale: Daniele Caldarini, Andrea Mirò
Assistente alla regia: Fabio Zulli
Con: Andrea Mirò, Alberto Patrucco
Daniele Caldarini (pianoforte, tastiere)
Francesco Gaffuri (basso, contrabbasso elettrico)
Giuseppe Gagliardi (batteria, percussioni)
Voci fuori campo di G. Gaber e G. Brassens di: Marco Balbi, Alarico Salaroli
Service: Theatre Project
Fonico: Simone Pirovano
Proiezioni: Riccardo Russo
Produzione: TiEffe Teatro Milano.
Si ringrazia la Fondazione Gaber.
Ho sempre pensato che il teatro fosse anche arte dell’incontro. Incontro tra le
persone in platea, tra questi e il palcoscenico, incontro tra gli attori, incontro e
scontro tra l’attore e il suo personaggio. Incontro di lingue e linguaggi, di
espressioni artistiche contaminate, incontri attraverso il tempo tra il passato e il
presente. Incontri veri e, a volte, immaginati. In Degni di Nota gli incontri sono
multipli. Intanto quello tra un attore/autore come Alberto Patrucco, straordinario
ed efficace stand up comedian, e una musicista/autrice di particolare sensibilità e
carisma come Andrea Mirò, qui per la prima volta impegnata anche come attrice;
poi quello tra la parola e la musica, tra la comicità d’autore e la canzone d’autore
per scoprire che raccontano di storie simili, storie individuali e collettive del nostro
tempo. Ma se il teatro può immaginare, o meglio far immaginare, luoghi, tempi e
personaggi, può anche far incontrare chi non si è mai incontrato per distanza di
luoghi o differenze di tempo. E’ il caso di un altro incontro “degno di nota”, quello
più audace ed impossibile, quello tra i due Giorgio, quello tra Gaber e Brassens.
Sono loro a delineare il percorso dello spettacolo, con quanto ci hanno lasciato in
canzoni, poesia, visione della vita. A volte sguardi opposti, che paiono
allontanarsi, si incrociano e poi ancora si allontanano. Abbiamo provato a
sottolineare i grandi temi della loro poetica, la vita, la morte, l’amore costruendo
le tappe di uno spettacolo di teatro musicale tra incroci e digressioni, dove il loro
presente, quello dei due “Giorgi”, si incontra con il nostro, in particolare quello
raccontato dalla comicità a forti tinte di Alberto Patrucco, anche autore di
traduzioni salaci e colorite delle straordinarie canzoni di Brassens. La sfida
registica è stata quella di tracciare una articolata linea rossa lungo la quale
sistemare, o provare a sistemare, le tessere di un mosaico, o forse meglio, le
schegge di un “cluster”, un’esplosione pacifica di parole, musica, idee e
suggestioni, non sempre e volutamente controllabile, spesso e involontariamente
sorprendente. Uno spettacolo, Degni di Nota tra Gaber e Brassens dove si ride, si
riflette, forse si pongono delle domande, magari quelle per completare un
mosaico rimasto incompiuto, o magari per arricchire l’incontro con le persone in
platea. Incontro, appunto.
Emilio Russo
In Degni di nota, due è il numero perfetto. Due, come Georges Brassens e Giorgio
Gaber. Due, come Alberto Patrucco e Andrea Mirò, così come i codici espressivi
che si incrociano sulle tavole del palcoscenico: la canzone d’autore e la parola,
volutamente in bilico tra due – ancora una volta il due! – cifre stilistiche,
l’umorismo e la poesia. Degni di nota è tutto questo. È uno spettacolo di Teatro e
Canzone che scava nel tempo per brillare di luce propria nella più stretta
attualità, dando profondità prospettica, tra le altre, ad alcune tematiche
anticipate in anni non sospetti dai due Maestri d’antan. È una fusione di epoche,
ieri e oggi; una miscela di stili, l’anarchico “minimalismo” brassensiano e il
caustico “massimalismo” gaberiano; un’accoppiata di voci, quella profonda di
Alberto Patrucco e quella inconfondibile di Andrea Mirò; un ampio ventaglio di
emozioni, dalla risata liberatoria alla struggente malinconia, dall’ironia più sottile
al graffio della satira, in un entusiasmante incedere di canzoni, monologhi e
sonorità, sapientemente dosati dalla perfetta regia di Emilio Russo e da una band
di ispirati musicisti. La varietà dei temi, ostinatamente rivolti a scartare gli stanchi
cliché della comicità di oggi, portano lo spettatore a ridere con intelligenza
dell’amore, della vita e anche della morte. Niente celebrazioni, quindi, bensì l’idea
di unire, seppure in epoche storiche diverse, sensibilità tanto affini, punti di vista
che coesistono in perfetta armonia, anche grazie al tessuto connettivo della
musica. Uno spettacolo importante, neanche a dirlo, degno di nota, che resta a
lungo nella testa e nel cuore. Già, testa e cuore, ancora una volta il due.
Alberto Patrucco
Alberto Patrucco
Si avvicina al mondo artistico attraverso la
musica. Questa formazione, la conoscenza
del ritmo e della musicalità, avrà un peso
determinante nella costruzione dei suoi
monologhi e del suo modo di fare teatro.
Debutta ufficialmente nel 1976 al Teatro
Cabaret La Bullona a Milano. Entra in
contatto con il mondo del cabaret e assimila
l’etica e il modo di intendere e fare
spettacolo di quegli anni. La proposta artistica di Patrucco è semplice e in linea
coi tempi: monologhi e ballate, eseguite al pianoforte o alla chitarra, per
raccontare storie con parole e canzoni originali, per lo più umoristiche. Tra la fine
degli anni 70 e gli inizi degli anni 80, inizia un’intensa attività in molti locali
milanesi e, nelle nascenti tivù private, affronta le prime esperienze televisive (in
particolare, su Antenna Nord – l’attuale Italia 1, allora di proprietà dell’editore
Rusconi – conduce Dedicomania, un programma comico ispirato dal vivace
mondo delle radio libere). Con il boom commerciale del cabaret, grazie alle doti
dimostrate sul palco e al proliferare di agenzie di spettacolo, Patrucco allarga il
suo raggio d’azione in tutta Italia. Dal 1980 al 1990 propone una serie di
spettacoli che a buon diritto entrano nella storia di questo genere. Abbandonata
la musica, per un decennio sperimenta, approfondisce il monologo satirico puro,
sviluppando uno stile personale e inconfondibile, riprendendo le canzoni solo in
qualche occasione. Sono di quegli anni gli spettacoli: Gira la terra gira,
Superfluomania, Kitsch boom, Pesi massimi e Contromano. A partire dal 2000, le
esperienze televisive si sommano: i primi Zelig e Colorado cafè, oltre a Funari
news, Ballarò e la più recente Xlove, su Italia 1, nel 2015. È in questo periodo che
definisce l’argomento centrale del suo cabaret, ovvero, l’originale tesi del
“Pessimismo comico” che prenderà vita attraverso tappe precise e ben delineate:
• dal 2000 al 2005 elabora Tempi bastardi;
• nel 2005 prende parte alla Trentesima Rassegna della Canzone d’Autore,
organizzata dal Club Tenco e trasmessa da RAI DUE;
• dal 2006 Vedo buio!. A partire dal 2007, riprende il discorso musicale interrotto
anni addietro. Col consenso degli eredi, inizia ad adattare e interpretare alcune
opere di Georges Brassens mai tradotte in italiano. Torna a cantare e dà vita a
uno spettacolo comico inusuale: un incontro tra satira parlata e satira cantata.
Inizia così un percorso che lo condurrà a numerose e varie esperienze.
• Dall’ottobre 2007 al febbraio 2009,
scrive per Emme, il settimanale satirico
diretto da Sergio Staino.
• Nel 2008, esce Chi non la pensa come
noi – Alberto Patrucco interpreta
Georges Brassens.
• Dal 2009 al 2011, mette in scena lo
spettacolo di comicità e canzoni Chi non
la pensa come noi.
• Nel 2010, è la volta di Necrologica – Un libro lapidario. Si tratta di una moderna
Antologia di Spoon River, in salsa umoristica, arricchita dalle illustrazioni di Sergio
Staino e da un raffinato cd musicale.
• Dal 2012 al 2013, va in tour con Molestia @ parte, ancora con la formula
collaudata Comicità e Musica d’Autore.
• Da gennaio a giugno 2014, Satira volante. Appuntamento umoristico
settimanale, in diretta, per Ottovolante – RAI Radio2.
• Nel 2014, esce Segni (e) Particolari – Alberto Patrucco e Andrea Mirò cantano
Georges Brassens. Tredici nuove traduzioni, frutto dell’emozionante percorso
compiuto tra le parole e la musica del più raffinato cantautore francese del
secolo scorso.
• Dal 2014, Segni e particolari diventa spettacolo, con Andrea Mirò in scena.
• Il 27 Giugno 2015, Patrucco è unico protagonista al Festival Brassens Auprès de
son arbre a Parigi.
• Dal 2015, lo spettacolo teatrale trova il suo approdo ideale: Degni di Nota – Tra
Gaber e Brassens, con Andrea Mirò.
Dal 2002 l’impegno creativo, motore degli spettacoli dal vivo, delle pubblicazioni
e dei monologhi televisivi, è condiviso con Antonio Voceri. Nel 2005, gli viene
assegnato il Premio Charlot (Cabaret con la K). Nel 2007, il Premio Walter Chiari,
il Premio Satiroffida e il Delfino D’oro. Nel 2010, Il Premio Paolo Borsellino per
l’impegno culturale. Tutta l’opera di Alberto Patrucco si può considerare come un
gigantesco work in progress che ruota attorno alla spiazzante tematica del
pessimismo comico. L’autore è alla perenne ricerca della singolare
normalizzazione di questo tema che racchiude la sua visione del mondo. Sul
palcoscenico e nei suoi libri, sviscera la realtà rivoltandola e trovandone gli amari
ed esilaranti lati comici. La scrittura rimane l’elemento centrale del discorso
artistico di Patrucco, il punto di partenza: il contenuto comico è più importante
dell’effetto esilarante.
Andrea Mirò
La sua carriera artistica è cominciata a Calliano
negli anni ottanta come solista, e, dopo un
breve periodo di interruzione, è ripresa nel
1994 nella band di Enrico Ruggeri; in seguito
ha proseguito la carriera solista, continuando
contemporaneamente la collaborazione con
Ruggeri. Ha vinto l'edizione del Festival di
Castrocaro del 1986 con Pietra su Pietra. Come
solista ha partecipato al Festival di Sanremo
quattro volte: nel 1987 con Notte di Praga, nel 1988 con Non è segreto, nel 2000
con La canzone del perdono e nel 2003, in coppia con Enrico Ruggeri, con
Nessuno tocchi Caino.
Nel 2001 pubblica l'album Lucidamente, del quale è autrice di tutte le musiche e
dei testi, ad eccezione della cover The fairest of the seasons, canzone di Jackson
Browne, nota soprattutto nell'interpretazione di Nico. In questa canzone duetta
con David Surkamp dei Pavlov's Dog. Nel 2002 ha diretto l'orchestra al Festival di
Sanremo per il compagno Enrico Ruggeri che partecipa con il brano Primavera a
Sarajevo di cui è anche coautrice.
Nell'aprile 2007 esce l'album A fior di pelle preceduto dal singolo Il vento.
L'album contiene una collaborazione con Neri Marcorè nel singolo Preghierina
dell'Infame e anche una cover del brano Don't Let Me Be Misunderstood di Nina
Simone. Alla fine del 2008 collabora con il compagno Enrico Ruggeri alla
realizzazione della colonna sonora per il film East West East - Volata finale, del
regista albanese Gjergj Xhuvani, che verrà pubblicata l'anno successivo
nell'album All in - L'ultima follia di Enrico Ruggeri, al quale partecipa anche in
qualità di produttrice oltre che come musicista e cantante in un trio nel brano
Sulla strada.
Nel 2010 al Festival di Sanremo dirige l'orchestra per il compagno Enrico Ruggeri
che si esibisce col brano La notte delle fate e per Nina Zilli che porta al festival
L'uomo che amava le donne. Nel marzo 2012 duetta con la cantautrice Roberta
Di Lorenzo in Menti distratte contenuto nell'album della Di Lorenzo Su questo
piano che si chiama Terra. A maggio 2012 esce l'album Elettra e Calliope. Nel
2013 ritorna nuovamente al Festival di Sanremo dove dirige l'orchestra per il
cantautore Andrea Nardinocchi, esibitosi nella categoria "Giovani". Sempre nello
stesso anno riceve il Premio Lunezia Doc 2013 per la qualità Musical-Letteraria
delle sue canzoni.
Anche nel 2014 è al Festival di Sanremo nelle vesti di direttrice d'orchestra per il
gruppo Perturbazione (categoria "Campioni") e Zibba (categoria "Nuove
proposte"). Nel 2014 fa parte della giuria italiana all'Eurovision Song Contest.
Nell'aprile 2016 esce l'album Nessuna paura di vivere, prodotto da Manuele
Fusaroli, in cui collaborano tra gli altri Brian Ritchie e Nicola Manzan.
PER APPROFONDIRE
Giorgio Gaber, lungo viaggio biografico attraverso le sue parole
La storia di Giorgio Gaberscik, in arte Gaber, inizia il 25 gennaio 1939 in via
Londonio 28, a Milano.
Sono cresciuto in una famiglia piccolo-borghese, in una piccola casa, con le
abitudini e il tenore di vita di allora (...) si aveva un paio di scarpe sole e quando
queste finivano se ne compravano delle altre, il che era certo un buon segno.
Sacrifici, sicuro, ma all'insegna di un'essenzialità che oggi in qualche modo
potremmo anche rimpiangere. Mio padre era impiegato (...) mia madre era
casalinga, e mio fratello Marcello, più grande di me di sette anni, si era diplomato
geometra e suonava la chitarra. Mio padre suonava un po' la fisarmonica, quindi
un minimo di musica in casa c'era. Io poi, che avevo avuto un'infanzia piena di
malattie e di rotture di coglioni tra cui un infortunio a una mano, usai la chitarra
anche come sostegno e recupero del mio inserimento. (...) Io direi che tutta la mia
carriera nasce da questa malattia, la quale ha fatto sì che abbia voluto reagire ad
essa con la chitarra, portandomi così a fare questo lungo percorso nella musica.
Anni Sessanta
Inizia a comporre, quando è ancora studente.
La mia prima veglia come chitarrista la faccio a quattordici anni, guadagno 1.000
lire, la mia paga di chitarrista per quel Capodanno, e in quel momento non ho
nessuna intenzione di cantare, non mi sfiora proprio il dubbio – non è che suono
la chitarra perché voglio cantare, no; faccio
solo il chitarrista. (...) Fino al momento
dell'incontro con Celentano, perché io ero
proprio il chitarrista di Celentano. (...) Jannacci
c'era anche lui, anche lui era studente come
me, eravamo tutto un gruppo intorno a questo
Celentano, questo strano personaggio che ci
chiamava a suonare e ci dava anche i primi
soldi che guadagnavamo; lui sceglieva noi anche perché eravamo dei musicisti
che conoscevano il jazz, dato che i musicisti delle balere in quel periodo
suonavano veramente solo tanghi e valzer; noi eravamo invece un po' più
disponibili, vista la nostra formazione jazzistica, a fare delle cose un po' più
rockeggianti.
L'esordio discografico avviene con Ciao ti dirò, scritta con Luigi Tenco e incisa
dalla casa Ricordi. Legata a questa canzone è la prima apparizione televisiva di
Gaber nel programma "Il Musichiere" di Mario Riva, nel 1959.
“Ciao ti dirò" in realtà l'abbiamo scritta io e Tenco. Suonavamo in un locale con
una sorta di trio alla Nat King Cole, basso, chitarra e pianoforte, e cantavamo un
po' tutti, avevamo fatto una stagione estiva insieme, io infatti in quell'anno mi
ero appena diplomato. Poi un signore della Ricordi, sul cui biglietto da visita c'era
scritto Giulio Rapetti, mi chiamò perché voleva farmi incidere dei dischi, così
andai a fare il provino e mi chiesero di cantare qualcosa. (...) Io fui praticamente il
primo a fare un rock italiano, ad imitazione di un altro cantante, che faceva un
altro genere di musica ma che era sempre in qualche modo rockeggiante, e che
era Tony Dallara.
Nel 1959, in un noto locale milanese, il Santa Tecla, quasi una "cave" parigina,
conosce Sandro Luporini, che sarà il coautore di tutta la sua produzione
discografica e teatrale più significativa.
Conosco Sandro da quando avevo 19 anni. Per me, è stato un maestro di estetica.
(...) Eravamo ragazzi, vicini di casa a Milano. Io frequentavo un gruppo di pittori e
ci incontravamo per scambiarci idee. Nel gruppo c'era Sandro, più grande di me
di sette, otto anni. Abbiamo cominciato a scrivere per gioco, io facevo il
cantante televisivo e le canzoni che scrivevamo non erano adatte, ma al primo
spettacolo teatrale lui già c'era (...) anche se allora non firmava, perché non era
iscritto alla Siae. Per la verità qualche canzone a quattro mani l'avevamo già
scritta. Per esempio "Barbera e champagne".
Negli anni '60 la stesura di alcuni testi di maggior successo di Gaber è a cura dello
scrittore Umberto Simonetta. Si tratta di ballate ispirate al repertorio popolare
milanese: Porta Romana, Trani a gogò, La ballata del Cerutti, Le nostre serate,
che piacque molto a Eugenio Montale, Il Riccardo, Una fetta di limone, cantata
insieme a Jannacci in versione duo "I corsari".
Quando Gaber inizia a cantare, Milano è in una fase di originale crescita
culturale: ci sono Dario Fo, Paolo Grassi, Giorgio Strehler, Franco Parenti. Nasce
proprio in questi anni la definizione di 'cantautore', nell'ottica della rivalutazione
del testo della canzone, in antagonismo con la musica leggera della tradizione
italiana melodica e sull'onda delle risonanze della "chanson" francese.
Tutti quanti affrontammo il discorso cantautorale di quegli anni come una
soluzione a metà tra le influenze americane subite fino a poco prima e questa
canzone francese che via via ci aveva affascinati. Dunque nel '60 cominciano ad
esserci "La gatta" di Paoli, la mia "Non arrossire", "Quando" di Tenco, poi Bindi
con "Il nostro concerto", "Arrivederci", canzoni che in qualche modo si staccano
da una colonizzazione totale da parte dell'America, e cercano di riacquistare
un'autonomia e una sincerità, non dico culturale, ma certamente di intenti. Tutti
quanti abbiamo fatto un piccolo passo in avanti ed abbiamo cominciato a
prendere le cose sul serio, perché prima veramente si scherzava. Nessuno
pensava fino a quel momento che quel tipo di divertimento potesse diventare una
professione.
Dopo gli inizi brucianti, Gaber amplia i suoi interessi artistici; diventa molto
popolare: partecipa a quattro edizioni di Sanremo; nell'estate 1966 ottiene il
secondo posto al Festival di Napoli A pizza. Il pubblico
televisivo lo scopre e lo apprezza in rubriche musicali
e spettacoli di cui è ideatore-cantante-conduttore,
come Canzoniere minimo (1963), una delle prime
trasmissioni dedicate alla musica popolare e d'autore,
e E noi qui (1970), varietà del sabato sera sulla prima
rete, dove propone alcuni pezzi scritti con Sandro
Luporini che troveranno poi un ambito più congeniale
nel teatro, con Il signor G. Nella vita personale di
questi anni: nel 1965 si sposa con Ombretta Colli; nel
1966 nasce la figlia, Dalia.
C'erano stati i beatnik, il rock'n'roll, i primi dischi che i ragazzi comperavano da
soli senza i genitori. E poi sono gli anni in cui mi innamoro. Ombretta studiava
cinese e russo alla Statale, io andavo a prenderla con l'auto da cantante, con la
Jaguar, e loro per questo non dicevano niente. Di quegli anni mi avevano colpito
soprattutto due parole che sentivo ripetere molto spesso: rifiuto ed essenzialità.
Anni settanta
Nel biennio 1969-'70 è protagonista di una
tournée teatrale con Mina. È l'inizio della
svolta artistica: l'impegno teatrale, la
rinuncia cosciente oltre che alla televisione
anche all'attività discografica, e la scelta del
teatro, appunto, come luogo di espressione
diretta senza condizionamenti e filtri tra
l'artista e il suo pubblico. Il percorso artistico
di Gaber diventa lineare e conseguente: fare
della canzone non più un fine, ma un mezzo da adattare alla forma di
comunicazione teatrale.
Dopo un tour di due anni con Mina ho scoperto il teatro, la gente che ti viene a
sentire e guardare. Ho capito che volevo fare quello. Mi piaceva Dario Fo, ma
volevo essere diverso da lui. E poi il mio maestro, sa anch'io ho dei maestri..., è
stato Jacques Brel. Però devo dire che non c'erano solo queste cose, si sentiva
l'aria dell'impegno.
L'originale percorso artistico della "canzone a teatro" prende il via dallo
spettacolo Il signor G, che debutta il 22 ottobre 1970. Il successo del "Signor G" è
qualitativo ma non quantitativo. Evidentemente il pubblico del Gaber televisivo
non è lo stesso che frequenta i teatri, ma alla fine delle rappresentazioni gli
applausi sono calorosi e il pubblico presente si passa la voce. Con Dialogo tra un
impegnato e un non so (1972-'73) inizia la lunga stagione del "tutto esaurito", che
durerà, senza eccezioni, fino all'ultimo spettacolo. (Con Il signor G., ebbe 18.000
spettatori; con "Dialogo tra un impegnato e un non so" toccò le 166 recite con
130.000 presenze; "Far finta di essere sani" in 182 recite raggiunse i 186.000
spettatori).
Era tale la gioia, l'entusiasmo che mi procuravano questi nuovi incontri in teatro,
economicamente tutt'altro che soddisfacenti! Perché questo va detto: quando
smisi con la TV i teatri me li trovai vuoti, non pieni! Azzerata la mia immagine
televisiva, mi ritrovavo senza alcun aiuto da parte della stampa, affidato al solo
passaparola del pubblico, che allora era allucinante. Rifiutare la TV era un
privilegio che potevo permettermi, avendo da parte qualche soldino, ma ricordo
d'essere andato un anno in certi teatri e di aver fatto 100 persone, salvo poi
tornarvi l'anno dopo e farne 2.000! C'era veramente un bisogno di qualcosa che
non fosse la televisione, grande dominatrice invece degli anni Sessanta, e la mia
è stata una conquista graduale, persona per persona, di un nuovo pubblico!
Il signor G" era uno spettacolo a tema, con canzoni che sviluppavano il tema, con
monologhi, racconti, situazioni. Erano canovacci ricchissimi di spunti e
provocazioni sulla situazione reale e di collegamenti con le questioni "eterne" del
vivere. La gente si è vista arrivare addosso una forma ed un materiale di
spettacolo "strano" a cui ha reagito come pubblico teatrale. D'ora in avanti, ogni
spettacolo di Gaber rappresenta una tappa del suo processo evolutivo
individuale di presa di coscienza e di approfondimento della realtà, personale e
sociale.
Piano piano, impari a usare un linguaggio nuovo, diverso, a misura di teatro. Una
delle regole fondamentali, per esempio, è la necessità di usare diversi "archi"
espressivi anche all'interno di una canzone breve: per questo il "crescendo" è una
pratica ricorrente nel mio teatro, mentre è rarissimo che io mantenga per tre o
quattro minuti consecutivi un clima teso, fermo, immobile. Ecco, direi che il
teatro ti costringe a "muoverti", e a permeare di questo movimento anche la
musica. E ti accorgi che il nuovo linguaggio, mano a mano che te ne impossessi, ti
offre, come interprete, infinite possibilità in più, proprio perché mette alla prova
la tua capacità di adattarti a una gamma di toni molto più ampia, a sbalzi
improvvisi, a rovesciamenti di fronte.
Dal signor G in poi (tranne alcune rarissime
eccezioni) tutti i dischi incisi da Gaber hanno
soprattutto un valore di documentazione del lavoro
teatrale, a conferma del fatto che il suo interesse è
soprattutto volto alla verifica diretta con il pubblico.
E il pubblico ricambia con un numero di presenze agli
spettacoli senza precedenti nella storia del teatro
italiano, pur non essendo sollecitato dalla pubblicità
attraverso i canali consueti di promozione, di cui
Gaber non fa uso. Un dato solo indicativo: dal 1972 al
1982, accumula la vertiginosa cifra di due milioni di biglietti venduti. Ma oltre la
bravura dell'interprete e l'importanza dei testi, nel teatro di Gaber è il "fatto" che
risulta interessante: accade che l'intensità del coinvolgimento è tale che il flusso
di energia si fa "materia": cambia la qualità del clima, sul palco e in sala, durante
e dopo lo spettacolo... per questo il rapporto tra il pubblico di Gaber e ciò che
avviene sul palcoscenico va molto oltre la "piacevole" serata a teatro.
In quello che dico, credo di attingere molto, anche dal punto di vista della
recitazione, dai miei modi della vita. Quando recito non mi dico: in questo
personaggio devo entrare gobbo e faccio Riccardo III: no, entro normale. È come
se il mio teatro non avesse soltanto la barriera di quello che accade sul
palcoscenico e della gente che lo vede, ma tenesse conto che c'è un uomo che
esce dal camerino, che va sul palcoscenico e dice: siamo qua, parliamone e
vediamo un po' cosa succede. Esistono due modi di far spettacolo: o vai sul
palcoscenico per farti vedere (e quindi affermi te stesso), o ci vai perché cerchi
una comunicazione col pubblico. Non dico che con noi in teatro si formi
un'appartenenza, ma certo nasce qualcosa che ne fa parte. Sa perché alla fine io
grido, faccio queste smorfie, ho queste reazioni? Perché mi vergogno, e mi
vergogno perché sono stupito di questo riconoscimento che avviene tutte le
sere su cose che io e Luporini abbiamo in qualche modo scoperto per noi stessi.
È questo che rende il mio mestiere uno dei più belli che si possano fare. Cosa
volere di più, per 120 sere all'anno?
Con "Il Signor G" mi sono acquistato il grande privilegio di dire, di cantare in
teatro quello che sono e quello che penso, al di là dei condizionamenti del
mestiere dei quali prima risentivo. Poi, "Libertà obbligatoria", ti ripropone la tua
responsabilità individuale, si scaglia contro le finte aggregazioni – questo fasullo
desiderio di una falsa coscienza – e ti ributta
in faccia una tua responsabilità individuale,
perché oggi che la produzione ti divora e ti
entra nei polmoni, è diventata una battaglia
da fare nelle piccole cose, nelle scelte
qualsiasi.
Si delinea una strada, un genere di
rappresentazione composito, l'inizio di un
progetto e di un lungo discorso: il "Teatro
Canzone" è il genere originale più rappresentativo nel percorso artistico di
Giorgio Gaber: la canzone – così intesa – è in realtà l'unione tra un testo che ha in
sé un suo racconto preciso e una musica che ne amplifica il fatto emotivo. Il
teatro è un ulteriore mezzo per aumentare la resa emotiva del concetto: il testo,
la musica, le luci, il palcoscenico, tutto è per Gaber in funzione di un
allargamento emotivo.
Quando canto c'è un po' più di energia e quindi è più una festa; quando recito c'è
un po' più di concentrazione e quindi più profondità. (...) Quando non lavoro mi
annoio molto. Cerco di distrarmi continuando a pensare al lavoro: lo stacco totale
in un certo senso mi deprime.
Anni ottanta
Nel novembre del 1980 Gaber produce con una piccola etichetta indipendente Io
se fossi Dio, un 'singolo' di 14 minuti. La canzone, scritta in seguito all'uccisione di
Aldo Moro e pubblicata più tardi per ragioni di censura, è concepita come un
violento esplicito pamphlet contro il grigiore della scena italiana di quegli anni e
va considerata come il momento culminante di un'intera fase del lavoro di Gaber
e Luporini. La canzone viene inserita in Anni affollati nella stagione teatrale
successiva (1981-'82), spettacolo che chiude una prima parabola di intervento sul
sociale del "Teatro Canzone".
Certe volte mi chiedo perché non me ne resto più tranquillo, perché non mi metto
a scrivere cosette rasserenanti, magari gioiose. Poi mi guardo intorno, vedo che ci
stiamo tutti abituando al grigiore, alla piattezza, alla rassegnazione, e mi
accorgo che il mio compito, il mio lavoro, è quello di dire le cose che gli altri non
dicono. Le cose che voi giornalisti non avete più il coraggio di scrivere. Vorrei
sapere, per esempio, perché fino a qualche anno fa si poteva parlare liberamente
di Moro, dicendo che anche lui è responsabile del disastro in cui ci troviamo,
mentre oggi non si può più. La retorica ufficiale, la pietà istituzionale, ci
impediscono di avere reazioni spontanee, umane. Anche di provare pena, dolore.
(...). Cercheremo di spiegare che questa voglia di Dio è soprattutto una voglia di
avere una spinta, un desiderio morale. Voglia di credere, voglia di esistere. Non ci
interessa collocarci al di là del bene e del male, come quei nostri amici che
ascoltando "Io se fossi Dio" ci chiedevano: ma chi ve lo fa fare? Perché
prendersela tanto? Loro pensano che non sia il caso di indignarsi. Che va bene
tutto. E invece no: va bene un cazzo. Se non si lotta per cercare una ragione, per
inseguire la chiarezza, tanto vale crepare.
Con gli spettacoli degli ultimi anni '80, Gaber e Luporini cambiano registro,
spostano il piano dell'analisi dei malesseri collettivi a quello più intimo dei
sentimenti. È un "Teatro d'evocazione" dove l'attore, solo in scena, fa rivivere
attraverso il monologo personaggi e situazioni che sono nella sua memoria.
Attraverso il personaggio solista che riflette e comunica i propri pensieri, il
dialogo è sintetizzato all'essenziale, non è il monologo del teatro classico: è l'io
interiore che parla. Parlami d'amore Mariù (1986-'88), per esempio, è un
racconto a struttura aperta con brevi atti unici in forma monologica e canzoni
che costituiscono un'ampia indagine sulla tematica dello spettacolo.
"Parlami d'amore Mariù" non è una finestra sul privato; è una perlustrazione
nell'intimo che può svelare come certi sentimenti, anche l'amore, siano solo delle
illusioni, delle forme di isteria, curiosi coaguli che vivono dentro di noi ma separati
dal nostro cuore, fantasmi che coprono altri fantasmi... Per esempio, si può capire
perché, quando viene a mancare una persona cara, subito dopo si potrebbe
indifferentemente ammazzarsi o andare al cinema.
Anni novanta
Nel 1991, lo spettacolo antologico Il Teatro Canzone, presentato al Festival estivo
"La Versiliana", ripropone parte del repertorio precedente, col desiderio esplicito
di verificare a distanza di anni l'attualità dei temi via via svolti. Il recital offre una
magnifica attualità, sia per il linguaggio sia per i contenuti; non solo mantiene un
valore inalterato nel tempo ma anticipa concetti e idee destinate ad entrare nel
patrimonio collettivo. C'è anche un nuovo brano, Qualcuno era comunista, denso
di tensione morale che, da solo, si fa manifesto del sentire taciuto da molti. La
sensazione che ne scaturisce è che ora l'individuo subisca, senza avere più una
possibilità di riscatto.
Non è una canzone politica ma una pagina esistenziale, il racconto di un
malessere. Accadde che una parte della mia generazione andò, per anni, verso un
progetto utopico che chiamavamo comunismo. Forse impropriamente, visto che
nessuno di noi mirava alla dittatura del proletariato, né alla Comune dei cinesi, né
al riscatto dei contadini russi. Non era questione di schieramenti, ma di stati
d'animo: quella cosa ci aveva preso emotivamente, ed accomunava persone
divise da differenze enormi, perfino hippy e anarchici, che col comunismo non
c'entravano per niente. Più che una dottrina, insomma, ci muoveva uno slancio,
una grande speranza. E quando la speranza sparisce, non è che stai lì a pensare
che c'è ancora Cuba, o che è nata Rifondazione: è finita l'utopia, se ne va
l'illusione di poter agire, noi, per le generazioni che verranno. E allora rimani
vuoto e solo, e chi se ne frega di Breznev o del delirio delle Bierre: ci fai su una
canzone, non solo per raccontare la tua solitudine, ma per spiegare a te stesso
che uno slancio non va mai rinnegato: sarebbe come buttar via, con l'acqua
sporca, anche il bambino.
I testi degli spettacoli, dal 1996 al 2000, vertono via via sempre più sull'indagine e
l'approfondimento del discorso sull'individuo: lo smascheramento delle
contraddizioni che vive con se stesso e in rapporto alla società che lo induce a
gesti omologati, alla logica della produzione e del mercato. Nel continuo
tentativo di ritrovare un'autenticità all'interno delle sue istanze, Gaber
"somatizza" le idee e allontana le ideologie, tendendo ad una visione filosofica
provocatoriamente "antropocentrica" del
mondo. Un'idiozia conquistata a fatica, lo
spettacolo ripreso in questi anni in diverse
stagioni, ha un riferimento preciso e molti
legami con Libertà obbligatoria, con esso
sembra terminare il percorso iniziato nel 1976,
portando alle estreme conseguenze il discorso
iniziato più di vent'anni prima.
È un momento in cui ognuno si fa
assolutamente i fatti propri, senza interesse
per gli altri, in cui sembra proprio che
percepire l'esistenza reale di un'altra persona sia impossibile, che non esista
appartenenza a nulla. Ricordo anni in cui il senso collettivo era presente come
istinto nelle persone, poi via via è venuto a mancare. Credo che alla base del
lavoro di Luporini e mio – e dunque anche del Signor G – ci sia un grande
desiderio ci smascheramento. Del resto, da sempre, la nostra ricerca consiste
nella smontare innanzitutto le nostre false convinzioni che riguardano sia la sfera
personale che quella sociale, con lo scopo di diffidare di alcuni finti
comportamenti. Anche nella critica che noi da sempre abbiamo rivolto alla
sinistra c'è il desiderio di essere contro slogan di tipo propagandistico, a favore
della chiarezza di una ricerca autentica. Abbiamo sempre avuto fiducia che se
cambia la testa delle persone possono cambiare anche le cose.
Ho avuto, purtroppo come tanti, anche delusioni dalla piazza. Il fenomeno di
massa è un fenomeno che non amo, e che non ho amato neanche nei momenti in
cui si partecipava al movimento, che era una bella parola. Sento molto
importante l'esistenza di una quantità di individui che rappresentano ognuno un
desiderio, mentre la massa significa spesso l'annullamento del pensiero da parte
del gruppo. La massificazione, sia essa di destra o di sinistra, è sempre negativa.
Ognuno di noi ha ogni giorno molto spazio nei rapporti quotidiani per mettersi
alla prova e per trovare il "qui e ora", ci sono tantissime occasioni per essere
persone piuttosto che maschere. E lo smascheramento di quello che siamo mi
sembra una cosa realizzabile minuto per minuto nella nostra vita.
Anni duemila
La mia generazione ha perso, nel 2001, segna
l'eccezionale ritorno al disco di un artista che negli
ultimi trent'anni si è dedicato esclusivamente
all'attività teatrale (disco che arriva in testa alle
classifiche discografiche). Gaber si produce in una
anomala tournée: tiene conferenze nelle università
e nei teatri, canta e parla del suo nuovo lavoro e,
retrospettivamente, del suo percorso artistico.
Come un richiamo alle origini, partecipa allo show
televisivo di Adriano Celentano (insieme a Dario Fo, Enzo Jannacci e Antonio
Albanese), che resta la sua ultima apparizione televisiva.
Forse per questioni anagrafiche, mi trovo in un momento di riflessione, direi quasi
di bilancio. Non a caso il mio ultimo album si intitola “La mia generazione ha
perso”. Direi che oggi prevale un senso di amarezza per le sconfitte della mia
generazione. Del resto con Luporini abbiamo sempre cercato di parlare e di
riflettere attorno ai nostri slanci e alle nostre utopie ma anche intorno a ciò che ci
faceva male, che creava disagio a noi e forse, anzi sicuramente, non soltanto a
noi. Cercando di interpretarlo e di capirlo, quel male. Oggi più che a una
evoluzione positiva dell'individuo, mi sembra di aver assistito a un suo
mutamento direi quasi antropologico. E vedo un uomo sempre più sopraffatto e
totalmente in balia della violenza del mercato. E mi chiedo a cosa siano serviti i
nostri slanci, le nostre utopie, i nostri ideali, le nostre ribellioni, le nostre
trasgressioni. Purtroppo devo rispondere constatando che non siamo stati
migliori dei nostri padri e non credo possiamo costituire un esempio attendibile e
autorevole per i nostri figli. Siamo scesi in piazza per contestare, anche con
violenza, le dittature politiche del mondo, ma abbiamo perso di fronte all'unica
dittatura che ha realmente trionfato: quella del mercato. Almeno i nostri padri la
Resistenza l'avevano fatta davvero. Noi non siamo stati capaci di resistere alla
finta seduzione del consumo, anzi, ne siamo stati complici per quanto
inconsapevoli. Credo sia importante riconoscere i propri errori e le proprie
sconfitte, perché comunque la consapevolezza e l'onestà intellettuale rimangono
valori fondamentali. E in ogni caso ammettere la propria sconfitta è
indispensabile per poter ripartire con maggior chiarezza e con nuovi slanci vitali.
Sandro e io abbiamo una fiducia illimitata nelle potenziali risorse dell'individuo
e questa potrebbe essere la nostra fede. Laica, naturalmente.
Il primo gennaio 2003 Giorgio Gaber muore nella sua casa di Montemagno in
Versilia, lasciando, ben oltre l'immediato e condiviso shock emotivo, un enorme
senso di vuoto. Gaber non stava bene da tempo: la stagione teatrale "Gaber
1999-2000" era stata sospesa più volte.
Ci sono argomenti tabù che si cerca di rimuovere. Penso che se le strade si
riempissero di gente malata, forse cambieremmo la nostra testa. Invece nella
nostra società, per la vergogna della malattia, vediamo solo gente sana, e questo
cerco di dirlo anche nello spettacolo: quando incontriamo qualcuno che sta male
abbiamo un turbamento fuori misura, come se non sapessimo che quello è il
nostro specchio. Mi sembra che il tabù della nostra epoca sia la mancanza di
consapevolezza delle cose importanti e tragiche, essenziali della vita. La spinta
dovrebbe essere a parlare di queste cose non in modo macabro o funebre ma
come un fatto vitale, perché morte significa vita.
Liberamente tratto da: www.giorgiogaber.org
George Brassens, le chansonnier
Scrittore, poeta, ma soprattutto "chansonnier" autentico e originale, dissacrante
e ironico, nasce a Sète (Francia) il 22 ottobre 1921. La passione per la musica lo
accompagna sin da bambino. Ascolta le canzoni riprodotte dal grammofono che i
suoi genitori hanno ricevuto in dono per il matrimonio, ma anche quelle
trasmesse alla radio, spaziando da Charles Trenet (che considererà sempre come
il suo unico, vero maestro) a Ray Ventura, da Tino Rossi a Johnny Hess a altri
ancora.
I suoi stessi familiari amano la musica: il padre
Jean Louis, che di professione è muratore ma si
definisce "libero pensatore", e la madre Elvira
Dragosa (originaria di Marsico Nuovo, paesino della
Basilicata in provincia di Potenza), fervente
cattolica, che canticchia le melodie della sua terra
di origine, e impara velocemente quelle che le
capita di ascoltare.
Il futuro chansonnier si dimostra ben presto
insofferente nei confronti del sistema scolastico: è
proprio tra i banchi di scuola, però, che fa un incontro fondamentale per la sua
vita di artista. Alphonse Bonnafè, insegnante di francese, gli trasmette la
passione per la poesia incoraggiandolo a scrivere.
Dopo essere stato condannato a quindici giorni di prigione con la condizionale
per dei furti avvenuti al College Paul Valery di Sète, Georges Brassens decide di
interrompere la sua carriera scolastica e si trasferisce a Parigi, dove viene
ospitato da una zia italiana, Antonietta. Qui, diciottenne, comincia a fare lavoretti
di vario genere (tra cui lo spazzacamino) fino a quando è assunto come operaio
alla Renault.
Si dedica con sempre maggiore impegno alle sue vere passioni: la poesia e la
musica, frequentando le "cantine" parigine, dove respira le atmosfere
esistenzialiste dell'epoca, e fa ascoltare i suoi primi pezzi. Intanto impara a
suonare il pianoforte.
Nel 1942 pubblica due raccolte di poesie: Des coups dépées dans l'eau (Buchi
nell'acqua) e A la venvole (Alla leggera). Gli argomenti di questi testi sono gli
stessi che affronta nelle canzoni: la giustizia, la religione, la morale, interpretati in
modo dissacrante e provocatorio.
Nel 1943 è costretto dal servizio di Lavoro Obbligatorio (S.T.O., istituito nella
Francia occupata dai nazisti in sostituzione del servizio militare) ad andare in
Germania. Qui, per un anno, lavora a Basdorf, vicino a Berlino, in un campo di
lavoro. Durante questa esperienza conosce André Larue, suo futuro biografo, e
Pierre Onteniente, che diventerà suo segretario. Scrive canzoni e inizia il suo
primo romanzo, ma soprattutto sogna la libertà: così, quando riesce ad ottenere
un permesso, torna in Francia e non rientra nel campo.
Ricercato dalle autorità, è ospitato da Jeanne Le Bonniec, donna di grande
generosità, a cui Brassens dedicherà Jeanne, e Chanson pour l'Auvergnat
(Canzone per l'Alverniate).
Nel 1945 acquista la sua prima chitarra; l'anno successivo aderisce alla
Federazione Anarchica e comincia a collaborare, sotto vari pseudonimi, al
giornale Le Libertaire. Nel 1947 conosce Joha Heyman (soprannominata
"Püppchen"), che rimarrà sua compagna per tutta la vita, e alla quale Brassens
dedicherà la celebre La non-demande en mariage (La non richiesta di
matrimonio).
Scrive un romanzo grottesco (La tour des miracles, La torre dei miracoli) e
soprattutto si dedica alle canzoni, incoraggiato da Jacques Grello. L’intuizione che
imprimerà una svolta alla sua produzione è artistica viene raggiunta proprio
quando capisce che poesia e musica possono viaggiare sullo stesso binario: mi
sono detto: non vale la pena insistere, non sarai mai un grande poeta, non sarai
un Rimbaud, un Mallarmé, un Villon (…) Perché non provare ad abbinare le
poesie alla mia musica?
Il 6 marzo 1952 Patachou, famosa cantante, assiste, in un locale parigino, a
un'esibizione di Brassens. Decide di inserire alcune sue canzoni nel suo repertorio
e convince il titubante chansonnier ad aprire i suoi spettacoli. Grazie anche
all'interessamento di Jacques Canetti, uno dei massimi impresari dell'epoca, il 9
marzo Brassens sale sul palco del "Trois Baudets". Il pubblico rimane senza
parole dinanzi a questo artista che non fa nulla per apparire un divo e sembra
quasi imbarazzato, goffo e impacciato, così
lontano e diverso da tutto ciò che la canzone
del periodo propone.
Scandalizzano i suoi stessi testi, che narrano
storie di ladruncoli, piccoli furfanti e
prostitute, senza mai essere retorici o
ripetitivi (come invece gran parte della
cosiddetta "canzone realista", quella cioè di
carattere sociale, ambientata anch'essa nei
vicoli disagiati della capitale francese, di moda in quel periodo). Alcuni di essi
sono traduzioni da grandi poeti come Villon. Molti spettatori si alzano ed escono;
altri, sorpresi dinanzi a questa novità assoluta, restano ad ascoltarlo. Ha inizio la
leggenda di Brassens, il successo che non lo abbandonerà più da quel momento.
Grazie a lui, il teatro "Bobino" (che dal 1953 diventa uno dei suoi palcoscenici
preferiti) si trasforma in un autentico tempio della canzone.
Nel 1954 l'Accademia "Charles Cros" assegna a Brassens il "Gran Premio del
Disco" per il suo primo LP: le sue canzoni verranno raccolte nel tempo in 12
dischi.
Tre anni più tardi l'artista fa la sua prima e unica apparizione cinematografica:
interpreta se stesso nel film di René Clair Porte de Lilas.
Nel 1967 gli viene assegnato il Grande Premio della Poesia della prestigiosissima
“Académie Française”. Gli si propone anche di entrare a far parte
permanentemente di questo simposio detto in Francia “degli Immortali”, ma lui
rifiuta.
Nel 1976-1977 si esibisce per cinque mesi ininterrottamente. E' la sua ultima
serie di concerti: colpito da tumore all'intestino, si spegne il 29 ottobre 1981 a
Saint Gély du Fesc, lasciando un vuoto incolmabile nella cultura, ben interpretato
da queste parole di Yves Montand: "Georges Brassens ci ha fatto uno scherzo. E'
partito per un viaggio. Alcuni dicono che è morto. Morto? Ma cosa significa
morto? Come se Brassens, Prevert, Brel potessero morire!".
In Francia Brassens è stato sempre più popolare di quanto i Beatles non siano
stati in Gran Bretagna, e sono ormai migliaia le scuole, le istituzioni culturali, le
strade, le piazze, i parchi a lui intitolati, ciò che non è avvenuto per nessun altro
dei pur importanti esponenti della canzone francese. A più di trent’anni dalla sua
morte, ogni francese conosce almeno cinque o dieci o più delle sue canzoni. Lo
scrittore sudamericano G. Garcia Marquez lo ha definito addirittura il più grande
poeta della letteratura francese del ‘900. In Italia, stimatissimo dagli intellettuali
e studiato nelle università, è poco conosciuto dal grosso pubblico, che, non
padroneggiando bene il francese, spesso non riesce a comprendere le sue
inesauribili invenzioni linguistiche, le immagini poetiche, la vivacità ironica, tutti
mezzi di cui il poeta si serve nelle sue canzoni per trattare i grandi temi della
condizione umana.
Grande l'eredità lasciata dall'artista di Sète. Numerosi gli artisti che si sono
cimentati nell' interpretare le canzoni di Brassens; tra i tanti citiamo Graeme
Allwright in inglese, Paco Ibanez in spagnolo; per quanto concerne gli artisti
francesi, la lista di quanti hanno cantato o continuano a cantare Brassens è lunga,
trai tanti ricordiamo: Maxime le Forestier, Renaud e Barbara.
In Italia, tra i cantautori che maggiormente sono stati affascinati dalla musica di
Brassens ricordiamo Fabrizio De André e Nanni
Svampa.
Il primo lo ha sempre ritenuto il suo maestro per
eccellenza, e ha tradotto e cantato alcuni dei suoi
brani più belli: Marcia nuziale, Il gorilla, Il
testamento, Nell'acqua della chiara fontana, Le
passanti, Morire per delle idee e Delitto di paese. Il
secondo, con Mario Mascioli, ha curato la
traduzione letterale in italiano delle sue canzoni, proponendole spesso, durante i
suoi spettacoli e in alcuni dischi, in dialetto milanese.
Giuseppe Setaro è da molti anni studioso e divulgatore dell’opera di Georges
Brassens: partecipa a seminari, tiene conferenze o concerti-conferenze, in Italia e
ancor più in Francia, presso centri studi o in occasioni di eventi culturali o festival
musicali. Nell’intento di rendere accessibile a tutti in Italia l’opera dell’artista
francese, si è impegnato a tradurlo nella nostra lingua. I testi da lui tradotti sono
più di 80 e si trovano pubblicati in libretti che accompagnano i 5 CD dal titolo
Omaggio a G. Brassens. Setaro è oggi uno dei pochi italiani che interpretano
Brassens in Francia, dove viene regolarmente invitato a tenere concerti (collettivi
o individuali) nelle manifestazioni o festival, insieme ad artisti di grande prestigio.
Nel 2014, quando esce Segni (e) Particolari – Alberto Patrucco e Andrea Mirò
cantano Georges Brassens, affascinante percorso le parole e la musica del
cantautore francese (che diventerà anche spettacolo teatrale), Andrea Mirò
dichiara: “È stato un artista che ha ispirato (molto…) la nostra canzone d’autore e
che oggi risulta incredibilmente attuale. Alberto Patrucco ha deciso di tradurre a
nuovo alcune delle canzoni più significative, per la gioia degli appassionati, con
un occhio alle nuove generazioni, spesso private a loro insaputa di certi
fondamenti indispensabili. Per sposare l’antica tradizione con l’attuale musicalità
sono stata coinvolta ed ho accettato con entusiasmo la sfida. Abbiamo cercato di
dare vita a un album attuale e allo stesso momento fuori dal tempo e dallo
spazio” (www.albertopatrucco.it).
Brassens e De André, un legame a distanza
Fabrizio De André, parlando di quello che considerò
essere il suo maestro, diceva: "Mi ha sconvolto la
vita. Se ho iniziato a fare questo mestiere è solo
merito suo".
Una stima infinita, dunque, era quella che il
cantautore genovese nutriva nei confronti del suo
collega transalpino, che per lui rappresentava un
vero e proprio mito.
A tale proposito é utile citare un episodio: De André ebbe la possibilità di
conoscerlo personalmente ma non volle incontrarlo. Girava voce, infatti che
Brassens avesse un carattere scontroso e difficile e De André, dunque, non volle
rischiare di rovinare quel mito, per lui così importante, con una conoscenza
personale che forse lo avrebbe deluso.
E' lo stesso De André a sottolineare la rilevanza ed il peso che l' influenza di
Brassens ha giocato sulla sua produzione e le motivazioni del mancato incontro:
"In Brassens si intrecciavano tre culture: quella mitteleuropea, col valzer, quella
francese, con la giava, e quella napoletana, con la tarantella (sua madre Elvira
Dragosa, tra l' altro, aveva origini napoletane).
Ecco perché le mie prime canzoni vivevano su quei ritmi e su quella atmosfera.
Poi mi intrigava il fatto che trattasse temi scabrosi, di grande rilevanza sociale,
buttandoli via, cantandoli con una nonchalance da teatrante inglese, più che
francese: perché il teatrante francese è enfatico, declamatorio, quello inglese
dice cose terrificanti con una specie di indifferenza glaciale.
Brassens, insomma, fu il mio grande modello anche se, avendone avuta l'
occasione, ho sempre evitato di conoscerlo di persona: mi serviva troppo
tenermelo come mito; se questo mito, conoscendolo, fosse crollato, mi sarebbe
crollato il mondo. Sicché ho preferito immaginarmelo soltanto attraverso le sue
canzoni." (C.G. Romana, Fabrizio De André - Amico Fragile, 2000)
Anche chi ha conosciuto bene De André non si
stupisce del mancato incontro Brassens-De
André; come Fernanda Pivano, che afferma,
parlando di un altro mancato incontro, quello
con Bob Dylan, al quale il cantautore genovese
si ispirò: "Una volta Dylan ha chiesto a Fabrizio
di suonare con lui e Fabrizio non ha voluto farlo,
forse per la stessa ragione per cui a suo tempo
non ha voluto incontrare Brassens; sarebbe
bello credere che si incontrino un giorno negli
enormi spazi profumati dell'eternità e
conoscano finalmente la realtà inafferrabile che hanno inseguito, forse
sfiorandola appena, giusto abbastanza da illudersi di poter continuare a
inseguirla. La loro è una realtà fatta di cose semplici, di tutti i giorni, di rispetto
per l'amore e la morte, di orrore per l'ipocrisia e la violenza." (Fernanda Pivano,
C.G. Romana, Michele Serra, De Andre' il corsaro interlinea edizioni - Novara)
La stessa Pivano sottolinea l' importanza rivestita dall' influsso di Brassens sulla
formazione e sulla produzione di De André "L' influenza francese è venuta poco
dopo, quando il padre gli ha portato i dischi di Brassens. È diventato un suo
maestro di vita già a quattordici anni, e ha confermato scelte già maturate. (...)
Così aveva cominciato a cantare le canzoni di Brassens, ma anche quelle di
Aznavour, di Gilbert Bécaud, di Moulodji: solo a diciotto anni ne ha cantato una
sua.(...) Già da adolescente era turbato dai problemi sociali suggeriti da Brassens,
ma anche da quelli morali che a volte contrastavano con quelli sociali (...).
Brassens è stato per lui un esempio musicale che gli ha dato aperture e tecniche
sull'uso della chitarra. Si è ritrovato a inventare tarantelle non prendendo spunto
dalla musica napoletana ma dalle canzoni di Brassens, scoprendo solo molto più
tardi, che lo stesso Brassens aveva avuto la nonna e la mamma napoletane: cioè,
imitando Brassens imitava in realtà gli italiani." (Prefazione di Fernanda Pivano a:
Cesare G. Romana, Fabrizio De André - Amico Fragile, 2000).
Come accenna la Pivano in questa Prefazione al libro di Romana, fu grazie a suo
padre, Giuseppe De André, che Fabrizio ebbe modo di conoscere per la prima
volta le canzoni di Brassens. Il padre, dai suoi frequenti viaggi in Francia, era
solito riportare un' abbondante quantità di libri e dischi e fu lui che fece
conoscere Brassens a Fabrizio intorno al 1954, cioè a soli due anni dall' esordio
discografico dello chansonnier francese.
Dunque, con grande probabilità Fabrizio De André è stato davvero tra i
primissimi in Italia ad aver conosciuto Georges Brassens e le sue canzoni.
Bisogna dare il giusto peso a quella che era l'attitudine culturalmente aperta
della famiglia De André, dove la scoperta del nuovo, proveniente non solo dalla
Francia, e l' abitudine di commentarlo, come anche la grande passione per la
musica in genere, furono fattori fondamentali nella formazione musicale e
culturale di De André.
Le sue traduzioni ed interpretazioni non sono passate attraverso un
intermediario fisico o indiretto ma sono assolutamente il risultato del suo
meticoloso lavoro; si consideri tra l’altro come il francese utilizzato da Brassens,
ricco di riferimenti letterari e simbologie, presupponeva una profonda
conoscenza della lingua e della letteratura francese.
Lo stesso Brassens (che capiva l'italiano) riconobbe come le sue canzoni erano
state tradotte magistralmente da De André. E se c'è una qualità che va
riconosciuta alle traduzioni di De André è proprio il fatto di essere delle fedeli
trasposizioni degli originali.
Due testi…
Giorgio Gaber, Chiedo scusa se parlo di Maria
Chiedo scusa se parlo di Maria
non del senso di un discorso, quello che mi viene
non vorrei che si trattasse di una cosa mia
e nemmeno di un amore, non conviene.
Quando dico "parlare di Maria"
voglio dire di una cosa che conosco bene
certamente non è un tema appassionante
in un mondo così pieno di tensione
certamente siam vicini alla pazzia
ma è più giusto che io parli di
Maria la libertà
Maria la rivoluzione
Maria il Vietnam, la Cambogia
Maria la realtà.
Non è facile parlare di Maria
ci son troppe cose che sembrano più importanti
mi interesso di politica e sociologia
per trovare gli strumenti e andare avanti
mi interesso di qualsiasi ideologia
ma mi è difficile parlare di
Maria la libertà
Maria la rivoluzione
Maria il Vietnam, la Cambogia
Maria la realtà.
Se sapessi parlare di Maria
se sapessi davvero capire la sua esistenza
avrei capito esattamente la realtà
la paura, la tensione, la violenza
avrei capito il capitale, la borghesia
ma la mia rabbia è che non so parlare di
Maria la libertà
Maria la rivoluzione
Maria il Vietnam, la Cambogia
Maria la realtà.
Maria la libertà
Maria la rivoluzione
Maria il Vietnam, la Cambogia
Maria la realtà
Maria la realtà
Maria la realtà.
George Brassens, Les passents
Traduzione italiana e adattamento di
Fabrizio De Andrè
Je veux dédier ce poème
A toutes les femmes qu'on aime
Pendant quelques instants secrets
Io dedico questa canzone,
ad ogni donna pensata come amore
in un attimo di libertà
A celles qu'on connait à peine
Qu'un destin différent entraîne
Et qu'on ne retrouve jamais
a quella conosciuta appena,
non c'era tempo e valeva la pena
di perderci un secolo in più
A celle qu'on voit apparaître
Une seconde à sa fenêtre
Et qui, preste, s'évanouit
a quella quasi da immaginare,
tanto di fretta l'hai vista passare
da un balcone a un segreto più in là
Mais dont la svelte silhouette
Est si gracieuse et fluette
Qu'on en demeure épanoui
ti piace ricordarne il sorriso,
che non ti ha fatto e che tu le hai deciso
in un vuoto di felicità
A la compagne de voyage
Dont les yeux, charmant paysage
Font paraître court le chemin
alla compagna di viaggio,
i suoi occhi il più bel paesaggio
fan sembrare più corto il cammino
Qu'on est seul, peut-être, à comprendre e magari sei l'unico a capirla
Et qu'on laisse pourtant descendre
e la fai scendere senza seguirla
Sans avoir effleuré sa main
senza averle sfiorato la mano
A celles qui sont déjà prises
Et qui, vivant des heures grises
Près d'un être trop différent
a quelle che sono già prese
e che vivendo delle ore deluse
con un uomo ormai troppo cambiato
Vous ont, inutile folie,
Laissé voir la mélancolie
D'un avenir désesperant
ti hanno lasciato, inutile pazzia,
vedere il fondo della malinconia
di un avvenire disperato
Chères images aperçues
Espérances d'un jour déçues
Vous serez dans l'oubli demain
immagini care per qualche istante,
sarete presto una folla distante
scavalcate da un ricordo più vicino
Pour peu que le bonheur survienne
Il est rare qu'on se souvienne
Des épisodes du chemin
per poco che la felicità ritorni
è molto raro che ci si ricordi
degli episodi del cammino
Mais si l'on a manqué sa vie
on songe avec un peu d'envie
A tous ces bonheurs entrevus
ma se la vita smette di aiutarti
è più difficile dimenticarsi
di quelle felicità intraviste
Aux baisers qu'on n'osa pas prendre
Aux coeurs qui doivent vous attendre
Aux yeux qu'on n'a jamais revus
dei baci che non si è osato dare
delle occasioni lasciate ad aspettare
dei baci, mai più rivisti
Alors, aux soirs de lassitude
Tout en peuplant sa solitude
Des fantômes du souvenir
allora nei momenti di solitudine,
quando il rimpianto diventa abitudine
una maniera di viversi insieme
On pleure les lèvres absentes
De toutes ces belles passantes
Que l'on n'a pas su retenir.
si rimpiangono le labbra assenti
di tutte le belle passanti
che non siamo riusciti a trattenere.