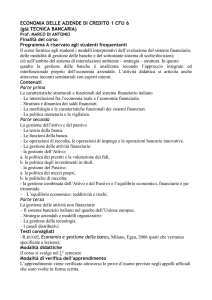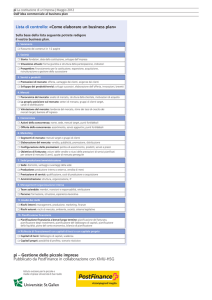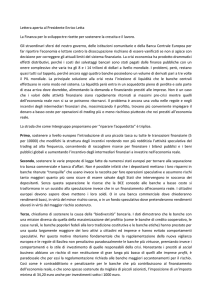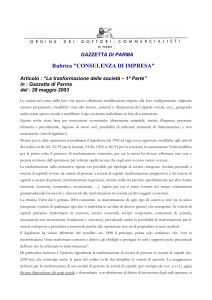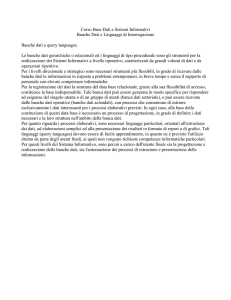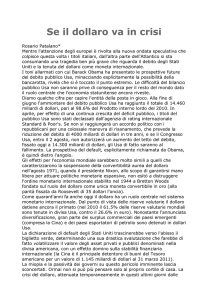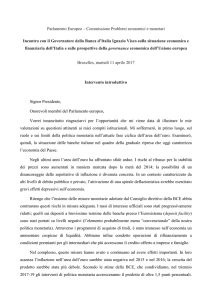Cap. 3 Il sistema finanziario nazionale: il conflitto (1914-1939)
Sommario
Le spese imposte dalla Guerra mondiale del 1914-18, rispondendo non a priorità di mercato ma a
preferenze ideologiche, distrussero il sistema finanziario preesistente. I cambiamenti intervenuti in ambito
di finanza interna ed estera, negli scambi commerciali e nella politica economica interna, determinarono
condizioni nuove. L’esito fu la formazione di un sistema orientato secondo le scelte compiute dalle unità
economiche aggregate non in base alla loro attività produttiva, ma secondo la loro residenza e condizione
sociale. Il sovrapporsi dei cambiamenti indicati definì, in ragione della sua efficacia, le condizioni che
divennero degli incentivi selettivi per le scelte di gruppi sociali e produttivi che furono avvantaggiati o
svantaggiati da nuove modalità di tassazione, mobilità dei capitali, organizzazione commerciale e situazione
politica. Conseguentemente, essi agirono consolidando o demolendo la situazione esistente fino a definire
una diversa concezione di rischio e di credibilità finanziaria.
Il centro e la periferia del sistema economico ne risultarono modificati. La posizione di centro fu
assunta dalle economie statunitense, inglese e francese, in quanto in grado di vincolare gli scambi mondiali
nei mercati dei beni, del capitale e delle riserve monetarie internazionali. la posizione di periferia fu invece
assunta sia dalle altre economie industriali, chiamate a coordinarsi o concorrere in quei mercati, in
particolare quella tedesca, giapponese e italiana; sia, in modo complementare, dalle economia dai paesi
produttori di materie prime. Osservato nella linea del tempo il sistema finanziario nazionale si definì nei
periodi di guerra, tra il 1914 e il 1918; di ricostruzione dell’economia internazionale, tra il 1919 e il 1924; di
attività e poi crisi dell’economia liberale, tra il 1925 e il 1933; in ultimo, tra il 1934 e il 1939, nella
frammentazione autarchica, che portò alla divisone del mondo in aree di sviluppo e alla egemonia, dopo la
Seconda guerra mondiale, di un’unica nazione: gli Stati Uniti.
1. Patrimoni, risparmi e investimenti
1.1 I caratteri generali: condivisione delle regole, vincoli costrittivi e vantaggi selettivi
Ogni sistema finanziario determina una modalità di allocazione di risorse e rischi nel
tempo tra gli operatori economici. Specificamente, questa allocazione riguarda,
principalmente, l’offerta di moneta, le modalità di disponibilità di capitale e il rendimento
delle obbligazioni cedute sul mercato estero. Tutto ciò comporta l’applicazione di modi e
procedure dello scambio di beni e servizi in grado, da una parte, di gestire
l’intermediazione delle disponibilità finanziarie, patrimoni e/o risparmi, tra unità
economiche, cioè tra famiglie, imprese e stati sovrani; e, dall’altra, di gestire il
trasferimento dei rischi tra le unità economiche e gli agenti che le compongono per
mezzo dei prezzi di beni e servizi, così come dei vincoli e degli incentivi operativi allo
scambio dei beni e servizi.
Queste scelte comportano inoltre trasferire potere di acquisto da una parte tra diversi
stati di natura, cioè attraverso titoli assicurativi, della rendita e simili; dall’altra di un bene
e servizio tra i diversi soggetti economici, attraverso le cambiali, le obbligazioni, le azioni
e simili.
Se le condizioni descritte vengono declinate secondo i principi di costo-opportunità
tra i mercati interno ed estero, senza che questo determini una sotto-utilizzazione delle
risorse in uno dei due contesti, si verifica una situazione che possiamo rappresentare
graficamente come in Fig. 3.1.
1
-
Equilibrio interno (II) ed esterno (XX) – Le quattro zone di disagio economico. (Krugman,
Economia internazionale 2, p. 338)
La figura mostra la condizione virtuosa nella relazione tra i mercati interno ed
internazionale; in cui la divisione del lavoro consente un pieno impiego delle risorse in
tutti i contesti: in questo modo si ottiene, infatti, un contemporaneo esistere di
condizioni di equilibrio interno ed estero. Con equilibrio interno si intende quello che
consente il pieno impego delle risorse e la stabilità dei prezzi; con equilibrio estero quello
che consente il livello ottimo del saldo del conto corrente.
Storicamente queste condizioni non sono mai esistite. La storia ha invece presentato
esclusivamente condizioni di divisione del lavoro in cui si attuano vantaggi di scambio
assoluti o relativi, come sono stati i sistemi finanziari mercantile e industriale già visti nei
capitoli precedenti. Dagli anni Novanta dell’Ottocento questa condizione venne a
consumarsi rapidamente. Le innovazioni tecnologiche – a partire dall’uso della industria
elettrica e chimica che consentirono di superare i vincoli di localizzazione della energia, la
crescita delle reti nella navigazione commerciale e nella rete delle comunicazioni
intercontinentali – portarono infatti ad un aumento degli scambi intra-settoriali, fondati
sulla fornitura di materie prime e beni intermedi in ragione della diversa produttività dei
fattori. Tra gli esiti di questa prima globalizzazione vi fu, quindi, quello di creare una
un’area di disagio, ovvero una sottoutilizzazione delle risorse in diversi contesti, nella
relazione tra i mercati domestico e internazionale.
Queste tensioni, ben visibili nei mercati di cambio delle valute, furono, nei due
decenni a cavallo del Novecento, risolte per mezzo di un aumento del volume delle
triangolazioni commerciali e finanziarie svolte per la maggior parte per tramite della City
di Londra. Molti paesi industrializzati infatti avevano un deficit verso i paesi produttori di
materie prime e un credito verso l’Inghilterra, che a sua volta aveva un credito, per
interessi, verso i paesi produttori di materie prime, di cui per esempio aveva finanziato le
reti dei trasporti. Ne seguì che molte società trovarono conveniente detenere fondi di
deposito in sterline presso le banche della City in modo da attuare saldi commerciali con
il duplice vantaggio di non richiedere movimenti di oro e di ricevere interessi sui depositi,
2
e/o possibilità di svolgere transazioni di pronti contro termine.
La Guerra modificò questi contesti, ponendo fine al sistema finanziario industriale e
aprendo al consolidamento di quello nazionale, che si articolò poi in diverse forme
organizzative e di gestione per tutto il Novecento. Durante il conflitto, molti altri paesi
importatori si orientarono ad un maggiore uso delle risorse nazionale, molti operarono
con saldi commerciali in disavanzo – specie con gli Stati Uniti – , molti operarono in
deficit, liquidando attività sull’estero e offrendo titoli a garanzia e modificando i calendari
delle scorte, in ultimo indebitandosi. I blocchi commerciali attuati in funzione bellica, e
soprattutto gli attacchi tedeschi ai convogli merci, portarono all’interruzione delle
forniture da parte dei paesi europei verso l’America latina e l’Asia. Ne seguì che questi
mercati furono forniti da Stati Uniti e dal Giappone, che ne divennero poi nel
dopoguerra i principali interlocutori commerciali e finanziari.
Condizioni di sotto o sovra occupazione portano a richieste e aspettative di
cambiamento. Esse rendono il valore reale della valuta nazionale meno certo e frenano
gli investimenti sul mercato interno portando all’esportazioni di capitali fino al limite di
generare una modifica della variazione nel livello dei prezzi. Questi fattori comportano,
da un lato, una ridefinizione del valore di cambio, che modifica il valore dei prestiti
definiti al valore nominale precedente alla caduta dei prezzi; dall’altro, essendo
denominati in valuta corrente, provocano una redistribuzione del reddito tra creditori e
debitori e a seguire una modifica della bilancia dei pagamenti che registra la variazione
sull’effetto reddito degli agenti, così come su quelli di sostituzione nelle componenti di
domanda e offerta.
Dunque, una condizione di disagio – ovvero di allontanamento dall’equilibrio – sul
mercato interno come quella descritta genera conseguenze sul mercato estero.
Similmente, una condizione di disagio sui mercati internazionali ha ripercussioni sul
mercato nazionale interno. Si perverrà, quindi, ad uno squilibrio della bilancia dei
pagamenti anche ogni qual volta che gli operatori riterranno non efficaci le scelte di
impiego dei loro capitali sull’estero. Qualora la differenza tra nei rendimenti si mostri
particolarmente elevata si verificheranno infatti azioni di rapido movimento di capitali da
un paese all’altro con conseguenti instabilità nella occupazione, nella distribuzione del
reddito, nella raccolta fiscale, fino ad alterare le condizioni del sistema economico nel suo
insieme.
La consapevolezza della necessità di affrontare le condizioni di disagio descritte
determina la nascita del sistema finanziario nazionale, che si manifesta attraverso la
creazione di una costrizione economica a livello nazionale. Questa permette,
distribuendo un costo minimo sul totale della popolazione, di generare dei vantaggi
selettivi per alcuni gruppi di governo, accumunati da posizioni specifiche, come ad
esempio tipologia di produzione, luogo di residenza e appartenenza politica. La
costrizione si manifesta attraverso strumenti quali il corso forzoso della moneta, il livello
di stabilizzazione del cambio tra valuta domestica e quella interazionale, la politica fiscale,
la tassazione dei redditi, le scelte di politica industriale e di spesa sociale, ad esempio per
l’istruzione e per la assistenza.
Le diverse realtà nazionali generano costrizioni economiche e sistemi di regole che
valgono solamente per i residenti. Il problema dell’assenza di un contesto istituzionale
capace di avere forza costrittiva a livello internazionale fu superato promuovendo
strumenti di condivisione, a cominciare dai trattati internazionali, come quelli di
3
Versailles del 1919 o di Genova del 1922, fino alla partecipazione ad organizzazioni
internazionali, come ad esempio la Società delle Nazioni. I cambiamenti indicati
portarono a ridefinire le componenti del mercato internazionale, riordinandole non in
relazione al prezzo, ma in relazione al loro reciproco, cioè i sistemi di pagamento. Nel
corso degli anni Venti, al centro di questa ridefinizione si pose la Banca d’Inghilterra
come perno di un sistema di banche centrali nazionali, cui veniva chiesto di riconoscere,
sottoscrivendo un trattato, alla sterlina il ruolo di valuta di riserva internazionale. La
centralità dei trattati commerciali ottocenteschi veniva così sostituita, nel periodo tra le
due guerre mondiali, dai trattati monetari.
Il sistema finanziario nazionale possiede delle caratteristiche specifiche che portano
ad una tendenziale ed endemica instabilità. Questa è generata, dal lato della domanda,
nella variazione delle preferenze dei consumatori, e dal lato dell’offerta, dalla ricerca
dell’innovazione tecnologica che porta ad una variazione dei prezzi relativi. Entrambe
determinano un cambiamento politico negli accordi tra i diversi gruppi di interessi
presenti a livello nazionale e nella disponibilità dell’insieme della popolazione ad accettare
il minimo dei costi. L’incertezza generata dalle preferenze dei consumatori e della ricerca
tecnologica si sviluppa sul breve e sul lungo periodo. Questi due mondi diversi, per
essere armonizzati tra loro, richiedono un processo di creazione di fiducia, che viene
delegato a degli organi con funzioni di arbitro, ovvero le banche centrali.
I caratteri di costrizione economica, incentivi selettivi e instabilità tendenziale, sono
rappresentati nell’equazione di economia internazionale secondo le seguenti modalità.
Consideriamo prima l’equilibrio interno. Esso richiede che la domanda aggregata
eguagli il livello del prodotto di pieno impiego delle risorse. Per convenzione si ritiene
che la domanda aggregata sia pari alla somma del Consumo (C), dell’Investimento (I),
della spesa pubblica in beni e servizi attuata dal Governo (G), a fronte dei Trasferimenti
(T) – ovvero le imposte, che riducono la diponibilità di spesa effettiva delle unità
economiche – e del saldo del conto corrente (CA), quale risulta della differenza delle
importazioni ed esportazioni tra mercato nazionale ed internazionale. Si noti che parte di
questa somma indicata come assorbimento interno – pari ad A = C+I+G – è utilizzata
per acquisire beni di importazione per cui non contribuisce, per il suo intero, alla
domanda aggregata di produzione interna, mentre vi contribuisce interamente la
domanda estera delle esportazioni di beni nazionali.
Considerando inoltre come il saldo valore positivo del conto corrente sia una
funzione decrescente della spesa e una funzione crescente del tasso do cambio reale –
CA(EP*/P, A) – la condizione di equilibrio interno risulta essere espressa dall’equazione
seguente.
Yf = C+I+G+CA(EP*/P, A) = A+ CA( EP*/P, A)
L’equazione indica il ruolo del governo nell’influenzare la spesa totale. Un aumento
di G (o una diminuzione di T) porta ad un aumento della domanda aggregata e della
produzione; analogamente una svalutazione di della moneta (cioè un aumento dei prezzi
al valore reale (P*) o un aumento di E) rendono i beni e i servizi nazionali meno cari di
quelli, analoghi, venduti sui mercati esteri e quindi – se non vi sono barriere tariffarie dei
paesi esteri sui prodotti nazionali – aumentano la produzione domestica.
Il sistema finanziario nazionale opera con la finalità di un aumento della produzione e
4
della occupazione in modo diretto modificando la politica fiscale, in modo indiretto
associando una politica inflativa ad un sistema di cambi variabili, cioè consentendo una
svalutazione in termini reali che induce i residenti a tornare a consumare i prodotti
nazionali. Diversamente in regime di cambi fissi un aumento inflativo può solo essere
compensato da una riduzione dell’offerta di moneta e una riduzione della produzione
interna.
In sintesi dunque, nonostante vi sia svalutazione e aumento della spesa nazionale,
l’equilibrio interno ed esterno non può mai essere raggiunto stabilmente, quindi
l’instabilità del sistema finanziario nazionale risulta inevitabile.
-
Politiche che conducono all’equilibrio interno ed esterno (Krugman, Economia internazionale 2, p.
341)
L’analisi economica mostra dunque come l’uso della sola politica fiscale o della sola
politica monetaria può raggiungere l’obiettivo prefisso di variazione della spesa solo a
condizione di allontanare il sistema dal punto in cui ottiene l’equilibrio sia interno che
estero.
Ne segue che una soluzione possa essere ottenuta solo o fondandosi sul mercato
interno con una azione coordinata delle due leve di politica monetari a e politica fiscale;
oppure basandola a partire dal mercato estero, attivando un progetto di coordinamento
tra i governi e le istituzioni in grado di esercitare, pur da una condizione esterna al
dominio nazionale, una azione di indirizzo economico sui mercati interni, tipicamente
per mezzo di trattati commerciali, fiscali, e/o vincoli di cambio. Queste modalità, però,
generano una tensione sistemica e continua tra gruppi di produttori e residenti per
acquisire un’egemonia sociale per ricercare soluzioni a loro più vantaggiose.
5
1.2. Le modalità operative: politiche fiscali e monetarie, tassi di cambio e mercati valutari
Negli anni post-bellici emerge un nuovo spazio centrale del sistema finanziario,
composto da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Il tratto essenziale era rappresentato
dal fatto che, essendo i paesi si poggiavano su presupposti finanziari, monetari ed
economici in conflitto tra loro, furono necessariamente indotti a trovare dei
compromessi.
Gli Stati Uniti erano un paese con una bilancia commerciale strutturalmente in
surplus, sia per i prodotti agricoli, dove non avevano veri concorrenti, sia per i manufatti
industriali, per i quali alcuni paesi europei potevano invece costituire temibili rivali. Per
questo le autorità americane desideravano addivenire ad una stabilizzazione monetaria
europea che, da una parte, avrebbe depotenziato i possibili vantaggi insiti in cambi
instabili, e dall’altra avrebbe favorito le esportazioni, e quindi le industrie, statunitensi.
Queste scelte si combinavano con la necessità di un efficiente mercato internazionale dei
capitali e dei titoli finanziari scambiati sul mercato secondario. Tale condizione portò il
governo statunitense ad impegnarsi ad ancorare la propria politica monetaria con la
stabilità del cambio della sterlina come valuta di riserva internazionale, intervenendo
quindi, sia con prestiti verso la Banca di Inghilterra, per salvaguardarne le parità di
cambio, sia sostenendo in modo debole la cornice istituzionale internazionale. La ragione
di questo comportamento è da ricercare nella consapevolezza che, una non adeguata
struttura del mercato del risconto nel sistema finanziario americano, avrebbe comportato
che le tensioni generate sul cambio avrebbero avuto diretti contraccolpi sulla produzione,
con la perdita di riserve e con conseguenti tensioni sul tasso di interesse e sull’offerta
monetaria nel mercato interno. Dietro la “calamita” aurea che fece si che la Fed attirasse
nella casse delle riserve federali la maggiore parte dell’oro del mondo vi era la
convinzione che il prezzo relativo della moneta dollaro fosse nel lungo periodo
completamente determinato dalla offerta e domande reale moneta americana ed europea,
cioè dal volume delle transazioni, e non dalla variazione dei prezzi in sé.
Dal canto loro le élite inglesi che desideravano mantenere la propria posizione di
leadership della finanza internazionale, si trovarono a dover arginare lo sviluppo della
finanza americana. Questa condizione portò il governo inglese ad impegnarsi in modo
diretto nella promozione di una cornice istituzionale internazionale capace di orientare le
politiche economiche nazionali. Si affinò quindi un progetto di cooperazione tra banche
centrali che avrebbe posto la Banca d’Inghilterra e la sterlina al centro del sistema
finanziario, ripristinando quei meccanismi che avevano permesso che i flussi di capitali
mondiali venissero trattati, con enormi profitti, dalla City di Londra.
6
- Tassi di crescita del Pil britannico e investimenti esteri
- Prestiti americani e britannici negli anni Venti
Montagu Norman, governatore della banca centrale inglese per tutto il periodo
interbellico, immaginava ancora un ordine internazionale della classe dei creditori,
sottovalutando, o non comprendendo pienamente, i nuovi bisogni delle economie
nazionali, in primo luogo degli Stati Uniti. La differenza della visione inglese e americana
rendeva necessario il raggiungimento di un compromesso. È importante però
sottolineare la diversa percezione della finalità a cui il compromesso era rivolto: nel caso
inglese doveva essere un ripristino strutturale delle regole della finanza internazionale,
auspicandone quindi la sua concretizzazione in forma di trattati; nel caso americano,
invece, l’accordo aveva funzioni transitorie, quindi si ammettevano solo soluzioni di tipo
di straordinario.
Entrambi non potevano, però, prescindere da un equilibrio sul mercato
internazionale, condizione per cui era necessaria la collaborazione con l’altra grande
potenza finanziaria mondiale: la Francia. Questa, uscendo vincitrice dal conflitto,
desiderava ritornare in una posizione primaria sullo scenario internazionale, attraverso la
centralità data ad una politica monetaria che consentisse la tutela della produzione
7
nazionale. Essa si articolò in manovre espansive, nel permanere dell’inconvertibilità del
franco, che sarà ripristinata nel 1928, e la conseguente inflazione sul mercato interno. La
possibilità di operare queste scelte di politica monetaria derivò dal fatto che il governo
francese accettò, come compromesso in campo internazionale, di utilizzare la sterlina
come valuta di riserva. In questo modo esso ottenne un viatico per ripristinare le proprie
condizioni patrimoniali attraverso l’accumulo di riserve auree presso la Banca di Francia e
l’intervento della medesima in azioni di sterilizzazione del cambio e di stabilizzazione del
corso dei titoli del debito pubblico.
In estrema sintesi, possiamo rimandare questi modi di guardare al ripristino del
sistema finanziario internazionale a due modelli. Il primo modello prendeva a riferimento
il pieno utilizzo delle risorse interne e quindi la capacità produttiva delle industrie
nazionali, la piena occupazione, la tutela dei diritti acquisiti con lo sviluppo economico o
a seguito di indennizzi di guerra. Questa visione comportava un’attitudine a ritardare il
ritorno alla stabilità dei prezzi e alla stabilizzazione dei cambi, fino a che non si fosse certi
che questi non avrebbero generato tensioni sulla finanza pubblica e sulle potenziali
esportazioni. Il secondo, invece, prendeva a riferimento la stabilità dei prezzi e auspicava
il ripristino della convertibilità della moneta con l’oro ad un valore identico o quanto
meno vicino a quello del 1913, così da limitare o annullare il danno patrimoniale che
l’inflazione bellica aveva generato. Questa visione aveva come contesto di riferimento
l’equilibrio del mercato internazionale, cioè la legge del prezzo unico, anche a costo di
determinare, nel quadro economico del primo dopoguerra, politiche deflattive sul
mercato interno.
Va sottolineato che queste due modalità operative che semplificando indichiamo, la
prima, come orientata alla tutela e valorizzazione della produzione; la seconda, come
orientate alla tutela e valorizzazione del patrimonio, furono tenute a trovare necessari
compromessi per poter ottenere consensi sociali e maggioranze di governo, ma restarono
fortemente incardinate nelle propri linee portanti. La prima fu principalmente sostenuta
dai governi e dai rappresentanti delle élite finanziaria americana, mentre la seconda fu
sorretta dall’élite e dal governo inglese, cui si affiancò quella francese, sia per affinità, sia
per desiderio di recupero di un proprio spazio sullo scenario internazionale.
Testimonianza diretta di queste due visioni – che resteranno intatte per tutti gli anni
Venti e che segneranno i fallimenti delle conferenze mondiali, le scelte delle politiche
protezioniste e della corsa al basso dei prezzi, così come poi la guerra delle svalutazioni
competitive dei primi anni Trenta e in ultimo il compromesso dell’accordo tripartito –, vi
è il carteggio di straordinaria qualità e interesse che di due dei protagonisti assoluti del
periodo: il governatore della Banca di Inghilterra, Montagu Norman, e il governatore
della Fed, Benjamin Strong.
Al primo, che nel redigere il decalogo di comportamento di una banca centrale di
fatto disegnava i contorni dell’intero sistema finanziario fondato sulla triangolazione degli
scambi e sulla gestione dei flussi delle partite correnti, facendo della Banca d’Inghilterra,
come disse Keynes, il direttore d’orchestra dell’intero sistema, Strong replicava: «tutto ciò
ha un suono sinistro per me: sarebbe come consegnare un assegno in bianco ai paesi
poveri»; e in un documento successivo, «la cosa più importante è l’autonomia.
L’autodecisione e la politica interna in base a solidi principi monetari». All’obiettivo di
contrastare indebite fluttuazioni del potere di acquisto dell’oro, egli ribadiva con la
centralità di mantenere la stabilità monetaria all’interno del proprio mercato: «dobbiamo
ignorare completamente qualsiasi percentuale di riserva obbligatoria o tradizionale e dare
8
maggior peso a quanto sta succedendo in […], occupazione, volume del credito e del
fatturato».
Queste due visioni arrivarono, come detto, ad un compromesso operativo che
comportò comunque una condizione di primato dell’una sull’altra. Negli anni tra il 1919
e il 1929 predomina un’idea patrimoniale, legata a necessità di ricostruzione post-bellica;
negli anni successivi alla crisi del 1929-1931, invece, predomina un’idea produttiva, legata
al ripristino dell’attività industriale.
La modalità patrimoniale, riproposizione più complessa del gold standard pre-bellico
discussa e parzialmente messa in opera dopo la conferenza di Genova, consistette nel
ricostruire una rete di scambi di beni e servizi, un sistema finanziario industriale regolato
dallo standard internazionale di un prezzo unico per ogni bene identico
indipendentemente da dove e da chi lo avesse prodotto. Questa condizione comportava,
per ogni paese, due distinti livelli di equilibrio: quello sul mercato interno e quello sul
mercato estero, i quali sarebbero stati raccordati da scorte dei beni e da depositi
sull’estero misurati in valuta nazionale. Questa scelta avrebbe portato, in un tempo breve,
al ripristino delle transazioni dei saldi tra le partite correnti in un un'unica grande stanza
di compensazione, il mercato delle accettazioni della City di Londra che, proprio per la
sua posizione di monopolio, poteva offrire un prezzo efficiente. La crescita economica
americana, però, mise con il tempo in evidenza il limite di queste modalità, che
comportavano una progressiva riduzione dei prezzi sul mercato interno di tutti i paesi
con conseguenze patrimoniali sui produttori. Queste condizioni di tensione finanziaria si
sovrapposero allo shock della bolla finanziaria del 1929 e determinarono la depressione
del 1929-1931 e la necessità di recupero da parte dei governi di incentivi alla produzione
attraverso svalutazioni e crescita dei prezzi.
L’esito della crisi fu, così, un aumento dei prezzi negli Stati Uniti e l’uscita della Gran
Bretagna dal libero scambio. Tali eventi inaugurarono così il prevalere della modalità
produttiva. Ne seguiva la convinzione che le variazioni dei tassi di interesse e dei livelli di
produzione incidessero sul tasso di cambio solo attraverso la loro influenza sulla
domanda di moneta. Conseguentemente si attuò un processo di svalutazione competitiva
tra il 1931 e il 1934, che si concluse quando fu evidente il danno reciproco provocato
un’instabilità prolungata nella scelta degli investimenti industriali. Questa consapevolezza
portò, sul piano internazionale, all’accordo governativo del 1936, noto come accordo
tripartito tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, e, sul piano nazionale, alla
riorganizzazione dei sistemi bancari privilegiando la tutela delle banche commerciali,
rispetto a quelle internazionali, e la loro riorganizzazione comi istituti di raccolta del
risparmio.
2. Guerra di valute
2.1 L’economia di guerra e la definizione del centro (1914-1919)
a. Il mercato dei beni
L’entrata in guerra delle principali economie industriali modificò radicalmente il
mercato dei beni e del lavoro così come era stato organizzato nelle ultime decadi
dell’Ottocento da quella che è stata definita come prima globalizzazione. Gli Alleati
intensificarono il controllo amministrativo sull’intero commercio europeo per mezzo di
9
accordi stipulati con i paesi neutrali per l’acquisto di beni alimentari e materie prime,
prevenendo così che il flusso delle esportazioni finisse verso l’Europa centrale. Inoltre,
venne inaugurato un boicottaggio nei confronti di tutte quelle società d’importazione che
operavano nell’orbita della Germania e dell’Impero austro-ungarico. I tedeschi risposero
a tutto ciò con la guerra sottomarina: tutto il naviglio mercantile intorno alle isole
britanniche, definite zona militare, cominciò a venire attaccato e affondato senza
preavviso.
La guerra sottomarina tedesca e il blocco navale alleato rispondevano entrambi
all’esigenza di limitare l’approvvigionamento necessario alla guerra. Si calcola che, nel
1914, la Germania avesse raggiunto il 90% dell’autosufficienza alimentare, se si considera
l’assunzione calorica. Tale dato, tuttavia, nasconde il fatto che il suo settore agricolo era
dipendente per un terzo dall’importazione di mangimi animali e impiegava circa un
milione di lavoratori stagionali stranieri. La guerra privò l’agricoltura tedesca di queste
fonti, sottrasse la manodopera necessaria ai lavori nelle campagne, nelle quali vi fu anche
penuria di capitali e mancanza di macchinari, carburante, cavalli, foraggio e fertilizzanti
azotati, necessari per aumentare la produttività dei terreni ma utilizzati anche per
fabbricare esplosivi. Tutto ciò portò al declino della produzione agricola tedesca. Alla
situazione fu trovato un parziale rimedio prima con l’introduzione di controlli sui prezzi
dei generi alimentari nell’ottobre del 1914, poi con il razionamento, iniziato nel gennaio
dell’anno successivo, ed infine con la creazione, nel maggio del 1916, di un Ministero per
le risorse alimentari. Inevitabile fu, tuttavia, una crisi alimentare che fece attestare
l’assunzione calorica media al di sotto dei livelli di sussistenza, raggiungendo il culmine
nell’inverno 1917-1918 in seguito ad un cattivo raccolto che ridusse le popolazioni delle
potenze centrale alla fame per diversi mesi.
A differenza di quella tedesca, l’economia britannica aveva maggiori risorse da
investire in agricoltura, il che rese possibile aumentare la superficie totale della terra
coltivabile, che crebbe di tre milioni di ettari tra il 1914 e il 1918. Il risultato fu una
crescita della produzione nazionale del 40%, con una ricaduta positiva sul prodotto
nazionale del 24%. La politica commerciale liberista britannica aveva fatto si che il paese
dipendesse largamente dalle importazioni per quanto riguardava i beni alimentari: il 65%
del fabbisogno nazionale era infatti, al 1914, di provenienza straniera e, almeno fino al
1916, il volume delle importazioni di questi beni primari rimase intorno al 90%,
traducendosi in un aumento dei prezzi al consumo, che fu del 61%. Tuttavia, come
anche in Germania, l’inverno del 1917-1918 fu particolarmente duro, con un cattivo
raccolto e una conseguente penuria di generi alimentari: un efficiente razionamento
gestito dal governo centrale assicurò comunque alla popolazione un’adeguata
alimentazione.
Come in Germania, anche in Gran Bretagna divenne chiaro che l’industria privata non
poteva far fronte da sola ad una guerra la cui fine sembrava più lontana di quanto
immaginato. L’enorme mole di commesse provenienti dal War Office eccedeva, infatti, le
capacità produttive delle industrie nazionali. Il governo britannico si mosse quindi, con
sempre maggior efficacia, verso la regolamentazione e il coordinamento dell’impresa
privata. La nuova organizzazione prevedeva lo sviluppo di una produzione standardizzata
di armamenti impiegando manodopera non specializzata, e quindi a basso costo, con una
conseguente riduzione delle paghe concordata con i sindacati attraverso una serie di
accordi specifici, che furono poi ricompresi nel Munition of War Act del luglio del 1915.
Contemporaneamente venne istituito il Ministero per le munizioni, assegnato a Lloyd
10
George, che dal giugno del 1915 prese il controllo dell’intero settore della produzione del
materiale di guerra.
Le problematiche connesse all’approvvigionamento alimentare e alla produzione del
materiale bellico sono legate a doppio filo con gli sconvolgimenti commerciali innescati
dalla guerra, che finirono per determinare fortemente anche i nuovi orientamenti degli
scambi internazionali nei decenni post-bellici. A causa del maggiore fabbisogno interno
legato alle necessità di guerra, le esportazioni europee verso le altre parti del globo
declinarono rapidamente, portando ad un generale riassestamento e re-indirizzamento dei
flussi commerciali internazionali: si assistette complessivamente ad una ridistribuzione
delle quote di esportazioni che i paesi europei, che fino ad allora avevano giocato la parte
del leone, non potevano più soddisfare. Il processo, una volta iniziato, si dimostrò
difficilmente reversibile nei suoi elementi fondamentali.
Naturalmente le dinamiche degli scambi commerciali fecero aumentare il flusso di oro
verso i paesi neutrali, che godevano di un rafforzamento delle bilance commerciali ed
erano divenuti rifugio per i fondi esteri. Le esportazioni dai continenti extra-europei
raddoppiarono nel periodo 1913-1928. Inoltre, le importazioni dei paesi europei in guerra
modificarono le capacità produttive dei nuovi paesi, determinando la creazione di nuovi
equilibri internazionali.
Fu soprattutto in seguito alla domanda di Gran Bretagna e Francia che la capacità
produttiva delle industrie nordamericane crebbe in maniera esponenziale, stimolando
anche la crescita della marina mercantile che, generando un abbassamento dei costi di
trasporto, portò ad un ulteriore incremento delle esportazioni verso l’estero, inaugurando
un processo che non si sarebbe concluso con il termine delle ostilità. L’America Latina,
territorio tradizionalmente legato all’esportazione britannica, conobbe una crescita delle
esportazioni nordamericane del 75%, che andarono a riempire il vuoto lasciato dal nuovo
orientamento delle risorse britanniche destinate alla guerra. Il Giappone divenne invece il
nuovo concorrente per l’area asiatica: alla diminuzione delle esportazioni europee fece
infatti seguito la costruzione, in territorio giapponese, di nuove cartiere, fabbriche di
medicinali, di vernici e di altri prodotti da distribuire sui mercati di tutta l’Asia. Il settore
tessile, in particolar modo, conobbe un grande sviluppo e il cotone giapponese veniva
venduto in India, nelle Indie orientali olandesi e, per la prima volta nella storia, in
Australia. Anche la grande industria siderurgica e metalmeccanica giapponese proliferò
negli anni tra il 1914 e il 1918, con particolari sviluppi nel settore delle acciaierie e della
cantieristica. Sebbene gli Stati Uniti e il Giappone, in quanto paesi già sviluppati, furono
quelli che maggiormente si avvantaggiarono del conflitto, anche i paesi in via di sviluppo
ricevettero qualche beneficio dal punto di vista industriale: quando, ad esempio, i
prodotti dessili del Lancashire non riuscirono più a raggiungere l’Asia a causa delle
difficoltà nel trasporto del cotone americano, il loro posto venne preso da nuove
manifatture indiane e cinesi.
Se i risultati nel settore industriale furono vari – in Argentina e Brasile, ad esempio, la
scarsità di capitali europei conseguente alla scoppio della guerra soffocò sul nascere lo
sviluppo di un’industria locale – , gli sconvolgimenti nel settore del commercio e della
produzione agricola furono ancora maggiori. Molti produttori delle aree extra-europee
furono indotti ad aumentare la loro produzione per far fronte alle richieste dei paesi
alleati, i cui rifornimenti di grano dalla Russia e dai paesi dell’Europa orientali si
interruppero bruscamente con lo scoppio della guerra. In Canada, ad esempio, i terreni
coltivati a grano aumentarono dell’80% tra il 1914 e il 1918, mentre in Argentina la
11
percentuale fu leggermente inferiore solamente a causa della più scarsa quantità di
tonnellaggio disponibile per il trasporto di cereali verso l’Europa. L’esportazione di carne
argentina, però, il cui rapporto tra valore e volume era maggiore rispetto a quello dei
cereali e quindi poteva venir spedita con maggior profitto, aumentò del 75% nel periodo
compreso tra il 1913 e il 1918.
-
Distribuzione percentuale degli scambi commerciali per continenti, (fonte: B. Eichengreen,
Gabbie d’oro, pp. 118-119)
12
b. La finanza interna
Oltre che nel settore dei flussi commerciali e della produttività, la guerra ebbe enormi
conseguenze anche sotto il profilo della politica fiscale, della politica monetaria e della
finanza internazionale.
Le tradizionali politiche fiscali e monetarie erano infatti del tutto inadatte a finanziare
uno sforzo bellico che si dimostrò ben più lungo, impegnativo e costoso di quanto i
governi dei paesi in guerra avevano inizialmente predetto. Una stima francese del 1911,
ad esempio, affermava che una guerra contro la Germania avrebbe avuto un costo di
circa 20 miliardi di franchi: la reale spesa della Francia si attestò invece su 181 miliardi di
franchi. Queste stime dimostrano inoltre come la guerra era una possibilità tutt’altro che
remota per i governi europei dell’epoca: addirittura nel 1890 le autorità tedesche
svilupparono un progetto secondo il quale, in caso di guerra, la Reichsbank avrebbe
dovuto sospendere la convertibilità in oro del marco e stampare 2 miliardi di marchi in
più, abolendo contestualmente la tassa di 550 milioni di marchi sull’eccesso di circolante.
Le spese statali aumentarono in maniera esponenziale durante il conflitto. Per
finanziare la macchina bellica, i governi dei paesi belligeranti ricorsero all’aumento della
tassazione e all’indebitamento, sia sul mercato interno che su quello estero. Tuttavia, non
tutti gli Stati ricorsero in egual maniera a questi due strumenti, riflettendo le peculiari
caratteristiche del proprio apparato produttivo e finanziario, ma anche le alleanze militari
e la posizione geografica. Complessivamente, l’opinione generale che il conflitto sarebbe
stato di breve durata limitò, inizialmente, l’introduzione di nuove tasse o un incremento
di quelle già esistenti: durante gli anni del conflitto, infatti, la spesa corrente fu finanziata
per meno di un terzo mediante le entrate fiscali. La decisione di non incrementare la
pressione fiscale rispondeva anche a finalità politiche e propagandistiche, nonché ad un
calcolo basato su precedenti esperienze simili. Memori della guerra franco-prussiana del
1871, Francia e Germania tendevano a non aumentare la pressione fiscale preferendo
indebitarsi e stampare nuova moneta, sicuri del fatto che, come appunto in passato, il
peso economico del conflitto sarebbe stato fatto ricadere sul nemico sconfitto.
Dopo la dichiarazione di guerra tedesca del 3 agosto 1914, il governo francese non
fece quasi alcuno sforzo sul versante delle entrate fiscali, preferendo anzi perseguire una
linea politica diametralmente opposta. All’interno della moratoria sul debito, venne
deciso che in caso di arruolamento gli affittuari, tanto nelle città quanto nelle aziende
agricole, sarebbero stati esentati dal pagamento della locazione, facendo così ridurre il
reddito imponibile dei proprietari. Informalmente, inoltre, erano state diramate istruzioni
agli esattori di non perseguire le famiglie dei militari. Tutto ciò risultò in un calo
complessivo del 60% delle normali entrati fiscali al termine del primo anno di guerra. Il
Parlamento tentò di bilanciare questa riduzione delle entrate attraverso l’incremento delle
imposte indirette, in particolar modo le dogane e le accise; tuttavia, dato che il conflitto
aveva fatto diminuire le importazioni di beni di consumo, l’aumento complessivo del
gettito per lo Stato fu decisamente limitato. Una tassa sul reddito venne effettivamente
approvata nel 1914, ma essa entrò in vigore tre anni più tardi contribuendo alle entrate
dello Stato per appena il 5%. Solamente nel luglio del 1916, il governo guidato da
Aristide Briand impose una tassa sui profitti di guerra, anche se il contributo delle
imposte dirette sulle entrate dello Stato francese rimase intorno al 20%.
Complessivamente, se si escludono le dogane, il gettito fiscale francese tornò ai livelli
precedenti il 1914 solo nel giugno del 1917.
13
Il peso della pressione fiscale sul totale del finanziamento bellico fu ancora più basso
in Germania. Il Reich tedesco, inoltre, ereditava un sistema fiscale federale assai
frammentato tra governo centrale e Lander regionali, poco adatto a sostenere uno sforzo
economico nazionale di enorme portata, come fu quello della guerra. La struttura fiscale
federale, derivante dall’unione doganale dello Zolleverein di primo Ottocento, era stata
mantenuta dalla Costituzione del Reich del 1871, che attribuiva alle istituzioni locali il
diritto di riscuotere e percepire le imposte dirette, svolgendo, in tempo di pace, funzioni
di governo. Anche in tempo di guerra, le élite locali esitavano a delegare al governo
centrale il diritto di riscuotere gli introiti della tassazione sulle imposte dirette e quindi,
anche se esse raddoppiarono nel periodo 1914-1918, il loro impatto sul finanziamento
del conflitto rimase basso. Una delle poche novità fiscali introdotte fu una Wehrbeitrag: un
contributo nazionale eccezionale di 1 miliardo di marchi, che venne adottato una prima
volta nel 1913, e ripetuto poi nel 1914 e nel 1915. Le imposte indirette furono quindi
l’unico terreno sul quale il governo centrale del Reich poté avere libertà di manovra. Le
dogane e le accise furono quindi aumentate, anche se le entrate doganali diminuirono
gradualmente nel corso del conflitto soprattutto in connessione alla sospensione delle
tariffe sulle importazioni dei beni essenziali, in particolar modo alimentari, necessaria per
tentare di alleviare le pessime condizioni di vita della popolazione. Le autorità decisero, in
seguito, di introdurre nuove tasse sulla Reichsbank, sul carbone, sui biglietti ferroviari ed
infine, nel 1918, nuove accise sulle bevande e sui prodotti di lusso.
Rispetto a Francia e Germania, la Gran Bretagna, per la sua lunga tradizione di
accentramento amministrativo e per l’ampia condivisione che godeva il principio della
tassazione diretta, si trovava certamente in una posizione di vantaggio per aumentare le
entrate fiscali. L’imposta sul reddito venne raddoppiata già nel novembre del 1914,
aumentando gradualmente negli anni successivi fino a determinare un incremento
complessivo del 500% per il periodo che va dal 1913-1914 al 1918-1919. In generale, se
nel Reich il gettito derivante dalle imposte dirette raddoppiò durante la guerra, in Gran
Bretagna esso quadruplicò, aumentando la quota delle imposte dirette sulle entrate
complessive dello Stato da meno del 60% del 1913-1914 all’80% registrato durante la
seconda metà della guerra. Per attenuare gli effetti di questi aumenti, il governo
britannico elaborò anche un piano pensato come integrazione della maggiorazione delle
tasse sul reddito. Tale piano prevedeva l’imposizione di un’ulteriore imposta sul
munizionamento ed un’altra sui profitti eccedenti i livelli d’anteguerra, andando a colpire
in particolar modo i guadagni di quelle imprese che avevano ricevuto un incremento
eccezionale delle commesse in connessione al conflitto. La guerra segnò anche una netta
discontinuità con il tradizionale libero scambio inglese. Quando vennero introdotti i
cosiddetti dazi McKenna, nel 1915, il dogma libero-scambista venne abiurato nella tacita
accettazione generale, inaugurando tariffe su beni come la birra, il tè, i veicoli, i film, gli
orologi e gli strumenti musicali. Complessivamente, la guerra britannica fu finanziata
molto più attraverso l’aumento della tassazione rispetto a quanto riuscirono a fare
Francia e Germania.
Quando il gettito fiscale, per motivi politici, tecnici o militari, non era in grado di far
fronte alle accresciute necessità statali, il ricorso all’indebitamento diventava necessario.
Teoricamente, i prestiti potevano essere emessi sul mercato interno e sul mercato estero,
anche se non tutti i paesi in guerra ebbero la stessa disponibilità d’accesso ai fondi
stranieri. Tra i paesi impegnati nel conflitto, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna furono gli
unici a riuscire ad ottenere prestiti a lungo termine nel mercato interno. Il governo
britannico, alla data del 1917, aveva emesso tre grandi prestiti a lungo termine garantiti
con l’emissione di buoni del Tesoro o anticipazioni della Banca d’Inghilterra. Se il primo
14
prestito fu collocato presso le grandi istituzioni finanziarie e pochi ricchi imprenditori, la
seconda emissione fu invece sottoscritta da più di un milione di creditori, molti dei quali
provvisti di modesti mezzi finanziari. Negli Stati Uniti, invece il segretario di Stato
William G. McAdoo, orchestrò una sapiente propaganda al fine di indurre alla
sottoscrizione da parte di un vasto pubblico dei cosiddetti Loans for Liberty.
La situazione francese era invece nettamente peggiore. Pur aumentando più
lentamente, il debito crebbe fino a raggiungere un livello decisamente maggiore rispetto
al reddito nazionale. Sul passivo dello Stato pesava in particolar modo l’elevato livello di
partenza del debito d’anteguerra, causato in gran parte dagli indennizzi che la Francia era
obbligata a versare alla Germania in seguito alla sconfitta nella guerra franco-prussiana
del 1871, per pagare i quali il governo aveva ripetutamente emesso obbligazioni i cui
proventi venivano poi trasferiti al governo tedesco. Inoltre, il debito pubblico francese
era aumentato nel 1914 del 50% in seguito ad un grande piano di lavori pubblici,
concentrato in particolare sulla costruzione di un nuovo sistema di canali interni, e per le
spese militari in previsione dell’espansione coloniale. Dato che in Francia non esisteva un
mercato per i titoli a breve delle dimensioni di quello britannico, per ottenere il credito
necessario il governo ricorse alla Banca di Francia, il cui statuto venne modificato ben
nove volte tra il 1914 e il 1919 per permettere all’istituto di fornire allo Stato anticipazioni
al tasso dell’1%. Questa politica monetaria portò però ad una rapida crescita dell’offerta
monetaria in circolazione, che determinò un aumento dell’inflazione: si calcola che la
quantità di franchi in circolazione quadruplicò nel periodo compreso tra il febbraio del
1914 e il febbraio del 1918.
Anche la Germania tentò di emettere debito a lungo termine, ma sperimentò enormi
difficoltà nel collocarlo ad un ritmo adatto a sostenere le esigenze finanziare del governo
centrale. Nel settembre del 1914 venne emesso il primo prestito, sottoscritto da banche,
imprese, società di assicurazione e un numero di piccoli imprenditori. Ad esso, seguirono
ulteriori prestiti ad intervalli di sei mesi, che però non riuscirono a coprire interamente i
buoni del Tesoro emessi dal governo per sostenere le necessità economiche del Reich. La
esigenze di coprire l’indebitamento statale, inoltre, rischiavano di indebolire le capacità di
accesso al credito delle piccole industrie e imprese, deviando verso le finanze pubbliche i
normali flussi. Per proteggere il mondo industriale, quindi, la Reichsbank cominciò ad
acquistare gran parte dei buoni emessi dal Tesoro: si calcola che, fino al 1917, il 75% di
essi finì nel portafoglio della banca centrale tedesca. La conseguenza fu, però, un enorme
aumento dell’offerta delle banconote della Reichsbank, il cui volume crebbe all’incirca di
sette volte nel periodo compreso tra il luglio 1914 e il luglio 1918, generando una pesante
inflazione che rimarrà una caratteristica dello scenario tedesco post-bellico fino alla metà
degli anni venti.
c. La finanza estera
Nei giorni successivi alla dichiarazione di guerra dell’Austria alla Serbia del 28 luglio
1914, al fine di proteggere la solvibilità delle banche, le piazze di Berlino, Parigi e New
York sospesero le attività. Ultima tra di esse, la Borsa di Londra pose fine alle
negoziazioni il 31 luglio; esse sarebbero poi riprese solo il 4 gennaio seguente.
Le merchant bank inglesi furono le più colpite dalle nuove condizioni finanziare
internazionali che si realizzarono durante la guerra. Le loro attività principali, infatti,
quella di accettazione e quella di emissioni di prestiti esteri sulla piazza di Londra, si
interruppero quasi del tutto nella seconda metà del 1914: i prestiti ai governi stranieri,
15
furono proibiti o sottoposti al controllo del governo inglese. Le autorità di governo
presero, al tempo stesso, alcune precauzioni: il 4 agosto venne concessa una moratoria
sui pagamenti, che permetteva di ritardarli di un mese assicurandone il risconto presso la
Banca d’Inghilterra. Provvedimenti simili furono presi a Parigi e Berlino. Wall Street
chiuse i battenti il 31 luglio, poche ore dopo la chiusura della Borsa di Londra in
conseguenza delle ingenti vendite che stavano riguardando i titoli statunitensi; così anche
le borse svizzere, che rimasero poi chiuse fino al 1916, ad eccezione di quella di Ginevra
che riaprì, invece, già il 20 agosto del 1914.
Le ventuno maggiori case bancarie londinesi si riunirono nell’Accepting Houses
Committee per gestire collettivamente le trattative che si sarebbero aperte di lì a breve
con la Banca d’Inghilterra. Il 13 agosto fu raggiunto un accordo tra le parti che prevedeva
che la Banca, con l’appoggio del Tesoro e del governo, scontasse tutte le tratte accettate
dalle banche prima del 4 agosto e concedesse prestiti a tutti quegli istituti accettanti che
non sarebbero stati in grado di onorare gli effetti alla scadenza dei medesimi, stimati in
un valore di circa 350 milioni di sterline.
Seppure tali provvedimenti rivitalizzarono il sistema creditizio inglese, evitando un
collasso generalizzato, non tutte le case bancarie ne beneficiarono in modo eguale. Molto
dipendeva dalla localizzazione geografica degli interessi e delle attività. Se, infatti, la
Baring Brothers, che operava principalmente nelle Americhe e nell’Estremo Oriente, fu
colpita in modo marginale dagli effetti finanziari della guerra, questi ebbero conseguenze
drastiche su un istituto bancario come la Schroder, che intratteneva invece fortissimi
legami con l’Europa centrale e con la Germania in particolare. Le sue accettazioni
caddero dagli 11,7 milioni di sterline registrati nel 1913 a soli 1,3 milioni nel 1918, mentre
gli utili lordi medi precipitarono a 9.000 sterline annue negli anni di guerra a fronte delle
315.000 del periodo 1905-1913.
La guerra non determinò affatto una diminuzione dei flussi internazionali dei capitali: i
paesi Alleati, ad esempio, raggiunsero un totale di ben quattro miliardi di sterline di debiti
tra il 1914 e il 1918. Tra tutti i paesi impegnati nel conflitto, solamente gli Stati Uniti
riuscirono a far fronte alle necessità belliche senza bisogno di indebitarsi all’estero: da
debitori netti essi si trasformarono, grazie alla guerra, nel paese creditore netto del
mondo. Insieme alla Gran Bretagna, che prestò per un totale di 8,5 miliardi di dollari, gli
Stati Uniti erano i creditori maggiori con 9,2 miliardi di dollari, mentre la Francia
rimaneva molto distaccata con 1,7 miliardi di dollari prestati. La Gran Bretagna e la
Francia erano state costrette a indebitarsi con gli Stati Uniti, mentre i francesi ricorsero
anche a linee di credito aperte da Londra. Gli altri paesi della coalizione erano tutti
debitori: la Russia per 4 miliardi di dollari, principalmente nei confronti della Francia e
per una piccola parte verso la Gran Bretagna; l’Italia per 5,1 miliardi di dollari verso Stati
Uniti e Gran Bretagna.
16
-
Politica fiscale di quattro paesi, 1905 e 1913-20 (fonte: B. Eichengreen, Gabbie d’oro, p.
146)
Va tuttavia sottolineato come il sistema dei prestiti internazionali ai governi era stato
del tutto rivoluzionato dal conflitto. Le linee creditizie, infatti, erano gestite sempre più
direttamente dai governi, che si svincolavano dai tradizionali meccanismi che avevano in
passato regolato il settore, emarginando gli istituti privati che si erano specializzati in
queste operazioni finanziarie. Il governo statunitense, ad esempio, prestò direttamente
alla Francia 2,9 miliardi di dollari, mentre solamente 336 milioni arrivarono dalle banche
americane. La Prima guerra mondiale determinò, da questo punto di vista, la fine delle
fortune dei Rothschild, la casa bancaria leader del settore dei prestiti agli Stati. Il loro
declino era tuttavia dovuto anche alle poche connessioni che essi avevano con Wall
Street e New York, che stava diventando il centro dei flussi di capitali a livello globale.
Poche furono le istituzioni bancarie e gli intermediari finanziari che riuscirono a
mantenere una posizione prominente nella gestione degli enormi movimenti di capitali
mobilitati dalla guerra. Se, come detto, i Rothschild persero negli anni del conflitto molto
terreno, la Baring Brothers fece enormi profitti soprattutto grazie alla sua presenza in
Russia e al ruolo di agente ufficiale del governo russo nel Regno Unito, ricoperto fino alla
Rivoluzione del 1917, grazie al quale gestì le trattative per la concessione dei prestiti
inglesi al governo dello Zar. Dall’altra parte dell’oceano Atlantico, la guerra segnò l’ascesa
della casa bancaria privata J.P. Morgan. La banca newyorchese fece registrare enormi
profitti durante gli anni del conflitto grazie a due tipi di attività finanziarie: essa divenne il
principale istituto nella gestione delle emissioni dei prestiti ai governi stranieri e,
17
contemporaneamente, essa ricoprì il ruolo, forse persino più remunerativo, di agente
statunitense dei governi inglese e francese per l’acquisto di munizioni.
Nell’ottobre del 1915 la J.P. Morgan assunse, per la prima volta, il controllo del
sindacato d’emissione per un prestito con destinatari i governi inglese e francese per un
ammontare di 500 milioni di dollari. A questa operazione, che non riscosse un successo
totale, seguirono altri quattro sindacati di emissione, sempre guidati dalla J.P. Morgan a
favore del Regno Unito, che tra il 1916 e il 1917 raccolsero un totale di 950 milioni di
dollari. Nello stesso periodo, più precisamente nel gennaio del 1915, il governo inglese
decise di privare il War Office e l’Ammiragliato del diritto di trattare direttamente
l’acquisto delle munizioni con i fornitori britannici o esteri, soprattutto a causa delle
dimensioni raggiunte dalle richieste fatte alle industrie statunitensi. Il governo britannico,
quindi, decise di trovare un agente sul posto dotato dei contatti e delle competenze
necessarie ad acquistare le merci al miglior prezzo di mercato possibile. La J.P. Morgan,
grazie anche alle connessioni che continuava ad avere con il mercato finanziario inglese,
venne ufficialmente incaricata dal governo britannico di gestire gli acquisti alle migliori
condizioni possibili, ricevendo in cambio una commissione del 2% sul prezzo delle merci
fino a 10 milioni di sterline e dell’1% oltre quella cifra. Questa situazione rimase in essere
fino all’aprile del 1917, ovvero fino all’entrata nel conflitto anche degli Stati Uniti, il cui
governo assunse la gestione dei prestiti e delle vendite di materiale militare agli Alleati in
maniera diretta, lasciando comunque alla J.P. Morgan il ruolo di consulente finanziario.
L’accesso delle potenze centrali ai finanziamenti esteri era decisamente più limitato. A
New York, ad esempio, tra il 1914 e il 1917 solamente 35 milioni di dollari finirono nelle
casse degli Imperi centrali. Il sentimento anti-tedesco presso il pubblico americano si era
infatti rafforzato con il progredire della guerra, raggiungendo il suo apice in
concomitanza con l’intensificarsi della guerra sottomarina e la successiva entrata in guerra
degli Stati Uniti. La Germania tentò, quindi, di ottenere finanziamenti liquidando le
proprie attività all’estero. Tuttavia esse erano, da una parte, posizionate principalmente in
territori vicini o controllati dalle potenze nemiche, le quali sequestravano tutti i beni e le
imprese di cittadini tedeschi; dall’altra si trovavano in luoghi resi inaccessibili dal blocco
navale britannico. Tra le poche fonti di finanziamento rimaste alla Germania vi erano,
quindi, le risorse che essa poteva estorcere ai paesi conquistati, come fece nei casi di
Belgio, Olanda e Lussemburgo. Inoltre, il trattato di Brest-Litovsk, firmato con la Russia
sovietica nel marzo del 1917, anche se non portò alcuna riparazione di guerra al governo
tedesco, accrebbe i domini territoriali della Germania verso est e portò nelle casse del
Reich sei milioni di rubli, pagati per compensare le proprietà tedesche espropriate in
Russia.
d. La politica
Oltre ai mutamenti sul piano strettamente economico appena ricordati, la Prima
guerra mondiale portò un cambiamento radicale anche sul piano politico-decisionale, che
ebbe poi notevoli conseguenze sull’organizzazione e sui rapporti economici e monetari
mondiali degli anni tra le due guerre. Era impensabile, infatti, mobilitare milioni di
uomini e donne per un conflitto così lungo e sanguinoso senza dar loro nulla in cambio.
In tutta Europa si susseguirono, prima, durante e dopo la guerra, una serie di riforme
elettorali che ampliarono largamente il diritto di voto, attenuando o abolendo del tutto il
legame ottocentesco tra voto e proprietà o ricchezza. I parlamenti nazionali, dominati a
lungo dai gruppi dei grandi industriali e dei proprietari agrari, si aprirono per la prima
volta ai rappresentanti delle classi subalterne. In Austria, Cecoslovacchia, Danimarca,
18
Inghilterra, Finlandia, Germania, Olanda, Norvegia, Polonia e Svezia venne anche
concesso il voto alle donne. Contestualmente si assistette ad una improvvisa crescita dei
partiti socialisti e laburisti, così come delle associazioni sindacali: in Gran Bretagna, ad
esempio, il Partito laburista ottenne nel 1918 più di due milioni di voti, a fronte dei
370.000 ricevuti nel 1911.
Era in atto una trasformazione che aveva profonde implicazioni economiche: il
conflitto tra produttori e rentier che aveva dominato i parlamenti ottocenteschi si stava
trasformando in un conflitto tra lavoratori salariati e datori di lavoro.
Contemporaneamente, la guerra aveva visto crescere e trionfare il principio di nazionalità
e quello parallelo di difesa delle minoranze. Il metodo migliore per perseguire questi
obiettivi era quello della rappresentanza proporzionale, e non più maggioritaria, che,
restituendo una fotografia più esatta delle preferenze politiche dei votanti, consentiva da
una parte una crescita numerica dei parlamentari socialisti e laburisti, dall’altra aumentava
la frammentazione politica favorendo il proliferare dei partiti e, quindi, facilitava la
formazione di governi di coalizione intrinsecamente più deboli, esposti ai confliggenti
interessi economici dei diversi gruppi sociali rappresentati. Ad eccezione della Gran
Bretagna, che conservò la sua tradizionale suddivisione in constituencies e un sistema
elettorale maggioritario, nella maggior parte dei paesi europei – tra cui Italia, Germania,
Francia, Belgio, Norvegia, Finlandia, Polonia, Lituania, Estonia e Cecoslovacchia –
vennero introdotti sistemi proporzionali.
Quando alla fine del conflitto le autorità di tutta Europa si cominciarono a muovere
verso il ritorno a quella che veniva considerata una normale cooperazione monetaria e
finanziaria internazionale, incardinata nel ripristino della parità aurea ai livelli pre-bellici, i
conflitti generati da questi tentativi si riprodussero nei nuovi parlamenti eletti con
metodo proporzionale, facendo emergere l’opposizione tra gruppi di interesse sulla
questione della redistribuzione del reddito che le scelte politiche, fiscali e monetarie
implicavano.
Il cambiamento più radicale e con più conseguenze era stato certamente la mutata
condizione dei principali attori economici a livello mondiale. Se Londra era stata in
passato il perno del sistema, con la sterlina che, continuativamente convertibile in oro fin
dal 1819, aveva giocato il ruolo di cardine degli scambi commerciali e
dell’armonizzazione monetaria a livello mondiale, tale situazione, e i rapporti economici e
politici che ne erano conseguiti, era ormai definitivamente superata. Gli Stati Uniti erano
diventati i creditori netti del mondo, attirando a sé una quota sproporzionata di riserve
auree globali, mentre le banche americane erano ormai dei competitori temibili a livello
internazionale nelle operazioni finanziarie, cominciando ad aprire filiali all’estero per
competere con le banche inglesi nel settore dei prestiti a lungo termine.
L’intreccio tra il tema delle riparazioni tedesche imposte a Versailles nel 1919, e
quantificate da un’apposita commissione nel 1921, e i debiti di guerra avrebbe richiesto
che la cooperazione finanziaria messa in campo dagli Alleati durante il conflitto fosse
continuata anche in tempo di pace. Soprattutto, vista la mutata distribuzione delle risorse
finanziarie e delle capacità industriali, gli Stati Uniti avrebbero dovuto accettare
esplicitamente il proprio ruolo centrale all’interno degli accordi e della nuova architettura
finanziaria in via di costruzione. Il ritorno al gold standard pre-bellico, come vedremo,
sarebbe stato tutt’altro che semplice: il quadro macroeconomico generale all’interno del
quale quel sistema aveva funzionato era stato, infatti, irrimediabilmente alterato dal
conflitto.
19
2.2 Stabilizzazione del cambio e mobilità dei capitali (1919-1928)
Gli anni successivi al termine del conflitto furono caratterizzati da un forte e rapido
boom economico, che durò dai primi mesi del 1919 fino all’estate del 1920, quando la
caduta dei prezzi diede il via ad una severa recessione economica che durò fin agli inizi
del 1922.
Nel marzo 1919, inoltre, gli Stati Uniti sospesero le operazioni a sostegno della
sterlina e del franco, che cominciarono a perdere valore. Le autorità inglesi decisero
allora di lasciare che il cambio della sterlina venisse deciso dalle contrattazioni sul
mercato; contemporaneamente, per prevenire un deflusso di oro dalla Banca d’Inghilterra
verso gli Stati Uniti, il 29 marzo 1919 venne emesso un Order in Council che vietava
l’esportazione di monete e lingotti d’oro, ponendo di fatto fine al gold standard.
In ogni caso la sterlina non si svalutò troppo perché, se la guerra pose fine al sistema
aureo ottocentesco, la fiducia che le autorità internazionale avrebbero operato per un suo
rapido ripristino rimase, almeno per qualche tempo, intatta, sostenendo la fiducia nella
valuta inglese.
Coerenti con la diffusa idea che, nonostante i deprezzamenti dovuti principalmente al
deficit della bilancia dei pagamenti e ai crediti esteri concessi da Londra, il governo
britannico avrebbe presto ripristinato la convertibilità aurea, come aveva indicato anche il
Cunliffe Commitee nel 1918, molti paesi – tra cui Belgio, Danimarca, Norvegia, Italia,
Francia, Svezia e Svizzera – agganciarono informalmente, tra il 1919 e il 1920, la propria
valuta alla sterlina.
Quest’ultima, però, si rivelò con il passare dei mesi meno stabile del previsto e presto
questo blocco della sterlina cominciò a disgregarsi, dando vita ad un periodo di instabilità
dei cambi, che determinò contestualmente un processo per il ritorno alla parità aurea che
fu graduale ed estremamente lento: la stabilizzazione tedesca arrivò, ad esempio, solo nel
1924, quella britannica nel 1925 e quella francese di fatto nel 1926 ed ufficialmente nel
1928.
Per comprendere la necessità di mantenere la flessibilità dei cambi devono essere
prese in considerazione le difficoltà che tutti gli Stati europei sperimentarono sul fronte
del debito pubblico, che determinò enormi conseguenze su tutti i livelli, in primo luogo
quello fiscale e monetario, che divennero i campi di battaglia dei diversi gruppi socioeconomici e politici. La medesima scelta di lasciar operare liberamente le forze di
mercato, abolendo i controlli sui prezzi e sulle transazioni rispondeva alla finalità di
segnalare un ritorno alla normalità pre-bellica per rassicurare i maggiori operatori
economici.
Tornare, tuttavia, a questa supposta normalità era tutt’altro che semplice: il mancato
allineamento dei prezzi nei vari mercati si abbinava all’inadeguatezza dei trasporti e ad
un’allocazione di manodopera, impianti e attrezzatura che era stata impiegata nella
produzione di capitale e materiale bellico. A queste difficoltà si aggiungevano gli ostacoli
che permanevano nel settore del commercio internazionale: se, infatti, i nuovi paesi sorti
dalla disgregazione dell’Impero austro-ungarico fecero ricorso alle tariffe doganali per
supplire alla mancanza di un sistema fiscale efficiente, anche gli Stati Uniti aumentarono
la pressione sulle barriere all’ingresso con la tariffa Fordney-McCumber.
20
Come accennato, il problema cruciale era quello del debito pubblico degli Stati. Fino a
quando una quota di quest’ultimo rimaneva senza una copertura, le banche centrali
venivano poste sotto costante pressione da parte del governo per mantenere un basso
tasso d’interesse, da una parte per facilitare l’accesso al credito e il collocamento delle
emissioni del Tesoro, dall’altra per non deprimere gli investimenti che minacciavano di
bloccare il processo di ricostruzione. Se il debito era invece stato consolidato, le spese
derivate comportavano un aumento delle imposte o un taglio della spesa pubblica. La
riduzione di quest’ultima era però impraticabile nel clima politico post-bellico, in quanto
era difficilmente pensabile tagliare le pensioni, l’assistenza sanitaria e le case per i reduci
di guerra, mentre molti governi vararono piani di sussidi e interventi in favore dei
mobilitati disoccupati.
Incrementare il peso fiscale era parimenti difficile, in quanto le parti più ricche della
popolazione premevano, nel quadro di un ritorno alla normalità, per una rapida
abolizione delle tasse straordinarie del tempo di guerra. Contestualmente i rappresentanti
laburisti e socialisti giustificavano il mantenimento di una tassazione progressiva che
andasse a colpire quelle imprese che avevano maggiormente prosperato proprio grazie al
conflitto mondiale. Lo stallo determinò una crescente inflazione, che rappresentava
l’unico modo che le autorità governative avevano per continuare a finanziare la spesa
pubblica senza incidere, nel momento, sugli interessi dei gruppi socio-economici.
a. Il centro del sistema: Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia
Gli Stati Uniti
Dopo la firma dell’armistizio nel novembre del 1918, negli Stati Uniti i prezzi
diminuirono del 5%, e dell’8% in Gran Bretagna: la deflazione fu determinata
dall’aumento del volume delle merci generato dalla riconquistata sicurezza dei trasporti
marittimi. Dalla primavera del 1919, però, l’abolizione dei controlli sulla produzione, sui
prezzi e sulle esportazioni, che spinsero il settore industriale ad una rapida ricostruzione
delle scorte di materie prime e i venditori al dettaglio a riempire i magazzini, generarono
una crescita dell’inflazione, sia per l’abbondante liquidità accumulata negli anni della
guerra, sia per la difficoltà industriali ancora presenti, specie in Europa, dove permaneva
una scarsa capacità produttiva, conseguenza di una difficile transizione da una
produzione bellica ad una di consumo. Le spinte inflattive generarono a Wall Street una
corsa speculativa che indusse interventi del Federal Reserve Board, mentre la
speculazione edilizia si diffuse in tutto le città degli Stati Uniti.
Di fronte a questa situazione la politica fiscale e monetaria americana rimase, però,
espansionistica. Le scelte, in apparenza paradossali, sono da ricercare nella convinzione di
una scarsa incidenza del tasso di sconto nell’indirizzare azioni efficaci in un contesto
mancante di un mercato secondario delle accettazioni, nonché nelle esigenze di gestione
del debito pubblico da parte del Tesoro. Il problema centrale degli Stati Uniti, come
anche della Gran Bretagna, era infatti quello del consolidamento di una grande quota del
debito pubblico, che era stato emesso con scadenza a breve termine. L’obiettivo del
Tesoro americano era sostituire i buoni da esso emessi a breve con obbligazioni a lungo
termine, processo che doveva concludersi, secondo le autorità americane, nel luglio del
1920. Per facilitarlo era necessario che la Fed mantenesse un basso tasso di sconto al fine
di non imporre costi sul Tesoro. Le esigenze del debito pubblico contrastavano, dunque,
con le politiche che si sarebbero dovute attuare per porre un freno all’inflazione, ed anzi
finivano con l’aggravarla. La prova di tutto ciò sta nel fatto che il tasso di sconto della
21
Federal Reserve Bank di New York venne alzato dal 4 al 4,5% solamente nell’ottobre del
1919, in concomitanza con la scadenza per il pagamento dell’ultima rata del Victory Loan.
Tra la fine del 1919 e l’inizio del 1920 le condizioni cambiarono nuovamente. La
crescita cominciò a perdere il suo vigore e dall’estate dello stesso anno si trasformò in
deflazione; ciononostante, il Federal Reserve System aumentò progressivamente i tassi di
sconto prima al 6% e poi al 7%. L’inversione della politica sul tasso di sconto, a fronte di
un indebolimento dell’economia mondiale, fornisce ulteriori indicazioni sulle scelte delle
autorità governative. Il governatore William P. Harding alla conferenza del Federal
Reserve Board del 18 maggio 1920 precisò, che nessuno era all’oscuro che, già all’inizio
del 1920, del crollo del prezzo della seta giapponese, della riduzione delle materia prime,
e del fatto che i prezzi del caffè, della gomma e dello zucchero avevano cominciato a
declinare; tuttavia, il governatore poteva vantarsi del fatto che gli Stati Uniti fossero
l’unico paese industriale che avesse ristabilito la convertibilità aurea della valuta, l’unico
luogo dove fosse possibile ottenere oro senza restrizioni.
Alla fine del primo trimestre del 1920 le riserve auree statunitensi declinarono dal 50%
delle passività emesse fino al 44%, una percentuale pericolosamente vicina alla soglia
minima del 40% prevista dalla legge. Al fine difendere la convertibilità, il Tesoro
cominciò a fare pressioni sulla Fed perché aumentasse il tasso di sconto, che fu in effetti
così alzato. Tuttavia, l’aumento di quest’ultimo determinò un aumento anche da parte
delle banche estere, lasciando invariata la tendenza al deflusso. Gli Stati Uniti avevano
accumulato, nel corso della Prima guerra mondiale, una grandissima quantità di riserve
auree, pari a 23 miliardi di dollari. Queste, però, sembravano non bastare: nel maggio del
1920 il tasso di copertura scese, infatti, al 40,9%. Ne seguì la spinta ad un ulteriore
aumento dei tassi che arrivò fino al 7%, anche se l’attività economica aveva già
cominciato a rallentare. Le scelte di difesa della convertibilità in oro del dollaro, quindi,
andarono a peggiorare la spirale deflattiva, con un conseguente calo dei prezzi,
depotenziamento della produzione e aumento della disoccupazione. Anche quando dalla
metà del 1920 il livello delle riserve auree della Fed cessò di diminuire, i tassi rimasero
elevati per attrarre capitali, ricostruire le scorte e ripristinare la copertura. Si temeva che,
se gli operatori avessero deciso di convertire i tre miliardi di banconote, la convertibilità
avrebbe dovuto essere sospesa e con essa le ambizioni americane di far diventare il
dollaro una delle valute di riserva di livello internazionale. Contestualmente, le autorità
monetarie si mostravano risolute nel mantenere alti i tassi d’interesse al fine di
contrastare la speculazione che era stata stimolata dalla spirale inflattiva del biennio
precedente. Tra il dicembre del 1920 e la primavera del 1921, il Federal Reserve Board
respinse i sempre maggiori avvisi che arrivavano dal segretario del Tesoro americano
Andrew Mellon e da altri politici a Washington per la riduzione del tasso d’interesse.
Le altalene della politica fiscale e monetaria non frenarono la crescita dell’attività della
borsa di New York che, al termine del conflitto, sembrò ereditare per molti versi il ruolo
predominante che era spettato alla City di Londra nel periodo pre-bellico. L’Edge Act del
1919 permetteva alle national banks di costituirsi in società per azioni al fine di ampliare il
proprio raggio d’azione ad operazioni finanziarie internazionali, portando ad una crescita
del numero delle filiali estere delle banche americane da 26 nel 1913 a 181 nel 1920. Il
finanziamento del commercio estero, infatti, era sempre più indipendente dai capitali
inglesi e le accettazioni in dollari cominciavano a fare una concorrenza importante a
quelle in sterline.
22
Queste operazioni finanziarie furono facilitate dalla creazione nel 1919 dell’American
Acceptance Council, che aveva lo scopo di far conoscere i vantaggi di questo strumento
finanziario ad un più vasto pubblico, a cui fece seguito, nel 1921, l’istituzione della
International Acceptance Bank. In questo mercato le banche di New York erano le più
importanti per volume d’affari, scontando il 75% delle accettazioni complessive, con
numeri che crebbero costantemente nel periodo considerato, passando dai 250 milioni di
dollari del 1916, fino a raggiungere 1 miliardo nel 1920 e 1,7 miliardi nel 1929.
Il settore dove Wall Street acquisì un ruolo di leadership, proseguendo un processo
che si era già sviluppato durante la Prima guerra mondiale, fu quello dell’esportazione dei
capitali. In particolar modo dal 1922 in poi, con la ripresa del ciclo economico il
risparmio americano venne indirizzato sempre di più all’estero, usando l’esperienza, le
competenze e i contatti che molte banche della costa orientale avevano sviluppato
durante il conflitto. Durante la seconda metà degli anni Venti, fino al biennio 1928-1929,
i sindacati di emissione di prestiti esteri collocati sulla piazza di New York superarono
quelli collocati su Londra di almeno il 50%. Tali capitali, di cui il 95% fu investito in
obbligazioni di opere pubbliche, vennero indirizzati in tutto il mondo: il 41% di essi
prese la via dell’Europa, il 25% del Canada, il 22% furono emessi in favore di paesi
dell’America Latina, mentre il 12% di paesi asiatici.
Sulla piazza di New York vi furono tre novità fondamentali, soprattutto per quanto
concerne l’architettura finanziaria e le operazioni svolte. In primo luogo, le grandi banche
americane, le investment bank e le national bank, mantennero un ruolo di primo piano nelle
attività finanziarie internazionali, come nel periodo precedente alla Prima guerra
mondiale. Questi istituti, tuttavia, non erano più gli intermediari di investitori europei e
aziende statunitensi, bensì il tramite tra i risparmiatori americani e i debitori europei.
L’Istituto di rifermento in tal senso fu certamente la J.P. Morgan & Co, che costruì le
proprie fortune sul ruolo centrale di intermediario tra i prestiti americani e il governo
britannico. La sua prospettiva internazionale, grazie alla presenza della Morgan, Grenfell
& Co. a Londra e della Morgan, Harjes & Co. a Parigi, fece si che essa divenisse
rapidamente la più grande banca al mondo: con un attivo di 680 milioni di dollari, ovvero
circa quattro volte quello delle più grandi merchant bank inglesi, la J.P. Morgan fu capace
di collocare sul mercato più di sei miliardi in titoli nel periodo 1919-1933.
Non meno importante fu la Kuhn Loeb & Co. che, con un totale in attivo di 120
milioni di dollari registrato nel 1929, aveva costruito le sue fortune grazie alla propria
supremazia negli affari ferroviari, mentre la Dillon Read & Co., fondata nel 1921, aveva
prosperato particolarmente grazie alle emissioni di titoli delle grandi imprese tedesche, tra
cui è degna di nota quella del gigante dell’acciaio Vereinigte Stahlwerke, il cui valore
ammontava a ben 100 milioni di dollari e venne collocata sul mercato newyorchese tra il
1926 e il 1928. Nel settore delle emissioni dei titoli stranieri si ritagliò un posto di rilievo
anche la National City Bank of New York la quale guidò più di un terzo di tutti i
sindacati di emissioni sottoscritti a New York nel periodo 1921-1929, soprattutto per
mezzo della sua società controllata, la National City Company.
Una delle innovazioni finanziarie più importanti che si verificarono sulla piazza di
New York in questi anni furono gli investment trust. Questi, che apparvero per la prima
volta in Gran Bretagna ad inizio secolo, cominciarono a diffondersi negli Stati Uniti
durante gli anni Venti. I nuovi fondi d’investimento venivano promossi dalle società
bancarie e finanziare per promuovere investimenti collettivi e diversificare il rischio.
23
Non sempre, tuttavia, questi progetti erano portati avanti con il massimo della
trasparenza e dell’onestà: l’acquisto di azioni da parte di una società controllata dallo
stesso gruppo al fine di far salire il valore dei titoli costituiva una pratica diffusa, mutuata
da simili operazioni che avevano caratterizzato la piazza londinese alla fine
dell’Ottocento. Gli investment trust ebbero comunque un enorme successo, passando da 40
prima del 1921 a 770 nel 1929, di cui ben 591 formatisi dopo il 1927 in concomitanza
con il boom della speculazione su Wall Street. Nacqueroanche gruppi che riunivano più
fondi d’investimento: tra questi, il maggiore fu senza dubbio il Founders Group, nato nel
1921, che nel 1929 fece registrare un attivo di 626 milioni di dollari, seguito dal gruppo
Goldman Sachs che aveva un attivo di quasi 500 milioni di dollari.
Un ultimo sviluppo del mercato azionario newyorchese deve essere sottolineato,
ovvero la maggiore capacità di attrarre fondi destinati all’economia nazionale.
Parallelamente al boom economico – che durò negli Stati Uniti dal 1922 al 1929 – vi fu
un grande entusiasmo nella sottoscrizione di titoli delle aziende, le quali ricorrevano
sempre più al mercato azionario per finanziare le proprie attività. Per supplire alla
disintermediazione le banche commerciali, attraverso società controllate, iniziarono ad
operare nel settore del mercato dei titoli delle aziende statunitensi: ad esempio, due terzi
delle emissioni a cui partecipò, tra il 1921 e il 1929, La National City Bank, riguardarono
imprese americane. Questo processo fu accompagnato da una crescita del numero dei
piccoli azionisti che, spinti dall’esperienza dei prestiti di guerra e da una generale
pubblicità che invitava all’investimento azionario, cominciarono ad investire nel mercato
borsistico anche quando essi non possedevano i mezzi finanziari per farlo.
La Gran Bretagna
La guerra lasciò in eredità alla Gran Bretagna un mercato monetario caratterizzato da
un eccesso di liquidità, conseguenza diretta dell’aumento del debito pubblico che, per
finanziare la guerra, era salito da 650 milioni a 7.800 milioni di sterline. Un terzo del
debito sarebbe giunto a scadenza in 5 anni, mentre un quinto solamente entro tre mesi,
diventando uno dei problemi principali da affrontare. Tutta la politica economica inglese
degli anni Venti è volta, in primo luogo, a consolidare questo debito a breve
trasformandolo a lunga scadenza, a ridurre il deficit di bilancio dello Stato, ma
soprattutto a ripristinare una parità aurea della sterlina che, sola, avrebbe permesso alla
City di continuare ad essere il centro finanziario mondiale, nonostante la concorrenza
della piazza newyorchese in grande ascesa.
24
-
Tassi di cambio sterlina-dollaro, 1921-25 (B. Eichengreen, Gabbie d’oro, p. 209)
L’abbondanza di liquidità e di domanda inespressa lasciata in eredità dalla guerra rese
possibile un boom economico che, dall’armistizio del novembre del 1918, arrivò, con una
breve pausa, fino all’estate del 1920, quando iniziò una recessione molto grave che ebbe
il suo picco nel 1921. I prezzi aumentarono del 40% fino alla metà del 1920, per poi
cadere del 50% fino al gennaio del 1922, con una parallela diminuzione del costo della
vita e dei salari. Le industrie più colpite da questa crisi furono i tradizionali settori
carbonifero, tessile, siderurgico e della cantieristica navale, che soffrivano fortemente la
concorrenza internazionale. Anche per questo, vi fu in questo periodo un aumento delle
fusioni imprenditoriali, soprattutto nel settore metallurgico, con la creazione della United
Steel Corporation Group nel 1920, e nel comparto tessile, con l’unione di tre aziende
come la Amalgamated Cotton Mills Trust, la Crosses & Heaton e la Joshua Hoyle &
Sons nel 1920.
Sul fronte monetario le cose erano già in moto da prima della fine della guerra. A
gennaio 1918, il governo di Lloyd George nominò il Comitato Cunliffe che doveva
studiare i problemi valutari e dei tassi di cambio alla conclusione della guerra, guidato
appunto da Lord Cunliffe, ex governatore della Banca d’Inghilterra. Di estremo interesse
risulta il fatto che il ripristino della parità aurea della sterlina non fu neanche dibattuto:
esso era, infatti, dato per scontato. L’unico nodo da sciogliere erano le tempistiche, le
modalità e la fissazione del tasso di cambio. Il Cunliffe Report dell’agosto del 1918
proponeva un classico ritorno al gold standard, immaginando il ripristino delle regole di
afflusso e deflusso di capitali che avevano permesso il funzionamento del sistema
monetario e finanziario dell’Ottocento.
La conclusione della guerra portò anche allo sforzo delle classi dirigenti inglesi di
ripristinare il sistema aureo a livello internazionale, in quanto la mancata collaborazione
delle banche centrali degli altri paesi avrebbe infatti depotenziato gli sforzi deflattivi
inglesi per tornare ad una parità aurea pre-bellica. I primi tentativi di trovare un accordo
internazionale vennero fatti alle conferenze di Bruxelles, del 1920, e di Genova, nel 1922.
Alla conferenza di Bruxelles, indetta dalla Lega delle Nazioni e svoltasi tra il 24 settembre
e l’8 ottobre 1920, vennero indicati i tre problemi principali che affliggevano il contesto
economico internazionale, tutti e tre strettamente connessi tra loro: il primo era la
tendenza inflattiva, che poteva essere risolta solo attraverso un pareggio del bilancio; il
secondo era l’instabilità dei tassi di cambio, per il consolidamento dei quali si aveva
bisogno di una stabilizzazione dei prezzi; infine, il problema della scarsità dei capitali
necessari all’industria, risolvibile solamente con la riattivazione dei canali creditizi
internazionali.
25
A Bruxelles non fu però presa alcuna risoluzione. A ragione di ciò si può addurre il
fatto che nessun argomento di tale importanza poteva avere una soluzione efficace finché
i problemi circa le riparazioni tedesche e i connessi debiti inter-Alleati rimanevano in
sospeso. Se la raccomandazione di portare in pareggio il bilancio attraverso un netto
taglio delle spese sociali e militari aveva comunque un ampio successo, lo stesso non si
può dire dello schema proposto dagli inglesi di creare in seno alla Lega delle Nazioni,
un’organizzazione internazionale incaricata di concedere prestiti per la ricostruzione. A
tale ipotesi si opposero in primo luogo gli Stati Uniti, che temevano che nuovi prestiti
internazionali avrebbero compromesso il rimborso di quelli già esistenti.
Le complicazioni che avevano minato il successo della conferenza di Bruxelles si
ripresentarono anche due anni dopo, alla conferenza internazionale di Genova. Un
ulteriore problema era legato alla grande scarsità di oro. La produzione era, infatti,
diminuita costantemente dal 1913, mentre la domanda era aumentata. Contestualmente,
una gran parte delle riserve auree europee era finita negli Stati Uniti per effetti dei
mutamenti commerciali e nei flussi creditizi occorsi a causa della guerra. Per far fronte a
questo problema, particolarmente pressante soprattutto per la Gran Bretagna, la
commissione finanziaria della conferenza predispose alcune proposte, elaborate
dall’establishment monetario e finanziario inglese, per armonizzare gli interventi delle
banche centrali dei diversi paesi.
Venne così proposto un nuovo sistema, che prevedeva la possibilità per le banche
centrali di detenere, oltre l’oro, riserve ufficiali in valuta estera. Candidando la City a
ritrovare il ruolo ottocentesco di centro finanziario mondiale, la proposta rispondeva alle
necessità inglesi di recuperare il terreno perduto durante la guerra nei confronti di New
York. Nuovamente, però, questi tentativi sarebbero difficilmente stati coronati da
successo finché gli Stati Uniti non si fossero decisi a cooperare con i paesi europei. Tale
atteggiamento, però, era contrastato da una visione fortemente nazionalistica delle
autorità monetarie e politiche americane. Gli Stati Uniti operavano già in un regime di
gold standard con riserve auree più che abbondanti, con rischi di deflazione ridotti al
minimi, e non si reputava necessario instaurare un sistema di cooperazione internazionale
guidato, per di più, dalla Banca d’Inghilterra, che avrebbe indebolito il sistema americano
in ascesa.
Nel periodo 1920-1925, la sterlina guadagnò sul dollaro in maniera non continuativa,
esponendosi a continui apprezzamenti e deprezzamenti. Il tasso di cambio era infatti
salito da 4,63 dollari per sterlina alla fine del 1922 fino a 4,70 del gennaio 1923, data in
cui entrò in carica il primo governo laburista della storia inglese. In concomitanza con
l’invasione franco-belga della Ruhr e della fuga di capitali francesi verso Londra, la
sterlina declinò a 4,30 dollari, anche in conseguenza della sfiducia di cui godeva il Partito
laburista al governo negli ambienti finanziari.
Anche il governo laburista aveva comunque sottoscritto gli obiettivi del Cunliffe
Committee, impegnandosi al ripristino della parità aurea e nominando, nel febbraio del
1924, il comitato Chamberlain-Bradbury, incaricato di fare le proprie proposte sui temi
del consolidamento del debito pubblico e sulle condizioni del ritorno della sterlina al gold
standard. La deflazione implicita in questo processo intensificava, infatti, le pressioni sui
buoni del Tesoro, facendo diventare necessario un consolidamento del debito fluttuante.
Trasformare i buoni a breve del Tesoro in obbligazioni avrebbe infatti ridotto il valore
del debito in scadenza negli anni successivi.
26
Con il ritorno dei conservatori al governo nell’autunno del 1924, giunse alla
conclusione il processo di consolidamento del debito pubblico e della stabilizzazione
della sterlina alla parità d’anteguerra. Responsabile di tale politica fu, in primo luogo, il
nuovo cancelliere dello scacchiere Wiston Churchill. L’aggiustamento monetario
necessario fu tentato invitando gli Stati Uniti a perseguire una politica inflattiva, che
avrebbe alleggerito le pressione della svalutazione della sterlina sull’economia britannica.
Gli americani, però, non erano assolutamente propensi ad intraprendere questa strada:
una recessione dell’economia ebbe sì luogo nel 1924, ma essa fu talmente breve e tiepida
che non convinse le autorità statunitensi a restringere il credito interno.
Come detto, però, la deflazione era inevitabile. I salari cominciarono a diminuire,
soprattutto nel settore dell’industria carbonifera che non mostrava alcun segno di ripresa,
anche in connessione con il prestito Dawes che aveva ridato slancio alla concorrente
industria carbonifera e siderurgica tedesca. La disoccupazione, quindi, rimaneva su alti
livelli, attestandosi su due cifre percentuali per tutto il periodo fino al 1940. Le politiche
deflattive attuate per tornare alla parità prebellica della sterlina si andarono infatti a
concatenare con una serie di difficoltà che le industrie britanniche stavano incontrando
fin dalla fine dell’Ottocento in conseguenza all’inefficienza produttiva dei principali
settori tradizionali. La concentrazione regionale della disoccupazione certifica tale analisi:
essa si concentrava infatti nelle zone dello Yorkshire, del Lancashire, della Scozia, del
Galles e dell’Inghilterra nord-orientale, dove condensava la produzione di carbone, di
acciaio, di prodotti tessili e della cantieristica navale. Nel 1921, ad esempio, la percentuale
di disoccupati dei cantieri navali ammontava al 36%, e quella del settore meccanico al
27%, a fronte di una media nazionale, comunque alta, del 17%. L’aumento della
disoccupazione provocò un sommovimento sindacale che culminò nello sciopero
generale del maggio del 1926 che, pur ricevendo un’adesione spettacolare da parte di
tutte le categorie sindacali – continuando, per i minatori, per ben sei mesi – non ebbe
infine delle ripercussioni sul fronte salariale. Le paghe, infatti, vennero comunque
drasticamente ridotte portando il livello generale dei salari a livelli tutt’altro che
considerevoli.
Il peso della svalutazione della sterlina ricadde interamente sulle spalle dell’economia
industriale britannica. D’altronde, quando il 28 aprile del 1925 Churchill annunciò,
durante il Budget Speech, il ritorno della sterlina alla parità aurea prebellica fissata in 4,86
dollari per sterlina, per sua stessa ammissione egli pensava più alle necessità della City, del
ripristino dei flussi commerciali internazionali e con essi del ritorno ad una supremazia
inglese nel settore degli investimenti all’estero, dei prestiti internazionali e dei movimenti
di capitale. Queste politiche, insieme alle competenze finanziarie dei banchieri londinesi,
fecero si che, sebbene New York divenne la piazza preferita per ottenere finanziamenti
da parte di pubblici e privati, la City continuò ad essere un centro finanziario di primo
piano, aumentando le proprie ricchezze per tutti gli anni Venti.
Nel mercato dei cambi, un’attività che si sviluppò nel clima di instabilità monetaria del
periodo inter-bellico, la piazza londinese divenne fin da subito il polo principale, grazie
soprattutto alla grande quantità di banche da tutto il mondo che avevano un ufficio o una
filiale nella City. Tra i principali operatori in questo settore vi erano quei broker che
avevano già una certa esperienza in cambi esteri, come S. Japhet, Samuel Montagu e R.
Raphael, ma il ruolo di leader di questo tipo di mercato fu ricoperto dalla Kleinwort, una
delle merchant bank più grandi, che fece fruttare al massimo la sue partnership con la
Goldman Sachs a New York, nonché le relazioni con Amsterdam, Berlino, Parigi e
27
Budapest. Anche nel settore del finanziamento del commercio internazionale la
supremazia inglese era pari a quella avuta nel periodo precedente al 1914, recuperando
dalle ovvie ripercussioni subite durante la guerra. Il volume delle accettazioni sul mercato
londinese tornò ai livelli del 1913, ovvero a 350 milioni di sterline in valore nominale, già
nel 1920. Dopo questa data vi fu un declino in concomitanza con la recessione del 19201921, al quale seguì però una importante crescita che portò al massimo di 415 milioni di
sterline nel 1926, facendo rimanere la cambiale su Londra lo strumento principale per
finanziare i flussi commerciali globali.
Nel periodo successivo alla Prima guerra mondiale si assistette anche ad una maggiore
concentrazione nel settore bancario. Attraverso una serie di fusioni apparvero quelle che
vennero poi definite le Big Five, società bancarie gigantesche che non avevano eguali
neanche a Wall Street. Queste erano la Midland Bank, la Lloyds Bank, la Barclays Bank,
la Westminster Bank ed infine la National Provincial Bank. Le prime tre erano le più
grandi banche al mondo e, tutti insieme, questi istituti bancari raccoglievano più del 90%
dei depositi dell’intero paese, soprattutto attraverso una fitta rete nazionale di filiali.
Queste nuove grandi banche cominciarono a fare una concorrenza spietata alle vecchie
merchant bank, sia sul mercato delle accettazioni, sia per le attività all’estero. Merita di
essere ricordato, ad esempio, l’iniziativa della Barclays di formare quella che potrebbe
essere definita come una banca imperiale britannica, acquisendo il controllo della AngloEgyptian Bank, della National Bank of South Africa e della Colonial Bank, che
confluirono nella maggior banca multinazionale dell’epoca, che contava ben 506 filiali
all’estero: la Barclays Bank Dco (Dominion, Colonial and Overseas).
Complessivamente, l’influenza internazionale di Londra aumentò, soprattutto grazie
alle banche multinazionali con sede nella capitale dell’Impero britannico. Tra il 1913 e il
1928, infatti, il totale delle filiali estere delle banche britanniche, le quali erano diminuite
da 31 a 27, quasi raddoppiò, passando da 1387 a 2253. In questo nuovo contesto,
comunque, le merchant bank, controllate ancora dalle famiglie fondatrici ed estremamente
più piccole delle Big Five, continuarono ad occupare il ruolo dell’aristocrazia bancaria
inglese: la Baring Brothers era ancora la maggiore casa bancaria degli anni Venti; seguiva
poi la Schroder & Kleinwort, la Morgan Grenfell, con forti legami con la J.P. Morgan &
Co, newyorchese; la Hambro ed infine i Rothschild, il cui declino era in realtà relativo e
mantenevano un ruolo importante nel mondo finanziario.
La Francia
Anche la Francia uscì dalla Prima guerra mondiale con un eccesso di circolazione
monetaria e un enorme debito pubblico, al quale si aggiungeva un livello di tassazione
decisamente modesto. Fino al 1923, però, il paese rimase convinto che i costi della
ricostruzione dei distretti nord-orientali, distrutti durante la guerra, sarebbero ricaduti
interamente sulla Germania. Basandosi su questo assunto, il governo avviò una politica di
forte indebitamento senza aumentare la tassazione.
Grazie ad una politica monetaria espansiva la ricostruzione delle zone distrutte dal
conflitto proseguì certamente a ritmo accelerato e la Francia, dopo un breve
rallentamento nella recessione del 1921, fu uno dei paesi più produttivi nel boom
economico degli anni successivi. Una conseguenza di queste politiche fu, però, un
ulteriore aumento della circolazione monetaria e, di conseguenza, un corrispondente
aumento dell’inflazione. Posto a 100 i prezzi all’ingrosso del 1914, i prezzi arrivarono a
28
333 nel dicembre 1921; a 468, nel 1923; a 518 nel 1924; ed infine a 640 nel dicembre
1926. Un accordo tra il ministro delle finanze e la Banca di Francia, siglato nel dicembre
del 1920, imponeva un tetta al debito a cui poteva accedere il governo pari a 27 miliardi
di franchi, che doveva essere ridotto di due miliardi di franchi all’anno a partire dal
dicembre del 1921. Un secondo massimale, pari a 41 miliardi di franchi, veniva
introdotto anche per il circolante monetario, che era salito dai 27,5 miliardi di franchi del
1918 fino a 37,3 miliardi nel 1921.
Nel periodo compreso tra il 1919 e il 1923, convinti che tutto l’indebitamento sarebbe
ricaduto sulla Germania attraverso un pesante piano di riparazioni, il debito interno
crebbe di 90 miliardi di franchi. Di questi, però, meno della metà venne finanziato con
titoli a lungo termine e irredimibili. Il resto del debito fu finanziato, invece, con i bons de
la défense nationale a breve termine, con scadenze a uno, tre, sei, dodici o ventiquattro mesi,
che ponevano lo Stato in una situazione estremamente precaria dal punto di vista
finanziario, in quanto la circolazione di notizie sfavorevole poteva facilmente
trasformarsi in un mancato rinnovamento dei bons in scadenza.
La situazione del franco cominciò a diventare preoccupante quando, dopo il
fallimento dell’invasione della Ruhr, risultò chiaro che la Germania non avrebbe pagato il
debito francese e che, quindi, il governo doveva trovare altri metodi per ottenere i fondi
necessari. Il problema fiscale divenne, quindi, all’ordine del giorno e determinò il
percorso del franco dalla svalutazione fino alla stabilizzazione raggiunta di fatto nel 1928.
Contestualmente all’insuccesso dell’invasione della Ruhr, si diffuse nell’opinione pubblica
il fatto che l’accordo tra ministro delle finanze e Banca centrale era stato violato: nel
novembre del 1923, infatti, il governo, per la seconda volta consecutiva, non sarebbe
riuscito a corrispondere alla banca i due miliardi di franchi pattuiti a causa della scarsità
delle entrate di quell’anno, costringendo il Parlamento a votare una legge eccezionale che
permetteva di non rispettare l’accordo preso.
Tra il settembre del 1923 e il febbraio del 1924 si assistette di conseguenza ad un
deprezzamento del franco, che passò dai 16 a 25 franchi per dollaro, producendo una
crisi inflattiva che cominciò a spaventare le industrie esportatrici, che iniziarono a
fatturare le vendite all’estero in valuta, ritardando contestualmente il rimpatrio delle
entrate dall’estero per non subire perdite dovute al tasso di cambio. Per arginare il
deprezzamento del franco e l’inflazione, il Parlamento approvò nel marzo del 1924 un
aumento del 20% delle imposte, riuscendo così a porre le basi per una rinnovata fiducia
nei creditori esteri e prendere in prestito 100 milioni di dollari dalla J.P. Morgan e 4
milioni di sterline sulla piazza di Londra. Dopo questa manovra finanziaria il franco
cambiò rotta, apprezzandosi del 40%, e il disavanzo fiscale in percentuale alla spesa
pubblica si dimezzò tra il 1923 e il 1924, diminuendo ancora del 75% nel periodo 19241925. Nel gennaio del 1926 il Ministro del tesoro fu infine in grado di far fronte agli
impegni presi con la Banca di Francia restituendo 2 miliardi di franchi del proprio debito.
Contestualmente, lo Stato pose freno al suo indebitamento, che passò da 3,8 miliardi di
franchi nel 1923 a 0,8 miliardi del 1925.
L’adozione di queste misure, che avevano permesso alla valuta francese di superare la
crisi inflattiva del 1924, non bastarono però ad evitare il ripresentarsi di una nuova crisi,
che si manifestò tra il 1925 e il 1926 pur a fronte dell’assenza di problemi fiscali o di
disavanzo della spesa pubblica. Il franco cominciò a cedere all’inizio del 1925, passando
da 19 per dollaro fino a 27 di fine anno, per arrivare nel luglio del 1926, all’apice della
crisi, a 41 franchi per dollaro. Le cause profonde di questa nuova crisi del franco vanno
29
ricercate all’interno delle politiche fiscali e, soprattutto, nella non risolta disputa tra
sinistra e destra su quali gruppi sociali avrebbero dovuto sostenere l’onere fiscale per il
risanamento del debito pubblico. Nel 1924, infatti, l’aumento del 20% delle imposte
aveva finito per gravare soprattutto sui gruppi sociali che sostenevano tradizionalmente i
partiti di sinistra i quali, appena giunti al governo con Herriot dopo le elezioni generali
del 1924, tentarono di spostare l’onere fiscale altrove. Nella legge finanziaria elaborata dal
Ministro delle finanze Etienne Clémentel vi era, infatti, una riduzione delle imposte di
consumo e un aumento delle imposte dirette, con una nuova tassa patrimoniale pari al
10% del patrimonio posseduto.
Le conseguenze di queste manovre finanziarie furono di due tipi: da una parte vi fu
una fuga di capitali all’estero, mentre dall’altro si assistette ad un rifiuto a rinnovare
l’acquisto dei bons del a défense nationale in scadenza, che portò la Banca di Francia a
scontare i buoni del Tesoro stampando la moneta necessaria alle esigenze finanziare del
governo. Questo portò, però, a superare agli inizi del 1925 quel massimale sul debito
governativo verso la Banca di Francia deciso con l’accordo del 1920, la cui violazione fu
però nascosta dalle autorità governative e monetarie francesi falsificando il bilancio della
banca centrale, fin quando la cosa divenne di dominio pubblico in aprile portando alle
dimissioni di Herriot. L’incertezza politica continuò però a dominare la scena francese:
fino a tutta la prima metà del 1926, si susseguirono una serie di governi e ministri delle
finanze che non riuscirono a mettere insieme le maggioranze parlamentari necessarie a
far approvare i vari provvedimenti fiscali proposti.
Nell’estate del 1926 la crisi si era talmente aggravata che alcuni deputati della sinistra
moderata che, guidati dall’economista Bertrand Nogaro e dall’ex banchiere Jacques
Duboin, si rivoltarono al Cartel des Gauches sostenendo che la priorità assoluta era
addivenire ad una stabilità monetaria. Dopo aver fatto cadere un secondo governo
Herriot nel luglio del 1926, questo gruppo di dissidenti costituì la base dell’accordo per la
formazione di un nuovo governo di unità nazionale nuovamente guidato da Poincaré.
Tramontando così definitivamente la prospettiva di un’imposta patrimoniale, alla quale il
Bloc National si era sempre opposto, Poincaré si fece attribuire dal Parlamento pieni
poteri in materia finanziaria inaugurando una politica di tagli alla spesa e di incremento
delle imposte indirette.
La nuova politica economica di Poincaré allontanò i timori di una patrimoniale e fece
rientrare i capitali in Francia, stabilizzando il mercato dei bons governativi e arrivando così
a stabilizzare il franco, con un decisivo miglioramento del cambio. Dai 49 franchi per
dollaro registrati il 21 luglio 1926, si arrivò infatti, in dicembre, a 25,5 franchi per dollaro,
che divenne anche la parità a cui il cambio venne fissato dalla Banca di Francia al
momento della stabilizzazione nel luglio del 1928. Se raffrontato ai 5 franchi per dollaro
del periodo precedente alla Prima guerra mondiale, quindi, il franco aveva perso ben
l’80% del proprio valore.
30
-
Prestiti americani all’estero e variazioni delle riserve internazionali, 1919-1929, (fonte: B.
Eichengreen, Gabbie d’oro, p. 157)
b. La periferia del sistema: Germania, Italia e Giappone
La Germania
Le nazioni vincitrici decisero di far ricadere unicamente sulla Germania la
responsabilità morale del conflitto e, conseguentemente, l’onere economico per la
ricostruzione post-bellica. Nel 1919, alla Conferenza di pace di Versailles, fu stabilito che
il paese tedesco doveva versare annualmente dei pagamenti con finalità di riparazioni. La
situazione fu aggravata dal fatto che l’ammontare esatto di tali riparazioni e la loro
rateizzazione rimasero per lungo tempo nell’incertezza, provocata in gran parte dal
disaccordo tra gli Alleati, che non riuscivano a raggiungere una posizione unica né
sull’ammontare totale, né sulle modalità dei versamenti. Il governo francese era
inflessibile nell’esigere cifre esorbitanti, attraverso le quali mirava ricostruire i dieci
départements nord-orientali più colpiti dai combattimenti e ripagare gli enormi debiti
contratti con Gran Bretagna e Stati Uniti; questi ultimi si rifiutavano sia di rinunciare a
parte dei crediti francesi, sia di elargire nuovi prestiti a condizioni di favore per la
ricostruzione post-bellica.
A Versailles si finì per posticipare indicando una Commissione per le Riparazioni, che
raggiugerà poi un accordo solo un biennio più tardi durante la Conferenza di Londra del
1921. Due eventi in particolare determinarono questo protrarsi: il 19 novembre del 1919
il Congresso degli Stati Uniti rifiutò il Trattato di Versailles, vedendosi quindi di
conseguenza declassare il proprio rappresentante nelle commissioni finanziarie degli anni
Venti a membro osservatore; nello stesso novembre del 1919, le elezioni politiche
portarono, in Francia, alla vittoria della coalizione di destra del Bloc National.
Nel 1921, anno in cui ricorreva il cinquantenario della guerra franco-prussiana, gli
Alleati decisero che la Germania sarebbe stata costretta a pagare riparazioni per un totale
simile a quello imposto alla Francia nel 1871, ovvero di 132 miliardi di marchi oro,
31
l’equivalente a 31 miliardi di dollari. Il determinare il debito tedesco in oro aveva la chiara
finalità di assicurare le potenze vincitrici che tale somma non sarebbe stata erosa da una
possibile svalutazione o dall’inflazione. A questa cifra si sommava un miliardo di marchi
annui da versare per sostenere le spese dell’occupazione e una tassa del 26% sul totale
dell’esportazioni annue tedesche per i successivi 42 anni. La proposta Alleata, presentata
nel gennaio del 1921, venne approvata, nonostante le resistenze tedesche, nel maggio
dello stesso anno.
La situazione non era comunque rimasta immobile nel periodo intercorso tra
Versailles e la Conferenza di Londra. La Germania, infatti, fu obbligata immediatamente
a iniziare i primi trasferimenti verso le potenze vincitrici, in particolar modo quelli per la
Francia, la quale come detto basava i suoi piani di ricostruzione industriale soprattutto sul
carbone tedesco. Fino al maggio 1921 una serie di pagamenti interinali pari a otto miliardi
di marchi oro vennero effettuati, appunto, principalmente in carbone, ma anche in oro
della Reichsbank, materiali bellici, proprietà immobiliari del settore pubblico nei territori
e nelle colonie cedute, materiale rotabile e naviglio. Il governo tedesco effettuò tali
pagamenti soprattutto per dimostrare alle potenze vincitrici la propria disponibilità e
conseguire così una riduzione sul totale dovuto. Questi sforzi si rivelarono, però, vani e
la riduzione non fu mai ottenuta.
Tutti i beni ceduti tra il 1919 e il 1921 erano di proprietà statale, quindi essi non
ebbero impatto sul settore privato né, nell’immediato, sulle finanze e sul debito dello
Stato. Quando, però, ci si sarebbe trovato di fronte alla necessità di sostituire il materiale
ceduto, il governo sarebbe stato costretto a indebitarsi ulteriormente, aumentando le
incertezze sul futuro della Germania, complicate politicamente anche dal fallito putsch di
Kapp del marzo del 1920. Per far fronte ai pagamenti interinali e in prospettiva delle
future riparazioni, il Ministro delle finanze Matthias Erzberger fece approvare nel 1920
dal Reichstag una riforma del sistema fiscale che mirava ad aumentare gli introiti statali
sia tramite un’imposta speciale, sia attraverso il trasferimento delle imposte sul reddito
dai Lander al Reich.
L’ammontare delle riparazione equivaleva al 10% del reddito nazionale tedesco. Per
ottenere tale cifra è stato calcolato che la Germania avrebbe dovuto trasformare in valuta
estera per i pagamenti l’80% delle esportazioni del 1921-1922. Questo obiettivo si
sarebbe potuto raggiungere tagliando drasticamente le importazioni, ma la riduzione di
inputs esterni come il rame, il cotone e la lana, non era coerente con la necessità di
aumentare le esportazioni, dato che l’industria tedesca si fondava su tali importazioni. Un
incremento di queste ultime, la cui dipendenza era in effetti aumentata in seguito alla
perdita di parte del territorio nazionale e delle colonie, era invece più che necessario.
Tuttavia, anche se le esportazioni tedesche fossero cresciute in maniera così eccezionale,
difficilmente le potenze vincitrici avrebbero potuto gestire senza danni per le proprie
industrie un’invasione di merci provenienti dalla Germania, la cui produzione si
concentrava tradizionalmente in settori già altamente competitivi come la siderurgia,
l’industria tessile e quella carbonifera. Il paradosso fu che gli Alleati, mentre criticavano
lo scarso impegno tedesco ad accrescere le proprie esportazioni, incrementavano le
tariffe doganali in entrata. Sull’intera situazione gravava inoltre la recessione economica
del biennio 1920-1921, che riduceva contemporaneamente sia le disponibilità degli Alleati
all’importazione, sia quelle tedesche alle esportazioni.
Ciononostante, sorprendentemente, il governo tedesco riuscì a effettuare il 75% delle
riparazioni previste per l’anno successivo al maggio 1921. Gran parte del merito è da
32
attribuire alla riforma della tassazione di Ezrberger. Per questo motivo un piano simile
venne preso in considerazione anche nell’estate del 1921. Il nuovo governo guidato da
Herman Muller, però, non riuscì a raggiungere un accordo tra le diverse parti politiche:
mentre i socialisti chiedevano una nuova tassa patrimoniale, le altre forze desideravano
un aumento delle imposte sulle vendite. Il compromesso, facilitato dalla concessione fatta
dalla Commissione per le Riparazioni di ridurre al 75% i pagamenti previsti, venne
raggiunto solamente nel gennaio del 1922: la DVP diede il via libera ad un prestito
forzoso pari ad un miliardo di marchi oro ed in cambio i socialisti della SPD accettarono
un incremento delle tasse sui consumi.
La situazione sopra descritta determinò, nel periodo che va dalla fine del conflitto alla
prima metà del 1922, una crescente inflazione. Il governo tedesco fece perno sul
collocamento delle proprie obbligazioni presso la Reichsbank, la quale si trovava in
questo modo obbligata a creare nuova moneta che andava ad alimentare la spirale
inflattiva. Inizialmente, tuttavia, la situazione sembrava sotto controllo, almeno fin
quando determinate categorie potevano avvantaggiarsi della situazione. I gruppi
industriali e mercantili, infatti, incrementarono i propri profitti giocando sull’aumento dei
prezzi che si verificava tra il momento dell’acquisto e quello della vendita di un bene. La
produzione, e quindi l’occupazione, era in tal modo stimolata dall’inflazione. In questo
contesto le organizzazioni sindacali si limitavano a garantire che i salari crescessero nella
stessa misura in cui crescevano i prezzi. Nello stesso tempo, la credibilità di cui godeva
l’idea di un rapido ritorno al gold standard internazionale, spingeva gli investitori stranieri a
far affluire capitali in Germania, basandosi sul fatto che il deprezzamento del marco
avrebbe presto subito un’inversione di tendenza, consentendo conseguenti profitti in
linea capitale.
In questo contesto, l’attenzione deve essere focalizzata sull’andamento del tasso di
cambio del marco sul dollaro. Le sue variazioni sono infatti una spia della fiducia
accordata all’economia tedesca dai mercati internazionali e riflettevano, quindi, qualsiasi
variazione che avvenisse sul fronte politico internazionale e nazionale, dal tema delle
riparazioni, all’accordo sulla riforma fiscale, fino alla più generale stabilità interna della
Germania. Tra il maggio 1920 e il maggio 1921 la situazione rimaneva indeterminata sia
sul fronte delle riparazioni sia per i possibili, ma non certi, effetti della riforma di
Erzberger, facendo oscillare il marco senza tendenze chiare. Dopo l’ultimatum del
maggio del 1921 lanciato dagli Alleati riuniti a Londra, il marco si indebolì notevolmente,
per poi recuperare terreno tra l’autunno del 1921 e il gennaio del 1922. Durante il 1922,
però, il marco subì ulteriori deprezzamenti, soprattutto in conseguenza di un mancato
accordo sulle riparazioni, sulla riforma fiscale interna, e in seguito alla crescente instabilità
politica interna, soprattutto in conseguenza dell’assassinio di Walter Rathenau, Ministro
degli esteri e portavoce del fronte moderato tra i più ascoltati in campo internazionale.
La situazione subì una svolta quando, alla fine del 1922, Raymond Poincaré divenne il
nuovo Primo ministro francese a guida di una coalizione di destra e nazionalista non più
favorevole a contrattare nuovi compromessi sulle riparazioni, ma disposta invece all’uso
della forza, come dimostrò l’invasione della Ruhr da parte di truppe francesi e belghe,
che entrarono in territorio tedesco l’11 gennaio del 1923. Anche in questa occasione il
tasso di cambio reagì prontamente con una nuova svalutazione del marco. La mossa
francese, però, unita alla resistenza passiva dei lavoratori tedeschi della Ruhr, non riuscì a
spezzare l’impasse sulle riparazione e dal maggio del 1923 l’inflazione tedesca si
trasformò in iperinflazione, con una crescita del tasso di cambio, della circolazione
monetaria e dei prezzi che non aveva precedenti per la sua rapidità e gravità.
33
-
Tassi di cambio marco-dollaro. Prezzi e circolazione di banconote, 1919-23 (fonte: B.
Eichengreen, Gabbie d’oro, p. 162)
In questo contesto il disavanzo del bilancio pubblico, già in passivo per via dei
pagamenti interinali e per la prima rata delle riparazioni, cominciò ad aumentare
vertiginosamente. L’inflazione determinava, inoltre, un aggravarsi di tale situazione: la
spesa nominale, infatti, influiva maggiormente sul tasso di inflazione rispetto alle entrate
nominali, il cui valore reale era eroso dall’intervallo temporale che intercorreva tra la fase
di accertamento e di riscossione delle imposte. Lo stesso discorso può essere fatto per
altre imposte, come ad esempio quella sul reddito decisa nel 1919, che era stata rateizzata
in 47 rate annuali e il cui valore si era praticamente azzerato in seguito all’inflazione già
nel 1921. Questi processi ampliavano costantemente il disavanzo dello Stato, le cui uscite
aumentarono vertiginosamente nel terzo trimestre del 1923, quando la spesa pubblica
raddoppiò per sostenere la resistenza passiva della zona della Ruhr. Non potendo più
piazzare le proprie obbligazioni sul mercato – la credibilità in un apprezzamento del
marco dopo la svalutazione era infatti svanita fin dal 1922, determinando una fuga di
capitali – , il governo tedesco faceva acquistare i propri debiti dalla Reichsbank, il cui
direttivo era nominato dal Cancelliere e aveva quindi scarsa autonomia di manovra,
inasprendo quindi il circolo di creazione monetaria, svalutazione e inflazione.
Centro nodale per comprendere tale situazione sono certamente le riparazioni di
guerra, che certamente pesarono molto sugli eventi monetari tedeschi del biennio 19221923. Tuttavia, occorre chiarire anche che, una volta fissato l’ammontare delle
riparazioni, il mancato accordo tra i gruppi di interesse su chi dovesse farsi carico del
conseguente onere fiscale, il cui corollario era una radicale redistribuzione del reddito,
determinò, come sola via praticabile, l’aumento del circolante, la svalutazione e
l’inflazione.
In un primo periodo, comunque, l’inflazione produsse effetti positivi sull’economia
tedesca, stimolando le esportazioni e aumentando conseguentemente la produzione e
l’occupazione. L’aumento dei prezzi, fino a tutto il 1922, non destò eccessive
preoccupazioni, soprattutto perché i salari vennero indicizzati all’inflazione azzerando il
34
ritardo della crescita salariarle rispetto ai prezzi. Per rimanere al passo con questi ultimi,
ad esempio, nel febbraio del 1923 i colletti bianchi del settore carbonifero ricevevano lo
stipendio ogni dieci giorni, mentre nel settembre dello stesso anno due volte a settimana.
Con l’esplodere della crisi iperinflattiva, che aveva mandato i prezzi assolutamente fuori
controllo, le incertezze per gli operatori divennero insostenibili, finendo per deprimere gli
scambi commerciali e l’attività economica di molti settori industriali. Se è vero che alcuni
gruppi erano maggiormente avvantaggiati da questo processo – i debitori, ad esempio, o i
produttori di beni capitali – , quando il caos cominciò a danneggiare seriamente l’attività
produttiva la necessità di arrivare ad una stabilizzazione fu percepita come vitale.
Paradossalmente, i gruppi d’interessi che avevano causato l’iperinflazione
opponendosi strenuamente alle riparazioni furono gli stessi che resero possibile una
stabilizzazione, che fu ad un tempo economica e politica. Tra l’ottobre e il dicembre del
1923 si realizzò infatti quella convergenza di intenti e sforzi tra governo, Alleati e mondo
industriale tedesco, in particolar modo il settore carbonifero, che portò alle riforme
necessarie alla ripresa di un normale corso economico-politico. Al centro di questa
intricata rete di relazioni vi era l’industria pesante tedesca e in particolare i grandi
complessi siderurgici delle zone della Ruhr e della Saar, il cui carbone era necessario al
buon funzionamento della siderurgia francese, alla quale i tedeschi erano poco propensi a
mettere a disposizione le proprie risorse in termini di riparazioni di guerra. Da qui
nasceva quindi l’opposizione che i proprietari e i gestori delle imprese carbonifere
esercitarono contro l’imposizione delle riparazioni da parte degli Alleati; cresceva,
contestualmente, il peso politico di questo gruppo industriale, il cui appoggio era
ricercato indistintamente dai governi tedeschi e da quelli stranieri.
Dato che l’industria pesante aveva un accordo con la Reichsbank che le permetteva un
accesso al credito a tassi d’interesse fissi, i sussidi di cui essa godeva aumentavano al
crescere dell’inflazione. Un ulteriore aiuto economico pervenne, dopo l’invasione della
Ruhr, da nuovi finanziamenti governativi per evitare il licenziamento della manodopera
improduttiva. Nuovi elementi erano però sopraggiunti nel corso della seconda metà del
1923: l’efficacia della resistenza passiva aveva cominciato a diminuire fortemente, tanto
che le consegne di carbone erano passate dai livelli minimi del febbraio 1923, quando la
resistenza era appena iniziata, al 40% della quota fissata dalla Commissione per le
riparazioni registrato nel luglio; la confusione finanziaria conseguente all’inflazione aveva
poi fatto calare drasticamente la produzione e le vendite; infine, il 26 settembre 1923, il
nuovo governo Stresemann, succeduto al governo Cuno caduto in agosto, pose fine
all’elargizione dei sussidi per i lavoratori della Ruhr, i quali, vedendo diminuire il proprio
tenore di vita, organizzarono scioperi e disordini.
In autunno le condizioni erano quindi mature per un accordo, che fu raggiunto
direttamente tra gli industriali della Ruhr e il Micum, la Commissione inter-alleata per il
controllo delle fabbriche e delle miniere. Secondo questo accordo, il 27% del carbone
tedesco sarebbe stato consegnato alla commissione, che avrebbe anche assunto il
controllo della distribuzione. Le consegne di carbone, coke e lignite arrivarono a coprire
il 50% di quelle previste nel dicembre nel 1923 e l’80% nel febbraio del 1924. Con il
ripristino dei pagamenti delle riparazioni da parte della Germania, gli Alleati
dimostrarono per la prima volta la propria disponibilità ad accettare anche trasferimenti
parziali, nonché a rivedere l’intero programma di accordi mediante l’istituzione, il 30
novembre 1923, di due nuovi comitati incaricati di revisionare l’intero meccanismo delle
riparazioni, aprendo uno spiraglio a possibili concessioni.
35
Sulla base di queste mutate condizioni, fu possibile per il governo tedesco operare in
funzione di una stabilizzazione che, al contrario di quella tentata in agosto con
un’imposta straordinaria, poteva ottenere una credibilità sul più lungo periodo. In primo
luogo occorreva porre fine alla spirale iperinflattiva, che aveva raggiunto, come detto,
livelli assolutamente incredibili. Nel novembre del 1923 il governo fissò il tasso di
cambio a 4,2 miliardi di marchi per dollaro, emettendo una nuova valuta, il Rentenmark,
il cui valore era pari a 1.000 miliardi dei vecchi marchi.. Lo statuto della nuova
Rentenbank, ratificato il 15 ottobre, aveva stabilito che essa non avrebbe potuto
oltrepassare un credito complessivo di 2400 milioni di marchi oro, mentre alla metà di
tale cifra era stato fissato il tetto per i crediti allo Stato. La nuova regolamentazione fu
messa alla prova già nel dicembre del 1923 quando il Reich, avendo già raggiunto la
soglia di 1200 milioni di crediti dalla banca, ne chiese altri 400, vedendosi però rifiutata la
richiesta, rafforzando così la credibilità del nuovo corso tedesco.
Se questa stabilizzazione monetaria fu in qualche modo necessaria, senza una riforma
fiscale mirata a consolidare la bilancia dei pagamenti, insieme ad un piano di prestiti
internazionali, essa sarebbe stata poco credibile sul medio-lungo periodo. Il bilancio
statale venne riportato in pareggio grazie alla cancellazione dei sussidi alla Ruhr e alla
Renania, al taglio del 25% del personale pubblico e alla decurtazione del 30% dei salari
dei dipendenti rimasti in servizio. Nel gennaio del 1924, l’unione di queste riforme e la
disponibilità Alleata di andare incontro alla Germania, fecero tornare al situazione alla
normalità.
Il Piano Dawes, che rivedeva l’ammontare e le modalità di trasferimento delle
riparazione tedesche, posticipava una parte dei pagamenti, portando il servizio del debito
ad appena l’1% del Pil tedesco nel 1924-1925, ammontare che fu pagato facilmente
grazie ad una imposta di modesta entità sui trasporti. Parte integrante del piano fu la
collocazione di un prestito internazionale, negoziato tra la primavera e l’estate del 1924
ed infine emesso in ottobre, che faceva affluire in Germania un ammontare di valuta
estera pari a 800 milioni di marchi oro. Più di metà di questi capitali fu prestato dagli Stati
Uniti, il 25% furono invece capitali inglesi, mentre il resto venne ripartito tra Francia,
Belgio, Olanda, Italia, Svezia e Svizzera. Se ancora nel 1924 si nutrivano dei dubbi
sull’effettiva efficacia della stabilizzazione dell’autunno precedente, l’afflusso di capitali
esteri spazzò via ogni dubbio fornendo, sia al governo che all’economia tedesca, le
risorse necessarie a sostenere la ripresa economica e la rivalutazione del marco. Il 1
settembre 1924 il Reichsmark sostituì di nuovo il Rentenmark ad una ristabilita
convertibilità al tasso di 4,2 marchi per dollaro, mentre i tassi di interesse subirono un
calo necessario alla ripresa degli investimenti, passando all’11% nel novembre del 1924,
innescando così una catena di prestiti americani che sarebbe continuata per i successivi
quattro anni.
L’inflazione tedesca, il passaggio all’iperinflazione e la successiva stabilizzazione, non
poterono rimanere senza conseguenze su un sistema bancario che era uscito sofferente
dall’esperienza bellica e dalla successiva sconfitta. Proprio la spirale inflattiva, d’altronde,
aveva avvantaggiato enormemente gli industriali, i debitori, rispetto ai creditori, ovvero
alle banche, che ne uscirono decisamente indebolite: nel periodo compreso tra il 1913 e il
1924, le nove maggiori banche tedesche persero il 43% del capitale e il 50% delle riserve,
anche se occorre sottolineare come gran parte delle perdite si verificò tra il 1914 e il
1920. Sempre come conseguenza diretta del conflitto, le banche tedesche persero gran
parte del loro giro d’affari all’estero in corrispondenza delle confische o della vendita
delle attività. La Deutsche Bank ci offre un esempio di entrambe le situazioni: mentre,
36
infatti i suoi investimenti nei settori ferroviario e petrolifero in Siria e a Mosul andarono
del tutto perduti, essa riuscì a cedere gli interessi nelle ferrovie dell’Anatolia ad una banca
svizzera di Zurigo, la Bank fur Orientalische Eisenbahnen, e a vendere la Deutsche
Uberseeische Elektrizitats-Gesellschaft ad un consorzio bancario spagnolo nel 1920.
Durante la spirale inflattiva del 1921-1923 le banche tedesche, come tutta l’economia
del paese, furono interessate da una grande fuga di capitali: conseguentemente alla
progressiva svalutazione del marco, i depositi sull’estero degli istituti finanziari
aumentarono dal 7,3% del 1920 al 30,9% del 1923, mentre, nello stesso periodo, la
percentuale di obbligazioni del Tesoro detenute passava dal 48,3% al 2,2% sul totale delle
attività. I fondi all’estero venivano investiti soprattutto nelle controllate delle banche
tedesche, costituite in particolar modo sulla piazza di Amsterdam, che erano incaricate di
gestire le transazioni in valuta. Un’altra conseguenza dell’inflazione fu l’incremento della
tendenza alle fusioni e alle acquisizioni, che venivano organizzate soprattutto in
conseguenza della sottocapitalizzazione delle piccole banche regionali. Nel periodo 19181925, le nove grandi banche di Berlino acquisirono in tutto 279 banche, di cui 62
entrarono a far parte della Deutsche Bank e 36 della Disconto Gesellschaft, che
aumentarono la loro quota di risorse sul totale delle banche commerciali, passando dal
39% registrato prima della guerra al 70% del 1930.
Il nuovo ruolo di importatore di capitali ricoperto dalla Germania dopo la fine della
Prima guerra mondiale, ed in particolare dopo la stabilizzazione del 1924, fece mutare
anche il ruolo delle grandi banche e della piazza finanziaria di Berlino, costrette a gestire
passività sull’estero che aumentarono fino a 4,2 miliardi di dollari tra il 1924 e il 1930. Le
banche commerciali più grandi, che erano riuscite ad evitare il declino in cui era incorso,
ad esempio, Bleichroder, si trovarono in un ruolo centrale nel gestire e indirizzare i
capitali che dal 1924 affluirono nel paese. La M.M. Warburg & Co., ad esempio, riuscì a
far fruttare nel migliore dei modi i suoi contatti negli Stati Uniti, divenendo il
rappresentante europeo dell’International Acceptance Bank, occupando in tal modo una
posizione di privilegio nella negoziazione di prestiti per le istituzioni private e pubbliche
tedesche.
L’Italia
Come in altri paesi europei, la Prima guerra mondiale condusse ad un enorme
aumento del debito pubblico italiano, che finanziò circa i 2/3 delle spese belliche. Quasi
il 72% di tale debito era stato raccolto sul mercato interno – con l’emissione di cinque
prestiti nazionali tra il 1915 e il 1917 –, mentre il restante 28% era stato finanziato
attraverso il debito estero in un quadro di collaborazione interalleata, mediante il fisco e
la stampa di banconote. Durante la guerra si ebbe così un’intensificazione della
collaborazione tra la Banca d’Italia, che aumentò progressivamente il suo ruolo pubblico,
e il Tesoro. A testimonianza di questa vicinanza va citata la figura di Bonaldo Stingher,
direttore generale della Banca d’Italia che per qualche mese ricoprì, nel governo Orlando
del 1919, anche il ministero del Tesoro, lasciando solo formalmente la responsabilità di
direttore della banca centrale. Come per Francia e Inghilterra, il tasso di cambio della lira
sul dollaro era stato sostenuto per tutta la durata del conflitto dalle autorità monetarie
statunitensi. Venuto meno il loro appoggio al termine del conflitto, la lira cominciò a
svalutarsi determinando un processo inflattivo parallelo che si nutrì anche del breve
boom economico post-bellico grazie alla sospensione dei controlli e dei razionamenti,
che portarono ad esprimere tutta la domanda compressa nei quattro anni precedenti.
37
Il conflitto mondiale determinò nuovi equilibri sia all’interno del mondo bancario
italiano. Alla crescita del peso finanziario delle quattro maggiori banche del paese – la
Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano, il Banco di Roma e la Banca Italiana di
Sconto – , si accompagnò un mutamento nei rapporti tra finanza e industria, il cui esito
fu che quest’ultima si svincolò sempre di più dal settore bancario per rivolgersi allo Stato,
che non sospese mai quel ruolo attivo in economia che aveva guadagnato durante la
guerra. In alcuni casi grandi industriali tentarono direttamente l’acquisizione degli istituti
bancari. Fu questo il caso, ad esempio, dei fratelli Perrone, proprietari dell’Ansaldo e soci
di maggioranza della Banca Italiana di Sconto, che diedero avvio alla scalata alla Banca
Commerciale Italiana; oppure della Fiat che, insieme all’industriale Riccardo Gualino,
provò a prendere il controllo del Credito Italiano.
Lo sviluppo industriale italiano durante la guerra era stato strettamente legato alle
commesse statali. L’enorme crescita della domanda aggregata determinò sostanziali
mutamenti produttivi, organizzativi e finanziari che finirono con l’essere la causa di
squilibri che non tardarono a manifestarsi. Fondamentalmente mancavano progetto per
la trasformazione delle industrie belliche, cresciute enormemente in connessione alle
accresciute spese militari, in aziende capaci di affrontare la nuova situazione di mercato
che si venne a creare alla fine del conflitto. Anche per questo motivo la recessione del
periodo 1921-1923 fu, in Italia, particolarmente severa.
In più, la grande compenetrazione che si era realizzata negli anni precedenti tra
industrie e banche fece si che la crisi industriale si trasformò velocemente anche in una
crisi finanziaria. In questi primi anni post-bellici andarono, così, incontro al fallimento le
due maggiori industrie pesanti italiane, la Ansaldo e l’Ilva, che trascinarono con sé anche
due dei quattro più grandi istituti finanziari, ovvero la Banca Italiana di Sconto, come già
visto legata strettamente all’Ansaldo, che fallì nel 1922 proprio a causa delle sue
esposizioni industriali. Anche il Banco di Roma, che nel 1923 venne salvato su diretto
ordine dell’appena insediato governo Mussolini.
Le banche, e di concerto anche le aziende, furono salvate attraverso finanziamenti
pubblici e privati, con il coordinamento della Banca d’Italia, facendo in sostanza
proseguire l’interventismo statale in economia nato durante il conflitto anche in tempo di
pace. Negli anni della stretta monetaria per consentire il ritorno alla parità aurea, sempre
più le grandi banche ricorrevano allo sconto dei propri titoli presso la Banca d’Italia per
tentare di recuperare liquidità. Tra agosto e settembre del 1925, ad esempio, soltanto la
Comit scontò più di mezzo miliardo di lire presso le casse della Banca d’Italia.
Il fallimento della Sconto, la terza banca del paese, ebbe notevoli conseguenze
sull’intero sistema. In particolare venne alla luce la necessità di una più stringente
disciplina bancaria: tra il 1920 e il 1924 vennero presentati 4 proposte legge in questo
senso, prima di addivenire all’approvazione della legge bancaria del 1926. Tuttavia molti
istituti bancari non attesero l’ufficialità della legge e tentarono invece di anticiparla,
adeguandosi a quelle misure che ritenevano possibili veder approvare nel giro di pochi
anni. In primo luogo vi fu un tentativo di aumentare il capitale sociale delle banche.
Tuttavia, quest’ultimo non fu incrementato con l’inserimento di capitali freschi, bensì fu
scelta la via delle fusioni o della creazione di finanziarie costruite ad hoc, che in pratica
permettevano un aumento puramente fittizio dei capitali ed un maggior controllo degli
istituti da parte dei gruppi proprietari. Questo processo – esemplificato dalle banche
cattoliche che, una volta riunite, si specializzarono nel credito mobiliare perdendo il loro
tradizionale radicamento sul territorio – portò ad un sistema bancario da una parte
38
sempre più fragile, dall’altro sempre più dedito ad operazioni di credito industriale e
mobiliare.
Ciononostante, fino al 1925 la lira sembrava molto più stabile di altre valute europee,
come ad esempio il franco, aiutata anche dal processo di risanamento fiscale portato
avanti al primo governo Mussolini. Così, il governo tentò di approfittare di queste
favorevoli condizioni internazionali per provare a giocare un ruolo maggiore, favorendo
soprattutto un’espansione finanziaria nell’Europa centrale e nel Mediterraneo. Contro il
parere di Stringher e della Banca d’Italia, il governo e la Banca Commerciale Italiana si
avventurarono in un prestito alla Polonia, dopo che le richieste di quest’ultima erano
state rifiutate sia dagli inglesi che dagli americani, che non consideravano il nuovo paese
come un tassello fondamentale da stabilizzare nel quadro monetario europeo. Fu quindi
la Banca Commerciale Italiana che nel 1923 lanciò, con la garanzia governativa e solo sul
mercato italiano, il prestito polacco pari a 400 milioni di lire. Già dopo pochi mesi, però,
la mancata stabilizzazione della valuta polacca fece rimanere il 70% della seconda tranche
del prestito nel portafoglio della Banca Commerciale Italiana, pesando sul bilancio di
quest’ultima fino al 1931.
Proprio a partire dal 1925, la politica finanziaria italiana sembra essere sempre di più
una prerogativa politica portata avanti da Mussolini e dai suoi ministri delle finanze,
esautorando così gradualmente Stringher e la Banca d’Italia. Si intrecciano, nei due anni
successivi, le negoziazioni sulla restituzione dei debiti italiani agli Stati Uniti e alla Gran
Bretagna, il prestito della Morgan all’Italia e, infine, il percorso della lira verso il ritorno
alla convertibilità aurea alla cosiddetta «quota novanta». Nello stesso periodo, nell’aprile
del 1925, il ritorno della sterlina alla convertibilità deciso da Winston Churchill provoca
una rinnovata offensiva speculativa sulla lira.
Gli Stati Uniti dichiaravano apertamente a Stringher, nel giugno del 1925, che il
rinnovo del prestito della banca Morgan era vincolato alla disponibilità delle autorità
italiane a riaprire le trattative per trovare una soluzione al problema dei debiti inter-alleati.
La gestione della politica monetaria passa così nelle mani di Volpi, nuovo Ministro delle
finanze che aveva sostituito de’ Stefani, che riesce a far stabilizzare la lira intorno ad una
quota di 120 lire per sterlina, che rimase più o meno stabile tra l’autunno del 1925 e la
primavera del 1926. Una valuta stabile permise di condurre rapidamente in porto le
trattative con il governo statunitense e con la Morgan per il prestito che avrebbe poi
permesso la stabilizzazione della lira.
La principale caratteristica dell’accordo tra il Tesoro americano e il governo italiano
sul debito è la lunga rateizzazione dello stesso, pagabile dagli italiani in 62 anni con rate
progressive, fatte in modo che la maggior parte dell’ammontare del pagamento fosse
destinata alle ultime rate, posticipando così la restituzione delle quote più pesanti.
Contestualmente, però, il prestito lanciato da un sindacato di emissione statunitense con
a capo la Morgan, il cosiddetto prestito Kingdom of Italy, per un totale di 100 milioni di
dollari, ebbe condizioni molto più sfavorevoli per l’Italia. Il tasso applicato fu infatti del
7% con durata venticinquennale. Alla fine il governo italiano ricevette 90 milioni di
dollari, a fronte dei 94,5 emessi, pagando quindi 4,5 milioni di dollari di commissioni,
facendo del prestito italiano uno degli affari più vantaggiosi della Morgan negli anni
Venti.
Durante il primo semestre del 1926 i mercati finanziari internazionali furono
attraversati da un’importante turbolenza, che fece seguito ad eventi quali
39
l’ammutinamento della flotta inglese a Invergordon, lo sciopero generale inglese del
maggio e le inquietudini politiche e monetarie che caratterizzarono lo scenario francese
prima della stabilizzazione de facto del franco del luglio-dicembre. Dopo la visita di
Benjamin Strong – che fu in Italia a fine maggio con il chiaro intento di indurre le
autorità ad una stabilizzazione della lira conveniente alle esportazioni americane, sia di
merci che di capitali – , Mussolini annunciò, nel famoso discorso di Pesaro del 18 agosto
1926, la volontà del governo di ripristinare il ritorno all’oro della lira ad una parità di 90
lire per sterlina, che corrispondeva al valore che aveva assunto la lira nel momento in cui
Mussolini era salito al potere nell’ottobre del 1922. Se la quota 90 viene confrontata con
le 153 lire con le quali veniva scambiata la sterlina nel luglio del 1926 si nota come il
nuovo tasso di cambio deciso dal governo prevedeva una rivalutazione della valuta
italiana pari al 65%. La stabilizzazione venne raggiunta, poi, de jure, nel dicembre del
1927.
Contemporaneamente alla stabilizzazione della lira, alla risoluzione della questione dei
debiti italo-americani e al prestito italiano, si pose mano anche alla regolamentazione del
sistema creditizio con la legge bancaria, che fu approvata in realtà subito prima dell’inizio
della stabilizzazione, il 6 maggio 1926, e completata poi con la convenzione del 15
giugno. Questa legge stabilì l’unificazione degli istituti di emissione, lasciandone il
privilegio alla sola Banca d’Italia, la quale doveva anche detenere tutte le riserve
metalliche e valutarie per la copertura dei biglietti in circolazione, che doveva essere pari
al 40% del circolante, inglobando quindi anche quelle precedentemente detenute da altri
istituti di emissione, come il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia. La Banca d’Italia, che
otteneva anche forti poteri di vigilanza sul sistema bancario, recuperò l’autonomia
perduta circa le politiche monetarie italiane, ponendo così le base per la stabilizzazione
della lira degli anni successivi.
Grazie alla forza del regime dittatoriale inaugurato con le cosiddette leggi fascistissime
del biennio 1925-1926, Mussolini riuscì a far scendere prezzi e salari grazie anche alla
nuova disciplina del lavoro imposta dalla legge sindacali di Alfredo Rocco dell’aprile del
1926, imponendo una deflazione che non si tradusse in un’eccessiva disoccupazione. La
stabilizzazione monetaria, però, colpì duramente le esportazioni italiane, che si ridussero
del 5% già nel 1927, avvantaggiando la concentrazione industriale, che fu favorita dal
regime e dai finanziamenti concessi dalle grandi banche di credito ordinario, specialmente
nel settore elettrico, meccanico e chimico. Con la lira nuovamente nel novero delle
monete stabili, un flusso di capitali americani si riversò in Italia, andando a finanziare
industrie come la Fiat, la Pirelli, la Montecatini, la Edison e la Breda per una cifra
calcolata in 6259 milioni di dollari tra il 1925 e il 1927, che raggiunse i 7672 milioni nel
1929.
Il Giappone
La Prima guerra mondiale contribuì in Giappone ad incrementare uno sviluppo
industriale che aveva gettato già solide basi nel decennio precedente. Il tasso annuo di
aumento della produzione industriale fu, infatti, del 6,3% nel periodo 1905-1913,
dell’8,4% nel 1913-1920 e del 7% dal 1920 al 1929. Dopo la restaurazione del 1868 e
l’inizio dell’occidentalizzazione del paese, l’aumento del volume del commercio estero
rappresentò una grande spinta allo sviluppo nipponico, con un aumento complessivo
annuo pari al 7,2%. I prodotti esportati, però, non erano prodotti manifatturieri, bensì
beni primari come la seta e il tè. Lo sviluppo industriale fu invece promosso direttamente
dal governo, che se ne assunse la guida sostenendo direttamente le industrie, in particolar
40
modo quelle dei cantieri navali, del ferro e dell’acciaio. A fianco di queste ultime, come
già accennato, fu l’industria cotoniera che fece registrare i maggiori sviluppi. Il conflitto
accelerò fortemente questo processo, portando il Giappone ad occupare un ruolo di
primo piano nell’economia mondiale durante gli anni 1914-1918, soprattutto sfruttando
gli spazi lasciati vuoti dai paesi europei in guerra.
Il trend positivo nelle esportazioni continuò anche per tutti gli anni Venti. È stato
infatti calcolato che fra il 1913 e il 1929 le esportazioni totali aumentarono del 133%: la
seta greggia arrivò ad occupare il 37% del totale, mentre i prodotti serici e cotonieri il
28%. L’economia giapponese, quindi, dipendeva da un gruppo relativamente ristretto di
beni da esportare. Inoltre, le esportazioni prendevano la via quasi di un solo paese, gli
Stati Uniti, dai quali le industrie giapponesi dipendevano per un 43% del totale del loro
volume di esportazioni.
Come detto la guerra determinò un forte aumento delle esportazioni giapponesi, che,
superando di gran lunga le importazioni, portò il paese ad accumulare oro e valute estere.
Queste riserve accumulate vennero utilizzate per finanziare cospicue importazioni.
Parallelamente, sostenendo che lo yen fosse stato artificialmente sopravvalutato dal
periodo di guerra e prevedendone una rapida svalutazione, gli investitori cominciarono a
ritirare i proprio capitali portando ad una contrazione dei prezzi delle azioni sulla borsa di
Tokyo, visibile già dal marzo del 1920. Questo processo portò al fallimento della Masuda
Bill Broker Bank nell’aprile dello stesso anno, che provocò una generalizzata sfiducia nel
sistema bancario giapponese e una parallela corsa agli sportelli. Da aprile a luglio del
1920, 21 banche furono costrette a sospendere le proprie attività, alcune
temporaneamente mentre altre permanentemente, nonostante gli interventi della Banca
del Giappone che si lanciò in alcuni prestiti speciali per salvare le banche i cui fallimenti
avrebbero maggiormente esposto le industrie chiave del paese.
Il fallimento della Ishii Corporation, una importante azienda di legname che operava
anche sul mercato azionario e possedeva importanti quote di diversi istituti bancari, del
28 febbraio del 1922 fu un altro shock per l’economia giapponese e per il suo sistema
bancario. Il crollo della Ishii determinò, infatti, una corsa agli sportelli in alcune banche
da questa controllate, in particolar modo nel sud-ovest del paese, nella prefettura di
Kochi, e nella regione del Kansai, a Osaka, a Tokyo e nei loro dintorni. Quindici banche
furono costrette a dichiarare fallimento e, tra il dicembre del 1922 e l’aprile del 1923 la
Banca del Giappone emise prestiti speciali in favore di ulteriori venti banche.
Su un sistema economico e finanziario già scosso da questi eventi, irruppe, il 1
settembre del 1923, il grande terremoto del Kanto, che devastò Tokyo, il porto di
Yokohama e le prefetture circostanti, causando tra i 100.000 e 140.000 morti.
Il terremoto ebbe numerose conseguenze sul piano industriale e bancario. la
disintegrazione del capitale fisico degli istituti finanziari – molti di essi videro la completa
distruzione di molte delle proprie filiali e sedi amministrative – portò ad una perdita di
fiducia generale nel sistema bancario: i depositanti corsero a ritirare, dove possibile, i
propri risparmi e contestualmente ci fu un enorme ritardo, a volte una completa
sospensione, delle rate dei debiti. Il 7 settembre, il governo giapponese varò una
moratoria sui debiti, permettendo la posticipazione di un mese dei pagamenti dovuti in
settembre.
41
Le esigenze di ricostruzione, evidenti fin dai giorni immediatamente successivi al
sisma, determinarono anche un enorme aumento delle importazioni dei materiali
necessari. A questo fine, il 27 settembre la Banca del Giappone emanò l’Earthquake
Casualty Bill, un’ulteriore ordinanza speciale con la quale si faceva carico dello sconto di
carta commerciale nelle aree colpite fino a un massimo di 100 milioni di yen.
L’esposizione finanziaria e la stampa di banconote portarono all’insostenibilità della
parità aurea dello yen, che venne svalutato del 20% dando il via ad un’espansione
creditizia che culminò poi nella grave crisi finanziaria del 1927.
Tale crisi iniziò nel mezzo del processo legislativo con il quale si desiderava ordinare i
prestiti contratti con l’Earthquake Casualty Bill attraverso l’emanazione, da parte del
Tesoro, di specifiche obbligazioni che andassero a scontare quelle precedenti. Durantei l
dibattito parlamentare che ne seguì, il Ministro delle finanze Naohauru Kataoka dichiarò
che la banca Watanabe di Tokyo era fallita, rivelando informazioni fino a quel momento
segrete. Questa affermazione provocò un panico sul settore bancario, che fu investito da
una corsa agli sportelli e da una fuga di capitali in particolar modo nelle regioni delle due
grandi metropoli giapponesi Tokyo e Osaka. Anche se l’approvazione del disegno di
legge sopramenzionato, il 23 marzo 1927, contribuì a calmare le acque, nuove rivelazioni
circa le cattive condizioni finanziarie della Banca di Taiwan, che aveva strettissime
relazioni con la giapponese Suzuki & Co., fecero nuovamente cadere nel panico il sistema
finanziario.
Quest’ultimo fu aggravato dal mancato compromesso politico circa la necessità di
aumentare il tetto di circolante della Banca del Giappone, che provocò le dimissioni del
governo Wakatsuki, aumentando l’incertezza. A destabilizzare il sistema avevano
contribuito anche una serie di eventi politico-militari che si erano susseguiti nel corso
degli anni Venti, minando la fiducia degli investitori, sia giapponesi che stranieri, nella
stabilità del sistema. Si ricordano, in particolare, l’estremo ritardo con cui vennero ritirate
le truppe dal fronte siberiano, il cui rimpatrio avvenne solamente nel settembre del 1922
e che avevano contribuito ad aggravare il bilancio statale nei tre anni precedenti; la guerra
civile cinese, che ebbe un’escalation nel 1924 con schermaglie tra truppe cinesi e
giapponesi – come ad esempio l’incidente di Jinan, capitale della regione cinese dello
Shandon, del maggio del 1928 – che durarono fino a tutti gli anni Trenta, per poi finire
nella seconda guerra sino-giapponese combattuta dopo il 1937; infine,
Per tentare di uscire dalla crisi finanziaria del 1927, ed avviare contestualmente un
percorso di riavvicinamento alla parità aurea dello yen, si addivenò ad un cambio della
guida politica del paese. Il nuovo governo di Giichi Tanaka, leader dell’opposizione, si
insediò il 20 aprile del 1927, con Korekiyo Takahashi – ex banchiere, Primo ministro e
governatore della Banca del Giappone – a ricoprire il ruolo di ministro delle Finanze. Il
nuovo governo, mentre preparava una restrittiva riforma fiscale, deliberò
immediatamente una moratoria d’emergenza sui debiti di tre settimane, effettiva tra il 22
aprile e il 12 maggio 1927. In questo periodo vennero messi a punto e varati due atti
legislativi. Il primo, il Bank of Japan’s Special Bill, autorizzava la banca centrale a
scontare carta commerciale emettendo nuove banconote con la garanzia governativa fino
a un massimo di 500 milioni di yen. Il secondo invece, il Financial Relief Bill for
Taiwanese Bank, mirava a mettere in sicurezza i conti della Banca di Taiwan, con un
prestito di 200 milioni di yen. Entrambi gli atti, emanati l’8 maggio 1927, contribuirono a
riportare la calma nei mercati finanziari.
42
Nel corso della crisi era stata varata anche una nuova legislazione bancaria, che
sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio del 1928. Venivano fissati i requisiti di capitale
minimo per ricevere l’autorizzazione a svolgere attività d’intermediazione finanziaria e
contestualmente si impediva, alle banche come ai manager delle stesse, di intraprendere
attività parallele all’infuori del sistema bancario. Inoltre, veniva rafforzata la capacità di
vigilanza dell’intera struttura da parte della Banca del Giappone, incoraggiando allo stesso
tempo la fusione tra istituti al fine di stabilizzare il sistema. Se il numero di banche era già
calato durante gli anni Venti, questo si ridusse in maniera ancora più vistosa dopo il 1927
dimezzandosi addirittura rispetto a quello del 1901.
La perdita di risorse durò per tutta la decade post-bellica, vedendo un’inversione della
tendenza che aveva visto invece prosperare l’economia giapponese durante il conflitto. Il
deficit nella bilancia dei pagamenti si aggravò costantemente: si calcola che, tra la fine del
1920 e la fine del 1928, le riserve in valuta estera diminuirono di quasi il 50%, passando
da 2.179 a 1.199 milioni di yen. Le autorità giapponesi vedevano nel ripristino della parità
aurea dello yen un elemento essenziale per giungere ad una rinnovata stabilità del sistema,
ripristinando i flussi del commercio internazionale. Un nuovo governo guidato da Osachi
Hamaguchi, entrato in carica nel luglio 1929, tagliò le spese pubbliche nei bilanci del
1929 e del 1930, riuscendo a ripristinare la parità dello yen all’oro nel gennaio del 1930.
La convertibilità fu però ristabilita nel momento peggiore, quando la crisi economica
cominciava a propagarsi dagli Stati Uniti in Europa e da qui nel resto del mondo. Il
Giappone cominciò immediatamente a perdere cospicue quantità di oro in seguito al
ritiro dei capitali dall’economia nipponica. Quando, poi, la Gran Bretagna decise di
svalutare la sterlina, nel settembre del 1931, anche il Giappone dovette fare lo stesso per
non aggravare ulteriormente la sua posizione sul mercato internazionale, facendo cadere
lo yen molto al di sotto della valuta inglese.
3. La crisi del 1929 e la Grande Depressione (1928-1932)
Nelle serie storiche delle maggiori economie del Novecento, il periodo 1929-32 si
distingue per gli aumenti della disoccupazione, la riduzione del reddito, la contrazione
del commercio internazionale, con variazioni vicine al 25 per cento dei valori pregressi.
Questa depressione, la maggiore del Novecento, è associata nella memoria collettiva
alla crisi finanziaria del 1929.
Il crollo degli indici di borsa a Wall Street, sebbene riferibile più propriamente al
momento finale di una bolla speculativa che alle condizioni della produzione, è divenuto,
nella memoria storica, il nome con il quale si indica il periodo di depressione economica
in quanto era in grado di indicare l’accentuata vulnerabilità che il sistema produttivo ha
avuto verso la mobilità nel mercato dei capitali e la contrazione dei consumi, condizioni
verificatesi in modo congiunto a partire dal 1929.
Nel corso degli anni Venti le economie occidentali conobbero una radicale
trasformazione nei comportamenti di consumo delle famiglie. Questa condizione ebbe
una ripercussione sull’insieme del sistema economico, rendendolo più sensibile alle
variazioni dei prezzi nominali dei beni di consumo. Ne seguì una vulnerabilità dell’intero
sistema: l’attività produttiva, distribuita nel medio periodo, divenne più sensibile alle
scelte compiute dai consumatori nel breve periodo.
43
La letteratura argomenta come errata l’associazione tra crisi finanziaria e depressione
dell’economia reale, poiché la depressione precede nel tempo l’evento del crollo dei
valori finanziari registrato a New York e risulta maggiormente fondata sugli squilibri nel
mercato delle materie prime, dei prodotti agricoli e nelle scelte di politica commerciale,
più che nelle scelte di politica finanziaria.
Sebbene l’esistenza di questi due diversi eventi sia inconfutabile, occorre guardarsi da
due letture del processo storico entrambe fallaci: se da una parte risulta, infatti,
impossibile porre in termini di necessaria causalità la crisi finanziaria con la grande
depressione; dall’altra, però, è necessario riconoscere l’incidenza che la crisi finanziaria
ebbe sulla Grande Depressione degli anni Trenta.
Infatti, in seguito alle crisi dei sistemi finanziari nazionali del periodo 1929-1931,
aumentò la percezione della vulnerabilità dei principi stessi con cui governare il sistema
economico, in particolar modo riguardo le scelte normative nei due campi della politica
monetaria e del mercato dei capitali. La raggiunta consapevolezza di questa vulnerabilità
nelle due sfere appena menzionate portò, negli anni successivi alla crisi finanziaria, ad un
radicale riordino del sistema economica internazionale nel suo insieme, ispirato a un’idea
di tutela dei rapporti tra disponibilità di capitali e attività produttiva al fine di evitare crisi
della bilancia dei pagamenti e fuga dei capitali. Ne seguì la scelta di vincolare la
disponibilità del risparmio all’attività produttiva e, nello specifico, di impedire la libera
circolazione dei capitali, impedendo contestualmente commistioni tra l’offerta di credito
e l’attività produttiva. Gli anni Trenta vennero così ad essere caratterizzati dal vincolo alla
mobilità dei capitali e dalla separazione tra banca e industria.
Si ritiene opportuno, quindi, considerare le crisi del 1929-1931 su entrambi i piani,
ovvero come esiti di bolle speculative dei mercati azionari e valutari americani ed europei;
e come momento fondante del processo di ridefinizione delle regole del mercato dei
capitali, del bene e del lavoro, che continuò per tutti gli anni Trenta, estendendosi in
parte fino a costituire uno dei fattori della riorganizzazione del modello del sistema
finanziario del secondo dopo-guerra, da conflittuale a egemone.
L’analisi delle crisi del 1929 e del 1931 come bolle speculative si fonda
sull’osservazione empirica, da una parte, della variazione dei prezzi delle azioni quotate a
Wall Street nel periodo 1921-29, e dall’altra sull’impatto che il rischio di cambio ha avuto
in termini patrimoniali in seguito alle modalità con cui era regolato il sistema dei
pagamenti internazionali. La svalutazione della sterlina del 1931 impose, infatti,
attraverso il vincolo del gold exchange standard, una svalutazione della corona austriaca
causando, in conseguenza, un danno patrimoniale ai detentori di quella valuta,
trascinando nel fallimento la Credit-Ansalt e, di conseguenza, molte altre banche
europee.
Riguardo la crisi finanziaria americana del 1929, la maggiore evidenza del processo
speculativo su Wall Street è ricavabile dal confronto tra i prezzi delle azioni nel periodo
tra il 1921 e il 1929. Confrontando il rapporto del dividendo pagato dalle società con il
prezzo delle azioni relative, si osserva come questo sia diminuito dal 6,5% del 1921 al
3,5% nel 1929. La bolla dei prezzi si arrestò il 28 ottobre 1929: l’indice crollò da 298 a
260, il giorno scese ancora fino a 230. La contrazione rispetto alla fine del mese
precedente fu del 40%. Il massimo e il minimo del percorso speculativo registrato
dall’indice dei prezzi di Standard & Poor è espresso nei valori dell’indice di 347 del
settembre 1929 sceso a 47 nel giugno 1932.
44
Alla fine degli anni Venti, tra il 1928 e il 1929, il mercato finanziario statunitense
registrò altri due importanti processi di cambiamento nel mercato dei capitali: l’aumento
del tasso di sconto dei titoli scambiati a pronti contro termine e la conseguente attrazione
di un flusso speculativo di capitali. Osservando la serie storica dei prestiti contro termine
della borsa di Wall Street, è evidente come i tassi passano da un ordine di grandezza del
5-6% nella seconda metà degli anni Venti, ad un valore del 12% nel 1928 e del 20% nel
1929. Questa variazione così alta dei premi comportò una straordinaria attrazione di
capitali verso attività borsistiche con finalità speculative.
Alla base del processo vi fu un’espansione del mercato delle obbligazioni di società di
public utilities, come ad esempio quelle della General Electric, che venivano vendute ai
risparmiatori dell’ovest degli Stati Uniti, i quali le accettavano basandosi sull’idea,
largamente condivisa dalla cultura dell’epoca, di una rapida e ineluttabile
modernizzazione del paese, che avrebbe quindi permesso, nel giro di un breve lasso di
tempo, di ricavare utili dagli investimenti fatti.
La conseguente estensione del mercato azionario rese evidente la possibilità di
svolgere attività speculative, portate avanti da diversi soggetti finanziari grazie alla pratica
di vendita di titoli pronti contro termine, legalmente possibile nella borsa di Wall Street
durante tutti gli anni Venti. Grazie a questa tecnica, nota come margin buiyng, gli
investitori potevano acquistare titoli a credito indebitandosi per una parte del loro valore
con un broker o una banca. In tal modo si acquisivano grandi quantità di azioni,
stimolando trend rialzisti del valore nominale dei titoli e ricavando, così, grandi profitti.
Il contratto di margin buying aveva due condizioni: la richiesta del saldo dell’intero
debito, raramente utilizzata, oppure, più frequente in funzione degli andamenti del
mercato, dell’aumento delle garanzie sul debito stesso. All’inizio dell’ottobre del 1929,
quando gli investitori cominciarono a percepire la fragilità dell’intero sistema, le vendite
aumentarono e i prezzi delle obbligazioni cominciarono a crollare. A questo punto i
broker vennero sommersi da richieste di aumento dei depositi di garanzia da parte delle
banche: per far fronte a queste richieste essi si riversarono sul mercato secondario
tentando di ottenere pronti contro termine presso altre banche. Su questa situazione si
inserì la politica monetaria della Fed che, al fine di ridurre il volume del mercato dei titoli
pubblici per sostenerne prezzi e al fine di non alimentare la speculazione, ridusse le quote
settimanali assegnate al risconto dei titoli, inducendo una catena di fallimenti delle piccole
banche, che si vedevano private di una risorsa di liquidità.
L’esito congiunto di questi ultimi due processi portò tra il 1929 e il 1933 al fallimento
di circa quattromila delle ventimila banche operanti nel paese. In moltissimi casi si trattò
di banche a sportello singolo: la crisi comportò, così, in modo indiretto, una
riorganizzazione strutturale del mercato dei capitali degli Stati Uniti, che si manifestò nel
breve e medio periodo come una contrazione dell’offerta di moneta, mentre nel lungo
periodo come aumento dimensionale delle società bancarie.
La Fed non giudicava in modo negativo questa situazione in quanto permetteva un
processo di aggregazione e di crescita di dimensione degli intermediari bancari
statunitensi. Tale crescita degli intermediari commerciali alleggeriva le autorità monetarie
dalla necessità di operare direttamente sul mercato secondario e, di riflesso, le consentiva
di utilizzare le proprie riserve a sostegno del valore internazionale del dollaro,
45
coerentemente con un progetto strategico che puntava a fare del dollaro la moneta di
riferimento del sistema finanziario internazionale.
Questa catena di eventi generò, dunque, la consapevolezza del consumarsi di una
profonda variazione nel mercato finanziario. Gli agenti economici modificarono la loro
idea di tutela da un concetto di stabilità dei prezzi ad un’idea di credibilità della moneta in
cui quei prezzi erano espressi. Questa condizione è indicata dalla scelta dei privati di
ritirare i depositi presso le banche e dalla contemporanea scelta della Fed di non
aumentare in modo espansivo la quantità di moneta in circolazione. L’esito fu il ridursi
del rapporto depositi-circolante e più generalmente del livello della base monetaria, cioè
dell’indicatore composto dalla somma tra circolante e riserve bancarie, che passò dal
1929 al 1933 da 3,7 a 2,4.
Sostenute dalla Fed di New York, le grandi banche newyorkesi aumentarono la
propria concessione creditizia evitando il fallimento di molti istituti. Wall Street recuperò
già nei primi mesi del 1930, stabilizzando la produzione industriale e il tasso di
occupazione. Nell’estate del 1932 fu nominata una commissione d’inchiesta sul
funzionamento del mercato dei titoli, per ordine del presidente Hoover, che fece
maturare un clima di riforme radicali del mercato finanziario statunitense. La modifica
della normativa venne approvata nel 1933, intervenendo, con il Securities Act, sul
mercato dei capitali, e con lo Glass-Steagall Act, sugli istituti di credito. La prima legge
aveva l’obiettivo di migliorare la qualità e la circolazione delle informazioni sui titoli
quotati, mentre la seconda separava completamente le attività di banca commerciale, che
si doveva limitare alla raccolta dei depositi e alla concessione dei prestiti, e di banca di
investimento, attive sul settore dell’emissione, collocamento e compravendita dei titoli.
La crisi finanziaria arrivò in Europa sotto forma di un ritiro dei depositi esteri dalle
banche di Gran Bretagna, Germania, Austria e Ungheria. Questi depositi erano
eccezionalmente liquidi e reattivi alle variazioni della fiducia. I risparmiatori che
percepivano una non adeguata liquidità dei titoli li abbandonavano, spostandosi su altri
titoli. Conseguentemente, le banche si trovavano ad essere in una condizione di mancata
raccolta di risparmio e il loro attivo, già critico, continuava a peggiore. Queste condizioni
potevano essere sanate solamente da interventi della banca centrale, che avrebbe dovuto i
titoli immobilizzati in cambio di valuta nazionale. Quindi, il ritiro dei depositi a fronte
della paura della svalutazione finiva per alimentare un circuito finanziario che aumentava
le probabilità che la stessa svalutazione divenisse realtà, in ragione del fatto che le riserve
internazionali su cui la banca centrale poteva fare affidamento erano quelle che essa
poteva raccogliere sui mercati esteri.
Siccome i flussi di capitali internazionali si muovono in conseguenza dei tassi
d’interesse, la concatenazione dei valori del tasso di sconto delle banche centrali aveva la
sua origine dalla banca che possedeva la maggior parte di oro disponibile, ovvero la Fed.
Fintanto che quest’ultima avesse tenuto alto il suo tasso di sconto, gli altri erano
impossibilitati a fare diversamente, determinando una rigidità generale del sistema.
Finché i sistemi nazionali avessero accettato di rimanere nel sistema del gold standard, ogni
variazione del rapporto tra valute nazionali e oro poteva essere contrattata solo
internazionalmente.
46
-
Fuga di capitali, offerta di moneta e tassi di interesse, (fonte: Krugman, Economia
internazionale 2, 270)
I punti 1 e 1’ della figura mostrano rispettivamente l’equilibrio sul mercato monetario
e sul mercato dei cambi, in un contesto di cambi fissi, in cui il livello E 0 indica la
condizione di stabilità del cambio e M1 il livello di offerta di moneta compatibile.
E’ inteso che la stabilità venga meno solo in seguito a cambiamenti significativi nella
bilancia dei pagamenti, cioè dopo variazioni nel volume o nel valore del saldo tra
importazioni ed esportazioni, del flusso di capitali e delle riserve. Immaginando che una
di questa condizioni si verifichi, il sistema sarà interessato da una alta mobilità dei
capitali. Gli agenti, stimando una caduta del cambio, calcolano il possibile danno
patrimoniale e se ne tutelano cambiando i propri capitali in valute più stabili. Il processo
però, essendo attuato ad un livello di cambio nominale non ancora modificato, finisce
per anticipare il succedersi dell’evento di svalutazione che si teme accada.
La parte superiore della figura illustra questo cambiamento. La previsione di un
peggioramento sposta verso destra la curva che indica il rendimento atteso in valuta
nazionale. Poiché il tasso di cambio corrente è ancora E0, l’equilibrio sul mercato dei
cambi (punto 2’) richiede una crescita fino a R* +(E1- E0) E0 del tasso di interesse
interno, che eguaglia il tasso di interesse atteso, misurato in valuta nazionale, sulle attività
denominate in valuta estera.
Questo processo è quanto fu evitato nel caso delle aspettative di svalutazione della
sterlina nel 1927 e del dollaro nel 1929, aumentando le riserve in valuta nazionale per
mezzo di prestiti internazionali. La svalutazione fu però impossibile da evitare, come
vedremo a breve, nel 1931 nel caso della valuta austriaca e, in seguito, di quella inglese,
proprio a causa della mancata collaborazione tra le banche centrali e in specie per via
dell’indisponibilità della Fed e della Banca di Francia, determinando forti mobilità,
ovvero fughe, di capitali tra i diversi mercati. Il rapido ripetersi di condizioni simili
convinse, inoltre, gli operatori privati e i governi che la organizzazione del sistema
finanziario internazionale nella forma del gold-exchange standard, definito nella conferenza
47
di Genova nel 1922, non fosse più credibile. La Conferenza di Londra tenuta a un
decennio dalla precedente ne decretò così, come si vedrà, formalmente la fine.
La crisi europea scoppiò appunto in Austria, dove le connessioni tra banca e industria,
storicamente forti, erano aumentate esponenzialmente durante la Prima guerra mondiale.
Nel maggio del 1931 la maggiore banca austriaca, la Credit-Anstalt, che aveva un
bilancio, nel 1930, pari all’intera spesa del governo centrale e che era stata malamente
gestita per tutti gli anni Venti. Alla pubblicizzazione, l’11 maggio 1931, delle difficoltà
finanziarie del colosso bancario austriaco seguì un rapido ritiro dei depositi bancari e un
immediato intervento del governo che, d’accordo con la banca centrale, tentò di andare
in soccorso della banca in difficoltà, Le ripercussioni si estesero, quindi, alla valuta
nazionale, provocando un aumento del 25% del circolante nel solo mese di maggio, che
si tradusse in un conseguente e massiccio ritiro dei depositanti austriaci ma soprattutto
francesi, che avevano perso fiducia nel sistema industriale e finanziario austriaco. In una
classica situazione di collaborazione bancaria internazionale, l’Austria avrebbe potuto
ottenere i prestiti di cui necessitava per ripristinare la fiducia. La scarsa convinzione
americana e l’opposizione del governo nazionalista francese di Pierre Laval, che non
vedeva di buon occhio la possibile unione doganale tra Germania e Austria, fecero però
naufragare questa possibilità, portando all’introduzione di una moratoria sul ritiro dei
depositi esteri e del controllo sui cambi e quindi alla sospensione de facto del gold standard
in Austria.
Gli investitori inglesi e francesi che si erano visti congelare i depositi austriaci vennero
indotti ad ottenere liquidità dai depositi in Germania. Soprattutto, il caso austriaco aveva
messo i risparmiatori in allarme in quanto aveva determinato un preoccupante
precedente. Inoltre, gli eventi politici tedeschi del 1931, con la caduta del governo Müller
in marzo, lo scioglimento del Reichstag e l’avanzata dei nazisti alle elezioni di settembre,
contribuirono ad accelerare il processo di deflusso di denaro dalla Germania. Si calcola
che la Reichsbank perse, nelle sole prime due settimane di giugno del 1931, 630 milioni di
oro, più del 25% del totale di inizio mese. Il processo di fuga di capitali aumentò
nuovamente in luglio, con il fallimento dell’industria tessile Nordwolle che produsse una
corsa agli sportelli della Danat Bank, la sua principale banca creditrice. Nuovamente,
motivazioni politiche furono alla base della mancata cooperazione internazionale nella
messa a punto di un prestito tedesco: in particolar modo la Francia, che vedeva nelle
difficoltà tedesche solo un pretesto per ottenere una moratoria sulle riparazioni di guerra,
fu inamovibile.
In conseguenza dei ritiri esteri dei depositi, la Germania impose delle restrizioni sulla
circolazione del marco, aumentando le pressioni sulla sterlina: non a caso il ritiro di oro
dalla Banca d’Inghilterra iniziò il 13 luglio, giorno in cui la Danat Bank tedesca venne
dichiarata fallita. Al 18 luglio, le riserve perdute dalla Banca d’Inghilterra ammontavano
già a 10 milioni di sterline, destinati a diventare 56 milioni alla fine del mese, nonostante
il 22 luglio le autorità aumentarono il tasso di sconto.
Il funzionamento del gold standard internazionale si fondava sulla cooperazione tra
banche centrali nei momenti di difficoltà, pratica che venne lentamente a consumarsi.
Tuttavia, il progetto di rendere il dollaro la moneta egemone per gli scambi internazionali
era antitetico al mantenimento della regola della cooperazione inter-bancaria. Nel luglio
del 1931, quando la Fed partecipò al prestito alla Banca d’Inghilterra insieme alla Banca
di Francia per un totale di 25 milioni di sterline, il governatore Harrison precisò in una
letterache quella sarebbe stata l’ultima volta in cui gli Stati Uniti sarebbero intervenuti in
48
soccorso della sterlina e che le richieste di liquidità inglesi avrebbero dovuto essere
soddisfatte mediante il ricorso ad altre istituzioni.
Nonostante questa straordinaria iniezione di liquidità, la sterlina non riusciva a
rimanere in parità di cambio col dollaro. Sarebbe stata necessaria un’ulteriore riduzione
della spesa pubblica o un aumento delle imposte: tuttavia, l’esecutivo laburista, in carica
dal giugno del 1929, guidava un governo di minoranza, che aveva bisogno dell’essenziale
aiuto dei liberali per mantenere la maggioranza nella Camera dei Comuni. Se, quindi, da
una parte i laburisti si opponevano al progetto di ridurre la spesa pubblica, i liberali si
rifiutavano di votare nuove tasse, portando alla caduta del governo il 23 agosto 1931.
Il governo di unità nazionale – formato da quattro ministri laburisti, quattro
conservatori e due liberali – tagliò la spesa pubblica di 70 milioni di sterline, aumentò le
tasse per 75 milioni, colpendo sia i redditi che le imposte indirette – e tagliò del 10% i
sussidi di disoccupazione. Questo permise di ottenere un prestito dalla J.P. Morgan per
un totale di 200 milioni di dollari con il fine di sostenere il valore della sterlina, a cui si
affiancò un altro prestito del medesimo importo da parte della Banca di Francia.
La fiducia nella cooperazione internazionale, e quindi nelle manovre necessarie a
sostenere la valuta inglese, era ormai scossa e i capitali continuarono ad abbandonare il
paese, minacciando ulteriormente le riserve della Banca. Dato che ulteriori tagli alla spesa
pubblica non erano praticabili, grazie anche ai segnali di scontento che giungevano, ad
esempio, dalla rivolta dei marinai della flotta inglese a Invergordon, il 19 settembre la
Gran Bretagna sospese la convertibilità della sterlina. Dopo le elezioni dell’ottobre del
1931, che videro trionfare il Partito conservatore, vi furono ulteriori tagli alla spesa
pubblica, nonché l’adozione di un dazio doganale, che era stato uno dei punti del
programma economico dei conservatori sin da prima del 1914, rendendo necessaria
un’altra grande riorganizzazione dei trattati commerciali vigenti nel sistema economico
internazionale.
Molti paesi seguirono, con tempi diversi, l’esempio inglese, per motivi essenzialmente
legati alla bilancia dei pagamenti e ai rapporti commerciali. A fine settembre erano già
nove i paesi che avevano sospeso la convertibilità aurea, tra cui Svezia, Danimarca e
Norvegia, a cui si aggiunsero, in ottobre, Portogallo, Finlandia, Bolivia e Salvador, il
Giappone in Dicembre, e altri otto paesi nel corso del 1932. Se nel 1931 i paesi legati
all’oro erano 47, alla fine del 1932 solamente poche nazioni importanti, come gli Stati
Uniti, la Francia, l’Italia e l’Olanda, continuavano a mantenere la convertibilità aurea.
Molti paesi – tra cui il Portogallo, l’Egitto, l’India, l’Australia, i paesi scandinavi e il
Giappone – agganciarono, tra il 1931 e il 1933, la propria valuta alla sterlina inglese per
non sperimentare un calo della competitività e un ulteriore rallentamento della
produzione nazionale.
L’utilizzo sempre più frequente di dazi doganali, quote e controllo dei cambi
portarono ad una situazione che si presentava, all’inizio del 1933, caratterizzata da grande
incertezza. Le grandi potenze, quindi, organizzarono un’ulteriore conferenza economica
mondiale, prevista a Londra per l’estate del 1933, per tentare di trovare qualche rimedio
alla confusione economica e finanziaria internazionale. L’anno precedente, alla
conferenza di Losanna, tenutasi da giugno a luglio del 1932, furono mossi i primi passi
nella direzione di una distensione delle relazioni internazionali, sancendo, in particolar
modo, l’abolizione delle riparazioni tedesche nella speranza di liberalizzare il commercio
estero della Germania. A questa iniziativa, però, non seguì, come sperato da inglesi e
49
francesi, un annullamento dei debiti contratti nei confronti degli Stati Uniti, trascinando
un elemento che, ancora alla fine del 1932, generava forti tensioni tra i paesi europei
debitori e i creditori statunitensi. Nel periodo tra l’elezione e l’entrata in carica di
Roosvelt, alcuni paesi europei, tra cui la Francia e il Belgio, forti dell’impossibilità
d’azione dell’uscente amministrazione Hoover, non pagarono la rata del debito di
quell’anno, mentre la Gran Bretagna la pagò depositandola in oro nelle casse della Banca
d’Inghilterra.
Anche sul fronte degli accordi commerciali le condizioni non erano le più favorevoli
possibili. Barriere doganali si diffusero un po’ dovunque in seguito all’aggravarsi della
depressione economica. L’esempio più significativo di questo processo, oltre alle rigide
politiche tariffarie francesi, fu la conferenza economica dell’Impero Britannico, tenutasi a
Ottawa tra il luglio e l’agosto del 1932, dove furono stipulati accordi tra i paesi membri
del Commonwealth che crearono sostanzialmente un blocco doganale imperiale
britannico.
La conferenza di Londra si aprì quindi in un clima decisamente conflittuale sulle
tematiche dei debiti tra Stati, delle relazioni commerciali e dei tassi di cambio. Inoltre,
anche se in via teorica un accordo con concessioni reciproche sarebbe potuto essere
raggiunto in particolare tra i tre paesi più importanti, la Francia, la Gran Bretagna e gli
Stati Uniti, i gruppi di interessi su cui si poggiavano le basi politiche dei rispettivi governi
avrebbero impedito le necessarie, rispettive, concessioni, portando di fatto allo stallo che
si realizzò nell’estate del 1933 alla conferenza economica mondiale di Londra.
A rendere ancora più complessa la situazione contribuì la svalutazione del dollaro, che
fu decisa il 19 aprile del 1933, comunicata ai governi degli altri paesi proprio quando,
dopo i primi incontri preliminari, stavano iniziando le consultazioni tra ministri per la
conferenza mondiale di Londra. La situazione bancaria statunitense aveva cominciato a
deteriorarsi già nel febbraio del 1932, quando si verificarono una serie di fallimenti
bancari e di corse agli sportelli nelle banche del Michigan del febbraio del 1932, che
portarono alla chiusura eccezionale delle banche in altri undici Stati. La Fed intervenne
con continue iniezioni di liquidità che cominciarono a consumare le proprie riserve auree:
la Fed di New York, ad esempio, raggiunse nel marzo il 40% di riserve in rapporto al
circolante, il minimo consentito dalla legge, e quindi non fu più in grado di sostenere le
banche newyorchesi.
L’attesa della svalutazione da parte dei depositanti contribuì in maniera decisiva ad
aggravare le pressioni sul dollaro: le posizioni nel Congresso a favore della svalutazione
crescevano anch’esse, soprattutto da parte dei senatori degli Stati a maggioranza rurale,
che vedevano peggiorare le condizioni degli agricoltori. Dopo un breve interludio di
recuperata stabilità, le tensioni sul dollaro ripresero quando, in aprile, le intenzioni di
Roosvelt di applicare una politica di svalutazione valutaria divennero più evidenti.
Quando il deflusso di riserve auree fu insostenibile, il dollaro venne separato dall’oro, il
19 aprile 1933.
La conferenza economica mondiale di Londra, tenutasi in un clima di sfiducia
reciproca e di interessi divergenti, non raggiunse nessun risultato degno di nota. Semmai,
essa è importante proprio perché rivelatrice dei diversi interessi dei gruppi sociali che
sostenevano i governi di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Il governo inglese
pretendeva, come contropartita al suo rientro in sistema di parità aurea, che la Banca di
Francia modificasse i proprio regolamenti interni per permettere una distribuzione
50
internazionale dell’oro più equa; gli americani, inoltre, richiedevano la liberalizzazione del
mercato francese e l’abolizione delle barriere doganali. Il governo francese di Daladier, da
parte sua, dipendendo in particolar modo dal sostegno dei deputati dei dipartimenti
rurali, non poteva non agire per sostenere, attraverso dazi alle importazioni, un prezzo
minimo del grano all’interno. Qualsiasi accordo era, quindi, ancora politicamente
impraticabile.
4. Uscire dalla crisi (1933-1939)
I provvedimenti monetari ed economici presi dall’amministrazione Roosvelt nella
prima metà del 1933 per porre rimedio alla crisi economica – la sospensione della
convertibilità del dollaro in aprile e il National Industrial Recovery Act in giugno –
ebbero, a ben vedere, conseguenze modeste sugli investimenti, sulla produzione e
sull’occupazione. Se da una parte vi era stata una depressione sul fronte dell’offerta con
la svalutazione del dollaro, gli effetti positivi di quest’ultima venivano depotenziati dagli
aumenti salariali conseguenti all’estensione all’intera struttura industriali dei codici di
concorrenza equa del Nira. Se, infatti, i beni d’investimento aumentarono del 58% nei
primi due semestri del 1933, riflettendo in qualche modo la fiducia che gli investitori
avevano nella politica monetaria di Roosvelt, essi diminuirono nel periodo successivo,
quando divenne evidente l’assenza di una coerente e funzionale manovra espansiva di
lungo periodo.
A gennaio del 1934, venne fissata una nuova parità aurea pari a 35 dollari l’oncia. La
stabilizzazione ebbe immediati effetti sulle esportazioni, che decollarono, facendo affluire
oro e capitali verso gli Stati Uniti per tutto il biennio 1934-1935. Tuttavia, la Fed
continuò a perseguire una politica monetaria di sterilizzazione dell’oro in entrata,
caratterizzata quindi da uno scarso sostegno al credito e all’economia. Il timore
dell’inflazione, infatti, fece si che, ad un aumento delle riserve auree statunitensi calcolata
in 1409 milioni di dollari tra gennaio e dicembre 1934, l’aumento del circolante fu pari
solamente a 247 milioni. Un andamento simile si registra anche per il 1935, durante il
quale la circolazione monetaria aumentò di 502 milioni dollari a fronte di un aumento
delle riserve auree pari a 1734 milioni.
La capacità produttiva industriale americana fu caratterizzata, quindi, da un
andamento altalenante, conseguenza diretta di una timida azione di stimolo all’economia
perseguita dalle autorità monetarie. Contestualmente, senza dare il via ad una ripresa
economica statunitense, il deflusso di capitali e oro dall’Europa aumentava le pressioni
sul blocco aureo, ed in particolar modo sulla Francia, che subì le conseguenze peggiori.
In generale il periodo 1934-1939 fu caratterizzato dalla tendenza ad un flusso di capitali a
breve termine che si muovevano dalle nazioni meno sviluppati, con deficit nella bilancia
dei pagamenti, verso i paesi tradizionalmente creditori, come gli Stati Uniti e la Gran
Bretagna, caratterizzati da un surplus commerciale strutturale. Tra il 1934 e il 1937, si
calcola che 5,5 miliardi di dollari arrivarono negli Stati Uniti, mentre in Gran Bretagna –
dove l’afflusso di capitali iniziò già nel 1931, favorito anche da una parallela svalutazione
della sterlina rispetto al dollaro – confluirono, fino al 1937, 4 miliardi di dollari. La
maggior parte di questi capitali, tra i 6 e i 7 miliardi di dollari, arrivarono dall’Europa
continentale, in particolar modo dalla Francia, dalla Germania e dal Belgio.
Nei paesi ancora legati all’oro – Francia, Belgio, Olanda, Svizzera, Polonia e
Cecoslovacchia – , le cui valute si erano apprezzate sulla sterlina e sul dollaro addirittura
51
del 67%, le condizioni economiche peggiorarono: con una produzione industriale ancora
del 22% al di sotto dei livelli precedenti al 1929 e una bilancia dei pagamenti
costantemente in disavanzo a causa della crescente competitività delle esportazioni
americane, questi paesi subirono un costante deflusso di riserve auree. Formatosi
all’indomani della decisione di Roosvelt di svalutare il dollaro, il blocco dell’oro cominciò
a sfaldarsi già sei mesi dopo. Ogni svalutazione aggravava la crisi degli altri paesi: l’Italia
introdusse un rigido controllo dei cambi che fece divenire puramente formale la sua
adesione al gold standard, mentre la Cecoslovacchia abbandonò il regime aureo già nel
febbraio del 1934, seguita nel 1935 dal Belgio.
La situazione francese era particolarmente preoccupante. Nel periodo 1929-1934,
corretta per la variazione del cambio, il prezzo all’ingrosso delle merci francesi era
aumentato del 14% rispetto agli Stati Uniti, del 18% rispetto alla Svezia e alla Gran
Bretagna e addirittura del 93% rispetto al Giappone. La competitività estera
dell’economia francese era quindi in seria difficoltà, portando ad un calo delle
esportazioni e ad un aumento delle importazioni, che fu del 19% – il maggiore mai
sperimentato dalle economia occidentali – nel biennio 1933-1934. Come negli anni Venti,
inoltre, la Francia era nuovamente vittima di uno stallo politico sulla questione fiscale, la
leva che più direttamente poteva essere usata dal governo per finanziare una bilancia
commerciale in disavanzo. Tra il 1932 e il 1934 si succedettero sei governi di minoranza
guidati dai radicali, nessuno dei quali riuscì però ad avere una maggioranza sufficiente per
apportare le modifiche necessarie. Nel febbraio del 1934 venne formato un gabinetto
d’unità nazionale guidato dall’ex presidente della Repubblica Gaston Doumergue, il
quale, dopo aver ottenuto pieni poteri dal Parlamento, aumentò le tasse, ridusse la spesa
pubblica e tagliò i salari degli impiegati pubblici e le pensioni degli ex combattenti.
Dopo la svalutazione del franco belga del marzo del 1935, il deflusso di riserve auree
della Francia e dei paesi ancora rimasti nel blocco aurea peggiorò. Nel 1935, la quantità
d’oro persa dalla Francia fu pari al 20% del totale delle riserve, quella dell’Olanda il 25%,
mentre quella della Svizzera del 40%. La spirale deflattiva si aggravava sempre di più,
cominciando a scatenare moti di protesta contro i tagli alle pensioni e ai salari. In Francia,
nel novembre del 1934 venne formato un nuovo governo guidato dal liberale PierreEtienne Flandin, il quale tentò di applicare politiche anti-deflazioniste, concretizzate in
una più aperta politica di credito da parte della Banca di Francia e emissioni di titoli di
Stato, rifiutando allo stesso tempo qualsiasi ipotesi di svalutazione valutaria. Per far
questo, Flandin sostituì il governatore della banca centrale Clément Moret, che aveva
riconosciuto l’impossibilità di conciliare politiche monetarie espansive con la
convertibilità aurea, con Jean Tannery, più incline ad andare incontro alle direttive
governative. La Banca di Francia cominciò così a concedere anticipazioni a trenta giorni
ai privati che ponevano come garanzia i nuovi buoni del Tesoro, il cui tetto alle emissioni
fu incrementato del 50%.
Nel primo trimestre del 1935, però, i limiti strutturali di queste misure divennero
evidenti. Il volume delle importazioni aumentò del 12% tra gennaio e marzo, il doppio di
quello delle esportazioni. La svalutazione del Belgio non fece altro che aumentare le
pressioni sulla Francia, che vide diminuire le proprie riserve auree del 2% nel maggio del
1935 e addirittura dell’11% nel solo giugno dello stesso anno. Per difendere il suo oro, la
banca centrale francese aumentò il tasso di sconto, dal 2,5% al 6%, finendo però per
aumentare il servizio del debito e strozzare l’offerta creditizia sul mercato interno,
rinvigorendo la spirale deflazionista. Il governo Flandin cadde nel maggio del 1935, dopo
una richiesta di pieni poteri da parte del Primo ministro negata dal Parlamento. Il suo
52
successore, Pierre Laval, che smantellò il programma espansivo di Flandin e ricorse a
ulteriori tagli delle spese pubbliche, inimicandosi così altri settori della società. Queste
politiche deflattive, però, aggravarono la situazione economica generale, inibendo nuovi
investimenti privati e portando, a partire dall’estate del 1935, ad ulteriori emissioni di
buoni del Tesoro, il cui limite fu tecnicamente violato nel gennaio del 1936, che venivano
poi scontati dalla Banca di Francia. In questo modo, i prezzi all’ingrosso in Francia
aumentarono del 17% tra luglio del 1935 e febbraio del 1936, facendo diminuire
nettamente il valore delle esportazioni e finendo per peggiorare la situazione della
bilancia dei pagamenti. Seguì un ulteriore deflusso di riserve auree della Banca di Francia:
tra il marzo del 1935 e lo stesso mese del 1936 si registrò una perdita del 20% del totale,
e del 9% nei soli mesi di aprile e maggio 1936.
Nel gennaio del 1936 Laval fu costretto a dare le dimissioni, sostituito da Albert
Sarraut fino alle elezioni della primavera successiva. Nel frattempo le opposizioni alle
politiche deflattive diventavano maggiormente condivise da settori sempre più ampi della
società. Le politiche di austerità, che avevano duramente colpito anche le classi medie,
furono uno dei collanti della coalizione tra socialisti, comunisti e radicali, che si unirono
nel Fronte Popolare, ottenendo in conseguenza della vittoria delle elezioni dell’aprile
1936 il controllo del Parlamento. Inizialmente il governo di Leon Blum, come Flandin,
tentò di percorrere una via di reflazione senza svalutazione attraverso un piano di lavori
pubblici per 20 milioni di franchi finanziati tramite lo sconto di buoni del Tesoro da
parte della Banca di Francia. Per assicurarsi la collaborazione dell’istituto centrale, sempre
diffidente sull’uso di queste politiche monetarie, Blum riorganizzò la struttura stessa della
banca centrale, in particolar modo istituendo la nomina governativa per 18, su 20 totali,
dei membri del Consiglio dei Reggenti, l’organismo di governo dell’istituto presieduto da
un governatore anch’esso di nomina ministeriale.
La politica di credito a basso costo così inaugurata, insieme all’aumento del costo di
lavoro in conseguenza degli aumenti salariali concessi con l’accordo di Matignon,
depressero ancora di più la produzione industriale, che calò del 6% nel solo giugno 1936,
e fecero contrarre nuovamente le esportazioni, provocando una fuga di capitali e un
ulteriore deflusso di riserve auree. Il 26 settembre il governo fece si che la Banca di
Francia sospendesse il suo sostegno ad un franco sempre più sotto pressione,
abbandonando di fatto la convertibilità aurea.
Tuttavia, affinché questa svalutazione avesse un effetto reale sull’economia francese,
il governo Blum riteneva essenziale evitare che anche altri paesi svalutassero le loro
monete, togliendo in questo modo qualsiasi efficacia all’uscita francese dal gold standard.
L’idea di una svalutazione concertata tra le varie nazioni era già affiorata nel corso del
1935, ma gli americani si opposero per tutto il periodo a conferenze mondiali su temi
monetari. Prima di svalutare il franco, le autorità francesi percorsero così, in un clima di
reciproca diffidenza da parte di tutti i governi di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, la
loro seconda opzione, ovvero quella di un accordo solamente tra le tre maggiori valute,
cioè tra dollaro, sterlina e franco. L’originale bozza predisposta dal Ministro delle finanze
francese, Vincent Ariol, prevedeva strette bande di oscillazione nei cambi tra sterlina,
dollaro e franco, svalutazioni consensuali e l’impegno reciproco a sostenere le parità dei
cambi bilaterali tra le tre valute, insieme ad un comune impegno per un rapido ritorno
alle parità auree. Stante l’opposizione inglese e americana a tale accordo, l’unica cosa che
sopravvisse fu una dichiarazione dei tre governi nella quale si impegnavano ad evitare il
ricorso a svalutazioni competitive e ritorsioni commerciali.
53
Dopo una serie di revisioni dei testi provvisori eseguite sia a Londra che a
Washington, il 26 settembre, lo stesso giorno della svalutazione de facto del franco,
vennero emesse contemporaneamente dai tre governi delle dichiarazioni nelle quali si
sottolineava la volontà alla cooperazione volta alla riduzione dell’instabilità dei cambi,
affermando che nessun governo avrebbe svalutato la moneta per assicurarsi vantaggi
competitivi. La borsa francese rimase chiusa per una settimana per dare al Parlamento il
tempo di varare una legge che fissasse la svalutazione del franco al 25%, come
concordato precedentemente in via informale con le autorità americane e inglesi, che non
avrebbero tollerato un maggiore deprezzamento della valuta francese.
L’accordo tripartito, come venne definito, riuscì a porre fine al periodo di instabilità
monetaria e svalutazioni competitive tra le varie valute. Fissando la svalutazione del
franco al 25% del suo valore precedente e portandolo ad un livello sostenibile dalle
esportazioni americane, veniva scongiurata la necessità di un’ulteriore svalutazione
compensativa del dollaro che avrebbe portato con sé nel deprezzamento anche il blocco
legato alla sterlina. Il prezzo dell’oro fu così fissato a 35 dollari all’oncia, fornendo un
punto di riferimento nominale per tutto il sistema internazionale. Conseguentemente il
sistema trovò una sua stabilità, con la sterlina scambiata ad una parità di 105 franchi dalla
riapertura dei mercati il 2 ottobre 1936 fino al marzo del 1937, grazie all’intervento
costante delle autorità monetarie inglesi e francesi per limitare, da una parte
l’apprezzamento della sterlina e, dall’altra, un’eccessiva svalutazione del franco. Seppur
attraversati da qualche turbolenza – il franco tornò a svalutarsi nell’aprile del 1937,
stabilizzato poi alla fine del 1938, mentre la sterlina si deprezzò di poco nella seconda
metà del 1938 – , ma sostanzialmente contribuì a ristabilire normali rapporti tra i mercati
finanziari nazionali.
Una percorso diverso nei suoi ultimi esiti politici ed economici fu quello della
Germania. La crisi economica colpì fortemente le esportazioni delle industrie tedesche,
che continuarono a contrarsi almeno fino al 1934, anno in cui esse ammontarono
solamente al 50% del volume delle esportazioni registrato nel 1929. L’aumento della
spesa pubblica registratosi a partire dall’estate del 1932 e incrementato dall’arrivo al
potere di Hitler nel gennaio 1933 ebbe, tra i suoi effetti, quello di aumentare il bisogno di
importazioni necessarie alle industrie tedesche.
Per limitare gli effetti che questo processo avrebbe potuto avere sulla bilancia dei
pagamenti, vennero introdotte alcune misure. La prima di queste fu l’imposizione di
licenze di importazione, che avevano lo scopo di limitare queste ultime a quei prodotti
ritenuti essenziali al progresso industriale tedesco, tagliando così tutto ciò che veniva
giudicato superfluo. In secondo luogo, vi fu un controllo sui pagamenti dei prestiti
all’estero. Tra il 1932 e il 1933, infatti, si era avuto un enorme deflusso di capitali dalla
Germania, che avevano contribuito ad un progressivo esaurimento delle riserve auree e
di valuta estera: queste ultime passarono da 2.405 milioni di marchi del 1928, a 975
milioni del 1932, fino ad arrivare a 165 milioni nel 1934. Nel giugno del 1933 il governo
tedesco impose la sospensione, ad eccezioni di quelli del piano Dawes e del piano Young,
del pagamento di tutti i debiti contratti all’estero, che sarebbero stati pagati solamente per
la metà del loro ammontare in valuta estera e per l’altra metà in marchi. Nel giugno del
1934 questa moratoria divenne completa sull’intero ammontare dei debiti. Furono, infine,
stipulati degli accordi commerciali con i paesi del sud-est europeo e dell’America Latina,
stabilendo canali bilaterali preferenziali per le esportazioni e importazioni da e per la
Germania.
54
La spesa statale destinata alle opere pubbliche, inaugurata già nel 1932 e perseguita
poi con maggiore efficacia dal Nazismo, fu l’elemento centrale della ripresa economica
tedesca negli anni Trenta, che permise al paese di raggiungere virtualmente il pieno
impiego, seppur con salari mantenuti artificialmente bassi e con enormi costi politici, già
dal 1936. Nel biennio 1933-1934 furono avviate opere per il rimboschimento e per il
miglioramento dei processi agricoli, nonché per implementare i servizi pubblici di base,
come la rete stradale e ferroviaria. Si calcola che in quel biennio lo Stato finanziò lavori
per un totale di circa 4000 milioni di marchi e a dicembre 1934 i lavoratori disoccupati
scesero da 6 a 2,6 milioni. Il contestuale scioglimento dei sindacati fece sì che fu possibile
mantenere gli stipendi su bassi livelli, depotenziando il rischio di un possibile aumento
dei prezzi e liberando più risorse per ulteriori investimenti. L’ultimo tassello fu la politica
di riarmo, operata in vista di un prossimo conflitto, che il governo tedesco avviò a partire
dal 1935. La disoccupazione praticamente scomparve nel 1938, mentre i prezzi furono
fissati per decreto al livello dell’ottobre del 1936 per scongiurare una possibile inflazione.
Le spese per il riarmo, stimate in 90 miliardi di marchi, richiesero speciali forme di
finanziamento, elaborate da Hjalmar Schacht, il quale ebbe un ruolo di primissimo piano
nella gestione economico-finanziaria della Germania nazista degli anni Trenta,
ricoprendo sia il ruolo di Governatore della Reichsbank, dal 1933 al 1939, sia quello di
Ministro delle finanze del governo nazista, dal 1934 al 1937. Un tipico esempio di tali
forme di finanziamento sono i Mefo-Wechsel, obbligazione a tre mesi, spesso estesi a
cinque, di una finanziaria statale denominata Metallische Forschungsgesellschaft, i cui
azionisti erano grandi aziende elettriche e metallurgiche, come la Simenes e la Krupp. I
Mefo-Wechsel venivano accettati in forma di pagamento dalle industrie minori a capitale
limitato che fornivano materiale alla Wehrmacth. Questi titoli di credito potevano poi
essere scontati dalla Reichsbank.
Questo fu possibile grazie anche ad un deciso accentramento dei poteri monetari nei
vertici politici nazisti, come appunto dimostrato dalla figura di Schacht. La legge bancaria
nazista del 1934 rafforzò la vigilanza della Reichsbank, e quindi del governo, sull’intero
sistema bancario, introducendo limitazioni sui depositi a lungo termine e sull’inserimento
di rappresentanti di istituti di credito nei consigli di amministrazione delle industrie. Il
legame tra banche e industrie, tuttavia, si stava sfaldando, soprattutto per il ruolo di
protagonista assoluto dei finanziamenti alle attività produttive svolto dallo Stato per tutti
gli anni Trenta. Il panorama bancario tedesco fu inoltre colpito seriamente dalla politica
anti-semita di Hitler: se gran parte dei dirigenti ebrei lasciarono il loro posto già tra il
1933 e il 1934, fu solo dopo le dimissioni di Schacht da Ministro delle finanze nel 1937 –
Schacht aveva infatti compreso il ruolo centrale dei banchieri ebrei nel sistema – che
riprese un’ondata anti-semita, culminata nella Kristallnacht del novembre 1938, dopo la
quale divenne obbligatoria l’espulsione di tutti gli ebrei dalle imprese tedesche.
Se la Germania si era progressivamente sganciata dai problemi e dalle conseguenze
monetarie e economiche del blocco dell’Europa occidentale e degli Stati Uniti con le sue
politiche autarchiche, la ritrovata stabilità monetaria conseguente all’accordo tripartito tra
Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia ebbe ricadute sull’economia reale al di sotto delle
aspettative.
In Francia la sola svalutazione del franco non fu infatti sufficiente a frenare il
progressivo deterioramento della bilancia commerciale, che continuò a chiudere in
disavanzo anche nel 1936-1937 dando il via a nuove fughe di capitale. Dal lato
dell’offerta, infatti, sussistevano gli effetti delle politiche del Fronte Popolare che
55
influivano in maniera negativa sui costi che dovevano sostenere le imprese francesi
soprattutto sul versante dei salari, che a Parigi crebbero di più del 50% tra giugno 1936 e
giugno 1937, ed in misura minore nel resto del paese. Ulteriori spinte alla contrazione
dell’economia mondiale provenivano, tra il 1937 e il 1938, dagli Stati Uniti, i quali,
importando più di un settimo delle esportazioni mondiali, influiva notevolmente
sull’andamento economico degli altri paesi. Tra agosto 1937 e gennaio 1938, la
produzione industriale subì un calo del 30%, conseguenza di un forte calo della domanda
dovuto alle scelte di politica economica messe in campo dalle autorità.
Nel 1937, infatti, al fine di diminuire il disavanzo del bilancio federale venne deciso
un aumento della tassazione per un totale di 1,2 miliardi di dollari e, contestualmente, la
misura da 1,7 miliardi di dollari in favore degli ex combattenti, che era stata centrale nello
stimolare i consumi, non era stata ripetuta nel 1937, né venne rimpiazzata con altre
misure di spesa pubblica. Infine, temendo spinte inflazionistiche, la Fed iniziò a condurre
una politica monetaria restrittiva, aumentando al 50% la percentuale obbligatoria di
riserve nell’agosto del 1936, e di un ulteriore 50% all’inizio del 1937. La crisi culminò in
un nuovo crollo di Wall Street, il 19 ottobre del 1937, che però, grazie alla flessibilità
ottenuta dalle economie europee in assenza di vincoli aurei, non si propagò in una
depressione mondiale e permise anzi una rapida ripresa, dovuta anche ad un aumento
della spesa militare in tutto il mondo, che si palesò già nella seconda metà del 1938,
quando sia la produzione che il commercio estero statunitense riprese a crescere.
5. Quadri di approfondimento
5.1 Il fallimento della Conferenza economica mondiale di Londra del 1933
5.2 La tecnica del marging buying e il declino delle aspettative nella crisi di Wall Street del 1929
Le cause della crisi finanziaria di Wall Street e dell’esplosione della bolla speculativa
dell’ottobre del 1929 rimangono alcuni dei nodi storiografici più praticati dagli storici
economici.
5.3 Le riserve auree di Stati Uniti e Francia negli anni Trenta
Conclusioni
1. La Prima guerra mondiale determinò dei cambiamenti nella politica economica degli
Stati, negli scambi commerciali e nella finanza interna ed estera, portando ad un riorientamento dei sistemi finanziari.
2. La prima manifestazione di questa riorganizzazione si esplicita nelle modalità di
finanziamento della guerra. Le scelte fiscali operate tra il 1914 e il 1919,
determinarono un vincolo di finanza pubblica che si riflesse nelle modalità di
stabilizzazione delle valute nel corso degli anni Venti.
3. Di conseguenza, la produzione e il commercio dei singoli Stati risultarono vincolati
dalla politica valutaria dei governi. Queste scelte modificarono gli orientamenti di
stabilità e credibilità finanziaria. Da una cultura ottocentesca che aveva come unico
56
referente l’oro, che rappresentava la stabilità di un prezzo internazionale, si passò ad
una priorità dei prezzi nei mercati interni. Il risultato fu una concorrenza-guerra tra
valute nazionali.
4. Il conseguente mutamento si articolò in tre momenti: quello di alta mobilità di
capitali, crollo della fiducia e disintegrazione finanziaria del sistema internazionale
negli anni 1928-1931; quello delle svalutazioni competitive tra valute nazionali, nel
1931-1936; de infine, quello inaugurato dall’accordo tripartito nel tentativo di
stabilizzazione dell’economia internazionale attraverso un accordo sui cambi tra le
principali valute.
5. L’accordo non fu comunque sufficientemente solido da garantire il ritorno della
fiducia internazionale e per evitare l’esasperarsi di scelte nazionaliste, che si
tradussero in una corsa al riarmo e, infine, nello scoppio della Seconda guerra
mondiale.
Letture
-
B. Eichengreen, Gabbie d’oro
Kindleberger, Grande Depressione
Temin, The Lessons of the Great Depression, 1989
Frieden, J.A., Global Capitalis. Its Fall and rise in the Twentieth Century
Feinstein, C.H. (a cura di), Banking, Currency and Finance in Europe between the Wars,
Oxford, Oxford University Press, 1995.
57