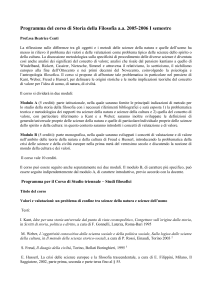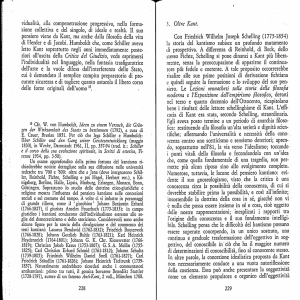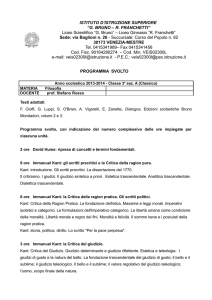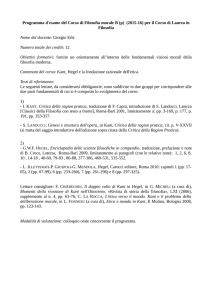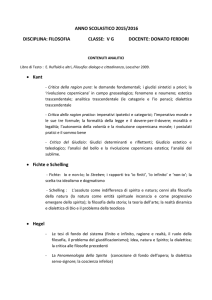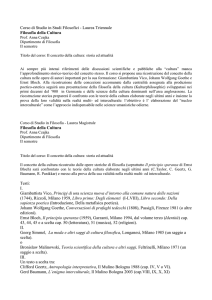RIVISTA QUADRIMESTRALE - ANNO XVI
NUOVA SERIE - N. 45 - GENNAIO-APRILE 2002
Manni
Pubblicazione quadrimestrale promossa dal Dipartimento di filosofia
dell’Università degli Studi di Lecce, con la collaborazione del “Centro Italiano
di Ricerche fenomenologiche” con sede in Roma.
2
Questa rivista si pubblica anche con i contributi del Ministero dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, attraverso il Dipartimento di Filosofia
dell’Università degli Studi di Lecce, e dello stesso Dipartimento.
Direttore responsabile: Giovanni Invitto
Comitato scientifico: Angela Ales Bello (Roma), Angelo Bruno (Lecce),
Antonio Delogu (Sassari), Giovanni Invitto (Lecce), Aniello Montano (Salerno),
Antonio Ponsetto (München), Mario Signore (Lecce).
Redazione: Doris Campa, Raffaele Capone, Daniela De Leo, Lucia De
Pascalis, Alessandra Lezzi.
Comitato Scientifico e Segreteria hanno sede presso il Dipartimento di Filosofia,
Università degli Studi - Via M. Stampacchia - 73100 Lecce - tel. (0832) 336627/8;
fax (0832) 3366626.
Amministrazione, abbonamenti e pubblicità: Piero Manni s.r.l., Via Nino Bixio,
11/b - 73100 Lecce - Tel. e Fax. 0832/387057. Iscritto al n. 389/1986 del Registro
della Stampa, Tribunale di Lecce. Abbonamento annuo: Italia t 25, Estero t 35,
c/c postale 16805731 intestato a Piero Manni s.r.l., Lecce. L’abbonamento, in qualunque mese effettuato, decorre da gennaio e dà diritto a ricevere i numeri arretrati dell’annata. Un fascicolo t 10, degli anni precedenti il doppio.
SOMMARIO
5
G. Greco
TEMPORALITÀ E AFFEZIONE
NELLE “ANALYSEN ZUR PASSIVEN SYNTHESIS” DI HUSSERL
26
M. Salvioli
OLTREPASSARE IL SEGNO.
DERRIDA E RICOEUR LETTORI DI HUSSERL
43
S. Franzese
RIPENSARE LA “NORMALITÀ”.
LA NOZIONE STRUTTURALE DI NORMALITÀ IN MERLEAU-PONTY
57
V. Scaloni
BLOCH INTERPRETE DI KANT:
TEMPO DELLA SCIENZA, TEMPO DELLA STORIA,
81
A. Levallois
DALLA STORIA DEI COMPORTAMENTI COLLETTIVI
ALLA BIOGRAFIA STORICA. STORIOGRAFIA E PSICANALISI
91
A.Negri
DIO: UNA PASSIONE? ATENE E GERUSALEMME
94
S.Ciurlia
I TANTI VOLTI DELLA FILOSOFIA DI LEIBNIZ
105
L. De Pascalis
FELICE BALBO. PER UN RADICALE REINIZIO FILOSOFICO
110
P. Miccoli
DALL’IMPRESA DELL’ESSERE ALLA SORPRESA DEL VOLTO
114
Recensioni
125
Pubblicazioni ricevute
3
NOTE PER GLI AUTORI
I contributi vanno inviati alla Direzione di “Segni e comprensione” c/o
Dipartimento di Filosofia – Via V. M. Stampacchia 73100 Lecce. I testi debbono essere inviati in duplice copia, su carta formato A4, dattiloscritta su una sola
facciata, a doppia interlinea, senza correzioni a mano. Ogni cartella non dovrà
superare le duemila battute. Il testo deve essere inviato assolutamente anche
su “floppy disk”, usando un qualsiasi programma che, però, dovrà essere indicato (Word, Windows, McIntosh). Il materiale ricevuto non verrà restituito.
Per la sezione “Saggi” i testi non dovranno superare le venti cartelle comprese le note bibliografiche, per la sezione “Note” non dovranno superare le
sette cartelle, per la sezione “Recensioni” e “Notizie” le tre cartelle.
Si raccomanda che i titoli siano brevi e specifici. La redazione si riserva il
diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie, previa
comunicazione e approvazione dell’Autore.
Agli Autori saranno inviate tre copie del fascicolo in cui appare il loro lavoro.
4
TEMPORALITÀ E AFFEZIONE
NELLE “ANALYSEN ZUR PASSIVEN SYNTHESIS”
DI HUSSERL
Nella trattazione svolta si cerca di mettere in luce come le Analysen zur
passiven Synthesis, testo fondamentale del pensiero di Husserl negli anni
venti, indirizzino la ricerca fenomenologica, in relazione alle nozioni fondamentali di coscienza, tempo e genesi, verso direzioni teoriche diverse da
quelle prese nel periodo più tardo della sua riflessione. Lo studio procede fornendo un quadro della costituzione passiva, nelle diverse fasi in cui essa si
articola, per chiarire come le sintesi operate nella dimensione pre-noetica e
pre-noematica della coscienza siano comprensibili a partire dalla temporalità
e dalle forme che essa assume nel processo genetico. Il confronto tra le analisi del concetto di intenzionalità nelle Analysen e nella sesta delle Logische
Untersuchungen mostra come lo studio dell’intenzionalità, nella sua dimensione fungente, conduca verso una legalità associativa, che regola i decorsi
intenzionali nell’esperienza antepredicativa, sulla base di connessioni materiali tra contenuti pre-dati. L’indagine dell’associazione e dei suoi principi, effettuata seguendo come filo conduttore la nozione di temporalità oggettiva,
chiarisce il rapporto tra le sintesi operate nell’intenzionalità fungente e la temporalità del flusso delle predatità. Il percorso prosegue con la riconduzione,
fondata sulla temporalità soggettiva, dell’appercezione all’affettività. Con lo
studio delle leggi della propagazione dell’affezione e della formazione di unità
preoggettuali, è possibile vedere come nell’affettività risieda la condizione
della possibilità della costituzione degli oggetti e degli atti oggettivanti che li
colgono.
L’esame della costituzione passiva nelle sue fasi di sviluppo permette di
evidenziare, in particolare, il ruolo dell’affezione come componente teorica
fondamentale messa in gioco
dal rapporto tra temporalità e coscienza. Proprio grazie all’affezione è possibile l’articolazione della temporalità costituente in temporalità oggettiva e
soggettiva e, quindi, la distinzione tra attività e passività con il subentrare della
prima alla seconda. Risulta particolarmente rilevante la modificazione, effettuata alla luce della nozione di affezione, delle nozioni di tempo e di coscienza rispetto alle lezioni sulla coscienza interna del tempo del 1905. Le Analysen
fanno riferimento ad una soggettività affettiva più ampia rispetto all’ego
trascendentale, ovvero a una dimensione affettiva preegoica e preriflessiva
della coscienza, che dimostra come quest’ultima non coincida immediatamente con l’autocoscienza. Nell’affezione, radice comune dell’empirico e del
trascendentale, viene individuata la chiave di volta per comprendere non solo
il rapporto tra attività e passività, ma anche la proposta di un’estetica trascen-
SAGGI
di Giulio Greco
5
dentale, che indirizza la ricerca fenomenologica verso direzioni teoriche
diverse, e per molti aspetti alternative, rispetto a quelle prese in testi più tardi
come la Krisis e le Cartesianische Meditationen. A questo scopo, si rivela fondamentale il ruolo del pensiero di Kant: polo attorno al quale gravitano molte
tematiche trattate nelle Analysen, nel suo doppio ruolo di costante punto di
riferimento critico e di fonte di ispirazione teorica.
1. Il concetto di intenzionalità nelle Analysen zur passiven
Synthesis: predelineazione e riempimento
6
Le Analysen zur passiven Synthesis cominciano con una ripresa di tematiche già trattate nelle Logische Untersuchungen, in particolare nella Sesta
Ricerca, legandosi quindi a riflessioni appartenenti ai primi anni della ricerca
fenomenologica e su cui Husserl sente il bisogno di tornare dopo la stesura
delle Idee a partire dagli anni 1917/1918. Il tema dell’evidenza e quello dell’indeterminatezza dell’intenzione rivelano la continuità teorica tra le Logische
Untersuchungen e le indagini contenute nelle Analysen. L’evidenza come pura
verificazione riempiente dell’atto intenzionale oggettivante era stata definita
nella Sesta Ricerca come pienezza ideale di un’intenzione, come identificazione adeguata tra l’inteso, il contenuto dell’intenzione, e il dato come tale.
La pura verificazione si era configurata asintoticamente, come ideale di riempimento di un atto intenzionale non raggiungibile nella dinamica effettiva del
riempimento.
Il problema della verificazione si presenta teoricamente legato a quello dell’indeterminatezza dell’intenzione. L’analisi fenomenologica descrive l’esperienza in termini di adombramento graduale: l’appercezione, l’atto intenzionale
il cui correlato oggettuale è la cosa esperita, si configura come un tessuto di
intenzioni parziali, riempite e non, di vario genere, in parte puramente
percettive, in parte immaginative o anche signitive (o indicazionali), ognuna
delle quali ha come contenuto un momento o una parte della cosa. Ogni
oggetto, dice Husserl, è intenzionato determinatamente per certe sue parti o
momenti e indeterminatamente per altre. L’indeterminatezza è definita come
“proprietà di postulare un’integrazione non completamente determinata, ma
determinata solo all’interno di una sfera delimitata secondo una legge” 1.
L’indeterminatezza è quindi una proprietà dell’intenzione cui corrisponde un
certo ambito di riempimento possibile.
Questo tema resta poco indagato nelle Logische Untersuchungen, ma sarà
importante nel passaggio dalla fenomenologia statica a quella genetica. La
fenomenologia, così come trattata nelle Ideen, come studio dei tipi di oggettualità e della molteplicità regolata di atti conoscitivi, mediante i quali essi si
manifestano alla coscienza, non sarà più considerata sufficiente a chiarire la
costituzione dell’oggettualità. Gli atti intenzionali oggettivanti sono considerati
come i correlati soggettivi di oggettualità stabili, già presenti, mentre sarà necessario indagare non solo la dinamica sistematica che regola la loro
aggregazione in atti complessivi unitari, ma anche la loro origine.
SAGGI
Il problema della dinamica di interazione tra le intenzioni nel processo della
costituzione richiede un approfondimento della nozione stessa di intenzionalità. Per affrontare questo problema, Husserl porta la ricerca fenomenologica al
livello dell’intenzionalità fungente, nella sfera della riduzione fenomenologica
prenoetica e prenoematica del flusso delle datità, ovvero nella sfera della passività che soggice al rapporto tra soggetto e oggetto.
Le Analysen fanno emergere, riguardo alla coppia di concetti intenzioneriempimento, più di quanto scoperto nelle Logische Untersuchungen: la chiave
di volta usata per ridefinire la problematica dell’intenzionalità è il concetto di
predelineazione, intesa come componente anticipatrice e protenzionale dell’intenzione, che da essa viene guidata verso la realizzazione o il riempimento. Nell’ambito dell’intenzionalità fungente, la predelineazione indica quindi la
direzione fornita all’intenzione dalla rappresentazione vuota che ne costituisce
il contenuto e che la predispone al possibile riempimento da parte di una
datità. Il riempimento subentra quando il dato intuitivo che va al di là della predelineazione, ovvero di ciò che è atteso in maniera determinata dalla rappresentazione vuota, non è caratterizzato come semplice riempitivo, ma come
una più precisa determinazione 2. Il dato che fornisce la coincidenza è ciò che
riempie primariamente e che soddisfa la predelineazione, e il sovrappiù, che
l’intenzione offre come appartenente all’oggetto, riempie secondariamente la
medesima intenzione, facendo sì che la semplice sintesi di “continuità” tra rappresentazioni vuota e piene, fornite dalla datità, ovvero la semplice raffigurazione di ciò che è atteso, si trasformi in una sintesi di identificazione. Nel
caso della percezione attuale, la pura verificazione riempiente è un limite ideale e adesso è possibile spiegare perché: la predelineazione costituisce, infatti, per essa un orizzonte indeterminatamente aperto a diverse possibilità di
riempimento, quindi, se è sempre possibile il mero render pieno, non è altrettanto possibile un riempimento effettivo e totale.
Husserl reimposta il problema della natura degli atti oggettivanti, operando
una svolta nella direzione dell’indagine trascendentale del soggetto, portandola sul piano dell’analisi fenomenologica della sfera della intenzionalità fungente. In questa analisi, Husserl sdoppia il concetto di intenzione: essa non
viene più considerata solo come “coscienza-di”, ma anche come tendenza
(Strebung) e rilegge la distinzione tra render-pieno e riempimento, parlando di
tendenza alla realizzazione in riferimento al primo e tendenza alla conoscenza in riferimento al secondo. La predelineazione si configura sia come una tendenza dell’io che intenziona anticipatamente e attivamente, sia come tendenza priva di partecipazione dell’io, ovvero come un in-tendere (Hintendieren)
rappresentativo protenzionalmente diretto ad un futuro percettivo solo possibile. La tendenza alla conoscenza, che fa sì che la sintesi della verificazione
si costituisca al termine del processo sintetico tra la rappresentazione vuota,
che funge da intenzione, e la corrispondente rappresentazione piena che offre
il dato, presuppone sempre una tendenza alla realizzazione come soddisfacimento dell’intenzione preafferrante. La tendenza alla conoscenza si soddisfa
come sintesi solo perché conserva in sé il carattere dell’identità, che deve
essere possibile nella tendenza alla realizzazione, tra l’intenzione anticipatrice
7
8
e l’intenzione che afferra l’originale. Husserl individua una sorta di stratificazione nel processo di riempimento: vi è un primo livello, in cui si attua la
coincidenza di un’intenzione preafferrante e protenzionale, che fonda la predelineazione, e di una rappresentazione anticipatrice, dove l’intenzione non ha
la forma dell’essere diretto su qualcosa nella sua oggettualità; vi è, inoltre, un
secondo livello nel quale l’intenzione vera e propria è diretta sul suo oggetto
in virtù della sua identità con l’intenzione anticipatrice, ne penetra l’essenza e
trova riempimento. Husserl rintraccia, in questa componente dell’intenzione,
una tendenza al dare nell’originale, ma che non è ancora un dare nell’originale. In particolare, “la direzione verso l’oggetto rappresentato in maniera
vuota è precisamente quel modo della tendenza rappresentativa diretta verso
il suo oggetto nel quale la coscienza rappresentativa non si è ancora sviluppata intenzionalmente. […] E questo è forse del tutto esatto se viene realmente tenuta fuori gioco ogni ingerenza dell’attività dell’io” 3.
Husserl usa il concetto di orizzonte per approfondire ulteriormente il rimando reciproco di predelineazione e riempimento, definendolo come un insieme
coerente di intenzioni vuote, che nel procedere dell’esperienza, sono attualizzate in diverse direzioni; un insieme, cioè, di possibilità di riempimento, predelineate dalla struttura dell’intenzione, lasciate indeterminatamente aperte.
L’orizzonte costituisce quel carattere di indeterminatezza che appartiene a
ogni intenzione e che fa sì che essa non sia indissolubilmente legata all’oggetto che la riempie.
Il problema diviene quello di verificare quale è la legalità a partire dalla
quale si parla di dinamica predelineazione-riempimento, e quali sono le leggi
che rendono sistematica l’esperienza, indirizzando gli atti intenzionali verso
certi dati e non altri, ovvero verso il processo di costituzione degli atti oggettivanti e degli oggetti, verso i quali essi si dirigono, a partire dalla datità preoggettuale. Risolvere questo problema significa indagare le condizioni di possibilità in base alle quali si costituiscono, nel flusso incessante degli atti di
coscienza, quelle unità stabili oggettive e identiche per ogni categoria di
oggetti. A questo problema Husserl dà il nome di genesi: “l’essenza dell’esperienza, che l’analisi fenomenologica ricerca, è la possibilità stessa dell’esperienza, e completamente nell’essenza e nella possibilità dell’esperienza accertata vi è eo ipso la condizione della possibilità dell’esperienza” 4.
L’indagine della genesi degli atti oggettivanti procede nei due sensi dell’esplicitazione della natura dell’oggettività e di quella della soggettività. Rispetto
alla proposta della fenomenologia descrittiva delle Logische Untersuchungen,
le Analysen zur passiven Synthesis rappresentano un’apertura al trascendentalismo: se prima gli atti di coscienza erano studiati solo nella loro tipologia in
rapporto alle forme di manifestazione dei contenuti noematici, adesso è necessario indagare l’origine di questi contenuti, il modo in cui si costituiscono e
le modalità in cui essi si manifestano. Il nuovo obbiettivo, che Husserl si prefigge di conseguire dagli anni venti in poi, non è più quello di indagare i sistemi di correlazione tra atti di coscienza e oggettualità che si offrono ad essa
come “prodotti finiti”, ma di cercarne l’origine: “analizzare la costituzione non è
analizzare la genesi, che è appunto genesi della costituzione”5. Non è tuttavia
SAGGI
sufficiente, per poter parlare di vera e propria genesi, passare dalle datità originali all’ordine sistematico delle appercezioni, con le loro modificazioni in protenzioni e ritenzioni, come Husserl stesso sottolinea nell’importante appendice
alle Analysen intitolata Statische und genetische phänomenologische
Methode 6.
La modificazione del concetto di intenzionalità, effettuata nella prima parte
delle Analysen alla luce del concetto di orizzonte, permette a Husserl di individuare nella componente predelineante e protenzionale di ogni intenzione
non solo un’anticipazione dell’intuizione riempiente nella forma di una rappresentazione vuota, ma anche una direzionalità nel tempo, che costituisce il
primo livello di collegamento tra temporalità e soggettività. Da ciò consegue
non soltanto una presa d’atto della necessità del rapporto tra le sintesi operate nell’intenzionalità fungente e la temporalità del flusso dei vissuti, ma anche
un nesso altrettanto necessario di queste con la struttura temporale della
coscienza, articolata in presente impressionale, ritenzione e protenzione.
Il tempo è la forma di tutte le oggettività in quanto tali, cioè in quanto in sé,
ma, così concepito, non è efficace nello spiegare il divenire dei suoi contenuti.
È per questo che la fenomenologia della coscienza interna del tempo viene
considerata da Husserl non una fenomenologia genetica, bensì la sua fondazione, perché mette in luce il fondamento della genesi. “Se la coscienza del
tempo è il luogo originario della costituzione sia dell’unità e cioè dell’oggettualità, sia delle forme di collegamento della coesistenza e della successione, essa
è tuttavia solo una coscienza che produce una forma generale. La mera forma
è senza dubbio un’astrazione: l’analisi intenzionale della coscienza del tempo
e del suo operare è dunque sin da principio un’analisi astrattiva. Essa prende
in considerazione e si interessa solo della forma temporale necessaria di tutti i
singoli oggetti e di tutte le molteplicità oggettuali, oppure, correlativamente, si
interessa solo della forma delle molteplicità che costituiscono l’elemento temporale”7. L’analisi temporale da sola non può dirci che cosa dia unità contenutistica a ogni singolo oggetto, perché astrae dal momento contenutistico e non
permette di rendere evidenti le strutture sintetiche del presente esperito.
Husserl individua la necessità non di un’astrazione dal contenuto, bensì di
un’astrazione dalla forma, per individuare i “puri” nessi strutturali a priori8 che
legano i contenuti, indipendentemente dall’operare formale della soggettività,
nella sfera della passività. È necessaria pertanto un’astrazione dall’esperienza della percezione presente e del ricordo, che sono già sempre strutturati
oggettualmente, in modo da regredire al livello che precede l’esperire vero e
proprio, quello della passività soggiacente, per ricostruire la genesi dell’oggettualità dai rinvii associativi preintenzionali tra i contenuti.
Come Husserl sostiene: “l’analisi fenomenologica descrittiva della
coscienza che costituisce l’oggettualità temporale ci ha già condotti ai principi
elementari della legalità della genesi che domina la vita soggettiva. Ora
appare ben presto chiaro che la fenomenologia dell’associazione, è, per così
dire, una prosecuzione ad un livello più alto della teoria della costituzione
originaria del tempo. L’associazione estende infatti l’operazione costitutiva a
tutti i livelli dell’appercezione”9.
9
Si potrebbe anche aggiungere che la teoria dell’associazione estende il
campo dell’indagine genetica dal presente fluente al passato, nel suo deflusso ritenzionale. Sul piano della datità, vi è un collegamento tra ciò che è dato
nel presente e ciò che è rimemorato, sul piano della coscienza, vi è un collegamento tra la coscienza percipiente e originariamente costituente con la
coscienza ridestante che opera con atti riproduttivi. L’associazione permette,
quindi, di approfondire il concetto di temporalità, individuando i nessi essenziali che legano il presente fluente al passato e al futuro all’interno del flusso
dei vissuti.
2. La costituzione associativa
e l’autostrutturazione della datità
10
Si possono individuare quattro livelli di strutturazione nel percorso della sintesi passiva. La sintesi associativa interviene nella sfera primordiale della temporalità oggettiva. In questo primo livello di datità irrelate interviene la sintesi
di unità associativa (Einheitsbildung) o pre-affettiva, sulla base dei tre principi
della somiglianza o omogeneità, del contrasto e della contiguità. Il secondo livello riguarda l’affezione operante nel presente fluente che produce il ridestamento (Weckung) delle datità nella ritenzione e nella protenzione. Quando l’affezione motiva un dirigersi dell’io, sorge il momento della recettività, che fonda
l’apprensione dell’oggetto come tale. L’apprensione (Auffassung), da un lato,
permette il subentrare di una forma di attività della coscienza, dall’altro lato,
resta motivata del tutto passivamente. Nel quarto livello, a recettività permette
la formazione dell’oggetto e la sua comprensione (Erfassung) ed esplicazione
(Explikation). Mentre nella modalità del tenere-sotto-presa affettivo, l’oggettualità era mantenuta nell’apprensione, la ricettività porta l’interesse della
percezione sull’oggetto come intero unitario indiviso con le sue proprietà. La
comprensione dell’oggetto è ciò che Husserl chiama appercezione.
È di fondamentale importanza notare come qui non si stia parlando di fasi
che si susseguono cronologicamente nella genesi dell’oggettualità: la costituzione è un processo scomponibile solo teoreticamente mediante indagine
fenomenologica. Husserl parla di processi regolati da leggi sempre in atto, che
si completano e si compenetrano, di piani che si sovrappongono. Un oggetto,
per formarsi, non segue un processo di “costruzione”, bensì, dopo la sua manifestazione alla coscienza, è possibile risalire alla sua origine, ripecorrendo il
cammino dai dati che si presentano fino alle unità oggettuali. Le datità sono
preoggettuali in quanto, propriamente, si presentano (auftreten) e non sono
coglibili come oggetti, perché non si manifestano (erscheinen) come gli oggetti. Si tratta di un percorso inverso a quello di Kant, in cui è l’analisi delle funzioni del soggetto, separabili da ciò cui si applicano, a giustificare l’intuizione
di oggetti. Per Husserl il punto di partenza e di arrivo è l’intuizione di un oggetto, di cui è possibile indagare l’origine, ma che non necessita di fondazione o
giustificazione: “il grande compito della filosofia trascendentale è la coscienza
SAGGI
in generale come costruzione stratificata delle operazioni costitutive. In queste
si costituiscono in livelli o strati sempre nuovi sempre nuove oggettività, si costituiscono oggettività di tipo sempre nuovo, si sviluppano sempre nuovi tipi di
datità originali, […]. Tutti gli altri livelli sono dunque soppressi in quelli superiori, ma non sono per questo persi; sono al contrario sempre disponibili per uno
sguardo rivolto ad esse, per ulteriori scoperte”10. Non bisogna fraintendere
questo passo: la coscienza è la stratificazione stessa delle operazioni costitutive passive e attive, ma non è un insieme di funzioni indipendenti da ciò cui
si applicano. Ogni operazione costitutiva passiva e attiva può essere caratterizzata come una sintesi. Per questo Husserl sostienene che la sintesi è una
proprietà fondamentale della coscienza11 e che ogni correlato intenzionale
della coscienza ha la medesima struttura, in quanto si costituisce come unità
sintetica di molteplicità. L’analisi fenomenologica conduce a “die Aufhebung
der Eigenheit der Synthesis ”12, espressione che si potrebbe tradurre con “l’emergere della proprietà fondamentale della sintesi”. Il concetto kantiano di sintesi indica, per Husserl, l’unità noetica della coscienza e l’unità noematica del
suo correlato intenzionale, nel duplice senso del collegamento tra giudizi e dell’unità degli oggetti. Questo concetto può essere anche utilizzato anche per
designare i nessi dell’associazione e della temporalità oggettiva nella sfera
puramente passiva della datità. Un tale utilizzo del termine sintesi emergerebbe, secondo Husserl, già in Kant: “è qui di particolare interesse storico,
ricordare le geniali intuizioni di Kant, che, soprattutto nella sua deduzione
trascendentale della prima edizione della Critica della ragione pura, trovano
espressione nella dottrina significativa, ma non chiara, della sintesi della
capacità di immaginazione produttiva. Quando Kant parla nella sua opera di
una sintesi analitica, egli intende con ciò la conoscenza che si dispiega nelle
forme esplicite del concetto e del giudizio, e questo lo riporta indietro alla sintesi produttiva. Ma essa è, secondo il nostro modo di vedere, nient’altro che
ciò che abbiamo chiamato costituzione passiva”13. Husserl si riferisce alla
prima edizione dell’opera per l’idea, secondo lui presente, dell’autostrutturazione dell’esperienza indipendentemente dalle attività funzionali dell’intelletto14.
Husserl assume i tre principi classici dell’associazione –somiglianza, contrasto, contiguità–, rileggendoli in chiave fenomenologica ed evitando le interferenze dell’appercezione.
La somiglianza o omogeneità è il collegamento, contenutisticamente determinato, più generale che sussista tra le datità. Nel processo di sovrapposizione (Überschiebung) di due dati immersi nel flusso delle datità, troviamo
dei momenti percettivi emergenti: da un lato, la coincidenza sintetica di due
dati in virtù di una qualità comune15, dall’altro lato, il conflitto sintetico delle
qualità divergenti. La legalità che governa la sfera delle predatità passive si
fonda interamente sulla natura della datità: la sintesi dell’omogeneità contenutistica o comunanza qualitativa si impone in un continuum sensibile senza
nessuna forma di coscienza della relazione tra i dati, poiché la relazione viene
reperita nella coscienza passiva sulla base della sua emergenza percettiva
(Abgehobenheit) dal e grazie al contesto nel quale è immersa16.
11
12
L’emergere della comunanza qualitativa sottintende sempre un contrasto
come condizione complementare della fusione di omogeneità. Ad una molteplicità di dati in quanto tali appartengono quindi sia la fusione che il contrasto.
Il principio della contiguità temporale “sussume” in sé i due precedenti, in
quanto dalla costituzione materiale apre alla costituzione formale dei nessi
associativi. La sintesi dell’omogeneità e il contrasto si configurano come concatenamenti e congiungimenti e rimandano in quanto tali, cioè in quanto non
sono meri insiemi di dati privi di nesso, al fenomeno originario della contiguità
temporale nelle sue due forme: successione come operazione originariamente
ordinante e cosistenza come compresenza di ciò che è collegato. È solo all’interno di un contesto di coesistenza e successione che possono darsi i collegamenti unificanti derivanti da omogeneità e contrasto. Questo principio rivela il
ruolo della temporalità nella sintesi passiva. La datità, in quanto tale, è già in sé
temporalmente estesa ed è dotata di continuità interna oggettiva, che si basa
sulla continuità di un’estensione, di una durata. È grazie alla struttura temporale interna e materiale del dato che esso può fondersi esternamente in una
sintesi di continuità con altri dati. Anche nella coesistenza, la gradazione continua (Abstufung) della qualità o delle intensità può essere rappresentata come
un continuo di somiglianza del dato con se stesso nel decorso temporale.
Husserl mostra come l’associazione possieda già in sé una componente formale temporale e come questa si leghi strettamente con quella materiale. La
temporalità risulta fusa e inseparabile dal flusso delle datità preoggettuali: la
temporalità e il flusso si presuppongono a vicenda. Come Husserl stesso
sostiene, “l’intera dottrina della coscienza interna del tempo è il prodotto di
un’astrazione idealizzante (begrifflichen Idealisierung)”17, senza, si potrebbe
aggiungere, il completamento della fenomenologia dell’associazione. A questo
livello della costituzione il flusso delle datità coincide con il tempo delle datità,
che si può scindere solo mediante un’astrazione da ciò cui è indissolubilmente
legato. Viceversa, senza una soggiacente costituzione temporale, l’associazione costituirebbe sempre un passato o un presente riprodotto e senza tempo.
La costituzione temporale formale, nel senso suddetto, è la temporalità oggettiva come forma fondamentale di ogni coscienza capace di atti oggettivanti.
Husserl sostiene che le leggi dell’associazione originaria forniscono “le
condizioni di possibilità della formazione di unità iletiche, mentre la formazione
stessa dell’unità, la formazione effettiva di singoli gruppi o di singoli dati iletici
che esistono per sé dipende ancora dal fattore dell’affezione”18.
L’affezione è definita da Husserl come uno stimolo (Reiz), “un impulso che
trova soddisfazione e che da qui si dispiega nella tendenza verso l’intuizione
originariamente offerente, nella tendenza che disvela sempre più il se stesso
oggettuale, nella tendenza verso la presa d’atto (Kenntnisnahme), verso
l’osservazione più dettagliata dell’oggetto”19. L’affezione si innesta sull’associazione mediante il concetto di emergenza e la innerva, configurandosi come
insieme di tendenze che percorrono e motivano i nessi associativi. La caratteristica fondamentale della legalità affettiva consiste nella capacità di quest’ultima di propagarsi da un contenuto iletico ad un altro, secondo le condizioni predelineate dai nessi puramente passivi già sussistenti, e di saldare il legame tra
SAGGI
le datità in questione attirando la coscienza sul loro rapporto associativo.
L’affezione si propaga attraverso i nessi associativi coesistenti o successivi,
essa può trasmettersi dal presente impressionale al passato ritenzionale, ridestando quest’ultimo alla coscienza. L’affezione permette, inoltre, anche lo
spostamento verso il futuro: il percepito pone la soggettività in attesa del suo
decorso futuro, offrendo alle attese protenzionali un contenuto che appartiene
al presente o al passato. “Proprio per questo –sostiene Husserl– l’affezione
possiede, riguardo alla direzione della propagazione, una tendenza unitaria
diretta verso il futuro, e per lo stesso motivo, l’intenzionalità è prevalentemente
orientata verso il futuro”20. Ciò che è atteso non è solo un vuoto istante temporale futuro, ma è contenutisticamente determinato sul piano protenzionale.
I risultati di queste indagini sono rilevanti anche per il rapporto tra attività e
passività, e, in particolare, per il passaggio dall’una all’altra. Nella passività
affezionale abbiamo a che fare, paradossalmente, con una passività operante
e costituente e un’attività soggettiva passiva e pre-afferrante, essenzialmente
affettiva. Questa sorta di “inversione di ruoli” rappresenta il punto di contatto
più stretto tra attività e passività.
Nel momento in cui il soggetto cede all’affezione e si dirige attivamente
all’oggetto per afferrarlo (erfassen), sorge il momento della ricettività
(Rezeptivität), definita da Husserl come il livello più basso di attività, il livello in
cui si verifica la vera e propria esplicitazione dei nessi passivi e la presa di
coscienza, da parte della soggettività, di ciò che si era costituito prima di ogni
suo operare. La ricettività appartiene ancora alla sfera della passività, in quanto si contrappone alla spontaneità, ma si differenzia dalla passività pura. Nella
ricettività, infatti, l’esperienza si impone all’io, conducendo davanti ad esso
oggetti formati, ponendosi come ponte di passaggio dalla passività all’attività:
“il concetto fenomenologicamente necessario di ricettività non si trova affatto
in opposizione assoluta all’io, espressione che deve comprendere tutti gli atti
che in senso specifico provengono dal polo-io; piuttosto bisogna guardare la
ricettività come il grado più basso di attività”21.
La ricettività conduce davanti all’io oggetti che si contrappongono ad esso:
nella costituzione dell’oggetto interviene la soggettività, che non si limita, come
nella fase preoggettuale, a dirigersi verso un nuovo momento percettivo secondo le linee prefissate dai nessi associativi nell’esperienza puramente passiva, ma tiene costantemente sotto presa anche le fasi decorse del processo,
legandole di volta in volta al presente. La struttura temporale della ricettività è
anticipata dal ridestamento affettivo della temporalità oggettiva e passiva, ma
non coincide con quest’ultima. Gli istanti passati sono tenuti sotto presa e
vanno a costituire i termini di una sintesi di identificazione continua, che permette di “tenere fermo” l’oggetto e “lasciar scorrere” il tempo: “solo sul fondamento di questo mantenere sotto presa (Im-Griff-behalten) attivo-passivo,
l’oggetto può essere colto in una percezione schietta come oggetto che dura,
ossia come un oggetto che non è solo ora, ma che era lo stesso anche prima
e che sarà pure lo stesso nel prossimo ora”22. L’oggetto permane identico nel
continuo mutare delle sue manifestazioni: l’identità dell’oggetto si distacca dal
mutare del tempo23.
13
14
L’appercezione, l’atto oggettivante che coglie la manifestazione dell’oggetto, non si risolve nel carattere intenzionale dell’atto stesso, ma consiste nell’attualizzazione delle strutture passive dell’esperienza ai fini della costituzione
del presente e del passato. L’affezione si propaga a rappresentazioni vuote e
ai nessi associativi di queste con rappresentazioni piene attuali e produce: da
un lato, la costituzione dell’oggettualità presente a partire dalla unità affettive
preoggettuali non solo coesistenti, ma anche successive; dall’altro lato, la
ricostituzione del passato nella forma della rimemorazione. La rimemorazione,
come atto oggettivante permette la presentificazione di contenuti passati
tramite il riempimento di una ritenzione, operando una sintesi di identificazione
tra una rappresentazione piena presente e una rappresentazione vuota, contenuto della ritenzione. La rimemorazione inverte il processo di modificazione
ritenzionale, nel quale una rappresentazione si svuota progressivamente dalle
sue determinazioni nella catena di ritenzioni, sprofondando nell’orizzonte
vuoto del passato. Nella dinamica dell’esperienza come progressivo adombramento dell’oggetto nei suoi momenti e nelle sue parti, è di fondamentale
importanza la rimemorazione nella costituzione non solo del passato, ma
anche del presente, per la sua funzione di collegare le manifestazioni del
medesimo oggetto passate a quelle presenti.
Inoltre, sul piano della passività affezionale, le attese protenzionali si limitavano a orientare il processo esperienziale, determinandone il senso, al livello della ricettività, invece, le attese si attualizzano in posizioni di interesse,
ossia in una tendenza attiva del soggetto, in cerca di riempimento per le intenzioni vuote, verso una sempre più determinata apprensione (Auffassung) dell’oggetto. I decorsi percettivi che, sul piano della passività erano semplicemente attesi, divengono meta adesso di un interesse attivo del soggetto che
intenziona in maniera vuota.
Qui è possibile vedere all’opera due diverse forme di temporalità che si
intrecciano: la temporalità oggettiva, nella quale l’oggetto permane identico
per la coscienza sotto forma di flusso di datità unificate, e la temporalità
soggettiva del susseguirsi delle sue manifestazioni. La temporalità oggettiva è
una componente della genesi temporale degli oggetti, ma la loro tematizzazione dipende dalla coscienza che temporalizza soggettivamente le loro
manifestazioni, organizzandole in un processo finalizzato alla conoscenza
compiuta degli oggetti. La costituzione dell’atto intenzionale della comprensione, come atto oggettivante, rappresenta il punto di passaggio dalla presenza di un’unità affetiva preoggettuale alla manifestazione di un oggetto in senso
proprio. L’essere costituito dell’oggetto rispetto al flusso delle datità è la condizione indispensabile del suo essere per una coscienza. In Erfahrung und
Urteil, Husserl fa l’esempio del tavolo percepito e di quello rimemorato:
entrambe le oggettualità sono presenti insieme nel tempo soggettivo, ma
appartengono a decosi percettivi differenti nel tempo oggettivo 24. L’idealità dell’oggetto consiste nella sua indipendenza dal flusso delle datità, garantita dal
senso donato alle sue manifestazioni: l’identità dell’oggetto consiste nel
riconoscimento del medesimo senso nelle sue manifestazioni. L’appercezione
è strettamente legata alla donazione di senso: è dal loro rapporto che dipen-
SAGGI
dono l’identità dell’oggetto al di là delle sue manifestazioni sempre parziali e
l’attribuizione a se stessa dei propri atti oggettivanti da parte della coscienza25.
“Tutti gli oggetti sono necessariamente dati in una temporalità, e questa
temporalità si costituisce come determinazione dell’identico senso oggettuale”26. La “medesimezza” del senso oggettuale garantisce che l’identico
oggetto nella molteplicità delle sue apparizioni, nelle percezioni e nelle rimemorazioni, sia inseparabile dalla sua collocazione nella temporalità oggettiva: “il
senso oggettuale e il senso temporale, che lo accompagna, costituiscono
un’unità del senso che coappartiene ad entrambi, e da entrambi scaturisce il
modo di essere”27. Il senso oggettuale permette il riconoscimento di un oggetto nella rimorazione e la conservazione della sua posizione nell’ordinamento
temporale. È tramite la rimemorazione che è possibile separare i vissuti che
sono manifestazioni di un oggetto conosciuto dal flusso delle datità, in modo
tale che essi contribuiscano al processo costitutivo. Un contenuto oggettuale
resta tale indipendentemente dal suo essere percepito perché può essere
rimemorato.
3. Affezione e ricettività: la costituzione della coscienza
Le considerazioni effettuate finora permettono di individuare nel rapporto
tra affezione e temporalità il nodo teorico fondamentale della tematica della
genesi: a partire dallo studio di questo rapporto è possibile gettare luce sulla
dicotomia attività-passività e, in generale, sulla modificazione della nozione di
coscienza proposta da Husserl nel contesto della fenomenologia genetica.
Per Husserl il termine “passivo” ha una doppia possibilità di significato.
Questo termine può indicare il subire qualcosa nel senso della passione o del
patimento, e può anche indicare una situazione in cui qualcuno non partecipa
ad uno stato di cose e resta inoperoso o inattivo in qualità di osservatore esterno. Quest’ultimo significato si ricollegherebbe bene alla radice etimologica del
verbo tedesco auftreten, utilizzato da Husserl per indicare il modo di darsi
della datità originale, coinvolta nei processi associativi, rispetto alla quale il
soggetto è appunto uno spettatore passivo.
Il primo dei due significati del termine emerge in alcune opere husserliane
precedenti al periodo delle lezioni contenute nelle Analysen, ossia prima del
1918. Nella Philosophie der Aritmetik si parla di “ricezione passiva” di contenuti pre-dati28: quando gli elementi fondamentali di una relazione sono dati,
non è necessario alcun atto di pensiero per apprendere la relazione stessa
che intercorre tra essi, perché questa non è il risultato di un atto relazionante29.
Nelle Ideen, la sintesi originata dalla coscienza del tempo viene esclusa dalle
sintesi attive di coscienza perché non consiste in “una sintesi attiva e discreta”, ma è recepita come lo sono i dati iletici30. Quest’ultima anticipazione è
molto importante.
Il secondo dei significati in questione emerge per lo più dopo il 1918, con
lo sviluppo della problematica delle genesi, in riferimento alle sintesi associative nella temporalità oggettiva. Le datità iletiche emergono dai dati con-
15
16
trastanti e si fondono col simile dando vita a relazioni fondate sulla natura contenutistica del dato, prima che l’io si rivolga ricettivamente ad essi. In questa
situazione l’io non compie alcun intervento istituente o ponente.
Sempre dopo il 1918, il primo significato non viene abbandonato, ma viene
recuperato in relazione alla nozione di ricettività, per caratterizzare la quale
Husserl utilizza una terminologia già presente in Kant: “rispetto alla rappresentazione il mio animo (Gemüt) o è operante (handelnd) e mostra capacità
(facultas) o è patente (leidend) e consiste nella ricettività (Empfänglichkeit receptivitas). […] Le rappresentazioni, rispetto alle quali l’animo si rapporta
subendole, dalle quali il soggetto viene affetto (affiziert) […], appartengono alla
sensibilità, quelle invece che contengono un puro fare (il pensiero) appartengono alla capacità di conoscenza intellettuale. […] Quella ha il carattere della
passività (Passivität) del senso interno delle sensazioni, questa la spontaneità
dell’appercezione, cioè della pura coscienza dell’operare che produce il pensiero”31.
Husserl considera la ricettività come un dirigersi rilevante dell’io su ciò da
cui è affetto e critica Kant per aver risolto la ricettività nel puro essere affetto.
La ricettività è la forma più primitiva di attività dell’io e, attraverso essa, qualcosa che prima era presente alla coscienza in modo anonimo, viene oggettualmente e tematicamente posto per la coscienza. L’affezione potrebbe
essere considerata come un momento attivo nella costituzione degli oggetti,
ma essa, a differenza della ricettività, è priva di qualsiasi riferimento all’io
come polo dei vissuti ed è riferita alla soggettività in generale. Proprio per il
suo riferimento all’io, la ricettività sembra proporsi come vero spartiacque tra
l’attività e la passività. Tuttavia, la distinzione posta da Husserl tra essere affetto ed essere ricettivo, momenti che si identificano nell’estetica trascendentale
di Kant, permette di approfondire la nozione di ricettività e di indagare ulteriormente il rapporto tra passività e attività 32.
La ricettività opera con due tipi di datità differenti. Da un lato, essa si esplica sulle unità affettive preoggettuali, organizzate secondo la legalità dell’associazione e della costituzione originaria temporale, e, in questa veste, costituisce il fenomeno dell’apprensione finalizzato alla presa d’atto e alla comprensione dell’oggetto a partire dalla predatità. Dall’altro lato, la ricettività offre
“passivamente”, nel dirigersi comprendente dell’io, oggetti costituiti, sui quali
non esercita ancora alcuna attività spontanea e che costituiscono il punto di
partenza dell’operare categoriale33. L’esperienza ricettiva non solo rende
disponibili gli oggetti all’operare dell’io, ma ne predelinea l’esplicitazione sulla
base degli orizzonti interni ed esterni dell’oggettualità: la ricettività predelinea
la possibilità da parte dell’io di portare l’oggetto a manifestazioni diverse da
quella iniziale, cioè a nuove manifestazioni e, di conseguenza, a nuove rappresentazioni in grado di mostrare l’oggetto in tutte le sue determinazioni, in tutti
i suoi lati e prospettive. Ogni esperienza ricettiva lascia quindi aperti all’attività
dell’io i passaggi ad altri gruppi di manifestazioni.
Vi sono, tuttavia, processi percettivi, come le cinestesi, che attualizzano
queste possibilità senza la necessità di un volgersi attivo dell’io: ad esempio,
il movimento degli occhi rivolto all’oggetto, ma non ancora attenzionalmente e
SAGGI
appercettivamente. La dicotomia attività-passività non coincide quindi con la
distinzione tra attualità e inattualità per la coscienza fissata nel secondo volume delle Ideen: ci sono modi dell’intenzionalità che sono puramente passivi
e fungenti, ma attuali, come appunto le cinestesi 34. Husserl parla, a questo
proposito, di attività dell’io in cui l’oggetto non è ancora possesso stabile della
coscienza e nelle quali l’interesse conoscitivo non è ancora volontà conoscitiva: le sintesi di raffigurazione possono essere così concepite, in quanto operazioni in cui un atto intenzionale è reso pieno, senza che vi sia una vera e propria sintesi di riempimento e una più precisa determinazione di un oggetto
riconosciuto come identico e perdurante nel tempo nella serie degli atti
appercettivi 35.
Tutto questo getta luce su quanto già detto sul rapporto tra sintesi passiva
e sintesi attiva, oggettuale e categoriale. Il soggetto viene a essere parte del
processo della genesi e non si limita a intervenire in esso marcando la linea di
confine tra attività e passività: questa dicotomia emerge nella genesi stessa,
ma non la precede. La passività non coincide con l’assenza di partecipazione
del soggetto alla costituzione, né l’io si limita a interventi esterni al processo
costitutivo, come dimostrano l’affezione e la ricettività che designano processi
che avvengono comunque per una coscienza e nella coscienza. La genesi è al
contempo costituzione dell’oggetto e anche del soggetto, in quanto in essa si
producono tanto l’oggetto quanto l’atto oggettivante che lo comprende: è per
questo motivo che Husserl parla di genesi della costituzione 36. La genesi si propone come processo che include contemporaneamente la costituzione dell’oggetto e la genesi dell’atto oggettivante che lo comprende e ciò significa che,
se è vero che l’atto oggettivante è necessario ad accogliere la manifestazione
dell’oggetto, è altrettanto vero che l’accesso all’oggetto dato fa parte dell’essere
dell’oggetto stesso 37. Se così non fosse l’io trascendentale interverrebbe su
materiale offerto passivamente e opererebbe solo mediante sintesi attive nella
costituzione attiva di oggetti, configurando un doppio livello genetico nel quale,
accanto alla costituzione passiva, troverebbe posto un’istanza di tipo kantiano
e il processo della genesi perderebbe la sua unità e continuità38.
A conferma di questa tesi sta anche il fatto che passive non sono solo le
unità affettive preoggettuali o singole predatità: anche tutte le operazioni costitutive sorte dall’attività stessa dell’io, appena terminata la loro esecuzione
attuale, possono essere considerate passive. Un esempio è dato dal ricordo
emergente affettivamente che si origina dal ricadere di una costituzione oggettuale nella passività e che è associativamente ridestato dalla serie delle modificazioni ritenzionali. Si tratta della rimemorazione come puro apparire nel
ricordo, che è un operare passivo dell’io che non produce nulla, ma richiama,
sulla base di nessi associativi e grazie alla trasmissione dell’affezione, rappresentazioni vuote ritenzionate, selezionando poi quelle che saranno sottoposte a sintesi di identificazione con rappresentazioni piene attuali e quindi
ripresentate. Il puro apparire nel ricordo si configura come l’equivalente sul
piano ritenzionale del mero render pieno di atti intenzionali.
L’inattività non coincide quindi con la Ichlosigkeit, l’assenza dell’io: l’io può
partecipare non attivamente ma passivamente in quanto costantemente pre-
17
18
sente. La costituzione passiva ha luogo “senza partecipazione attiva dell’io”,
“senza partecipazione dell’io attivo”, e tuttavia “con partecipazione passiva
dell’io”39. I decorsi percettivi passivi avvengono quindi senza partecipazione
attiva dell’io, ma sono ugualmente soggettivi nel senso che si verificano e
sono tali per un soggetto40.
Per Husserl la coscienza non coincide immediatamente con l’autocoscienza: al contrario di quanto sostenuto nella metafisica classica da Cartesio a
Kant, e anche in empiristi come Locke e Hume, Husserl sostiene che non tutto
ciò che avviene per una coscienza avviene per un io. Coscienza per Husserl
non significa conoscenza di sé, possesso di sé e coincidenza con sé nei contenuti di coscienza. Possiamo dire che le sintesi passive sono decorsi preoggettuali soggettivi, ma non egologici, e la loro “soggettività” consiste nel fatto
che in qualsiasi momento possono essere afferrati attivamente dal soggetto
che le recepisce come affettivamente rilevanti. Questa tesi ci permetterebbe di
concludere che la soggettività trascendentale è più estesa rispetto all’io
trascendentale. Questa distinzione è assente in un’opera dall’intento sistematizzante come le Cartesianische Meditationen o nella Krisis. Tuttavia, essa
sembra coerente con l’approccio teorico delle Analysen, opera in cui Husserl
identifica la costituzione passiva con la capacità di immaginazione di Kant,
tenendo presente la prima edizione della Critica della ragione pura, nella quale
la Einbildungskraft era considerata come facoltà autonoma dall’intelletto, a differenza della Krisis, nella quale, seguendo la seconda edizione della stessa
opera, Husserl tratta dell’intelletto doppiamente fungente, considerando la
capacità di immaginazione come l’effetto dell’operare dell’intelletto sulla sensibilità41.
Nella Krisis e nelle Cartesianische Meditationen Husserl lega più strettamente all’io trascendentale la sintesi passiva e l’intera tematica della costituzione, interpretando la genesi come un processo comprensibile esclusivamente a partire dal suo prodotto finale, nel quale si realizza l’atto trascendentale di costituzione genetica nel suo significato intenzionale ed eidetico. Nelle
Analysen, invece, sono le forme e condizioni di possibilità della genesi, in
primo luogo la temporalità, che la rendono comprensibile: la genesi non è in
quest’opera considerata indipendente dal suo termine teleologico, ma non è
neanche vincolata ad esso42.
I processi che si verificano nella sfera della pura passività sono soggettivi
perché fondati sulla struttura fondamentale della soggettività: l’intenzionalità.
Le datità preoggettuali sono per un soggetto e sono comunque intenzionate,
ma la loro presenza, al contrario della manifestazione di oggetti, non presuppone nessun atto riferito ad un io-polo di Erlebnisse: per questo motivo
Husserl parla di un’intenzionalità “passiva” e “latente” (fungierende
Intentionalität), alla quale pertiene la capacità di trasformarsi in intenzionalità
attiva e afferrante43.
“Con ciò si vuol dire che la distinzione tra attività e passività non è una distinzione rigida, che questi due termini non possono essere trattati come stabiliti definitoriamente una volta per tutte, ma questa distinzione è solo un
mezzo per descrivere e mettere in evidenza un contrasto, il cui senso deve
SAGGI
essere determinato originariamente di nuovo a seconda del caso singolo,
riguardo alla concreta situazione dell’analisi. Questa osservazione vale per
tutte le descrizioni dei fenomeni intenzionali”44.
Data la relatività della dicotomia tra attività e passività, attestata nel passo
citato, è opportuno tentare di portare il problema su di un piano a partire dal
quale risulti comprensibile ed eventualmente chiarificabile nella sua articolazione. Il tentativo è quello di portare la dialettica attività-passività sul piano
della temporalità, non per definirne i termini, ma, coerentemente con le intenzioni di Husserl, per comprenderne la motivazione interna.
4. Temporalità e affezione nella genesi passiva
Nella passività non abbiamo a che fare con una coscienza del tempo a livello eidetico e noematico, come nelle lezioni del 1905 45, né con una coscienza costituente il tempo e i nessi temporali, ma con una genesi temporale dell’oggettualità e della soggettività trascendentale. Nel momento in cui la soggettività è prodotta essa stessa nella temporalità di una sintesi originaria, si introduce il tema della genesi nella sfera della riduzione fenomenologica, che
adesso non riguarda più soltanto gli oggetti e le essenze, ma anche la
coscienza come ego sottoposto a riduzione. Il tempo non è la forma della genesi, ma è la genesi stessa. La passività si configura come condizione della
possibilità della costituzione di oggetti e anche come condizione della possibilità della soggettività stessa. Husserl abbandona quindi la dialettica tra temporalità costituente e temporalità costituita a favore di una temporalità immanente 46 come struttura apodittica dell’esperienza e della genesi che si articola
in temporalità oggettiva e soggettiva.
La temporalità assume quindi una doppia valenza ontologica e gnoseologica, perché coincide con il modo stesso in cui si svolge la genesi e con la
modalità di comprensione della genesi stessa. La spazialità, invece, non
assume il medesimo rilievo teorico perché comporta un riferimento all’attività
dell’io attraverso la nozione di cinestesi: la spazialità è sì un momento costituente, ma si comprende a partire dalla nozione di coesistenza.
Nel testo 54 del volume X dell’Husserliana, contenente lezioni risalenti a
prima del 1911, Husserl aveva già parlato della difficoltà, già emersa a proposito della critica a Brentano, di conciliare il tempo delle manifestazioni che fissano gli oggetti temporalmente, e quello degli oggetti: “è dunque evidente che
le apparizioni che costituiscono il tempo sono in via di principio delle oggettualità diverse rispetto a quelle costituite nel tempo, che esse non sono oggetti individuali o processi individuali, e che non possono venire loro sensatamente attribuiti i predicati di quelli. Perciò non può neppure avere senso dire
(e nello stesso senso) che essi sono nell’ ‘ora’ e che fossero prima, che si
siano susseguite cronologicamente o che siano simultanee”47. Qui Husserl
parla del rapporto tra la coscienza costituente il tempo e il tempo costituito.
L’approfondimento teorico nelle Analysen è evidente se si confronta questo
passo con quello di Erfahrung und Urteil, citato precedentemente48, nel quale
19
20
Husserl faceva l’esempio del tavolo rimemorato e di quello percepito: entrambi gli oggetti sono presenti insieme nel tempo soggettivo, ma riguardano
decorsi percettivi appartenenti a due periodi diversi del tempo oggettivo. Il
problema diviene quello della temporalità stessa delle manifestazioni che costituiscono gli oggetti nel tempo, e, soprattutto, quello di conciliare il flusso dei
vissuti con il tempo della coscienza, la quale isola in esso delle unità stabili,
che appartengono al flusso in quanto prodotti dalle predatità che in esso si
danno, ma sono ripresentabili indipendentemente dal flusso stesso. Lo statuto temporale degli oggetti viene a dipendere strettamente da quello del
soggetto e, più in generale, dalla concezione del tempo che si adotta.
Nel 1905 Husserl era stato indotto da questo problema a teorizzare una
coscienza intemporale in grado di costituire i vissuti nel tempo e il tempo stesso, non essendo a sua volta temporale. La coscienza costituente originariamente il tempo era intesa come pura attualità, come “presente originario”
(Urgegenwart), un presente non inteso come modalità del tempo. Husserl
prese in considerazione in quel periodo anche l’idea di una autotemporalizzazione della coscienza, secondo la quale la coscienza costituente il tempo e
quella costituita temporalmente coincidevano.
Il nodo teorico che Husserl scioglie col progressivo sviluppo della tematica
della genesi riguarda il rapporto tra temporalità della coscienza e coscienza
del tempo, istanze che aveva tentato di far coincidere in un’unica coscienza
atemporale, non riuscendo, però, a spiegare il rapporto tra le fasi del flusso
della coscienza costituente, sviluppantesi esse stesse temporalmente, e le
fasi del flusso di coscienza costituite nel tempo.
A partire dagli anni venti Husserl separa i due momenti della temporalità
della coscienza, e di ciò che ad essa si offre, e della coscienza del tempo: il
fenomeno originario e la sintesi originaria del tempo non è più opera della
coscienza, ma è la componente fondamentale della genesi della coscienza
trascendentale. La coscienza del tempo non opera più le sintesi originarie del
tempo che avvengono nella sfera della passività, e diviene secondaria 49 rispetto alla più fondamentale temporalità della coscienza. Le sintesi temporali passive precedono la coscienza di queste sintesi stesse, come la temporalità della
coscienza precede la coscienza del tempo: tutto questo presuppone il fatto
che è la stessa nozione di coscienza ad essere profondamente modificata.
Gli elementi che permettono la revisione dell’idea di tempo sono due: la
modificazione dei concetti di temporalità oggettiva e temporalità soggettiva, e
la tesi circa la necessità del loro rimando reciproco.
La temporalità oggettiva si fonda sulla dinamica ritenzione - impressione
originaria - protenzione, che forma il flusso dei vissuti e non è un contenuto del
flusso. Il presente non è costituente, perché emerge da un passato già costituito e si radica in esso, ponendosi come presente solo sullo sfondo di una
continuità già data. Tutto ciò non implica, tuttavia, che l’oggettività del tempo
sia un’indipendenza dalla coscienza, perché, come detto, per Husserl sarebbe
impossibile spiegare la temporalità della coscienza a partire da un semplice
tempo naturale e trascendente.
La temporalità genetica delle Analysen è un tempo più originario di quello
SAGGI
dell’immanenza vissuta delle lezioni del 1905. La temporalità genetica, infatti,
si oppone alla temporalità noematica e corrisponde al modo stesso in cui si
sviluppa la genesi: la temporalità effettivamente vissuta, in cui hanno luogo le
sintesi temporali da cui la soggettività è affetta, è sempre costituente nella sua
duplice articolazione oggettiva e soggettiva e non è mai costituita da un’idealità trascendentale fondata sulle facoltà del soggetto. La genesi è quindi tempo
ed è il modo in cui la coscienza si articola costituendo passivamente se stessa e i vissuti come tempo.
“L‘ego si costituisce nell’unità di una storia; e se noi abbiamo detto che nella
costituzione dell’ego sono incluse le costituzioni degli oggetti che sono per lui,
sia immanenti che trascendenti, ideali che reali, è ora da aggiungere che i sistemi costitutivi, per i quali sono nell’ego certi oggetti e certe categorie di oggetti, hanno la loro possibilità solo entro i limiti di una genesi secondo leggi”50. La
legalità essenziale della genesi è costituita dal tempo, “pertanto il mondo è un
problema egologico universale e parimenti, considerato secondo una direzione
pura immanente dello sguardo, esso è l’intera vita della coscienza nella sua
temporalità immanente”51. Queste citazioni ci permettono di introdurre
adeguatamente il tema della necessità del rimando reciproco di temporalità
soggettiva e temporalità oggettiva, ovvero del rapporto tra coscienza e temporalità costituente. La tesi fondamentale di Husserl riguardo a questo rapporto è
che le condizioni trascendentali soggettive della genesi debbono essere a loro
volta temporali affinché si abbia una genesi trascendentale dell’oggettualità,
secondo le direttive indicate nel passo sopra citato. È necessario chiarire quindi in che modo le condizioni soggettive della genesi siano temporali.
Mediante la donazione di senso l’atto oggettivante diventa appercettivo,
diviene un atto riconosciuto dalla coscienza come proprio: la temporalità
soggettiva subentra quando l’io temporalizza l’appercezione ed è affetto da se
stesso, ovvero è ricettivo rispetto a se stesso come atto o serie di atti; dato che
l’atto oggettivante e intenzionale in quanto tale è temporale in virtù della sua
struttura predelineante e preafferrante, che lo predispone a una direzionalità
nel tempo, la coscienza obbiettiva e tematizza se stessa come tempo e si costituisce come temporalità in una forma diversa dalla temporalità della costituzione degli oggetti e del flusso dei vissuti.
“Husserl si distingue da Kant per il fatto che la soggettività assoluta, l’io
trascendentale, non è esso stesso un’attività in sé senza tempo, che costituisce da fuori l’unità formale del tempo, ma sta essa stessa in una temporalità
immanente, che la costituisce come sua fonte originaria”52.
La dimensione passiva si presenta come dimensione non egoica della
coscienza, ovvero come soggettività passiva e affettiva: solo così si può spiegare l’oggettività del tempo e il suo rapporto necessario con la coscienza. La
temporalità oggettiva, infatti, non è posta dalla coscienza, ma è comunque tale
solo per una coscienza. Husserl apre la strada ad una soggettività non centrata sull’ego, ma sull’affettività-ricettività, per la quale le predatità del mondo della
vita sono date “nella forma universale permanente della temporalità, poiché
quest’ultima si costituisce in una genesi costantemente passiva e interamente
universale comprendente in maniera essenziale ogni elemento nuovo”53.
21
22
La temporalità soggettiva si costituisce per la soggettività egoica allo stesso
modo in una costituzione passiva: la coscienza obbiettiva se stessa auto-affettivamente come atto appercettivo prima di ogni attività dell’io, cioè preriflessivamente. La soggettività preriflessiva e preegoica è “cosciente” di sé come
tempo, non in virtù di un atto ponente, ma perché è affetta da sé come tempo:
l’accesso alla temporalità costituente, nella sua duplice articolazione oggettiva
e soggettiva, è determinato dall’affezione. Di conseguenza si può anche dire
che “la coscienza del tempo non è una riflessione sul tempo, ma è la temporalizzazione stessa: il dopo della coscienza è il dopo del tempo stesso”54.
Rispetto alle lezioni sulla coscienza interna del tempo del 1905, nelle
Analysen muta la concezione del tempo e con essa anche la nozione di
coscienza ne esce profondamente modificata: mentre nelle prime la coscienza ultima si configura come intemporale e “ponente”, nelle Analysen la
coscienza originaria del tempo, nella sua dimensione passiva, risulta “patente”
e priva di connotati attenzionali e tetici, e precede una coscienza attiva derivata del tempo astraente e idealizzante.
Questa soluzione teorica sembra essere già adombrata da Husserl nelle
stesse lezioni del 1905 dove aveva parlato di “coscienza interna” o “coscienza originaria” (Urbewußtsein): una (auto-)coscienza che non può essere
colta in se stessa attenzionalmente, ma solo a distanza in manifestazioni di
oggetti ad essa iscritte nel tempo. “Bisogna però seriamente riflettere se sia
necessario assumere una coscienza ultima che sarebbe necessariamente
‘inconscia‘; infatti, in quanto intenzionalità ultima, essa non può essere
oggetto d’attenzione (se fare attenzione presuppone un’intenzionalità già
data) quindi non può mai, in questo caso particolare giungere alla coscienza”55. La soluzione di Husserl a questo problema è, nelle Analysen, data dall’affezione, per la quale questa coscienza sarebbe “inconscia” perché puramente affettiva e sarebbe costituita, come tempo nel tempo, come flusso di
vissuti senza essere presente a se stessa, proprio per la sua capacità di
essere affetta dalla temporalità costituente oggettiva del flusso delle predatità e da se stessa come temporalità costituente soggettiva delle manifestazioni oggettuali. L’intenzionalità ultima, che non potrebbe essere intenzionale nel senso dell’atto oggettivante, perché muovente da un terreno che
precede la costituzione di esso, viene risolta nell’affezione. Quest’ultima
condivide con l’intenzionalità alcune caratteristiche: la direzionalità verso un
dato, in quanto è costituita da un impulso che trova soddisfazione nel dato
come l’intenzione trova riempimento nell’oggetto56, essa può essere effettiva
o potenziale allo stesso modo in cui l’intenzione può essere attuale o d’orizzonte. Ciò che differenzia l’affezione dall’intenzionalità è la sua mancanza di
direzionalità teleologica e, soprattutto, il suo prodursi a partire da una dimensione di passività, nel senso della passione e del patimento, e non a partire
da una spontaneità.
Nella manifestazione di oggetti trova compimento la costituzione passiva e
mediante essa la coscienza può avere consapevolezza della temporalità
oggettiva e della temporalità dei suoi atti intenzionali. L’esperienza del presente vivente si conferma così non solo il necessario punto di partenza di ogni
1
HU XIX, 2, pp. 572 sg., trad. it., p. 338. Per quanto riguarda le opere di Husserl si è tenuta
presente l’edizione pubblicata nella collana: Husserliana – EDMUND HUSSERL, Gesammelte Werke,
Den Haag – Dordrecht / Boston / Lancaster, Martinus Nijhoff (dal volume XXVII: Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht / Boston / London). I testi citati vengono identificati in base al numero del
volume nel quale sono inseriti con le seguenti abbreviazioni: Analysen zur passiven Synthesis.
Aus Vorlesungs – und Forschungsmanuskripten (1918-1926): HU XI; Logische Untersuchungen.
Zweiter Band: Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. Zweiter Teil: HU
XIX, 2; Ding und Raum. Vorlesungen 1907: HU XVI; Cartesianische Meditationen und Pariser
Vorträge: HU I; Zur Phänomenologie der Intersubjectivität. Zweiter Teil: 1921-1928: HU XIV;
Philosophie der Arithmetik. Mit ergänzenden Texten (1890-1901): HU XII; Ideen zu einer reinen
Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in
die reine Phänomenologie. 2. Halbband: Ergänzende Texte (1912-1929): HU III, 2; Ideen zu einer
reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Zweites Buch:
Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution: HU IV; Die Krisis der europäischen
Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie: HU VI; Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins (1893-1917): HU
X; Formale und transzendentale Logik: HU XVII. Erfahrung und Urteil. Untersuchung zur
Genealogie der Logik, redatte ed edite da L. Landgrebe (1939), Meiner Verlag, Hamburg 1985
viene citato come EU.
2
Cfr. HU XI, pp. 79 sgg., trad. it., pp.124 sgg.. Cfr. anche HU I, p. 84, trad. it., p.75.
3
HU XI, p. 91, trad. it., pp. 137 sg.
4
HU XVI, p. 141. Il carattere preafferrante, come momento essenziale e imprescindibile dell’atto intenzionale, fa assumere a quest’ultimo il valore trascendentale di apertura che Heidegger
aveva segnalato nei suoi Grundprobleme der Phänomenologie (1927).
5
HU XIV, p. 41. Cfr. anche R. BERNET, I. KERN, E. MARBACH, Edmund Husserl, Felix Meiner
Verlag, Hamburg 1989, trad. it., Il Mulino, Bologna 1992, p. 255.
6
Cfr. HU XI, pp. 336-346.
7
HU XI, p.128, trad. it., pp. 180-181.
8
Qui non si tratta però dell’apriori materiale descritto in Formale und transzendentale Logik e
in Erfahrung und Urteil, ma di ciò su cui esso è fondato, ad un livello antepredicativo.
9
HU XI, p. 118, trad. it., p. 170.
10
HU XI, p. 218, trad. it., p. 285.
11
Cfr. HU I, p. 17.
12
HU I, p. 79.
13
HU XI, p. 275.
14
La genesi si propone come chiarimento di un’origine e non come fondazione mediante principi che presuppongono un’egoità trascendentale o che sono comunque riferibili ad essa. Nelle
Analysen, la legalità della genesi coincide con le condizioni di possibilità dell’esperienza e degli
oggetti dell’esperienza, tuttavia, queste condizioni non strutturano l’esperienza dall’esterno e
possono darsi solo nell’esperienza stessa, perché non sono fondate su una coscienza trascendentale esterna al processo genetico. Sul problema dell’autostrutturazione e autoorganizzazione
dell’esperienza si possono consultare: E. MARBACH, Reine und angewandte Phänomenologie.
Überlegungen zur Rolle der Erfahrung in Husserlscher Sicht, in J. FREUDIGER, A. GRAESER, K.
PETRUS (a cura di), Der Begriff der Erfahrung in der Philosophie der 20. Jahrhunderts , C. H. Beck,
München 1996, pp.133-152; T. SEEBOHM, Die Bedingungen der Möglichkeit der
Transzendentalphilosophie. Edmund Husserls transzendental-phänomenologischer Ansatz,
dargestellt im Anschluß an seine Kant-Kritik, Bouvier, Bonn 1962, e D. LOHMAR, Erfahrung und
kategoriales Denken. Hume, Kant und Husserl über vorprädikative Erfahrung und prädikative
Erkenntnis, (Phaenomenologica 147) Kluwer, Den Haag, 1998. Lohmar approfondisce il problema dell’autostrutturazione dell’esperienza in rapporto allo schematismo kantiano e alla costituzione passiva in Husserl.
SAGGI
analisi genetica, ma anche il suo punto di arrivo57.
23
24
15
A rigore si dovrebbe qui parlare di proprietà, tuttavia, è proprio della costituzione delle proprietà che si sta parlando, ed è opportuno usare, come Husserl stesso fa, un termine sinonimo
come qualità, attribuendo a quest’ultimo un significato diverso. Nonostante manchi nelle Analysen
una tematizzazione esplicita del linguaggio, si potrebbe dire che il linguaggio, per sua natura è
adatto a parlare degli oggetti dell’esperienza ed è costitutivamente incapace di portare a espressione le predatità passive e i rapporti tra di esse.
16
Solo se l’associazione è svincolata dall’appercezione è possibile parlare di nessi nella datità
passiva, di fenomeni non appercettivi, ma comunque presenti nel flusso di coscienza.
L’indipendenza dell’associazione dall’appercezione è quindi la condizione della possibilità della
trattazione non empiristica di questo fenomeno. Cfr. E. HOLENSTEIN, Phänomenologie der
Assoziation. Zu Struktur und Funktion eines Grundprinzips der passiven Genesis bei E. Husserl,
(Phaenomenologica 44) M. Nijhoff, Den Haag, 1972.
17
HU XI, Beilage XII, p. 387.
18
HU XI, p. 152, trad. it., p. 209.
19
HU XI, p. 149, trad. it., p. 205.
20
HU XI, p. 156, trad. it., p. 213.
21
EU, p. 83, trad. it., p. 80.
22
EU, p. 119, trad. it., p. 114.
23
Il “tenere-sotto-presa” e il “preafferrare” (Vorgreifen) attivi sonno differenti dalle ritenzioni e
dalle protenzioni. Questa distinzione è già presente in HU X, Beilage XI, p. 118, trad. it., p. 145.
24
Cfr. EU, p. 184, trad. it., p. 173. Su questo esempio, cfr. anche P. SPINICCI, I pensieri dell’esperienza. Interpretazione di “Esperienza e giudizio” di Edmund Husserl, La Nuova Italia,
Firenze 1984, pp. 76 sgg.
25
E, si può aggiungere, del carattere progettuale e sistematico della conoscenza, che risulta
quindi radicato nell’esperienza stessa.
26
HU XI, p. 329.
27
HU XI, p. 330.
28
Cfr. HU XII, p. 38.
29
Cfr. HU XII, p. 42.
30
Cfr. HU III, 2, p. 295, trad. it., 264.
31
I. KANT., Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, in Kants Werke. Akademie Textausgabe,
Band VII, De Gruyter, Berlin 1968, p. 140.
32
Per un confronto tra Husserl e Kant sul problema dell’intuizione si veda N. ROTENSTREICH,
Synthesis and intentional objectivity, (Contributions to phenomenology 33) Kluwer, Dordrecht
1998.
33
Cfr. EU, pp. 90 e 232, trad. it., pp. 84 sg. e 217 sg..
34
Cfr. HU IV, pp. 87 e 158, trad. it., pp. 410 sg. e 494 sg..
35
Cfr. EU, p. 93, trad. it., p. 87.
36
Cfr. HU XIV, p. 41.
37
Cfr. E. LÉVINAS, Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger, trad. it. di F. Sossi, Cortina,
Milano 1998, p. 130 sgg..
38
Su questo problema si può consultare: J. DERRIDA, Il problema della genesi nella filosofia di
Husserl, trad. it. di V. Costa, Jaca Book, Milano, 1992 Cfr. anche W. R. MC KENNA e J. EVANS J. (a
cura di), Derrida and phenomenology, Kluwer, Dordrecht 1995.
39
HU I, p. 29, trad. it., p. 28; HU XI, Abhandlung II, p. 323 e Beilage XI, p. 386.
40
“Die Erscheinungen verlaufen vermöglich, passiv oder aktiv; aber auch passiv sind bewußt
als solche, die wir ‘subjectiv‘ ablaufend haben, und als das tuend ablaufen lassen könnten” Ms D
12 I, p. 15 (5. IX. 1931).
41
Cfr. HU VI, par. 25 e 28, pp. 93 sgg. e 106 sg., trad it., pp. 118 sgg. e 133 sgg..
42
T. Seebohm sostiene che, in opere più tarde come le Cartesianische Meditationen e la
Krisis, “si ha l’impressione che Husserl, nel chiarimento dei risutalti della sua ricerca, si lasci
guidare in parte e consapevolmente da preconcetti metafisici, che erano certamente affidabili per
le vecchie analisi, ma che non voleva ingiustamente adattare a ciò che, in particolar modo le
nuove ricerche sull’estetica trascendentale avevano prodotto”. Seebohm conclude che “la
costruzione sistematica delle più tarde trattazioni generali, come le Cartesianische Meditationen
è equivoca, ed equivoci per lo stesso motivo sono anche molti concetti fondamentali”. Vedi T.
SAGGI
SEEBOHM, Intentionalität und passive Synthesis. Gedanken zu einer nichttranszendentalen
Konzeption von Intentionalität, in Gerbach H. M., H. R. SEPP (a cura di), Husserl in Halle.
Spurensuche im Anfang der Phänomenologie, P. Lang, Frankfurt a.M. 1994, p. 64.
43
Cfr. HU XI, pp. 76 e 89, trad. it., pp. 118 e 135; cfr. anche Beilage IV, p. 358, sull’“intenzionare dossico”.
44
EU, p. 119, trad. it., pp. 113 sg.
45
Cfr. HU X.
46
La temporalità è comunque immanente visto che Husserl sostiene l’impossibilità di spiegare
la coscienza del tempo e, soprattutto, il legame di questa con la temporalità della coscienza stessa a partire da un tempo trascendente e naturale. Bisognerebbe chiarire meglio la dicotomia tra
immanenza e trascendenza. Nel par. 69 di Formale und transzendentale Logik, Husserl sostiene
che “noi distinguiamo tra oggetti immanenti e oggetti trascendenti soltando all’interno di un concetto più ampio di trascendenza”. Il concetto husserliano di trascendenza evita ogni interpretazione psicologista, restando sempre riferito alla coscienza ed essendo privo di ogni carattere
“noumenico”. Si potrebbe discutere sulla stessa presenza di un’effettiva distinzione tra immanenza e trascendenza in senso classico in Husserl. La trascendenza consiste nell’idealità generale di
tutte le unità intenzionali rispetto alle molteplicità che le costituiscono: questa “trascendenza” originaria si fonda sull’intenzionalità come struttura fondamentale della coscienza. “La trascendenza
del reale (real) si costituisce […] secondo il suo senso ed essere nella sfera immanente”, pur non
essendo “un frammento reale (reel) della coscienza”. Sembra che la distinzione tra trascendenza
e immanenza sia da collocare in un concetto più ampio di immanenza, da rapportare a una
trascendenza fondamentale della coscienza, di cui l’intenzionalità è esplicazione. Cfr. HU XVII, pp.
174 sgg., trad. it., pp. 205 sgg..
47
HU X, pp. 369 sg., trad. it., p. 356, e pp. 73 sg., trad. it., pp. 100-102.
48
Cfr. EU, p. 184, trad. it., p. 173.
49
Cfr. il passo di HU XI, già citato: “l’intera dottrina della coscienza interna del tempo è il
prodotto di un’astrazione idealizzante” senza il completamento della genesi, che è lo studio della
temporalità nella sua forma più originaria.
50
HU I, p. 109, trad. it., p. 100.
51
HU I, p. 89, trad. it., p. 80.
52
T. SEEBOHM, Intentionalität und passive Synthesis, cit., p 65.
53
HU I, pp. 114 sg., trad. it., p. 105.
54
E. LÉVINAS, Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger, cit., pp. 175-176.
55
HU X, p. 382, trad. it., pp. 365-366.
56
Cfr. HU XI, p. 149, trad. it., p. 205.
57
Tra le pubblicazioni recenti sul tema del rapporto tra temporalità e affezione si segnalano:
A. MONTAVONT, Le phénoméne de l’affection dans les Analysen zur passiven Synthesis de Husserl,
in Temporalité et affection, (Alter. Revue de Phénoménologie 2) éditions Alter, Fontenay-auxRoses 1994; ID., De la passivité dans la phénoménologie de Husserl, PUF, Paris 1999 e R. KUHN,
Der Begriff der Passivität. Zur Kritik der passiven Synthesis in der genetischen Phänomenologie,
Alber, Freiburg/München, 1998. Sul rapporto tra l’evoluzione della fenomenologia genetica e le
ricerche sulla coscienza del tempo si veda: T. K ORTOOMS, Phenomenology of time,
Phaenomenologica 161, Kluwer, Dordrecht 2001.
25
OLTREPASSARE IL SEGNO
DERRIDA E RICOEUR LETTORI DI HUSSERL
di Marco Salvioli
Per H.
“Il linguaggio riesce a dividere anche dove
non c’è più niente da dividere.” 1
26
“I have tried to keep us from forgetting that there are still signs in discourse”2.
Questa frase apparentemente innocua contiene in nuce il pensiero che anima
l’orizzonte grammatologico aperto dalle ricerche condotte da J. Derrida almeno
fino alla prima metà degli anni Settanta. È all’interno di tale orizzonte che è venuta elaborandosi la pratica di lettura e di interpretazione –quasi un controcanto
rispetto alla koiné ermeneutica– che è stata definita “decostruzione”.
Questo articolo intende delineare un luogo comune, a partire dal quale
poter pensare la coappartenenza polemica della fenomenologia ermeneutica
di Ricoeur e della grammatologia. Per fare questo ho deciso di adottare un
punto di vista inconsueto, ma geneticamente e storicamente pregnante, rispetto alle coordinate a cui si è attenuta la maggior parte della critica negli ultimi
anni. La voce e il fenomeno3 quindi verrà letta come l’elemento di rottura che
–a partire da una differente interpretazione del ruolo del segno in Husserl–
emerge sullo sfondo della filosofia ricoeuriana del linguaggio, per contestarne
dall’interno l’architettura.
“I have tried to keep us from forgetting that there are still signs in discourse”. Penso di non allontanarmi eccessivamente da un’interpretazione corretta
di questo enunciato, applicandone il senso al movimento di pensiero de La
voce e il fenomeno, che sembra trattenere (to keep from) sull’incerto confine
che conduce dal segno al significato. Tanto più efficacemente, in quanto tale
“impressione” è suscitata nel confronto con la fenomenologia di Husserl che si
determina nel compito dell’andare “alle cose stesse”, riducendo ogni mediazione (del tipo del segno o dell’immagine) per ottenere un’intuizione “in carne
ed ossa” dell’oggetto intenzionato.
Occorre pertanto sviluppare l’illusoria ovvietà dell’espressione derridiana
attraverso due osservazioni. In primo luogo, nell’accostare l’espressione di cui
sopra assistiamo ad un tentativo di impedire al pensiero di obliare, nell’elaborazione e nella comprensione del discorso, il momento del segno. In altre
parole, Derrida ha avvertito che la possibilità della rimozione è inscritta nella
struttura stessa del segno, considerato tradizionalmente un elemento di “passaggio”. Tale possibilità, smacherando l’impulso fonologocentrico della tradizione occidentale, si è manifestata soprattutto nel privilegio accordato alla
Ricoeur: oltre il segno, per voler-dire
La prima riflessione di un certo spessore sul problema del linguaggio fornita da Ricoeur è situata all’interno della prima parte di Finitudine e colpa7, intitolata L’homme faillible, che propone un’antropologia della fallibilità correlata
ad un’ontologia della sproporzione tra essere finito e infinito. Il fatto che
Ricoeur incontri il linguaggio a partire da una domanda antropologica è particolarmente significativo per due ragioni. Da un lato, questa posizione apre alla
concezione del linguaggio come mediazione e come atto, fondati sulla stessa
essenza dell’uomo, “medium tra l’essere e il nulla” (FC, 121); dall’altro,
SAGGI
voce rispetto alla scrittura nel discorso filosofico da Platone fino ad Heidegger.
Pertanto “trattenere” il segno dall’oblio, o meglio dalla disattenzione che supera auto-convincendosi di mantenere (Aufheben), significa rispondere praticamente al privilegio dettato dalla tradizione soffermandosi4 sulle tracce del
rimosso, confinate in ciò che è marginale e secondario rispetto all’analisi.
Questo movimento di pensiero annuncia, senza esaurirne la portata, la “logica del supplemento” e la nozione derridiana di “archi-scrittura”.
In secondo luogo, l’enunciato auto-interpretativo di Derrida è tratto dal dialogo con Ricoeur tenuto a Montréal (1971), nel contesto di una riflessione sull’articolazione della semantica e della semiologia. A mio parere tale situazione
non è riducibile alla dimensione di un episodio casuale, ma può essere pensata come il sintomo di legami più profondi tra le ricerche dei due filosofi5. Di
fronte all’impegno di Ricoeur per distinguere l’orizzonte del discorso da quello
del segno, il pensiero di Derrida può essere quindi delineato come il tentativo
di pensare insieme “discorso e segno”, dove il segno “e” è da leggersi secondo il movimento della différance piuttosto che secondo la logica della sintesi,
fosse anche trascendentale, che conduce inevitabilmente alla costituzione di
un terzo termine chiamato a mantenere la gerarchia del privilegio.
La disputa sul segno, rimosso o da trattenersi, è condotta pertanto sul testo
della Prima delle Ricerche logiche6 di Husserl che, mentre da una parte afferma con decisione l’oblio della domanda sull’essenza del segno in generale,
dall’altra permette anche di sottrarre la domanda sul segno all’orizzonte dell’ontologia tradizionale, evidenziandone la struttura quasi paradossale di
“qualcosa che sta per qualcos’altro”, la cui essenza consiste pertanto nell’essere-attraversato, come se non esistesse che in funzione di altro (VF, 53-56).
Il testo husserliano distinguendo il segno indicativo da quello espressivo, proprio del linguaggio, pone la sfida di una concezione del linguaggio che non sia
riducibile alla nozione di segno, in quanto mostrerebbe immediatamente il proprio significato, pur nel caso limite del “discorso solitario”. Dalla critica a questa concezione del linguaggio, sorgono sia la fenomenologia ermeneutica che
la grammatologia, pur con esisti contrastanti sul rapporto tra segno e senso.
Pertanto la posizione di Ricoeur, che traccia il cammino dell’interpretazione
che procede dal segno al senso, può essere considerata come uno dei principali obiettivi –benché implicito– della decostruzione derridiana.
27
28
Ricoeur si inserisce nella prospettiva “umanistica” inaugurata da H.J. Pos ed
approfondita da M. Merleau-Ponty8. Queste decisioni teoretiche influenzeranno profondamente la successiva polemica con lo strutturalismo e la conseguente proposta di articolazione tra la semantica e la semiologia.
All’interno di questo orizzonte, Ricoeur considera quindi il linguaggio in
forte correlazione con la percezione, intendendoli come i due momenti che
compongono secondo la sintesi trascendentale per cui “l’oggettività dell’oggetto è che la dicibilità aderisca all’apparizione di una cosa” (FC, 113).
Il linguaggio è inteso come logos –“verbo infinito” scrive Ricoeur– che,
entrando in dialettica con la necessaria parzialità della percezione, consente
al pensiero di superarne l’hic et nunc per elevarsi all’universalità del senso9.
Seguendo lo schema husserliano, si può dire che, attraverso il linguaggio, l’atto noetico fugace e prospettico si attesta nella permanenza noematica di un
senso, per cui “quando significo, dico più di quel che vedo” (FC, 100). Questa
eccedenza del discorso sullo “sguardo muto” è definita da Ricoeur come “il
voler dire del dire” (FC, 99). Richiamandosi alla Prima delle Ricerche logiche,
il pensatore identifica la propria concezione del linguaggio con la nozione husserliana di espressione (Ausdruck). Distinta dalla funzione comunicativa e
indicativa, l’espressione “annuncia ad altri ciò che voglio dire, ma annuncia ad
altri solo in quanto significa, cioè indica il senso, il contenuto rappresentato”
(FC, 99). Al di là delle difficoltà di tale interpretazione –che emergeranno compiutamente dalla lettura di VF– l’espressione come atto che manifesta ciò a cui
si riferisce il locutore è ciò che costituisce il “proprio” del linguaggio umano,
secondo una serie di citazioni che collegano Platone, Aristotele, Hegel e
Husserl. L’espressione, pur non trovando il proprio centro nel riempimento
intuitivo, è diretta sulla cosa: il voler dire vede il suo telos nel riferirsi a ciò che
esiste nel mondo o nel soggetto. Il linguaggio, infatti, eccede per supplire la
finitezza della percezione attuale, coordinando la molteplice fugacità dei punti
di vista intorno all’unità universale rappresentata dal nome, inteso da Ricoeur
come “regola di questo rapporto di supplenza e di questo riferimento reciproco delle apparizioni” (FC, 101). Pertanto, nel linguaggio si dà quell’eccedenza
non dualistica che segna la differenza tra la presenza del percepito alla
coscienza e il significato linguistico, fenomenologicamente tenuti in tensione
dalle nozioni di “noema” e di “senso”.
Il linguaggio, tuttavia, non è costituito solo dal carattere universale e identico del nome. Per Ricoeur, ciò che conferisce maggior senso al discorso è il
verbo. Attraverso di esso infatti, i nomi vengono coordinati come soggetto e
predicato all’interno della frase che sola costituisce il giudizio nella verità o
nella falsità. Grazie alla struttura temporale dell’espressione verbale, l’enunciato si può riferire all’esistenza nella modalità dell’affermazione o della negazione che, per Ricoeur, sono collegate all’analisi della volontà nel giudizio. “È
dunque all’identità tra verbo e assenso, consenso ed elezione (o come li si
vorrà chiamare) che tutte le nostre analisi conducono. Se adottiamo il linguaggio husserliano e la correlazione noesis-noema, diremo che la sovrasignificazione del verbo è il noema correlativo della noesis che ora ci appare
costituita dal momento volontario dell’affermazione” (FC, 108-09).
SAGGI
A partire da questa interpretazione, si può quindi comprendere come per
Ricoeur il “voler dire” non è semplicemente una icastica traduzione del più
logico “significato”. Accentuando il “voler dire del dire”, Ricoeur intende
mostrare che il momento volontario dell’affermazione si radica nel carattere
oggettivo e significante dell’espressione. Pertanto, se l’operazione logica di
significazione espressa dal nome permette il superamento dell’individuale nell’universale, al verbo competono l’accorso con la dimensione esistenziale e
con quella relazionale nelle quali trova compimento la libera capacità umana
dell’affermazione. Quindi è il verbo che è chiamato a manifestare la concezione del linguaggio come atto e mediazione, che trova nell’uomo la propria
ragione d’essere.
Ritornando alla domanda inaugurale di questo articolo: che ne è del segno
in tale orizzonte? Per il Ricoeur di FC, il segno riveste una importanza molto
marginale fungendo da “portatore trasparente” dell’atto significante: “la parola
ha la mirabile proprietà di rendere trasparente la sua sonorità, di cancellarsi
carnalmente evocando l’atto che conferisce il senso, in una parola, di farsi
segno. Nel segno risiede la trascendenza del logos dell’uomo” (FC, 99-100).
Al di là dello “spiritualismo linguistico” di cui può essere sospettata questa
argomentazione a causa del completo disinteresse dimostrato da Ricoeur per
la materia segnica, ciò che è importante è comprendere perché chi si concentra sul senso rischia di dimenticare il corpo del segno. Fungendo quasi
come una lastra perfettamente diafana, il segno lascia apparire il senso come
qualcosa al di là di se stesso, il che –rifiutate le posizioni psicofisiche dello psicologismo– suggerisce una sorta di “linguaggio degli angeli”. Il problema, tuttavia, emerge nel momento in cui, abbandonata la posizione del locutore che
vuole dire e assunta quella di colui che ascolta, si cerca di “afferrare” il significato espresso: in tal caso si è colti di sorpresa dalla resistenza offerta dalla
materia della lastra, pur così trasparente. Tale opacità condurrà in seguito
Ricoeur ad elaborare la propria fenomenologia ermeneutica, mentre la medesima resistenza verrà sfruttata da Derrida per decostruire il sistema logocentrismo: la materia del segno, infatti, dovrà essere considerata classicamente
come materia prima che attende di essere in-formata dall’atto conferitore di
senso (Ricoeur), oppure occorre considerare la possibilità di una materia preformata indipendentemente dalla coscienza come il significante della linguistica (Derrida)?
In assonanza con alcune considerazioni husserliane10, Ricoeur non approfondisce né l’enigma del segno che “lascia apparire cancellandosi” né il senso
della trasparenza della sonorità, per tacere dell’assenza della scrittura.
Pertanto, il segno è menzionato come il luogo dove “risiede” ciò che oltrepassa, come oggetto ideale11, l’hic et nunc di ogni localizzazione. Il segno, in quanto materializzazione residua dell’intenzione significante, è allora chiamato ad
essere discreto: come qualcosa che funge da “passaggio”, ma di cui non si è
in fondo certi della necessità.
A questo punto, si può comprendere facilmente come l’impostazione ricoeuriana, così attenta all’atto di discorso e al momento del senso come intenzione, possa essere stata profondamente scossa dalla “sfida della semiolo-
29
30
gia”. L’avvento dello strutturalismo linguistico ha quindi costretto Ricoeur a
rifondare le proprie posizioni, pur conservando l’ordine delle priorità, nel progetto di una teoria della complementarità tra momento semiologico e momento semantico, entrambe fondati su una reinterpretazione linguistica della riduzione fenomenologica husserliana.
La legittimità della spiegazione oggettivante della scienza linguistica si
fonda sul postulato dell’autonomia del sistema chiuso della langue, costituito
dalle sole differenze interne tra i significanti, sostenendo l’inessenzialità dell’emittente e della realtà significata alla spiegazione del linguaggio. Di fronte
alle derive totalizzanti di tale interpretazione, fondate sul primato dell’inconscio, Ricoeur attesta l’irriducibilità dell’atto significante al sistema delle differenze tra i segni facendo riferimento all’esperienza che ogni parlante ha di se
stesso12.
In questo senso, come scrive chiaramente D. Ihde, la teoria linguistica di
Ricoeur si fonda su “a husserlian model of language”13, intendendo con ciò la
decisa subordinazione del segno all’atto che conferisce il significato. In continuità con l’impostazione di FC, il linguaggio è pensabile nella sua essenza
solo se non ci si “sofferma” direttamente su di esso come oggetto autonomo.
Il segno, pertanto, non è filosoficamente pensabile “in sé”, ma unicamente
come il residuo di un’astrazione valida ai soli fini della scienza linguistica o
come mediazione da superare. Per dare sistematicità a tale concezione,
Ricoeur giunge quindi a riformulare i principi della fenomenologia, presentata
da Husserl dalle Ricerche logiche a Idee I, in direzione di una filosofia del linguaggio. Eccone le tesi: “1) la significazione è la categoria più inglobante della
descrizione fenomenologica; 2) il soggetto è il portatore della significazione; 3)
la riduzione è l’atto filosofico che rende possibile la nascita d’un essere per la
significazione” (CI, 261). Ricoeur può così definire il linguaggio a partire dall’intenzionalità della coscienza, quale processo di trascendenza implicito in
ogni vissuto14, che costituisce la condizione di possibilità del segno espressivo
e significante.
Il centro della fenomenologia ricoeuriana del linguaggio è da ricercarsi
nella traduzione della riduzione fenomenologica in funzione di una “teoria del
linguaggio generalizzato” che fonda la pretesa dicibilità del vissuto. In seguito
e attraverso l’atto della riduzione, che istituisce il campo dell’esperienza trascendentale, l’ente è considerato come senso. Allora “tutto è significazione”
(CI, 261), in quanto ogni cosa è considerata come un vissuto che guida il soggetto al di là di se stesso in direzione delle trascendenze. Attraverso la riduzione, i concetti di “mediazione” e “segno” convergono: “Il linguaggio cessa di
essere un’attività, una funzione, un’operazione tra le altre e si identifica col
mezzo significante totale, con il sistema dei segni gettati come una rete sul
nostro campo di percezione, di azione, di vita”15.
Il gesto di Ricoeur consiste essenzialmente nel considerare la riduzione
fenomenologica come la risposta al problema dell’origine della funzione simbolica. La riduzione è pensata come l’inizio trascendentale (CI, 273), ossia né
storico né cronologico, della relazione significante dell’uomo nei confronti della
realtà. A partire dalla riduzione, il linguaggio si dà in quanto voler dire (CI, 98)
SAGGI
di un soggetto che si relaziona al mondo: originariamente, quindi, non si dà
segno se non in riferimento a qualcosa, perché “segno” è –prima di essere una
cosa materiale– un atto e una relazione. Coerentemente riduzione, intenzione
significante e intenzionalità sono coestensive: “il vissuto non è un vivere del
tutto naturale, ma è un sistema di significazioni che appare in una coscienza
che lo costituisce”16.
L’interpretazione della riduzione fenomenologica data da Ricoeur, che
risponde della domanda sull’origine –non genetica, ma trascendentale– della
vita significante, presenta un momento negativo ed uno positivo (CI, 274-276).
Se da un lato “la riduzione fenomenologica non [è da interpretarsi] come la
perdita di qualche cosa, l’esaurimento di un’intensità ontologica, ma come una
presa di distanza e un atto di differenza, a partire dal quale non ci sono soltanto cose, ma segni” (SS, 110), dall’altro “la riduzione, nel suo senso più
pieno, è questo ritorno a sé a partire dal proprio altro, che costituisce il trascendentale non più del segno, ma della significazione” (CI, 276).
Questi momenti sono inscindibili: se è possibile affrontare il linguaggio dall’una o dall’altra prospettiva, occorre ricordare che si sta meditando su un
unico atto che si dà nella forma della “sintesi trascendentale” di due momenti
paralleli, sebbene asimmetrici. Il testo ricoeuriano ci consente di esprimere
questa dialettica a partire dalla distinzione tra intenzione significante e riempimento di significato, presentata da Husserl nella Sesta Ricerca logica17 per
articolare fenomenologicamente l’unità dell’atto conoscitivo.
Il primo movimento è quello della costituzione del “segno” attraverso la
considerazione dell’intenzione significante. Infatti, il segno trova la propria
condizione di possibilità nella presa di distanza dalla realtà che si ha in concomitanza con il darsi della coscienza. La coscienza si costituisce nella
sospensione del proprio rapporto “naturale” di partecipazione indifferenziata al
mondo: attraverso la riduzione viene esplicitato il nesso intenzionale che sussiste tra l’intenzionalità della coscienza e il “segno vuoto”, come “tensione
verso” che prende corpo nell’atto di parola. Il segno, correlato del senso, sorge
dal movimento di differenziazione tra la coscienza e le cose, ed indica un’assenza determinata.
Il secondo movimento, istituito a partire dalla riduzione fenomenologica,
rende ragione del “riferimento” a partire dalla nozione fenomenologica di riempimento di significato. Lo scarto aperto dalla relazione intenzionale tra la
coscienza e il mondo, che si manifesta nel linguaggio come segno, è solo l’aspetto negativo che richiede la positività dell’espressione che vuole dire la
cosa. Il segno è dunque la via che occorre percorrere, ma anche lasciarsi alle
spalle, nel momento che si giunge alla cosa. Il riferimento ontologico è il telos
di un compito infinito richiesto dall’assenza significante del segno:
“L’appartenenza del linguaggio all’essere esige dunque che si rovesci un’ultima volta il rapporto e che il linguaggio appaia esso stesso come un modo d’essere nell’essere” (CI, 280).
Infatti, la principale differenza tra semiologia e semantica risiede, per
Ricoeur, nell’accettazione o nel rifiuto del “principio del riferimento” istituito a
partire dalla considerazione sinottica delle teorie del significato di G. Frege18 e
31
di Husserl, per cui l’una sembra essere letta attraverso e in funzione dell’altra19. Questa alleanza non fa altro che ripetere il movimento dialettico della
riduzione fenomenologica che vuole rendere ragione, allo stesso tempo, della
differenza tra pensiero e vita e della mediazione insita nell’atto del parlante
che si riferisce alla cosa. La fenomenologia di Ricoeur, nel fornire una visione
dell’essenza del linguaggio, si pone anche come il punto di vista capace di articolare e giustificare trascendentalmente i diversi metodi di analisi del linguaggio stesso. Il nucleo di questa operazione consiste nel fondare la legittimità
metodica della linguistica strutturale20 e della Speech acts theory21, istituendo
contemporaneamente la differenza tra semiologico e semantico. Secondo
Ricoeur, per avere una visione globale del linguaggio, occorre integrare le due
prospettive metodiche fondandole sull’atto della riduzione fenomenologica
come istituzione della funzione simbolica. In questo senso il principio della differenza semiologica, che agisce per riduzione e astrazione, non è che il lato
negativo del principio del riferimento semantico in atto nel discorso: “Mentre il
segno rinvia solo ad altri segni nell’immanenza di un sistema, il discorso è
relativo alle cose. Il segno differisce dal segno, il discorso si riferisce al mondo.
La differenza è semiotica, la referenza è semantica”22.
La domanda di Derrida può così emergere dall’elaborazione fenomenologica e linguistica di Ricoeur: se la differenza e il segno non sono che un
momento nel cammino di riappropriazione dell’atto e della cosa nel “campo
semantico”, che ne è dell’autonomia corporea del significante?
32
Derrida: restare sul segno per poter dire
Ciò che tenterò ora di mostrare è che La voce e il fenomeno rappresenta il
fattore decostruttivo dell’impresa ricoeuriana di coordinazione del semiologico
e del semantico sull’interpretazione linguistica della riduzione fenomenologica.
In questo senso, Derrida si oppone al progetto di una semantica controllabile
dalla coscienza che la pone in atto e la vive come via all’ontologia. Tale progetto, infatti, incarna e riassume i due momenti metafisici ascritti a Husserl
come fonologocentrismo: privilegio della presenza (della cosa al senso e del
senso alla coscienza) e volontarismo teleologico. Queste tentazioni sono
immanenti all’opera husserliana e rispondono ad una concezione strumentale
del linguaggio chiamato ad esprimere ciò che il pensiero riflette dell’essere…
senza eccedenze. Decostruire il privilegio del voler-dire, significa rimanere sul
segno in quanto tale. Più che l’articolato testo husserliano, questo gesto mette
in crisi l’interpretazione ricoeuriana fondata sulla priorità del discorso come atto
e sulla riduzione, in ultima analisi, del segno al senso. Per Derrida, infatti, la trascendenza del significato non emerge semplicemente dalla capacità del segno
di “cancellarsi carnalmente” (FC, 100), ma tale trascendenza è già da sempre
inscritta nella rete dei significanti, per cui il significato trascendentale (POS, 30)
non è che una ipostatizzazione, costruita volontariamente e après-coup, del
gioco esistente tra le forme sensibili del significante e l’atto dell’esprimere.
La voce e il fenomeno, pertanto, si propone di pensare insieme “discorso e
SAGGI
segno”, o meglio di dislocare, attraverso l’ascolto attento del rimosso e dei
margini, il tradizionale ideale metafisico del discorso apofantico che “porta a
manifestazione ciò che è”. Per fare ciò, Derrida si è avvalso essenzialmente
di tre elementi profondamente connessi e del lato meno praticato dell’opera
husserliana: mi riferisco alla fenomenologia genetica che articola i momenti
della materia, del tempo e dell’altro attraverso la considerazione della genesi
passiva23. Sarà, infatti, l’apertura che la forma sensibile del segno permetterà
alla generazione passiva dei rinvii significanti (occorre mantenere l’ambiguità
di questa espressione) che sosterrà il carattere decostruttivo della nozione
derridiana di scrittura e la successiva disseminazione. Pertanto, non sembra
fuori luogo sostenere che Derrida inviti a pensare il rapporto strutturale tra
segno e significato in termini “ontogenetici”24.
La lettura derridiana, che si pone “a metà strada tra il commentario e la traduzione” (VF, 48), si apre con l’analisi della differenza istituita da Husserl
–all’interno della sezione della prima ricerca logica dedicata a “Le distinzioni
essenziali”– tra “espressione” (Ausdruck) ed “indice” (Anzeichen). Nella concezione husserliana l’indice consiste in un segno che non convoglia alcun
significato (Bedeutung) a differenza dell’espressione: “Il significare non è una
specie dell’essere segno, intendendo il segno come indicazione” (RL 1, 291).
Mentre l’indicazione si pone come un fattore esterno che connette associativamente due elementi in modo puramente estrinseco, l’espressione è indissociabile dalla connessione ad una Bedeutung. Secondo Derrida –che concorda con la lettura di Ricoeur– per comprendere il senso ed il valore di questa distinzione, che determina il tono di tutto il percorso husserliano, occorre
spiegare il termine Bedeutung pensandolo come voler-dire: “la Bedeutung è
sempre ciò che qualcuno o un discorso vogliono dire: sempre un senso di discorso, un contenuto discorsivo” (VF, 48).
Il ricorso al voler-dire non porta alla luce solo il privilegio che viene accordato alla parola –in quanto espressione linguistica, rispetto al segno indicativo
nel lavoro di chiarificazione e fondazione della logica pura– ma pone un secondo e più importante privilegio: quello del punto di vista del soggetto del discorso nella determinazione del significato. Quest’ultimo non dipende dal segno
espressivo, che in quanto tale potrebbe essere facilmente confuso con quello
indicativo, ma dall’atto significante, che fa di un mero fenomeno fisico un quid
dotato di senso. Pertanto, la differenza risiede nella coscienza, nel vissuto
intenzionale: in assenza di una vita donatrice di senso, la distinzione essenziale si ridurrebbe ad un omogeneo agglomerato materiale. La distinzione tra indice ed espressione non può dunque essere operata se non facendo ricorso
all’interiorità del voler-dire come l’intenzione che ha un parlante di esprimere
attraverso le parole il proprio vissuto. Infatti, solo la coscienza, in quanto luogo
del darsi immediato del vissuto, può essere l’origine dell’atto significante che
istituisce la relazione logica tra oggetto e significato (RL 1, 304).
Questa impostazione mostra come, per Husserl, non sia possibile limitarsi
ad una concezione “comunicativa” dell’espressione per comprendere la distinzione d’essenza tra espressione ed indicazione. Infatti, il linguaggio comunicativo non rende ragione di tale distinzione, presentando al contrario una con-
33
34
catenazione (Verflechtung) strettissima tra funzione indicativa ed espressiva
per cui “il voler-dire è sempre incatenato, preso in un sistema indicativo” (VF,
50). Nella comunicazione il linguaggio non si limita ad esprimere un significato ideale (bedeutung) nel quale si dà il rapporto all’oggetto, ma attraverso l’esteriorizzazione nel supporto sensibile e nel rapporto all’altro si produce un
passaggio dall’espressione all’indice. Nel rapportarsi all’altro, infatti, l’espressione propria diviene indice di un’intenzione non evidente. Nell’ascolto non ci
troviamo mai di fronte ad un voler-dire, ma ad un segno che indica un atto
significante smarrito nell’opacità del materiale sensibile percepito. In altre
parole, se, per il parlante, ciò che è primo è ciò che vuole dire ed è da comunicarsi attraverso il fenomeno sensibile adeguatamente animato, per l’uditore
ciò che è primo è il fenomeno fisico in quanto portatore di un’intenzione di
senso non immediatamente manifesta, che apre la possibilità di associazioni
empiriche e, perciò, potenzialmente arbitrarie. Quindi, la radice indicativa della
comunicazione coincide quindi con la necessaria mediazione intersoggettiva
della materia sensibile che, in quanto tale, costituisce una resistenza all’evidenza della presenza alla coscienza.
Il senso della distinzione tra espressione e indicazione deriva, in Husserl,
dalla correlazione immediata esistente tra significato ed espressione all’interno
della coscienza. Tale correlazione è tematizzabile solamente considerando il
soliloquio che avviene all’interno di sé nella vita psichica isolata (RL 1, 302303), ovvero nella presenza del senso alla coscienza in un’intuizione immediata. Secondo Derrida, accedendo al soliloquio Husserl intende ridurre soprattutto l’esistenza mondana intrinsecamente connessa al concetto di segno indicativo, che comprende in sé l’opacità e la spazialità propria della materia. Infatti
per Husserl, i vissuti psichici sono immediatamente presenti alla coscienza: per
comunicare tra sé e sé non vi è bisogno di alcun indice, mentre si danno certamente oggetti ideali. In questo modo, “il rapporto all’oggettività segna dunque
un’intenzionalità ‘pre-espressiva’ (vor-ausdrücklich) mirante a un senso che
sarà poi trasformato in Bedeutung ed in espressione” (VF, 64).
Il darsi della Bedeutung, presuppone quindi due momenti che –come ha
mostrato Ricoeur– si richiamano reciprocamente: l’intenzione di esprimere e
la riduzione dell’opacità dell’indice. Anche per Derrida si dà un conflitto tra
voler-dire e segno. Il termine “espressione” è definito dal carattere volontario
ed intenzionale dell’esteriorizzazione espressiva che la connette all’attività di
un soggetto cosciente. Da un lato, non si dà espressione senza l’intenzione di
un soggetto che anima il segno dotandolo della Bedeutung e dall’altro, nell’esprimersi di quella intenzione: “ciò che ‘vuol-dire’, ciò che il voler-dire vuol dire,
la Bedeutung, è riservato a colui che parla e che parla in quanto dice ciò che
vuol dire: espressamente, esplicitamente e coscientemente” (VF, 65).
Relativamente al problema del significato e del linguaggio, infatti, la presenza
può essere preservata solo se si radica il significato nell’intenzione di esprimersi che, in quanto tale, coincide con il “voler-si-dire della presenza del
senso” (VF, 66). Pertanto, il processo di animazione del materiale sensibile
operato dall’atto significante è interpretato nel senso di una metafisica volontaristica, che funge da presupposto dell’idealismo fenomenologico-trascen-
SAGGI
dentale. È in tale orizzonte che Derrida può parlare, per i vissuti d’espressione, di omologia tra la coscienza intenzionale e quella volontaria. L’essenza del
linguaggio è determinata dal telos, fissato dalla volontà, di manifestare un
significato presente alla coscienza e che appare nella sua purezza nell’interiorità della vita psichica isolata. La teleologia implicita al linguaggio costituisce, quindi, il motivo trascendentale dell’esclusione della totalità del campo
indicativo dall’essenza del fenomeno linguistico. In questo modo, la dissonanza con l’interpretazione ricoeuriana diviene evidente proprio nel momento in
cui Derrida si accinge a leggere in Husserl un certo volontarismo. Ciò che, per
Ricoeur, era la volontà come libera capacità di affermazione diviene con
Derrida “volontarismo metafisico” che riduce la fecondità espressiva del linguaggio all’ambito controllato dall’intenzione cosciente25.
A partire dalla considerazione della relazione tra soliloquio e Bedeutung,
Derrida può trarre due conseguenze. In primo luogo, l’espressione testimonia
dell’idealità della Bedeutung, che si dà come identità del senso permanente
attraverso l’indefinitività della ripetizione empirica ed indipendentemente dall’esistenza mondana. In secondo luogo, lo statuto dell’espressione tende verso la
rappresentazione, per cui “nella ‘vita solitaria dell’anima’, non ci serviamo più
delle parole reali (wirklich), ma soltanto di parole rappresentate (vorgestellt)”26.
Così, il segno espressivo è da situarsi –a differenza di quello indicativo–
nell’immaginazione che procede dalla neutralizzazione dell’esistenza fattuale
e si dà come rappresentazione immaginaria della parola che mostra immediatamente, senza l’ausilio di alcun supporto materiale, il proprio contenuto
ideale ossia il voler-dire. Il riferimento husserliano al ruolo dell’immaginazione
e della rappresentazione è colto da Derrida al fine di mostrare la coincidenza
tra la riduzione del segno indicativo –attuata per far emergere l’espressione
del voler-dire nella sua purezza– e la riduzione fenomenologica attuata da
Husserl in Idee I27. Infatti, l’espressione e il vissuto emergono nella loro purezza solo dopo aver messo tra parentesi l’opacità materiale. Allora, attraverso il
ruolo giocato dalla fantasia, inizia a manifestarsi il legame essenziale che connette la fenomenologia ad una concezione del linguaggio per cui il segno è
destinato a “cancellarsi carnalmente” (VF, 76-77).
Facendo leva sui temi dell’ idealità della Bedeutung e del valore rappresentativo del linguaggio, depurati da ogni materialità per essere pensati come vissuti immediati della coscienza, Derrida può impostare la propria critica alla fenomenologia trascendentale come metafisica della presenza alla coscienza, a scapito dell’autonomia del significante. Infatti, la tesi di Derrida è che la distinzione
tra indicazione ed espressione, attraverso il privilegio di quest’ultima a scapito
della materialità costitutiva del segno, costituisca lo schema della riduzione fenomenologica. Conseguentemente, l’intera fenomenologia viene a determinarsi
attraverso una idealizzazione del linguaggio operata sulla base del privilegio
della voce nella determinazione del logos28. La decostruzione derridiana del
testo husserliano, mostrando l’irriducibilità del segno indicativo nella costituzione stessa del significato, giunge a contestare direttamente l’interpretazione ricoeuriana della riduzione come “origine trascendentale del linguaggio”. Sembra
infatti che Derrida ne accolga le istanze, per poi decostruirla mostrando come
35
36
l’indice permane nel campo ridotto della “significazione totale”.
La posizione di Derrida, pertanto, consiste nell’opporsi alla possibilità di un
linguaggio puramente espressivo sulla base della necessità del segno indicativo all’interno del soliloquio. Che si consideri una parola effettivamente pronunciata o una parola immaginata, la struttura di ripetizione del segno linguistico
non varia. Per Derrida, infatti, l’essenza del linguaggio non è da ritrovarsi né
nell’espressione né nell’indicazione, quali Husserl le descrive, ma nel rapporto
tra idealità e rappresentazione proprio della struttura di ripetizione del segno29.
Le “parole”, per Derrida, più che dal rapporto tra sensibilità, atto e oggetto
–che non le interroga nella loro datità, ma solo in funzione del telos espressivo– dipendono dalla suddetta struttura di ripetizione. Una parola funziona,
infatti, se può essere considerata come un oggetto ideale –riconoscibile come
identico attraverso la ripetizione indefinita delle sue incarnazioni empiriche– in
virtù della sola “forma”, cioè indipendentemente dal suo voler-dire o dall’oggetto che intende. L’idealità del significato (Bedeutung) come voler-dire, che in
Husserl regge la struttura del discorso, essendo indipendente dalla fisicità del
linguaggio necessaria alla comunicazione che ne marca l’opacità, non è per
Derrida ingenerata o immediata. Essa dipende dalla possibilità dei concreti atti
di ripetizione e dall’idealità della “forma sensibile del significante”30 correlata a
quelli. Infatti, è proprio attraverso il ricorso all’idealità formale del significante
che Derrida decostruisce la distinzione di Husserl tra linguaggio “interiore e
rappresentato” e linguaggio “esterno e reale”. In entrambe i casi, si fa riferimento a segni indicativi costituiti in una forma ideale e sensibile. In questo
modo la presentazione dell’espressione pura nel soliloquio dipende dalla
forma sensibile correlata alla struttura di ripetizione del segno considerata
come a priori materiale del linguaggio. Se la parola immaginata non è immediatamente presente alla coscienza, ma è già da sempre possibilità di un processo (nel quale si è costituita la significazione) che sfugge all’intuizione, ciò
significa che l’espressione è da sempre contaminata dall’indicazione. Il volerdire non va quindi ad animare una materia sensibile informe, ma si riconosce
in una forma già inerente al significante. In questo modo la forma non dipende solo dall’attività significante della coscienza, ma è in parte ricevuta dalla
coscienza attraverso un processo che le sfugge. Anche nel soliloquio, il linguaggio non è quindi trasparente alla coscienza: se vi è coscienza del volerdire, non per questo la possibilità semantica connessa ad un significante è
esaurita da ciò che si intende. Se anche nel monologo interiore si ripete l’intreccio di funzione indicativa ed espressiva e non è dato in alcun modo un linguaggio puramente espressivo, ciò significa che il soggetto deve pensarsi
attraverso l’alterità del segno indicativo. In questo modo, il bagaglio lessicale
sedimentato nel soggetto è molto più ampio della sua possibilità di esprimere
significati: per Derrida, in altre parole, l’involontario linguistico (significante)
anticipa e rende possibile il voler-dire (Bedeutung) anche nel soliloquio.
Se è stato possibile per Husserl, postulare la coincidenza di espressione e
Bedeutung nel monologo interiore, e per Derrida, ritrovare l’indicazione nell’espressione cosiddetta pura, questo è accaduto per la sorprendente affinità di
struttura tra l’idealità della forma del segno sonoro e l’idealità della Bedeutung,
SAGGI
sopra articolate. Questa prossimità marca l’enigma della voce: il rapporto a sé
precede (Husserl) o segue (Derrida) il darsi della voce nel sentirsi-parlare? Per
Derrida, il corpo sensibile della voce collabora alla costituzione della coscienza: non vi è trascendentale puro, ma ogni legalità delle strutture fenomenologiche è contaminata con la fattualità. La distinzione tra empirico e trascendentale si dà solo nel linguaggio che istituisce le differenze insieme alla presa di
coscienza e, tuttavia, tale distinzione rimanda ad un passato mai attualizzabile,
ad uno sfondo “sintetico a priori” che ha prodotto la distinzione pur non essendo mai stato presente (alla coscienza): il movimento della différance (VF, 103).
La prossimità della voce alla coscienza, data dalle caratteristiche fenomeniche dell’immediatezza e della trasparenza, costituisce il mezzo, l’etere, che
permette di esprimere un senso presente a sé, precedente in via di diritto l’espressione, ma che di fatto è inseparabile dall’incarnazione linguistica. Così la
voce fenomenologica, marcando “l’unità del suono e della voce” (VF, 117), si
dà come il fenomeno privilegiato della fenomenologia in quanto, attraverso il
proprio statuto di trascendenza apparente, fonda il campo trascendentale
costituendo la differenza tra il mondano e il trascendentale. Nella prossimità a
sé del “sentirsi parlare”, nella necessità che lega l’idealità formale dell’elemento fonico e la presenza ideale della Bedeutung alla coscienza, il corpo
sensibile del segno linguistico sembra cancellarsi nel momento in cui è pronunciato, per darsi come trasparenza che restituisce il voler-dire in modo
immediato. È attraverso questo “lavoro” della voce fenomenologica che, per
Derrida, il fonema risulta essere il più ideale dei segni dandosi come “l’idealità dominata del fenomeno” (VF, 116). Pertanto, la voce è pensata da Derrida
come sintesi di attività e passività, espressione e comprensione, circolo perfetto che permette da un lato la riduzione fenomenologica dalla singolarità
empirica del segno all’universalità ideale della Bedeutung nell’espressione
pura e dall’altro il dominio della presenza e dell’intuizione nella comunicazione linguistica (VF, 118) nel momento in cui si postula la prossimità assoluta del
significato al significante ridotto a forma ideale dalla voce: “La voce è l’essere
accanto a sé nella forma dell’universalità, come co-scienza. La voce è la
coscienza” (VF, 118).
La fenomenologia allora –in quanto scienza eidetica sorta dalla riduzione
della fattualità empirica all’essenzialità dei puri vissuti di coscienza– è resa possibile dalla prossimità ideale della Bedeutung al fonema attuata da e nella voce
in quanto fenomeno della coscienza. La lettura derridiana di Husserl sottolinea,
quindi, il legame necessario tra l’elemento del mondo-della-vita della voce in cui
si radica la coscienza trascendentale e l’elemento ideale della Bedeutung (VF,
114-115). La critica di Derrida, che si attua nel decostruire la continuità cercata
da Husserl tra la vita e l’idealità (VF, 39), può allora giungere alla considerazione del rimosso: “Come capire questa riduzione del linguaggio quando Husserl,
dalle Logische untersuchungen fino all’Origine della geometria, non ha cessato di considerare che non […] solo il linguaggio parlato ma l’iscrizione è indispensabile alla costituzione di oggetti ideali […]?” (VF, 118).
Il gesto di Derrida, interrogando a ritroso l’opera husserliana mostra che,
come l’idealità della Bedutung è correlata alla struttura di ripetizione del segno,
37
38
così alla costituzione del linguaggio “scientifico” (come telos della logica) è
necessaria l’incarnazione della voce nella scrittura fonetica che ne permette la
trasmissione. Pertanto, nel manifestarsi della scrittura al cuore della costituzione dell’oggetto ideale si annuncia en retour la tensione che contesta dall’interno la decisione delle “distinzioni essenziali”: la non-presenza originaria
propria dell’atto di scrittura viene ad abitare la presenza dell’oggetto ideale
Bedeutung, dato nella prossimità a sé del sentirsi-parlare. Per Derrida,
Husserl –avendo decretato la necessità genetica della scrittura per l’idealità–
ha permesso a posteriori il riconoscimento dell’essenzialità del lavoro del
significante (e per estensione del segno indicativo) all’origine del senso.
Conseguentemente, Derrida può affermare l’originarietà dell’intreccio di
espressione ed indicazione secondo la logica del “supplemento originario”: la
contaminazione precede, come un limite assoluto dell’analisi, la presunta
distinzione tra l’interiorità della voce e l’esteriorità della scrittura. Per essere
tale, la presenza del voler-dire alla coscienza nell’espressione del soliloquio
necessita della esteriorità quasi-trascendentale del “codice linguistico”, tradizionalmente associato all’ordine della contingenza empirica dell’indicazione.
In questo senso, la rivalutazione del segno indicativo nella costituzione stessa del campo trascendentale operata da Derrida conduce alla nozione di “supplementarietà originaria” che, attribuendo la struttura dell’“al posto di” propria
del segno all’autodonazione fenomenologica, trasla il risultato filosofico delle
analisi fenomenologiche da un idealismo dell’immediatezza ad una filosofia
della “rappresentazione originaria”. Questa traslazione –quasi parodia del
gesto di Ricoeur– si concretizza, a partire dai margini del testo husserliano,
dopo aver indicato come l’essenza del linguaggio derivi dall’intreccio originario
di espressione ed indicazione, nella decisione di mostrare la necessità della
non-pienezza alla struttura espressiva del voler-dire. In questo modo, Derrida
può esplicitare la dialettica di assenza e presenza che regge l’interpretazione
della Bedeutung come voler-dire. Tale dialettica si determina a partire dalla concatenazione di significazione, idealizzazione e ripetizione nella descrizione del
rapporto tra il segno e il senso. In altre parole, ciò che è presente alla coscienza è un vissuto marcato, realisticamente, da un ritardo31 del pensiero sull’essere ed incarnato nella complicità inscindibile della voce e del fenomeno.
Attraverso la voce e la struttura di ripetizione del segno –che la precede costituendola come linguaggio– si procede all’idealizzazione dell’hic et nunc sfuggente dell’evento “vissuto”: “Il per-sé sarebbe un al-posto-di-sé: messo per sé,
invece di sé. Qui appare la strana struttura del supplemento: una possibilità
produce a ritardo ciò cui è detta aggiungersi” (VF, 128). È così che Derrida ci
introduce al “pensiero della scrittura” a partire dalla fenomenologia.
Lo statuto della scrittura, che non si aggiunge all’oralità se non perché l’aveva costituita da sempre, mostra il movimento della différance e della supplementarietà originaria, in riferimento alla differenza tra intenzione e intuizione, tra linguaggio e conoscenza ritrovata ai margini della fenomenologia. La
fenomenologia della contaminazione proposta da Derrida si risolve in una filosofia della rappresentazione originaria (Bernet) che culmina nel riconoscimento delle condizioni per cui “la cosa stessa si sottrae sempre” (VF, 145)
Conclusioni
All’interpretazione ricoeuriana di Husserl, che imposta i rapporti tra segno
e senso secondo la logica della dialettica “a sintesi aggiornata” tendente al
superamento contestuale dell’opacità del segno, Derrida oppone una concezione che articola sullo stesso piano i due lati della dicotomia. Tale relazione
richiama, nel movimento della différance, il problema della “sintesi a priori” che
indica come il “reale” preceda, senza darsi nella forma dell’origine, il distribuirsi
gerarchico delle opposizioni tradizionali. All’interno di questo dibattito, condotto ai margini della fenomenologia, l’elemento discriminante è da ritrovarsi nella
potenza di risignificazione offerta dalla considerazione del tema della genesi
passiva32, la cui fecondità si è da poco appreso ad apprezzare nella retta considerazione delle aporie che sorgono dall’eterno enigma dei rapporti tra pensiero ed essere. In questo senso, si può leggere La voce e il fenomeno come
un tentativo di pensare l’essenza del linguaggio “in quanto tale”, ovvero come
qualcosa che –nella sua “materialità”– anticipa, organizza e contribuisce a
generare l’orizzonte del senso. Pertanto, se per Ricoeur il valore del linguaggio si misura nella capacità di rivelare il senso compreso oltre il segno ricevuto, in Derrida il gioco tra segno e significato è chiamato a produrre nuove connessioni irriducibili al processo archeo-teleologico dell’espressione e perciò
non sottomesse al dominio della coscienza.
E. MELANDRI, Contro il simbolico. Dieci lezioni di filosofia, Ponte alle Grazie, Firenze 1989, p. 36.
La frase di è Derrida tratta dalla trascrizione del dibattito con Ricoeur e altri, seguito al XV∞
Congresso dell’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Francaise, tenuto a Montreal
nel 1971, dove Ricoeur presentò l’intervento Discours et communication e Derrida espose la conferenza Signature événement contexte. La trascrizione è stata pubblicata in Appendice a L.
LAWLOR, Imagination and chance. The difference between the thought of Ricoeur and Derrida,
State University of New York Press, Albany N.Y. 1992, p. 137.
3
J. DERRIDA, La voix et le phénomène, PUF, Paris 1967; trad. it. di G. Dalmasso, La voce e il
fenomeno. Introduzione al problema del segno nella fenomenologia di Husserl [VF], terza ed. riv.
e aggiornata, Jaca Book, Milano 1997.
4
Da un certo punto di vista, il rapporto di Derrida con la fenomenologia husserliana, ed in particolar modo con il gesto della riduzione che ne consente l’esercizio, può essere descritto come
un reiterato indugiare sulla soglia, un differire il momento del passaggio dall’atteggiamento naturale a quello fenomenologico. Soffermarsi sulla struttura di rinvio del segno significa allora differire il compimento della fenomenologia come metafisica della presenza. Cfr. J. DERRIDA, La différance (1968) in Marges – de la philosophie, Les Editions de Minuit, Paris 1972; trad. it. a cura di
1
2
SAGGI
lasciando spazio alla fecondità del pensiero che si dà grazie a questa assenza. La permanenza sul segno, aprendo lo spazio dell’associazione involontaria e della genesi passiva, diviene così produttiva senza per questo essere originaria o fondante. Dicendo, senza voler-dire.
39
40
M. Iofrida, Margini [M], Einaudi, Torino 1997, p. 36.
5
Importante, benché pressoché non considerato, è il fatto che Derrida abbia collaborato con
Ricoeur durante quattro anni sicuramente decisivi per l’elaborazione del pensiero di entrambe. Cfr.
G. BENNINGTON, J. DERRIDA, Jacques Derrida, Edition du Seuil, Tours 1991, p. 303: “1960-1964
enseigne à la Sorbonne (“philosophie générale et logique”: assistant de S. Bachelard, G.
Canguilhlm, P. Ricoeur, J. Wahl)”. Inoltre, P. RICOEUR, Riflession fatta. Autobiografia intellettuale,
Jaca Book, Milano 1998, p. 56: “Il mio seminario di fenomenologia, la cui direzione ho condiviso
con J. Derrida fino alla sua partenza per la Ecole normale supérieure, soddisfaceva le mie aspettative; […] al suo interno mettevo alla prova i temi della mia ricerca, cosa che consentì che il titolo
di questo seminario di fenomenologia si estendesse all’ermeneutica e alla filosofia del linguaggio”.
6
E. HUSSERL, Ricerche logiche, trad. it. di G. Piana, Il Saggiatore, Milano 1968; in part. Prima
ricerca “Espressione e significato” [RL 1], pp. 289-374.
7
P. RICOEUR, Philosophie de la volonté 2. Finitude et culpabilité, I. L’homme faillible, II. La
symbolique du mal, Aubier, Paris 1960; trad. it. di M. Girardet Sbaffi, Finitudine e colpa [FC], intr.
di V. Melchiorre, Il Mulino, Bologna 1972.
8
H.J. POS, “Phénoménologie et linguistique” in Revue Internationale de Philosophie, n. 2,
1939. M. MERLEAU-PONTY, “Sulla fenomenologia del linguaggio” in Segni, Il Saggiatore, Milano
1967, pp. 117-134.
9
Riguardo a tale reciprocità del dire e del vedere, Ricoeur afferma che “su questo punto coincidono la prima delle Ricerche logiche di Husserl e i primi capitoli della Fenomenologia dello spirito di Hegel” (FC, 99). Ho sottolineato questa alleanza soprattutto perché essa, proprio riguardo
alla posizione del segno, costituirà uno dei principali obiettivi della decostruzione derridiana, il che
rinforza la nostra ipotesi iniziale. Cfr., “Il pozzo e la piramide. Introduzione alla semiologia di
Hegel” (1968), in M, pp. 105-152.
RL 1, § 10, p. 306: “Sia la rappresentazione della parola sia l’atto significante sono dati in
un’esperienza vissuta; tuttavia, mentre viviamo la rappresentazione della parola, non viviamo
affatto in essa, ma esclusivamente nell’effettuazione del suo senso, del suo significato. E mentre facciamo ciò, mentre siamo impegnati nella effettuazione dell’intenzione significante ed eventualmente del suo riempimento, tutto il nostro interesse è diretto all’oggetto che in essa viene
inteso e che mediante essa viene denominato”.
10
FC, p. 100: “Ciò che è detto, il lekton del mio leghein, il dictum di ogni dictio, trascende,
come unità ideale del senso, il semplice vissuto dell’enunciato”.
11
P. RICOEUR “La structure, le mot et l’évènement” (1967) in Le conflit des interprétations.
Essais d’herméneutique, Seuil, Paris 1969; trad. it. di R. Balzarotti, F. Botturi, G. Colombo, “La
struttura, la parola, l’avvenimento” in Il conflitto delle interpretazioni [CI], Jaca Book, Milano 1977,
p. 99: “Per noi che parliamo il linguaggio non è un oggetto ma una mediazione, è ciò attraverso
cui, per mezzo del quale, noi ci esprimiamo ed esprimiamo le cose. Parlare è l’atto che supera la
chiusura dell’universo dei segni, nell’intento di dire qualcosa su qualcosa a qualcuno. Parlare è
l’atto con cui il linguaggio supera se stesso come segno, verso il suo riferimento e verso ciò che
gli sta di fronte. Il linguaggio vuole scomparire, vuole morire come oggetto”.
12
D. IHDE, Hermeneutic Phenomenology. The philosophy of Paul Ricoeur, Northwestern
University Press, Evanston 1971, p.168 e ss.
13
La posizione è già presente in “Etude sur les ‘Meditations Cartésiennes’ de Husserl” (1954)
in P. Ricoeur, A l’école de la phénoménologie, Vrin, Paris 1986 p.179-180: “Le langage est possible a priori parce que se trascender, pour la coscience, c’est anticiper le même dans l’autre, presumer le sens unifiant de cette altérité. La coscience est parente du Logos, en ceci qu’elle se
dépasse dans l’identique […] Le ‘merveilleux’, pour Husserl, c’est précisément que par le fluant et
le potentiel il y ait ‘sens’ ”.
14
CI, p. 262. Attorno a questo punto gravitano, del resto, il senso dell’originalità eretica di
Ricoeur rispetto ad Husserl, la possibilità di fondare sulla fenomenologia sia la linguistica strutturale che la speech acts theory e la fondamentale critica derridiana al logocentrismo fenomenologico. Cfr. anche: J. DERRIDA, “La forma e il voler-dire. Nota sulla fenomenologia del linguaggio”, in
M, pp. 209-231.
15
P. RICOEUR, La sfida semiologica [SS], antologia a cura di M. Cristaldi, Armando, Roma
1974, p. 110.
16
E. HUSSERL, Ricerche logiche, vol. II, op. cit., pp. 296-548.
SAGGI
17
G. FREGE, “Uber Sinn und Bedeutung” (1892), trad. it. “Senso e denotazione” in A. Bonomi
(a cura di), La struttura logica del linguaggio, Milano, Bompiani 1973, pp. 9-32. Di Frege, Ricoeur
accoglie due elementi: la distinzione tra ciò che un’espressione linguistica dice (Sinn) e ciò intorno a cui quella viene detta (Bedeutung); e il movimento che porta il linguaggio a trascendere il
Sinn verso la Bedeutung.
18
CI, p. 101: “Proviamo a distinguere con Frege, Sinn e Bedeutung, o, con Husserl,
Bedeutung ed Erfüllung: in questo modo viene articolata un’intenzione significante che rompe la
chiusura del segno, che apre il segno sull’altro, insomma che costituisce il linguaggio come un
dire, un dire qualcosa su qualcosa. Il momento in cui si produce il volgersi dall’idealità del senso
alla realtà della cosa, è il momento della trascendenza del segno. Questo momento è contemporaneo alla frase.” In questa sede non posso approfondire se la tesi di Ricoeur sia filologicamente
sostenibile. Il problema di Ricoeur è quello di far dialogare la filosofia analitica e la fenomenologia, quello di Derrida sembra opposto. Ricorderò solo, a questo riguardo, che Derrida distingue
sempre Husserl e Frege. Ad es., cfr. J. DERRIDA, Positions, Editions de Minuit, Paris 1972; trad. it.
di M. Chiappini e G. Sertoli, Posizioni. Scene, atti, figure della disseminazione [POS], Ombre corte
edizioni, Verona 1999, p. 40: “Il senso è la fenomenalità del fenomeno. Nelle Ricerche logiche,
Husserl rifiutava la distinzione di Frege fra Sinn e Bedeutung. Più tardi, essa gli parve utile, ma
non nell’accezione in cui l’intendeva Frege, bensì per indicare la divisione fra il senso nella sua
estensione più generale (Sinn) e il senso come oggetto di un enunciato logico o linguistico, il
senso cioè come significazione.”
19
F. De SAUSSURE, Corso di linguistica generale, tr. it.di T. de Mauro, Laterza, Bari 1983; Cfr.
inoltre: L. HJEMSLEV, I fondamenti della teoria del linguaggio, Einaudi, Torino 1968. Inoltre, cfr. P.
RICOEUR, “Les probléms du langage” in Cahiers de Philosophie, n. 2-3, 1966, pp. 27-41.
20
J. L. AUSTIN, Come fare cose con le parole, Marietti, Genova 1987; J. R. SEARLE, Atti linguistici, Boringhieri, Torino 1976. Cfr. inoltre: L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino
1999. Sulla continuità tra questa corrente filosofica e la fenomenologia husserliana, cfr. P.
RICOEUR, “Husserl e Wittgenstein sul linguaggio” (1968) in Filosofia e linguaggio, antologia a cura
di D. Jervolino, Guerini, Milano 1994, pp. 81-94; P. RICOEUR, “Fenomenologia e filosofia analitica”
in La sfida della semiologia, op. cit., pp. 105-115.
21
P. RICOEUR, Filosofia e linguaggio, op. cit., pp. 10-11. Tale prospettiva ricoeuriana trova il proprio corrispettivo scientifico nella teoria dei livelli linguistici proposta da E. BENVENISTE, Problemi di
linguistica generale, Il Saggiatore, Milano 1990.
22
Pur non potendo soffermarmi su questo punto, rimando il lettore alle argomentazioni espresse in J. DERRIDA, Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl (1953-1954), PUF,
Paris 1990; tr. it. di V. Costa, Il problema della genesi nella filosofia di Husserl [PG], Jaca Book,
Milano 1992. Tale opera –come ha ampiamente dimostrato V. COSTA, La generazione della forma.
La fenomenologia e il problema della genesi in Husserl e in Derrida, Jaca Book, Milano 1996–
risulta imprescindibile per una piena comprensione della legittimità della lettura derridiana.
23
E. MELANDRI, Le “Ricerche logiche” di Husserl. Introduzione e commento alla Pima ricerca,
Il Mulino, Bologna 1990, p. 155 e ss.
24
Questa divergenza annuncia già quella tra “polisemia controllata” e “disseminazione”. Cfr.
CI, pp. 107-108; J. DERRIDA, La dissemination, Seuil, Paris 1972; tr. it. di S. Petrosino e M. Odorici,
La disseminazione, Jaca Book, Milano 1989, p. 267 e pp. 356-357.
25
VF, p. 75: dove Derrida fa riferimento alla “rappresentazione nella fantasia” della parola in
Husserl (op. cit., p. 303). Il fenomeno dell’immagine della parola permette a Derrida di richiamarsi a Saussure (Cours de linguistic générale, cit. in VF, 78-79) che identifica, secondo il nostro autore, “significante” ed “immagine acustica”. Il parallelo, tuttavia, non compromette la lettura di
Husserl: Derrida distingue chiaramente i due autori. Quindi, a mio giudizio, la lettura di Derrida non
può essere accusata semplicemente di aver confuso l’ordine semiologico con quello semantico.
L’interpretazione di Husserl data in VF può essere definita “post-strutturalistica” in quanto prende
atto della concezione linguistica del segno, senza, tuttavia, fraintendere l’impianto della ricerca
fenomenologica.
26
E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, tr. it. di E.
Filippini, Einaudi, Torino 1965, § 70, pp. 148-151.
27
Cfr. l’ottimo studio di R. BERNET, “La voix de son maître” in Revue philosophique, n. 2, Paris
1990, pp. 147-166. Ora in La vie du sujet. Recherches sur l’interpretation de Husserl dans la phé-
41
42
noménologie, PUF, Paris 1994, pp. 267-296.
28
VF, pp. 83-84: “Un fonema o un grafema è sempre necessariamente altro, in una certa misura, ogni volta si presenta in un’operazione o una percezione, ma può funzionare come segno e
linguaggio in generale soltanto se un’identità formale permette di riprenderlo e di riconoscerlo.
Questa identità è necessariamente ideale. Essa implica dunque necessariamente una rappresentazione: come Vorstellung, luogo dell’idealità in generale, come Vergegenwärtigung, possibilità della ripetizione riproduttiva in generale, come Repräsentation, in quanto ogni avvenimento
significante è sostituito (del significato come pure della forma ideale del significante). Dato che
questa struttura rappresentativa è la significazione stessa, io non posso avviare un discorso ‘effettivo’ senza essere originariamente impegnato in una rappresentatività indefinita.” Per la comprensione di questo difficile passaggio, forse il più originale e il più frainteso di VF, è bene tenere
presente E. HUSSERL, Logica formale e trascendentale. Saggio di critica della ragion logica,
Laterza, Bari 1966, p. 26: “Il linguaggio ha l’oggettività che compete alle oggettualità del cosiddetto mondo spirituale o mondo di cultura, e non quella propria della pura natura fisica. In quanto formazione spirituale obiettiva il linguaggio ha le stesse proprietà delle altre formazioni spirituali.
allo stesso modo noi distinguiamo dalle mille riproduzioni di un’incisione l’incisione stessa, e quest’incisione, l’immagine incisa stessa, è quella che viene guardata attraverso ciascuna riproduzione, e che è data in ciascuna allo stesso modo come un ideale identico. D’altronde, è soltanto
sotto la forma di riproduzione che essa ha esistenza nel mondo reale.”
29
VF, p. 86. Inoltre cfr. R. BERNET, Op. cit., p. 279: “L’apprèhension d’un objet idéal, par exemple la forme sonore identique (type) du mot ‘lion’ se rèalise en effet le plus aisément au moyen
d’une variation imaginaire: je m’imagine différentes personnes prononçant ce mot avec des
accents, des intonations et des intensitès variables pour faire apparaître le ‘type’ commun de ces
multiples tokens du mot ‘lion’ ”.
30
VF, p. 127: “La dif-ferenza deve essere pensata prima della separazione tra il differire come
ritardo e il differire come lavoro attivo della differenza. Beninteso, ciò è impensabile a partire dalla
coscienza, cioè dalla presenza, o semplicemente dal suo contrario, l’assenza o la non coscienza”.
31
E. HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, a cura di P. Spinicci, trad. it. di V. Costa, Guerini e
Associati, Milano 1993. Inoltre: V. COSTA, La generazione della forma, op. cit.
RIPENSARE LA “NORMALITÀ”.
LA NOZIONE STRUTTURALE DI NORMALITÀ
IN MERLEAU-PONTY
SAGGI
di Sergio Franzese
Quella di “normalità” è una delle nozioni più difficilmente definibili e poliedriche e senz’altro una di quelle che ha suscitato le più accese polemiche. È una
nozione problematica e sfuggente, circondata da un alone di pericolosità sociale, perché può facilmente veicolare pressioni, repressioni e discriminazioni
all’interno di una collettività. Il prevalere in ambito decostruzionista e postmoderno del prospettivismo pluralistico delle “formazioni discorsive” (Foucault) e
dei giochi linguistici sulle “metanarrazioni totalizzanti” (Lyotard), sui sistemi
delle verità universali ed eterne, ha portato progressivamente alla condanna ed
al tentativo di eliminazione totale della nozione di normalità, intesa come strumento di potere e sopraffazione del potere istituzionale e costituito, espressione di una classe dominante, contro il diverso, il dissidente, l’Altro.
Per contro, il linguaggio comune ha continuato a fare uso dei sostantivi e
degli aggettivi inerenti alla “normalità”, uso evidentemente legittimato dal fatto
che nella visione comune del mondo, al di là delle teorizzazioni e degli ideologismi, esiste qualcosa che risponde alla nozione di normalità. La domanda
quindi è se invece di procedere all’eliminazione di questa nozione, non sia
piuttosto il caso di ridefinirla, pur avendo ben presente la sua congenita ed ineliminabile pericolosità e la necessità di limitare i suoi rischi.
Il riferimento al linguaggio come fondamento di legittimazione della normalità sembrerebbe piuttosto sdrucciolevole per l’indeterminatezza e le ambiguità che questo uso rivela. L’aggettivo “normale” ed il sostantivo “norma”, da cui
deriva, assumono, in diversi contesti e prospettive significati assolutamente
divergenti tra loro. Nella lingua italiana, a cui faccio principalmente riferimento, il significato del termine “norma” passa dal più consolidato uso etico e giuridico, a quello medico di parametro fisiologico, a quello sociale, come “uso”,
“consuetudine”. L’aggettivo “normale” oscilla in un ampio spettro semantico, in
funzione del contesto in cui è impiegato, come sinonimo di “ovvio”, “logico”,
“giusto”, “consueto”, “coerente”, “usuale”, “solito”, “comune”, “naturale”1.
Tuttavia al disotto di questa polivalenza è possibile rintracciare un carattere
comune ai diversi significati, che nel loro insieme tendono a definire un comportamento che in maniera evidente si dispone secondo una logica comune e
condivisa e che si manifesta con ampia frequenza. La nozione di normalità
riguarda la relazione comportamentale tra soggetto ed ambiente o, se si preferisce tra soggetto e mondo, ed è all’interno della polarità soggetto-mondo che
viene a costituirsi la norma in relazione alla quale si determina la normalità.
È ipotizzabile allora che il problema della normalità e della sua inafferrabi-
43
lità si nasconda in questo dualismo tra soggetto e mondo, che discende dal
dualismo del soggetto cartesiano. Diventa allora necessario riprendere la
nozione di normalità sulla base del superamento del dualismo cartesiano e di
una concezione che reintegri in un’unità organica soggetto e mondo, ridefinendoli l’uno in rapporto all’altro.
1. Corpo, mondo e logos.
Il fondamento di un’ermeneutica percettiva
44
1.1 Norma come stile di comportamento. Trascendenza e lavoro
La definizione del soggetto e del suo rapporto col mondo si sviluppa progressivamente nelle opere di Merleau-Ponty, secondo fasi successive che si
sovrappongono e si incorporano l’una nell’altra.
La prima fase è strettamente legata all’influsso di K. Goldstein2. Gli studi di
Goldstein su soggetti cerebrolesi affetti da disturbi neuromotori evidenziavano
un quadro di disfunzione unitario con gradi progressivi di disintegrazione del
comportamento all’interno di un organismo visto come totalità (struttura) vivente inscindibile dal suo ambiente. In questa visione la malattia si definiva come
perdita di libertà in relazione all’ambiente, incapacità di sottrarsi alla situazione contingente e ai suoi stimoli, per declinarsi al futuro. In quest’ottica la facoltà spirituale non si oppone alla vita organica, ma ne è la capacità di prevedere il possibile, di sospendere l’attuale in vista del possibile e dell’adattamento
all’ambiente, ovvero la sua libertà.
Ne La struttura del comportamento 3 le tematiche di Goldstein si intersecano con la fenomenologia husserliana e con la Gestaltpsychologie. La critica
alla coscienza pura e alla soggettività assoluta di Husserl, basata sulla irriducibilità del corpo porta Merleau-Ponty a reimpostare il rapporto coscienzamondo a partire dalla corporeità e dalla percezione, intesa come rapporto originario di coscienza e mondo, al di là dell’antitesi tra idealismo ed empirismo.
L’analisi pontiana supera la diade soggetto-mondo per considerare il comportamento come fenomeno originario unitario in cui soggetto e mondo sono sempre “in presa” l’uno sull’altro. L’influenza gestaltiana permette di formulare una
definizione di comportamento come struttura, quindi come di una totalità dotata di un principio di differenziazione interno, contenente a sua volta un principio di unità di significato. In questa forma la struttura comportamentale assume il valore di un apriori, che non è più un apriori del solo soggetto puro, ma
è apriori del rapporto bipolare soggetto-mondo.
Il comportamento in quanto struttura si differenzia, a seconda della sua
appartenenza al mondo organico o inorganico, in base ad una differente struttura normativa che ne costituisce in qualche modo l’essenza. In quest’ambito
Merleau-Ponty enuncia due definizioni di norma, entrambe riferite alla struttura organica. La prima in cui la norma si dà come essenza della specie, ovvero come insieme di costanti individuali che esprimono le condizioni ottimali di
relazione all’ambiente e di attività: una norma vissuta che coincide con il pro-
Per norma qui non si intende un dover essere che faccia l’essere, ma la semplice conservazione di un atteggiamento privilegiato, statisticamente più frequente,
che dà al comportamento una unità di un genere nuovo. […] la struttura ideale di
un comportamento permette di connettere lo stato presente di un organismo ad
uno stato anteriore assunto come dato, di vedere in esso la realizzazione progressiva di un’essenza già intravedibile in quello stato, senza che mai sia possibile passare al limite o fare dell’idea una causa dell’esistenza (SC, pp. 259-260).
La norma caratterizzante la struttura umana è –e non si può fare a meno
di notare la consistente matrice hegeliana, presente in Merleau-Ponty attraverso la sua mediazione francese– la dialettica mondo-coscienza-lavoro, in
cui il lavoro, ovvero l’azione che si effettua nel mondo per trasformarlo e che
quindi parte dal mondo per ritornarvi, costituisce il punto centrale, la mediazione, del rapporto soggetto-mondo. Questa concezione richiede una rielaborazione della nozione di coscienza, che deve essere liberata dal suo ruolo di
attività psicologica pura, di facoltà della rappresentazione e del giudizio, per
essere ricombinata con una nozione di azione estesa al di là del suo aspetto
puramente motorio e organicistico. Questo si può ottenere, per Merleau-Ponty,
riportando alla luce quella attività conoscitiva originaria e fondante che è la
percezione, e evidenziandone la stretta correlazione e l’interdipendenza con
l’azione. Tramite la percezione si produce il superamento dell’in sé e del per
sé sulla base di un terreno in cui questa separazione non appare. La percezione è apertura immediata dell’esistenza al mondo e all’altro che precede la
formazione di significati intelligibili. Tuttavia il mondo a cui l’uomo si apre è
diverso da quello a cui si indirizzano gli altri esseri viventi. Il mondo naturale
dell’uomo è il mondo culturale e la percezione si apre direttamente su un
mondo di significati umani, che vengono vissuti senza mediazione intellettuale di una coscienza tetica. Il soggetto della percezione è un soggetto senza
identità, ovvero un’apertura anonima sul mondo per la quale la conoscenza è
una “co-nascenza” in virtù della quale esiste una “comunione” precosciente tra
soggetto e cose. “Nella percezione la soggettività è una soggettività naturale
un ‘io posso’ che non è un ‘io penso che’…”. Emerge qui la fondamentale
tematica dell’“io posso”, come soggetto precosciente e corporeo, che costituisce uno dei punti di maggior rilievo di tutto il pensiero pontiano. Il soggetto percipiente è soggetto pragmatico, ed esiste una relazione di senso vissuta tra
soggetto percipiente e cosa percepita, che è mediata dal corpo, in un rapporto di senso circolare. Ne consegue che l’attività rappresentativa tradizionalmente fatta coincidere con la coscienza deve essere considerata solo un
aspetto della vita di coscienza. Essa è qualcosa che si sviluppa all’interno
della coscienza stessa, ma non rappresenta lo stadio supremo dello sviluppo
della coscienza, piuttosto convive con un’altra forma di coscienza, preriflessiva o irriflessa, che la precede geneticamente e quindi trascendentalmente. La
vita della coscienza irriflessa e la percezione si rivelano allora essere un’unica e medesima cosa, nel loro ancoraggio corporeo che le mantiene sempre “in
SAGGI
prio essere. La seconda in cui la norma è l’apriori biologico di un individuo e
può essere considerata analoga alla nozione husserliana di Stile.
45
46
presa” sul mondo e sugli oggetti. È il corpo allora che si trascende verso il
mondo in un’azione che è espressione e creazione di significati. Il corpo è
coscienza irriflessa, percezione e in quanto tale è simbolico e significante per
sua natura.
Nella sua vita irriflessa la coscienza umana assume ed esprime la trascendenza del corpo, che non è contemplazione, ma costruzione continua di
un tracciato in cui vettori d’azione intersecano immaginariamente le linee di
una rete di intenzionalità secondo un’unità ed un orientamento di senso che è
l’esistenza stessa dell’individuo. Nella trascendenza del corpo si radica quell’atteggiamento peculiare dell’ordine umano che è il lavoro, come creazione e
trasformazione di significati umani e di oggetti culturali.
Corporeità e cogito sono i due poli fondamentali dell’analisi del radicamento del soggetto nel mondo, che costituisce la tematica centrale della
Fenomenologia della percezione.4 L’analisi dei casi neuropatologici presentati
da Goldstein e dei soggetti schizofrenici di Minkowski, porta Merleau-Ponty
verso una “analisi esistenziale” che permette di mettere in luce le strutture fondamentali dell’esistenza al di sotto della destrutturazione patologica.
Il confronto tra il “soggetto normale” e il malato, mantiene nell’opera pontiana la presunta identità di anormalità e patologia. Il soggetto normale si apre
nella percezione ad un rapporto immediato con il mondo, è il latore di un pensiero vivente che non comprende per sussunzione, ma coglie l’evidenza “antepredicativa” del mondo e degli oggetti. Allo stesso tempo il soggetto normale
in virtù della struttura propria del comportamento umano, si apre al virtuale e
crea con il suo corpo spazi e mondi simbolici che sono lo sfondo dei suoi movimenti. Questo potere di restare in presa col mondo trascendendolo è la libertà del soggetto, la libertà di “mettersi in situazione”, che è il modo caratteristico della sua esistenza.
Questo presuppone una fondamentale univocità del rapporto col mondo,
inteso come unico orizzonte di realtà a cui il soggetto può e deve riferirsi, e
rispetto a cui tutti i mondi “umani” sono sempre secondi e derivati. Presuppone
inoltre un soggetto dotato di un universale ed originario “montaggio” sul
mondo, tale da costituire un insuperabile parametro di comportamento e di
giudizio.
1.2 Urdoxa e precomprensione
Così l’analisi dell’atto percettivo mostra la percezione come fenomeno originario di apertura in cui il soggetto corporeo si incontra con le cose e con gli
altri sullo sfondo di un mondo originario unico che fornisce la garanzia ultima
di senso. Il sistema “io-altri-cose” è la struttura fondamentale della soggettività in quanto “essere-al-mondo”. Questa struttura è la condizione prima ed originaria dell’esperienza di un soggetto che non è una semplice coscienza, ma
un’esistenza corporea. Il superamento del soggetto cartesiano nella teoria dei
“due Io”, porta Merleau-Ponty a concepire una fondazione corporea del soggetto che sfugge di necessità alla coscienza tetica. Il corpo deve essere inteso come un io naturale ed anonimo che mi àncora nello spazio e nel mondo
in virtù di un patto ancestrale collocato nella preistoria della specie. L’esistenza
SAGGI
individuale è l’intreccio di una coscienza riflessiva e di un io impersonale, di
una dialettica di esistenza personale e anonima, inscindibili l’una dall’altra. La
percezione si radica nel flusso di esistenza impersonale, sull’io corporeo che
nel suo ancoraggio sul mondo è la condizione di possibilità di esperienza.
L’esperienza a sua volta riassorbendo in sé la nozione tradizionale di coscienza, in quanto riflessione su di un irriflesso che la fonda, rimanda al mondo
come all’orizzonte permanente di tutti i miei atti, come al “corrispettivo di una
teleologia corporea”, delineando il rapporto di “fundierung” che lega reciprocamente soggetto e mondo. Merleau-Ponty assume qui come elemento centrale della sua concezione la nozione husserliana di “intenzionalità fungente”
Che costituisce l’unità naturale e ante-predicativa del mondo e della nostra vita, che
appare nei nostri desideri, nelle nostre valutazioni, nel nostro paesaggio più chiaramente che nella nostra conoscenza oggettiva, e che fornisce il testo di cui le nostre
conoscenze cercano di essere la traduzione in linguaggio esatto (FP, p. 27).
Il veicolo dell’intenzionalità fungente è il corpo proprio e il suo effettualizzarsi è la percezione. Il soggetto definito in questo modo è eminentemente
pratico, un soggetto che, come avevamo già visto ne La struttura del comportamento, ha nell’azione, nel “lavoro” (hegelianamente inteso), nella “praxis”,
più che nella contemplazione o nella teoresi, i suoi fini prioritari. Il corpo non
appartiene alla regione dell’in sé, ma è installato in una zona di esistenza in
cui l’in sé e il per sé coesistono in una specie di “accoppiamento”, che è il rapporto intenzionale veicolato dal senso dell’oggetto, che si dà come costituito.
L’esperienza del corpo ci fa allora riconoscere una “imposizione di senso” che
non è quella della coscienza costituente universale, un senso che aderisce a
certi contenuti e dei significati che il corpo può comprendere e che, per altri
versi, è esso stesso a istituire.
Il mio corpo è la testura comune di tutti gli oggetti ed è, per lo meno nei confronti del mondo, lo strumento generale della mia comprensione. È il corpo a dare un
senso non solo all’oggetto naturale, ma anche ad oggetti culturali (FP, p. 294).
Su queste basi, la percezione individuale assume allora il valore di un’ermeneutica preriflessiva ed antepredicativa dell’oggetto, in cui si decifrano
significati umani che non è stata lei a costituire. Questa “comprensione” che,
come abbiamo visto, è nozione eminentemente pratica (essa è sinonimo di
“poter fare qualcosa”), coincide con il movimento stesso dell’esistenza.
Esistere è comprendere, e il “senso” è la nozione di compenetrazione ermeneutica della soggettività e del mondo in un’unità all’interno della quale si
muove la vita, che costituisce l’orizzonte di comprensibilità di una cosa. In
esso si esprime una sorta di “pre-comprensione”, la quale precede sempre e
rende possibile. la comprensione vera e propria delle cose.
La possibilità di una pre-comprensione è legata, in Merleau-Ponty, all’esistenza di una “logica del mondo” secondo la quale i sensi “sanno” come leggere ciò che si presenta alla loro ispezione e più in virtù della quale il mio
corpo e la mia percezione “sanno” cosa significhi un oggetto e come esso si
47
situi nel mondo (cfr. FP, p. 425). La nostra comprensione dell’oggetto è infatti
legata ad un mondo “di cui portiamo con noi le strutture fondamentali” e che
garantisce la coerenza e la verità della nostra percezione grazie alla sua unità
che è un’unità di “stile” (cfr. FP, p. 427).
Diventa centrale qui per Merleau-Ponty la concezione husserliana
dell’Urdoxa. Il primo sguardo dell’individuo pone il mondo e non abbandona
più questa certezza pre-riflessiva e indimostrabile, che poggia sulla fatticità del
mondo. Il primo atto percettivo sancisce l’adesione al patto primordiale che
presiede alla vita preriflessiva e che non può mai ed in nessun modo essere
revocato in dubbio filosoficamente, perché precede la coscienza tetica ed è
trascendentale rispetto alla riflessione filosofica. Esso è l’oggetto di una fede
originaria ed incrollabile nel mondo, l’Urdoxa, a cui la percezione rimanda continuamente, e che nella sua dimensione anonima, prepersonale ed atemporale, assume il ruolo di un a priori dell’esperienza, inscritto nel corpo come retaggio ancestrale della preistoria del soggetto.
48
1.3 La temporalità come orizzonte di senso
La trascendenza che la “archeologia della coscienza” ritrova all’origine
della coscienza riflessiva come riflessione sull’irriflesso, come rottura quindi
del presente permanente dell’intenzionalità fungente, introduce nell’ambito
della soggettività il tempo come dimensione costitutiva del rapporto di involgimento reciproco di soggetto e mondo. L’esistenza nel suo incessante movimento di trascendenza rimanda ad una temporalità che si nasconde sotto il
rapporto intenzionale degli oggetti e sotto il concetto di tempo oggettivo. In
Merleau-Ponty l’analisi della temporalità che parte dalla concezione husserliana del tempo articolato secondo protensioni e ritensioni a partire da un presente “ek-statico”, si fonde con la nozione di “tempo vissuto” di Minkowski,
assumendone le valenze esistenziali. Il tempo come dimensione esistenziale
è la dimensione in cui si apre il “campo di presenza” del soggetto, ovvero il
dominio temporale entro il quale il soggetto è in presa con le cose e può dispiegare la sua azione e che definisce il suo presente come dimensione qualitativa. In questo senso il presente è la dimensione centrale del tempo, che a
partire da essa si articola secondo l’intenzionalità fungente. Nella continua trascendenza del presente si realizza l’unità del flusso temporale, in cui non ci
sono né il passato in sé, né “il futuro futuro”, ma solo una rete di intenzionalità che è la struttura stessa del tempo.
Si delinea così tra soggetto e tempo un rapporto di Fundierung, in cui il
soggetto si concepisce come tale in virtù dell’unità temporale a cui inerisce, e
l’identificazione che si delinea tra temporalità e cogito –inteso come autocoscienza dell’esistenza, contatto immediato e atemporale dell’esistenza con sé
stessa– approda necessariamente ad una identificazione tra temporalità e
soggettività. È su questo punto che l’influenza di Minkowski si fa sentire con
maggior peso.5
Soggetto e mondo sono uniti indissolubilmente nella temporalità, la quale
determina lo “stile” di entrambi. Il soggetto si apre al mondo nel modo del “progetto”, in una protensione che parte dal campo di presenza. Intenzionalità, pro-
C’è un senso autoctono del mondo che si costituisce nel commercio con esso
della nostra esistenza incarnata e che forma il terreno di ogni Sinngebung decisoria (FP, p.563).
Questo rapporto di fondazione di senso reciproca tra soggetto e mondo è
possibile solo grazie ad una temporalità che mantiene saldamente uniti soggetto e mondo, con tutte le loro prospettive temporali nella struttura unica della
presenza. È fondamentale a questo proposito ricordare come il rapporto soggetto-mondo si ponga nella dimensione intersoggettiva che ne costituisce una
coordinata essenziale. Nella presenza il corpo si trascende verso la sua autocoscienza, il soggetto verso il mondo e verso l’altro, nella cui compresenza
ritrova quella certezza del mondo che si esprimeva nell’Urdoxa. L’altro è
cocreatore del senso del mondo e al tempo stesso garante della sua permanenza e della sua autonomia rispetto ad ogni altro soggetto. Merleau-Ponty
definisce così la sua critica della soggettività trascendentale, non esiste soggetto trascendentale perché il mondo è solo istituito e non costituito. La costituzione del tempo e del mondo è possibile solo a partire da un soggetto trascendentale che implichi tutte le soggettività concrete che nella loro coesistenza istituiscono il mondo ed il suo senso complessivo e formano il “campo
trascendentale”, in cui il soggetto concreto si scopre già sempre situato e dato
a se stesso. Il campo trascendentale è allora originariamente un campo intersoggettivo e la sua temporalità è la temporalità impersonale della storia (cfr.
FP, p. 552). Il tempo della storia è la temporalità-ambiente dell’uomo, in cui si
inscrivono la sua civiltà, la sua cultura, i suoi valori e le sue azioni, è il tempo
dello spirito oggettivo che abita gli oggetti, i paesaggi, le parole, ed in cui l’uomo incontra gli altri e si mantiene in comunicazione con loro.
2. Norma e normalità
2.1 Verso una norma strutturale
Abbiamo fin qui ripercorso il pensiero di Merleau-Ponty, evidenziandone gli
aspetti salienti, al fine di reperire gli elementi necessari ad avanzare una risposta al problema da cui eravamo partiti: cos’è la “norma”? Cos’è la normalità?
In che senso se ne può parlare?
Ne La struttura del comportamento avevamo trovato una nozione di norma,
intesa come la struttura con cui si presentano per un osservatore esterno le
costanti comportamentali di un organismo. Ovvero, nei termini di Goldstein, la
norma è la struttura del comportamento, in termini husserliani, è il suo “stile”.
Il che ci porta ad affermare che la percezione e l’osservazione di un individuo
SAGGI
getto, azione, trascendenza, “ek-stasi”, sono sinonimi della struttura originaria
dell’esistenza, dell’essere al mondo, come apertura del presente verso il futuro.
Il mondo a sua volta si offre al soggetto come “culla dei significati, senso di tutti
i sensi”, “patria di ogni razionalità”, totalità di senso già data prima del soggetto
e che il soggetto deve necessariamente riprendere per poterla ricostituire.
49
“X” deve darmi la struttura del suo comportamento, ovvero la sua norma. In
termini fenomenologici si potrebbe definire come una specie di riduzione eidetica, in questo senso si può dire che la norma del comportamento di X è la
“essenza” di X colta nella percezione e fondata nella sua certezza di atto conoscitivo di una datità diretta. Ciò che tuttavia è da sottolineare è che non si tratta di definire la norma di X, bensì quella del suo comportamento, ovvero quella della sua relazione con il mondo, secondo una linea lungo la quale si erano
mossi già Jaspers, Binswanger, e il già citato Minkowski.
D’altra parte Canguilhem, nel suo celebre saggio Il normale e il patologico,
ricorda che in latino arcaico il termine “norma” indicava uno strumento simile
alla squadra e l’aggettivo normale era sinonimo di perpendicolare. La “norma”
era quindi ciò che serviva a fare una cosa diritta, ovvero, come dice Bergeret,
il primo significato della parola latina “norma”:
determina soltanto quale sia angolo funzionalmente più adatto per articolare due
piani di costruzione e non una posizione ideale fissa della casa rispetto al suolo.
La costruzione si può trovare d’aplomb (cioè in equilibrio interno) anche se il suolo
è in rilevante pendenza (J. BERGERET, La personalità normale e patologica, p. 12).
50
Per traslato la “norma”, lungi dall’essere un parametro comportamentale
astratto fisso ed inalterabile, assume il suo senso solo in riferimento ad un “terreno”, cioè ad una condizione ambientale, e definisce il miglior adeguamento
possibile dell’individuo all’ambiente e di conseguenza le sue condizioni ottimali
di vita. L’adempimento della norma dovrebbe allora portare ad una soddisfacente relazione ambientale e all’adozione di quelli che Goldstein chiamava
“comportamenti privilegiati”.
Tuttavia, nella misura in cui il comportamento umano è caratterizzato da un
predominio della “forma simbolica” –che organizza e coinvolge nella sua dialettica le altre forme conferendogli un senso ed un significato peculiari– il suo
stile specifico di essere al mondo è essenzialmente segnato dalla trascendenza. La norma del comportamento umano, infatti, non consiste nella ricerca
di un equilibrio stabile con l’ambiente, ma in una ricerca di ciò che non è ancora, di una tensione verso il virtuale che è al tempo stesso un potere di negazione e di trasformazione del reale, veicolata da un potere di simbolizzazione
e concettualizzazione, che va di pari passo con l’integrazione dell’attività spirituale con l’attività corporea.
Questa prima definizione strutturale della norma che emerge dalle pagine
della prima opera di Merleau-Ponty, trova una sua migliore e più ampia definizione nella Fenomenologia della percezione. L’analisi fenomenologica della
percezione porta in primo piano l’aspetto preriflessivo dell’esistenza, inscrivendolo in una norma comportamentale più ampia che include sia la dialettica
delle forme, quindi l’integrazione corpo-spirito (problema dei due Io, rapporto
tra intenzionalità d’atto e intenzionalità fungente, cogito), sia quella dialettica
mondo-coscienza-lavoro che era indicata come comportamento privilegiato
dell’uomo. La norma, quindi, lungi dall’abbandonare il suo carattere strutturale si avvia a diventare struttura esistenziale atta a comprendere tutta la
2.2 Lo stile temporale
Il carattere comune ai comportamenti patologici esaminati da MerleauPonty è la perdita della funzione categoriale, ovvero, in breve, la perdita della
apertura simbolico-virtuale verso il mondo. Il soggetto in questo caso si è ritirato ed attestato su di una norma comportamentale privata di tipo “minoritario”, in cui la struttura della trascendenza è bloccata o invalidata. Questo vuol
dire che è invalidata “la capacità di dispiegare un passato, un presente ed un
avvenire”, cioè che è colpita la trascendenza del soggetto pratico verso il
mondo, e con essa tutte le strutture esistenziali che le afferiscono: intenzionalità, percezione, coscienza, cogito, la propria preistoria, come dominio aperto
e riassumibile dell’operatività del corpo. In pratica con la temporalità-trascendenza è stata colpita l’essenza stessa del soggetto, il che ci porta alla conclusione che la temporalità è la norma fondamentale del comportamento umano,
che si definisce come stile temporale e che la normalità consiste nello svolgersi del comportamento secondo la struttura della temporalità.
Dispiegamento “normale” della temporalità, vuol dire apertura di possibilità, molteplicità di mondi e di orizzonti, integrazione fluente di passato e futuro
in un presente che è la presa operativa del corpo proprio sul mondo. Il blocco
della temporalità significa allora la destrutturazione della presenza, non un
puro e semplice sbarramento del futuro, come suggeriva Minkowsky, ma il
grippaggio dell’esistenza su un assetto comportamentale che non può in alcun
modo essere definito normale e che ha nella “apragmaticità” il suo tratto caratteristico più essenziale. Il soggetto normale nella sua struttura profonda è,
come abbiamo visto, un io posso, cioè un soggetto d’azione, definito principalmente da un’intenzionalità fungente, da un’apertura pragmatica. In questo
senso un comportamento improntato ad una cronica “apragmaticità” non può
che essere considerato lontano dallo stile di comportamento normale. Inoltre
con la disgregazione della temporalità si ha una destrutturazione della personalità ed una frammentazione del soggetto, con una dissociazione dei campi
sensoriali, la perdita della funzione orientativa dello schema corporeo e la scissione dei due io, non più integrabili nel cogito. La pluralità dei mondi resa possibile dalla struttura temporale si riduce ad un unico mondo dotato di un solo
significato privato e senza apprezzabile riscontro nella realtà, in cui gli oggetti perdono la molteplicità di significati che gli è propria per assumere un solo
significato piuttosto aderente e ridotto.
L’assunzione dello stile temporale dell’esistenza come norma, produce una
nozione strutturale di norma, che non determina i contenuti del comportamento, ma il suo come. La norma così posta è tale da poter regolare il rapporto
individuo-ambiente, per ciascuna delle variazioni dei suoi termini, senza avere
alcun contenuto specifico, e può esprimere il senso che organizza ad un
tempo la vita di una specie, di una collettività o di un solo individuo in quanto
strutture. In questo senso deve essere affrontato anche il problema della tem-
SAGGI
gamma delle Erlebnisse, sul fondamento generale dell’“essere al mondo”.
Questo diventa comprensibile riconsiderando le analisi dei casi patologici
effettuate nella Fenomenologia della percezione.
51
poralità della norma, se essa sia eterna e immutabile oppure storica. La
norma, priva di contenuto, immutabile nelle sue articolazioni, che sono le articolazioni stesse della temporalità del soggetto, assume di volta in volta il contenuto che la situazione richiede. Essa è quindi ciò che cambia, rimanendo
sempre identica. Ciò che cambia è il modo in cui il comportamento esprime la
norma, rapporto quest’ultimo che definisce la normalità. La norma è allora
atemporale, in quanto struttura, ma in quanto esprime anche il senso di un
comportamento, non può eludere il riferimento alla situazione contingente in
cui questo senso si esprime, e la relazione che questo senso ha con il senso
generale del mondo. La normalità in questo senso si dà secondo il carattere
ambiguo della temporalità, come intersezione dello storico e dell’atemporale,
definendo così due assi di normalità, il primo (atemporale), quello del dispiegamento individuale della temporalità; il secondo (storico), quello dell’articolazione del senso del comportamento individuale con il senso generale del
mondo, l’ingranaggio del tempo individuale sul tempo collettivo. Questo
secondo aspetto ci rimanda alla dimensione intersoggettiva e al problema centrale della normalità, ovvero quello del giudizio di normalità e della sua legittimità. Ogni paradigma soggettivo di normalità deve trovare riscontro nella
dimensione intersoggettiva, così come al tempo stesso la norma individuale
non può essere schiacciata sulla norma ambientale. Il giudizio di normalità è
ad un tempo giudizio dell’individuo su se stesso e giudizio degli altri sull’individuo, che si articolano sincronicamente e diacronicamente.
52
2.3 Giudicare la normalità
Dal punto di vista soggettivo il giudizio di normalità indica un generale sentimento di sintonia con il mondo-ambiente (Minkowski) e di unità e continuità
di senso della sua storia personale, che si traducono in una fluida capacità di
azione ed in un dispiegarsi “silenzioso” della sua esistenza che permane nell’orizzonte di senso e di significato del mondo, che si dà fondamentalmente
come “comprensibile”. Ma questo punto di vista diacronico deve incontrarsi
con quello sincronico della considerazione intersoggettiva del comportamento
individuale, in cui quest’ultimo viene necessariamente correlato al comportamento degli “Altri”, che diventa normativo in quanto espressione di quel senso
incarnato del mondo con cui il comportamento individuale deve sintonizzarsi.
Il senso è il cuore della normalità e la normalità è il concetto mediatore che
esprime l’articolazione tra il senso proprio del soggetto ed il senso collettivo ed
intersoggettivo del mondo. Il soggetto assume nel senso della sua esistenza
personale il senso della situazione collettiva di cui diventa espressione e il suo
comportamento manifesta questa complessa struttura significativa, che diventa decifrabile dagli altri in virtù di una comunicazione preconcettuale, prima
ancora che predicativa, fondata e giustificata sull’orizzonte comune e sull’originaria certezza dell’“essere al mondo”.
Il superamento del soggetto cartesiano sulla base della concezione del
corpo proprio apre, per Merleau-Ponty, una dimensione intersoggettiva che
esclude radicalmente ogni forma di solipsismo. L’uomo si scopre già dato nel
mondo in mezzo ad altri uomini in cui la percezione scopre delle tipicità ana-
SAGGI
loghe alle sue. I soggetti istituiscono fra loro una comprensione operativa,
nella quale si manifesta un modo comune di esperienza del mondo. La comunicazione è comportamentale e viene immediatamente compresa dalla percezione degli altri.6
Il corpo dell’altro, in virtù del suo potere di simbolizzazione, è significativo
e si dà come un “oggetto culturale”, ed è per questo che la percezione può
operare nei suoi confronti una “trasgressione intenzionale” con cui accede alla
sfera dell’altro saltando la mediazione intellettuale.
La relazione intersoggettiva si colloca già da sempre in un intermondo che
è il luogo dell’incontro di due ipseità che si aprono in una reciprocità di stili, di
ritmi e di tempo, la quale non è trasparenza assoluta, ma una originaria possibilità di comunicazione e comprensione immediata, su cui si fonda la possibilità stessa della parola e del dialogo, come pure quella del fraintendimento o
del rifiuto della comunicazione.
La relazione tra ego ed alter-ego apre di necessità sul mondo comune su
cui entrambi sono già sempre coinvolti e in cui si incontrano. Questo mondo è
un mondo fisico e sociale, intessuto di significati culturali collettivi che ognuno
riprende e coopera ad istituire o a destituire. In questo mondo socio-culturale,
che è il mondo “naturale” dell’uomo, si trovano enti non materiali che vengono
costituiti nell’intermondo come “validità” mondane con valore universale, che
in quanto appartengono al “Si” oltrepassano l’individuo nello spazio e nel
tempo e vivono in lui preconsciamente come modi di coesistenza (cfr. FP, p.
468). In questo terreno di “validità” sedimentate e vissute si radica l’atteggiamento valutativo ed interpretativo del soggetto, che da esso trae i suoi parametri e la sua legittimità di giudizio. Ed è su questo terreno che il problema
della normalità deve essere riportato e posto, se se ne vogliono eliminare le
ambiguità che solitamente lo caratterizzano. Ogni definizione oggettiva della
normalità si dà come ambigua e paradossale, perché il suo parametro è il
logos prelogico del mondo, incarnato nel “Si” e non le valutazioni commisurative di una qualunque disciplina scientifica. Significativo in questo senso il suggerimento di Van den Berg, il quale a proposito dell’integrazione tra anima e
corpo afferma che “il normale è il preriflessivo” e la normalità intesa come preriflessività non può essere colta in prima istanza e con gli strumenti di pensiero oggettivanti della scienza, ma si manifesta circondata dal suo alone di ambiguità nell’apertura immediata della percezione.7 Questa percezione non è
un’intuizione arbitraria. Nella percezione di normalità convergono la storia personale, in quanto esperienza, quella dell’altro come comportamento e quella
sociale come tipica del comportamento umano, che si innestano sulla “validità” della normalità come valore intersoggettivamente determinato. Il giudizio di
normalità o anormalità nasce dell’impatto percettivo con l’altro, immediatamente e molto prima che se ne possano reperire razionalmente i fondamenti
oggettivi.8 La percezione ci apre immediatamente sull’esistenza dell’altro attraverso il suo corpo; ciò che l’individuo “anormale” esprime con il suo comportamento è la sua chiusura all’interno di un mondo privato e la sua impossibilità di una comunicazione efficace: il soggetto comunica, ma non comunica ciò
che vorrebbe comunicare, laddove il suo corpo comunica apertamente ciò che
53
si vorrebbe tacere. Correlativamente di fronte all’individuo “anormale” noi
entriamo “in scacco propriamente come uomini”9: egli non è più un “Altro”, ma
qualcosa che non appartiene più al nostro mondo.10 Noi avvertiamo però che
ciò che ci tiene in scacco non è semplicemente un’esistenza altra che si nega
o ci oggettivizza, un’ alterità assoluta. Quello che ci sta davanti non è l’abitante di un pianeta sconosciuto, bensì un esiliato dal nostro mondo, la cui forma
propria di esistenza è globalmente connotata da una sofferenza che non ha
niente in comune con quella che, sia pure nelle sue forme più estreme, si è
soliti provare, una sofferenza radicale e incomunicabile, un’assoluta alienità.
Questa sofferenza è incomunicabile, ma non completamente incomprensibile
dall’esterno. La possibilità di comprendere una forma anormale di esistenza è
lasciata aperta dal comune fondamento mondano che lega in ogni caso gli
individui e dalla disponibilità a mettersi in gioco e ad assumere la norma “centrifuga” del comportamento anormale. Questa possibilità di mettersi in gioco
però non mette in crisi il mio essere al mondo, come ad esempio sosteneva
Enzo Paci nell’introduzione a Il tempo vissuto di Minkowski (p. XII). Una forma
anormale di esistenza non può mettere in gioco radicalmente il nostro mondo,
perché ne rappresenta una forma minoritaria, piuttosto proprio nel momento in
cui ci si mette in gioco per comprendere questa forma di esistenza “decaduta”, riaffermiamo la nostra possibilità di trascendenza di fronte alla sua chiusura, in un rapporto che non è biunivoco, ovvero riaffermiamo la nostra normalità, proprio in quella sua struttura tipica che all’altro manca.
54
2.4 La normalità come valore
Lalande afferma che il termine “normale” è equivoco perché designa allo
stesso tempo un fatto e un valore attribuito a questo fatto. Senza voler entrare
nella questione epistemologica se in generale esistano fatti che non sono
anche un valore, in questo caso l’equivocità non sussiste: la normalità è un fatto
che è un valore. Bisogna annettere alla normalità il carattere assiologico che le
è proprio, in quanto “validità” nel mondo intersoggettivo. All’interno di una società, in una data situazione storica vengono a costituirsi della “tipicità” di comportamento, che si stabilizzano come “validità” dotate di un senso proprio che
si accorda con il senso generale del mondo all’interno di certe coordinate spazio-temporali. Tali validità sono effettive fintanto che il senso generale a cui si
riferiscono è in corso ed è convissuto socialmente. Questo orizzonte di senso,
pur con le differenze prospettiche e l’essenziale inconfondibilità, e non sovrapponibilità, delle rispettive “sfere di appartenenza” si pone come “mondo
ambiente comune”, “identità del sistema di apparizioni” che costituisce la norma
in base alla quale sono ravvisabili le “variazioni” e le “anormalità” individuali.
Il comportamento normale esprime quindi una capacità di vivere, lavorare,
cooperare, in breve, di interagire efficacemente nel mondo e con gli altri e in
conseguenza di ciò la normalità è un valore, perché definisce ciò grazie a cui
l’esistenza ha una sua effettualità.11 Ciò che la percezione ci rivela del comportamento dell’altro, facendolo apparire normale, non è il dispiegarsi della temporalità, né l’integrazione della sua struttura comportamentale, in se stesse, ma
quello che da queste strutture proviene: un’esistenza libera da condizionamen-
1
Questa polivalenza del linguaggio comune è speculare alla pluralità di concezioni della normalità sul piano teorico in cui troviamo una normalità statistica, una normalità idealistica, una normalità vitalistico-esistenziale, una normalità psicanalitico-psichiatrica, una normalità etico-sociale.
2
K. GOLDSTEIN, Der Aufbau des Organismus, 1930.
3
M. MERLEAU-PONTY, La struttura del comportamento, Bompiani, Milano 1970 (nel testo: SC).
4
M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologia della percezione, Il Saggiatore, Milano 1980 (nel testo: FP).
5
In Minkowski la concezione della soggettività come temporalità permette di concepire il rapporto tra soggetto e mondo in termini di sincronia al “divenire-ambiente”, sulla base di una “dimensione in profondità”, l’inconscio, che è la matrice profonda delle volizioni e degli atti, che sfugge
ad ogni coscienza tetica, ma che può essere solo intuita come la sorgente sotterranea delle tendenze profonde condivise da tutti i soggetti, le quali costituiscono il dinamismo del divenire in
generale della vita.
6 “Il comportamento percepito di un’altra persona mi è immediatamente dato come il correlato
del mio comportamento e qualcosa che io potrei anche rifare. Perciò io posso comprenderlo in termini puramente pratici, senza doverci pensare” (R. FRIEDMAN, 1975, p. 232; la citazione è in FP).
7
J.H.VAN DEN BERG, The Phenomenological Approach to Psychiatry, C.C. Thomas Publ.,
SAGGI
ti occulti e inibizioni che si mostra nel disinvolto dispiegarsi di un agire corporeo efficacemente in presa sul reale, in una prospettiva che può essere ripresa
–almeno virtualmente– da un altro soggetto, con margini di efficacia analoghi.
Per contro, l’anormalità “si costituisce associativamente con i modi della normalità”, però “secondo il carattere della discordanza e della delusione”.
L’anormale non ci mette in scacco perché fa paura, perché è imprevedibile o perché mette in questione il nostro mondo, infatti per poterlo fare dovrebbe essere dentro a questo stesso mondo a pieno titolo, cioè dovrebbe essere
normale. Il comportamento anormale può fare contingentemente paura o può
destare sorpresa o perplessità, ma il mondo comune resta fondamentalmente
saldo e continua a “funzionare”. L’imbarazzo che connota emotivamente l’incontro con l’anormalità è piuttosto quello di un’aspettativa irrimediabilmente
delusa, di un’effettiva impossibilità di riconoscimento reciproco, un limite di
inassociabilità che ci fa sentire che con l’altro “non si ha nulla da fare e a che
fare” (se non prendersene cura, dandosi certe condizioni umanitarie o professionali). Non esistono progetti o prassi che si possano, anche solo virtualmente, dividere con lui o riprendere da lui, né alcun vero dialogo può avere
luogo, l’infinito interrogativo che l’altro è solito rappresentare per noi appare
insuperabilmente chiuso. L’opacità illuminata e illuminante che caratterizza
ogni alter-ego si è persa nell’oscurità di un mondo irraggiungibile. In questo
senso allora si può dire che la normalità è un valore ed è un valore di relazione, perché indica la condizione fondante della vita sociale: la possibilità di riconoscimento e di comunicazione.
55
Springfield (IL), 1955.
8
Su questo punto, sia pure con terminologia diversa, concordano sia Minkowski, sia Van den
Berg, i quali esemplificano questa posizione facendo riferimento alla loro esperienza professionale, il primo a più riprese ne Le temps vecu, il secondo in The Phenomenological Approach to
Psychiatry, cit., pp. 8-9.
9
Cfr. D. CARGNIELLO, Alterità e alienità, Feltrinelli, Milano 1966, pp. 218-219.
10
Sul fenomeno della perplessità, come scadimento dell’alterità in alienità, cfr. B. CALLIERI,
Quando vince l’ombra, Città Nuova, Milano 1982, pp. 80-84.
11
Cfr. FP, p. 226, dove Merleau-Ponty stesso utilizza la nozione di “vita efficace”.
56
BLOCH INTERPRETE DI KANT:
TEMPO DELLA SCIENZA, TEMPO DELLA STORIA
1.Introduzione
Nell’edificazione del suo discorso filosofico sulla speranza e sull’utopia
concreta, E. Bloch ha ritenuto che uno strumento speculativo essenziale
potesse essere costituito dal confronto critico con la tradizione filosofica e in
particolare con l’Idealismo tedesco, verso il quale ebbe sempre un atteggiamento problematico, lontano da sterili schematismi. Tale orientamento ha
determinato nel corso degli anni una maggiore attenzione da parte dei critici
per il rapporto fra Kant e Bloch, finalizzata a meglio determinare la portata dell’apprezzamento manifestato dal filosofo per l’etica kantiana, nella quale, pur
nei limiti dovuti ad una eccessiva astrattezza, rintracciava un forte potenziale
utopico.1 Proprio la fondamentale tonalità etica rappresenta d’altra parte una
delle caratteristiche peculiari della filosofia blochiana, tanto da segnarne
anche la originale visione del marxismo.2
La nostra ricerca si muove su un terreno diverso, poiché si propone di analizzare il rapporto tra i due filosofi sotto la particolare ottica della concezione del
tempo, un tema che finora non è stato trattato,3 anche perché Bloch nelle opere
maggiori ha dedicato alla temporalità kantiana solo osservazioni sporadiche,
apparentemente contraddittorie tra loro.4 Prendendo in considerazione la definizione di ‘forma del senso interno’, che Kant aveva dato per il tempo nella
Critica della Ragion Pura, Bloch ne criticava sostanzialmente il carattere ideale, proponendo di contro la propria visione di un tempo inteso come ‘modo di
esistenza materiale’ o come ‘modo di tendere obbiettivo di un’ intensità obbiettiva’. Egli faceva leva sulla convinzione che la coscienza del tempo è coscienza di un tendere, di cui il tempo stesso rappresenta la forma, una forma appunto orientata finalisticamente, moventesi in perfetta aderenza con i suoi mutevoli contenuti, pertanto distante dal senso assegnato da Kant al termine.
Le nostre analisi, ne siamo consapevoli, per quanto riguarda l’universo gnoseologico kantiano, toccheranno territori in parte noti, poiché la critica di Bloch
al paradigma temporale continuistico-scientifico-quantitativo è già stata oggetto di ampie trattazioni critiche.5 Riteniamo comunque che possa essere utile
questo nostro contributo perché essa non era ancora stata affrontata in diretta
relazione a Kant e inoltre perché, nel condurre la nostra ricerca, abbiamo tenuto presente anche il quarto volume delle Leipziger Vorlesungen,6 dedicato
all’Idealismo tedesco nell’arco del suo intero sviluppo e nel quale è presente l’unica trattazione distesa compiuta da Bloch della concezione kantiana del
tempo. Nelle Leipziger Vorlesungen emerge con estrema chiarezza la convin-
SAGGI
di Vincenzo Scaloni
57
58
zione di Bloch che lo sforzo filosofico di Kant nella Critica della Ragion Pura
debba essere messo in relazione alla nascita e allo sviluppo della scienza
moderna, prendendo le distanze da un approccio di tipo metafisico come quello heideggeriano, teso a considerare Kant un “pastore dell’essere”.7 Per quanto Bloch avesse rivolto severe critiche all’idealismo gnoseologico e “all’orgoglio
dell’ego trascendentale”8 per la loro inevitabile ricaduta in una visione meccanicistica della natura, egli riteneva comunque corretto interpretarlo come una
risposta teorica al processo di matematizzazione della natura avviato dalla fisica galileiano-newtoniana. Kant aveva d’altra parte accolto dalle filosofie razionalistiche del XVII e XVIII secolo la convinzione radicata che la validità oggettiva del sapere scientifico fosse determinata dal suo rapporto privilegiato con la
matematica.9 Bloch insiste particolarmente però proprio sui limiti delle cognizioni matematiche kantiane e sulla forma ‘spazializzante’ del suo pensiero, che
incideranno sul modo di concepire il tempo, ma rispetto ai quali il tempo stesso poteva rappresentare un elemento generante contraddizioni10. La soluzione
al problema della conoscenza, avanzata da Kant, ha il suo fulcro nella attività
sintetica a priori, che rappresenta per Bloch a livello gnoseologico la centralità
acquisita dal lavoro nella società moderna.11 Perciò, nell’evidenziarlo, Bloch ha
sempre l’occhio rivolto all’idealismo tedesco, nel quale emerge la dimensione
storica del pensiero e della produttività umana, dimensione intimamente connessa al tempo. Il sistema filosofico kantiano è un ‘sistema aperto’, come Bloch
lo definisce, apprezzandolo e differenziandolo da quelli monolitici di Spinoza,
Leibniz e Hegel, caratterizzato da una innegabile coerenza interna nelle singole ‘Critiche’, ma da due significative fratture tra di esse.12 E questa sua apertura era dovuta, secondo la precisa specificazione di Bloch, proprio alla “notevole temporalità del suo principio di spontaneità”.13 La creatività, connessa al
tempo, assegnata da Kant nella ragion pura ad un orizzonte formale-matematico e meccanicistico, si inaridiva, chiudendo la sua capacità di generare e dare
forma in un circolo ideologicamente privo di futuro, e stimolando le critiche di
Bloch (il sistema kantiano “è […] chiuso unicamente in quanto totalità dell’esperienza teorico-meccanica”),14 che ne vedeva negate in questo modo le
potenzialità più umane, quelle appunto relative alla storia.
Nella seconda parte del nostro lavoro tenteremo di mostrare come, proprio
sul terreno storico, sia possibile invece rintracciare una certa convergenza tra
la temporalità kantiana e quella blochiana, poiché entrambe danno un particolare significato alla dimensione del futuro, legandola alla destinazione etica
dell’uomo e al concreto manifestarsi del Novum positivo, risultato della prassi
etico-rivoluzionaria che attua una possibilità latente nella realtà. È lo stesso
Bloch a fornirci alcune indicazioni che orientano la trattazione verso la filosofia della storia kantiana, giustificando in questo modo la direzione presa dalla
ricerca. “In Kant il dovere veniva ancora definito come qualcosa che non si
verifica mai nella natura, onde anche la storia può possedere il suo filo conduttore a priori non nel fatto, ma solo nel problema di un regno dei fini etici.”15
L’a priori kantiano è l’indicatore del problema della storia, come instaurazione
di un assetto politico-sociale che rispetti appunto le peculiarità etiche dell’uomo, peculiarità che non possono trovare soddisfazione in un rapporto pretta-
2. Sintesi trascendentale kantiana
ed esperienza meccanicistica del presente
Uno dei motivi ricorrenti nel discorso filosofico di Ernst Bloch, preoccupazione costante e punto di partenza obbligato, è l’accettazione del terreno problematico della modernità, con la perdita di senso dell’esistenza umana, la
crisi e il deserto di valori in cui si muove l’uomo moderno. “La vita –afferma
Bloch– […] è già da lungo tempo divenuta vuota. Barcolla insensatamente.”18
Alla radice del nichilismo dell’epoca moderna Bloch indica l’assetto economico borghese-capitalistico e la scienza galileiano-newtoniana, che hanno
entrambi condotto alla formazione della civiltà del calcolo e della tecnica,
degradando gli oggetti a semplici “cose” inanimate19. La quotidianità della vita
associata è permeata dalla razionalità matematico-quantitativa e, in conseguenza di ciò, scandita da una nuova astratta concezione temporale che
tende ad uniformare le alterità in essa presenti. “Il concetto di tempo cronometrico, uniforme come un metronomo, deriva dal pensiero legato al valore di
scambio, il quale livella ogni diversità anche qualitativa in una sequenza di
prezzi solo quantitativamente caratterizzante”20
In questo contesto la gnoseologia kantiana, concretizzatasi nella prima delle
tre grandi Critiche, rappresenta per Bloch, con il suo tentativo di fondazione logica della fisica newtoniana, una delle tappe culminanti di questo processo di ridu-
SAGGI
mente conoscitivo con la natura, poiché questo è un rapporto impoverente la
natura e l’uomo stesso. Il Sollen, il dover-essere rappresenta per Bloch, al di
là del suo formalismo, la libertà del soggetto, lo scarto attivo che il soggetto
può effettuare di fronte a realtà disumanizzanti e amorali, la scelta di una contromossa tesa a contrastare la negatività e a mettere in crisi qualsiasi posizione panlogistica di tipo hegeliano. Per questo motivo “Kant supera Hegel, come
l’inquieto a priori supera nell’uomo ogni tipo di oggettivismo compiuto troppo
presto”16 e per questo motivo il soggetto non può che destinare al futuro la
soluzione del problema della storia. Si tratterà insomma di mostrare come,
quando Bloch afferma che in Kant “ciò che viene dopo [la gnoseologia logicomeccanicistica] è invece esclusivamente speranza di un futuro non ancora
divenuto, infinitamente aperto, e non appartiene fondamentalmente a nessun
circolo dell’esistente”,17 egli possa farlo, non proiettando semplicemente il proprio pensiero filosofico nell’interpretazione della filosofia kantiana, ma fondatamente, poiché sono rintracciabili delle precise corrispondenze negli scritti
kantiani relativi alla storia, sul modo di intendere il futuro. La peculiarità di Kant
e della sua etica del dover-essere, in rapporto alla prassi storica, è correttamente individuata da Bloch nella relazione aperta, non garantita sull’esito, che
essa instaura con il futuro, il tempo della speranza e della possibilità. Lo scarto quindi fra scienza meccanicistica ed etica è lo scarto fra il presente inautentico e il futuro possibile e aperto, fra il destino obbligante che determina
l’uomo, non tenendo conto della sua libera volontà, e la destinazione frutto
della libera scelta compiuta coscientemente e liberamente dall’uomo stesso.
59
60
zione ad una dimensione univoca del soggetto e dell’oggetto. Il soggetto trascendentale kantiano infatti, privato delle sue componenti pulsionali ed affettive
produceva, grazie alla sua attività sintetica, un oggetto di conoscenza puramente logico-formale e matematico, dando il suo negativo contributo all’uniformità
del mondo moderno. Così, quando nelle Leipziger Vorlesungen Bloch definisce
la Critica della Ragion Pura “un libro che ha messo in movimento la filosofia classica tedesca” –e aggiunge, evidenziando l’indubbio ruolo storico avuto dall’opera, “senza la Critica della Ragion Pura non ci sarebbero stati Fichte, Schelling,
Hegel e neppure il Marxismo, che presuppone e ha in sé la filosofia classica
tedesca come una delle fonti”21– egli non intende mutare la sua opinione critica
nei confronti della gnoseologia kantiana, quanto invece valorizzarne in pieno l’aspetto attivo, su cui essa si fonda. “L’idealismo trascendentale è dunque l’idealismo della produzione, dove non esiste alcuna coscienza individuale e neppure
uno Spirito del mondo (Weltgeist), […] ma una coscienza in generale.”22
L’individualità della singola coscienza concreta si perde nelle strutture a priori
epistemologiche, dotate di una valenza meta-storica, della coscienza trascendentale kantiana ed è questo fissarsi, quasi oggettivandosi, sganciato dal processo storico e dal suo divenire, l’elemento che per Bloch risulta inaccettabile.
L’energia sintetica a priori, l’energia della produzione e della costruzione si sviluppa dunque, nell’ambito conoscitivo, nei limiti segnati dalla scienza matematica, l’unica in grado di fornire la vera conoscenza, la conoscenza apodittica, il
che, tradotto in termini kantiani, suona come l’unica capace di formulare giudizi
sintetici a priori, giudizi che per la loro struttura logica siano validi scientificamente. La sintesi trascendentale dell’Appercezione, che ha come “nocciolo e
motore”, “l’automovimento creatore della coscienza”, “la spontaneità della
coscienza in generale”, è il “giudizio scientifico d’esperienza […] [che] consiste
solo di verità comprovabili.”23 Con la direzione scientifico-formale, data alla produttività sintetica, si evidenzia anche in Kant il paradosso dell’Homo Faber e più
in generale del pensiero borghese, sia esso idealistico o materialistico, il quale,
sorto con la finalità demiurgica di plasmare attivamente la realtà naturale e storica, terminava il suo percorso nella determinazione di una razionalità immanente al reale stesso, manifestantesi sotto la forma di una legalità definitiva ed
eternizzante. Pur non ponendoci qui lo scopo prioritario di approfondire gli effetti ideologici di tipo passivo, generati da questo percorso teorico,24 la reificazione
della coscienza borghese, anche ”kantiana”, produceva come riflesso ideologico una giustificazione e una apologetica del mondo presente, un’ “esperienza
meccanicistica del presente”,25 nella quale un ruolo fondamentale è giocato dal
tipo di temporalità inerente a tale visione del mondo.
3. Matematizzazione della scienza e matematizzazione
dello spazio e del tempo in Kant: grandezza e sequenza
La critica blochiana al carattere ideologico della scienza moderna investe
in pieno, per quanto si è visto sopra, la filosofia kantiana e di conseguenza
anche la concezione del tempo dell’Estetica trascendentale e dello
SAGGI
Schematismo trascendentale, le sezioni della Critica della Ragion pura26 nelle
quali tale tematica si dispiega più densamente.
Nel richiamare il nodo teorico dell’Estetica appare subito evidente l’intenzione di Bloch di connettere l’opera kantiana alle questioni sollevate dalla
fisica newtoniana. Volendo infatti meglio esplicitare il senso e il contenuto
della domanda sui giudizi, Bloch afferma: “come mai esiste la scienza quantitativa… come mai per così dire i fenomeni appartengono al numero, e
come mai esistono numero e misura, sequenza e grandezza, che sono alla
base dell’intuizione in senso scientifico, che rendono pura l’intuizione in
senso scientifico, che dall’intuizione formano la scienza matematica?”.27
Poiché le soluzioni proposte da Kant al problema epistemologico si fondano
sulle strutture trascendentali dello spazio e del tempo, forme a priori della
sensibilità, che rendono possibile l’astratto costruttivismo geometrico-matematico, è necessario in primo luogo mettere l’accento sulla critica incisiva e
ripetuta alla quale Bloch sottopone proprio la concezione kantiana della
matematica, che risulta arretrata e inadeguata, “non paragonabile” –a detta
di Bloch– a quella di “matematici creativi come Descartes e Leibniz”.28 “Se
Kant fosse stato all’altezza della matematica del suo tempo, allora non
avrebbe dichiarato la grandezza categoria fondamentale della matematica
pura. Non era più possibile dal calcolo differenziale e chiaramente da
Lagrange, rendere un caso specifico come la grandezza determinazione
fondamentale della matematica. La matematica è una scienza di rapporti, il
rapporto di grandezza è certo uno dei più significativi ma non l’unico in
essa.”29 L’insistenza con la quale Bloch ritorna su queste considerazioni nel
corso dell’esposizione rivela la sua convinzione, sulla quale torneremo in
seguito, che è possibile mettere in crisi il modello matematico-quantitativo
del tempo non necessariamente uscendo dalla scienza, ma a partire da
quella stessa, qualora non si strutturi più sotto un punto di vista meramente
quantitativo, avvicinandosi di fatto e aderendo maggiormente alla flessibilità
e alla variabilità della vita.30 A Bloch preme essenzialmente mostrarci come
la configurazione quantitativa della concezione kantiana della matematica
determini allo stesso modo sia la geometria sia l’aritmetica, che ne sono le
articolazioni, fondate rispettivamente sull’intuizione dello spazio e sull’intuizione del tempo. “La geometria in quanto scienza fondamentale dello spazio
(räumlicher Art) ha, secondo Kant, a che fare con grandezze, l’aritmetica
invece in quanto scienza fondamentale del tempo con sequenze (Reihen).
Nella sequenza dei numeri: uno, due, tre, quattro, in questo procedere uniforme siete in presenza del tempo reso puro, il segno più (Pluszeichen) è il
segno del tempo.”31 La matematizzazione della scienza e la matematizzazione del tempo sono processi che in Kant si corrispondono specularmente.
La sequenza matematica, nella sua uniforme scansione numerico-quantitativa, rappresenta infatti la pura formalizzazione del tempo, che priva il tempo
stesso di qualsiasi aderenza ai contenuti in esso pulsanti o induce in essi per
lo meno una rigida omogeneizzazione. D’altra parte la stessa definizione
kantiana di forme a priori della sensibilità rivela proprio un certo prevalere
della forma sui contenuti intuiti, che, per essere tali, devono adeguarsi alle
61
62
condizioni spazio-temporali. Bloch, nel far notare come per Kant “senza spazio e tempo” non sia possibile e non esista di fatto “alcuna intuizione”, dunque alcuna attività sintetico-produttiva, sottolinea anche come essi siano
nella costruzione kantiana “pensabili senza contenuti”, “vuoti contenitori”,
“pensabili come contenitori”,32 puntando ancora a stigmatizzarne il carattere
formale-ideale. Bloch era perfettamente consapevole delle differenze insite
nel passaggio da un formalismo oggettivo, in cui spazio e tempo venivano
considerati realtà assolute (Newton) ad un formalismo soggettivo, in cui essi
invece erano forme a priori trascendentali (Kant). In Experimentum Mundi,
prendendo le distanze da entrambe le posizioni, egli indirizzava però critiche
di stampo diverso al tempo “parvenza subbiettivo-ideale” e al tempo come
“in sè ipostatizzato” poiché “l’ipostasi di una uniformità del tempo, affermata
come obiettiva […] è altrettanto insostenibile quanto la totale negazione del
carattere reale del tempo nell’idealismo subbiettivo, il quale, a sua volta,
intende il medesimo abstractum.”33 Il problema della consistenza ontologica
dello spazio e del tempo era però particolarmente acuto e spinoso proprio in
Kant, poiché, avendoli egli determinati contemporaneamente come realtà
empiriche e idealità trascendentali, rinviava ad una difficoltà di fondo del criticismo, la contraddittoria compresenza in esso di empirismo e razionalismo,
materialismo e idealismo, assunta da Bloch nelle Leipziger Vorlesungen
come criterio ermeneutico, accanto al rilievo dato, come si è visto, ai limiti
della matematica kantiana. “Senza intuizioni, senza essere riempiti con intuizioni, non esistono né spazio né tempo; […] essi sono dunque legati strettamente all’intuizione e ottengono così realtà empirica, ma idealità trascendentale.”34 Naturalmente, avendo sempre di mira la costruzione di un impianto teorico, valido in senso assoluto, poiché fondato su strutture trascendentali pure, Kant, nel dipanare il filo della matassa rappresentata dallo spazio
e dal tempo, ne indirizzava l’applicazione necessaria entro l’ambito fenomenico-scientifico, l’ambito della coscienza in generale e dell’universo matematico, con la conseguenza non trascurabile per Bloch di determinare tale
universo come l’unico effettivamente oggettivo-reale. “Spazio e tempo sono
oggettivo reali (objektiv-real), questo suona empirico, perfino empiristico,
questo suona materialistico. Ma essi sono perciò oggettivo-reali solo nei
fenomeni, poiché li utilizziamo necessariamente sui fenomeni nella nostra
scientificità. Attraverso la necessità dell’uso essi sono oggettivo-reali, dunque non a scelta, non viventi in me, ma viventi solo nella coscienza in generale, e alla coscienza in generale corrisponde allora il mondo matematico in
quanto matematico. Dunque il mondo matematico è oggettivo-reale e così
Kant crede di aver risposto alla sua prima domanda, come sono possibili
giudizi matematici a priori.”35 Le riflessioni di Bloch ci sembrano qui perfettamente coerenti con la sua visione complessiva della gnoseologia kantiana,
che veniva inserita nella linea di sviluppo del pensiero moderno, per il suo
tentativo di costruire una conoscenza matematico-meccanicistica. In quest’ottica la forma temporale sarebbe in Kant strettamente dipendente dalla
struttura trascendentale della coscienza, che edifica il mondo scientifico
della matematica, e non avrebbe invece niente a che fare con una tempora-
SAGGI
lità reale perché vissuta dal soggetto umano concreto. Dall’acquisizione di
questo dato possiamo fondatamente constatare che non sussiste alcuna
sostanziale contraddizione tra i brani all’inizio considerati di PrinzipHoffnung e Experimentum Mundi. Anche quando infatti Bloch dichiara “giusta” la definizione kantiana di ‘forma del senso interno’ per il tempo, immediatamente specifica, in una direzione inquivocabilmente anti-kantiana,
“quando questo ‘senso interno’ non venga preso in senso idealistico-trascendentale.”36 Ma il senso idealistico-trascendentale, come si è visto, è per
Bloch non consono ad un tempo vissuto umano, ad eventi temporali quali il
nascere e il perire, indicati in modo appropriato come termini di confronto,
che vengono vissuti integralmente perfino nel nostro corpo, e non lasciati
alla mera contemplazione o alla mera temporalità astratta.37
Ogni tipo di esperienza sensibile viene resa uniforme ed omogenea, adeguandosi allo spazio ‘forma del senso esterno’ e al tempo ‘forma del senso
interno’, con la nota prevalenza, assegnata da Kant e molto apprezzata da
Bloch, del tempo sullo spazio. Poiché il tempo è caratterizzato dalla sequenza e lo spazio dalla grandezza, la natura del tempo risulta dinamica, mentre
quella dello spazio statica. Dalla prevalenza del tempo dovrebbe derivare
dunque una certa dinamicità dello spazio kantiano, ma dalla trattazione di
Bloch si ricava che viene indotta al contrario una staticità del tempo. La ragione di queste ulteriori difficoltà nella relazione spazio-tempo, come rapporto
tra esperienza esterna e esperienza interna, è dovuta di nuovo alla compresenza di idealismo e materialismo, unita alla preoccupazione kantiana di non
cadere in una posizione soggettivistica di stampo berkeleyano. “Già il tempo
come forma del senso interno, come Kant la chiama, presuppone qualcosa
che permane, e questo permanere non può mai essere un’esperienza interna, poiché solo cose che esistono realmente al di fuori di noi possiedono la
permanenza. Già il tempo e proprio il tempo non sarebbe, se non ci fosse
nulla di permanente, che si rendesse conoscibile nella forma della durata.
Questo non può provenire da un flusso della vita interiore, ma dal permanere di una cosa. Nelle cose è un oggetto dell’esperienza esterna.” 38 In Kant
dunque il tempo non sarebbe neppure senza qualcosa di esterno che permane (la durata è “una misura del tempo per i fenomeni esterni” 39), ma proprio perché esterno, questo qualcosa è posto nello spazio. L’esperienza interna presuppone allora l’esperienza esterna, anche se quest’ultima, determinata come durata, è segnata dalla sequenza matematica. La durata induce
una certa spazializzazione del tempo con gli effetti rilevanti sullo schematismo trascendentale, che vedremo successivamente. Se infine spazio e
tempo sono a fondamento rispettivamente della geometria e dell’aritmetica,
discipline entrambe caratterizzate in modo quantitativo (come contiguità e
successione, grandezza e sequenza), Kant può –secondo Bloch– concludere che “i numeri reggono il mondo dell’intuizione, poiché noi li abbiamo prescritti all’intuizione, ciò significa noi in quanto coscienza in generale, o come
si può qui più chiaramente dire, in quanto coscienza scientifica stessa.” 40 La
natura può dunque essere dotata di una struttura necessaria, matematica,
poiché siamo noi stessi in quanto soggetti conoscenti a determinarla.
63
4. L’apodittica dello “Schematismo trascendentale”
e l’inquietudine del tempo
64
Nella parte dedicata da Bloch allo Schematismo trascendentale divengono
evidenti in tutta la loro portata, sia da un punto di vista filosofico sia da un
punto di vista storico, le conseguenze di questa posizione kantiana, lasciando
emergere tutta la distanza che separa la concezione del tempo di Bloch rispetto a quella di Kant, per lo meno relativamente alla parte della sua filosofia che
si sta qui prendendo in considerazione. Lo schematismo trascendentale rappresenta d’altra parte quella delicata sezione in cui Kant deve mostrare come
le dodici categorie dell’intelletto, con la loro attività sintetica, possano applicarsi alla molteplicità dei fenomeni “per decifrare –citiamo sempre da Bloch–
il mondo e con ciò poterlo leggere.”41 È qui che si presenta per Kant il vero
nodo teorico da risolvere in relazione alla fisica newtoniana, poiché, mentre in
precedenza si era trattato della costruzione matematico-geometrica, ora invece si tratta del rapporto fra i numeri e la loro applicazione alla natura. Bloch
illustra con la consueta puntualità i termini della questione: “Se io chiamo il tre
una categoria o una definizione, allora essa è in se stessa chiara ed evidente.
Difficile diviene l’applicazione della stessa alla natura, dunque nella fisicamatematica, che però esiste in modo pienamente sviluppato, come meccanica newtoniana.”42 Le categorie, che, in quanto funzioni dell’intelletto, appartengono al regno del puro pensiero, devono dunque uscire dalla loro condizione metastorica, se vogliono entrare in contatto con i materiali offerti dalla
sensibilità ed ordinarli tramite la sintesi. Le difficoltà sorgono in questo punto,
secondo Bloch, proprio dalla costante preoccupazione kantiana per una
costruzione scientifica, che sia valida universalmente e necessariamente, o
per dirla direttamente con l’incisiva espressione usata da Bloch dalla “superstizione (Aberglaube) dell’apodittica”.43 Il ponte che permetteva il passaggio
dalle categorie ai fenomeni viene indicato da Kant, come è noto, proprio nel
tempo44, in diretta relazione con quella prevalenza affermata nell’Estetica trascendentale; ma il tempo è un elemento così fluido da poter quasi mettere in
crisi la meta stessa perseguita da Kant di una fondazione sicura della scienza. Il tempo è “qualcosa che ha così poco a che fare con ciò che è schematico, con queste finestre dipinte, con questo bisogno di una stasi (Stillstand)
apodittica”. Il tempo ha una struttura totalmente diversa, in quanto esso è “un
elemento così inquietante (ein so Unheimliches) all’interno della gnoseologia,
un elemento così pienamente oscuro (ein so vollig Unübersichtliches), per se
stesso incompiuto (Unabgeschlossenes), che continuamente procede
(Weiterlaufendes), che si muta o si lascia mutare, per così dire lo schema del
mutamento –che Kant ha preso invece come una regola.”45 Per sua natura il
tempo risulta essere un elemento inquietante, oscuro, incompiuto ma se si
vuole utilizzarlo in una uniforme dimensione scientifica, esso deve essere
necessariamente costretto in rigidi schemi46, che corrono però quasi il rischio
di veder compromessa la loro supposta apoditticità, proprio a causa dell’elemento non rigido sul quale Kant pensava di poterli fondare. In questo cristal-
SAGGI
lizzato universo dell’ineluttabile, della stasi apodittica, un solo fattore potrebbe
dall’interno produrre uno scardinamento: questo fattore è il tempo. Così Bloch
non fa che ribadire di seguito alcune considerazioni, allo scopo di approfondire ancora di più il contrasto fra la struttura profonda del tempo e l’uso che ne
è stato fatto dalla scienza moderna. Essendo una “categoria inquietante”, è
comprensibile che il tempo “in generale non si inserisce bene nel formalismo
e nel razionalismo matematico”, entrambi infatti tendono a depauperarlo per
poterlo sottoporre a controllo. In questo modo contro il tempo “è stata sempre
condotta guerra attraverso la formazione della sequenza. Il tempo fu matematizzato, reso uniforme (gleichförmig), regolare (gleichmäßig).” Per svuotare
completamente il tempo della sua essenza inquietante, allo stesso modo che
la realtà viene svuotata di ogni carattere qualitativo-intensivo, la scienza
moderna lo ha matematizzato e reso seriale, inserito in una sequenza quantitativa in cui gli istanti hanno fra di loro la stessa valutazione numerica e sono
privi di ogni connotato particolare. “In una sequenza vi è sempre la stessa
distanza da uno a due, da sette a otto, da trecentoquindici a trecentosedici, si
forma dunque un continuum della sequenza. Questo è il tempo, che è stato
posto, per così dire, in una camicia di forza, essendo stato aritmetizzato. Per
questo motivo esso funziona così bene anche per Kant.”47 In tutte queste
espressioni emerge chiaramente la vicinanza delle critiche di Bloch alla determinazione quantitativa del tempo, rispetto a quelle di altri filosofi, a lui contemporanei che più o meno nello stesso periodo avevano riflettuto sugli stessi problemi.48 La temporalità kantiana della ragion pura è per Bloch senza dubbio la temporalità quantitativa della scienza moderna, che è rappresentata
nello spazio da una sequenza rettilinea, che traduce su un piano geometrico
il procedere di numeri-istanti ad intervalli regolari. Il tempo della fisica è “una
sorta di dimensione spaziale”, in cui “gli oggetti si ordinano in un campo propriamente non-storico.”49 L’apodittica, spazializzando il tempo, ha impedito
qualsiasi eventuale sviluppo futuro, determinando semplicemente una vuota
ripetizione dell’identico a sè. “Nello spazio –ribadisce Bloch– Voi non avete
alcun futuro, sempre un essere-stato (ein Gewesensein), un succedersi (ein
Nacheinander). Lo spazio è la forma della quiete, dell’essere-stato, dell’essere-morto (Abgestorbensein), dell’essere-formato (Gestaltetsein).”50 Lo spazio è
essenzialmente la forma della reificazione e dell’estraneazione, del riproporsi
nel presente di un contenuto già formato in modo definitivo. Se “nella sequenza –come dice Bloch– abbiamo anche un precorrere e un anticipare”,51 tale
anticipazione ricade in un circolo, poiché nella temporalità spazializzata tutto
scorre, ma nulla effettivamente diviene, da essa non può scaturire di conseguenza nulla di nuovo. Per questo motivo Bloch può definire filosoficamente
una tale situazione, il ‘cattivo presente’ o ‘cattivo divenuto’, un presente che,
nonostante la sua parzialità e negatività, ideologicamente pretende di fronte a
sé un soggetto pienamente conciliato. Il fluire del vuoto tempo matematizzato
avviene in istanti uniformi, nei quali, scomparsa ogni opacità, scompare anche
ogni eccedenza contenutistica oltrepassante e dunque ogni concreta possibilità che l’utopico trovi un suo ancoraggio. “E il mondo di questo idealismo gnoseologico non è affatto un mondo utopico; al contrario: l’orgoglio dell’ego tra-
65
66
scendentale era prevalentemente di produrre proprio il mondo presente delle
leggi, il mondo dell’esperienza matematico-scientifica.”52 Il tempo matematico
fluisce quindi in modo falsamente indifferenziato, poiché la sua apparente
compiutezza, “il meccanico sempre-di-nuovo, della pura quantità” ha come
effetto inibente lo “storico-Invano”,53 un corso storico privo di qualsiasi tendenza, privo così di qualsiasi umanità. Se lo schematismo trascendentale rappresenta il temporalizzarsi delle categorie e quindi il loro entrare nel mondo sensibile-storico, il farsi umano della coscienza trascendentale, Bloch risponderebbe dal suo punto di vista che proprio il tempo come regola, utilizzato da
Kant come supporto alla scienza meccanicistica, causerebbe la nullità del
senso e della direzione del corso storico. Verrebbe meno in questo modo l’aspetto che maggiormente aveva interessato Bloch, riguardo alla temporalità
kantiana, il suo essere legata alla creatività della sintesi, poiché, al contrario
di quanto si è detto dello spazio, “il tempo è la forma della creazione
(Gestaltung), del dare forma (Gestaltens)”,54 dunque da esso può scaturire
effettivamente il Novum, ma non nelle strutture legali matematico-scientifiche
che sono concretamente ed ideologicamente costrittive. Bloch interpreta la
peculiarità della temporalità kantiana nella direzione degli sviluppi che essa
avrà nell’idealismo tedesco e sul piano del divenire storico, come essa verrà
a dispiegarsi nella Fenomenologia dello Spirito di Hegel, quando l’energia
dinamica temporale sarà “l’origine non solo delle categorie, ma anche del contenuto delle categorie. Con il tempo vien fuori la storia”.55 La storia è l’ambito
in cui il tempo riacquista la propria centralità, poiché in essa può realmente
essere rimessa in discussione qualsiasi concrezione spazializzata, qualsiasi
parziale formazione che voglia presentarsi con un crisma di assolutezza. “Solo
la filosofia della storia, che di nuovo agita ciò che è stato, superandolo utopicamente, riporta in posizione centrale il tempo, forma intuitiva e campo di azione della vitalità attiva.”56 La preminenza del tempo sullo spazio può nell’ambito storico dispiegare finalmente in pieno la sua creatività57 e il suo dinamismo
nelle componenti umane più profonde che ad essa attengono, legandosi alla
preminenza della ragion pratica sulla ragion pura, della azione orientata alla
trasformazione dell’esistente, per dar vita a nuove forme storiche, sulla mera
conoscenza logico-meccanicistica58. Prima di concludere vogliamo però mettere in risalto come Bloch ribadisca ancora che, anche dal punto di vista prettamente matematico, la sequenza unidimensionale quantitativa è solo una tra
le possibili sequenze. “Ci sono inoltre, sviluppate soprattutto da Leibniz,
sequenze matematiche molto particolari, che sono del tutto diverse da quella
semplice rettilinea, alla quale corrisponde l’ora con il quadrante. Ci sono
sequenze del tutto diverse, e a maggior ragione un tempo del tutto diverso.”59
Il vero errore di Kant, nell’aver indicato il “tempo come una regola dell’uso
delle categorie sugli oggetti”, è stato di averlo voluto “sviluppare puramente
dall’intelletto”, cioè di averlo voluto determinare a priori, dando una forma sofistica al problema e rendendolo così “insolubile”.60 Pur avendo concesso al
tempo un ruolo fondamentale, Kant è caduto nella contraddizione, dovuta alla
sua preoccupazone di costruire una scienza apodittica perché matematizzata,
di averlo spazializzato, riducendolo ad una dimensione univoca.
5. Antropologia, filosofia della storia, futuro aperto
La gnoseologia kantiana non poteva dunque rispondere alla nuova impostazione del problema metafisico in Bloch, come problema intensivo-esistentivo, poiché “nelle leggi della natura non si trova ciò che interessa sommamente all’uomo: non c’è ombra della «domanda originaria», di quel sapere connesso all’esistenza che sta tanto a cuore a Bloch, come ciò da cui ha inizio il
pensare metafisico.”61 Tale affermazione, sulla quale concordiamo, deve però,
a nostro avviso essere supportata necessariamente, come abbiamo cercato di
fare, da una analisi della concezione del tempo perché, se il senso autentico
e originario del “meta” è in Bloch collegato al futuro, cioè ad un qualcosa che
ancora non è stato realizzato e che oltrepassa l’esistente in ogni sua rigida
entificazione, esso potrebbe però essere vanificato e subire uno smacco definitivo da parte del meccanicismo e della sua temporalità seriale, proprio perché essi, chiudendo qualsiasi spazio per lo sviluppo futuro, ne impedirebbero
la realizzazione.
La polemica incessante condotta da Bloch contro quelle posizioni teoriche
che ritenevano di poter cogliere le strutture fondamentali dell’essere, in quanto
esse erano già pienamente compiute, aveva origine dall’esigenza essenziale di
mantenere aperto il futuro, salvaguardando allo stesso tempo la libertà umana,
uniche condizioni queste dalle quali poteva scaturire il Novum, come tentativo
di soluzione dell’incompiutezza dell’esistenza. Allo stesso modo la ricerca di un
sapere pratico indirizzò Bloch verso l’etica kantiana, la quale, volgendosi oltre i
fenomeni dell’esperienza presente-passata, spezzava grazie alla prassi morale “l’anello esterno” che imprigiona l’uomo, nel tentativo invece di far emergere
“l’Io autentico”62, dando così un senso ed una direzione all’esistenza umana. “Si
cerca vanamente [nella filosofia di Hegel] quella disposizione che si volge verso
l’alto ed è cosciente del pericolo, così evidente nelle parole di Kant e di Fichte,
secondo cui oltre la semplice ripetizione di ciò che vi è o vi era, deve esistere
un sapere che fonda l’azione o una visione che da quel mondo che non è qui,
ma che deve essere qui, spinge ad agire”.63 La condizione di spaesamento e il
nichilismo dell’uomo moderno, che sul piano esistenziale si manifestavano
“come perdita della coscienza della meta che insieme avvince ed oltrepassa”,64
correndo il rischio di assolutizzare in modo dogmatico il nulla, il vuoto di senso
come risposta al problema metafisico, trovavano nel riconoscimento da parte di
Bloch della componente utopica insita nell’etica kantiana, nella razionalità pratica dei postulati, una posizione filosofica che manteneva invece desta proprio
la coscienza della meta, intesa in Kant come movimento verso una totalità
SAGGI
Abbiamo così tentato di marcare il punto di massima divergenza fra Kant e
Bloch, sulla questione cruciale del tempo, una divergenza che rimanda in Bloch
–come abbiamo cercato di indicare sopra– alla ricerca di un “tempo del tutto
diverso”, nel corso della quale però sarà possibile un riavvicinamento a Kant
sotto un punto di vista oramai non più esclusivamente conoscitivo, ma relativo
all’impulso vitale proprio dell’etica e alla prassi storica da essa generata.
67
68
incondizionata che induceva di per sé significato nella vita dell’uomo. “Ma è
proprio l’Ultimo, la seità ed il suo volto, immediata evidenza del ben comprendersi e della coscienza utopicamente più profonda, che è stato inaugurato dal
razionalismo kantiano del postulato, del tutto metacategoriale e metasferico,
che si può tradurre solo nello spirito kantiano dell’affezione da parte della cosa
in sé.”65 La questione fondamentale dell’antropologia filosofica kantiana (che
cos’è l’uomo?), nella quale Kant riteneva si potessero sintetizzare le tre domande relative al conoscere, all’agire morale e allo sperare, veniva assunta in pieno
da Bloch, il quale, una volta evidenziati i limiti della risposta teoretico-conoscitiva, riteneva che essa potesse trovare una soluzione solo nella dimensione
della prassi e della speranza, poiché entrambe erano aperte ed orientate all’ulteriore, dunque al futuro66. I termini del confronto con Kant ed Hegel erano per
Bloch quelli tra un ‘sistema aperto’ ed incompiuto, per lo meno sul piano eticostorico, ed uno invece caratterizzato da una compiutezza chiusa e già tutta
risolta, nel quale il processo storico scandito dal movimento dialettico, non faceva altro che realizzare una meta finale iscritta in esso fin dall’inizio. Bloch paragona Hegel ad un Newton della storia e della ragion pratica,67 per il suo tentativo di enucleare una logica storica dotata della stessa necessità di una logica
teoretica della natura, i cui contenuti-eventi potevano essere dedotti in modo
sistematico. La teleologia hegeliana della storia aboliva in un circolo proprio le
prerogative considerate da Bloch irrinunciabili della libertà umana e del futuro
come tempo della possibilità aperta. Tali prerogative erano invece i cardini della
filosofia della storia di Kant,68 il quale, nella sua ricerca di un filo conduttore a
priori che potesse dare un senso al corso storico, altrimenti svolgentesi come
un insieme di avvenimenti casuali e confusi, prendeva spunto da osservazioni
antropologiche, riguardanti l’uomo, la sua condizione nella storia e la libertà
delle sue azioni. “Non si può reprimere un certo risentimento a vedere gli uomini operare sulla grande scena del mondo, e trovare talvolta una apparente saggezza in casi isolati, ma da ultimo nell’insieme un miscuglio di stoltezza, di
infantile vanità, spesso anche di infantile malvagità e mania di distruzione, per
cui non si sa alla fine qual concetto formulare della nostra specie così orgogliosa delle sue prerogative.”69 Il realismo antropologico kantiano individuava
nell’uomo un essere nel quale convivono e si mescolano il bene e il male, sotto
la forma dualistica della razionalità e dell’istinto. Il percorso storico umano che
nella sua origine –secondo Kant– si può ricostruire solo per congettura, ipoteticamente, viene interpretato nelle diverse tappe del suo sviluppo, come il progressivo affrancamento dall’istinto grazie all’intervento della componente razionale. Tramite la razionalità l’uomo tende progressivamente a liberarsi dai suoi
istinti immediati che si appagano nel soddisfacimento dei bisogni primari, che
accomunano l’uomo all’animale. Ciò che distingue l’uomo dall’animale però è
proprio la rottura del circolo, riproponentesi, del semplice istinto naturale immediato, è –come la definisce Kant– la “consapevole attesa dell’avvenire. Questa
facoltà, che non si limita a godere del presente, ma che abbraccia un avvenire
spesso lontano, è il segno più caratteristico della natura privilegiata dell’uomo.
Essa serve a preparare l’uomo per scopi lontani conformi alla sua destinazione, ma è nel tempo stesso una fonte inesauribile di inquietudini e di preoccu-
SAGGI
pazioni a causa dell’incertezza di questo avvenire, da cui gli animali vanno
esenti.”70 Nella proiezione verso il futuro l’uomo scopre la sua peculiarità distintiva, che è legata intimamente alla destinazione morale. Il futuro stesso però,
essendo carico dell’incognita che lo caratterizza, genera nell’uomo contemporaneamente paura e preoccupazioni. Il realismo kantiano non si prospetta dunque come conservatorismo, proprio perché non ritiene la natura umana eternamente identica a se stessa e quindi tale posizione lo conduce legittimamente a porsi la fondamentale questione se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio.71 Se l’essenza umana non è statica, immobile, già fissata e se la domanda sull’uomo rimane in Kant effettivamente aperta, ciò implica una concezione del tempo storico, nella dimensione del futuro, non necessitata, il cui compimento non è garantito, è solo possibile o al massimo probabile.72 Da questo punto di vista la convergenza con Bloch sembra rivelarsi in
modo evidente, fin dall’antropologia, anche se l’antropologia blochiana parte
dal presupposto completamente diverso di voler superare qualsiasi dualismo,
qualsiasi scissione sensibilità-intelletto, dando invece dell’uomo una compatta
immagine psichico-corporea. L’uomo è per Bloch apertura nella sua stessa
struttura costitutiva, poiché si sente essenzialmente mancante di qualcosa e
tende così a colmare tale mancanza, rivolgendo il suo impulso verso l’esterno.
La fame viene indicata come l’istinto dinamico fondamentale; l’autoconservazione che è alla sua base non viene legata in senso pessimistico hobbesiano
ad una essenza umana identica in eterno a se stessa, ma come tendenza
all’autoampliamento, spinta a mutare le condizioni che renderebbero dura o
addirittura impossibile la propria conservazione. “Così autoconservazione
significa, in ultima istanza, l’appetito di tener pronte condizioni più autentiche e
più adeguate al nostro sé che si dispiega, e che lo fa solo nella solidarietà e in
quanto solidarietà. Se queste circostanze avanzano, allora in esse si prepara
un incontro con se stessi; e l’incontro con se stessi comincia, molto coinvolgente, in tutte le manifestazioni e opere che annunciano una situazione finale.
Tuttavia il nostro sé, con la sua fame dalla variabile estensione, resta ancora
aperto, mosso, in ampliamento.”73 La posizione di Bloch acquista certo una sua
radicalità e questo è evidente anche nel ruolo giocato dal tempo in relazione
alla apertura dinamica dell’essenza umana. Se Kant infatti individuava nell’andare oltre il presente, la peculiarità razionale dell’uomo rivolta al futuro, in Bloch
la temporalità diviene il criterio discriminante per quanto riguarda la stessa classificazione degli affetti, fino a designare la speranza come affetto umano fondamentale. Bloch distingue gli affetti pieni, quelli che si soddisfano nel presente, in ciò che è disponibile nell’immediato, dagli affetti d’attesa, in particolare il
timore e la speranza, che invece si rivolgono a qualcosa che non è presente, e
si proiettano così nel futuro. Poiché gli animali sono capaci di sentire unicamente il timore, la distinzione con l’uomo può essere data solo dalla speranza.
“Tutti gli affetti sono riferiti all’orizzonte del tempo essendo essi eminentemente intenzionati, ma gli affetti di attesa si aprono completamente a questo orizzonte. Tutti gli affetti sono riferiti a ciò che vi è di propriamente temporale nel
tempo, cioè al modo del futuro, ma mentre gli affetti adempiuti hanno solo un
futuro non autentico, cioè un futuro in cui non avviene obiettivamente niente di
69
70
nuovo, gli affetti di attesa implicano per essenza un futuro autentico; appunto
quello del non-ancora, dunque di ciò che obiettivamente non c’è ancora stato.”74
La dimensione del futuro è quella essenziale per l’uomo perché è quella che
aderisce alla possibilità di rendere autentico il non-ancora-stato, indirizzando il
corso storico alla creazione del Novum qualitativamente diverso, che è l’aspetto determinante per Bloch. Sia per Kant sia per Bloch dunque le riflessioni sull’essenza umana finiscono per indirizzarsi alla meditazione sulla storia, sul
senso del suo svolgimento e sulla possibilità per l’uomo di intervenire per orientarlo verso la meta. Delineare a priori il corso storico è infatti una questione che
Kant articola come possibilità di conoscere e di predire il futuro storico, implicante l’esatta determinazione del significato di questa predizione. “Per prevedere, l’uomo ha bisogno del nesso secondo le leggi naturali, mentre in ordine
alle libere azioni future deve fare a meno di questa guida o indicazione”.75 Una
conoscenza a priori della storia dovrebbe basarsi su un giudizio di tipo sintetico a priori, così da poter connettere i fatti storici in virtù di leggi necessarie
come quelle della natura, potendone dare solo in questo modo una previsione
apodittica. L’indicazione conoscitiva a priori viene meno però nell’ambito storico poiché la storia è il frutto delle libere azioni degli uomini, sulle quali è impossibile ogni previsione nell’ordine della necessità, poiché essa causerebbe una
rigida determinazione della libertà umana e con essa conseguentemente del
futuro. Il corso della storia non è e non può essere per Kant predeterminato
logicamente76, ma è aperto in quanto il suo indirizzo dipenderà dalle libere scelte compiute dagli uomini. “Poiché noi abbiamo a che fare con esseri che operano liberamente, ai quali si può certo in precedenza indicare ciò che devono
fare, ma non si può predire ciò che essi faranno e se dal sentimento del male
fatto a se stessi non sappiano trarre un forte stimolo per fare ancora meglio di
ciò che non era prima di quello stato”.77 Le uniche indicazioni che si possono
dare nell’ambito storico sono relative all’etica e alla prassi, a ciò che gli uomini
devono fare, ma resta un’incognita su ciò che essi effettivamente poi faranno,
a causa della libertà che li contraddistingue. L’uomo rivela la sua destinazione
verso il futuro, che di per sé non è ancora deciso, non è ancora determinato, è
aperto e a questa sua indeterminatezza è unita anche l’inconoscibilità teoretica, il suo mantenersi nell’ordine della possibilità. L’analisi kantiana delle concezioni a priori della storia più diffuse e più note al suo tempo non poteva che
concludersi dunque con un netto rifiuto di esse, prescindendo dalle loro previsioni sul corso storico in senso negativo, positivo oppure di sostanziale equilibrio tra bene e male (terrorismo morale, eudemonismo, abderitismo), a partire
dalla constatazione che il problema del futuro storico dell’umanità e del suo
eventuale progresso verso il meglio non poteva essere risolto “mediante l’esperienza”,78 poiché da questa non si ha alcuna garanzia di un andamento storico costante, privo cioè di ‘punti di conversione’ verso il meglio o verso il peggio, e perché l’aspetto fondamentale da considerare resta sempre quello delle
decisioni e delle conseguenti azioni degli uomini. Il cinico realismo politico dell’abderitismo, di coloro che ritengono che gli uomini vadano considerati “come
sono e non come… dovrebbero essere”,79 sul quale Kant concentra maggiormente la sua attenzione e la sua analisi, viene inoltre criticato sulla base del
SAGGI
principio che l’unico modo di prevedere il corso storico nel futuro è “se chi predice fa ed organizza egli stesso i fatti della storia”,80 stabilendo un nesso fra previsione ed accadere dell’evento in una certa direzione, fondato sulla prassi, che
correttamente è stato giudicato come l’approssimarsi di Kant ad un modo di
pensare e di intendere la storia di tipo dialettico.81 L’a priori storico non è di
carattere teoretico, ma etico-pratico, dunque legato alla finalità che indirizza e
dà senso ed unità al corso storico. D’altra parte, se da un evento, come era
stata la Rivoluzione Francese, che aveva suscitato grande interesse e partecipazione, si devono trarre delle conclusioni in senso antropologico, andava
ammesso che “il vero entusiasmo si riferisce solo e sempre a ciò che è ideale,
a ciò che è puramente morale e non può innestarsi sull’interesse individuale”,82
rivelando quindi nella natura umana una disposizione etica che la spinge verso
il meglio. Il teleologismo storico si determina in Kant come avvento di una
società democratico-borghese, che, rispettando la legalità, permetta il concretizzarsi della libertà dell’uomo in strutture giuridiche, ma anche come avvento
di una struttura federativa internazionale, a garanzia di una pace perpetua tra
le nazioni. Una volta individuata una meta ideale normativa del percorso storico, sotto la forma di uno stato ideale, essa sarà per Kant l’obiettivo di un avvicinamento all’infinito, che implica in sé un movimento orientato al futuro: “nel
riferimento assiologico (e metodologico) al futuro… s’impernia la visuale storico-filosofica kantiana. È infatti nella prospettiva del futuro assetto cosmopolitico della società che si rende possibile il definirsi di un movimento, di una significanza e intelligibilità nel tempo, di una storia”.83 In riferimento a Bloch ci si deve
però interrogare sulla natura di questo futuro, perché, se egli ne aveva riconosciuto perfettamente il carattere aperto, ne aveva però colto allo stesso modo
l’infinità, un’osservazione questa che anche terminologicamente si connette
alla critica blochiana, mutuata da Hegel, alla cattiva infinità kantiana, a quel progresso infinito che, non conducendo mai al suo scopo, rimaneva privo del proprio contenuto. Essa rappresenta un motivo costante, presente in molte opere
di Bloch84 e segna anche il suo riavvicinamento ad Hegel sotto il punto di vista
della realizzazione contenutistica, anche se Hegel, per superare l’aborrito vuoto
formalismo è spinto verso una compiutezza chiusa a qualsiasi sviluppo futuro.
“Hegel ha pagato questo prezzo troppo alto, ed esso non era necessario; il futuro non deve essere sbarrato per cessare di essere infinito.”85 L’astrattezza kantiana del dover-essere coinvolge, secondo Bloch, la stessa consistenza del
futuro, per quanto esso divenga nella filosofia della storia kantiana il modo del
tempo per eccellenza, sotto un’ottica metodologico-assiologica, che per Kant è
quella relativa al piano dell’ideale. Che questo però non poteva bastare a Bloch
appare evidente in particolare nelle considerazioni che egli svolge a proposito
dell’uso kantiano della categoria della possibilità. Se Kant –infatti– “trasferisce
la possibilità dalla parte delle forme pure del pensiero”,86 cioè ne ha indirizzato
l’uso particolarmente all’ambito gnoseologico delle categorie della modalità,
egli però deve concedere ad essa nuovo spazio “anche se a prezzo del dualismo […] in quel peculiare campo di pensiero riguardante l’esperienza conoscibile che appartiene alla ‘ragione’ morale e non all’ ‘intelletto’ conoscente; un
campo che viene dunque abitato dal ‘postulato’ e dall’‘ideale’.”87 Si tratta qui evi-
71
72
dentemente dell’ambito etico-storico, che, Kant, coerente con il dualismo della
propria costruzione antropologica, aveva caratterizzato come scisso tra mondo
materiale dell’essere fenomenico e mondo ideale dell’etica e del dovere. Egli
ritiene che non vi sarà mai un perfetto ricongiungimento fra i due piani e l’unica soluzione è lasciare la possibilità di un progresso all’infinito, dello sforzo che
sempre l’uomo dovrà compiere, della tensione che dovrà caratterizzare la sua
prassi storica. “Il costante progresso del genere umano verso il meglio è possibile: perché è un dovere dell’uomo agire in questo senso nella serie indefinita delle generazioni e in tutto l’ambito dei rapporti sociali sulla nostra terra.”88 La
possibilità così concepita rimane sul piano ideale e se si tiene presente questa
posizione kantiana, si comprende perfettamente il senso del suo ‘chiliasmo filosofico’, che è appunto quello di un chiliasmo laico, che non prevede nella storia la soluzione del problema metafisico e non prevede dunque la storia come
ambito della salvezza umana, ma semplicemente del raggiungimento di una
convivenza sempre più umana.89 La totalità incondizionata è infatti per Kant
solo meta ideale, mentre la storia è l’ambito del condizionato, dunque manca in
essa uno svolgimento processuale necessario.90 Consapevole dei limiti impliciti nella posizione filosofica kantiana, Bloch, con la sua opera di approfondimento e di ricerca teorica intorno alla possibilità oggettivo-reale, si proponeva
una fondazione del processo storico come processo ontologico del non-ancora-essere, non garantito nel raggiungimento della sua meta, per la radicalità
della sua apertura, che spinge al suo compimento. In questo modo Bloch caratterizza l’utopia concreta, come un’utopia che cerca la sua mediazione con la
realtà nella possibilità oggettivo-reale, che più direttamente si lega al manifestarsi del Novum ontologico, prendendo le distanze dalla semplice possibilità
kantiana del dover-essere. “Tuttavia la possibilità così concepita [Bloch intende
qui nel senso kantiano] non è una possibilità oggettuale-reale; nel mondo dell’esperienza dell’idealismo trascendentale non vi sono vie che conducano a
essa. E anche come possibilità del dovere, del postulato, dell’ideale essa non
viene affatto qualificata in maniera peculiare; nell’astorico campo prospettico di
una ‘coscienza in generale’ c’era magari inclinazione, ma non posto costitutivo
per il futuro, per la ‘speranza del futuro’, come diceva Kant nei Sogni di un visionario.”91 Se è certamente vero che Kant concede al futuro uno statuto assiologico, come tempo dell’avvicinarsi umano all’ideale normativo, manca però nella
sua filosofia etico-storica il ‘posto costitutivo per il futuro’, che per Bloch è però
quello essenziale, poiché per costitutivo si intende qui fondante, come il Novum
che in esso può scaturire. Se il tempo come forma del tendere aderisce ai propri contenuti, l’aderire del tempo, anche nel modo del futuro, alla struttura
umana aperta ed incompiuta e alla struttura ontologica del reale, altrettanto
aperta ed incompiuta (“la stessa cosa in sé è appunto ciò che non è ancora”92),
concede una consistenza diversa al futuro, come viene concepito da Bloch,
grazie alla quale può in esso manifestarsi il senso autentico del ‘meta’. Sia
quando Bloch aveva interpretato la spontaneità creativa della sintesi kantiana
nella direzione della produttività storica concreta, sia quando aveva criticato
l’indeterminatezza del futuro storico in Kant, egli voleva perseguire la realizzazione dell’utopia, la soluzione nella storia del problema metafisico.
SAGGI
1
R.CALIÒ CALTABIANO, “Valenze utopiche nella metafisica kantiana”, in Per il secondo centenario della Critica della Ragion Pura, Edizioni G.B.M., Messina1982, pp. 201-219; ma anche il lavoro
di G. CUNICO, Critica e ragione utopica. A confronto con Habermas e Bloch, (Marietti, Genova1988),
in particolare le pp. 221-255; da ultimo, per quanto riguarda la filosofia della storia kantiana, segnaliamo un’opera che prende le mosse proprio dall’interpretazione blochiana di Kant: L. TUNDO, Kant.
Utopia e senso della storia, Ed. Dedalo, Dedalo 1998, in particolare le pp.7-25.
2
Bloch illustrò tale sua posizione con una celebre affermazione: “Il socialismo, il comunismo
è quanto fu a lungo ed invano cercato sotto il nome di morale.” Cfr. E. BLOCH, Marxismo e utopia,
(Ed. Riuniti, Roma1984), pag.95; sul rapporto etica-marxismo negli anni venti (Lukàcs e Bloch) si
veda il saggio di G. CACCIATORE, “Marxismo, etica e utopia”, nel volume collettaneo intitolato Figure
dell’utopia. Saggi su Ernst Bloch, F. Redi Editore, Avellino1989, pp.35-151.
3
Una trattazione fugace, sulla quale torneremo nel corso del nostro lavoro, si trova nell’opera di A. WüSTEHUBE, Das Denken aus dem Grund. Zur Bedeutung der Spätphilosophie Schellings
für die Ontologie Ernst Blochs, Königshausen & Neumann, Wurzburg 1989, pp.59-60.
Osservazioni interessanti sono inoltre presenti nell’articolo di H.-E SCHILLER., “Kant in der
Philosophie Ernst Blochs”, in: Bloch Almanach, 5, 1985, pp. 45-92, ora però ristampato nel volume: Bloch-Konstellationen. Utopien der Philosophie, Lüneburg, zu Klappen, 1991, pp. 51-101, da
cui citeremo. Schiller è senza dubbio lo studioso che più a fondo ha condotto l’analisi del rapporto tra Kant e Bloch, tanto da ritenere che esso anche nelle opere mature non mutò sostanzialmente, sebbene Bloch lo avesse riequilibrato a favore di Hegel. P.54: “Tuttavia con lo spostamento di valutazione e di peso per Bloch non è mutata anche la struttura fondamentale del rapporto con Kant e Hegel. Quest’ultimo ha ‘in confronto a Kant, tutto quanto è per sé importante: la
mediazione, la dialettica, il processo –ma il dover-essere non c’è più’.” La citazione presente nel
brano è tratta da E. BLOCH, Subjekt-Obiekt. Erläuterungen zu Hegel, volume 8 della Werkausgabe,
Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1985, tradotto in Italia da R. BODEI,Soggetto-Oggetto.Commento a
Hegel, Il Mulino, Bologna1975). D’ora in poi indicheremo quest’opera con la sigla S-O seguita
dalla pagina dell’edizione tedesca e tra parentesi quadra dalla pagina corrispondente dell’edizione italiana; S-O, p.496 [520].
4
E. BLOCH, Das Prinzip-Hoffnung, v.5 della Werkausgabe, trad. it. Il principio speranza,
Garzanti, Milano 1994 ; indicheremo quest’opera con la sigla P-H, seguendo le modalità già esposte in precedenza. P-H, pp. 1004-1005 [991]: “Un pensiero carico di temporalità si rivela per lo più
carico anche d’umanità. Perché perire e nascere non sono solo contemplati, ma li si esperimenta dapprima molto da vicino nel proprio corpo e nel proprio essere. Anche se il tempo non è in
alcun modo la forma del senso interno, ma in tutto e per tutto un modo d’esistenza materiale, la
coscienza del tempo dischiude, più di quella dello spazio, una tensione e una finalità nell’essere.”
E ancora in: Experimentum Mundi, v.15 della Werkaugabe, tr. it. Experimentum Mundi, Editrice
Queriniana, Brescia1980, che indicheremo con la sigla EM, p.106 [142]: “Kant lo ha definito ‘forma
del senso interno’: questa definizione è giusta, quando questo ‘senso interno’ non venga preso in
senso idealistico-trascendentale, o magari in senso psicologico, bensì come modo di tendere
obbiettivo di un’intensità obbiettiva”. Sono questi i soli brani presi in considerazione da Wüstehube
per evidenziare la critica di Bloch alla concezione kantiana del tempo come forma a priori della
sensibilità, senza però toccare assolutamente l’aspetto sintetico unito al tempo, che è invece a
nostro giudizio quello fondamentale.
5
Valga per tutti R. BODEI, Multiversum. Tempo e storia in Ernst Bloch Bibliopolis, Napoli1979.
6
E. BLOCH, Leipziger Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, Band 4, Suhrkamp,
Frankfurt a. M.1985; d’ora in poi indicheremo quest’opera con la sigla LV.
7
E. BLOCH, Philosophische Aufsätze zur objektiven Phantasie, v.10 della Werkausgabe, pp.
442-460. Non mancano però del tutto in Bloch sfumature heideggeriane; si può confrontare infatti il passo di EM a pag.47 [80]: “…a ragione Kant dice che la sensibilità e l’intelletto debbono avere
una radice comune, e proprio questa fa sì che l’intellectus concreto abbia in sé abbastanza sensus per differenziarsi da un intelletto astratto, detto a ragione ‘arido’.”
8
P-H, p.167 [173-174].
9
Questo tratto, oltre che emergere dall’impostazione delle LV, viene direttamente espresso da
73
74
Bloch in S-O, p.62 [60]: “A sua volta Kant affermò che in ogni scienza si trova tanta scienza in proporzione alla matematica ivi contenuta; ciò che non è inteso in senso meccanico e quantitativo,
nel senso della scienza della natura newtoniana, non è comprensibile scientificamente.”
10
LV, p.87: “Significativo è perciò che Kant abbia posto il tempo in una posizione così alta, in
perfetta buona fede scientifica, contro le sue stesse intenzioni schematiche, la sua stessa essenziale spazializzazione del pensiero. Il tempo è la forma del senso interno, della sintesi e della sua
energia creativa.”
11
In P-H Bloch afferma a pag.297 [302]: “Tra i materialisti dell’età moderna solo Hobbes parla
di una produzione razionale, con una tesi fondamentale che resta valida fino a Kant: sono conoscibili soltanto quegli oggetti che sono costruibili matematicamente.”
12
LV, p.12.
13
S-O, p.461 [483].
14
S-O, p.497 [521].
15
E. BLOCH, Geist der Utopie, v.3 della Werkausgabe, tr.it. Spirito dell’utopia (La Nuova Italia,
Firenze1992); indicheremo quest’opera con la sigla GU e con le modalità già esposte; GU, pp.
229-230 [233].
16
GU, p.88 [90].
17
S-O, p.497 [521].
18
GU, p.11 [3].
19
P-H, p.778 [767-768]: “A partire dal XII secolo scompaiono i concetti qualitativi della natura
utilizzati da un Giordano Bruno e talora ancora da Bacone. Galilei, Cartesio, Kant sono concordi
nel ritenere che solo ciò che è prodotto matematicamente è conoscibile e solo ciò che è concepito meccanicamente è compreso in modo scientifico.”
20
EM, p.93 [129-130].
21
LV, pag. 46. Per comprendere il senso pieno delle lezioni che Bloch tenne a Lipsia sulla
filosofia classica tedesca, è necessario tener presente il contesto socio-politico in cui esse
ebbero luogo, nel pieno cioè dei contrasti sorti con le autorità politiche, di osservanza stalinista,
che causarono l’esonero del filosofo dall’insegnamento universitario. Dal punto di vista filosofico il motivo di rottura fu il dibattito, che si sviluppò sulle pagine della “Deutsche Zeitschrift für
Philosophie”, a proposito del rapporto fra dialettica idealistica hegeliana e dialettica materialistica marxista. L’interpretazione ortodossa staliniana negava infatti qualsiasi contatto tra marxismo e filosofia classica tedesca, giudicata espressione della controrivoluzione europea di fronte alle profonde trasformazioni prodotte dalla Rivoluzione Francese. Il punto di vista ortodosso
venne espresso nel dibattito da Rudolf Otto Gropp, nel suo articolo Il metodo dialettico marxista e la sua contrapposizione alla dialettica idealistica di Hegel. Egli afferma: “La nostra più alta
eredità filosofica è la filosofia di Marx ed Engels e questa filosofia si contrappone a quella di
Kant fino ad Hegel… è una deformazione della verità ricondurre il marxismo all’hegelismo come
sua presunta fonte principale.” Abbiamo tratto questa citazione (p. 14), come le notizie sopra
riportate, dal capitolo introduttivo dell’opera di Stefano ZECCHI, Utopia e speranza nel comunismo, Feltrinelli, Milano 1974, pp. 9-49. Ulteriori informazioni sul periodo trascorso da Bloch a
Lipsia si possono anche trovare nel volume Hoffnung kann enttäuscht werden. Ernst Bloch in
Leipzig, dokumentiert und kommentiert von Volker Kaysa, Petra Kaysa, K.D.Eichler und Elke
Uhl, Hain, Frankfurt a. M. 1992, pp. 7-184, mentre nel volume Karl Marx Il Mulino, Bologna
1972, alle pp. 151-173, si trova la prolusione accademica svolta da Bloch a Lipsia nel maggio
1949, con il titolo “Università, Marxismo, Filosofia”. In essa è già evidente la distanza di Bloch
dalle posizioni ortodosse; pp. 166-167: “Il marxismo trae gran parte della sua superiorità nei
confronti del vecchio materialismo antistorico e naturalistico dalla filosofia hegeliana, ed Hegel
è, fra l’altro, una specie di summa dell’intera filosofia idealistica. Perciò l’idealismo va studiato,
perché, a grande e sempre ulteriore distanza, fruttifichi ancora in un senso criptomaterialistico;
non deve restare astrattamente ignorato.”
22
LV, pag. 60.
23
LV, p. 60.
24
Per questo rinviamo alle dense pagine di G. CUNICO, op. cit., pp. 210-220; p. 215-216: “Per
il materialismo come per l’idealismo il sapere è soltanto conoscenza di ciò che è necessario e
immodificabile, ossia di ciò che si è già cristallizzato nei fenomeni esperibili e delle leggi ‘eterne’
della sua cristallizzazione. Per entrambi ciò che è doveva essere e non poteva essere altrimenti;
SAGGI
ciò che diviene o sta per divenire non potrà che seguire le leggi della sua necessità (materiale o
ideale che sia).”
25
P-H, p.164 [174].
26
I. KANT, Critica della Ragion pura, Editori Laterza, Roma-Bari 1981, pp.64-92; pp.160-179.
27
LV, p.72.
28
Ivi, p. 74.
29
Ivi, p. 30. Già nella pagine dedicate allo scritto pre-critico Indagine sulla distinzione dei principi della teologia naturale e della morale del 1764, Bloch aveva affermato (LV, p.29): “Kant divide decisamente la matematica dalla filosofia. La matematica era l’organon della filosofia di
Cartesio, Spinoza e ancora della Scuola wolffiana. Kant dichiara che la matematica è la scienza
delle grandezze e la filosofia quella delle qualità. Le qualità sono più difficili e più ingarbugliate…
È presente anche una differenza metodica: la matematica parte da una definizione e deduce, la
filosofia al contrario deve prima trovare la definizione.” E ancora a pag.30: “Kant non era purtroppo del tutto all’altezza della matematica del suo tempo. In Leibniz non si tratta neanche più di
grandezze, ma di rapporti.” Riguardo al rapporto tra matematica e filosofia nel pensiero kantiano
si può confrontare il saggio di S. MARCUCCI, premesso all’antologia Kant e le scienze. Scritti scientifici e filosofici, Liviana Editrice, Padova 1977, pp. 1-70.
30
Bloch riteneva che la crisi delle scienze, intervenuta agli inizi del ‘900, dovesse essere valutata positivamente poiché segnava la rottura di un sapere ormai irrigidito e la conseguente ripresa della ricerca e della vita. In particolare la fisica aveva assunto un nuovo crisma filosofico, poiché produceva immagini molteplici del mondo, esattamente come finora avevano fatto le diverse
speculazioni filosofiche. LV, p.82: “La crisi della matematica… ha rimosso nella matematica e nella
fisica l’apodittico della meccanica newtoniana. Da allora la matematica e soprattutto la fisica sono
di nuovo filosofiche e da allora è stata di molto attutita l’altezzosità della matematica nei confronti della filosofia.” Poiché alla fisica newtoniana ineriva una visione del flusso temporale, come di
un continuum seriale-quantitativo, è stato R. Bodei ad avanzare l’ipotesi che Bloch potrebbe essere giunto a considerare la rottura della continuità temporale, sulla base anche dei suoi interessi
per la fisica dei quanti. Cfr. R. BODEI, op. cit., pp. 55-56: “Per quanto riguarda la discontinuità del
tempo, una suggestione può aver guidato Bloch (che aveva studiato fisica e che conservò sempre uno spiccato interesse per tale materia) a considerare il tempo in termini discontinui: la rappresentazione del tempo ‘granulare’ compiuto dalla meccanica quantistica e dalla misurazione del
tempo in ‘crononi’…”.
31
LV, p. 73.
32
Ivi, p.65, p.75.
33
EM, pp. 106-107 [143].
34
LV, p. 75.
35
Ivi, pp. 75-76.
36
EM, p. 106 [142]. Su questo punto invece Schiller sembra accreditare, anche se di passaggio all’interno del suo articolo, una contrapposizione tra i due brani; cfr. H.E. SCHILLER Op. cit.,
p.63: “Anche se il tempo per parte sua viene compreso –tuttavia solo in EM– kantianamente come
forma del senso interno, poi però come ‘modo di tendere obbiettivo di un’intensità obbiettiva’, proprio del Daß telico. ‘Il tempo è la forma dell’intensivo uscir fuori’, dunque non la forma che limita
la conoscenza della soggettività umana.”
37
Per quanto riguarda l’esempio del nascere e del perire, Bloch quasi certamente lo trae da
Hegel. In S-O, alla p.219 [226-227], viene riportato il seguente brano dell’Enciclopedia delle
Scienze filosofiche, Laterza, Bari 1971, di p.218: “Tutto, si dice, nasce e muore nel tempo; se si
astrae da tutto, vale a dire dal riempimento del tempo, ed anche dal riempimento dello spazio,
restano il tempo vuoto e lo spazio vuoto, –cioè si pongono e rappresentano allora codeste astrazioni dell’esteriorità come se esse fossero per sé. Ma non è già nel tempo che tutto nasce e
muore: il tempo stesso è questo divenire, nascere e morire; è l’astrarre che insieme è; è Chronos,
produttore di tutto e divoratore di tutti i suoi prodotti.”
38
LV, pp. 63-64.
39
LV, p.73.
40
Ivi, p.75.
41
Ivi, p.83.
42
Ivi, p.44.
75
Ivi, p.83.
Osserva S. MARCUCCI, Op. cit., a pag. 27: “…dove la tematica del tempo ha avuto fecondi
sviluppi epistemologici è stato all’interno della meccanica, la quale costruisce i suoi concetti di
movimento servendosi della rappresentazione del tempo.” Su questo rapporto con la meccanica
R. Bodei afferma a p.138 dell’opera già citata: “La meccanica di Newton, nel servirsi di un tempo
assoluto, staccato dai contenuti ed omogeneamente suddivisibile in parti uguali nel suo fluire, ha
poi legittimato come vero il tempo quantitativo, reversibile e privo di finalità che si usa nelle equazioni matematiche.”
45
Ivi, p.84.
46
Ivi, p.85: “l’uso delle categorie, dunque dei concetti dell’intelletto, sulla molteplicità dei fenomeni viene effettuato secondo il tempo, secondo lo schema della sequenza del tempo (Zeitreihe),
del contenuto del tempo (Zeitinhalt), dell’ordine del tempo (Zeitordnung), del modello del tempo
(Zeitinbegriff).” Questi quattro schemi corrispondono naturalmente alle quattro sezioni della Critica
della Ragion Pura: Assiomi dell’intuizione, Anticipazioni della percezione, Analogie dell’esperienza, Postulati del pensiero empirico in generale.
47
Ivi, p.86. Rispetto alla lettura che stiamo qui proponendo, che inquadra lo schematismo trascendentale all’interno della visione blochiana di Kant come filosofo della fisica meccanicistica
newtoniana, caratterizzata dal determinismo e dalla negazione del futuro, va segnalato un brano
nel quale Bloch tende ad evidenziare la complessità delle riflessioni kantiane sul tempo nelle categorie meccaniche stesse. S-O, pp. 496-497 [520]: “Kant però non ha chiuso il mondo; conosce un
circolo solo nella sua meccanica, e neppure negli schemi temporali –presentati in modo così profondo ed acuto– delle categorie meccaniche, e meno che mai negli scopi autonomi che la volontà umana si prefigge.”
48
Si può osservare per esempio una nuova convergenza con Heidegger, il quale interpreta la
temporalità dello schematismo trascendentale come una successione di “adesso” (jetztfolge), che
determina una stabilità del tempo stesso e quasi un suo immobilismo, poiché ogni “adesso” è uguale all’altro. M. HEIDEGGER, Op. cit., pp. 96-97: “Il tempo, come pura successione di ‘adesso’, è adesso in ogni tempo. È adesso in ogni ‘adesso’. Il tempo mostra così la sua stessa stabilità. Il tempo,
come tale, è ‘immobile e permanente’, ‘non scorre’… Ma il tempo, come successione di ‘adesso’,
appunto perché, scorrendo in ogni ‘adesso’, è un ‘adesso’, è sempre anche un altro ‘adesso’”.
49
GU, p.252 [254].
50
LV, p.87.
51
Ivi, p.84. Il tempo cronologico ha il suo centro nel presente, nel qui e nell’ ora, che però è
per Bloch totalmente inadeguato, se dalla sua esperienza non può scaturire il ‘novum’ radicale, da
lui auspicato. Il qui e l’ora rimandano alla famosa sezione della Fenomenologia dello Spirito La
Nuova Italia, Firenze 1992, intitolata “La certezza sensibile o il questo e l’opinione”, pp. 81-92,
nella quale Hegel prende in considerazione la posizione filosofica teoretico-conoscitiva. H.E.
Schiller mette in evidenza come vi sia una netta differenza tra il concetto di attimo in Bloch e quello hegeliano del qui e dell’ora, pp. 55-56: la posizione hegeliana “infatti presuppone il concetto di
verità assoluta, e la costellazione, nella quale l’attimo possiede lo status di ora oggettivato è sin
dall’inizio una costellazione epistemologica, non una dell’esperienza vitale. La Fenomenologia di
Hegel, come però anche lo scienziato empirista (der empiristische Wahrheitstheoretiker), non ha
a che fare con un attimo concreto, ma con il pensiero che già interpreta l’ora.” In termini diversi
ritroviamo espresso lo stesso concetto anche in R.BODEI, Op. cit., pp. 51-52: “Il progetto blochiano è antitetico a quello presentato da Hegel nella Fenomenologia dello Spirito. Bloch rifiuta di cancellare il qui e l’ora della ‘coscienza sensibile’ nell’universalità. Ma rifiuta anche la sostanza della
critica feuerbachiana a Hegel, poiché il suo scopo non è quello di rivendicare i diritti dell’empiria
e del presente, bensì di mostrare come, in genere, il presente stesso non si possa cogliere in
quanto tale.”
52
P-H, p.167 [173-174].
53
Ivi, p.333 [337].
54
LV, p. 87.
55
Ivi, p.87.
56
GU, p.252 [254].
57
Bloch concede un rilievo eccezionale alla creatività, individuandola come il vero antitodo al
nichilismo. Il creativo è visto come colui il quale si oppone al vuoto alogico della realtà, anche se
43
44
76
SAGGI
egli stesso non è a sua volta esente da contraddizioni; GU, pp. 210-211 [214-215-216]: “Ma io esisto solo per creare. Sembra così che l’opaco scompaia ancor più profondamente. Ma chi sono io
per poter creare? Valgo così tanto o sono tanto amato? Non sempre lo si avverte, il freddo interiore aumenta a dismisura… Più in alto [di coloro che sono soddisfatti della situazione attuale] sta
chi almeno si dispera per la situazione in cui si trova; ma solo il creativo combatte in tutta la profondissima coscienza delle sue forze costruttive contro la disgregazione troppo tecnica o carica di
risentimento. Ma neppure il creatore riesce ad essere presente sempre ed ovunque, né può credere facilmente in ciò che il suo pensiero accende in lui e sopra di lui. Questo dubitare e disperare ancor sempre indifesi, questa mancanza della serietà che sfida la morte, propria del Si incondizionato alla visione, è la seconda esperienza d’angoscia, quella logica: è la preoccupazione dell’uomo produttivo di non essere, anche in quanto tale, totalmente autentico e fermo.”
58
GU, p.285 [287]: “Il tempo della storia in cui creiamo permea lo spazio terreno su cui è
apparsa la nostra vita, in cui inseriamo le nostre opere, la geografia dei paesaggi umani, delle loro
architetture e del loro luogo spirituale; qui ci è concesso e ci è possibile presentire, trovare, realizzare valori, far avanzare attraverso e contro il tempo e lo spazio possibili strutture a priori e persino ciò che è ultimo benché extratemporale ed extraterreno.”
59
LV, p.86.
60
Ivi p.88.
61
R.CALIÒ CALTABIANO, Op. cit., p.208.
62
GU, p.222 [226].
63
Ivi, p.233 [236].
64
Ivi, p.211 [215].
65
Ivi,.235 [238].
66
Si può confrontare sulla tematica antropologica del divenire identico a sé dell’uomo quanto
afferma G.CUNICO, Op.cit., alle pp. 242-248; L. TUNDO, Op. cit., pp. 149-154.
67
GU, p.230 [233]: “la Fenomenologia dello Spirito intendeva realizzare per la ragione pratica
ciò che in precedenza la filosofia della natura di Newton aveva messo a disposizione per la ragione teoretica, onde la filosofia hegeliana della storia aveva la pretesa di costituire il sistema storico compiuto per il primato della ragion pratica.”
68
Come è stato riconosciuto anche da Karl JASPERS che, nella sezione dedicata alla filosofia
di Kant della sua opera I grandi filosofi, Longanesi, Milano 1973, pp. 483-712, traccia un sintetico
ma efficace parallelo tra la filosofia hegeliana e quella kantiana della storia; pp. 670-671: “Hegel
pensa il corso dello spirito della storia come il movimento della totalità, il cui senso è per lui costituito da un unico ora presente, senza passato né futuro. […] Hegel tentò di delineare una grandiosa storia del mondo nella pienezza dei suoi contenuti. Kant non dette alcuna visione totale
empiricamente determinata. Egli pose il compito di scoprire, sotto la guida della ragione, le tracce di un intento naturale nella realtà di fatto della storia. Il compito posto da Kant non è stato soddisfatto da Hegel. Nell’esposizione di Hegel infatti è scomparso il carattere della ricerca critica.
Mancano inoltre in Hegel il futuro e l’appello alla libertà.” I riferimenti che faremo agli scritti kantiani sulla storia sono tratti da I. KANT, Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, Utet,
Torino 1995; in particolare prenderemo in considerazione le opere: Idea di una storia universale
da un punto di vista cosmopolitico, Congetture sull’origine della storia, Se il genere umano sia in
costante progresso verso il meglio, In che cosa consiste il progresso del genere umano verso il
meglio?. D’ora in poi indicheremo quest’opera con la sigla SP, seguita dal numero della pagina.
69
SP, p.124.
70
Ivi, pp. 199-200. Kant aveva già in precedenza dato una definizione di razionalità che si
muoveva in questo stesso orizzonte; SP, p.125: “La ragione in una creatura è un potere di estendere oltre i naturali istinti le regole e i fini dell’uso di tutte le sue attività; essa non conosce limiti ai
suoi disegni.”
71
Su ciò confronta F. FERGNANI “Dialettica e utopia in Kant”, in ‘Utopia’, aprile 1972, pp. 3-10;
rinviamo inoltre a A. BURGIO, Strutture e catastrofi. Kant, Hegel, Marx, (Editori Riuniti, Roma2000),
pp. 21-75; p. 31: “Se è tipico del realismo politico classico il riferimento a una antropologia fissista, Kant ne modifica la prospettiva: muove da premesse realistiche e pessimistiche –l’uomo è un
animale ‘bisognoso di padrone’, un ‘legno storto’, un impasto di ragione e passione, di inclinazioni patologiche e di libertà– ma prende sul serio la causalità della volontà, la sua capacità di modificare la natura costringendola a farsi carico dei fini che la ragione le impone. […] C’è conflitto tra
77
78
ciò che in noi è fermo e ciò che si evolve, ma se ne discende un cambiamento è perché la parte
mutevole ha il sopravvento.”
72
WüSTEHUBE, nelle pagine già segnalate, afferma che il distanziarsi di Bloch dalla concezione kantiana del tempo contrasta con la sua accettazione invece di alcuni temi della filosofia della
storia di Kant, quali quello di un’piano della natura’ rintracciabile nello sviluppo storico e quello di
una ‘moralizzazione del genere umano’; p.60: “Alle tendenze oggettive della Natura e della Storia
deve corrispondere una umanità emancipata, che emancipa se stessa.” Non viene notata però
l’importanza che una concezione del tempo, nel modo aperto del futuro, ha per l’idea di una destinazione morale dell’uomo, sulla quale invece stiamo qui concentrando la nostra attenzione.
73
P-H, p.77 [83].
74
Ivi, p.83 [89].
75
SP, p.217.
76
P. Chiodi ravvisa appunto nella condizionatezza il fulcro della concezione kantiana della storia e il suo legame complessivo con il criticismo. P. Chiodi, “La filosofia kantiana della storia”, in:
Rivista di filosofia, 58, 1967, pp. 263-287; p. 268: “Semplificando, si può affermare che è fuori del
criticismo, come Kant lo intese, ogni concezione della storia che neghi al corso storico i caratteri
della condizionatezza e della possibilità.Si tratta di due caratteri strettamente connessi, perché
concepire un evento come condizionato equivale a concepirlo come non-necessario, cioè tale da
poter non-essere (qualora manchino le condizioni della sua realizzabilità).” D’altra parte, in un
brano posto nell’appendice dello scritto kantiano Se il genere umano sia in costante progresso
verso il meglio, che, come ci avverte il curatore, fu però rifiutata da Kant, viene affermato: “Che,
cioè, il genere umano abbia in sé il dovere di promuovere, in tutte le età e presso tutti i popoli, tale
progresso, è certo, anche se la riuscita rimane problematica. Ma si chiede di più: si chiede di poter
affermare assertoriamente, secondo il principio costitutivo della ragion giudicante teoretica, che il
genere umano si trova effettivamente in tale progresso, e vi si è trovato fin da principio. Ma poiché ciò non può essere ricavato da nessuna esperienza, sarebbe necessario stabilire tale verità
con un giudizio a priori e, quindi, con la coscienza della necessità di tale procedere verso il meglio;
in altri termini apoditticamente: poiché senza di ciò non si potrebbe predire in modo naturale l’ordine degli accadimenti per tutti i tempi futuri e per l’intero genere umano in base all’agire dell’uomo: per questo è necessaria la conoscenza della sua necessità.” (SP, p.229).
77
Ivi, p.216-217.
78
Ivi, p.216. L’osservazione empirica della storia non può fornirci di per sé la certezza dell’esistenza di un filo conduttore della storia e di un progresso degli uomini verso il meglio, può però
rivelarci la presenza di tracce che testimonino per lo meno della tendenza del corso storico, come
Kant cerca di mostrarci, facendo riferimento alla Rivoluzione Francese. SP, p.219: “La rivoluzione di un popolo di ricca spiritualità, quale noi abbiamo veduto effettuarsi ai nostri giorni, può riuscire o fallire; essa può accumulare miseria e crudeltà tali che un uomo benpensante, se anche
potesse sperare di intraprenderla con successo una seconda volta, non si indurrebbe a tentare a
tal prezzo l’esperimento; questa rivoluzione, io dico, trova però negli spiriti di tutti gli spettatori (che
non sono in questo gioco coinvolti) una partecipazione d’aspirazioni che rasenta l’entusiasmo,
anche se la sua manifestazione non andava disgiunta da pericolo, e che per conseguenza non
può avere altra causa che una disposizione morale della specie umana.”
79
Ivi, p.214.
80
Ibid.
81
F. FERGNANI, Op. cit., p.4: “Kant comprende benissimo che la predizione o previsione influisce sul corso degli avvenimenti e contribuisce ad orientarli in un determinato senso, cosicché
essa stessa pone in qualche modo una premessa per il proprio verificarsi. Previsione o anticipazione o profezia non restano al di fuori della praxis storica in una pura aderenza speculare; s’integrano invece ad essa, partecipando alla propria validazione –o in caso diverso alla propria invalidazione– attaverso le disposizioni e gli atti che esse promuovono o scoraggiano.”; e a pag.5:
“Mettendo in luce la portata pratico-operativa di una posizione teorica quale la predizione, sottolineando l’influenza che l’assunzione di una determinata immagine del futuro esercita sul prodursi
del futuro stesso, si mostra assai più prossimo ad una mentalità dialettica di quanto per solito non
si sia ritenuto e non si ritenga.” La libertà delle azioni umane è il vero e proprio nodo teorico caratterizzante la posizione kantiana; su questo tema cfr. A.BURGIO, Op. cit., pp. 60-61 e L.TUNDO, Op.
cit., pp.112-115.
SAGGI
82
SP, p.220. Si muove su questa stessa linea anche la famosa nota dedicata da Kant alle utopie letterarie, pp. 226-227: “È dolce immaginare costituzioni politiche rispondenti alle esigenze
della ragione (soprattutto sotto l’aspetto del diritto); ma è temerario proporle ed è colpevole sollevare il popolo per abolire la costituzione esistente. L’Atlantide di Platone, l’Utopia del Moro,
l’Oceana di Harrington e la Severambia di Allias vennero successivamente poste sulla scena, ma
non se ne fece neppure mai l’esperimento (se si eccettua l’infelice aborto di una repubblica dispotica di Cromwell). È avvenuto di queste creazioni politiche come della creazione dell’universo:
nessun uomo vi fu presente e non poteva trovarvisi, perché avrebbe dovuto essere il suo proprio
creatore. Sperare che un giorno, per lontano che sia, possa compiersi una creazione politica
quale qui si pensa, è un dolce sogno; ma non solo si può pensare di avvicinarsi ad essa sempre
più, ma, nella misura in cui essa può accordarsi con la legge morale, è un dovere, non dei cittadini, ma del capo dello stato.”
83
F. FERGNANI, Op. cit., p.9. L’autore, nella stessa pagina da cui abbiamo citato, seguendo proprio il criterio indicato del volgersi al futuro della prospettiva storica kantiana, la avvicina a quella di
Marx e conclude: “non però con Hegel, e in particolare con l’Hegel maturo, il quale non chiude la
storia –come suona il trito luogo comune– ma dichiara a tutte lettere che il pensiero razionale speculativo non ha il minimo motivo d’interesse per il futuro, avendone ‘già abbastanza’ del riconoscimento di ciò che ‘eternamente è’: ossia della ragione così come si è realizzata nel divenuto.”
84
Si potrebbero richiamare a questo proposito numerosi brani, ma vogliamo segnalarne qui
due, a nostro avviso, particolarmente significativi; GU, p.225 [228]: “La dottrina hegeliana, secondo la quale ogni razionale è già reale, conclude una pace prematura e totale con il mondo; ma il
carattere meramente approssimativo dell’infinità della ragione kantiana, e proprio della ragion pratica, fa del mondo un oceano sconfinato: quale consolazione viene al naufrago o al girovago, per
i quali non è mai possibile l’arrivo?”; S-O, p. 494 [517]: “Kant, invero, non dà al tempo del mondo
neppure la possibilità di essere un tempo compiuto; in quanto approssimazione infinita, esso è
piuttosto, fondamentalmente, non suscettibile di compimento. Allo stesso modo, egli ha pagato un
tributo troppo alto –un tributo neppure richiesto e propriamente dannoso alla profondità– con il suo
formalismo del continuo non essere-apparso del vero e proprio contenuto del Sé.”
85
S-O, p. 449 [470].
86
P-H, pp. 281-282 [286].
87
Ivi, p. 282 [287]. A proposito di queste pagine, nelle quali Bloch svolge le sue osservazioni
sullo scarso uso che è stato fatto all’interno della storia della filosofia, della categoria della possibilità oggettiva, ha avuto accenti critici S. Zecchi e proprio su quanto Bloch afferma relativamente
a Kant e ad Hegel. S. ZECCHI, Op. cit., pp. 129-130: “…le considerazioni su Kant e Hegel in merito a questo problema hanno un’unilateralità interpretativa e critica che testimonia più il desiderio
di Bloch di assumere una posizione ‘militante’ e ‘impegnata’, che spazzi via subito l’ombra dell’idealismo trascendentale e dell’idealismo oggettivo dal possibile oggettivo-reale, che l’assenza di
un’analisi articolata sulla concezione del possibile nei due filosofi, o un’incomprensione del loro
pensiero sul problema in questione.[Bloch avrebbe affrontato].. il tema della possibilità in Kant, trascurando, ad esempio, tutta la problematica, interna al pensiero kantiano, della funzione delle
categorie della modalità, che si ripercuote nelle interpretazioni del pensiero contemporaneo,
estendendosi dal neo-kantismo al dibattito sulla logica della modalità…”. Se tutto ciò è vero per
quanto riguarda l’ambito logico-gnoseologico, è invece, a nostro avviso, discutibile quando Bloch
tratta il significato che la categoria kantiana della possibilità assume sul piano etico-storico, perché in questo caso riesce, con pochi cenni, a evidenziare la sua distanza da Kant e le difficoltà
che incontrerebbe l’utopia concreta a fondarsi su un possibile solo ideale. P-H, p.282 [287]:
“L’ideale che in Kant domina in lungo e in largo, astrattamente preordinato anche alla politica:
‘estensione del dominio della libertà morale’, intende d’altra parte la possibilità come potenzialità
di un avvicinamento, purtroppo infinito, a questo ideale nella storia.” Per una analisi dell’importanza della categoria della possibilità reale per l’utopia concreta di Bloch rinviamo al già citato saggio di G. Cacciatore.
88
SP, p.233.
89
P. CHIODI, Op. cit., p.280: “Dunque, ciò che nell’idea si dice del senso della storia nel suo
aspetto fondamentale, cioè politico, è qualcosa di possibile nell’ordine dei fatti e di ideale (rispondente a un’idea) nell’ordine dei progetti: sotto ambedue gli aspetti è qualcosa di non necessario,
di non incondizionato, di realizzabile a certe condizioni.”
79
90
P-H, p.282 [287]. Bloch fa qui riferimento ad un famoso passo di Kant, che egli amava citare; lo prendiamo da GU, p.235 [238]: “Io non penso che un qualsiasi affetto od un’inclinazione che
intervengano prima di essere stati esaminati tolgano al mio animo la possibilità di appoggiarli o di
contrastarli a seconda dei motivi. Ma faccio un’eccezione: la bilancia dell’intelletto non è del tutto
imparziale, ed il braccio che porta l’iscrizione speranza del futuro ha un vantaggio meccanico per
il quale anche i motivi leggeri che cadono nel suo piatto fan sì che si sollevino dall’altra parte tutte
le speculazioni che in sé hanno maggiore peso.”
91
GU, p.253 [255].
80
DALLA STORIA DEI COMPORTAMENTI COLLETTIVI
ALLA BIOGRAFIA STORICA.
STORIOGRAFIA E PSICOANALISI1
Durante il secolo scorso, la biografia storica ha conosciuto una vicenda
movimentata, e non sempre ha avuto lo stesso successo di cui gode oggi.
Rilegata al purgatorio per lunghi anni, essa ha ritrovato grazia agli occhi degli
storici negli ultimi due decenni, quando, sulla scena intellettuale e storica, si
affacciava la psicanalisi.
Questa simultaneità sembra paradossale. Come accettare il fatto che i rapporti tra la storia e la psicanalisi –pratica, per eccellenza, del singolare– siano
terminati proprio quando sembravano i più giustificati?
Questa è la domanda che desidererei porre, esponendo brevemente il
posto occupato dalla biografia storica nelle trasformazioni che hanno interessato la disciplina storica durante il XX secolo e, in modo particolare, nell’indefinita disciplina psicoanalitico-strutturalista. Evocherei, di seguito, il rinvigorimento della biografia storica negli anni ‘80, cercando di dimostrare che gli
interrogativi che l’accompagnano non sono estranei sia agli argomenti che
all’apporto della psicanalisi.
I. La scomparsa della biografia
nelle trasformazioni della disciplina storica
“In materia storica, si è troppo abituati ad attaccarsi soprattutto alle manifestazioni brillanti, altisonanti ed effimere dell’attività umana, ad importanti
avvenimenti o uomini illustri, invece di insistere sui grandi e lenti movimenti
delle istituzioni, delle condizioni economiche e sociali”. Così scriveva, nel
1896, Gabriel Monod, nella Revue historique che, egli stesso aveva fondato
nel 18762. Nel 1903 un sociologo, François Simiand, nella nuova Revue de
synthèse historique di Heri Berr, batteva sempre sullo stesso tasto. Egli invitava “gli storici a passare dal singolare al fenomeno regolare, alle relazioni stabili, che permettono di divincolare delle leggi, dei sistemi di causalità3” e li incitava a passare dall’individuale al sociale mettendo insieme i metodi della giovane sociologia.
Tuttavia, se si è dato credito al lavoro di Alain Corbin sulla Revue historique4, si é dovuto comunque attendere una buona ventina d’anni prima che una
storia che rispondesse a questo programma si fosse messa in pratica.
Effettivamente, è proprio questo il movimento da cui, alla fine degli anni ‘20,
è scaturita la rivista degli Annales, che ha portato a compimento la rottura con
la storia degli “uomini illustri”, al fine di promuovere una storia sociale nella
NOTE
di Anne Levallois
81
82
quale l’individuo non veniva più considerato come singolarità, ma come parte
della collettività. Senza svalutare ciò che Henri Berr aveva scritto qualche
anno prima: “la storia, insomma, è la psicologia stessa: è la nascita e lo sviluppo della psiche”5, Lucien Febvre nel 19226 dava una definizione di ciò che
doveva essere l’oggetto di studio dello storico: “non l’uomo, mai l’uomo, le
società umane, il gruppo organizzato”. La psicologia che lo ha interessato è
stata quella delle credenze, delle idee, dei sentimenti, poiché, “l’individuo non
è altro che ciò che la sua epoca e il suo stato sociale gli permettono di essere”7. Tesi, questa, che egli ha brillantemente illustrato nel suo Luther.
Marc Bloch, l’altro fondatore degli Annales, sospettato talvolta di sociologismi, riteneva, anche lui, indispensabile al progresso della storia, lo studio teorico dei fenomeni psicologici. “I fatti storici, sono, per essenza, fatti psicologici
–scriveva nella Apologie pour l’histoire–. È dunque in altri fatti psicologici, che
normalmente si trovano i loro antecedenti; senza dubbio, i destini umani si inseriscono nel mondo fisico e ne subiscono il peso. Proprio là, pertanto, dove l’intrusione di queste forze esteriori sembra la più brutale, la loro azione non si
esercita se non perché orientata dall’uomo e dal suo spirito”8. L’uomo studiato
da Lucien Febvre e Marc Bloch è un uomo astratto nella misura in cui il suo universo mentale e affettivo corrisponde a quello del suo gruppo e della cultura
alla quale egli appartiene. La storia dei comportamenti illustra il dinamismo di
questi nuovi approcci che non si situano più nel tempo della biografia e dell’evento, ma nella lunga durata di profonde mutazioni. Questi nuovi approcci, inoltre, denotano l’influenza esercitata, dalle scienze sociali e psicologiche sugli
storici e, più generalmente, sulla vita intellettuale, dall’inizio del secolo. Il movimento si sarebbe prolungato durante il dopoguerra con l’invenzione francese
dello strutturalismo e con la proclamazione della morte del soggetto. Questa
corrente, fortemente influenzata dall’etnologia di Lévi-Strauss e dalla psicanalisi di Lacan, avrebbe teorizzato l’uomo come l’effetto dei sistemi simbolici costitutivi della società, all’origine dei quali, ci sarebbe stata la proibizione dell’incesto. Si riteneva che le regole inconsce della parentela e la preminenza del significante, enunciato nell’assioma lacaniano “l’inconscio è strutturato come un linguaggio”, avrebbero dovuto produrre l’ordine umano e costituire i paradigmi di
tutti i sistemi di potere. In questa logica, si trattava di analizzare le forze di cui
l’individuo sarebbe stato vittima, al fine di raggiungere le strutture inconsce su
cui si fonda la sua esistenza. Lo strutturalismo lasciava all’uomo la libertà di
prendere coscienza del suo stato di asservimento, intrinsecamente legato alla
sua condizione di essere umano ma, interdicendogli di pensarsi come attore
della storia, lo privava di ogni possibilità di invenzione. Ben si comprende allora, che la biografia abbia potuto perderci il suo interesse.
È in questo contesto che la psicanalisi è entrata a far parte della scena storiografica. Nel 1974, un’opera redatta da Jacques Le Goff e da Pierre Nora,
Faire de l’histoire, faceva il punto sulla “nuova storia”9; due contributi si riferivano esplicitamente alla psicanalisi: quelli di Michel de Certau e quello di Alan
Besançon. Entrambi intendevano situarsi nella continuità freudiana; ma,
facendo appello a delle teorizzazioni assai differenti e problematiche, questi
contributi hanno importato nella storia l’opacità e la confusione propri del cor-
NOTE
pus teorico della psicanalisi. Così, ne “L’operazione storica”10 –della quale
L’écriture de l’histoire11 avrebbe prolungato la riflessione per tutto l’anno
seguente– Michel de Certeau ha sviluppato una vera e propria filosofia della
pratica dello storico. Il proposito qui, non è quello di riassumerla ma piuttosto
di definire ciò che la sua concezione di operazione storica prende in prestito
dalla psicanalisi. “La storia, egli scriveva, si definisce interamente per un rapportarsi del linguaggio al corpo (sociale), e dunque anche attraverso il suo rapportarsi ai limiti che il corpo pone, sia sulla modalità del posto particolare di
dove si parla, sia sul modo dell’oggetto altro (passato morto) di cui si parla12.
Nella esplicitazione di questa proposizione Michel de Certeau riprende, in
modo sottile, la concezione lacaniana del soggetto, localizzato nella connessione del corpo al linguaggio, e introduce, così facendo, una teoria del rapporto natura/cultura in termini di mancanza ad essere e di desiderio senza
fine. La storia si praticherebbe su “questa frontiera mutabile tra il dato e il creato e alla fine, tra la natura e la cultura13”. In L’écriture de l’histoire, dopo aver
evocato la diversità delle modalità discorsive della storiografia, che a parer
suo, “simbolizza il desiderio che costituisce la relazione all’altro” e “il segno di
questa legge”, Michel de Certeau si attiene agli Écrits di Lacan per confermare questo posto occupato dalla storia tra il corpo sociale (natura) e il linguaggio. “Nella misura in cui il nostro rapporto con il linguaggio è sempre un rapporto alla morte, il discorso storico è la rappresentazione privilegiata di una
scienza del soggetto” e del soggetto “considerato in una divisione costituente”
–ma con una messa in scena delle relazioni che un corpo sociale intrattiene
con il suo linguaggio14.
Il procedimento di Michel de Certeau, in accordo con la teoria del soggetto diviso che il suo procedimento propone, ha l’utilità di essere stato un lavoro di invenzione avente come fine la possibilità di costruire delle nozioni proprie alla storia, per non accontentarsi di un semplice transfert di vocabolario.
Alain Besançon che, in Francia ha dominato il movimento effimero della
psico-storia, si avvia verso tutt’altra direzione. Nell’opera Faire de l’histoire, il
suo articolo “L’inconscient”15 mantiene un tono molto freudiano. Histoire et
expérience du moi, lo aveva preceduto qualche anno prima; Alain Besançon
rifacendosi completamente all’analisi storica di Freud, ne aveva ripreso a suo
modo la nozione del complesso di Edipo per vederne la struttura fantasmatica e organizzatrice della psiche umana. Egli pensava che era proprio in quel
punto, che Freud aveva trovato l’invariante che permetteva di rendere conto
della modalità di relazionarsi esistente tra un individuo singolare e la sua
società di appartenenza, e nel suo articolo “L’incoscient”, egli si proponeva di
instaurare una “storia psiconalitica” che prende a modello il metodo e il materiale dello psicanalista. Ma, cercando di sistemare questa idea, Alain
Besançon ha utilizzato, senza esaminarlo nuovamente, il vocabolario freudiano e, una così povera e stereotipata concezione dello psichismo, tale da fargli perdere il suo talento. La griglia di lettura che egli applica, senza dubbio nell’illusione che l’interpretazione psicanalitica permetterebbe di raggiungere una
verità, schiaccia la realtà che avrebbe dovuto svelare. Questa idea di una similitudine che dovrebbe esistere tra la posizione dello storico e quella dello psi-
83
84
canalista, era già stata evocata da Alphonse Dupront, lo storico delle Crociate,
in un articolo datato 1969, “L’histoire après Freud”, e quindi anteriore rispetto
a quelli di cui parliamo. Nel suo stile infinitamente prezioso, egli non nascondeva la sua ammirazione per Freud e per la sua posizione di terapeuta; in tutto
questo, egli trovava una lezione per lo storico: “Egli insegna soprattutto attraverso il suo esempio. L’esempio del medico che osserva, che sa attendere e
ascoltare, ricevere e dopo, con flessibilità, rendere. Non si tratta dunque di un
metodo, ma di un’attitudine, e chi dice attitudine dice posizione e disciplina spirituale. La psicanalisi mette in presenza”16.
È là che si arresta la comparazione con Alain Besançon. Poiché l’inconscio
che predica Alphonse Dupront è un inconscio collettivo, fortemente contrassegnato dal junghismo, nel quale si trasmettono dei contenuti, degli archetipi.
Mentre quello di Alain Bençon, volendosi strettamente freudiano, è concepito
come una struttura immanente alla natura umana e, al di fuori della storia.
Questo ingombro della storia per mezzo di concetti psicanalitici, sarebbe
stato denunciato, in termini molto vivi, da Michel de Certeau. “Un certo numero di lavori –egli scriveva in L’écriture de l’histoire– tanto in etnologia quanto in
storia, mostrano che l’uso di concetti psicanalitici rischia di diventare una
nuova retorica. Essi si trasformano allora in figure di stile. Il ricorso alla morte
del padre, all’Edipo e al transfert è buono a tutto. Questi ‘concetti’ freudiani,
che si suppone di poter utilizzare a qualsiasi fine, non sono difficili da collocare nelle regioni oscure della storia. Sfortunatamente però, se essi hanno soltanto per oggetto il proposito di designare o di coprire ciò che lo storico non
comprende, non diventano nient’altro che degli utensili decorativi. Questi ‘concetti’ circoscrivono l’inspiegato; non lo spiegano”17.
Tre anni più tardi, nel 1978, Alain Besançon, rinnegava ciò che precedentemente aveva esaltato e, abbandonava la psicanalisi dopo avere scoperto “la
stupefacente povertà dell’inconscio18. L’incontro tra la psicanalisi e la storia
non è avvenuto fondandosi su una interrogazione avente di mira il passato, la
sua inscrizione e la sua trasmissione presso gli individui, ma attraverso la
ricerca di una teorizzazione del rapporto natura/cultura. Le sistemazioni di
Freud e di Lacan che così sono state utilizzate, superano largamente i dati
antropologici acquisiti per mezzo della pratica psicanalitica, come pure le speculazioni teoriche della psicanalisi stessa: corpus spezzato da differenti sistemi e fonte di una temibile linguistica stereotipata, non potevano che portare
questo incontro ad un vicolo cieco.
II. Il rafforzamento della biografia. Con o senza la psicanalisi?
Gli anni ‘80 hanno visto una nuova affermazione, presso gli storici del
genere biografico. Questo riconsolidamento corrisponde ad un cambiamento
profondo della loro modalità di interrogarsi sul posto occupato dall’individuo
nella Storia. Dopo una storia globale, nella quale l’individuo non veniva considerato che come un elemento della collettività, e dopo una “storia frammentata”19, nella quale l’individuo si è riconosciuto come il prodotto delle strutture, è
NOTE
stato l’attore della storia che è rinvenuto al centro dell’attenzione.
Lo strutturalismo aveva fatto il proprio tempo, i suoi cantori sparivano uno
a uno e, senza che tutto ciò apparisse esplicitamente, l’individualismo metodologico della sociologia, che aveva avuto una assai cattiva reputazione, ridiventava un modello possibile.
Nel 1981, France-Culture inaugurava una serie di trasmissioni intitolate
“Les inconnus de l’histoire”. La serie di trasmissioni avrebbe dato il suo titolo
a Fayard, che l’editore giustificava in questi termini: “attraverso il racconto
sempre appassionante di una avventura individuale questi testimoni esemplari permettono di conoscere la loro epoca, ma anche, in un passato continuamente riattualizzato, di comprendere meglio il nostro tempo”. Georges Duby
partecipava alla trasmissione, e nel 1984 pubblicava Guillaume le Maréchal20.
Due anni più tardi, Pierre Bourdieu cominciava una guerra contro “L’histoire de
la vie”, pubblicando nella rivista Actes de la recherche en sciences sociales,
“L’illusion biografique”. Un genere, egli sottolineava, che era appena passato
dagli etnologi ai sociologi, dei quali metteva in dubbio “la visione della vita
come esistenza dotata di senso, col doppio valore di significazione e di direzione”. Senza supporre come, riprendendo i termini di Shakespeare, sembrava suggerirlo, che la vita fosse necessariamente “una storia che accontenta un
idiota, una storia piena di rumori e di furore ma senza significato”, le sue conclusioni apportavano delle nozioni essenziali per superare gli scogli dello strutturalismo e per evitare quelli del soggettivismo. In effetti, la sua critica della
storia della vita, lo portava a costruire un modello dinamico, introducendo “la
nozione di traiettoria come serie di posizioni successivamente occupate da un
medesimo agente, (o da un medesimo gruppo) in uno spazio esso stesso in
divenire, e sottomesso a delle incessanti trasformazioni”. Partendo da questa
definizione, egli poteva classificare gli avvenimenti biografici “come tante
sistemazioni e tanti spostamenti nello spazio sociale”. La costruzione di questo spazio sociale, per lui, era peraltro un’operazione preliminare a quello che
egli definiva la superficie sociale della “personalità designata dal nome proprio, cioè l’insieme delle posizioni che simultaneamente sono occupate in un
dato momento del tempo da una individualità biologica, socialmente istituita,
che agisce come supporto di un insieme di attributi e di attribuzioni proprie
che, gli permettono di intervenire come agente efficiente in dei campi differenti”21. Accanto a questa nozione di spazio sociale da costruire, Bourdieu ne
avanzava un’altra che tratta dell’individuo considerato nella sua singolarità,
l’habitus, definito come “sociale incorporato dunque individuato”. L’anno
seguente in Choses dites, egli perveniva alla nozione di habitus il cui, secondo lui, era quello non solo di superare “l’opposizione del tutto scientificamente assurda tra individuo e società”, ma anche di allontanare l’alternativa della
coscienza e dell’inconscio22. Un anno dopo la pubblicazione di Choses dites,
un editoriale degli Annales, con il sottotitolo di “Histoire et sciences sociale. Un
tournant critique”, prendeva atto dei limiti della storia quantitativa e, metteva in
questione i paradigmi che questa aveva preso in prestito dal marxismo e da
strutturalismi differenti23. L’appello era stato lanciato per dei “metodi nuovi”,
con un esplicito riferimento al movimento italiano della micro-storia, e per delle
85
86
“nuove alleanze”. Un eminente rappresentante della micro-storia, corrente italiana sensibile alle questioni della psicanalisi, non avrebbe tardato a rispondere all’appello degli Annales, che consacrava un numero intero al suo
“Tournant critique”. In “Les usages de la biographie”, Giovanni Levi inventariava le principali domande metodologiche formulate dalla biografia, tra le quali
figuravano quelle di Bourdieu, e restituiva al genere biografico e alla biografia
storica la propria legittimità: “Non si può negare che ci sia uno stile proprio ad
ogni epoca, un habitus che risulta da esperienze comuni e reiterate, esattamente come ad ogni epoca corrisponde lo stile particolare di un gruppo. Ma
esiste anche, per ogni individuo, uno spazio di libertà significativo, che trova
la sua origine precisamente nelle incoerenze dei confini sociali e che dà luogo
al cambiamento sociale […]; la specificità delle azioni di ciascun individuo, non
può essere considerata come indifferente o privata di pertinenza24”.
Lo stesso anno in Le Débat, Jacques Le Goff, riavutosi dalle sue critiche
contro gli “scribacchini” della storiella25 e riferendosi ai momenti importanti
nella storia dei comportamenti, annunciava di aver messo in cantiere un SaintLouis. Egli aderiva così alla causa della biografia, “indispensabile strumento
d’analisi delle strutture sociali e dei comportamenti collettivi”26. Simultaneamente, alcuni storici del mondo contemporaneo esprimevano, anche loro,
il proprio interesse nei confronti della biografia storica. Philippe Levillain consacrava a tale questione un lavoro abbondantemente documentato che si
inserisce, in qualità di manifesto, in un’opera redatta da René Rémond, Pour
une histoire politique. Dopo aver ricordato, seguendo il percorso delle epoche,
i rapporti che la storia ha intrattenuto con la biografia, Philippe Levillain osservava che quest’ultima, per anni largamente disprezzata in Francia, conosceva, dall’inizio degli anni ’80, un progresso considerevole. Il suo lavoro cominciava col ricongiungere questa evoluzione dell’introduzione dell’individualismo
metodologico che cerca di “spiegare le scelte effettuate dall’individuo, partendo dal principio che una società non è un sistema e che i fenomeni sociali
sono il risultato di una somma di comportamenti. In poche parole, se gli individui sono modellati dalle società, essi manifestano piuttosto che spiegare27.
Questa nuova prospettiva del rapporto individuo/società, che segna la fine dell’epoca strutturalista, ha rilanciato, per Philippe Levillain, la questione della psicostoria. “Bisogna, naturalmente, –egli scrive– sottoporre l’individuo metodologico allo sguardo della psicostoria; cioè sottoporlo allo sguardo delle relazioni tra psicologia, psicanalisi e storia”28. Ma questo ritorno di interesse per la
biografia gli sembrava sollevare delle ragioni di un altro ordine e dovere: essere riposto nel contesto più ampio delle recenti scoperte della genetica. Poiché
lo si sa adesso, egli scriveva, che “ non solamente, ogni uomo è differente
dagli altri esseri viventi, ma che ogni uomo vivente è anche differente da tutti
gli altri uomini del passato e da tutti quelli del futuro”. Ed egli concludeva il suo
lavoro in questo modo: “La biografia storica, così come è stata riabilitata oggi,
non ha la vocazione di esaurire l’assoluto dell’‘io’ di un personaggio come essa
ha troppo preteso e troppo lo pretende. E se il simbolismo dei suoi fatti e delle
sue gesta può servire da rappresentazione collettiva attraverso un uomo, dato
il ritratto, essa non esaurisce la diversità umana […]. Essa non deve più crea-
NOTE
re delle tipologie. In compenso, essa rappresenta il modo migliore per mostrare i legami che esistono tra presente e passato, tra memoria e progetto, tra
individuo e società, e di sperimentare il tempo come prova della vita. Il suo
metodo come il suo successo risultano dall’insinuazione della singolarità nelle
scienze umane, che per molto tempo non hanno saputo cosa farne. La biografia, se non isola l’uomo dai suoi dissimili o se non lo esalta a loro spese, è
il luogo per eccellenza della condizione umana nella sua diversità”29.
Sul finire degli anni ’80, la biografia storica aveva dunque ritrovato la sua
legittimità. E non è proprio senza un certo sorriso che in Libération del 7 ottobre 1999, si potevano leggere le seguenti parole che Jacques Le Goff aveva
pronunciato: “Insisto sull’idea che ho acquisito circa la grande importanza che
riveste la biografia, la quale rappresenta l’apice del mestiere dello storico”.
Dunque, l’interesse che lo storico nutre per l’individuo, lo conduce alla sommità della sua arte. Ma oggi, una delle ragioni del successo della biografia storica non potrebbe dipendere dal fatto che è cambiata la nostra idea di uomo?
Non si crede più al progresso della Storia, si è smesso di pensare che essa
doveva compiersi e che doveva portare l’uomo a riconciliarsi con se stesso e
con il suo mondo. Con il venire meno di questa credenza, è stato il modello
universale di un uomo astratto, pieno di razionalità impostosi all’umanità intera, che è scomparso. Lo si constata nel momento in cui, al pensiero di far
diventare quest’uomo razionalmente pensato, si è sostituito l’interesse per
degli uomini concreti, per degli individui singolari. Non si tratta più di pensare
l’uomo nella sua generalità, ma piuttosto di aprirsi alla diversità umana e, pertanto, di riuscire a rendere esplicita la maniera secondo la quale i destini si
determinano a mano a mano che tentano di afferrare quella parte di libertà,
della quale ciascuno può disporre. Non si ragiona più su di un soggetto umano
astratto, ma sulle condizioni e le modalità di elaborazione di questa complessità che si chiama individuo.
Questa evoluzione mi sembrava essere determinante per il posto che ha
occupato la biografia durante il XX° secolo, ed è in questa nuova comprensione della singolarità che la storia e la psicanalisi si ricongiungono. Tentiamo,
adesso, di definire i termini di questa confluenza. Si impone immediatamente
una prima osservazione. Se è vero che oggi la psicanalisi non gode più dello
stesso successo di cui godeva, in Francia perlomeno, durante gli anni del
trionfante strutturalismo, ciò non toglie che si sia diffusa in tutti gli strati della
società. Essa si è infiltrata nelle psicologie, e con buona probabilità non è
estranea al rinnovamento attuale della biografia storica. Così, l’attenzione
posta dagli storici al “per sé” dell’individuo e alla variabilità delle sue forme in
funzione della struttura della società, sembra inserirsi in una sensibilità ad uno
spazio soggettivo di riflessione e di interrogazione, che la psicanalisi ha contribuito a liberare e, del quale essa è stata il cardine delle possibili trasformazioni. Allo stesso modo, ogni biografo, oggi, ha integrato l’idea dell’importanza
che la storia infantile ha nella formazione di un individuo e del posto che la
sessualità occupa nel gioco delle identificazioni.
La psicanalisi apre dei percorsi utili alla comprensione dell’uomo in quanto
essere storico. Essa non obbliga lo studio biografico a chiudersi in una siste-
87
88
mazione dell’apparato psichico, ma propone una descrizione del processo di
umanizzazione nel quale le capacità psicologiche dell’individuo non possono
essere dissociate dalle relazioni che le costituiscono. La psicoanalisi affina
l’approccio biografico, tenendo conto del complesso gioco di interrelazioni tra
i determinanti di un individuo e l’individuo stesso, che è alla volta membro di
una comunità umana con le sue regole e le sue istituzioni, e spazio soggettivo di appropriazione. Lo spazio sociale e storico, che oggi la psicanalisi dà alle
sue indagini, è molto più grande rispetto a quello concepito da Freud. Le tracce lasciate dai traumi della Storia, la loro trasmissione alle successive generazioni lo hanno portato ad interrogarsi sui processi attraverso i quali la Storia
si trasmette e inconsciamente si inscrive negli individui, mescolandosi inestricabilmente al loro presente.
Ma come sottolineava Michel de Certeau, occorre essere attenti al fatto
che numerose nozioni della psicoanalisi –come quelle di inconscio, o di complesso di Edipo, per esempio– sono attualmente utilizzate nelle scienze sociali, e certamente in storia, con un intento esplicativo, quando in realtà non spiegano nulla. Se si pensa di designare una realtà precisa, questo vocabolario è
una trappola. Poiché, la maggior parte delle volte, i termini psicanalitici rimandano ad un livello di analisi o ad una situazione di cui bisogna spiegare le
dimensioni relazionali e affettive, e restituire la complessità dei diversi registri
implicati nel momento in cui si cerca di rendere conto di un comportamento.
Così, il termine inconscio, che si è imposto sotto la sua forma sostantivata e
che gli storici non disdegnano di utilizzare, se lo si isola dal contesto nel quale
Freud lo ha utilizzato e dalla nuova significazione che egli ha trovato in esso,
è di una estrema imprecisione. Come Raymond Aron ha fatto notare, l’inconscio psicanalitico non può identificarsi con il non-conscio30. In effetti, il termine
inconscio, è sempre esistito e l’innovazione freudiana aderisce al suo utilizzo
per denotare il risultato dell’operazione di rimozione, in altre parole di oblio, di
affossamento di un evento doloroso del quale non ci si può più ricordare, a
causa dell’enorme carica di sofferenza e di angoscia che il ricordo apporterebbe. La specificità dell’inconscio freudiano consiste nel fatto che esso si
risolve ad essere un problema di memoria, con il senso di un passato che si
inscrive senza potere rinvenire alla coscienza, poiché esso è la fonte di una
enorme sofferenza. Attraverso differenti modalità, la rimozione ha sempre lo
scopo di impedire il ritorno dell’evento doloroso, la cui minaccia è sempre presente. Mentre non si è liberi di ricordare, il rimosso continua a resistere, sotto
forme inconoscibili e malgrado il suo anacronismo, esso va ad intaccare il presente. Postulare un inconscio mitico, forse equivale a parlare del “mistero”
della persona, ma tutto ciò non rende giustizia allo sforzo di razionalità fatto da
Freud per tentare di descrivere attraverso quale modalità, il passato vissuto
poteva restare alla volta attivo e inconscio31.
Infine, non si può parlare di biografia e di psicanalisi senza evocare il coinvolgimento personale dello storico nel momento in cui diventa biografo. È proprio lui,
infatti, che, al di là della sua fedeltà al documento, dà vita al testo, all’archivio,
attraverso la lettura che ne fa. E così rigorosa, dato il suo metodo, è stata la sensibilità che traspare dal suo stile e che fa esistere l’individuo che ha ricreato.
1
Questo articolo è preso da una relazione fatta alla Société des amis d’Ismail Urbain, il 22
gennaio del 2000, in occasione di una giornata consacrata alla “Actualité de la biographie” e alla
quale Alain Corbin e Jacques Nobécourt avevano accettato di partecipare. Di questo li ringrazio.
2
G. MONOD, Revue historique, 7-8/1896, p.325.
3
F. DOSSE, L’histoire en miettes, La Découverte, Paris 1977, p.22.
4
A. CORBIN, Au berceau des Annales, Presses de l’Université de Toulouse, 1983, pp.105-107.
5
H. BERR, La synthèse en histoire, 1911, cit. da J. REVEL, Dictionnaire des sciences historiques, PUF, Paris 1986, pp. 450-456.
6
L. FEBVRE, La terre et l’évolution humaine. Introduction géographique à l’histoire (1922), 2e
ed.., Albin Michel, deuxième éd., Gallimard, Paris 1986, pp. 936-966, qui, p.941.
7
L. FEBVRE, Combat pour l’histoire, A. Colin, Paris 1953, p.211
8
M. BLOCH, Apologie pour l’histoire, ou Métier d’historien, 7ème éd., A. Colin, Paris 1977, pp.
157-158
9
Faire de l’histoire. I. Nouveaux problèmes. II. Nouvelles approches. III. Nouveaux objets.,
NOTE
Una prova “a incavo” ne è data dal libro di Alain Corbin, Le monde retrouvé
de Louis-François Pinagot32. In questa non-biografia, che si potrebbe ugualmente definire biografia di uno sconosciuto, Alain Corbin ha riesumato tutti gli
aspetti accessibili della realtà che ha impregnato la vita dello zoccolaio e che
gli ha dato il colore del suo mondo. Se questo lavoro permette di avvicinarsi il
più possibile a quella che sarebbe potuta essere la condizione di uno zoccolaio
dell’Orne nel XIX° secolo non è semplicemente a causa dell’abbondante documentazione o dell’immaginario debordante di uno storico. Tutto ciò è dovuto
principalmente alla sua sensibilità e all’attenzione che lo storico ha dato ai differenti registri nei quali si svolgeva l’esistenza di un uomo di questo tipo.
La biografia è senza ombra di dubbio un mezzo privilegiato che permette
di penetrare in un’epoca, ma che lascia con la fame di sapere il biografo desideroso di ricostruire una vita o di arrivare a conoscere “la verità di un personaggio”, per usare l’espressione di Jacques Le Goff, che ne fece il principio sul
quale deve fondarsi il lavoro dello storico. Poiché, se si possono ricostituire dei
campi del possibile, delle coerenze, dei “bricolages”, se si può ristabilire la
molteplicità attraverso l’apparente unità di una vita, si può parlare di verità?
La psicanalisi ha contribuito a creare questa illusione lasciando credere
che l’inconscio sarebbe stato il luogo di questa verità, quando essa può, tutt’al
più, aiutare lo storico ad affinare il suo approccio e a sapere che, scrivendo
una biografia, è anche di lui stesso che la biografia diventa questione. Di questa nuova prospettiva, i saggi di ego-storia che hanno seguito il ritorno della
biografia storica sembrano apportare una prova, e non è senza una ragione
che recentemente, a proposito di Georges Duby33, è stato possibile parlare di
“storia autobiografata”.
(traduzione di Emanuela Monda)
89
90
sotto la direzione di J. Le Goff e P. Nora, Gallimard, Paris 1974.
10
“L’opération historique”, cit., I, pp. 3-43.
11
“La production du lieu” in L’écriture de l’histoire, Gallimard, Paris 1975.
12
“L’opération historique”, cit., p.10
13
Ibid., p.17.
14
L’écriture de l’histoire, Gallimard, Paris 1975, p.120.
15
“L’inconscient. L’épisode de la prostituée dans Que faire et dans le Sous-so ” cit., II, pp. 31-55.
16
A. DUPRONT, “L’histoire après Freud”, Revue de l’Enseignement supérieur, 1969, n. 44-45,
pp. 27-63, qui p.28.
17
M. DE CERTEAU, L’écriture de l’histoire, cit., p.292.
18
A. BESANÇON, “De Gibbon à Freud et retour”, L’Arc, N°72, 1978, pp. 4-8, qui p.8.
19
Per riprendere il titolo del libro di François Dosse, L’histoire en miettes..
20
G. DUBY, Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du monde, Fayard, Paris 1984. La
presentazione dell’editore si trova nella prefazione di quest’opera.
21
P. BOURDIEU, “L’illusion biografique”, Actes de la recherche en sciences sociales, pp. 62-63,
giugno 1986, pp. 69-72.
22
Choses dites, Les éd. de Minuit, Paris 1987, p.43.
23
Annales E.S.C., n°2, 1988.
24
G. LEVI, “Les usages de la biographie”, Histoire et sciences sociales. Un tournant critique,
Annales, E.S.C., nov.-dic. 1989, pp. 1325-1336.
25
Op. cit., p.XIII.
26
J. LE GOFF, “Comment écrire une biographie historique aujourd’hui?”, Le Débat, n° 54,
marzo-aprile 1989, pp. 48-53, e Saint-Louis, Gallimard, Paris 1996.
27
PH. LEVILLAIN, “Les protagonistes: la biographie”, in Pour une histoire politique, R. Rémond
(éd.), Seuil, Paris 1988, pp.121-159, qui pp. 149-150.
28
Op.cit., p.151.
29
Ibid., pp.158-159.
30
R. ARON, Leçons sur l’histoire, de Fallois, Paris 1991, pp. 474-475.
31
Sulla nozione di inconscio si veda l’articolo di V. DESCOMBES, “L’inconscient adverbial”,
Critique, ottobre 1984, n. 449, pp. 775-796.
32
A. CORBIN, Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot, sur les traces d’un inconnu. 17981876, Flammarion, Paris 1998.
33
Si veda a questo proposito M. VELCIC-CANIVEZ, “Histoire et intertextualité. L’écriture de
Georges Duby”, Revue historique, CCII/1, gennaio-marzo 2000, pp. 187-206.
DIO: UNA PASSIONE?
ATENE E GERUSALEMME
Il libro di Giovanni Invitto (Sartre. Dio: una passione inutile, Padova,
Messaggero, 2001, pp.96) fa pensare oltre Sartre. Se Dio è passione, se non
soffro questa passione, se non faccio questo sacrificio, debbo dire: Dio non è.
Sartre non può fare questo sacrificio perché non vuole valori teologicamente
fondati, vuole un mondo fondato sulla libertà pienamente umana. Ma è solo un
problema etico?
C’è sempre stato, c’è e ci sarà sempre un conflitto tra fede e ragione: un conflitto che si butta alle spalle qualsiasi possibilità di rifugio in un intelligo ut credam
o in un credo ut intelligam. Il grande tentativo di Tommaso, che fu quello di conciliare le ragioni della fede e quelle della ragione, si vanifica non appena si patisce la consapevolezza che il dominio della fede resta fondamentalmente eterogeneo rispetto a quello di una ragione che, soprattutto oggi, “si accontenta di
verità parziali e provvisorie, senza più tentare di porre domande radicali sul
senso e sul fondamento ultimo della via umana, personale e sociale”.
Sto citando dalla Fides et ratio, una delle più belle encicliche di Giovanni
Paolo II (Introduzione, 3), in cui il conflitto tra la fede e la ragione si tende a
risolverlo affidando alla ragione il compito di rispondere a “domande radicali”, cui essa non può rispondere. Intanto, il problema dei “rapporti tra fede e
ragione” resta lì, radicato nel cervello dell’uomo che invano cerca di sottrarsi a quella che, tra le “domande radicali”, è la più “radicale”: c’è Dio? Si può
restare quanto si vuole, con la rassegnata coscienza dei suoi limiti, nel dominio della ragione e, quindi, ad assumersi una “responsabilità” (da respondère) unicamente in relazione a “verità parziali e provvisorie”, ma che, oltre il
dominio di essa, ed altro da essa, ci sia un dominio più alto, quello della
fede, non c’è divertissement (uso il termine nel senso di Pascal) che possa
farlo dimenticare.
Karl Barth aveva affermato che bisogna parlare di Dio come teorici, perché
come uomini non possiamo parlarne. Dividendo la vita di uomo, nella sua interezza, in due parti, se una si pone domande che so già essere parziali e provvisorie, l’altra la devo considerare come la sofferenza del non-sapere, la
domanda intorno a ciò che trascende la possibilità di conoscenza.
E il problema di fondo, del “rapporto tra fede e ragione”, rimane in piedi.
Tanto che anche il pensiero laico più intransigente inarrendevolvemente
immanentismo, da ultimo non poco teologizzando, questo problema lo pone,
svolgendo il motivo di una “postsecolarizzazione”, cioè di una nuova stagione
culturale ed anzi pluriculturale o della temperie di un “ragione pluralizzata” in
cui non si può ridurre tutto al “secolo”, non si può stendere tutto nell’orizzonte
NOTE
di Antimo Negri
91
92
umano e mondano, per ciò stesso aprendo la considerazione ad uno spazio
ultra-“secolare” in cui si iscrive la cifra dell’Assoluto.
Accenno, con ciò, all’ultima fase della riflessione di un filosofo come Jurgen
Habermas, per il quale “l’11 settembre la tensione tra società secolare e religione è esplosa in modo del tutto diverse” (Fede e sapere, “Micromega”, 2001,
5, p.7). Non intendo, qui, spiegare il senso della “tensione” nuova, diversa, tra
“società secolare” e “religione” –o, senz’altro, del nuovo rapporto che si è istituito o si va istituendo, nell’epoca della “postsecolarizzazione” fatta coincidere
con quella della “globalizzazione”– di cui parla Habermas. Ma posso e devo
sottolineare che il rapporto Fede e sapere, il titolo sotto il quale Habermas colloca lo sviluppo delle sue argomentazioni, è quello stesso di un’opera celebre
del giovane Hegel, Glauben und Wissen (1802). Devo aggiungere, qui, che il
Glauben vale la “fede” e Wissen vale la “ragione” dell’enciclica di Papa
Giovanni Paolo II? Oltre il “sapere”, la “ragione”, anche la “ragione plurisecolarizzata”, non più monolitica in senso kantiano, la “fede”.
Sì, da ribadire: nel suo essere oltre la ragione, la fede è altro dalla ragione.
Questo essere “oltre” la ragione e questo essere “altro” dalla ragione della
fede è l’“oltre”, l’“altro” dello stesso Dio, costituisce, come diceva Hegel, la
sfera dell’“incalcolabile”, dell’“incomprensibile”, del “vuoto”, di un “Dio inconoscibile, che sta al di là dei pali di confine (Gryntzpfalle) della ragione”.
Si tratta di una linea di demarcazione che è la stessa che, ad esempio, fa
intervenire Léon Chestov quando separa lo spazio di Atene (la ragione) e lo
spazio di Gerusalemme (la fede). Inconfondibili, Atene e Gerusalemme, inconfondibili la ragione e la fede, con i pali di confine che si alzano tra l’una e l’altra. Eppure, quando il processo della secolarizzazione è diventato, soprattutto nella post-modernità, più impetuoso, Gerusalemme o è stata invasa o è
stata abbattuta da Atene. Perché e quando è invasa, anzi tutto? Trovo una
risposta in Chestov: perché e quando gli abitanti di Atene sono stati presi dalla
concupiscientia irresistibilis sciendi (Concupiscientia irresistibilis. Della filosofia medievale, trad. it., Bocca, Milano 1946, pp.228). Una sorta di hybris, questa concupiscientia, propria degli abitanti di Atene, o degli uomini presi dalla
superba aspirazione di essere sicuti dei. La stessa superbia che li ha portati,
li porta, ad un certo punto ad abbattere Gerusalemme: la stessa che a fare
“morire” Dio (Nietzsche).
E, intanto, gli abitanti di Atene non potevano e non dovevano né invadere
né abbattere Gerusalemme. La ragione? Sta nel fatto che Gerusalemme, in
quanto città del mistero e quindi della fede, resta, per dirla con un altro esponente dell’esistenzialismo francese, Gabriel Marcel, il luogo del metaproblematico, dell’inverificabile (P. PRINI, G. Marcel e la metodologia dell’inverificabile, Roma 1968).
Il “metaproblematico”, l’“inverificabile” è “oltre i pali di confine della ragione”
(Hegel). O oltre la possibilità di conoscenza dell’uomo, proprio perché sottratto all’esperienza dell’uomo. Parola di Kant, per il quale Dio non può e non deve
essere oggetto di scienza. Kant: Dio si sottrae. Dio non può essere oggetto di
conoscenza, cioè di giudizi determinanti. Dio non vuole nomi (nome =
nemein). Non può essere oggetto di categorie, perché il categoriale immette
NOTE
nel parlare. Ma di che possiamo parlare? Della nostra esperienza. Ma Dio non
è (non è più?) nella nostra esperienza.
Ma si può farlo “morire”, per questo? Anche Sartre ha cercato, lungo l’arco
di oltre un quarantennio di riflessione, di farlo “morire”. O avvertendo l’indimostrabilità della sua esistenza o tendendo a persuadere che “la passione dell’uomo è quella di sacrificarsi perpetuamente perché Dio esista”, per ciò stesso votandosi a un “sacrificio inutile e dannoso” (Alcune domande a Jean-Paul
Sartre e a Simone de Beauvoir, “Il Politecnico”, Torino, n. 31-32, agosto 1946,
pp. 33-35).
Certo, Dio si pone sul piano dell’assoluta alterità. Si parla di amore Dei e di
timor Dei. Nell’amor Dei, Dio può essere soggetto o oggetto di amore. Nel
timor Dei, egli è così terribile che, ad un certo punto, non si lascia vedere. Egli
diviene l’assolutamente Altro. In Huis clos, era la famosa affermazione che l’altro è l’inferno. Anche l’assolutamente Altro è l’inferno?
Però, quando in Atene mi pongo queste domande, posso rispondere? La
risposta di Sartre, così come emerge dal testo di Invitto è che Dio sarà anche
una passione inutile, ma, proprio perché passione, io non posso non soffrirne.
E il dilemma rimane.
93
I TANTI VOLTI DELLA FILOSOFIA DI LEIBNIZ*
di Sandro Ciurlia
94
I. Nell’aprire la Prefazione al suo celebre studio su La logique de Leibniz
(1901), Louis Couturat ricordava le parole della comunicazione leibniziana al
De L’Hospital del 27 novembre 1694 in cui il filosofo tedesco scriveva: “La mia
metafisica è tutta matematica”1. Metafisica, logica e matematica, infatti, sono
le componenti che dominano in lungo ed in largo il pensiero di Leibniz.
All’analisi dei loro rispettivi rapporti hanno dedicato le proprie fatiche critiche i
corifei della novecentesca Leibniz-Renaissance, all’insegna di uno schema
interpretativo volto per lo piú a centralizzare o la posizione della logica rispetto alla riflessione metafisica matura o viceversa. Com’è noto, già Bertrand
Russell, nel 1900, aveva sostenuto il primato della logica nel sistema leibniziano, descrivendo l’intrinseca contraddizione di una monade che si riconosce
come unico fondamento della realtà e, nel contempo, si vede costretta ad
ammettere una “pluralità di sostanze” per rendere ragione della varietà del
mondo. Da qui, secondo Russell, lo scindersi della filosofia leibniziana in una
parte essoterica, ma poco rilevante (la metafisica), ed in una esoterica, decisiva per gli sviluppi della filosofia moderna (la logica)2.
Gli stessi intenti alimentavano lo stesso Couturat, il quale leggeva il pensiero di Leibniz all’insegna del passaggio dalla logica giovanile alla metafisica
matura nei termini della trasformazione –e della sopravvivenza– della prima
nella seconda3, mentre Ernst Cassirer aveva tenuto a sottolineare il rilievo e
l’originalità della produzione logico-fisico-matematica di Leibniz4.
Non sono mancati tentativi di centralizzare il versante opposto: Jean
Baruzi, per esempio, aveva esortato a tenere in giusta considerazione la
dimensione teologica del pensiero del Lipsiense5 e, di seguito, Heinz
Heimsoeth si era dedicato a rintracciare le piú dirette fonti di tale misticismo
filosofico6.
Il dibattito critico sulla speculazione leibniziana, dunque, s’è declinato proprio sul registro dell’analisi dei rapporti tra logica e metafisica, sempre nel
segno dell’esigenza di predicare il primato di una delle due. In realtà, si tratta
di universi aporetici strettamente connessi, come lo stesso Leibniz, in numerose circostanze, non esita a confermare. In un passaggio di una sua celebre
autobiografia aveva scritto: “Interea in Zabarella et Rubio et Fonseca aliisque
scholasticis non minori, quam antea in Historicis voluptate versabar et eousque profeceram, ut Suaresium non minore facilitate legerem, quam Milesias
fabulas solemus, quas vulgo Romanos vocant”7. L’influenza congiunta, pertanto, di Suárez e Hobbes, di Zabarella, Rubio e Fonseca alle origini delle
prime manifestazioni originali del suo pensiero costituisce un’altra convincen-
NOTE
te prova della doppia originaria matrice del suo pensiero. Ciò non tanto per
sottolineare magari la ‘cattiva’ lezione di un Russell o di un Couturat, quanto
per ribadire la necessità di un significativo ritorno allo studio dei testi del grande filosofo tedesco, con tutte le oscurità, le inquietudini, le ambivalenze che
essi recano in sé. A quest’esigenza risponde con brillantezza e con rigore
Massimo Mugnai nel ricco e brillante volumetto qui discusso.
Il proposito d’introdurre al pensiero di Leibniz può apparire, in prima istanza, quasi irrealizzabile. Siamo di fronte, infatti, ad un poligrafo di straordinaria
ricchezza critica, cultore di estetica, di diritto, di questioni politiche e morali, ma
anche –e soprattutto– di logica e di matematica. Tutto ciò in una condizione in
cui ciascuno di questi rami dell’arbor scientiae risulta coeso al successivo
senza, però, che la sintesi che ne discende debba essere considerata come
l’unità sistematica e compiuta delle disiecta membra del sapere. Mugnai parla,
infatti, nell’illustrare le tante aree del pensiero di Leibniz, di un “continuo slittare di piani” (p. IX) in seno ad una galassia critica priva di un unico centro. La
prima preoccupazione di Mugnai, dunque, dinanzi ad una simile labirintica
complessità di motivi speculativi, è stata quella di rendere un quadro lineare e
“compatto” dei temi al centro della riflessione leibniziana, senza, con ciò, perdere di vista i loro pesi e le loro non sempre accavallabili dimensioni critiche.
Inevitabilmente l’attenzione viene rivolta in larga misura ai problemi metafisici
e gnoseologici con cui Leibniz si confrontò ininterrottamente sin dal De arte
combinatoria (1666), oltre alla produzione logica ed ai grandiosi progetti enciclopedici che aleggiano sullo sfondo. Con un intento dichiarato: sforzarsi di
“spiegare la genesi e il significato della concezione delle ‘monadi’ ” (Ib.).
Rispettare l’articolata costituzione dell’unità di un pensiero in cosí incessante divenire come quello di Leibniz significa, dunque, intenderne le multiformi stratificazioni. Ciò all’insegna di una valutazione della metafisica, nella fattispecie della monadologia, da intendersi come la risposta, articolata in un
altro registro, allo stesso orizzonte problematico che rende ragione della produzione logica precedente. L’obiettivo è duplice: evitare, facendo leva sui testi,
di leggere la filosofia di Leibniz nel segno di nette cesure o di macroscopiche
fratture; svelare, di seguito, la parzialità di un giudizio come quello di Russell
secondo cui la monadologia sarebbe solo paragonabile ad un divertente racconto delle “fate”. Ci si trova dinanzi, infatti, scrive Mugnai, ad “un tentativo di
risposta a problemi reali, sollevati dalla scienza del XVII secolo e connessi, in
particolare, alla dinamica e al labirinto del continuo” (p. X).
In uno studio come quello di Mugnai si rendono necessarie distinzioni critiche, scelte tematiche. Una parte cospicua di spazio e di attenzione spetta al
Leibniz logico. Ciò non va, tuttavia, a discapito di altri significativi ambiti. Anche
perché la progressiva disponibilità sia dell’edizione critica dei testi maggiori,
sia di nuovi inediti consente d’integrare e di arricchire l’immagine complessiva
che era possibile farsi della sua filosofia8.
Nell’affrontare un simile colosso speculativo e nell’arginare il rischio di perdersi dietro i mille fili di tale intricato ordito, Mugnai dichiara di “privilegiare un
approccio storiografico ‘interno’, anziché ‘esterno’ ” (p. XII). Cosa che, poi, si
sintetizza nella contemperazione di un approccio sincronico e di uno diacroni-
95
96
co: rispettando il divenire dello sviluppo del suo pensiero, Mugnai segue la traccia lasciata dai vari quesiti tematici con i quali il Lipsiense va a confrontarsi. Ed
anche se una simile impostazione potrebbe lasciare intendere significative
osimpatie” verso “forme di storiografia filosofica di tipo “analitico”, l’attenzione
da Mugnai dimostrata nei riguardi della “struttura delle argomentazioni” (Ib.), in
verità, non va mai a detrimento della cura delle coordinate storico-critiche del
contesto entro cui il pensiero di Leibniz si colloca e di cui è espressione.
A conferma del carattere anzitutto divulgativo del testo, il lavoro di Mugnai
si apre con un lungo capitolo dedicato alla trattazione della vita del filosofo. Si
ha, cosí, modo di intendere la straordinaria varietà degli interessi, l’arguzia, la
prudenza diplomatica e la grande abilità umana e critica di un uomo che
Fontenelle definì l’Ercole di molti Ercole.
Nell’avviare la discussione sui molti temi della sua “guida”, Mugnai prende
l’avvio dai primi nuclei problematici della meditazione leibniziana. Da subito, i
suoi studi sulla natura dei segni assumono risvolti d’ordine metafisico, essendo legati alla discussione dello statuto delle idee e delle rappresentazioni. È
evidente, in quest’ottica, il parallelo peso esercitato da Suárez e da Hobbes.
Si ricordi che sul tema dell’individuo, a lungo meditato dal grande gesuita spagnolo, Leibniz aveva avuto modo d’esprimersi, non senza il decisivo influsso
di Thomasius, nella Disputatio metaphysica de principio individui del 1663. Il
convenzionalismo razionalistico di Hobbes, invece, risulta essere, ai suoi
occhi, un duttile strumento in grado di sottrarre il pensiero alle spinose implicazioni di natura metafisico-teologica connesse alla discussione della natura
della verità. Pensare in termini computazionali al problema del ragionamento,
come fa Hobbes, equivale, infatti, a far luce sui termini costitutivi del procedimento denotazionale ed a considerare possibile, una volta isolati i concetti
semplici del pensiero, una logica inventionis imperniata sulla ratifica di tecniche integrate di calcolo logico dei detti termini elementari. Quest’ordine di questioni impensierisce Leibniz, con sostanziale unità d’intenti, quantomeno dal
De arte combinatoria al Dialogo (1677). Si avvia, in tal modo, quell’analitica del
linguaggio volta a configurarsi come un’indagine delle modalità attraverso cui
si esprimono giudizi sul mondo. In quest’ottica non va mai trascurata quella
convinta tensione universalistica (di matrice ermetico-neoplatonica) che
sostiene e suggella l’enciclopedismo combinatorio leibniziano.
Mugnai non trascura di ravvisare il pendant che equilibra gli slanci del
razionalismo convenzionalistico leibniziano del primo periodo: la riflessione sul
concetto di idea. Quest’ultima è sinonimo sia di rappresentazione, sia di
modello di realtà. Sorge, però, il problema, sul primo versante, del suo rapporto con le cose di cui è imago. Cosí, nella questione viene coinvolto Dio,
nella cui Mens sussistono le idee, il quale assume la funzione di supremo
garante della loro legittimità. È evidente, qui, l’eco dell’impostazione di
Cartesio. Ma, intorno a questo punto, la posizione di Leibniz è carica di un prezioso spirito di distinzione: risulta possibile discutere dello statuto delle idee a
seconda che siano contenute “nella mente di Dio” o “nella mente degli uomini”. Il rapporto di transitività tra i due ordini di idee permette di ragionare sul
modo in cui, per Leibniz, si “esprime”, attraverso il linguaggio, il “mondo”.
NOTE
L’approccio di Mugnai, proprio in quanto in grado di andare oltre la cronologia senza violarla, si dimostra capace di mettere in luce le sfuggenti ambivalenze del pensiero leibniziano sulla tematica delle idee: si è spesso ritenuto, infatti, che solo a partire dalla ‘svolta’ metafisica delle Meditationes del
1684 si sia autorizzati ad osservare come la fiducia nel convenzionalismo linguistico si converta nel sostanziale innatismo delle monadi, inserite in un ordine di simmetrica armonia al cui governo c’è l’onniscienza e la misericordia di
Dio. Mugnai guida a valutare, viceversa, i termini effettivi della questione ed
indica i nodi di difficoltà annidatisi tra le pieghe di uno schema di tal fatta:
anche nell’impianto del passaggio denotazionale dal signum alla res si
nasconde il principio metafisico della priorità delle idee. Si tratta, come spesso accade, di concetti, quelli di convenzionalismo e di metafisica delle idee, il
cui accostamento non deve far pensare ad un’espressione contraddittoria.
Entrambi esprimono, infatti, essenziali esigenze leibniziane: perseguire la duttilità del calcolo e garantire, nel contempo, l’unità invariante del vero al di là dei
vari sistemi linguistici di riferimento attraverso cui lo stesso enunciato vero si
esprime di volta in volta. Mugnai ricorda, al proposito, la comunicazione epistolare a Gallois della fine del 1672, nella quale Leibniz mette assieme le due
cose: “Le note e i simboli sono arbitrari, sia che siano parole, sia caratteri, ma
le idee si presentano come le medesime per tutti”9.
Le idee, dunque, assumono una dimensione di universalità, dalla cui combinazione discendono i concetti complessi. Esse, cosí, non si riducono solo a rappresentazioni. Ora, se si esprimono i dati ed i fatti del mondo attraverso il linguaggio, le idee stesse, nel manifestarsi, divengono nomi. Questi ultimi, in quanto “sostituti delle idee” (p. 39), orientano il ragionamento, ma, in apparenza, surrogano l’ontologicità delle idee al proprio transeunte carattere di segni. Da qui
l’estrema attenzione verso lo studio della natura del signum. Non si tratta tanto
e solo, infatti, di codificare le “complessioni” degli enunciati meditando sulla loro
funzione logica, quanto di riflettere, anche se in forma indiretta, sulle stesse
idealità sostanziali, proprio operando sui nomi che le esprimono: un modo, questo, in sintesi, di recuperare la metafisica mediante l’analisi logica nel complessivo intento di salvare l’unità del linguaggio per garantire l’unità dell’essere.
In quest’ottica, una posizione del tutto particolare occupa la matematica,
rispetto a cui linguaggio e verità sembrano unirsi in modo mirabile, come Leibniz
sostiene nel Dialogo. Detto altrimenti, verità e idea si combinano sino a congiungersi. Le idee, poi, essendo “modi”, dipendono tutte dalla sostanza prima ed
increata, cioè da Dio. Torna ad imporsi, in questa maniera, la distinzione tra l’idea come archetipo, legittimata dall’Autore supremo delle cose, e l’idea riversatasi nel linguaggio mediante cui si trova una giustificazione alle cose.
La produzione filosofica del periodo giovanile viene considerata da Mugnai
come l’espressione di un atteggiamento eclettico, quello che aveva consentito a Leibniz di deliziarsi nello studio di Suárez come di Hobbes, di Cartesio
come dei cultori dei cosiddetti “dizionari numerici” (Dalgarno10, Digby11,
Becher12 e Kircher13 su tutti). Sullo sfondo, però, si delineano i contorni di un
deciso neoplatonismo, che Mugnai considera desunto soprattutto dallo studio
dell’autore che gli consegna l’idea della necessità di una tecnica combinatoria:
97
Johann Heinrich Bisterfeld14. L’organicismo neoplatonico di quest’ultimo conferma, ab imis, lo stretto legame che per Leibniz deve venire a determinarsi tra
calcolo logico ed enciclopedia nei termini del ripristino di un’unità originaria ed
ormai perduta del sapere. “Per quanto singolare ciò possa apparire –scrive
Mugnai– Leibniz […] cercherà di integrare queste prospettive filosofiche generali con una teoria della conoscenza ispirata a Hobbes, purgata, ovviamente,
del materialismo” (p. 66).
In questa fase l’influenza del filosofo inglese si fa sentire anche per quel
che riguarda la teoria della sensazione: tende, cosí, progressivamente a configurarsi, in sede di teoria di conoscenza, quella singolare forma di fenomenismo tipica del Leibniz maturo, venata dal realismo dell’antitypia e vivacizzata
dall’analisi del contributo dell’“immaginazione” nella nostra percezione dei
fenomeni. Ci sono, dunque, la sensazione, l’esperienza ed un tessuto di idee
innate. In sintesi: nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu, nisi intellectus ipse. Ciò ripropone l’annoso problema della “realtà” del mondo esterno:
a quali condizioni la realtà può essere ritenuta esistente e come può essere
descritta? Nelle Meditationes Leibniz parlerà, per rispondere a tale quesito, di
“definizione reale”, distinta da quella “nominale” hobbesiana, facendo leva sul
concetto di possibilità, in modo da rendere la realtà un attributo predicabile
delle cose solo se ritenuto possibile per il pensiero ed elaborabile senza contraddizione nel giudizio. Una metafisica, dunque, sempre filtrata dalla logica e
da un’esigenza di controllo razionale del mondo.
98
II. V’è un altro importante punto. Se assume una dimensione tanto indecentrabile il linguaggio, è evidente che il concetto di verità acquista anzitutto
una veste proposizionale, poi ontologica. Da qui la disamina leibniziana dei tipi
di verità con cui la ragione umana si confronta: quelle di ragione, quelle di fatto
e quelle miste dell’induzione mediante cui si esprimono gli assunti (sempre
approssimati e rivedibili) delle scienze fisiche.
La philosophia naturalis esprime giudizi sul mondo. Ma di cosa si costituisce la realtà che s’intende descrivere? Torna la spinosa questione delle monadi. Mugnai considera che, per evitare di considerarne la teoria come “il parto
di una fantasia filosofica priva di inibizioni” (p. 86), è necessario valutare il problema nel contesto dell’ontologia delle relazioni tra determinazioni individuali.
La categoria di relazione è ritenuta, da Leibniz, responsabile della costituzione di quegli aggregati di sostanze individuali quali sono i corpi. Esiste, cosí,
una relazione soggettiva, dipendente dall’attività dell’intelletto, ed una oggettiva, tesa a rendere ragione degli aggregati corporei complessi. La monadologia è anche legata, dunque, ai problemi del continuo. Sulla questione Mugnai
si sofferma a lungo, sottolineandone la difficoltà di soluzione rispetto alle convinzioni atomistico-nominalistiche della gioventù, e ne lega i passaggi alla trattazione leibniziana del problema della forza, in dialogo costante e critico con
Cartesio. Simili percorsi trovano un decisivo punto d’approdo nella monade,
essendo essa punto di forza eppure entità immateriale, caratterizzata da relazioni reali. Da questo punto in poi l’intera teoria monadologica oscillerà tra una
decisa forma di realismo ed un misurato fenomenismo entro una concezione
NOTE
della materia distinta quanto-qualitativamente in funzione del suo grado di
dignità ontologica nel quadro teleologico dell’armonia prestabilita.
La costruzione degli assunti monadologici leibniziani non muta, tuttavia,
l’interna fisionomia di quel “nominalismo metodologico” (p. 152) legato ai parametri dell’occamistico “principio di economia” ed ai principî generali della logica nova, come Leibniz aveva stabilito nella Prefazione al Nizzoli (1670).
Rimane, infatti, un sostanziale atteggiamento di distacco del lipsiense da troppo elaborati coinvolgimenti realistico-teologici: ne è testimonianza proprio la
monade, caratterizzata, in fondo, da evidenti venature fenomenistiche, quantunque si dica “reale”. Il mondo delle monadi ed il mondo dei fenomeni, cosí,
si coordinano distinguendosi sia per i limiti della rappresentazione, sia per l’impenetrabile originarietà della sostanza semplice. Il tutto si complica, poi, con
la distensione sulla meccanica dell’universo di un velo teleologico tale da
rimandare agli alti fini contenuti nella mente di Dio, supremo Architetto dell’universo. Quel nominalismo di metodo evocato da Mugnai, dunque, alimenta e
suggella il “minimalismo ontologico” (p. 163) delle monadi, assai piú problematico ed affascinante rispetto a quel presunto piatto ottimismo metafisico
leibniziano dileggiato, tra gli altri, dall’arguto Voltaire.
Uno dei capitoli piú brillanti del testo di Mugnai è il sesto, dal titolo Individui,
concetti completi e mondi possibili. La sostanza individuale costituisce, per
Leibniz, una notio completa e rappresenta l’unica realtà ontologicamente riconoscibile. Se tale è la sua natura, essa “racchiude già tutti i predicati o avvenimenti, ed esprime tutto l’universo”, dichiara il filosofo nel Discorso di metafisica
del 168615. La sostanza semplice come nozione compiuta implica, secondo la
concezione scolastica della sostanza, l’ammissione della sua piena autonomia
logico-ontologica. Ma, se verità è “inerenza”, la determinazione individuale
deve essere predicata sul registro della categoria di relazione; non può piú,
dunque, essere raccolta nella sua isolata autoteticità in quanto vincolata ad un
circuito di molteplici contatti tra elementi semplici. Antica convinzione, questa,
chiara a Leibniz sin dalla Disputatio lipsiense sul problema dell’individuazione.
L’“inerenza” in senso logico realizza, cosí, un’esigenza ontologica. Il predicato, nel copularsi al soggetto, ne soddisfa un costitutivo indigere (aver bisogno). Si pensi al celebre –e spesso abusato– esempio dell’impresa cesariana
di superamento del Rubicone. Il problema qui non è solo volto ad esemplificare l’identità logico-ontologica di una verità di fatto. Si tratta, piuttosto, di arrivare al punto di chiedersi in funzione di quali parametri, in un dato mondo possibile quale quello dell’“età aurea” della civiltà romana, sia legittimo attribuire
un significato definito ai concetti di Cesare e di Rubicone e se, inoltre, si possa
dedurre dalla nozione completa di Cesare l’impresa storica dell’attraversamento del Rubicone. Se tutti i predicati di Cesare derivano da se stesso, come
si combina la fissità della notio completa con la varietà dei mondi possibili? La
prima è, per cosí dire, invariante rispetto al succedersi dei secondi? Ora, al di
là dei “decreti divini” che legano ontoteleologicamente una determinazione ad
un mondo, il quesito è prioritariamente semantico e non è necessario avere in
mente Montague per avvedersene.
Logica e ontologia qui si richiamano pur conservando la loro autonomia.
99
100
Anzitutto, ricorda Mugnai, sostanza semplice e nozione individuale vanno considerate come elementi paralleli: la prima assume una decisa aseità ontologica; la seconda necessita di una rete di relazioni e di un’estrinsecazione dei suoi
predicati impliciti per manifestare il suo senso. Non solo. La natura a suo modo
ontologica della relazione modifica e condiziona lo statuto semantico del soggetto di predicazione: com’è possibile pensare l’ordine della combinazione tra
l’articolarsi degli eventi in un dato sistema-mondo e lo stesso soggetto nell’orizzonte semantico complessivo di quel medesimo mondo? Da quest’impostazione problematica discendono le meditazioni leibniziane sul tema logico della
“contingenza”, che determina un enunciato comunque analitico (perché l’evento accade nell’unico mondo possibile in cui può avere senso), ma non necessario. Si tratta di una questione ardua ed assai rilevante, visto che nel cuore del
concetto di necessità finisce con l’insinuarsi la particolarità della contingenza.
Il problema non è solo squisitamente logico; ha anche implicazioni eticometafisiche di cui Leibniz è appieno consapevole. Lo scopo complessivo dell’analitica del fatto è, infatti, quello di offrire una dignità logico-linguistica all’evento e, al secondo passaggio, un valore metafisico all’ordine contingente del
mondo legandolo alla ragion sufficiente. Scandagliando con attenzione i testi,
Mugnai giunge a riscontrare una doppia tonalità del necessario, basata sulla
distinzione tra necessità assoluta e necessità ipotetica. Ben presto in tali questioni trovano spazio i “decreti divini”, per cui, osserva ancora Mugnai, diviene
possibile pensare alla contingenza del dato sia in termini esclusivamente logici, sia nell’ottica di una connessione di tipo causale e finalistico tra gli eventi.
Logica e metafisica… metafisica e logica.
La “saggezza di Dio”, cosí, combinando universalità e semplicità, guida i
destini del mondo umano –il migliore tra i possibili– che persiste in un perenne
stato di ordine ed armonia. Si è a lungo discusso intorno a questo passaggio.
Le parole del Candide risuonano ancora irridenti e beffarde. Mugnai invita a
comprendere, però, come qui il migliore non stia per l’ottimo, poiché indica solo
il sistema di forze entro cui un dato sistema di eventi, suscettibile di essere pensato (perciò incontraddittorio), acquista senso. In piú, considerare il nostro il
migliore dei mondi possibili non significa certo indulgere in un inno antropocentrico, nonostante l’uomo ne sia un momento ontologico di elevata dignità:
infatti, “il tutto fa aggio sulle parti” (p. 214). Traspare ancora un organicismo di
tipo neoplatonico che riconduce a quella singolare sintesi di logica e metafisica
tipica del pensiero maturo di Leibniz. Anche perché, nel quadro della valutazione della questione dell’ottimismo leibniziano, non va dimenticata la vicenda
della teodicea, con tutti i suoi a volte impervi significati etico-metafisici. Com’è
noto, viene ammesso il male, permesso da Dio, ma nella prospettiva della realizzazione di un bene maggiore. In tal modo, “l’ironia di Voltaire […] appare
meno incisiva” (p. 219): ci si confronta, infatti, con l’insipienza, l’errore e la cattiveria; la prospettiva di un quadro provvidenziale e garantito da Dio entro cui i
primi si collocano non attenua certo la difficoltà di confrontarsi con essi. Vivere
gli equilibri del mondo significa, secondo Leibniz, accettarne le ambivalenze,
adeguandosi ad una forma di “rassegnazione di tipo stoico” (Ib.). Mugnai non
tralascia di segnalare, inoltre, come l’etica assuma una dimensione pubblica,
III. Il volumetto di Mugnai rappresenta molto piú che una semplice presentazione dei grandi temi della filosofia leibniziana. È un libro che si offre a diversi
livelli di lettura, da quella alimentata dalla curiosità a quella erudita, sino a quella
NOTE
convergendo nel diritto. L’intera vicenda dell’agire, poi, acquista una specifica
configurazione metafisica nel senso che si inserisce nel contesto della discussione dei rapporti tra libertà individuale e determinismo ontologico.
L’ultimo capitolo del libro di Mugnai è dedicato alla ricerca leibniziana di una
lingua artificiale. La questione s’inserisce nel quadro della riflessione sulla
genesi dei linguaggi naturali nel tentativo di superare la condanna alla Babele
delle lingue. Ad ogni modo, utopistica viene considerata dal Lipsiense la ricerca di una lingua originaria, pura, “adamitica” tale da presentarsi come il modello originario di un sistema compiuto di comunicazione tra gli uomini. Infatti, a
giudizio di Leibniz esiste nelle lingue un “fondamento naturale” e un “fondamento arbitrario” (p. 240), in considerazione del fatto che la lingua è un corpo
dinamico proteso ad elaborare nel tempo la propria fisionomia. Essa si fonda
su una serie di “mots radicaux” da cui scaturisce un articolato procedimento di
derivazione e, assieme, di generalizzazione. Ciononostante, il linguaggio ordinario presenta una spigolosa ambivalenza di fondo. Si affaccia, in questa
maniera, la prima idea di una sua formalizzazione per poter trasformare il problema della comunicazione del pensiero in una forma di calcolo. Il De arte combinatoria costituisce, in tal senso, un “punto d’intersezione” (p. 247) di progetti:
quello enciclopedico, dato che, alla fine, sarà possibile restituire alla loro sistematica organicità tutti gli ambiti dello scibile una volta isolati i concetti semplici;
quello relativo alla realizzazione delle accademie delle scienze come luoghi in
cui i risultati del primo ordine di ricerche possono essere messi a pubblica disposizione; quello dello studio di una grammatica razionale in grado di offrire
un’intelaiatura sintattica coerente al linguaggio; quello della scelta dei “caratteri ottimali” di designazione dei termini elementari, allo scopo di ratificare e realizzare quelle tecniche integrate di calcolo finalizzate ad una piena trasformazione della logica in un’ars inveniendi. Tante idee e progetti si inserivano, ad
ogni modo, “in un piano piú vasto”, il cui “fine ultimo era il miglioramento delle
condizioni generali (materiali e spirituali) della vita umana” (pp. 262-3).
Quando si parla di calcolo logico ci si riferisce, com’è noto, all’intenzione
leibniziana di matematizzare la logica. Il termine ‘logica matematica’, d’altronde, lo conia proprio il Lipsiense e ciò costituisce, forse, il principale elemento
di originalità dell’impostazione leibniziana, che pure si collocava in un consolidato filone di studi dedicato alla ricerca di una lingua universale. Il numero,
cosí, non designa solo la quantità, ma assume una specifica funzione denotazionale e semantizzante. Applicare metodi di calcolo algebrico alla logica
intenta a formalizzare il linguaggio ordinario significa studiare le condizioni
della validità dell’inferenza. Ma, alle spalle di ciò, non c’è solo un’esigenza di
ordine, di controllo e di prevedibilità. Leibniz prevede la presenza, infatti,
anche di una sorta di “logica del probabile” in grado di valutare “le aspettative,
le congetture, gli indirizzi” (p. 262) delle ricerche umane: si tratta, “nell’ambito
degli studi filosofici, [di] un’assoluta novità” (Ib.).
101
102
specialistica, offrendo preziosi spunti di riflessione a ciascuna. Esso si fonda su
una solida dimensione di equilibrio storiografico che non slega mai il testo dal
contesto. Si sfugge, cosí, a tentazioni attualizzanti in relazione ad un pensiero,
quello leibniziano, che offre innumerevoli suggestioni, specie in ordine alle pionieristiche ricerche logiche portate innanzi dal genio di Lipsia. È, tuttavia, chiaro
che, a giudizio di Mugnai, la logica si colloca in una posizione di centralità negli
equilibri del sistema, senza che, con ciò, sia necessario ritornare a parlare della
sua primazia magari nei termini di un neocouturatismo. Anzi, logica e metafisica
vengono restituite al loro specifico ordine problematico e, nel far ciò, la metafisica viene letta in una posizione di continuità rispetto alle pregresse ricerche leibniziane. Si assiste, in tal modo, ad una sorta di ritorno all’antico: vengono, infatti,
alla memoria gli inviti di Cassirer a legare strettamente la metafisica leibniziana
agli sviluppi delle sue indagini scientifiche, allo scopo di poter intendere l’originalità di una “metafisica scientifica” per la quale, per esempio, la sostanza non è il
sostrato, ma una sorta di implicita funzione algebrica e l’armonia prestabilita non
costituisce il vaneggiamento di una fantasia eccitata, quanto la raffigurazione simbolica del sistema funzionale delle relazioni tra le monadi16. La metafisica, dunque, come orizzonte problematico complessivo da inserirsi nella prospettiva di
quei quesiti di filosofia naturale da cui era scaturita la rivoluzione scientifica seicentesca.
Centrale è, nella trattazione, la questione del linguaggio. Mugnai non procede
soltanto ad enunciarne l’analitica; si orienta anche a descrivere la componente
neoplatonica che guida gli intenti leibniziani, la quale permette al filosofo di coniugare il calcolo logico con la formalizzazione linguistica e l’enciclopedismo. Ci si
avvede, inoltre, di quanto debba essere ancora scandagliato questo filone di
ricerca, poiché è spesso altro dal solco dell’ermetismo lulliano dalle cui teorie
Leibniz era attratto, come ha dimostrato a suo tempo Paolo Rossi17. Sulla spinosa questione del nominalismo giovanile Mugnai offre ancora un significativo stimolo, inducendo a valutare il senso dell’attenzione da Leibniz dimostrata verso
quella tradizione filosofica, senza piú dimostrare tanta enfasi, come spesso è
accaduto18, verso la Disputatio o la Prefazione al Nizzoli. Mugnai, infatti, illustra il
graduale passaggio dal nominalismo alla metafisica dell’idea già a partire dai primissimi anni Settanta; e l’indicazione in merito alla persistenza di un “nominalismo metodologico” nel corso degli anni è un modo per ribadire la realtà di un
Leibniz per nulla ‘conquistato’ dalla logica nova, viceversa solo gradevolmente
impressionato dalla sua duttilità euristica, anche se è di certo terministico l’impianto della Combinatoria e ad esso bisogna riferirsi per comprenderlo. Ma proprio il lavoro di Mugnai contribuisce a far intendere, ancora una volta, come sia
equivoco declinare al singolare tali concetti. Ci si riferisce sempre, infatti, a singolari collettivi, nel cui asse semantico confluiscono sollecitazioni ed indirizzi speculativi tra i piú vari. Nominalismo è anche, infatti, sinonimo di neoplatonismo, di
individualismo, di calcolo, di zenonismo19 e di enciclopedismo oltre ad essere un
concetto teso a designare il complesso rapporto della logica con la metafisica ed
un altrettanto articolato fronte di considerazioni rispetto al progetto di una ragionata riforma della logica formale classica. Proprio il metodo “analitico” adottato
nel libro consente di descrivere le linee di sviluppo delle ricerche filosofiche leib-
* M. MUGNAI, Introduzione alla filosofia di Leibniz, Torino, Einaudi, 2001, pp. XIII-278. Le citazioni tratte da questo libro sono indicate, nel corpo del testo, in parentesi tonde.
1
L. COUTURAT, La logica di Leibniz, voll. 2, ed. it., a c. di U. Sanzo, Napoli, Edizioni Glaux,
1973-1974, v. I, p. 32. La lettera al De L’Hospital è contenuta in G.W. LEIBNIZ, in Mathematische
Schriften, 7 Bde. Hildesheim, Georg Olms Verlag, 1962 [già Berlin-Halle, 1849-1863], Bd. II, pp.
255-62: 258.
2
Cfr. B. RUSSELL, Esposizione critica della filosofia di Leibniz, tr. it., a c. di E. Bona Cucco,
Milano, Longanesi, 1971, pp. 25 e sgg.; Storia della filosofia occidentale e dei suoi rapporti con le
vicende politiche e sociali dall’antichità a oggi, tr. it., a c. di L. Pavolini, Milano, Teadue, 1991 [già
Milano, Longanesi, 1983], p. 562.
3
Cfr. L. COUTURAT, La logica di Leibniz, cit., v. I, pp. X-XI.
NOTE
niziane ed il progressivo ampliarsi del loro fronte problematico: cosí, diviene possibile cogliere la latitudine di un’aporetica legandola alla data storicamente determinata, alla fase di pensiero ed al contesto tematico “interno” di cui è espressione.
Si può magari discutere dei rimaneggiamenti espositivi, delle inevitabili scelte, del privilegio di alcuni temi in luogo di altri. Va considerato, però, che ci si riferisce, in fondo, ad un’introduzione al multiverso pensiero leibniziano, il cui obiettivo primario è quello di offrirne una ‘sintesi’ quanto piú esaustiva possibile, non
di discutere della cogenza o della raffinatezza di questo o quel contributo interpretativo. Ciononostante, Mugnai non esita a segnalare i grandi nodi problematici, i momenti di tormento critico e ciò su cui è necessario ancora lavorare. Tra
i tanti temi aperti, per esempio, c’è il problema delle fonti sia del nominalismo
giovanile leibniziano entro l’articolarsi dell’orizzonte delle sue letture giovanili, sia
del platonismo aritmologico e del neoplatonismo enciclopedico maturo: una sua
giusta focalizzazione dovrebbe portare a comprendere attraverso quali vie, dirette e/o indirette, Leibniz giunse ad inserirsi nel solco delle dette tradizioni di pensiero offrendovi il proprio contributo. Tutto un orizzonte, per esempio, aveva
aperto, a suo tempo, Carlo Giacon20 quando, in polemica con Antonio Corsano21,
descrisse i termini della ricezione leibniziana dell’occamismo, inducendo a
distinguere tra nominalismo, terminismo ed occamismo stesso, questione decisiva, questa, per cogliere gli itinerari interni e le intenzioni di fondo della
Disputatio e di tanta parte del pensiero giovanile di Leibniz.
Per ritornare al testo di Mugnai, rimane sullo sfondo il confronto con
Cartesio, con Locke e, soprattutto, con Pascal, alla cui critica dell’impianto
assiomatico della geometria si deve lo stimolo leibniziano volto ad una revisione integrale del suo razionalismo e ad un significativo allontanamento dal
convenzionalismo di Hobbes. Rilievi, questi, che tali in realtà non vogliono
dirsi, proprio alla luce della natura dello studio di Mugnai, nato da precise esigenze di informazione e di diretto contatto con alcuni dei tanti volti della filosofia leibniziana. La bibliografia finale, succinta ma ragionata, invita con garbo,
volendo, a proseguire lungo i tanti percorsi critici di cui si compone il pensiero
filosofico di Leibniz, cosí ricco, problematico ed opalescente da apparire, a
tratti, tormentato dal suo stesso tumultuoso spirito creativo.
103
104
4
Cfr. E. CASSIRER, Leibniz’s System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen, Marburg,
Elwert, 1902.
5
Cfr. J. BARUZI, Leibniz et l’organisation religiouse de la terre, Paris, Alcan, 1907.
6
Cfr. H. HEIMSOETH, Die sechs grossen themen der abendlandischen Metaphysik und der
Ausgang der Mittelalters, Berlin, J. Dunnhaupt, 1934.
7
G.W. LEIBNIZ, Vita Leibnitii a se ipso breviter delineata, in G.E. GUHRAUER, Gottfried Wilhelm
Freiherr von Leibniz. Eine Biographie, Bde. 2, Hildesheim, Georg Olms Verlag, 1966 [già Breslau,
Hirt, 1846], Bd. II, p. 55.
8
Cfr. G.W. LEIBNIZ, Sämtliche Schriften und Briefe, Akademie Verlag, Berlin, 1923 e sgg. Tale
edizione ancora in corso di tutti gli scritti di Leibniz, patrocinata dapprima dalla Deutsche
Akademie der Wissenschaften e poi sostenuta da vari centri di ricerca tedeschi, annovera finora
trenta volumi nel suo catalogo.
9
Ivi, II, I, p. 228.
10
Cfr. G. DALGARNO, Ars signorum, vulgo Character Universalis et Lingua Philosophica,
London, Hayes, 1661.
11
Cfr. K. DIGBY, A Treatise on the Nature of Bodies, Paris, 1644. L’opera fu tradotta in latino
con il seguente titolo: Demonstratio immortalitatis animae rationalis, sive tractatus duo philosophici in quorum priori natura et operationes corporum, in posteriori vero natura animae rationalis
ad evicendam illius immortalitatem explicantur, Frankfurt, 1664.
12
Cfr. J. BECKER, Character pro notitia linguarum universalis. Inventum Steganographicum
hactenus inauditum, Frankfurt, typ. J.C. Spoerlin, 1661.
13
Cfr. A. KURCHER, Polygraphia nova et universalis, ex combinatoria arte detecta, Roma, 1663.
14
J.H. BISTERFELD, Phosphorus catholicus, seu artis meditandi epitome, cui subjunctum est
consilium de studiis feliciter instituendis, Lugduni Batavorum, H. Verbiest, 1657; Bisterfieldus redivivus seu operum J.H. Bisterfieldi, voll. 2, Hagae Comitum, A. Vlacq, 1661.
15
G.W. LEIBNIZ, Discorso di metafisica in Saggi filosofici e lettere, ed. it., a c. di V. Mathieu,
Bari, Laterza, 1963, p. 118.
16
Cfr. E. CASSIRER, Leibniz’s System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen, cit., pp. 535-9.
Sulla questione dei rapporti tra calcolo logico e conoscenza scientifica si vedano soprattutto le pp.
106-8 e 547.
17
Cfr. P. ROSSI, Clavis universalis. Arti mnemoniche e logica combinatoria da Lullo a Leibniz,
Bologna, Il Mulino, 1983 [già Milano-Napoli, Ricciardi, 1960].
18
Com’è noto, in Italia è stato soprattutto Antonio Corsano a sottolineare l’importanza della
componente nominalistica propria della logica leibniziana, entrando in polemica con Francesco
Barone che aveva, invece, ribadito il costante realismo che alimenta e guida la stessa produzione logica di Leibniz: cfr. A. CORSANO, G.W. Leibniz, a c. di G. Sava, Galatina, Congedo, 2000 [già
Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1952]; Il pensiero filosofico di G.W. Leibniz, voll. 2, Bari,
Adriatica, 1952; F. BARONE, Logica formale e logica trascendentale, voll. 2, v. I: Da Leibniz a Kant,
Torino, Edizioni di “Filosofia”, 1957, pp. 1-40; Introduzione e Nota bibliografica, in G.W. LEIBNIZ,
Scritti di logica, ed. it., a c. di F. Barone, voll. 2, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. XI-CII. Per una ricostruzione dei termini della polemica ingaggiata da Corsano con Barone si permetta di rinviare a
S. CIURLIA, Antonio Corsano e la filosofia analitica: il pensiero giovanile di Leibniz, Galatina,
Congedo, 2002, pp. 171-5.
19
Ha richiamato di recente l’attenzione sul tema dello studio leibniziano delle opere degli zenonisti P. ROSSI nell’articolo dal titolo Leibniz e gli zenonisti, in “Rivista di Storia della Filosofia”, LVI
(2001), pp. 469-76. Secondo Rossi, autori come Roderigo Arriaga e Francisco Oviedo, “al di là
delle differenze, si oppongono alla teoria aristotelica del continuo, fanno variamente uso del concetto di punto, credono a entità indivisibili reali e non costruite dal pensiero” (Ivi, p. 470); costituiscono, dunque, un ponte di passaggio di grande rilievo per intendere l’idea di Leibniz di una materia composta di “punti matematici” e sono parte integrante della sua complessiva concezione critica del nominalismo.
20
Cfr. C. GIACON, La seconda scolastica, voll. 3, Milano, Bocca, 1944-1950 (v. II:
Precedenze teoretiche ai problemi giuridici: Toledo, Pereira, Fonseca, Molina, Suárez, Bocca,
Milano, 1947); Suárez, Brescia, La Scuola, 1945; Tracce occamiste nel pensiero leibniziano,
in AA.Vv., Studi in onore di Antonio Corsano, a c. di A. Lamacchia, Manduria, Lacaita, 1970,
pp. 349-60.
21
Sul confronto Corsano-Giacon intorno al significato dell’occamismo leibniziano si veda
ancora S. CIURLIA, Antonio Corsano e la filosofia analitica etc., cit., pp. 175-8.
FELICE BALBO.
PER UN RADICALE REINIZIO DELLA FILOSOFIA
NOTE
di Lucia De Pascalis
È solo negli ultimi trenta anni che si è avuta, negli ambienti filosofici, una rivalutazione del pensiero di Felice Balbo, definito “il filosofo torinese della crisi”.
Si tratta della crisi che ha investito l’Italia intera, sia durante la seconda
guerra mondiale, sia nell’immediato dopoguerra; una crisi, pertanto, estesa a
tutti i campi della vita sociale1. Dunque, la crisi cui si riferisce Balbo, non è soltanto una crisi socio-politica e socio-economica ma, anche e soprattutto, una
crisi morale.
Chiaramente, come altri studiosi italiani suoi contemporanei, anche
Balbo portò avanti una riflessione sul come affrontare il superamento della
crisi. Nei suoi scritti indica nella filosofia la strada maestra per uscirne. Per
il filosofo torinese, compito della filosofia è quello di guidare l’azione dell’uomo verso l’emancipazione, fornendo, in sostanza, delle formule di liberazione dai rigidi astrattismi. Il discorso vale non soltanto per l’auspicato superamento del sistema capitalistico, ma anche nell’ipotesi di una rifondazione
della filosofia stessa, dando vita ad una “comunicazione viva col semplice
uomo di buona volontà”2.
È innegabile che la filosofia abbia, nel corso dei secoli, reso sempre più
ardua la possibilità di accesso alla sua comprensione, restringendola ad una
élite di studiosi.
Partendo da questa osservazione, Balbo auspica la necessità di rimuovere questi schemi di rigidità, questi termini di chiusura, per dar vita ad una filosofia realmente vicina all’uomo ed attenta ai suoi bisogni.
Nel pensiero di Balbo o, meglio, nel suo progetto di ricostruzione filosofica
vi è “una filosofia che nasce dalla vita”3 e, benché Balbo tenga a sottolineare
che il suo pensiero non sia inquadrabile in uno “schema esistenzialistico”, in
cui persistano scorie metafisiche e formulazioni pseudo-religiose, la sua “filosofia” resta, comunque, “esistenziale”.
“L’uomo senza miti” è l’uomo che rifiuta le illusioni metafisiche, le ideologie,
rintracciando in queste dei vaniloqui che, in nessun modo, portano alla liberazione dal dato4.
Balbo individua lo strumento dell’auspicata liberazione nell’azione, vista
come “tecnica dell’accadimento dell’uomo”5; ma per poter superare il dato, per
affermare l’uomo, l’azione deve essere sorretta dall’amore.
“L’azione soltanto (teoria e prassi assieme), questo atto d’amore, questa
autorità liberante, questa forza autonoma rappresenta la via della redenzione
105
106
della persona”6 che, solo se guidata dalla coscienza può orientarsi al bene,
rifuggendo il male. L’esperienza della coscienza, pur trascendendo l’uomo, si
attua nell’umanità: “la coscienza è la presenza nell’umanità di una tensione
positiva, del principio stesso attivo dell’uomo”7.
Si può notare come, secondo Balbo, tutti i lavori siano necessari al progresso umano, in virtù del fatto che ogni uomo ha una naturale propensione,
una propria vocazione che lo avvia ad una fondamentale funzione, a svolgere
un lavoro “tecnico e specificato”.
Per poter realizzare la propria vocazione, ogni uomo deve compiere il proprio dovere, contribuendo, con gli altri uomini, al progresso dell’umanità8.
Eppure, se si guarda alla storia umana, come specificarsi delle tecniche, sembra quasi che si vada a cadere nella meccanicità astratta ed inumana, nella
pura esecutività dell’uomo che ubbidisce e soggiace ad un ordine, ad una
macchina”9.
L’uomo che lavora con indifferenza, sempre con altrettanta indifferenza
viene assorbito, inglobato, ingoiato da una meccanicità astratta, lasciandosi
“meccanizzare passivamente” e rischiando di essere annullato in ciò che egli
stesso ha creato, a causa di un cattivo rapporto con la macchina alla quale si
rivolge, “come alla più giovane e promettente creatura del mondo moderno”10.
Questa sconfinata fiducia nella macchina, fa cadere l’uomo nell’esteriorismo, allontanandolo da se stesso, dal proprio Io, dalla propria coscienza,
facendolo divenire oggetto tra gli oggetti.
Ciò che si richiede all’uomo è una reazione, una risposta definitiva che lo
porti a cercare una via di uscita, un riscatto dalla passività.
Bisogna amare il proprio lavoro ed impegnarsi, sino in fondo, per la sua
buona riuscita e, per farlo, è necessario che il lavoro di ognuno rispecchi la
vocazione di ciascuno11.
Nel pensiero di Balbo la filosofia è una tecnica fra le tecniche e, come tale,
ha una funzione ben definita, la quale esula dalla mera contemplazione cosicché, il principio unificatore di tutte le tecniche è rappresentato dalla coscienza,
presente in ogni specificazione tutta intera.
Le tecniche sono, perciò, unificate dalla spinta verso la realizzazione dei
mezzi per attuare il bene. Le azioni della persona, però, non hanno alcun
senso se non sono protese al perfezionamento ed allo sviluppo umano; infatti, se non sono ben compiute, non possono “servire all’uomo”, comportandone anzi la crisi, la decadenza, il non-uomo12.
Se vuol dare all’uomo la sicurezza di una metodica vittoria sul mito13, ovunque questo si presenti nella sua attività, la filosofia deve divenire sperimentale. Il filosofo torinese è favorevole al metodo sperimentale galileano:
“L’introduzione del metodo sperimentale, del metodo galileano, in tutte le attività dell’uomo è ciò che può evitare il risorgere del mito che, come tendenza,
è ineliminabile, al pari di un’idea kantiana”14.
Questa nuova filosofia deve confrontarsi con il metodo sperimentale che
prevede il controllo, la riprova e la conferma dell’esperienza.
Anche il filosofo, infatti, accettando la propria vocazione, accetta con essa
il dovere di dare una risposta ai bisogni degli uomini che, come è facilmente
NOTE
riscontrabile, poiché sono sempre nuovi, comportano il continuo variare delle
risposte filosofiche15.
Il tema della filosofia come tecnica, il superamento di questa come ideologia e, ancora, la caduta della filosofia come mito hanno spinto Balbo a scrivere la sua seconda opera.
Un anno dopo L’uomo senza miti del 1945, ecco apparire Il laboratorio dell’uomo. Con quest’opera, il filosofo torinese ha inteso dar voce ad una cultura
utile all’uomo16; partendo, appunto, dalla situazione di crisi riscontrabile nella
cultura umanistica tradizionale, non più rispondente e del tutto inadeguata alle
domande poste dall’uomo contemporaneo.
Risulta, quindi, indispensabile una cultura capace di orientare la propria
attenzione sui problemi sociali, al mondo del lavoro, al rapporto uomo-macchina, al senso comune17; è questo l’auspicio del filosofo torinese, in quanto,
la teoria, in senso positivamente e costruttivamente umano, non si realizza e
non cresce senza il fare e lo stesso ragionare filosofico è un fare, ars logica18.
Compito primo della nuova filosofia è quello di umanizzare il rapporto che
gli uomini hanno con le macchine.
L’alienazione subentra a causa dell’indifferenza e della mancanza di inventiva che gli uomini pongono nello svolgere il proprio lavoro; perciò, è intorno
alla macchina ed all’atteggiamento da assumere nei suoi confronti che deve
vertere lo studio filosofico.
Balbo non vede le macchine quali mezzi di oppressione, come nemiche
dell’umanità, poiché diventano tali a causa del loro cattivo uso, del cattivo rapporto che gli uomini instaurano con esse.
Dallo scritto di Balbo Il lavoro umano, ripreso da L. Bazzoli in Felice Balbo:
Dal marxismo ad economia umana, si può leggere ciò che il filosofo torinese
sostiene circa il lavoro dell’uomo visto nel corso della storia19.
Secondo Balbo, “il lavoro umano non è (mai) stato impiegato, se non in
minima parte, come lavoro propriamente umano. Quasi sempre, la forza lavoro umana è stata impiegata come macchina o come forza motrice e solo raramente è stato possibile un lavoro umano come lavoro d’ideazione. Il non aver
utilizzato il lavoro umano, quale lavoro intelligente, ha comportato al singolo
ed all’universo un tragico danno, una incommensurabile perdita”20.
Quando Balbo afferma che la filosofia è fondamentale per ricostruire un
rapporto ormai deteriorato, si riferisce ad una una filosofia intesa, sempre,
come tecnica e non come metafisica21. L’uomo ha la possibilità di completarsi,
solo attraverso l’inserimento fisico nel progresso sociale, in qualità di lavoratore, con il conseguente possesso dei mezzi, grazie al piano tecnico.
Con l’inserimento nelle strutture del progresso civile della società, il lavoratore sente maggiormente “l’oppressione del sistema capitalistico borghese”
che si attua, non solo a livello economico e politico, ma che è in grado di portare persino alla disumanizzazione dei rapporti sociali stessi. Ciò avviene perché le due classi sociali fondamentali del sistema vivono in condizioni ed in
situazioni socio-economiche nettamente differenti.
Dovendo solamente lavorare, senza poter attuare la minima partecipazione ai livelli decisionali dell’azienda, il proletario subisce una disumanizzazione
107
108
a livello fisico, culturale ed economico. Balbo è dell’avviso che anche sulla
classe dominante, quella borghese, si attui una sorta di oppressione. Infatti, il
borghese è allontanato dal lavoro, in quanto il suo contributo lavorativo è considerato pressocché inutile.
Si può notare, perciò, come il sistema capitalistico borghese sia minato dall’interno, a causa del suo modo d’essere “mostruoso ed ingiusto”22.
Dunque, non si può non rimarcare quanto le sorti della filosofia e quelle della
società umana siano così fortemente legate, tanto da poter dedurre come non
sia possibile la crescita della filosofia separata dallo sviluppo umano, anzi come
essa sia necessaria allo stesso sviluppo. Nella società capitalistico-borghese,
caratterizzata dal benessere e dallo sviluppo scientifico e tecnologico sono,
comunque, indispensabili l’azione del filosofo e la conseguente speculazione
filosofica, per poter tentare di colmare quella parzialità di risposte che la scienza e la tecnica si sforzano di fornire alle domande poste dall’uomo.
Da qui nasce l’esigenza della filosofia, di quel tipo di conoscenza che soddisfa quei bisogni umani, della vita singola ed associata che, invece, non vengono soddisfatti dalla conoscenza razionale, di tipo tecnologico.
Spetta alla filosofia il compito di individuare e suggerire i modi per la piena
realizzazione dei bisogni umani. La funzione sociale del filosofo, allora, non è
certamente quella di risolvere i problemi che attanagliano, da sempre, la vita
umana, quanto, invece, quella di aiutare gli uomini ad affrontarli, secondo la
via filosofica del conoscere che, in seguito, permetterà loro di governare l’ambiente razionalmente, sottraendoli, così, al dominio degli accidenti.
Dunque, la filosofia deve porre alla base della sua pianificazione la definizione di una idea di uomo, in termini operativi, ossia, nei termini per cui l’idea
di uomo possa divenire il criterio ordinatore di ogni scelta sociale.
Affinché si attui lo sviluppo umano, però, è necessaria l’integrazione umana
che comporta il saper rinunciare ai propri privilegi per il bene comune, il ché significa essere disposti attivamente a voler realizzare ciò che manca al completo raggiungimento del bene. Lo sviluppo umano non equivale, in nessun modo, all’arricchimento economico dei singoli, quanto, invece, ad uno sviluppo, secondo l’essere ed il valore dell’uomo, nella sua vita personale e produttiva. Dalle affermazioni sopra enunciate, scaturisce che “per raggiungere il vero sviluppo umano
bisogna che sia presente nella società in modo predominante la tensione al bene
universale, senza condizionamenti e strumentalizzazioni al bene individuale”23.
Solo la filosofia dell’essere consente di dar vita ad una filosofia del progresso e
ciò che realmente realizza l’essenza umana, nella visione di Balbo, è il lavoro
umano, “ciò mediante cui l’uomo passa dalla potenza all’atto. L’uomo non può
vivere senza il lavoro […]. Prima del lavoro non vi è tensione all’essere, energia
disponibile, bisogno indistinto […] o beni che possano soddisfare i bisogni”24.
Gli intellettuali ed i filosofi, mettendosi concretamente al servizio della
società, intervengono sui bisogni della collettività, aiutando a promuovere la
nascita di idee ed istituti, indispensabili allo sviluppo dell’umanità25. Però, bisogna precisare che, secondo Balbo, all’accadimento non è sufficiente la sola
filosofia; il lavoro del filosofo deve essere integrato dalla tecnica (per il nostro,
infatti, sviluppo tecnico è sinonimo di sviluppo umano), intesa quale categoria
1
Cfr. S. LOMBARDINI, Oltre la crisi. Verso la società post-capitalistica, Il Mulino, Bologna 1979,
p. 227.
2
Cfr. G. IINVITTO, Le idee di Felice Balbo. Una filosofia pragmatica dello sviluppo, Il Mulino,
Bologna 1979, p. 36.
3
Cfr. F. BALBO, L’uomo senza miti, in Opere 1945-1964, Boringhieri, Torino 1966, p. 94.
4
Nella visione di Balbo, l’uomo, in un primo momento è un dato, una rappresentazione del
negativo, del non-Uomo, inteso come corporeità, come limite. Cfr. F. BALBO, L’uomo senza miti,
cit., p. 7. Solo in un secondo momento avviene la liberazione dal dato, dai condizionamenti materiali attuando, così, il passaggio dalla “persona esistenziale” alla “persona umana”. Sul significato
della persona in F. Balbo, vista come “punto di partenza e, insieme, come punto di arrivo”, cfr. G.
CAMPANINI, Balbo e il personalismo francese, in AA..Vv., Felice Balbo tra filosofia e società, a c. di
G. Campanini e G. Invitto, F. Angeli, Milano 1985, pp. 42 e sgg.
5
La distinzione che Balbo attua tra Uomo e l’uomo è la stessa che si frappone tra le potenzialità insite nella persona umana e la corporeità.
6
Cfr. F.BALBO, L’uomo senza miti, cit., p. 102.
7
Ivi, p. 7.
8
“Attorno alla vocazione è sempre necessario provarsi molto e con prudenza perché gli abbagli sono facili; ma ci si deve provare anche con coraggio perché chi scopre di avere sbagliato la
via, anche quando ne ha percorso un lungo tratto, deve avere la forza di seguire la nuova”. Cfr.
Ivi, p. 62.
9
Cfr. F. BALBO, Il laboratorio dell’uomo, in Opere 1945-1964, cit., p. 121.
10
Ivi, p. 113.
11
Condizione e vocazione vuol soltanto dire che i dati della nascita e dell’ambiente ci sono e
che ognuno ha il dovere, alla luce della sua coscienza, di modificarli o di scegliere, per quanto è
in suo potere, ma non ha il diritto di eliminarli e se ciò avvenisse sarebbe come un non accettare
la vita. Cfr. L’uomo senza miti, cit., p. 62.
12
Balbo sostiene che la filosofia sia l’unica tecnica che possa guidare l’uomo verso la liberazione, facendolo uscire dalla crisi. Per far ciò la filosofia deve proporsi come ametafisica e non
come antimetafisica, per non cadere, quindi, nel metafisicismo, in cui Balbo intravede la causa
stessa della crisi dei sistemi filosofici.
13
Il mito è la metafisica, l’ideologia, il riconoscimento della filosofia come formula assoluta
dell’Assoluto. Balbo, dichiarandosi contro tale visione della filosofia, cerca di dar vita ad una filosofia costruttiva. Cfr. Il laboratorio dell’uomo, cit., pp. 127-129.
14
G. INVITTO, Le idee di Felice Balbo, cit., p. 63.
15
È in questa nuova ottica che il filosofo deve operare; egli non può e, soprattutto, non deve
più osservare, contemplare, discutere su problemi trascendentali ma deve operare sulla società.
La filosofia deve essere vista come tecnica che guida l’azione dell’uomo al bene; la filosofia
si presenta, perciò, “come lavoro tecnico anch’essa, come macchina per rispondere accanto alle
altre macchine”. Cfr. F. BALBO, Il laboratorio dell’uomo, cit., p. 118.
16
Cfr. L’uomo senza miti, cit., pp. 102 e sgg.
17
“La cultura in ispecie è necessaria in quanto senza di essa le macchine di acciaio sono cieche e mute. La filosofia è necessaria per rispondere ai perché delle macchine […]. È necessaria
perché le macchine diventino umane”. Cfr. Il laboratorio dell’uomo, cit., p. 118.
18
Ivi, pp. 115-116.
19
L. BAZZOLI, Felice Balbo: Dal marxismo ad economia umana, Morcelliana, Brescia 1981, p. 100.
20
Ibidem..
21
Con Balbo c’è il superamento di questa visione, in favore di un modello scientifico unificatore, individuato nel “piano tecnico”, che rappresenta il mezzo per realizzare lo sviluppo sociale.
22
Cfr. F. BALBO, Il laboratorio dell’uomo, cit., p. 115.
23
V. POSSENTI, Felice Balbo: Antropologia e assoluto, in AA.Vv., Felice Balbo tra filosofia e
società, cit., p. 103.
NOTE
di lavoro specifico, compiuto dall’uomo attraverso l’azione, considerata come
l’unica via di liberazione.
109
24
25
F. BALBO, Il lavoro come dimensione essenziale dell’uomo, in Opere, cit., pp. 926-927.
Cfr. F. BALBO, Essere e progresso, cit., p. 821.
DALL’IMPRESA DELL’ESSERE
ALLA SORPRESA DEL VOLTO
di Paolo Miccoli
110
Il pensiero filosofico di Emmanuel Lévinas registra interesse crescente nell’odierna cultura internazionale. La dimensione etica che lo caratterizza complessivamente investe il dibattito filosofico attuale sugli ardui problemi di ingegneria genetica, di solidarietà universale, di globalizzazione politica e culturale, di antropologia comparata e di scienze umane. La nota di inconfondibile originalità è data dal platonismo perenne che spinge il filosofo lituano a polemizzare con la cultura moderna e postmoderna che ha privilegiato la significazione categoriale rispetto alla nozione fondamentale di essere, ha subordinato
l’intelletto intuitivo all’espressione linguistica, ha dissolto la trascendenza del
Bene nel’immanenza dell’intenzionalità fenomenologica. Il che equivale a dire
che la modernità si è costituita nel segno dell’anti-platonismo. Il Platone dei
Dialoghi che Lévinas interroga e interpreta è quello più disponibile a lasciarsi
conciliare con la tradizione ebraica e con la cultura talmudica. Un Platone, si
potrebbe dire, trapiantato dalla Grecia in Israele, che fa valere le ragioni dell’erranza fiduciosa di Abramo nei confronti del viaggio di ritorno di Ulisse nella
sua Itaca. perché, allora, Lévinas si è irrigidito a dissociare il pensiero platonico dalla metafisica occidentale? Per tre motivi: 1) la metafisica occidentale, o
più determinatamente l’ontologia aristotelico-tomista, ha consacrato il primato
dell’essere-totalità con oblio del Bene; 2) ha tematizzato la significazione, o
idealità formale, a prescindere dal Senso ontologico; 3) ha enunciato il privilegio della reminiscenza-circolarità con esclusione dell’immemoriale.
Intrecciando, per contro, la meditazione platonica con la rivelazione veterotestamentaria, il rinomato filosofo ha esaltato la trascendenza del Bene al di
là dell’essere e della sostanza, attestandola sovrana rispetto al modo predicativo dell’umano linguaggio filosofico. Ne conseguono due acquisti rilevanti:
la scoperta dell’Altro (Autrui) come diversità radicale e asimmetrica che accende la mia responsabilità nei suoi confronti e il postulato di trascendenza religiosa che rende il prossimo sacro e intangibile nella sua singolare cifra antropologica di “volto”.
L’itinerario speculativo di Lévinas è andato maturando a contatto con la
fenomenologia di Husserl e con l’ermeneutica esistenziale di Heidegger. La
metodica fenomenologica di interpretare il soggetto intenzionale come abitatore del mondo, se, per un verso, ha consentito all’autore critiche severe a
Cartesio, a Kant, agli idealisti e positivisti, per altro verso lo ha spinto a innovare profondamente la fenomenologia trascendentale in senso contenutistico
NOTE
e metodologico andando oltre la fatticità ontina e oltre l’orizzonte dell’intenzionalità fungente della coscienza, per aprirsi a tematiche religiose ed etiche che
investono la temporalità, la libertà, la responsabilità e la trascendenza, entro
cui si dischiude la comprensione dell’Altro come esperienza antepredicativa
della non-violenza e dell’amicizia intesa come reciproco riconoscimento e
rispetto di dignità dell’Io e del Tu a partire dall’altezza religiosa del Bene rivelatore e coinvolgente. Per dirla in termini lévinasiani: nell’altièrité (=maestà
della trascendenza) è da scoprire l’altèrité dell’altro.
Portarsi nell’orizzonte della scoperta e del ‘dono’ significa allentare le griglie gnoseo-ontologiche della predicazione categoriale essenzialmente legata
al principio di identità (“impresa dell’essere”) e votarsi all’incatturabile “sorpresa del volto” altrui che determina in me la sollecitudine alla custodia del fragile e dell’indifeso. Il volto umano fa trapassare la predicazione neutra dell’essere in atteggiamento fattivo nei confronti del Tu bisognoso che, nel circolo
dell’amore produttivo, include le note dell’interesse altruistico, dello zelo e del
sacrificio da parte dell’io-persona.
Dall’esistenza anonima (Dasein) di Heidegger Lévinas ha spostato sistematicamente l’attenzione all’esistente concreto con volto e nome proprio; è
trapassato dalla categoria anodina di Autrui a quella personalista di individu e
di prochain, attardandosi emblematicamente –nella considerazione di Abramo
ramingo– sul destino etico dello straniero e del nomade: personaggi che caratterizzano congenialmente la psicologia dei postmoderni in epoca di globalizzazione che accende non poche ipoteche e riserve etiche circa l’operato dei
governanti dei paesi ricchi nei confronti di quelli poveri.
Il pensiero sapienziale di Lévinas, caratterizzato da energica ispirazione
etica, può essere indagato e approfondito come critica e proposta alternativa
alle logiche del potere, supportate dal razionalismo dell’esprit bourgeoi. Fin qui
le sue tesi possono essere anche condivise. Convince meno i pregiudizio da
lui propagandato di intendere l’ontologia quale rivendicazione del principio di
identità, inteso come una sorta di legge di copertura della volontà di potenza,
dal momento che la metafisica occidentale sarebbe stata utilizzata in malafede come ideologia della sopraffazione da parte dei vincitori. Si può comprendere lo sfogo di chi ha vissuto sulla propria pelle le nefandezze del’Olocausto
ebraico ad opera dei nazisti (Lévinas ha vissuto la prigionia in un campo di
concentramento separato, oltre a perdere genitori e parenti nei forni crematori di Auschwitz), ma non si può accettare la tesi di ridurre la metafisica ad apologia della ragione di chi ha sempre… ragione. Anche se poi lo stesso autore
ammette che in Platone, ermeneuticamente accostato, non esistono due tesi
contrapposte; è piuttosto in ciascuno di noi che convivono, talora in forma conflittuale, Abramo e Ulisse: l’uno col coltello in mano, l’altro col turcasso e con
l’arco sulle spalle: ambedue contrassegnati da un destino di itineranza.
L’avventura religiosa verso l’Ignoto è superiore, a parere di Lévinas, al
viaggio di ritorno (nostos) verso la patria e gli affetti domestici. Abramo ubbidisce a Dio; Ulisse persegue il proprio desiderio di affermazione.
Su questi temi abbiamo avuto modo di riflettere, nella calura estiva del
2001, sollecitati da due volumi di alto interesse scientifico: il primo si intitola
111
Positivité et trascendence, suivi de Lévinas et la phenoménologie, (a cura di
J. L. Marion, PUF, Paris 2000). Detto volume raccoglie cinque scritti illuminanti
sul rapporto intrattenuto dall’autore con l’indirizzo fenomenologico; seguono,
poi, contributi chiarificatori di illustri studiosi che insegnano in quelle sedi accademiche che si sono onorate di avere Lévinas docente o cenferenziere:
Strasbourg, Poitier, Nanterre, Paris-Sorbone. Di questi contributi particolarmente interessanti abbiamo trovato quello di J.-Fr. Mattei, Platon et Lévinas:
au delà de l’essence (pp. 73-87) e quello di J. L. Chrétien, La traduction irreversible (pp. 309-328) sul tema del linguaggio, prospettato in una felice tensione tra senso e significato. Il secondo volume è dello studioso J. Rolland.
Strutturato in due parti, esso lumeggia anzitutto le categorie fondamentali del
pensiero lévinasiano (Je, Tu, Il, Es, Dire, Grace et Dieu), per poi addentrarsi
in quei percorsi metaforici che meglio lumeggiano le intenzioni dell’autore: da
qui il senso del titolo Parcours de l’autrement, (PUF, 2000).
112
Il volumetto contiene una breve nota di Ermanno Migliorini, pubblicata per
la prima volta nel 1984, Il paragrafo 51 della “Critica del Giudizio” Batteux e
Kant (con un’introduzione di G. Di Liberti), e inoltre sei saggi dedicati al suo
pensiero in occasione del primo anniversario della morte. Per il Migliorini, la
novità maggiore che Kant ci presenta nel § 51 della Critica del Giudizio è riposta nel partito “espressivo” che si manifesta fra espressione e comunicazione.
Luigi Russo ricorda le “fondamentali acquisizioni” propiziate da Migliorini
(p. 12), mentre G. Sertoli discute in particolare l’apprezzamento che Migliorini
compie dell’estetica inglese del Settecento. Fernando Bollino sostiene che l’indagine storiografica, non meno dell’analisi teorica e critica di Migliorini è volta
a cogliere le radici, anche le più lontane, “di un paradosso la cui drammaticità
egli vive per così dire dal di dentro e in prima persona, il paradosso di un’estetica che in quanto filosofica non può che fondarsi, storicamente, su quel
sistema delle arti che vede nella loro classificazione la risultanza più vistosa,
sistema che, tuttavia, sarà inteso e vissuto dalle arti, e dalla stessa critica,
come una ‘splendida prigione’ (p. 25).
Pietro Montani si sofferma invece sul riferimento “costante e significativo”
di Migliorini all’estetica di Kant (un tema legato quindi alla breve nota ristampata in appendice), mentre Elio Franzini si sofferma sulla “fenomenologia della
critica”. Enrico Crispolti esamina un aspetto diverso, quello in cui Migliorini si
rivela critico d’arte piuttosto che direttamente come estetologo.
Nel complesso i brevi saggi qui raccolti costituiscono, oltre che un omaggio all’illustre studioso scomparso, anche interessanti tentativi di approfondimento critico del suo pensiero estetico.
Albino Babolin
FRANÇOISE BASTIDE, Una notte con Saturno. Scritti semiotici sul discorso scientifico, Meltemi, Roma 2001, pp. 312.
Sono qui raccolti per la prima volta in volume (scelti da Beuno Latour) otto
dei numerosi saggi sul discorso scientifico scritti da Françoise Bastide, biologa e semiologa che ha fatto parte del Gruppo di ricerche semio-linguistiche
diretto da Algirdas J. Greimas. Nell’Introduzione Paolo Fabbri colloca questi
studi in quella che egli chiama la svolta semiotica: un mutamento di prospettiva focalizzato soprattutto sulla ricerca delle diverse manifestazioni del senso
attraverso vari sistemi significanti: arti figurative, scienze, letterature, ecc. Si
tratta di praticare un’analisi empirica di qualsiasi porzione della realtà significante: un’analisi testuale, vale a dire un’analisi degli intrecci e degli intrichi del
senso. Si supera in tal modo la testualità ristretta della filologia e si aprono
nuovi spazi di ricerca. L’attenzione si sposta dalla statica alla dinamica, dai sis-
RECENSIONI
AA.VV., Ermanno Migliorini e la rosa di Kant, Centro Internazionale Studi di
Estetica, Palermo 2000, pp. 88.
113
114
temi ai processi, ovvero ai modi di fare, alle azioni e ai loro soggetti che attraversando o percorrendo la rete della semiobiosfera ne collegano i vari nodi o
testi.
Nei saggi qui tradotti (da Roberto Pellerey) Bastide studia testi di Claude
Bernard, del fisiologo Homer Smith, dei fratelli Lumière, di Irène Curie e
Frédéric Joliot, il ruolo del Diavoletto di Maxwell nella fondazione della teoria
cinetica dei gas, la funzione semiotica delle immagini nella comunicazione scientifica, e i testi di divulgazione scientifica apparsi sui quotidiani francesi “Le
Monde” e “Libération”, sulla rivista scientifica britannica “Nature” e sul mensile
francese “La Recherche” a proposito della missione della sonda spaziale
Voyager I, passata nel punto più vicino a Saturno il 13 novembre 1980.
Il discorso scientifico è il discorso del “fare scienza”, del mettere in atto un
dispositivo retorico di persuasione qual è appunto un testo scientifico che si
struttura in relazione a un contro-testo a cui risponde, o di cui cerca di prevenire le obiezioni: si tratta di una strategia conflittuale e di una tattica persuasiva dove la testualizzazione è esposta ad “altro”, suo malgrado.
Colui che scrive deve «legittimare la sua competenza in quanto osservatore (ricevente) della “natura”, e anche la sua competenza come autore,
trasmettitore della rappresentazione vista». Una posizione attiva e passiva al
contempo. Per essere persuaso del valore di realtà di ciò che viene descritto
e che tuttavia non vede, il lettore «deve credere che il “garante” dell’enunciatore sia proprio “la scienza”. In questo senso ogni articolo scientifico, nella sua
globalità, è un “far credere”, mentre l’altro termine dell’alternativa è l’assenza
del garante “scienza”, oltre alla presenza di altri garanti responsabili, come
l’ambizione, che in campo scientifico può comportare la frode, ma anche l’invenzione, che porterebbe a scrivere narrazioni inventate» (p. 134).
In questo tipo di enunciazione il primo Emittente è la Natura interrogata
dallo scienziato-ricevente; la “risposta” è un oggetto visibile e accessibile allo
scienziato per la trasmissione ad altri. Si può ancora osservare –dice Bastide–
che «quando lo scienziato trasmette il suo risultato sotto forma di un articolo
pubblicato, il processo può essere descritto con la stessa formula»: lo scienziato-ricevente diventa «Ri-Emittente di un nuovo oggetto»: l’articolo per i lettori. «L’analogia non è solamente formale. Di norma non si pubblicano i risultati “grezzi”, così come escono dalle apparecchiature di registrazione. Si fanno
delle medie, si calcolano le varianti, si ricostruiscono rappresentazioni grafiche, si selezionano esperimenti “rappresentativi”, e soprattutto non si pubblicano solamente i risultati. In effetti, oltre a una descrizione dei risultati, un articolo contiene un commento (discussione), la descrizione del dispositivo posto
in opera (metodi e materiali), e una discussione sulla portata dei risultati
ottenuti in una problematica più generale (conclusione)» (pp. 222-223).
L’articolo deve fare i conti con una resistenza esterna, con i presupposti, gli
stereotipi, i significati aggiuntivi del lettore, con teorie rivali. Non ci si deve
stupire, allora, se l’autore discute gli approcci diversi dal suo, «e chiama in
aiuto quelli che gli sono compatibili, soprattutto se sono largamente
riconosciuti e costituiscono autorità» (pp. 238-239).
In questi saggi si cerca di dare conto dei diversi strati di cui è costituito il
RECENSIONI
discorso scientifico, mettendone in evidenza le relazioni ma anche le crepe
attraverso cui compare il contro-discorso.
Il discorso scientifico è un discorso sociale in cui prende vita la comunicazione scientifica e la realtà concreta della scienza, che non possono essere
considerate a prescindere dai loro attanti, ossia dalle funzioni che alcune
entità (animate o inanimate) svolgono all’interno della pratica discorsiva della
scienza stessa. In quanto discorso sociale il discorso scientifico si produce
come “ordine”, in senso foucaultiano, vale a dire come strategia di esercizio
del sapere e del potere. L’analisi del discorso scientifico è l’analisi della letteratura scientifica, ma è anche ciò che porta a distinguere la scienza dalla sua
“scientificità”, ossia da quell’idea –denunciata da Paul K. Feyerabend– secondo cui si ritiene che esistano delle caratteristiche o condizioni restrittive di
natura generale, esattamente individuabili, che un ricercatore impegnato a
produrre conoscenze deve assolutamente tenere in conto. Tutto ciò vale
anche per la semiotica in quanto metasemiosi. La “scientificità” produce una
serie di pratiche discorsive sociali o interazioni comunicative, assumendo il
ruolo di operatore semiotico, di operatore, cioè, di valore o significatività
sociale. Si pensi al ruolo della “scientificità” (connotatore sincretico di obiettività, certezza, modernità, efficienza) nella pubblicità di certi prodotti, ma anche
al “valore” (di scambio) sociale di certe professioni e indirizzi di studio.
Cosimo Caputo
115
PAUL RICOEUR, ALGIRDAS J. GREIMAS, Tra semiotica ed ermeneutica, a cura di F.
Marsciani, Meltemi, Roma 2000, pp. 96.
Vengono qui riproposti alcuni momenti che Ricoeur ha dedicato al confronto con la semiotica strutturale e in particolare con quella di Greimas. Un libro
quindi a predominanza ricoeuriana, dato che la voce di Greimas si ascolta
soltanto nel dialogo “Sulla narratività” (un dibattito svoltosi a chiusura di un colloquio sugli “Universals of Narrativity”, tenutosi al Victoria College di Toronto il
17 giugno 1984; trad. it. di A. Perri). Del resto, egli “non ha mai risposto direttamente per iscritto” a Ricoeur –nota F. Marsciani nell’Introduzione– anche se
non bisogna sottovalutare la sua dedica “à Paul Ricoeur” in testa ad un suo
importante saggio “Il contratto di veridizione”, 1983 (trad. it. in Del Senso 2,
Bompiani, Milano 1985).
Gli scritti di Ricoeur erano già apparsi in “Actes Sémiotiques-Documents”,
n. 15, EHESS e CNRS, Paris 1980: “La grammatica narrativa di Greimas”; in
Exigences et perspectives de la sémiotique, a cura di H. Parret e H.G.
Ruprecht, J. Benjamins B. V:, Amsterdam/Philadelphia 1985, voll. 2, vol. II, e
poi in Greimas, Maupassant. Esercizi di semiotica del testo, a cura di G.
Marrone, Centro Scientifico Editore, Torino 1995: “Figurazione e configurazione”; in “Nouveaux Actes Sémiotiques”, n. 7, PULIM, Limoges 1990, e in
trad. it. in “Aut Aut”, n. 252, 1992: “Tra ermeneutica e semiotica”.
116
La riflessione ricoeuriana si svolge in coincidenza, anche se in autonomia,
con Verità e metodo di Gadamer, ma in più stretta connessione con il contemporaneo affermarsi nella cultura francese delle scienze umane rispetto alla
“philosophie de l’esprit”. Ricoeur accetta la “sfida semiologica” lanciata dall’analisi strutturale delle lingue, dei fenomeni sociali e dalla psicanalisi. Tale sfida
mette in questione la centralità del soggetto come origine del senso. La linguistica strutturale è ritenuta responsabile di un oggettivismo astratto in cui la langue
prevale sulla parole, riducendo il linguaggio a un sistema chiuso e omogeneo
dove nessuno parla e nessuno risponde. Questa “linguistica anonima” trova un
complemento nella teoria sociologica della comunicazione che ha per oggetto la
circolazione dei messaggi tra un emittente e un ricevente. Il linguaggio viene qui
trattato come mero oggetto di scambio; emittente e ricevente sono ruoli costruiti sul modello dell’emittente e del ricevente fisici e la stessa comunicazione
rimane tributaria del concetto di trasmissione fisica. Manca quella che Ricoeur
chiama “intimità del dialogo”, dove il dire di uno diventa domanda rivolta all’altro
in attesa di una risposta. La linguistica strutturale e il modello informazionale
della comunicazione guadagnano la scienza –dice Ricoeur– ma perdono il rapporto con l’umano, col mondo, rapporto che va invece ripreso dalla filosofia.
Strutturalismo ed ermeneutica –insiste il filosofo francese (v. Filosofia e linguaggio, Guerini & Ass., Milano 1994, p. 70)– ridefiniscono la realtà in funzione del linguaggio, ma, mentre il primo procede a una de-cosalizzazione e
a una de-soggettivizzazione, la seconda attribuisce massima importanza al
significato e all’intenzione del testo e dell’autore del testo.
Ora, è certamente vero che la linguistica strutturale ha perseguito l’obiettivo formalista a garanzia della propria scientificità, e la glossematica hjelmsleviana ne è l’esempio paradigmatico, ma è anche vero che ciò non ne coglie
appieno la peculiarità. Di Hjelmslev, ad esempio, espressamente citato da
Ricoeur, difficilmente si prende in considerazione il pensiero partecipativo, la
materialità del segno, lo spazio che egli riserva alla valutazione/interpretazione, ci si sofferma, invece, soltanto sul suo algebrismo, secondo la più
comune “vulgata” del suo pensiero.
L’ermeneutica ricoeuriana apre un confronto con le scienze del linguaggio,
il che costituisce la sua peculiarità. In questa prospettiva, la comprensione
risulta mediata dalle procedure dell’analisi strutturale. “Spiegare” e “comprendere” non sono in una relazione di eclusione che li relega in campi diversi, né
di riduzione dell’uno all’altro, ma in una relazione di “dialettica interna”. La
semiotica di Greimas è “una variante di tale ermeneutica”; qui “la comprensione è considerata un effetto della spiegazione, senza tuttavia che la comprensione delle figurazioni di superficie perda il suo ruolo euristico” (p. 66). C’è
un rovesciamento di priorità tra spiegare e comprendere, che non comporta
però l’eliminazione del secondo da parte del primo.
La comprensione è distinta da una certa spiegazione (quella causale fisica) e non da ogni spiegazione. Comprendiamo quando siamo capaci di fornire
una “ragione di”, quando esplichiamo le “condizioni di” e non una causa
antecedente. È la spiegazione che conduce il gioco in un procedere dalla
superficie alla profondità per comprendere o riafferrare “l’operazione strut-
RECENSIONI
turante che fa ‘tenere insieme’ [o “mettere-in-intreccio”] una moltitudine di
eventi in un’unica storia” o in un racconto. L’intelligenza narrativa è quella che
penetra in una “testura”, in una rete di relazioni; è dunque “tutt’altra cosa che
una pretesa confusione o fusione emozionale di coscienza”. La comprensione
intesa come intelligenza narrativa “richiede la spiegazione, non più come suo
avversario ma come suo complemento e suo mediatore” (pp. 70-72).
La semiotica diventa così un nuovo terreno del confronto tra spiegare e
comprendere, che avviene all’interno dello stesso campo, quello dei segni, e
non più in due campi diversi: spirito e natura. Nasce da qui l’ulteriore interesse
per la semiotica di Greimas. Nel saggio del 1990 (“Tra ermeneutica e semiotica”), infatti, Ricoeur riprende quanto ha scritto ne “La grammatica narrativa”
(1980) e in Tempo e racconto II (1984), ma –dice– “a differenza di queste vecchie analisi, in cui adottavo un atteggiamento difensivo a favore dell’ermeneutica incentrata sulla comprensione e nello stesso tempo un tono polemico,
anche se moderato, nei confronti della semiotica di Greimas, vorrei utilizzare
qui quelle che allora consideravo obiezioni come una testimonianza a favore
della sinergia tra spiegare e comprendere che vedo oggi all’opera nella costituzione dei modelli greimasiani” (p. 73).
Si realizza una curvatura semiotica dell’ermeneutica, o un’ermeneutica
semiotica.
Cosimo Caputo
117
E. MATASSI, Bloch e la musica, Edizioni Marte, Salerno 2001
Il pensiero di Bloch, che parla di speranza, è ormai una voce lontana nel
tempo, inattuale e stridente con lo scenario mondiale. Eppure, sebbene ormai
le risonanze del suo pensiero nella cultura di oggi si siano affievolite, credo
che sia necessario lasciare ancora vibrare quelle lontane parole, affinché i
nostri giovani non si accontentino di sognare solo un nuovo e più potente computer o disperati cerchino nelle droghe l’ebbrezza di sogni impossibili.
Per questo è interessante il libro di Elio Matassi, Bloch e la Musica (Edizioni
Marte, Salerno 2001), che riporta alla ribalta uno dei temi fondamentali del
pensiero del filosofo tedesco: la musica. Indaga proprio laddove il suono
incanta, per ricordare e lasciare ancora vibrare l’appello blochiano a quella
tenue possibilità di individuare nella musica non solo la dispersione, ma anche
il sogno di un tutto ad-venire.
Matassi si insinua in uno dei nodi più problematici, ma anche più fecondi di
Bloch: l’apparenza e la sostanza. Stride questa distinzione che sembra rimandare a problematiche del pensiero moderno ormai sepolte dopo decenni di
decostruzione della filosofia occidentale. Oggi è ormai un pensiero comune,
radicato anche nei nostri usi e costumi, che dietro l’apparire non ci sia nulla che
saldi e fondi le apparenze: così queste, ormai libere da una ragione matrigna,
si danno senza un criterio che le distingua e le organizzi. I suoni, come appari-
118
re ed espressione che non rimandano ad una referenza certa, ma come segni
di segni, come segni dell’arte musicale disseminatrice per eccellenza, non sono
tuttavia per Bloch solo il segno del tempo lineare, e nascondono nella loro
seduzione sia la via della perdizione sia la via che conduce alla felicità.
L’autore di questo libro sulla musica in Bloch, che tra l’altro ha avuto una
menzione speciale della giuria all’Ottavo Premio internazionale di saggistica di
S. Valitutti, inizia la sua analisi proprio sottolineando l’incanto della musica e il
pericolo che essa nasconde: la storia raccontata da Ibsen e riportata dal filosofo della speranza nel suo libro Tracce mette in evidenza la capacità dei
suoni di suscitare potenze sotterranee, che dominano Lars, il protagonista
della parabola, portandolo alla dannazione. Matassi indaga proprio in questo
potere della musica e cerca di guadagnare per i nostri tempi bui di speranza
l’autenticità della musica, che Bloch chiama “seconda musica” (p. 9).
La sua indagine cerca in primo luogo di individuare la fonte a cui Bloch,
insieme ai suoi contemporanei, attinge per le considerazioni sul messianismo
nell’esperienza musicale. Così mette in evidenza il rapporto tempo-musica in
Rosenzweig che in Stern der Erlösung aveva individuato tre tempi: quello del
ritmo, quello della tonalità, che nella maggior parte dei casi si manifesta come
armonia, e quello della melodia, che, come anche Bloch indica, è il più vicino
al suono interno e singolare che genera un tempo caratteristico, inimitabile.
Questo tempo ideale e singolare si incontra e si scontra con il tempo unitario
dei molti che vivono in una società: il canto liturgico è la musica che parla di un
accordo di tutti e che “insegna agli individui a sottomettersi alla legge di un tempo
collettivo” (p.14). La melodia è invece l’altro tempo, il vero tempo musicale, che
batte e ripete il ricordo della differenza, rompendo la dimensione temporale della
realtà e aprendo all’annullamento di sé non verso il presente, ma verso il sogno.
Matassi passa poi a considerare il nesso musica e redenzione come è stato
trattato da Benjamin giovane negli scritti sul Trauerspiel e la tragedia: qui veniva, infatti, evidenziato il primato estetico e messianico della musica, capace di
andare oltre l’apparenza e il visibile. La tragedia per Benjamin evoca il lutto, ma
la commozione che accompagna il lutto indica anche la via per la redenzione.
La musica, come l’arte meno compromessa dall’apparenza, riesce a dilatare il
lutto attraverso il lamento fino ad aprire la via del riscatto, proprio laddove porta
ad estinzione la bella apparenza: la commozione, quando è autentica, diventa
il momento in cui la bellezza si spegne per accedere al sublime (pp. 22-23).
In quegli stessi anni anche Bloch –sottolinea il nostro autore– inizia ad
esaltare la musica come essa è sorta nella modernità (p. 26), quando, perduta la chiaroveggenza, solo il suono è riuscito ad andare ai margini del visibile;
infatti esso non rimanda al visto, come troppo spesso il linguaggio delle parole, ma al mistero, che vibra nella musica e può risuonare nei suoni che l’uomo
produce rispondendo a quel suono misterioso irriproducibile che aveva fatto
impazzire Lars nel racconto di Ibsen. La musica umana ha così la capacità di
coniugare l’esterno con l’interno, e Matassi sottolinea che riesce ad unire
insieme sentimento, commozione e mistero. Questo non vuol essere un’esaltazione del “cascame romantico”, che Bloch stesso scarta, ma dell’eredità
della fase classica del romanticismo (p. 28).
RECENSIONI
In questo libro Matassi, che già aveva affrontato in altri lavori i temi della
musica in Bloch sottolineando le differenze tra la prima e la seconda edizione
del Geist der Utopie, affronta qui oltre al tema del legame tempo-musica, anche
il rapporto tempo e spazio come viene trattato nei riferimenti alla musica presenti nell’opera blochiana della maturità, per tornare poi a considerare i temi
giovanili sulla musica in una nuova prospettiva. Lo spazio e il tempo non sono
naturalmente l’orizzonte in cui si danno le cose sensibili, ovvero non è ad esso
che Bloch guarda. Egli inoltre, facendo riferimento alla fisica di Riemann, non
prende in considerazione lo spazio delle geometrie tridimensionali, quello della
fisica classica che lo opponeva al tempo, ma guarda all’incrocio del tempo con
lo spazio. Matassi mette così in evidenza quel “fermarsi”, così importante nella
musica, che il filosofo della speranza indica come la figura del ritorno in patria:
lo spazio emerge proprio là dove il tempo si ferma, in quel contra-tempo che
taglia verticalmente lo scorrere temporale, nell’attimo adempiuto
dell’Anagnorisis: “Temporalità utopica della soggettività e dimensione spaziale
della musica trovano un fecondo punto di incontro in quei momenti in cui il
tempo assolve ad una funzione peculiare: quella di fermarsi” (p.30). La musica,
aggiunge così l’autore del libro, è l’unico luogo dove si esprime quell’attimo che
diventa anche spazio, così egli passa ad esaminare il große Augenblick nelle
grandi opere o sinfonie dove dal forte si passa all’adagio allargando il tempo: in
questo modo la musica si fa annuncio della redenzione. La musica spaziale è,
quindi, solo “un diverso atteggiarsi della specifica temporalità musicale” (p. 36).
Dopo questa puntualizzazione sul problema spazio-tempo che Bloch ha
messo in evidenza in Experimentum mundi, Matassi ritorna a cercare di chiarire
cosa possa essere quella “seconda musica”, di cui Bloch parla nel Geist. Così
mette in evidenza che non solo il tempo della musica è diverso dal tempo esterno, quello della società collettiva, ma non è univoco neanche in se stesso. Il carattere ex-centrico della musica, il fatto che essa possa esprimere anche dissonanze vaganti sono l’indice della possibilità di un contro-movimento. Anche la musica
atonale, che sembra totalmente anarchica va alla ricerca di un punto finale.
Proprio per questo il suono, benché sia interiorità pura, esige un approdo che può
avere un effetto storico all’esterno. Quello che preme a Matassi è proprio far emergere, nella concezione della musica blochiana, questo nesso tra musica e storia;
sottolinea così che questa potrebbe essere la sua dimensione più profonda (p. 43).
Passiamo ad esaminare le pagine dove Matassi tratta della seconda musica, per vedere se e come la musica possa essere la via privilegiata per accedere alla verità seconda. Bloch, infatti, non è interessato alla verità come adeguazione della proposizione alla cosa della realtà definita, non è interessato
più di tanto alla verità prima, quella che insegue Heidegger alla ricerca del
luogo che apre il mondo, di quella verità che dis-vela tracciando i confini tra
il nostro mondo e il mistero. Mi sembrano così interessanti le pagine di questo libro che prendono in considerazione, all’interno della concezione blochiana della musica, il problema del nesso suono-parola. A riguardo Matassi
non si dilunga a discutere se venga prima la parola o il suono, secondo i
canoni classici in cui si è tramandata questa antica querelle, quanto piuttosto
a mettere in evidenza la via che porta all’integrazione biunivoca di entrambi.
119
120
Egli si rifà agli studi di Leo Popper, amico di Lukács, che dedica proprio a lui
il suo libro L’anima e le forme. Il tentativo del nostro autore è da una parte
ricostruire le concezioni dell’epoca su questa antica disputa per comprendere meglio il terreno in cui si è mosso Bloch, da un’altra parte il suo scopo è di
esaminare se quei brevi stralci di concezioni così vicine al filosofo della speranza riescano a portare luce nelle pagine spesso oscure del Geist.
Ed è Popper –secondo le considerazioni di Matassi– che riporta il problema del nesso suono e parola totalmente all’interno della musica, guardando
non tanto alla loro distinzione o alla supremazia dell’uno o dell’altra, quanto
piuttosto alla fecondità della loro differenza e il Lied diventa così la loro amorosa unione, il loro atto d’amore (p. 47). E in questo contesto emerge la grandiosità dell’interpretazione blochiana che distingue tra un Lied aperto e uno
chiuso, a seconda se prevalgano le emozioni limitate oppure l’infinita melodia
scatenata delle grandi opere corali, quella Ereignis-Form che si avvicina alla
musica assoluta (p. 49). Il tema delle sonate mozartiane ritorna felice e sensuale in tutte le esposizioni, che quindi svolgono un tempo strutturato: esse,
quindi non generano un tempo aperto. Se Bach spesso in un quadro lucido
organizza le sue cantate, tuttavia in alcuni punti “i suoni più agiati sono liberi
per la meditazione lirica” (p. 53), e così il corale esprime il senso di una comunità più elevata di quella della banale collettività e del tempo del sociale come
è stato raggiunto finora. Il Fidelio beethoveniano poi è il luogo per Bloch più
proprio del Lied aperto, dove la temporalità non è più neanche melodica, ma
melismatica: questa è una musica al limite, una musica che “non accompagnando le parole e le azioni, le genera essa stessa” (p. 54). Così, mette in rilievo Matassi, una tale musica non si può adeguare ad un disegno drammaturgico precedente ed non può sopportare una forma poetica precostituita; il
suono infatti presume sempre un’eccedenza rispetto alla parola.
L’intento del libro –a mio avviso– è comunque quello indicato nelle prime pagine: il tema dell’incantamento della musica e della via da seguire per uscire dall’illusione estetica. E questo cuore dell’opera blochiana torna a pulsare intensivamente nelle ultime pagine, quando Matassi ricorda che le immagini estetiche per
Bloch sono isole dipinte su un vetro, il cui splendore è solo virtuale, e ricorda l’appello blochiano che dietro il vetro si possono intravedere “le utopiche terre del
significato” (p. 64). Il grembo della musica, come materia ultima dell’anima e della
latenza del Sé, continua a partorire utopicamente: per questo dietro l’apparire non
c’è una sostanza velleitaria, ma l’anticipazione di un’essenza che è da venire.
Le ultime pagine del libro sono, quindi, dedicate all’ascolto, all’appello di
Bloch a sintonizzarci su quel suono che pur vibra in noi, quantunque esso
nella vita quotidiana si disperda. Il suono interno, il silenzio indicibile –sottolinea Matassi– rimane muto se non risuonerà nella vita umana.
L’interiorizzazione dell’ascolto non porta una chiusura al mondo degli altri, non
è solo un tempo dissonante con il tempo della collettività. Anzi viene sottolineata la paradossalità della comunità che emerge dalla musica, una comunità ottimale che si consegue “non al prezzo del sacrificio dell’interiorità ma addirittura a partire da una sua enfatizzazione” (p. 68).
Per questo Matassi conclude che l’estetica blochiana pur passando per il
Patrizia Cipolletta
V. PEREGO, Finitezza e libertà. Heidegger interprete di Kant, Vita e Pensiero,
Milano 2001, pp. 231.
La determinazione della portata metodica e speculativa del sempre essenziale e continuo “dialogo” di Heidegger con il pensiero di Kant è certo una delle
vie privilegiate per determinare sia la vera portata e novità del pensiero di
Heidegger stesso, sia per meglio chiarire e interpretare i concetti fondamentali
ed il linguaggio tipici di Heidegger. E il tema specifico scelto dall’A., il rapporto “finitezza”-“libertà”, è di per sé uno dei temi più avvincenti ed irrinunziabili
del pensiero filosofico in generale, ed oggi di grande attualità.
Giustamente l’A. rileva “come Kant sia stato l’interlocutore privilegiato nella
fase decisiva in cui Heidegger elabora il progetto di un’ontologia fondamentale”, e quindi spetti ai suoi interpreti porre grande attenzione alla sua portata ed
influenza nel comprendere sviluppi e senso complessivo del pensiero heideggeriano. Il presente studio ha lo scopo di “mettere in luce in quali luoghi della
riflessione di Heidegger la filosofia kantiana sia stata una fonte primaria” (p.
13). Esso abbraccia pressoché tutta la riflessione heideggeriana da Essere e
tempo ai Beiträge.
Anche in questo suo aspetto il pensiero di Heidegger è fedele alla radicalità di indagine che lo caratterizza: la ricerca della “dimensione originaria”, che
in questa prospettiva è quella del “rapporto teorico-pratico”, illustrato nella
prima parte del testo e rapportato a quello emergente dalla considerazione
kantiana della soggettività, cioè dalla determinazione del rapporto in Kant fra
“ragione pura” teoretica e pratica.
Viene così introdotto lo studio del “problema della finitezza” in Kant e parallelamente in Heidegger il suo rapporto col Mit-sein heideggeriano e il confronto del sentimento kantiano del Sublime con l’angoscia heideggeriana.
Nella terza parte della ricerca viene indagato il procedere della riflessione
heideggeriana sulla libertà, sempre da Essere e tempo ai Beiträge. Essa
costituisce in Kant una “evidenza morale” imprescindibile, che si estende alla
sua visione finalistica del mondo tramite la libertà del giudizio “riflettente”; e
tende a risolvere il contrasto fra una concezione bensì oggettiva, ma meccanicistica degli eventi, e le esigenze morali dell’ “Io peso” come soggettività
cosciente e responsabile.
Essere e tempo pone bensì l’individuo empiricamente condizionato, come
corporeità, dalle leggi causali dell’universo fisico e psichico, ma in quanto soggetto moralmente responsabile portatore dell’imperativo etico, capace di superare i condizionamenti della sua “finitezza” ontologica e di esercitare quella
RECENSIONI
piacere si nega ad esso: la musica non può essere solo dispersione e incantamento. Tuttavia quella di Bloch –sottolinea il nostro autore– negandosi al piacere, non insegue un’estetica della negatività come quella di Adorno, perché la
musica per lui può riuscire a far emergere quel Grund utopico che è in ognuno.
121
122
“libera scelta” che è secondo la legge del Dovere ed è anche garanzia di capacità di distinguere verità ed errore.
I due capitoli conclusivi della ricerca di Perego sono perciò coerentemente
dedicati alla “coappartenenza di libertà e verità” e alla “decisione” nei Beiträge.
L’assolutezza “potenziale” della libertà di scelta si riflette sia nell’attività conoscitiva, come capacità di discernere, e preferire, la verità all’errore, che in quella pratica, come possibilità (meritoria, quindi implicante il postulato dell’immortalità del soggetto morale). Essa permette anche di aprire la strada a una considerazione “finalistica” della natura e alla filosofia kantiana della religione “nei
limiti della semplice ragione”.
L’A. quindi sottolinea giustamente la novità terminologica introdotta nei
Beiträge da Heidegger. La decisione, posta in Sein und Zeit nella prospettiva antropologica e soggettiva (come Entschlossenheit (risoluzione), viene
ora designata Entscheidung, mutamento a partire dal senso dell’esserci e
coinvolgente l’essere stesso del decidente sin dalla sua prima radice in
modo tale da dar senso nuovo e diverso a tutto l’esistere a partire della “verità dell’essere”. Così “Heidegger afferma che l’Esserci, in quanto esistente,
in quanto appartiene originariamente alla verità, è condizione del dispiegarsi e manifestarsi della essenza della verità dell’essere” e che l’ “ipseità” del
soggetto non è risultato dell’autoriconoscersi dell’io, “ma è il soggetto stesso che si comprende come intenzionato” (p. 205). La sua “chiamata” all’esserci è prodotta dal suo destinarsi alla verità dell’Essere, ed è opera
dell’Essere stesso. L’uomo diviene così il “luogo” essenziale del rivelarsi
della verità dell’essere, la cui verità è fondamento della sua libertà. La finitezza è allora condizione dell’appartenenza del soggetto alla verità dell’essere come “luogo” del suo manifestarsi e quindi anche del suo liberarsi conformemente a questa sua originaria verità. E la verità stessa dell’essere è
“libertà”, in quanto Esso si lascia coinvolgere dall’ente, come da “ciò che è
aperto” (p. 177). La finitezza ontologica dell’ente è condizione quindi del suo
partecipare alla libertà dell’essere.
Ciò tuttavia, come bene nota l’A., è il destinarsi alla verità del soggetto
umano per essere “luogo” della libertà dell’Essere, implica “in Heidegger il
rischio di un superamento della distinzione fra esperienza effettiva e riflessione e, di conseguenza, della radice ontica dell’ontologia” (p. 212).
Lo studio di Perego, ben documentato e sorretto da chiarezza di analisi e
riflessione, già dal confronto Kant-Heidegger, effettivamente molto significativo e continuo, affronta i nodi più delicati dell’interpretazione heideggeriana. Ci
auguriamo quindi che l’A. estenda la sua indagine ad altre prospettive di confronto, quali quello con Aristotele (da cui l’ultimo Heidegger trae la preferenza
del logo “semantico” rispetto a quello “apofantico”) e con Hegel e Nietzsche.
Certo il susseguirsi e sovrapporsi di tali confronti dimostra da un lato il grande
impegno heideggeriano di un assiduo dialogo con i luoghi decisivi della storia
della metafisica, e d’altro canto rende complessa e sempre non totalmente
conclusa l’indagine sul pensiero di Heidegger stesso, pure ormai scandito dai
suoi principali discepoli e interpreti in varie “fasi”. Tuttavia la ben nota esistenza di centinaia di studi e di opposte interpretazioni ha ormai consacrato la
Giancarlo Penati
L. DI PINTO, Il respiro della filosofia in Edith Stein, Laterza, Bari 1999.
La compatrona d’Europa, una donna eccezionale, una coraggiosa crocerossina di guerra, la fenomenologa prediletta da Edmund Husserl, una brillante psicologa della società e della comunità, una raffinata filosofa della scienza, un’esperta logica: questi sono solo alcuni dei tanti appellativi che nel volume di Luigia Di Pinto delineano la poliedrica figura di Edith Stein.
Sette appellativi perché sette sono per la Stein le stanze concentriche di
quel castello interiore che simbolizza l’anima di ciascuna persona umana nel
cui nucleo più profondo palpita la spiritualità; perché sette sono le ragioni del
suo divergere dal maestro Husserl; sette perché tante sono le pause di riflessione che nella seconda parte del volume scandiscono l’appropriazione personale del cammino speculativo di Edith Stein da parte della Di Pinto. Dalla
psicologia (pp. 233-277) all’antropologia (pp. 279-298), dall’etica della differenza (pp. 299-329) alla semiotica (pp. 201-210 e pp. 350-369), dalla politica
(pp. 98-107) alla pedagogia eucaristica (pp. 95-97), dalle scienze della natura
(pp. 197-232) alla mistica (pp. 331-375). Quest’ultimo binomio può sembrare
sorprendente, ma è proprio così! Edith Stein, una pensatrice nota soprattutto
come mistica, nella monografia della Di Pinto mostra un’inedita e sedimentata conoscenza della fisica del suo tempo. Nell’opera Introduzione alla filosofia,
ultimata un anno prima di entrare con gioia e piena consapevolezza nell’ordine di clausura del Carmelo, la Stein attacca senza mezzi termini il mito dell’economia del pensare di E. Mach (pp. 216-219) così come si configura nella
teoria della relatività ristretta di A. Einstein (pp. 210-216), dichiarandosi a favore della meccanica quantistica di Carl Max Planck (pp. 205-208). Tuttavia la
Stein non ridimensiona solo l’insensato ed autodistruttivo positivismo delle
scienze cosiddette esatte, che tra l’altro conosce bene e fino ad un certo punto
sa apprezzare con misura. Ella individua con criticità anche valore e limiti delle
scienze umane, in particolare rivolge la sua attenzione verso la psicologia,
anzi le psicologie. Potendo contare su una solida competenza psicologica,
maturata e nutrita nel rapporto culturale con lo psicologo L. W. Stern e soprattutto con Husserl (pp. 72-95), la Stein critica l’uso improprio ed “industrializzato” della psicologia sperimentale di W. Wundt (pp. 244-252) così come si configura nei tests della psicotecnica di H. Münsterberg (pp. 271-277) e propone
di disvelare nelle analisi psicologiche della persona anche il respiro della spiritualità, il nucleo più profondo (pp. 333-375) della psiche di ciascuno di noi.
“Non siamo solo dotati di ragione calcolante. Abbiamo anche una spiritualità”
dalla quale zampilla la nostra forza vitale spirituale-creativa, una forza vitale
RECENSIONI
grandezza e importanza speculativa del pensiero heideggeriano e la sua
valenza di una sorta di “reinizio” del pensiero filosofico (e teologico) e di un
mutamento di mente e di problematica ben diverso dalla sua liquidazione
“nichilistica” e pragmatico-esistenziale.
123
che consente di trovare il coraggio di realizzare una metamorfosi, una seconda nascita ogni qualvolta nella vita ci ritroviamo ad un bivio e dobbiamo esercitare una difficile scelta esistenziale. Così questa poliedrica Penelope cristiana ha combattuto la logica di dominio e violenza del suo tempo. Non solo
impegnandosi in un partito democratrico e schierandosi in favore dei diritti
delle donne, come si può vedere nei saggi e nelle conferenze raccolte del suo
famosissimo libro intitolato La donna. Per di più ella ha sempre praticato l’empatia, nell’insegnamento universitario e nel suo impegno nel sociale, continuando a restare “una donna in piedi che nessun totalitarismo è riuscita a
spezzare” e che nessuna presunta o apparente democrazia riuscirà mai ad
adombrare tacendo il suo nome nei manuali di storia della filosfia. Questo interessante volume che la Di Pinto ha dedicato alla compatrona d’Europa si apre
con un’autorevole Prefazione di Angela Ales Bello, la fenomenologa che ha
reso noto in Italia il pensiero della Stein.
Anna Valente
124
PUBBLICAZIONI RICEVUTE DA «SEGNI E COMPRENSIONE»
(oltre quelle recensite nella rivista)
Volumi:
A. ARDOVINO, Il sensibile e il razionale. Schiller e la mediazione estetica,
Palermo, Centro Internazionale Studi di Estetica, 2001, pp.74;
F. BIANCO, G. MATTEUCCI, E. MATASSI (a cura di), Dilthey e l’esperienza della
poesia, Palermo, Centro Internazionale di Estetica, 2001, pp. 66;
A. CAPUTO, Mente intenzionalità percezione in Husserl, Foggia, bastoni, 2001,
pp.172;
A. CARLINO, Realtà tra storia e mito, Lecce, Adriatica Salentina, 2001, pp.136;
F. DE NATALE, Tra ethos e oikos. Studi su Husserl, Heidegger e Jonas, Bari,
palomar, 2001, pp.172;
M. DIURISI D’AGOSTINO, A teatro con Agata Christie nel regno di Anmenhotep
IV, Lecce, Adriatica Salentina, 2001, pp. 368;
P. FARINA, Simone Weil. La ragionevole follia d’amore, Teramo, Prospettiva
Persona, 2000, pp.174;
R. HESS, La pratica del diario, Nardò, Besa, 2001, pp. 186;
G. LAMPIS, Una religione dell’atto cruento. I misteri di Mihtra, Roma, Mythos, pp.
96;
F. LEONI, Follia come scrittura di mondo, Milano, Jaca Book, 2001, pp.190;
S. MANCINI, Sempre di nuovo. Merleau-Ponty e la dialettica dell’espressione,
Milano, Mimesis, 2001, pp. 320;
C. MEAZZA, Tra passi di Heidegger e «gli antichi scolastici», Pisa, Ets, 2001,
pp.326;
A. MARTONE, Un’etica del Nulla, Napoli, Liguori, 2001, pp.252;
R. MESSORI, Le forme dell’apparire. Estetica, erm,eneutica e umanesimo nel pensiero di E. Grassi, Palermo, Centro Internazionale Studi di Estetica, 2001, pp.235;
A. MONTANO, Il guaritore ferito, Napoli, Metis, 2001, pp.82;
F. NIETZSCHE, Scritti giovanili 1865-1869, a c. di G. Campioni e M. Carpitella,
Milano,Adelphi, 2001, pp. 780;
A. SANTUCCI (a cura di), Filosofia e cultura nel Settecento britannico, 2 voll.,
Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 472, 526;
J.-P. SARTRE, Spaesamento. Napoli e Capri, a c. di A,Montano, Napoli, Libreria
Dante & Descartes, 2000, pp.70;
F. SEMERARI, Relazioni morali. Forme e problemi, Bari, Adriatica, 2001, pp.
125
254;
M. SERRES, Chiarimenti. Cinque conversazioni con Bruno Latour, a c. di M.
Castellana, Mandria, Barbieri, 2001, pp.238;
G. STRUMMIELLO, Il logos violato. La violenza nella filosofia, Bari, Dedalo, 2001,
pp.406;
F. SULPIZIO (a cura di), Studi cartesiani, Atti, Lecce, Milella, 2000, pp.398;
C. TUGNOLI, Girad. Dal mito ai vangeli, Padova, Messaggero, 2001, pp.270;
P. I. VERGINE, Bibliographia antiqua lupiensis, Galatina, Congedo, 2001,
pp.308;
L. ZA, Comunità memoria sviluppo, Lecce, Pensa, 2001, 208;
Periodici:
126
Acta philosophica, v.10, f. I, 2001;
Aquinas, XLIII, n.3, 2000;
Atti delle «celebrazioni del bicentenario della geo-astrofisica kantiana 17971997» e Annali del
Dipartimento di Scienze storiche filosofiche e geografiche, Università di Lecce,
v. XII, 1999-2000;
Cahiers du centre Interdisciplinare des Sciences du Langage, n.15, 2000;
Cuadernos del Pensamiento Latinoamericano, n.8, 2000;
Dianoia, a. V, dicembre 2000;
Economia e società, n.1, maggio 2001;
Fonti e documenti, Centro studi per la storia del Modernismo, n. 28-30, 19992001;
Giornale di Metafisica, a. XXI, n. 1-2, n. 3, 1999;
Hermeneutica, n.s., 2001: Domande di etica;
Idee, n. 46-47, 2001;
Il Contributo, n. 1-2, 2000;
Itinerari, n. 1, 2001;
L’immaginale, a. XVII, n.30, aprile 2001;
Le Carte, n. 4-5, 2001;
Notes et documents, Inst. Int. Jacques Maritain, a.XXIV, n.59;
Oltrecorrente, marzo 2001;
Paradigmi, n.55, 2001: Filosofia come inizio e come progetto;
Recherches husserliennes, v. 14, 2000; v. 15, 2001;
Rinascita della scuola, a.XXV, n. 2; n. 3-4, 2001;
Rivista di filosofia, a. XCII, n. 1; n. 2, 2001;
Uomini e idee, n. 8, 2000;
VIA, Voices in Italian Americana, v. 12, spring 2001, n.1;
Manni Editori
N O V I T À
Raffaele La Capria
Me visto da lui stesso
pp. 208, t 13,00
Raffaele La Capria parlando di sé riesce spesso a raccontare il complessivo contesto
culturale italiano, cerca e scova intelligenti consonanze con esso, descrivendo
passaggi fondamentali della sua generazione.
Sinora questa attitudine autocommentativa si era rivelata soprattutto nella scrittura.
La scrittura chiamava altra scrittura. In questo nuovo libro, invece, è la sua stessa
voce che ci arriva direttamente e ripercorre, sollecitata da alcuni interlocutori, la
propria vicenda, come in un racconto a puntate.
Raffaele La Capria è nato a Napoli nel 1922. Dagli anni Cinquanta vive a Roma,
dove ha lavorato a lungo alla Rai. Con la sua città natale ha da sempre avuto un
“poetico litigio”.Nel 1961 ha vinto il Premio Strega con Ferito a morte.
Romano Luperini
I salici sono piante acquatiche
pp. 144, t 13,00 (L. 25 .172)
Questo libro affronta con spregiudicatezza e senza inibizioni i nodi culturali e politici
del secolo ventesimo.
È il romanzo autobiografico di un intellettuale che non concede nulla al cursus
honorum e alla parte pubblico-istituzionale.
La vita è narrata invece in presa diretta come è stata vissuta, con immediatezza ed
emozione.
È il romanzo storico che, attraverso il contrasto fra un padre e un figlio, ripercorre il
Novecento dalla guerra partigiana e dalla contestazione del ’68 all’assassinio di Moro,
alla crisi delle ideologie, dal premoderno delle campagne toscane negli anni Trenta alla
modernità delle metropoli (Parigi, Roma), sino al postmoderno degli iperspazi e della
iperfolla nordamericani.
È il romanzo sulla contraddizione antropologica fra maschile e femminile, sul senso
della morte e della vita.
Ma è soprattutto un romanzo-testamento: insieme al bilancio individuale c’è quello
di una generazione intera che qui riconsidera le proprie speranze e delusioni.
Romano Luperini insegna Letteratura italiana all’Università di Siena. È autore di
numerosi saggi di critica letteraria e di un noto manuale per le scuole.
È stato anche militante e dirigente politico, e si è occupato di problemi sociologici e
politico-culturali.
127
Stampa: Tiemme - Manduria
nell’aprile 2002
per conto di Piero Manni s.r.l.
128