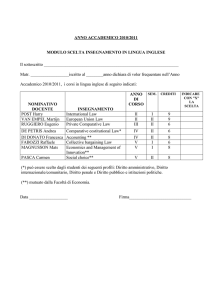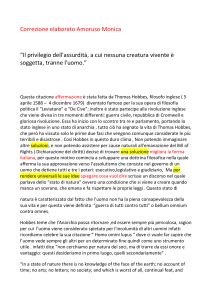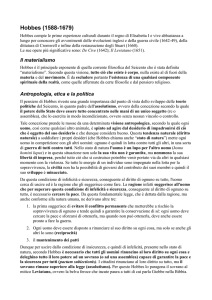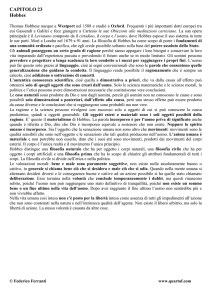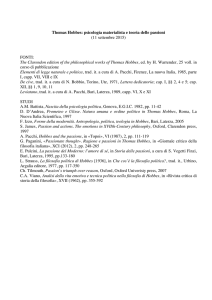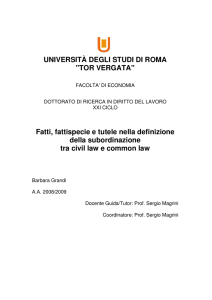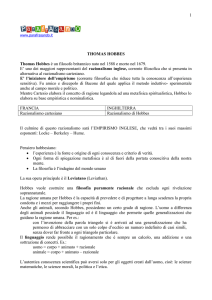Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali
Dipartimento di Filosofia
Dottorato di Ricerca in Filosofia – XXIV ciclo
Coordinatore
Prof. Virginio Marzocchi
Curriculum
Filosofia: Ricerche Teorico-Storiche
SSD M-FIL/01
Categorie giuridiche e ordine politico in Hobbes
Supervisori
Prof. Mario Reale
Prof. Stefano Petrucciani
Dottorando
Camila Perea Rojas
Matricola n° 983379
Anno Accademico 2010/2011
INDICE
Introduzione
2
PARTE PRIMA
Il contesto storico-scientifico del paradigma hobbessiano
I.
La rottura dell’armonia. Diritto e Rivoluzione nella storia inglese tra
Cinquecento e Seicento
II.
10
Il miracolo del sistema di common law.Elementi preliminari di storia del
diritto inglese
III.
40
Tra custom e reason.Voci della filosofia del diritto nel mondo di common
law
103
PARTE SECONDA
Il diritto e la metodologia logico-formale nella filosofia di Hobbes
I.
In controluce. La questione del diritto in Hobbes attraverso la critica di Hale
142
II.
Dal metodo geometrico al metodo giuridico. Un’inversione di prospettiva
164
Bibliografia
213
1
Introduzione
La ricerca che viene qui introdotta è il risultato di un lungo confronto con l’opera di
Hobbes, in particolare con le categorie giuridiche che operano all’interno della sua
riflessione filosofica.
La nostra attenzione si è progressivamente concentrata intorno a questo aspetto – che a
confronto di altri ha senz’altro ricevuto meno attenzione da parte degli studiosi – non
senza un motivo preciso, che è lo stesso per cui, a nostro avviso, risultano ancora oggi
stimolanti le letture che del filosofo inglese hanno dato interpreti quali Macpherson e
Schmitt: la volontà di uscire dal cupo cono d’ombra entro il quale è finito per
fossilizzarsi un pensiero che, se osservato nel vivo, mostra innumerevoli sfaccettature,
oscillazioni, tentennamenti, ma soprattutto dimostra essere impegno e sforzo costruttivo,
prima ancora che compiuto sistema e paradigma.
Sia detto per inciso, o anche come semplice curiosità, che proprio negli scritti su Hobbes
dello studioso tedesco si può rinvenire lo spunto che ha rappresentato la scintilla di
questa indagine: l’affermazione secondo la quale il filosofo inglese era interessato a
superare l’anarchia del diritto di resistenza feudale, cetuale o ecclesiastico.
Nel nostro caso non si tratta di restituire un “nuovo” Hobbes, come si è voluto tentar di
fare, anche in tempi recenti, dopo l’attribuzione all’autore di un’opera pubblicata
anonima nel 1620, (nella quale, tra l’altro, vi è contenuto un Discourse of Lawes che
2
sarebbe stato certo rilevante per la nostra analisi, ma condividiamo il giudizio di Perez
Zagorin e riteniamo che il suo contenuto difficilmente possa essere frutto della mente del
nostro).
L’intenzione è stata piuttosto quella di mettere a punto una linea di lettura che
consentisse l’acceso alla peculiarità di una costellazione di concetti all’interno della
quale i momenti forti del progetto hobbesiano – assolutismo, pessimismo antropologico,
positivismo giuridico, per citarne solo tre –
rivelano possedere confini flessibili e
porosi.
Tale scopo è stato realizzato estendendo il raggio d’azione dell’analisi non solo ai tre
grandi trattati politici, Elements of Law, De Cive e Leviathan, ma anche addentrandoci in
opere meno battute come il De Corpore, lo stesso De Homine e, primo tra tutti, il
Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of England.
Accompagnati lungo la via di ricerca dal contenuto di quest’ultimo in particolare, lo
sguardo si è rivolto indietro, soffermandosi in maniera insistente e particolareggiata,
forse anche eccessiva, ma siamo convinti non ingiustificata, in direzione dell’orizzonte
storico-politico dal quale è sorto il modello giuspolitico hobbesiano.
Dalla lettura del Dialogue emergeva infatti una critica complessiva – la prima in verità
– al modello di common law, la crisi del quale costituisce uno dei livelli cruciali su cui si
è articolato il cedimento sistemico avvenuto in Inghilterra nel passaggio dal ‘500 al ‘600.
Proprio da qui abbiamo deciso dunque di prendere le mosse per la nostra analisi,
convinti e consapevoli del fatto che in ogni pagina della sua opera, Hobbes abbia a
3
mente il venir meno dell’efficacia dei meccanismi giuridici e politici regolatori degli
interessi nel suo paese.
Non intendiamo far riferimento tanto alla circostanza, puntuale quanto ovvia, per cui la
composizione del De Cive è stata sollecitata dal dibattito sulla Shipmoney, o ad altro
ancora che di questo tenore si potrebbe affermare, ma piuttosto a qualcosa di ben più
strutturale ed essenziale: al fatto che Hobbes sia testimone del punto massimo di rottura
di un’armonia sociopolitica che non sembrava più in grado di ricomporsi da sé.
Riportiamo, a modo di esempio, uno specifico passaggio dell’analisi per tentare di
indicare meglio il senso complessivo nonché quello di alcuni dei momenti di questa
prima sezione.
Dall’analisi del fenomeno delle recinzioni emerge, a nostro parere, una dinamica di
fondo: mutate condizioni economiche spinsero verso un accentramento guidato da una
razionalità individualista che richiedeva una nuova configurazione di diritti. L’intera
questione è per molti versi riconducibile al problema del passaggio dall’uso alla
proprietà, nel caso specifico dal precedente uso, in parte comune, della terra alla
proprietà privata piena, tema fondamentale nel dibattito costituzionale del Seicento sul
piano giuridico e uno dei nodi centrali del pensiero hobbesiano sul piano del potere.
Nella sua tarda fatica sul diritto, Hobbes si riferisce costantemente e in modo
estremamente dettagliato a corti, procedure, statuti, delitti e pene; citava Selden,
Lambarde, e naturalmente Coke, il bersaglio principale.
4
La sua argomentazione faceva i conti con un mondo giuridico che ci è sembrato dunque
non solo degno di attenzione, ma ci è apparso anche e in qualche modo come un’ampia e
dettagliata mappa nella quale era possibile ritrovare e leggere in filigrana la trama di un
assetto che, già gravemente indebolito, avrebbe subito gli ulteriori colpi da Hobbes
inferti, prima di conoscere una rinnovata vitalità nei secoli successivi.
Il proposito di tenere insieme la prospettiva storica e teoretica ci ha quindi
inevitabilmente e necessariamente condotto anche al tentativo di ricostruzione del
retroterra scientifico-giuridico al quale attinge e nel quale si innesta la riflessione
giuspolitica hobbesiana.
Anche in questo caso il limite del regressus è stato spostato all’indietro, fino alla
riflessione di Saint German, dalla quale si prendono le mosse per percorrere un cammino
simile e parallelo al precedente, che giunge gradualmente fino a Selden, autore
riconosciuto e per molti aspetti anche assai apprezzato dallo stesso Hobbes.
Ciò che in questo caso si cercherà di ascoltare e far risuonare saranno le diverse voci di
una tradizione composita e sfaccettata, nella quale è possibile intravedere, a nostro
giudizio, innovazioni ed elementi conservativi di un paradigma embrionale che vedremo
poi delinearsi in maniera peculiare in Hobbes.
Avvaliamoci del giudizio di un autorevole medievalista e storico del diritto canonico per
introdurre il contenuto della seconda parte della nostra indagine, la quale procede verso
l’analisi testuale lasciandosi alle spalle questo lavoro archeologico.
5
Brian Tierney ha sostenuto nel suo importante libro The Idea of Natural Rights: Studies
on Natural Rights, Natural Law and Church Law, 1150-1625, che “il tentativo compiuto
da Hobbes di mettere insieme alcuni frammenti della dottrina medievale del diritto
naturale con la sua visione del mondo radicalmente differente, produsse delle incoerenze
fra le diverse branche del suo pensiero e delle debolezze all’interno dei suoi stessi scritti
politici”; con questa affermazione si potrebbe anche parzialmente concordare, sempre
che si tralasci un’intonazione del discorso che sembra valutare l’intento hobbesiano
come uno spregiudicato assemblaggio di elementi della tradizione medievale.
Tuttavia, rovesciando proprio questa sfumatura, ci sentiamo di affermare che, proprio
perché intento a rendere conto di una visione del mondo da costruirsi interamente nella
frattura dell’ordinato e armonico cosmo medievale, Hobbes si trovò a rifondare il
linguaggio preesistente, e ciò tentò di realizzare con tutte le contraddizioni e le aporie
che poteva comportare questa tragica operazione.
È dunque vero, seppur in parte, che egli prova ad agire nel regno del linguaggio come il
suo sovrano assoluto agisce nel mondo della politica, con una sorta di approccio
semantico à la Humpty Dumpty1: ma dal momento in cui conserva una terminologia
Sappiamo che le introduzioni non gradiscono le note, ma questa ci è particolarmente cara. Nell’articolo
intitolato Natural Law and Natural Rights. Old Problems and Recent Approaches, comparso in “The
Review of Politics”, n. 64, vol. 3, 2002, Tierney riporta le parole dello Humpty Dumpty di Carroll: “When
I use a word, it means just what I choose it to mean”. Potrebbe sembrare un divertissement letterario
invocare in maniera seria quel meraviglioso resoconto del nominalismo che è il capitolo sesto di Through
the Looking Glass per accennare al problema del linguaggio in Hobbes, quindi non andremo oltre. Per
curiosità e per dire della possibile concretezza del nesso, ricordiamo soltanto come sia stato ipotizzato che
il significato di glory nell’espressione “there’s glory for you”, da cui muove il puntuale scambio tra Alice
e Humpty Dumpty, sia stato influenzato proprio dalla definizione di sudden glory data da Hobbes in Lev.,
p. 27. Cfr. W. Gaffney, Humpty Dumpty and Heresy; Or the Case of the Curate’s Egg, in “Western
Humanities Review”, 22, 2, 1968, pp. 131-141.
1
6
antica di secoli, pur mantenendone spesso solo l’impalcatura, egli in realtà lascia aperto
un varco che permette di rintracciare continuità e discontinuità lessicali e semantiche,
nonché di indagare a fondo circa le ragioni delle une e delle altre.
Che vi sia uno iato strutturale, una sorta di faglia nelle fondamenta del sistema, è quanto
abbiamo evidenziato nella seconda parte di questo lavoro; seguendo le definizioni di
Hobbes, abbiamo tentato di indagare quanto esse “veramente” intendessero, non
sorvolando, ma piuttosto osservando con cura quanto emerge anche dalle loro
contraddizioni, tenendo soprattutto di mira – secondo l’indicazione del filosofo stesso,
che nel Leviathan scrive: “For it is not the bare words, but the scope of the writer, that
giveth the true light by which any writing is to be interpreted; and they that insist upon
single texts, without considering the main design, can derive nothing from them clearly,
but rather…make everything more obscure than it is” – “lo scopo dello scrittore”.
L’impatto dell’annuncio sistematico dell’opera hobbesiana ha posto talmente in primo
piano il momento ‘forte’ del suo pensiero (che potremmo forse racchiudere tutto
nell’istanza dell’assolutezza: del comando, dell’obbedienza, del sovrano) da produrre
l’eclissi (parziale o totale) di un’altra istanza in esso presente e a nostro parere forse di
altrettanta fondamentale importanza: un momento che non ci sentiremmo quindi di
definire ‘debole’, ma piuttosto, ci sia permessa la minima licenza poetica, umbratile (ci
sembra appropriato pensarla appunto come l’ombra del sistema).
Una spinta complementare, correlativa, ad ogni modo imprescindibile – la quale forse
costringerebbe a ripensare più ‘debolmente’ la prima (ma questa è una conseguenza per
noi di minore rilievo, se paragonata alla ricchezza e alla fertilità filosofica di quanto
7
ritrovabile nella seconda) – che si può ritrovare in due luoghi cardini della riflessione
hobbesiana: il concetto di equità e il concetto di autorità.
Dalla nozione di equity emerge il limite intrinseco che costituisce la regola essenziale
dell’esercizio del potere, il quale, sotto questa particolare angolatura, si rivelerà non
poter mai essere del tutto solutus.
A partire dal luogo contrassegnato dai termini autore-attore-autorità è possibile osservare
invece una peculiare concezione dell’uomo, nella quale viene soprattutto posto in
evidenza il diritto e il potere che ad esso ineriscono, in un senso talmente pregnante e in
se stesso costruttivo da fondare l’intera possibilità e plausibilità della costruzione statale.
8
PARTE PRIMA
Il contesto storico-scientifico
del paradigma giuspolitico hobbesiano
9
I
La rottura dell’armonia
Diritto e Rivoluzione nella storia inglese tra Cinquecento e Seicento
L’esigenza di ricostruire il contesto storico nel quale si collocano le componenti
giuridiche della filosofia di Hobbes non corrisponde ad una pretesa di spiegazione
globale e inattaccabile del suo pensiero, ma piuttosto alla volontà di trovare coordinate
materiali in grado di facilitarne l’ubicazione, e al contempo di rilevare fatti e
avvenimenti in grado di dare maggiore spessore al significato e alla portata di alcuni
aspetti teorici, assumendo così lo studio della storia politica, economica e sociale come
una fonte inesauribile di indizi, di influssi, di nessi.
Si tratta di una ricchezza sterminata che si potrebbe moltiplicare esponenzialmente
perlomeno in due direzioni, distendendosi per un verso in un passato che rimanda
continuamente ad un passato anteriore, e per un altro specificandosi in microstorie
sempre ulteriormente articolate e restringibili.
Così intesa, come complessità infinita e indomabile, questa stessa ricchezza esclude a
priori la possibilità di ricondurre alla storia, puntualmente e secondo una perfetta
corrispondenza biunivoca, ogni elemento di una determinata speculazione filosofica.
10
In questo senso ricostruire il contesto non significa quindi andare alla ricerca di fattori
che, sommati, abbiano dato un certo risultato (non perché si neghi la potenza delle cause,
ma perché si constata, prima ancora, l’impossibilità di tenerle tutte a mente); si tratta
piuttosto di cogliere alcune delle innumerevoli tensioni vitali che abitano il retroterra di
cui ci stiamo occupando, rendendolo di volta in volta arido o fertile.
E ciò si intende compiere partendo da un’immagine, quella della ‘rottura dell’armonia’,
che ben caratterizza il Seicento inglese, per passare poi all’analisi di alcuni momenti
chiave (il fenomeno delle recinzioni, il dibattito sulla tassazione, la conseguente disputa
sulla prerogativa regia e sullo stato di necessità) che permetterà infine di evidenziare gli
elementi di crisi del sistema di common law rilevanti in vista dell’esame delle
implicazioni giuridiche nel pensiero di Hobbes.
L’interesse enorme della storia del XVII secolo in Inghilterra è dato in primo luogo dal
suo essere momento di straordinaria trasformazione, di profondi rivolgimenti, in una
parola sola, di crisi2.
Per gli avvenimenti inglesi valgano le parole scritte da Santo Mazzarino a proposito
della vicende, simili pur se opposte nel loro strutturarsi, che portarono alla fine
dell’impero
romano
e
alla
nascita
dell’impero
accadico:
“organismi
nuovi
2
Così, nelle efficaci pagine introduttive del suo libro, M. Kishlansky, A Monarchy Transformed. Britain
1603-1714, London 1996 (tr. it. L’età degli Stuart. L’Inghilterra dal 1603 al 1714, Bologna 1999), p.13:
“Il periodo che coincise con il regno degli Stuart (1603-1714) introdusse moltissimi elementi che
caratterizzarono la nazione nei decenni successivi, gran parte dei quali presenti ancora oggi. Nacque il
commercio moderno; la scienza divenne maggiorenne; la letteratura maturò come non era mai successo
prima né si sarebbe ripetuto in seguito; l’ordinamento feudale perse vigore; la tortura, la stregoneria e
l’eresia scomparvero lentamente”.
11
germogliavano su un terreno sconvolto, e le antiche strutture franavano sotto il peso
della loro stessa antichità”3.
Decidere a quale delle due strutture si avvicini di più il percorso dell’Inghilterra, se a
quella della via romana che condusse dall’unità alla frammentazione, o quella che portò
dalla pluralità degli stati sumerici allo stato unico di Akkad, è problema non semplice, la
cui eventuale soluzione non esaurirebbe in ogni caso la complessità degli avvenimenti
d’oltremanica.
Teniamo fermo intanto un punto metodologico: l’individuazione di una struttura che
colleghi e regga un determinato passaggio storico, pur restando “una creazione sul
fantasma della realtà”4, è da assumersi non come una riduzione o un appiattimento, ma
come una via di accesso, una linea di lettura; massima importanza rivestirà allora lo
studio dei punti di rottura, laddove la riflessione voglia tendere alla comprensione dei
materiali e dei meccanismi con i quali si sono innalzate e mantenute le costruzioni
umane, poi incrinatesi e crollate per l’effetto corrosivo del mutamento.
La molteplicità di motivi concorsi nella crisi risoltasi con la ratio ultima della
Rivoluzione del 1640-1660 rende inadeguata ogni approssimazione unilaterale e
definitiva al problema che essa rappresenta.
Prendiamo le mosse da una considerazione generalissima. Con la fine del regno di
Elisabetta e l’inizio dell’età degli Stuarts si definirono e si radicalizzarono i termini di
3
S. Mazzarino, La fine del mondo antico, Torino 2008, p. 15.
Usiamo in senso traslato un’espressione di G. Radbruch sulla quale avremo modo di ritornare,
riprendendola nel suo significato puntuale: “La creazione del diritto ad opera del legislatore è una
creazione sul fantasma della realtà”. Cfr., G. Radbruch, Der Geist des englischen Rechts, Gottingen 1958
(tr. it. Lo spirito del diritto inglese, Milano 1962), p. 9.
4
12
una sistemica ‘rottura dell’armonia’5, che non senza ragione potrebbe pensarsi come la
lunga onda d’urto delle idee di Copernico e di Lutero.
“La grandezza dell’epoca elisabettiana stava nel fatto che la ricchezza di fermenti nuovi
non incrinava la nobile forma dell’ordine antico. E ciò era dovuto alla regina: non si sa
bene come, i Tudors si erano inseriti nella costituzione dell’universo medievale”6;
all’idea fondamentale sulla quale si reggeva questo universo, un ordine cosmico e
sociale gerarchicamente strutturato, creato da Dio e imperniato sulla Terra e sul Re, si
collegava direttamente la premessa – vera colonna portante della costituzione Tudor e
delle idee politiche di Giacomo I – della naturale armonia tra gli interessi del popolo e
quelli del monarca.
Ma se è vero che nel regno di Elisabetta la danza cosmica è rappresentata nel corpo
politico7, fu solo questione di tempo veder emergere le profonde crepe che si aprirono
tanto in quella come in questo.
Oltre il mito elisabettiano, non solo i fermenti nuovi furono gravidi di conseguenze, ma
lo stesso nobile ordine nel quale essi venivano ad inserirsi dimostrò avere al proprio
La “natura della malattia” del secolo si ritrova racchiusa per intero nelle famose parole di Ulisse nel
Troilo e Cressida (atto I, scena 3). W. Shakespeare, Tutte le opere, Firenze 1964, p. 766: “I cieli stessi, i
pianeti, e questo centro dell’universo, osservan grado, priorità e posto, perseveranza, corso, proposizione,
stagione, forma, ufficio, e costume, seguendo un preciso ordine; e perciò il magnifico pianeta Sole è in
nobile eminenza installato e posto nella sfera tra gli altri; il cui occhio salutifero corregge i sinistri aspetti
dei pianeti maligni, e come il bando d’un re, ingiunge senza intoppo a buoni e a malvagi; ma quando i
pianeti in maligna mescolanza si sviano dal loro ordine, quali pestilenze, e quali portenti, quale tenzone,
quale infuriar del mare e sussultar della terra, commozione dei venti, paure, mutamenti, orrori, stornano e
spaccano, lacerano e sradicano l’unità e il calmo connubio dei ceti dalla lor fissa condizione! Oh, quando è
scossa la gerarchia, che è la scala a tutti gli eccelsi disegni, l’impresa languisce! Come potrebbero le
comunità, i gradi nelle scuole, e le fratellanze nelle città, il pacifico commercio tra separanti sponde, la
primogenitura e il diritto di nascita, la prerogativa dell’età, corone, scettri, allori, conservare il loro
legittimo posto se non per mezzo della gerarchia? Sol togliete la gerarchia, mettete fuori tono quella
corda, e udite che discordo che segue; ogni cosa si scontra in puro antagonismo…”.
6
E. M. W. Tillyard, The Elizabethan World Picture, London 1943, pp.1-6.
7
Idem.
5
13
interno altri pericolosi elementi di debolezza: la storia amministrativa8 e costituzionale9
degli ultimi anni dell’era Tudor rivela come fosse già allora in atto un processo di
deterioramento strutturale che, con il primo re Stuart, conobbe una violenta fase di
accelerazione e portò infine agli esiti drammatici della guerra civile sotto Carlo I.
Da qualunque prospettiva lo si voglia osservare, in tale processo si palesa
l’indebolimento dei vincoli che tenevano unita la società inglese, la fine della concordia
degli interessi all’interno della classe dirigente e il venir meno del consenso dato ad essa
dal paese; dalla prospettiva del diritto si nota che la trama giuridica nazionale (poiché di
un prodotto propriamente inglese si tratta), sembrò non riuscire più a incanalare
ordinatamente i distinti interessi dei soggetti; superstite sin dal lontano dodicesimo
secolo in una forma peculiare che faceva della sua flessibilità la chiave della sua
resistenza, essa conobbe il punto del suo massimo irrigidimento.
Il dato politico decisivo rilevabile da questo quadro – ed è uno dei tanti punti critici
colto da Hobbes con disarmante lucidità – è proprio la non naturalità dell’armonia e la
necessità di individuare un centro intorno al quale costruirla artificialmente.
L’ambito del diritto è la lente che adotteremo quindi per scorgere i tratti sommari delle
difficoltà che travagliarono questa fase della storia inglese.
Cfr. J. E. Neale, The Elizabethan Political Scene, in “Proceedings of the British Academy”, 1948 (tr. it.
in E. Rotelli e P. Schiera, Lo Stato Moderno, II: Principi e ceti, Bologna 1971, pp. 189-211).
9
Ch. H. McIllwain, Costitutionalism: Ancient and Modern, New York 1947 (tr. it., Costituzionalismo
antico e moderno, Bologna 1990, p. 130).
8
14
Tale scelta, certo parziale, non è priva di fondamento: è stato detto che la scienza e la
riforma giuridica furono il centro della rivoluzione del XVII secolo 10; il campo nel quale
si combatté la battaglia per la supremazia e l’uscita dalla crisi costituzionale fu quello
della terminologia e delle pratiche giuridiche che innervavano il funzionamento del
governo e della società inglese.
Il vasto dibattito intorno alle categorie del diritto negli anni precedenti alla guerra civile
fu una sorta di difficile presa di coscienza che quella società, profondamente segnata dai
mutamenti economici, esercitò su se stessa.
Proprio dall’indicazione di uno degli elementi più significativi di queste trasformazioni
economiche è possibile mettere in evidenza, nel passaggio tra Cinquecento e Seicento,
alcuni aspetti peculiari della transizione da strutture di tipo feudale a strutture di stampo
capitalistico, utili ad indicare, nella loro concretezza, tendenze e questioni che influirono
con vigore sulla società e sul pensiero inglese del tempo.
La questione, complessa e ampiamente dibattuta, che si analizzerà qui soltanto
sinteticamente è quella delle recinzioni (enclosures) e dell’appropriazione delle terre
comuni ad opera soprattutto della gentry: uno dei fenomeni –forse il più rappresentativo
delle tematiche che qui vorremmo affrontare – caratterizzanti il processo di riordino
Cfr. B. Manning, “The Nobles, the People and the Constitution”, in T. Aston (a cura di), Crisis in
Europe 1560-1660, London 1965 (tr. it. in Crisi in Europa 1560-1660. Saggi di Past and Present, Napoli
1968, p. 347).
10
15
agrario e fondiario che, tra i due secoli, travolse insieme con i vincoli, i legami di
certezza giuridica e di solidarietà territoriale degli antichi rapporti di produzione11.
Il diritto consuetudinario, nato e sviluppatosi all’interno di una società tipicamente
agraria,
era
destinato
riorganizzazione
a
risentire
dell’ingente
profondamente
patrimonio
terriero
del
trasferimento
proveniente
in
e
della
gran
parte
dall’abolizione della proprietà ecclesiastica.
La serie di atti parlamentari con i quali si era compiuta la dissoluzione dei monasteri tra
il 1536 e il 1539, aveva sì gettato la base davvero solida della Riforma inglese, ma nel
mutamento del quadro della distribuzione della proprietà che essa comportava, vi erano
stati inevitabilmente fattori di potenziale destabilizzazione che, nel lungo processo di
assestamento che seguì, tramutarono la primaria forza coesiva della società Tudor in
principale fattore disgregativo di quella Stuart.
Pare opportuno prendere le mosse dal concetto di Common Law inteso come Law of the
Land. Land è un termine che va inteso sia nel senso politico di “paese” sia
nell’accezione di “suolo” posseduto12: in verità, entrambi i significati mostrano un
intimo collegamento, se si ricorda che la maggior parte della terra inglese apparteneva ai
grandi notabili, alle corporazioni, alla Chiesa e alla Corona. Proprio questi corpi
privilegiati, tra i quali era ascesa prepotentemente la gentry negli anni 1540-1640,
definirono l’identità politica, culturale e sociale del paese intorno alla garanzia del diritto
G. Giarrizzo, “Il pensiero inglese nell’età degli Stuart e della Rivoluzione”, in L. Firpo (diretta da),
Storia delle dottrine politiche, economiche e sociali, vol. IV, Tomo Primo, Torino 1980, p. 165.
12
Cfr. Ch. Hill, The Intellectual Origins of English Revolution, Oxford 1965.
11
16
di proprietà e al mantenimento dello status quo, avvalendosi dell’efficace strumento del
diritto consuetudinario per fare emergere dal lontano passato e conferire coscienza e
spessore a rapporti di fatto e decisioni legali, già esaltate a ‘precedenti’ e ora invocate
come leggi fondamentali13.
Nelle campagne inglesi la situazione di fatto era in continuo mutamento.
La forte crescita demografica, iniziata gradualmente dalla fine del Quattrocento e durata
fino alla fine degli anni quaranta del Seicento, fu un fattore rilevante che contribuì a
modificare gli assetti tradizionali: l’aumento della popolazione mise a durissima prova il
regime agrario tradizionale14, e il conseguente aumento della domanda di derrate
alimentari, insieme con il crollo dei salari dovuto alla manodopera in eccedenza, avrebbe
presto modificato in maniera definitiva non solo la configurazione della campagna ma
anche il rapporto tra questa e la città.
Gli effetti della crescita furono devastanti per i contadini privi di terra, che
maggiormente beneficiavano dell’agricoltura di sussistenza, ma rappresentarono
un’occasione grazie alla quale i produttori di beni in eccesso furono incentivati a
utilizzare proprietà fino ad allora scarsamente sfruttate.
Il declino dell’aristocrazia e l’ascesa della gentry fu determinato in gran parte dalla
capacità di cogliere quest’occasione: se le entrate della prima calarono in virtù sia
dell’inflazione, sia di una gestione anacronistica delle coltivazioni, la seconda, mutando
radicalmente l’atteggiamento tradizionale nei confronti della produzione agricola, si
Cfr. G. Giarrizzo, “COURT vs COUNTRY: la società dell’Europa barocca”, in G. Nocera (a cura di), Il
segno barocco: testo e metafora di una civiltà, Roma 1983, pp. 147-161.
14
Cfr. M. Kishlansky, op. cit., pp. 31 ss.
13
17
avviò verso l’adozione di sistemi rigorosi e più razionali di sfruttamento della terra, resi
ormai necessari dalle nuove esigenze del mercato.
La gestione moderna implicava necessariamente un’agricoltura intensiva, possibile su
larga scala solo con l’estinzione dei diritti comuni, l’accorpamento degli appezzamenti,
le recinzioni e soprattutto la concessione in affitto delle terre a prezzi di mercato, con la
conseguente espulsione dei possessori consuetudinari come i copyholders15.
Ciò che in questi anni giungeva a conclusione era la lenta e progressiva distruzione dei
sistemi delle terre comuni e dei campi aperti16, ovvero il definitivo tramonto della
razionalità ad essi sottostante.
Il valore economico delle common lands per la comunità non era affatto trascurabile:
esse non erano soltanto le terre dove gli abitanti del villaggio potevano svolgere svariate
attività (taglio della legna, fabbricazione del carbone, caccia, pesca, e – forse la più
importante – pascolo), ma avevano anche la funzione di integrare il reddito di molte
famiglie di piccoli proprietari, di affittuari o di lavoratori saltuari, nonché di
rappresentare la fonte principale di entrate di quei contadini nullatenenti che vivevano di
espedienti e lavoravano per lo più dietro salario quando i lavori agricoli erano più
intensi.
G. Garavaglia, Storia dell’Inghilterra Moderna. Società, economia e istituzioni da Enrico VII alla
Rivoluzione industriale, Bologna 1998, p. 44.
16
Cfr. P. Malanima, Uomini, risorse, tecniche nell’economia europea dal X al XIX secolo, Milano 2003,
pp. 99 ss.
15
18
Gli open fields, a differenza delle common lands, non erano proprietà comune, ma
proprietà privata composta di tante strisce non recintate, collimanti con i campi di altri
proprietari.
Qui, la coazione esercitata dagli interessi della comunità era ancora più manifesta: in
assenza di steccati, tutti i terreni dovevano seguire le medesime rotazioni ed erano
soggetti alle medesime coltivazioni. Seguendo gli stessi avvicendamenti, i campi erano
liberi da colture negli stessi lassi di tempo ed era proprio e solo in quei ben definiti
momenti che venivano sottoposti ad usi collettivi come la spigolatura e il pascolo,
facendo sì che i diritti di proprietà, sottostanti a regolamenti comuni, venissero sospesi
durante il periodo che andava dalla raccolta alla nuova semina.
Il sistema nel suo complesso, seppur chiuso alle innovazioni e all’espansione, mitigava
le difficoltà che affliggevano la campagne garantendo in particolare il delicato equilibrio
tra gli arativi e i terreni di pascolo.
In presenza di una limitata mercantilizzazione, si trattava di un impiego razionale delle
risorse17 che assicurava l’equa ripartizione dei rischi, fondamentale per allentare le
tensioni e mantenere la stabilità solidale della comunità.
Gli svantaggi dei campi aperti però non furono più trascurabili con la diffusione delle
relazioni di mercato: in un quadro mutato in cui la produzione era destinata alla vendita
e non più solo alla sussistenza, la ripartizione dei rischi era sinonimo non più di stabilità
ma di staticità, e di fatto finiva per rappresentare un ostacolo ai profitti.
17
Cfr. C. J. Dahlman, The open field system and beyond, Cambridge 1980.
19
La libertà di scelta da parte di individui che assumevano su di sé il rischio del successo o
dell’insuccesso delle decisioni riguardanti gli orientamenti produttivi, divenne la
soluzione ottimale per accrescere i profitti personali: così dettava la nuova razionalità.
L’individualismo agrario spinse allora per la cessazione dei diritti comuni e il
consolidamento della proprietà privata, mediante la ricomposizione e l’unificazione dei
terreni.
La coltivazione intensiva era inoltre solo uno dei vari modi con cui trarre profitto dai
nuovi appezzamenti: essi potevano anche essere impiegati permanentemente come
pascolo, oppure venduti o affittati ad un valore più alto.
Nella sua lunga storia (in relazione ai sistemi di campi aperti un’analisi approfondita
dovrebbe risalire al X secolo), il fenomeno delle enclosures prese molteplici forme, ma
fu nel XVII secolo che l’accentramento dei terreni divenne la norma. La modalità più
diffusa attraverso cui ciò avvenne fu l’estinzione dei diritti comuni e recinzione in
seguito all’accordo fra le parti: questo accordo poteva giungere grazie ad adesioni estorte
con la forza, così come in virtù di intese amichevoli18.
Siamo così giunti ad un punto fondamentale.
18
Hill parla di un accordo di recinzione stipulato dai freeholders di Eyam nel 1702 (Clarke Papers, II, p.
404) come un eccellente esempio di contratto hobbesiano. Ch. Hill, “Thomas Hobbes and the Revolution”,
in Puritanism and Revolution: Studies in Interpretation of English Revolution of the17th Century, New
York 1997, p. 255, nota.
20
L’intero procedimento delle recinzioni era sempre stato di difficile attuazione perché la
protezione del sistema di gestione dei campi aperti era uno degli scopi fondamentali del
diritto inglese, sia di equity sia di common law.
Nondimeno, proprio il fatto che questo sistema si basasse “su norme consuetudinarie,
createsi quindi progressivamente e non per imposizione di un’autorità superiore, aveva
fatto sì che esistessero diversi modi per procedere legalmente alla loro estinzione”19.
Così “il signore ha potuto piegare a suo favore i costumi”20, consolidando la sua
proprietà a discapito non solo dei nullatenenti, ma anche dei possessori consuetudinari.
“Non era la nascita della proprietà privata, ma la sua terra ora era più sua di quanto non
fosse prima”21: la malleabilità legale del diritto consuetudinario, utilizzata in questa sede
per rafforzare e in qualche modo cristallizzare la situazione di partenza, scardinava
antichi modi di produzione agricola e secolari forme di stabilizzazione sociale.
La voragine di incertezza giuridica che così veniva aperta avrebbe necessariamente
spinto verso forme di garanzia in grado di fissare e pacificare i rapporti sociali: in epoca
moderna, queste forme furono i contratti; dalla seconda metà del Settecento, l’estinzione
dei diritti comuni e le recinzioni avvennero per lo più mediante atti parlamentari.
Ci interessa sottolineare la struttura di fondo che emerge dal fenomeno delle recinzioni:
mutate condizioni economiche spinsero verso un accentramento guidato da una
razionalità individualista che richiedeva una nuova configurazione di diritti. L’intera
19
G. Garavaglia, op.cit., p. 117.
M. Bloch, Seigneurie française et manoir anglais, Paris 1960 (tr. it. Signoria francese e maniero
inglese. Lezioni sulla proprietà fondiaria in Francia e in Inghilterra, Milano 1980, pp 207-208).
21
P. Malanima, op.cit., p. 104.
20
21
questione è per molti versi riconducibile al problema del passaggio dall’uso alla
proprietà, nel caso specifico dal precedente uso – in parte comune –della terra alla
proprietà privata piena, tema fondamentale nel dibattito costituzionale del Seicento sul
piano giuridico e uno dei nodi centrali del pensiero hobbesiano sul piano del potere.
Proprio in questo passaggio cruciale si evidenziò la componente implosiva del diritto
consuetudinario, laddove il costume di cui esso era portatore si dimostrò definibile di
volta in volta in base agli interessi delle classi possidenti, e finì per rivelare la sua
potente carica di antigiuridicità.
Che il tentativo di neutralizzare la conflittualità naturalmente derivante da un tale quadro
sia passato poi dalla forma del contratto e successivamente dell’atto del Parlamento, è un
fatto della massima importanza per la nostra analisi: si tratterebbe di un movimento di
riassestamento complessivo di una società le cui strutture tradizionali, scardinate nelle
loro antiche forme, aspiravano ad un apparato istituzionale nuovo ed efficace, in grado
di mediare gli interessi distinti e assicurare certezza e maggiore stabilità.
Attraverso il fenomeno delle recinzioni sarebbe visibile quindi una sorta di primo livello
di quella rottura dell’armonia precedentemente citata, che accordava e legava insieme le
diverse componenti della società inglese.
Le enclosures sembrerebbero rappresentare dunque una delle tante fratture, quella tra il
paese e la classe dirigente dei proprietari terrieri, che alimentarono il fuoco della guerra
civile.
Il segno più evidente di questo scollamento fu il declino costante del controllo sulle
campagne da parte dei signori.
22
Per gran parte del secolo precedente la Riforma, la land question era già stata un tema
scottante22, ma nella seconda metà del Cinquecento e nella prima metà del Seicento le
sommosse contadine, provocate principalmente dalla scarsità di cibo e dall’opposizione
alle recinzioni, erano ormai endemiche in diverse regioni inglesi. L’obiettivo di queste
rivolte non era certo il sovvertimento dell’ordine costituito, ma piuttosto l’affermazione
di diritti basilari, come quello all’esistenza, oscurati proprio dietro il velo di un
apparente mantenimento dell’antico.
Il venir meno della produzione di obbedienza indica la progressiva perdita di vigore
nell’efficacia dell’azione ordinante ad opera del signore.
Il maniero costituiva una stretta fusione tra impresa economica e insieme di sovranità23,
e le trasformazioni della prima non potevano rimanere senza conseguenze sul piano dei
poteri: il consolidamento dei possedimenti che aveva portato in superficie la
contrapposizione tra diritti dei landlords e dei tenants, implicava una ridefinizione del
concetto di proprietà destinata ad avere forti ripercussioni in ambito giurisdizionale.
Si può affermare che il tramonto del feudalesimo in Inghilterra fosse iniziato molto
presto: già nel XII secolo l’espansione della giustizia regia, con la quale è nata la
common law, aveva imposto una notevole limitazione al sistema di giustizia delle
manorial courts, riservando ai tribunali del re la competenza in ambito criminale.
22
23
R. H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism, New York 1926, p. 138.
M. Bloch, op. cit., p. 93.
23
“Ma tutto ciò che riguardava i canoni, tutto ciò che riguardava il possesso della terra,
doveva restare al signore”24 e così il villano, nella giurisprudenza che si stabilì e per quel
che riguardava il suo rapporto col signore, fu sottratto alla giurisdizione regia.
Quando però le motivazioni del malcontento contadino sorsero precisamente nell’ambito
di competenza del signore e contro i suoi interessi, le istanze giurisdizionali locali
necessitarono l’appoggio di un’istanza superiore, ovvero di un potere centrale forte, in
grado di garantire controllo e ordine: l’alleanza tra ceto dirigente e Corona si cimenta sul
bisogno comune di questa garanzia.
Il filo che lega l’appropriazione della ricchezza e della terra all’appropriazione del potere
politico era stato visto nella sua doppia veste disgregativa, sul piano sociale e sul piano
istituzionale, da More25, ma la soluzione di un uso non proprietario della prima e del
secondo delineata già nel 1516 in Utopia, non poteva trovare spazio tra una classe
dirigente di proprietari terrieri i cui interessi combaciavano con quelli della monarchia.
In questa sinergia per cui “il potere non solo era concentrato nello stato, ma
riconcentrato nei proprietari terrieri”26, si può trovare una delle cifre dello stato assoluto
inglese.
L’arricchimento della gentry comportò un enorme aumento del controllo da essa
esercitato sul governo degli affari locali, in particolare nella veste dei giudici di pace
24
Ibid., p. 162.
Th. More, Utopia, I, 18.
26
B. Manning, cit., p. 338.
25
24
onorari; non fu quindi casuale che sia stato questo ceto a beneficiare maggiormente
dell’espansione della professione legale e della burocrazia giudiziaria.
Le nuove generazioni migrarono dalle campagne verso le città, ed entrarono in contatto
con i settori dinamici del ceto mercantile: “Londra pullulava di rampolli della èlite
terriera, e in molte famiglie fu il figlio avviato alla carriera legale, all’impiego o al
commercio a fare fortuna”27.
Inoltre, con il declino dell’aristocrazia fondiaria, anche l’influenza della gentry nelle
elezioni parlamentari si fece sentire sempre di più, determinandone la partecipazione
attiva al funzionamento del sistema di governo.
Si trattava quindi della concentrazione di potere in mano a una classe dirigente mutata
che si realizzava sia sul piano locale sia su quello nazionale, ma pur sempre in nome,
rispettivamente, della pace del re e nell’istituto del King in Parliament; proprio facendo
leva su un centralismo regio necessario a garantire la stabilità del regno, si configurava
un assetto che sembrava superare la dispersione di potere gettando un robusto ponte tra
la provincia e la città.
Ma la tenuta del centro del potere si sarebbe rivelata presto fragile e precaria.
L’allargamento del ceto dirigente (così come l’ampliarsi vertiginoso di quello dei poveri
nullatenenti, spinti dalla miseria in flussi migratori continui verso centri urbani non
certamente in grado di assorbirli tutti) stava trasformando la vita politica, sociale ed
economica del paese in una maniera così profonda e radicale da non poter essere a lungo
gestita dall’azione stabilizzatrice della Corona.
27
Id.
25
Tale pacificazione fu possibile fintantoché ci fu convergenza tra i suoi interessi e quelli
delle forze rappresentate in sede parlamentare, ovvero quelle che Thomas Wilson nel
1600 chiamava nobilitas major e nobilitas minor28.
Ma la convergenza venne meno quando i bisogni finanziari del re minarono il pilastro su
cui si basava il compromesso con la classe dirigente, ovvero il mantenimento dei diritti
di proprietà.
L’espansione degli obblighi dello stato rese impellente la regolarità e l’aumento delle
entrate della corona e ciò finì necessariamente per intaccare il privilegio di tassazione
attraverso il Parlamento della classe dirigente: il punto era nevralgico, perché grazie a
questo privilegio la nobiltà grande e piccola era riuscita a far sì che il peso principale nel
sostenere lo stato ricadesse sulle classi inferiori anziché su quelle superiori.
Se è vero che l’esenzione delle tasse per i nobili, flagello delle finanze francesi fino alla
fine dell’Ancien Régime, era sconosciuta in Inghilterra, è vero anche che in questa
peculiare declinazione del dominium politicum et regale29 inglese la dualità di tassazione
si riproponeva sotto altre vesti, ben più sottili.
È qui possibile notare come l’assenza di tale privilegio, che costituisce uno degli
elementi che differenziano l’assolutismo inglese da quello continentale, riproponga
comunque sull’isola problematiche analoghe a quelle d’oltremanica, che in entrambi i
casi avevano in sé il seme della rovina.
F. J. Fisher (a cura di), The State of England Anno Dom. 1600 by Thomas Wilson, in “Camden Society
Miscellany”, XVI, 1936, p. 23.
29
Così la famosa definizione di Sir John Fortescue, The Governance of England, Oxford 1885.
28
26
Ancora una volta il tema della proprietà, osservato dal punto di vista dei diritti fondiari,
può gettare luce sul problema di cui ci stiamo occupando.
Nel regime feudale le terre erano gravate da una serie di diritti stratificati che, formando
una scala continua e ascendente, giungevano per gradi dal contadino al re. In virtù della
sua formazione lenta e progressiva, questo sistema non giunse mai a completezza nei
paesi del continente; in Inghilterra, invece, esso era stato introdotto in blocco dopo la
conquista normanna del 1066, assumendo “un rigore che appartiene unicamente ai
sistemi sociali imposti”30, e tutta la terra, senza eccezione, fu concepita come proprietà
(ownership) esclusiva del re (Universal Derivative Tenure).
Risulta chiaro che in un quadro così concepito non vi è luogo per un concetto di
proprietà del suolo in senso assoluto: col fenomeno delle recinzioni abbiamo notato
come s’impose, a un certo punto, la necessità pratica e teorica di definire rigorosamente
un tale concetto.
L’eco di un’idea così strutturale e rigida del sovrano come primo signore del paese e
dello stato come sua impresa privata era destinata a farsi sentire nel tempo e le sue
implicazioni a livello economico, giuridico e politico, si sarebbero rivelate decisive
proprio nel momento finale del declino dell’ordinamento feudale.
30
M. Bloch, op. cit., pp. 128-129.
27
Sul piano del diritto, il fattore di capitale importanza che qui si intravede è
l’indistinzione, caratteristica del sistema di common law, tra diritto pubblico e diritto
privato, sulla quale avremo modo di soffermarci in seguito.
Sul piano delle finanze31, la concezione medievale che abbiamo brevemente delineato
comportava che il re, in tempo di pace, dovesse “vivere del suo” e governare quindi
servendosi solo delle entrate ordinarie derivanti dal patrimonio regio, sia per diritto di
prerogativa, sia per concessione permanente; il ricorso alle entrate straordinarie,
concesse dal Parlamento, sarebbe stato giustificato solo in circostanze estreme, ad
esempio, in caso di guerra.
L’inflazione e gli impegni governativi avevano però vanificato il principio
dell’autosufficienza del re già in pieno Cinquecento, e l’effetto di tale dissoluzione, non
apertamente riconosciuta sotto Elisabetta, fu la pesante eredità (aggravata dalla di lui
generosa munificenza) ricevuta da Giacomo I e da Carlo I: non è un caso che su questi
termini si sia articolata gran parte dell’aspra dialettica tra re e parlamento nel corso della
prima metà del secolo.
L’armonia nella classe dominante si ruppe quindi palesemente con l’avvento al trono di
Giacomo I.
La separazione della monarchia dalla sua base sociale fece sì che il re, per risolvere le
difficoltà finanziarie, si spingesse ad invadere i diritti della nobiltà e della gentry. Lo
scollamento, abbiamo visto, sembrava essersi aperto tra paese e classe dirigente.
31
G. Garavaglia, op. cit., pp. 457 ss.
28
Ciò che si prospetta adesso è un’ulteriore spaccatura, interna ora alla classe di governo,
di cui vanno rintracciate almeno approssimativamente le origini.
L’allargamento della base sociale che desiderava e reclamava un posto all’interno del
ceto dirigente, evidente con l’espansione su larga scala delle scuole e delle università 32,
determinò un movimento inflazionistico che portò ad un eccesso di postulanti in
rapporto al numero dei posti disponibili33.
La lotta per gli uffici e la connessa corruzione che ad essa si legava, rappresentò una
questione dolente negli ultimi anni del governo di Elisabetta e non fu più eludibile sotto
il primo re della dinastia Stuart.
Inoltre, proprio in presenza di un tale processo, la gestione amministrativa da parte della
corona secondo i cardini di un modello stabilito da secoli, non poteva non contribuire a
peggiorare il quadro: la vendita dei titoli, l’ereditarietà delle cariche, la venalità degli
uffici, il pagamento dei funzionari con onorari fluttuanti, gratifiche e prebende, ad
esempio, facevano tutti parte di una gestione dello stato come impresa privata che non
era più finanziariamente sostenibile34.
La corsa per il prestigio e per il profitto che vedeva le fazioni aristocratiche in lotta per
onori e impieghi rappresentò motivo di grave dissidio all’interno della classe dirigente,
Cfr. M. H. Curtis, “The alienated intellectuals of Early Stuart England”, in T. Aston (a cura di), Crisis in
Europe 1560-1660, London 1965 (tr. it. in Crisi in Europa 1560-1660. Saggi di Past and Present, Napoli
1968, pp. 395-423).
33
Cfr. J. E. Neale, art. cit., p. 206.
34
G. E. Aymler, Attempts at Administrative Reform 1625-1640, in “English Historical Review”, vol. 72, n.
283, 1957 (tr. it. in E. Rotelli e P. Schiera, Lo Stato Moderno, III: Accentramento e Rivolte, Bologna 1974,
p. 24).
32
29
ma certamente non l’unico: la discordanza profonda era sulla linea politica della
monarchia che, impegnata nel rafforzamento del potere centrale in veste di controllore e
regolatore della vita economica, religiosa e sociale, era rea agli occhi dell’aristocrazia e,
in particolare, agli occhi di proprietari terrieri e piccoli produttori urbani e di campagna
inclini ad uno sviluppo dell’economia in senso capitalistico, di aver oltrepassato la
misura necessaria per mantenere l’ordine esistente.
Tale limite era rappresentato dall’equilibrio tra le istanze del Government e quelle della
Property35: la sede di questa armonizzazione era stata storicamente il Parlamento, ed in
epoca Tudor essa era stata possibile sia perché sorretta da una robusta ideologia
dell’ordine cosmico (che a livello politico si rifletteva come naturale concordia degli
interessi dei governati e dei governanti), sia perché vantaggiosa economicamente per le
classi dominanti.
L’accordo si era diversamente attuato a seconda delle circostanze anche in virtù della
labilità dei confini tra le due sfere, ma ora che le esigenze della Ragion di Stato
entravano in collisione con i diritti dei sudditi (proprietari), la definizione degli ambiti
diveniva il problema cruciale.
La costituzione Tudor non presentava nessuna soluzione al riguardo e non è un caso che
lo scontro si presenti proprio quando la fine della linea dinastica richiederà
l’insediamento di una nuova famiglia regnante; il logorio del compromesso tra potere
regale e poteri feudali, tra ragion di stato e antica costituzione, imperniato sulla
Cfr. G. A. Ritter, «Divine right» und Präerogative der englischen Könige 1603-1640, in “Historische
Zeitschrift”, 196, 1963 (tr. it. in E. Rotelli e P. Schiera, Lo Stato Moderno, III: Accentramento e Rivolte,
Bologna 1974, pp. 69-106).
35
30
distinzione tra dinastia e popolo-paese, faceva emergere in tutta la sua portata la
questione fondamentale: “come dare legittimità alla proprietà (trasmissibilità ereditaria)
del potere?”36.
Intorno ai termini di tale questione si definirà, in maniera tortuosa e complessa, il
passaggio dalla tradizione dinastica a quella nazional-statale in Inghilterra.
Sin dal primo parlamento di Giacomo I (1604) il dissidio fu evidente: il Re, da una parte,
si preoccupava di affermare che i privilegi della Camera Bassa dipendevano da una
graziosa concessione del monarca; la formulazione, a rigor di termini esatta (perché
derivante da una concezione del rapporto fra re e sudditi che faceva leva sull’asimmetria
del contratto di signoria iniziato con l’avvento di Guglielmo I!), “inevitabilmente
suggeriva che quanto era stato concesso poteva essere tolto”37; dall’altra, il Parlamento
introduceva tra gli atti, in forma di apologia e soddisfazione, una difesa dei propri
privilegi considerati diritto e eredità dovuta, preesistenti l’attacco del re normanno (the
Norman Yoke) e superiori quindi rispetto alle prerogative regie.
La concezione del potere di Giacomo I prese forma nella prassi politica con il Bate’s
Case38 (1606), quando per la prima volta il Re sostenne l’utilizzo delle sue prerogative
assolute ed illimitate per accedere ad una riscossione fiscale indipendente dal
Parlamento.
G. Giarrizzo, “COURT vs COUNTRY: la società dell’Europa barocca”, cit., p. 156.
M. Kishlansky, cit., p. 112.
38
Gran parte del reddito reale proveniva dagli introiti doganali. Nel 1600 Elisabetta iniziò a riscuotere
un’imposta speciale sull’uva passa. Nel 1606 John Bate, il maggior importatore del prodotto, si rifiutò di
pagarla perché essa non era stata accordata alla corona dal parlamento. Cfr. Ibid., p. 118.
36
37
31
Il caso concerneva infatti il diritto della corona di elevare dazi aggiuntivi sulle merci
importate; i giudici, chiamati ad esprimersi in proposito, decisero all’unanimità in favore
del diritto del re di riscuotere le impositions.
Le motivazioni addotte dal giudice Fleming, che costituirono successivamente uno dei
pilastri delle teorie regaliste, indicavano un potere assoluto – distinto da quello abituale
– del monarca; esso era tale perché aveva come fine il beneficio generale, la salus
populi: “la sentenza si basava sulla distinzione mai affermatasi in Inghilterra a differenza
che sul continente, fra diritto pubblico e diritto privato implicava che l’interesse della
collettività, interpretato soltanto dal re in base alle regole della politica e del diritto
statale, in caso di conflitto, prevalesse sui diritti del singolo”39.
La situazione finanziaria ereditata da Elisabetta, peggiorata dall’incerta politica dello
stesso Giacomo, era ora drammatica. Il Great Contract, che tentava un compromesso
innovativo, prevedendo l’accordo di un sussidio che estinguesse tutti i debiti del re e di
una tassa annuale sulla terra, fallì.
Fallì soprattutto perché in esso era implicito un principio che sottraeva stabilmente al
consenso di una delle parti le decisioni in merito al proprio profitto e proprietà, e tale
parte, ovviamente, non diede il proprio assenso.
In questa sottrazione stabile vi era il fondamento della possibilità di un azione di
governo ordinaria e continuativa, indispensabile ormai per il funzionamento dello stato:
il problema era che entrambe le parti in campo intendevano avocare a sé la titolarità del
39
G. A. Ritter, art. cit., p. 89.
32
potere e quindi anche la decisione sui modi e le condizioni di tale azione. Un
compromesso contrattuale in merito era di fatto impraticabile.
Appoggiandosi alla decisione sul caso Bate, il segretario Cecil, conte di Salisbury,
aumentò le imposte e tassò nuove merci, facendo delle imposizioni una fonte regolare di
entrate e muovendo così un passo forzato verso quella riforma sentita come urgente
necessità dalla metà del XVI secolo; per il Parlamento, il pericolo potenziale della
sentenza di Fleming si dimostrò attuale.
Nel dibattito parlamentare del 1610 la Camera Bassa sostenne che la questione dei dazi
ricadeva nella sfera della proprietà e non in quella del governo e William Hakevill,
partendo da una concezione secondo la quale i diritti della corona facevano parte di un
rapporto di diritto privato, concluse l’impossibilità di tassazione, persino in caso di
guerra, al di fuori del Parlamento.
Persino in caso di guerra. Il punto era estremamente importante perché portava alla luce
l’importanza politica della definizione dei piani dell’ordinario e dello straordinario, della
pace e della guerra, della normalità e della necessità.
Si ricordi che il modello finanziario di stampo medievale prevedeva il ricorso alle
entrate straordinarie approvate dal Parlamento soltanto in casi eccezionali. Ebbene, le
difficoltà del Tesoro avevano finito per rovesciare i termini: la richiesta di erogazione di
stanziamenti straordinari al Parlamento diventò una pratica abituale dal 1572 e proprio in
33
base a questo accresciuto potere, il Parlamento reclamò il ruolo esclusivo di regolatore
normativo dell’economia ordinaria del paese.
Un principio giuridico fondante della common law, in base al quale è l’azione del
sovrano ad essere speciale ed eccezionale, veniva ora fatto valere sul piano delle entrate
a favore della preminenza del Parlamento sul re. Ma quest’ultimo, dal piano stesso del
diritto, avrebbe a sua volta sostenuto la propria prerogativa.
Durante il governo di Carlo I vi furono due casi che segnarono profondamente la
vicenda costituzionale inglese e che meritano quindi un’analisi più dettagliata: il
Darnel’s Case (detto anche “dei Cinque Cavalieri”, 1627) e lo Hampden’s Case (meglio
noto come Shipmoney Case, 1637).
I due erano legati – il primo indirettamente, il secondo direttamente – alla questione
della tassazione, dietro entrambi soffiava il vento della guerra e nelle due sentenze fu
chiamata in causa la specialità e l’eccezionalità della prassi regale.
Ancora una volta il conflitto con il Parlamento (quello del 1626, come è noto, fu sciolto
prematuramente) aveva portato alla negazione dei sussidi al re, questa volta necessari al
fine di sostenere il re danese Cristiano IV nella seconda fase della Guerra dei Trent’anni.
34
Il rimedio fu trovato nei forced loans, facenti parte da tempo dei programmi reali per
accrescere le entrate, ma mai prima d’ora così direttamente legati all’impossibilità di
ricevere aiuti dal Parlamento40.
Nel 1627 la corona fece imprigionare più di settanta gentiluomini rei di averne rifiutato
il pagamento; il King’s Bench – suprema corte del diritto comune – inviò al Consiglio
Privato i writs di habeas corpus richiedendo le motivazioni dell’arresto qualora i
prigionieri non ottenessero la libertà provvisoria.
Il re rifiutò il rilascio su cauzione argomentando che gli arresti erano stati effettuati per
ordine particolare del re (“per speciale mandatum domini regis”), evitando così di
sottomettere la questione dei prestiti forzosi a trattazione giudiziaria41.
Il quesito sulla causa dell’imprigionamento venne così ‘neutralizzato’ dietro una figura
prevista dalla common law, che si rivelò carente ancora una volta di mezzi giuridici
capaci di difendere i diritti dei singoli.
Le questioni sollevate dal caso erano di primaria importanza, non solo perché
riproponevano la questione della legittimità della raccolta di denaro senza
l’approvazione del Parlamento, ma anche e sopratutto perché riguardavano la garanzia di
un diritto che rientrava sempre nell’ambito semantico della property ma che prendeva
ora un altro nome, quello di libertà.
Un’incauta mossa di Carlo I fece esplodere i motivi di una crisi di fiducia nel suo
operato che si veniva delineando già dai primi anni del regno.
40
41
M. Kishlansky, op. cit., p. 148.
A. De Benedictis, Politica, governo e istituzioni nell’Europa moderna, Bologna 2001, pp. 182 ss.
35
In proposito del Darnel’s case i giudici non avevano emesso propriamente un giudizio,
ma un rule of court che impediva che il caso venisse citato in futuro come precedente,
circoscrivendolo a quella determinata occasione. L’Avvocato Generale però tentò di
modificare il verbale in modo da poterlo usare come precedente legale.
La Petition of Right fu la risposta vigorosa alla grave e palese minaccia del diritto che
così si era palesata. In essa il Parlamento colpì puntualmente gli eccessi nell’uso della
prerogativa (proibì, tra l’altro, di tassare senza il suo consenso previo e di arrestare senza
procedimento giudiziario) ma non riuscì ad imbrigliare il loro uso nel caso di stato di
necessità.
Proprio su questo concetto si era giustificata l’estensione del tributo di sostegno alla
marina (ship money) nel 1634; erano passati tre anni da allora quando John Hampden
fece ricorso alle vie legali sostenendo che il tributo non poteva essere ancora difeso con
l’argomento dell’emergenza temporanea e che i fondi avrebbero dovuto ricavarsi
chiedendo un sussidio al parlamento.
La vittoria su misura del re (nel tribunale i voti favorevoli furono sette, i contrari cinque)
fu uno dei segni più chiari della crisi politica e giuridica in atto; su questa fragile base
egli comunque governò, senza il Parlamento, dal 1629 al 1640, a dimostrazione
dell’inefficacia dei mezzi giuridici esistenti a limitare l’azione del sovrano.
Nella primavera del 1640 l’emergenza era talmente grave da non poter essere sottoposta
a valutazione. La rivolta della Scozia e la minaccia d’invasione del paese spinsero Carlo
a convocare il Parlamento, ma in undici anni le tensioni non si erano certo allentate: il
compromesso non fu possibile e l’assemblea venne sciolta dopo poco più di quindici
36
giorni (Short Parliament); dopo le catastrofiche sconfitte belliche, nell’autunno ebbe
inizio il Lungo Parlamento e nell’arco delle vicende che si susseguirono i colpi mortali
inferti ai due corpi del re decisero la vittoria del Parlamento.
Nel confronto entrambe le parti fecero ricorso al diritto, e non al potere, per sostenere le
loro rispettive cause; i giuristi assunsero un ruolo di primissimo piano e il fulcro della
disputa si collocò tutto all’interno della scienza giuridica.
Proprio sui protagonisti, sulle posizioni e i termini di questo dibattito dovremo in seguito
soffermarci.
La lacerazione della common law tuttavia trasse anche e soprattutto origine dalle tensioni
sociali del XVII secolo, e perciò il conflitto costituzionale non è pensabile
semplicemente come un chiaro confronto tra dispotismo e libertà, come una rivolta
contro la centralizzazione o come il tentativo fallito di mettere (di nuovo) in armonia le
due sfere della prerogativa del re e dei diritti dei sudditi, del Government e della
Property.
Abbiamo visto come l’assolutismo inglese sia rinvenibile nella stretta alleanza tra re e
ceto dirigente e non escluda, anzi necessiti del Parlamento come sede istituzionale del
compromesso; come fosse la difesa della proprietà piuttosto che quella della libertà a
imperniare l’alleanza, e infine come la concentrazione del potere consistesse in un
doppio movimento che, finché le entrate lo consentirono, rafforzava reciprocamente
monarchia e classe dei governanti.
37
Quando la sostenibilità finanziaria di questo assetto venne meno e la sovrapposizione
degli ambiti e la vaghezza dei confini tra governo e proprietà posero gravi difficoltà di
prassi politica, fu chiaro che il problema non era risolvibile con gli strumenti stessi del
diritto esistente, che l’armonia rotta nei fatti, poteva rientrare nella teoria del diritto solo
a patto di determinare un nuovo criterio di legittimità in nome del quale garantirsi la
titolarità e il controllo sul potere centrale.
L’appello alla proprietà ricompose in un ampio e incontrollabile movimento il
malcontento di tutti i delusi, dal ceto dirigente toccato recentemente nei suoi privilegi,
alla massa del popolo già da tempo martoriata, passando per i piccoli produttori delle
campagne e delle città, e la causa della libertà economica di cui esso era portavoce
sembrò accomunare le speranze e gli obbiettivi degli scontenti. Sembrò, perché le
divisioni all’interno del Parlamento presto evidenziarono come la difesa della proprietà
non potesse garantirsi in eguale maniera a tutti.
Il discorso di Edmund Waller alla Camera dei Comuni nel 1641 in occasione del
dibattito sulla Root and Branch Petition è estremamente esplicito: se il “bastione”
dell’episcopato fosse preso – affermava Waller – “…da questo assalto del popolo e con
ciò svelato una volta per tutte il mistero, che non possiamo negar loro nulla quando lo
chiedono così in armi, la prossima volta avremo un duro compito nel difendere la nostra
proprietà, come lo è stato l’ultima volta nel salvarci dalla prerogativa. Se…essi
prevalgono nella richiesta di eguaglianza nelle faccende ecclesiastiche, la prossima
richiesta può essere la Lex Agraria, una pari eguaglianza nei beni temporali. (…) sono
convinto che qualora una eguale divisione di terre e di beni sia richiesta, si scopriranno
38
altrettanti punti della Scrittura, che sembrino favorire ciò…E per quanto riguarda gli
abusi cui si riferisce nella Remonstrance, dove si racconta cosa questo o tal’altro
pover’uomo abbia sofferto da parte dei vescovi, così vi possono essere presentati un
migliaio di casi di poveri diavoli, che hanno ricevuto un duro trattamento dai loro
signori”42.
Nel 1642 la guerra civile scoppiò.
42
A Speech Made by Master Waller Esquire in the Honourable House of Commons (1641), citato da B.
Manning, art. cit., p. 360.
39
II
Il miracolo del sistema di common law
Elementi preliminari di storia del diritto inglese
Il percorso sin qui seguito ci ha portato ad indicare la molteplicità dei piani nei quali si
articola la crisi sistemica da cui quest’analisi ha preso le mosse, evidenziando come in
essa concorrano un insieme di fratture e cedimenti che finirono per coinvolgere l’intera
struttura della società inglese.
Abbiamo avuto modo di sottolineare l’importanza assunta dal diritto in questo contesto e
di accennare ad alcuni degli elementi caratterizzanti il sistema di common law che
proprio in questi anni mostrarono segni di ambiguità e di debolezza, rendendo palese la
gravità di una situazione di incertezza giuridica che richiedeva pressantemente la messa
a punto di una riforma complessiva.
Per comprendere pienamente le voci che in vario modo parteciparono a questo dibattito
è però necessario prendere ora in considerazione l’orizzonte teorico dal quale emersero.
40
La mirabile costruzione giuridica inglese aveva dietro di sé una lunga storia quando
giunse la crisi, e a questa sopravvisse appellandosi proprio all’antichità e alla nobiltà
delle proprie radici.
In cerca di rimedi alle carenze man mano emerse, i giusperiti d’oltremanica volsero lo
sguardo all’interno della tradizione di cui erano i rappresentanti, rinvenendovi strumenti
endogeni di identificazione e correzione dei difetti; al contempo, attraverso un confronto
agguerrito con le istanze che minacciavano il sistema dall’esterno, essi indicarono
elementi di adattabilità e perfettibilità che permisero in fin dei conti la messa a punto di
un potente meccanismo di difesa nel quale si articolavano abilmente conservazione e
rinnovamento.
Non è certo questa la sede per ripercorrere minutamente la vicenda storica del sistema di
common law partendo dai suoi albori nel 1066 o dalla definizione delle sue
caratteristiche profonde all’epoca di Enrico II, nonostante la profonda convinzione che
essa racchiuda, come un microcosmo, questioni capitali del tortuoso e lungo cammino
della modernità; si può e si deve però rendere conto del rilievo teorico delle tappe del
percorso lungo il quale si definirono alcuni degli aspetti, taluni più noti, altri meno, che
caratterizzarono sin da allora la peculiare declinazione giuridica inglese, al fine di
scorgere distintamente la natura e i limiti della mediazione che in essa si aspirava
realizzare.
La precocità della tendenza all’accentramento a discapito dei poteri locali è un tratto
indelebile della storia dell’Inghilterra, ma non propriamente un sigillo della sua atipicità.
41
In verità, sotto questo aspetto, la vicenda dell’Inghilterra non conferma tanto un presunto
carattere autonomo e separato – la sua insularità, nel linguaggio della storiografia –, ma
viene piuttosto a collocarsi in una singolare posizione nella storia europea, anticipando,
seconda solo alla Sicilia normanna, tensioni e soluzioni che, pur con specificità
territoriali e in maniera asincrona, segneranno l’intero sviluppo dei sistemi politici e
giuridici occidentali43.
In virtù di questa precocità, un fenomeno che idealmente può essere concepito come la
contrapposizione fra monarchia e cetualismo dei corpi sociali si dilata in un ampio lasso
temporale, all’interno del quale le modulazioni particolari che complicano il quadro fino
a farlo quasi svanire appaiono sì ‘aumentate’, ma in cui risulta anche facilitata l’analisi
delle dinamiche generali che intendiamo ora individuare.
La domanda sociale di certezza del diritto muove con mano ferma i fili della storia
giuridica e delle istituzioni.
Essa chiama in scena, di volta in volta, organi giurisdizionali nuovi capaci di
contrapporsi e concorrere con i vecchi per il raggiungimento della tutela e la garanzia di
una giustizia oscuratasi, evidentemente, dietro la fossilizzazione o la devianza di quelli
nati in precedenza.
Il trionfo della giustizia regia in Inghilterra tra dodicesimo e tredicesimo secolo fu
dovuto al minor costo e alla maggiore efficienza, rapidità ed equità dell’azione dei
tribunali centrali rispetto a quelli locali.
43
Cfr. H. J. Berman, Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, Cambridge
1983, cap. IX (tr. it., Diritto e Rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale, Bologna
1998).
42
Con le riforme del diritto processuale e sostanziale attuate da Enrico II si giungeva al
termine della fase embrionale del processo di accentramento iniziato con Guglielmo il
Conquistatore e proseguito dai suoi successori.
Il concetto di sovranità che presupponeva l’introduzione dell’universal derivative tenure,
sottostava anche alla particolare composizione del tribunale regio dal 1066 al 1154: la
Curia regis “non fu solo un’assemblea feudale dei principali fittavoli del re” ma
“comprendeva anche un gruppo di funzionari regi che amministravano gli affari della
corona per tutto il regno”44.
Il sensibile aumento dell’autorità centrale della Corona che in questo modo si delineava
procedeva lungo un binario doppio: da un parte, coinvolgeva coloro – o almeno una
parte di coloro – a discapito dei quali la giurisdizione regia si era estesa, ridefinendone
il profilo sotto la veste di delegatari locali, amministratori di giustizia incaricati di agire
in nome del re, baroni che, nonostante la sottrazione di rendita connessa direttamente
alla riduzione di giurisdizione, dopo poco più di due secoli avrebbero riconosciuto tale
potestà superiore e richiesto esplicitamente la sua opera di garanzia 45; dall’altra parte,
veniva
creato
quell’importantissimo
corpo
di
ufficiali
itineranti
la
cui
professionalizzazione sarebbe stata raggiunta solo sotto Enrico II.
Questo quadro stabiliva sì un sistema altamente centralizzato, ma rimaneva pur sempre
fondato sul controllo personale del re sul proprio seguito e sui diritti feudali; la sua
azione, inoltre, restava circoscritta all’intervento straordinario e di rimedio in occasione
di gravi reati o di torti avvenuti in casi specifici.
44
45
Ibid., p. 436.
Cfr. U. Mattei, Il Modello di Common Law, Torino 2010, Capitolo Primo.
43
Le riforme di Enrico II si mossero proprio nella direzione della stabilizzazione e della
regolarizzazione del sistema.
È estremamente interessante notare come la battaglia istituzionale dal sovrano
combattuta, che si concluse conferendo carattere permanente ai tribunali centrali e
sigillando in via definitiva l’ampliamento della giurisdizione regia, muoveva
esplicitamente, più che contro le generiche pretese dei baroni, contro la tendenza
specifica dei funzionari locali a “convertire i propri doveri ufficiali in diritti
patrimoniali”46: gli anni dell’interregno di Stefano di Blois furono segnati da questa
prima e significativa forma di sclerosi dell’organizzazione, a causa della quale si faceva
palese una reificazione dell’incarico che finiva per stravolgere le forme e i fini del
compito assegnato, trasformando in titolare il delegatario.
Dal seguente aneddoto traspare, a nostro avviso, la chiara percezione della questione in
gioco nella riforma di Enrico II.
«Una volta accadde che dopo aver sentito una decisione concisa e giusta resa nei
confronti di un ricco a favore di un povero, dissi a Lord Ranolfo [Glanvill]: “Sebbene la
sentenza a favore del povero avrebbe potuto essere rimandata mediante molti cavilli, egli
l’aveva raggiunta per mezzo di una decisione felice e veloce”. “Certamente”, disse
Ranulfo, “noi qui decidiamo le cause in modo molto più rapido dei tuoi vescovi nelle
46
F. W. Maitland, The Forms of Actions at Common Law, Cambridge 1948, p. 12, citato da U. Mattei, op.
cit., p. 4.
44
loro chiese”. “È vero”, dissi, “ma se il tuo re fosse così distante come è il papa dai suoi
vescovi, penso che anche voi sareste lenti come loro”» (corsivo nostro)47.
La precisazione del re plantageneto – nelle mani del quale, conviene ricordare, si veniva
ora a concentrare un esteso dominio che comprendeva anche tutta la Francia occidentale
–
coglieva in controluce uno dei punti nodali del problema insito nella sfida
dell’affermazione storica della common law, ovvero, riuscire a conferire efficacia
all’azione di un sistema giuridico centralizzato operante su un vasto territorio, e quindi
anche necessariamente in regioni distanti dal centro, lontane dagli occhi del sovrano: il
successo dipendeva dalla celerità e dalla felicità dell’esercizio della giustizia del re
anche, e forse soprattutto, in assenza del re.
L’assicurazione dell’indispensabile continuità amministrativa in un contesto spaziale
dilatato richiedeva la formazione di una monarchia impersonale in grado di conferire una
sorta di ubiquità ad una figura che per la maggior parte dei suoi sudditi era ormai
divenuta astratta48.
Due furono gli strumenti predisposti al raggiungimento di tal fine: i writs, sui quali ci
soffermeremo in seguito, e i giudici itineranti49.
47
W. Map, De Nugis Curialium, a cura di M. R. James, Oxford 1914, p. 261, citato da H. J. Berman, op.
cit., p. 434.
48
Cfr. C. Carozzi, “Le monarchie feudali: Francia e Inghilterra”, in N. Tranfaglia e M. Firpo (diretta da),
La Storia: i grandi problemi dal Medioevo all’età contemporanea, Torino 1986, vol. 2, p. 359. Vd. anche
H. G. Richardson e G. O. Sayles, The Governance of Medieval England from the Conquest to Magna
Carta, Edimburgo 1963, p. 169.
49
Cfr. Ch. H. McIllwain, op. cit., p. 80.
45
Ma la nozione chiave su cui poggerà la possibilità stessa dell’intera costruzione è uno
dei pilastri del diritto comune inglese, sviluppo estremo, in verità, di un fondamentale
principio di diritto comune europeo, vale a dire, la Pace del Re50.
Il trapasso dal privato al pubblico nella sfera del diritto repressivo è segnato
dall’affermarsi di questa specifica idea di pace e rimanda a un concetto di law che è
common non perché consuetudinario, ma perché eguale in tutto il regno: eguale in virtù
del suo esser promanato da organi legislativi e giudiziari centrali, comune in quanto
corrispondente ad un’unità politica concretizzatasi anche come effetto dell’attività di un
ceto di giuristi professionisti.
Si tratta di un aspetto originario che deve essere rimarcato con forza perché, pur
parzialmente eclissatosi nell’evoluzione storica del sistema giuridico inglese51, non
scompare mai, anzi e in maniera significativa riemerge prepotentemente ogni qual volta
le strutture di quest’ultimo si irrigidiscono, minacciando così la pace stessa.
Si tenga a mente quindi come la sorprendente via percorsa dalla common law inizi di
fatto con il gesto di un’invisibile mano sovrana che stila (di diritto scritto si tratta52!) un
diritto che, nel suo articolarsi effettuale, proseguirà il cammino tendendo
Cfr. M. Lupoi, Alle radici del mondo giuridico europeo, Roma 1995, pp. 484-485: “(…) è nella
monarchia inglese del XII secolo che si palesa l’estremo sviluppo del bannum carolingio: la Pace del Re
avvolge l’intero Stato e la sua violazione è un crimine contro il re; su questa nozione viene posto uno fra i
più importanti pilastri della giurisdizione accentrata di common law e dunque del diritto comune inglese”.
51
Cfr. U. Mattei, op. cit.: “Il «miracolo» del common law è quello di un diritto regio, e quindi comune a
tutti i sudditi, nato negli interstizi dei diritti particolari e via via sviluppatosi in maniera tale per cui la sua
natura di trionfo del centralismo regio non venne mai percepita, se non in misura comparativamente assai
limitata. Un diritto regio che ben presto si affrancò anche dallo stesso Re e venne ad assumere tali
caratteristiche di tecnicismo e, in definitiva, di imparzialità, che gli consentirono di sopravvivere a guerre
civili, rivoluzioni e rivolgimenti storici epocali, giungendo fino a noi con immutato carisma e prestigio
sociale”. Il fatto storico all’origine del «miracolo» del diritto inglese è quindi il trionfo del Re e della sua
pace.
52
Cfr. M. Lupoi, op. cit., p. 369.
50
46
progressivamente a rimuovere la sua fonte, per giungere, all’apice di quest’oblio, persino
a volerne vanificare la presenza, immobilizzandola.
Non ingannino le parole. Difficilmente si può immaginare qualcosa di più concreto ed
evidente delle riforme messe in atto da Enrico II: l’impronta che egli diede alle forme di
giustizia fu talmente profonda e definitiva da far sì che queste non venissero mai più
messe seriamente in discussione; ma ciò che orientava il percorso era la ricerca e la
formulazione di risposte alla domanda di certezza del diritto, prima e più che
un’adozione cosciente e personale della Corona.
L’innovazione nelle istituzioni in direzione della regolarità e permanenza del loro
carattere fu dunque il tratto saliente della trasformazione dell’amministrazione e della
giustizia pubblica guidata dal Re: nel 1178 il Bench, tribunale antenato della Court of
Common Pleas, che in futuro avrebbe deciso le cause civili, aveva dimora fissa a
Westminister; all’inizio del secolo successivo la Court of King’s Bench giudicava
regolarmente e in presenza del Re le cause che riguardavano in maniera diretta la
Corona; si trovava ad affiancare entrambe un organismo dall’importanza cruciale, la
Cancelleria, incaricato di emettere ordini in nome del Re nella forma di writs o di altri
tipi di documenti formali sigillati col Great Seal (avremo modo di sottolineare più
precisamente l’enorme rilievo di questo istituto quando affronteremo la questione della
nascita dell’Equity).
Sul fronte dell’organizzazione delle finanze, lo Scacchiere completava la configurazione
dello Stato inglese, tracciando un quadro d’insieme in cui è ben visibile sia lo sforzo di
47
definizione istituzionale, sia l’indicazione del pesante compito dell’arte di governo per i
secoli a venire, ovvero il mantenimento del precario equilibrio tra due elementi
essenziali, la giustizia e le finanze.
Per comprendere meglio il modo in cui i mutamenti dei metodi e delle procedure
trasformarono anche il contenuto della giustizia converrà soffermarsi ora su una delle
principali tra le riforme enriciane, la giurisdizionalizzazione dei writs.
Per secoli in Europa la notificazione della volontà dei re era avvenuta mediante brevi
ordini scritti (i brevia della lingua latina), i quali assunsero in inglese il nome di writ: a
questi “viene ascritto il merito di aver fatto venire in esistenza non soltanto un sistema
centralizzato di giustizia ed una gerarchia unitaria di corti, ma anche un medesimo diritto
oggettivo per l’intero regno d’Inghilterra”53.
Seguendo un percorso complesso di progressiva specializzazione, il writ inglese conosce
durante il XII secolo – ultima delle tappe in cui è scandibile la sua evoluzione – una
fase di ulteriore specificazione, tendendo a definirsi come mezzo tecnico dell’imperio
reale tanto per l’emanazione di ordini amministrativi, quanto per l’avvio delle cause
davanti alle corti del Re.
Con questo passaggio finale la forma propria nella quale si concretizzava il carattere
occasionale e rimediale della giustizia regia di cui abbiamo già avuto modo di dire,
diveniva uno strumento tecnico di uso regolare che coinvolgeva in maniera attiva i
funzionari della Corona nella Corte, gli avvocati e infine la popolazione all’interno della
giuria.
53
Ibid., p. 389.
48
Nella sua più antica versione il writ conteneva un ordine per mezzo del quale il Re
comandava agli sceriffi di attivarsi in un determinato senso per la soddisfazione della
parte che era riuscita a portare all’attenzione del sovrano il torto subito; l’ordine
contenuto nell’executive writ non si dirigeva contro i pronunciamenti dei tribunali locali
(non si trattava quindi di un giudizio d’appello), ma era la dichiarazione di un rimedio
ultimo concesso dalla graziosa volontà del Re, nel caso eccezionale in cui la
giurisdizione feudale non fosse riuscita a fare pieno diritto.
Inserendosi così nelle lacune delle procedure consuete (gli “interstizi” di Sumner
Maine54), il diritto regio inglese mostrava sin dagli inizi uno dei suoi tratti peculiari:
assumendo le sembianze della grazia, esso s’insinuava prepotentemente nei luoghi non
raggiunti dalla giustizia ordinaria per realizzare un ‘miracoloso’ affinamento
giurisprudenziale della giurisprudenza stessa; in questo modo la giustizia del Re
emendava sì in via straordinaria il diritto tradizionale esistente, ma finiva
insensibilmente anche per trasformarne la struttura portante in maniera duratura.
Con Enrico II assistiamo alla metamorfosi dell’antico executive writ in judicial writ: egli
“trasformò l’ordine regio dal comando di «Fare questo o quello» in «Convocazione di
un’inchiesta da parte dei giudici per definire la questione controversa – e lì ottenere il
writ»”55.
54
55
Cfr. H. Sumner Maine, Dissertations on Early Law and Customs, London 1981, p. 389.
H. J. Berman, op. cit., p. 446.
49
Con questo slittamento capitale verso la procedura intesa in senso tecnico – nel quale ci
sembra appunto di poter intravedere i primi passi della ‘miracolosa’ mimetizzazione
dell’intervento regio, nonché la prima manifestazione di quello* che diventerà il perno
del diritto inglese – si infrangeva l’idea dell’ordine imperativo e monolitico del potere
regale: una decisione personale chiamata a tutelare una determinata posizione giuridica
cedeva il passo ad un comando articolato; mentre nel breve esecutivo si realizzava una
giustizia che consisteva nell’essere risposta univoca e definitiva al tenace sforzo, anche
economico, in virtù del quale la voce della parte lesa aveva raggiunto le orecchie del
sovrano smuovendone la volontà, nel breve giurisdizionale prendeva corpo invece un
bisogno che riguardava la risoluzione di più numerose e complesse cause, l’insieme
delle quali richiedeva adesso l’adempimento di un compito di tutela quantitativamente e
qualitativamente mutato, perché connesso al mantenimento della pace del re.
In nome di questo alto principio, all’immediatezza, che legava precedentemente il venire
a conoscenza del torto alla presa di decisione in merito, si sostituiva un lasso di tempo
nel quale si sarebbe dovuta determinare la rilevanza giuridica degli avvenimenti: per
decidere, al Re non sarebbe più stato sufficiente ‘venire a sapere’; ora egli era ‘tenuto a
sapere’, e perciò gli era indispensabile la definizione mediata e quanto più oggettiva ed
imparziale della questione di fatto.
La giurisdizione regia veniva quindi a stabilirsi, innanzitutto e ancora, sull’emissione
dell’ordine scritto, con la fondamentale differenza però che il nuovo writ non conteneva
un ordine a procedere, ma comandava di avviare un’indagine orientata a condurre ad un
processo; in questa maniera la giustizia del Re stabiliva anche, e in maniera innovativa, i
modi specifici secondo i quali tale procedimento doveva essere condotto.
50
Il consolidamento del sistema di giustizia centralizzato ad opera di Enrico II non andava
nella direzione dell’onnipervasività, né il suo ampliamento significò l’abolizione dei
tribunali tradizionali, ma rappresentava piuttosto la “creazione di una giurisdizione regia
concorrente nelle cause ordinarie che coinvolgevano particolari tipi di pretese – ed esse
erano piuttosto numerose – che avevano un impatto sull’ordine pubblico”56.
In questo modo, si definiva in nome della stabilità del regno un ambito di specifiche
cause suscettibili di essere giudicate anche dai tribunali reali e nelle rigide procedure di
questi ultimi veniva normalizzato il nesso torto/rimedio per una serie determinata di
controversie.
Il modello dei writs aveva dato origine a nuovi tipi di forms of action il cui metodo di
prova non era più l’ordalia o il duello, ma quello di una giuria chiamata a decidere in
termini di vero o falso su un punto di rilevanza giuridica preparato dai common lawyers:
furono infatti questi ultimi ad adoperarsi maggiormente per perfezionare l’attacco
sferzato al monopolio dei diritti locali, affinando e forzando con ogni mezzo
l’argomentazione legale (pleading) in modo da far rientrare i loro casi nella classe di
torti tutelata dalle corti centrali.
In sinergia con la loro azione e in base al principio enunciato da Bracton secondo il
quale “dove c’è un torto, c’è un rimedio” (che in verità corrisponde ad affermare che la
classe delle causes of action è aperta), la Cancelleria moltiplicava l’emissione di writs
dando avvio ad un’attività che progressivamente avrebbe visto addensarsi, intorno a casi
56
Ibid., p. 453.
51
simili, simili rimedi, producendo brevi stereotipati che rappresentavano di fatto,
nonostante l’apparenza procedurale, un esercizio legislativo.
Furono proprio questi passi evolutivi a conferire al diritto inglese quello stile
giurisprudenziale peculiare che costituisce storicamente un’alternativa alle teorie di
responsabilità giuridica sull’esempio del diritto canonico.
Questo sviluppo dinamico ebbe sul piano del governo enormi ripercussioni, le quali però
incontrarono ben presto un limite intrinseco.
Il sistema dei writs incarnava una dialettica complessa tra ampliamento e delimitazione
della giurisdizione regia, che vedeva il farsi ordinario e regolare dell’intervento
indissolubilmente legato alla specificazione tecnica dei casi e delle modalità di agire;
proprio il fatto che il suo carattere fosse concorrenziale e non onnicomprensivo, permise
ai poteri locali di porre un freno alla produzione di brevi da parte della Cancelleria,
finendo per modificare con le sue stesse armi il segno originario del sistema: la
cristallizzazione delle forms of action, ascrivibile in gran parte alla limitazione
dell’emissione di writs ad opera delle Provisions of Oxford del 1258, fece sì che fosse un
numero chiuso di rimedi ora a precedere e determinare i diritti, invertendo di fatto i
termini dell’affermazione di Bracton57.
In questa fase successiva e per molti versi definitiva, furono gettate le basi di un assetto
istituzionale nel quali formule e mandati regi, nati sia per arginare derive anarchiche e
violente, sia per competere in efficacia e agilità con i tribunali locali, feudali ed
57
F. W. Maitland, op. cit., p. 6.
52
ecclesiastici, divennero l’ossatura immutabile del diritto e il nucleo permanente
dell’azione di governo.
La spinta centralistica in Inghilterra non voleva né poteva mirare alla scomparsa delle
corti locali; la cifra profonda del suo precoce successo consistette proprio nel definire in
maniera duratura una modalità di rapporto tra poteri coesistenti, tracciando così uno
schema concettuale destinato ad avere grandissima fortuna e rilievo nella storia del
pensiero e delle istituzioni anglosassoni.
Si trattò dell’affermazione di una tecnica giuspolitica rivelatasi doppiamente capace:
essa garantiva, anzitutto, certezza giuridica, perché agiva in nome di un principio
generale di mantenimento della pace, definiva specifici ambiti di competenza per ognuna
delle istanze e stabiliva rigide forme procedurali; si dimostrava poi un formidabile
strumento politico in grado di spostare i confini stessi del potere.
Con l’espansione della giurisdizione regia e il conseguente ridimensionamento dei poteri
ecclesiastici e feudali si realizzò per la prima volta un modello di coesistenza e
restrizione delle sfere di potere che, presto fu chiaro, era applicabile anche alla
delimitazione del potere stesso del Re.
Tentiamo di spiegare meglio le caratteristiche di questo nuovo modello ricostruendone
sinteticamente le vicende all’origine. All’apice della sua evoluzione, il sistema dei writs
era riuscito a mettere in moto un meccanismo di produzione di giustizia effettivamente
alternativo, espressione di un potere
– quello reale –
il cui compito consisteva
53
esclusivamente nel definire forme procedurali proprie, nelle quali sarebbero andate poi a
inserirsi e a risolversi rivendicazioni e torti determinati.
Nella trama sottile di questa rilevante limitazione di competenza è importante notare
come la comparsa di corti centrali così concepite, pur implicando la nascita di soggetti
nuovi, lasci immutato un aspetto strutturale della situazione precedente: il giudizio,
nell’antico processo, è il giudizio di Dio; ogni problematicità legale attiene
esclusivamente alla forma seguita nell’avviare il caso.
Non accade diversamente nei tribunali del Re, dove ogni sentenza è una Sua sentenza,
certa e giusta purché corrispondente a specifiche forms of action.
Nei tribunali antichi e nuovi la centralità del momento formale garantiva, in entrata,
un’enorme plasticità data sia dalla possibilità di adeguare svariati casi alle numerose
forme consuete, sia dalla moltiplicabilità delle forme d’azione stesse; in uscita, si
stabiliva una rigida, univoca e regolare connessione con un verdetto infallibile in grado
di ristabilire la giustizia.
Intorno ai writs si era articolato quindi un percorso parallelo (e per alcuni versi analogo a
quelli già esistenti) che, sviluppatosi inizialmente di volta in volta in risposta a puntuali
esigenze dei postulanti, si collocava fuori da – e in opposizione all’idea di – un sistema
giuridico comprensivo.
La successiva cristallizzazione delle forme d’azione sta a testimoniare però
l’impossibilità pratica di un’amministrazione della giustizia indefinitamente aperta al
54
caso concreto: la plausibilità e l’appetibilità politica della common law richiesero la
limitazione del numero dei writs, ovvero la necessità di segnare il confine entro e non
oltre il quale sarebbe stata riconosciuta la legittimità dell’azione delle corti reali.
In questo modo il nuovo sistema di diritto, pur rimanendo estraneo ad ogni cornice
astratta, sacrificava uno dei suoi elementi di plasticità a favore del consolidamento sia
della procedura come perno stabile della sua attività, sia delle forme d’azione già
stabilite come elementi strutturali immodificabili.
Lungo questo percorso era stata la giurisdizionalizzazione dei writs sotto Enrico II ad
indicare il metodo in virtù del quale sarebbe stata possibile l’espansione ed infine il
trionfo della common law: il successo dell’azione dei tribunali regi non sarebbe
spiegabile senza l’introduzione di questa mediazione, grazie alla quale veniva gettato un
ponte tra centro e periferia, nonché tra incertezza e verità.
È stata però un’altra riforma enriciana, intimamente legata al mutamento dei writs ma di
cui precedentemente si è detto solo en passant, a conferire spessore materiale ed
efficacia concreta ad un processo che, esposto solo nei termini suddetti, potrebbe
apparire fin troppo etereo.
Con l’introduzione della giuria si portava sul piano del nuovo sistema di diritto una
pratica già esistente nell’amministrazione normanna: l’uso di inchieste giurate per
l’ottenimento di informazioni rilevanti.
55
La più imponente e degna di memoria fu condotta da Guglielmo I, e sulla sua base
scaturì la compilazione del Domesday Book, il Libro del Giorno del Giudizio58, titolo più
che adatto per il primo catasto fondiario della storia d’Europa.
Occasionalmente anche i tribunali ecclesiastici avevano fatto ricorso a giurie di dodici
membri per la delucidazione e talvolta perfino per la decisione di controversie.
L’adozione stabile del processo per inchiesta nella cause civili di competenza dei
tribunali centrali rappresentò un’importantissima innovazione. Grazie ad essa trovarono
spazio fattori determinanti che avrebbero finito per rendere il trial by jury un metodo
probatorio preferibile rispetto a quelli dell’ordalia o del duello. Preferibile perché
migliore: dal punto di vista politico, il coinvolgimento della popolazione locale sotto la
guida di funzionari regi risolse la tensione tra l’esercizio decentrato della giustizia e il
suo controllo centralizzato, offrendo un’alternativa accettabile rispetto alle antiche
assemblee feudali; dal punto di vista giuridico, il suo lento affermarsi significò il rigetto
della procedura inquisitoria tipica del mondo di civil law e sigillò uno tra i più distintivi
caratteri del sistema di diritto inglese.
Questo passaggio si diede in via definitiva però solo quando vi fu il bisogno di dare una
risposta istituzionale all’abolizione dell’ordalia sancita dal concilio Lateranense IV
(1215).
La prima occorrenza del nome con cui è nota l’inchiesta si trova nel Dialogus de Scaccario, scritto sotto
Enrico II da Richard FitzNeal, il quale così spiegava: “For this reason we call this book the ‘book of
judgments’, not because it contains decisions made in controversial cases, but because from it, as from the
Last Judgment, there is no further appeal”. Vd. E. Amt, S. D. Church (a cura di), Dialogus de Scaccario,
and Costitutio Domus Regis: The Dialogue of the Exchequer, and The Establishment of the Royal
Household, New York 2007, pp. 96-99.
58
56
L’introduzione di un elemento umano chiamato a sostituire il giudizio di Dio espresso
attraverso gli elementi, non è in alcun modo interpretabile come gesto unilaterale e
risolutivo, segno di un processo di secolarizzazione banalmente inteso59; esso
rappresentò piuttosto la travagliata e sofferta risposta da parte della Corona, ormai sul
capo di Enrico III, ad un divieto della Chiesa che di fatto lasciava disarmata la giustizia
penale del regno60.
In un primo momento ai giurati venne chiesto di riferire quanto sapevano in base
all’ipotesi che essi, in quanto compaesani dell’imputato, conoscessero la verità sui fatti e
potessero quindi giurare di dichiararla, per l’appunto, veracemente.
La varietà e la discrepanza, nonché talvolta persino la contraddittorietà e l’inattendibilità
dei veredicta – vicini piuttosto a testimonianze e dicerie che non a verdetti veri e propri
–
delineò una procedura inquisitoria incerta, nella quale il giudice, esaminata
l’informazione raccolta, risolti i punti di contrasto e così raggiunta l’evidenza, decideva
e sulla questione di fatto, e sulla questione di diritto61.
L’infallibilità del giudizio sembrava messa in questa maniera a dura prova, al punto da
fornire l’occasione a coloro che si opponevano all’abolizione dell’ordalia di difenderne
il prestigio e la certezza.
Un breve accenno sarà forse sufficiente per cogliere la complessità della vicenda: l’ordalia e il duello
giudiziario, pratiche cruciali grazie alle quali si mantiene la separazione tra la parzialità dell’uomo e
l’infallibilità di Dio, vengono superati e condannati nel concilio del 1215 perché la “giustizia della Chiesa
tenderà a conciliare e inglobare la giustizia umana e la giustizia divina” (corsivo nostro). Vd. P. Prodi,
Una storia della giustizia, Bologna 2000, p. 48.
60
Cfr. T. F. T. Plucknett, A concise history of the common law, Boston 1956, p. 119.
61
Ibid., pp. 123-124.
59
57
Il baricentro venne quindi spostato all’opposto estremo: i giudici scaricarono l’intera
responsabilità sulla giuria, chiamata ora a pronunciarsi semplicemente in termini di vero
o falso, ed ebbero ad affermare l’imperscrutabilità del verdetto. Per eccesso, la sentenza
risultava così una specie di nuova ordalia, accettata pienamente senza venir posta in
alcun modo in discussione.
La razionalizzazione della giuria fu il risultato di un lento procedere per tentativi alla
ricerca della certezza del diritto.
La definizione di un istituto che avrebbe caratterizzato in maniera così peculiare
l’esperienza giuridica inglese dovette attendere la progressiva distinzione tra la funzione
della testimonianza e quella del verdetto per poter ribadire poi chiaramente la
separazione tra jury e judge.
Soltanto quando al veredictum corrispose la scoperta della verità dei fatti, e non più la
dichiarazione veritiera di quanto saputo (a metà del XVI secolo ai giurati non era
consentito di ricorrere alla propria conoscenza personale dei fatti in causa; essi dovevano
giudicare solo ‘secondo coscienza’), fu possibile assegnare alla giuria una sfera di azione
autonoma ed imparziale, differente sia da quella dei testimoni, sia da quella dei giudici.
Concepire gli iuratores esclusivamente e propriamente come judges of fact in dovere di
pronunciare un giudizio unanime, essendo la verità una ed una sola, implicava la
separazione netta tra questione di fatto, di competenza della giuria, e questione di diritto,
appannaggio unico della corte.
58
Naturalmente solo parte di questo percorso fu compiuto durante il regno di Enrico II.
Nell’ambito delle cause penali, l’Assise di Clarendon (1166) aveva reso stabile l’accusa
da parte della giuria, ma non il processo, il quale veniva regolarizzato per i sospettati di
fellonia nella forma esclusiva
– si badi bene –
dell’ordalia dell’acqua fredda,
escludendo quella del fuoco e il duello.
Diversa ed estremamente significativa fu la disposizione della medesima assemblea in
ambito civile: l’assize of novel disseisin – rivelatasi col tempo una delle leggi più
importanti tra quelle mai emanate in Inghilterra62 –
stabiliva che sarebbe stato il
processo per inchiesta a decidere azioni di reintegrazione in caso di recente
spossessamento.
Nel 1176 l’assize of mort d’ancestor, e più tardi quella di darrein presentment
completarono il quadro delle assisi possessorie: l’estensione dell’uso della giuria
riguardò rispettivamente le questioni circa il possesso in caso di morte del proprietario e
quelle in cui si doveva determinare la parte cui spettasse il diritto di aggiudicare un
beneficio ecclesiastico resosi vacante.
La regolarizzazione del trial by jury per questo specifico tipo di cause pone in evidenza
la stretta connessione tra l’impiego d’inchieste giurate e la protezione del possesso63
(visibile per la verità già nelle linee guida della compilazione del Domesday Book, dove
la tenure da tutelare era però quella del Re).
62
Cfr. F. Pollock, F. W. Maitland, The History of English Law Before the Time of Edward I, vol. I, New
Jersey 2008, p. 146.
63
Ibid., p. 143.
59
Essa rivela anche di più: il programma complessivo di normalizzazione e pacificazione
che Enrico II si propose di realizzare, doveva intercettare il piano sul quale la
conflittualità
dimostrava
essere
maggiormente
frutto
dell’intreccio
e
dell’interdipendenza tra moventi di tipo giuridico, politico ed economico, vale a dire, il
diritto di proprietà64.
Fu proprio su questo piano che le innovazioni formali si dimostrarono insufficienti: il re
“aveva bisogno di qualcosa di più delle nuove tecniche di soluzione delle controversie
mediante tribunali professionali, dei vari tipi di breve, delle inchieste regie e delle forme
d’azione; egli aveva bisogno anche di un nuovo ordine sostanziale della proprietà
terriera, un ordine che fosse in grado di penetrare la complessità degli interessi politici
ed economici coinvolti. Lo trovò nel concetto di possesso”65.
La complessità di interessi era senz’altro correlata alla compresenza di molteplici diritti
sulla terra propria del sistema di diritto feudale.
Si trattava di una realtà alla quale mal si adattavano i concetti di possesso e di proprietà
di tipo romano, perché qui il secondo non poteva assumere il carattere di esclusività
assoluta, ed il primo indicava più della semplice occupazione di fatto o dei diritti che da
essa derivavano.
Per comprendere la rilevanza generale dell’argomento, nonché quella specifica rispetto alla nostra
analisi, converrà riportare le seguenti parole di McIlwain: “Il diritto medievale di proprietà era anche il
diritto alle franchigie o libertà, dello status personale, del pubblico ufficio e di molto altro ancora. Ad
esempio, anche una cosa così costituzionale come la prerogativa del re, quando diventava oggetto di
discussione giuridica, era trattata nei tribunali applicando le stesse norme, che valevano per il diritto di
proprietà di un suddito”. Vd. Ch. H. McIlwain, op. cit., p. 82.
65
H. J. Berman, op. cit., p. 455.
64
60
L’ampliamento del concetto di possesso significava quindi il perfezionamento di uno
spazio di tutela che nel diritto romano restava limitato e subordinato a quello della tutela
della proprietà, e che reclamava invece in questo contesto uno statuto giuridico
autonomo, rivendicabile, in fin dei conti, persino nei confronti del proprietario stesso.
L’assise di recente spossessamento era per l’appunto un’azione contro l’espropriatore,
indipendente dalla proprietà.
Essa stabiliva una procedura regia che sanciva una legittimità nuova e forgiava
tenacemente un istituto sconosciuto in precedenza: il possesso incondizionato.
La cifra di questo fondamentale concetto sembra essere la sublimazione di una
situazione di fatto a diritto reale. Nella saisine il possesso veniva innalzato al rango dei
diritti e così lo si rendeva non solo indipendente dal controllo e dall’occupazione fisica
(corpore) della terra, ma anche riferibile a beni mobili o immateriali.
La giurisdizione regia, illuminando una zona d’ombra concettuale alla quale
corrispondeva però un’evidente realtà materiale, definiva un ambito di propria
competenza che sottraeva potere (ma non solo, lo vedremo appena di seguito) ai
tribunali baronali ed ecclesiastici.
Questa categorizzazione faceva “parlare” la realtà conferendogli certezza: perciò fu in
grado di dar vita ad un ordine sostanziale nuovo.
61
Compiuta questa sublimazione, dove veniva a collocarsi la fonte di legittimità della
saisine? Essa risiedeva evidentemente nel passato.
Si trattava di “un possesso reso venerabile dal tempo”66 che il re avrebbe protetto
indefessamente una volta sentite le risposte a specifiche domande di fatto.
Non una raccolta di prove, dunque, ma un celere ed efficace appello alla memoria degli
uomini innervava il processo che avrebbe offerto rimedio contro il disseisin, rivelando
una movenza tipica della common law: l’intervento eccezionale del re colmava
celermente una lacuna nelle procedure tradizionali, non creando – almeno all’apparenza
– diritto, ma conferendo spessore giuridico a posizioni antiche non ancora tutelate.
In maniera ancora emblematica, la stabilizzazione delle assisi possessorie dimostra come
l’espansione del sistema di giustizia regio implicò qualcosa di più complesso della
semplice sottrazione di giurisdizione alle corti feudali ed ecclesiastiche.
All’interno di queste assisi vigeva esplicitamente un principio di diritto privato che il re
aveva già fatto valere a difesa dei propri possedimenti e che ora, per grazia e in via
eccezionale, veniva reso agibile anche ai liberi possessori; vigeva inoltre,
potenzialmente, un importantissimo principio di diritto pubblico, a dimostrazione
dell’indistinguibilità e della sovrapposizione degli ambiti giuridici in epoca medievale
particolarmente nel mondo di common law: “the king himself will protect by royal writ
and inquest of neighbours every seisin of a free tenement. It is a principle which in
66
M. Bloch, La société féodale, Paris 1939-40, Vol. I, Libro secondo, cap. V (trad. it., La società feudale,
Torino 1974, p. 136)
62
course of time can be made good even against kings. The most famous words of Magna
Carta will enshrine the formula of the novel disseisin”67.
Converrà soffermarsi sulla prima parte della lucida formulazione di Pollock e Maitland.
La definizione delle cause specifiche di competenza dei tribunali centrali, condusse il
diritto inglese nella seconda metà del dodicesimo secolo a distinguere nettamente due
grandi categorie di possedimenti fondiari: da una parte, vennero qualificate come nonlibere le terre gravate da servizi disonoranti e dalla durata precaria (vi furono comprese
quindi la maggioranza delle piccole aziende contadine); le restanti terre, dall’altra,
costituirono le free tenures, alle quali si estese col tempo il nome e le caratteristiche –
l’ereditarietà in primo luogo – dei fees68.
Solo il possesso di queste ultime sarebbe stato protetto dalle corti del re; tutto ciò che
riguardava le unfree tenures rimaneva invece in mano alle corti locali.
Concepita in questo modo ed inserita in un quadro nel quale i termini del binomio terrauomo risultavano difficilmente individuabili, la separazione tra tribunali regi e feudali
portava con sé una nuova classificazione degli status, modificando anzitutto la nozione
stessa di libertà e schiavitù.
Secondo quale criterio? Ebbene, secondo il criterio della tutela del diritto.
67
68
F. Pollock, F. W. Maitland, op. cit., p. 146.
M. Bloch, La società feudale, cit., p. 218.
63
Nella giurisprudenza che si stabilì, soltanto i freemen trovarono riparo sotto l’ombra
protettrice del re, mentre i villani, nei rapporti col loro signore, furono sottratti alle corti
regie divenendo i secondi in blocco (e a differenza che in passato), uomini-legati
(bondmen).
Il principio fatto valere a monte faceva parte della tradizione del diritto comune europeo:
il servo non poteva essere giudicato e punito da nessuno al di fuori del suo signore,
ovvero, la libertà significava – in uno dei suoi molteplici sensi – la totale dipendenza
dal tribunale pubblico.
La straordinaria precocità dello sviluppo giuridico inglese e la risoluzione dei problemi
concreti che essa pose, ne richiese l’applicazione rigorosa al fine di conferire celermente
plausibilità e stabilità al sistema.
Ma la maglia della concezione risultò per un verso troppo stretta e per l’altro troppo
larga per setacciare efficacemente la realtà: pochi uomini potevano affermare di avere
sopra di sé come unico signore il re, ove moltissimi, anche di posizione elevata o di
antichi liberi natali, si trovavano in anelli inferiori della vasta rete di dipendenze che
innervava la società; questi ultimi, pur avendo possedimenti all’interno di estesi manieri,
non avrebbero potuto certamente essere definiti come non-liberi.
La forte disparità tra liberi e villani così intesi richiamò nel tempo l’uso di un altro
principio comune al senso dei tempi, secondo il quale lo schiavo era tenuto a fornire
tutto il suo lavoro al padrone: nel tredicesimo secolo la nozione di villein si era
significativamente ridotta ai detentori di terre obbligate da corvées estremamente
gravose e da servigi considerati poco onorevoli.
64
All’opera vi era il criterio dei servizi, il quale, applicandosi più all’uomo che alla terra,
spezzava efficacemente l’antica coincidenza dei loro statuti e scopriva il mezzo per
intenderli distintamente69.
Il problema della coesistenza della giustizia regia con quella aristocratico-fondiaria si
risolse con la conclusione di un accordo confinario tra le due potenze; il tratto netto che
divise in Inghilterra i poteri giudiziari, divise altrettanto chiaramente la società: una
rigida frontiera gerarchica
– benché collocata più in basso rispetto ad altre realtà
europee – estendeva di fatto la nozione di servitù e l’assoggettamento stesso ad una
massa di contadini un tempo variamente differenziata, la quale veniva omologata nel
vilainage e abbandonata in gran parte all’arbitrio del signore.
In cause riguardanti terzi il re avrebbe prontamente fatto giustizia ove richiesta, ma egli
rinunciava del tutto a interferire nel rapporto tra il Lord e i suoi uomini.
La concezione del villano come non-libero solo ed esclusivamente in rapporto al suo
signore, ma libero – perché avente diritto alla giustizia pubblica – nei confronti di
chiunque altro, era una sottigliezza giuridica che s’infrangeva contro il semplice
esercizio del concreto potere politico dell’aristocrazia inglese. Un’aristocrazia che,
intesa come classe contrassegnata dal sigillo della libertà, dove il semplice freeman non
69
Cfr. Ibid., pp. 304-309.
65
differiva de jure dal gentiluomo, era certo meno definita e più aperta della nobiltà (prima
di sangue e poi di diritto) tipica del continente, ma costituiva pur sempre un’oligarchia70.
La barriera del potere signorile che il re si asteneva implicitamente dal varcare già nella
formula del novel disseisin, sarebbe venuta a consolidarsi nell’articolo 39 della Magna
Carta del 121571 e ancor più chiaramente nel corrispondente articolo 29 della redazione
del 1217; a quest’ultimo fa riferimento la seconda parte della citazione di Pollock e
Maitland da cui abbiamo preso le mosse. Converrà riportarlo per intero:
Nullus liber homo decetero capiatur vel inprisonetur aut disseisiatur de aliquo
libero tenemento suo vel libertatibus vel liberis consuetudinibus suis, aut
utlagetur, aut exulet, aut aliquo alio modo destruatur, nec super eum ibimus,
nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum, vel per
legem terre72.
Sin dalla prima versione traspare la distinzione fondante su cui poggia il potente
principio espresso nel testo, ma è la significativa interpolazione di ben tre nuove nozioni
nella seconda stesura che specifica definitivamente il senso dell’asimmetria.
70
Ibid., p. 375.
Cfr. C. Bemont, Chartres des libertés anglaises, Paris 1892, p. 33. Vd. P. Vinogradoff, “Magna Carta,
Clause 39” , in H. E. Malden (a cura di), Magna Carta. Commemoration Essays, London 1917, pp. 78-95.
72
C. Bemont, op. cit., p. 55. In corsivo le aggiunte non presenti nella prima revisione del testo (1216).
71
66
L’articolo 39 traccia una linea di confine che esclude e subordina gli unfree villeins,
perché la garanzia di certezza e uguaglianza giuridica, cimentata sul giudizio dei pari,
non si applica al servo sottoposto al suo superiore, ma soltanto all’uomo libero.
Il bisogno di disporre di un criterio materiale separato dall’uomo che più efficacemente
scinda libertà e schiavitù, indicando concretamente l’uguaglianza che caratterizza e
definisce pari modo i freemen, condurrà infine all’aggiunta del ’17.
Che cosa sono quindi il liberum tenementum, le libertates e le liberae consuetudines?
Dei primi abbiamo già avuto modo di dire: si tratta dei liberi poderi, in opposizione alle
tenures in vilainage; le seconde comprendono immunità e franchigie di vario tipo,
mentre le ultime riguardano il diritto di riscuotere dazi e più in generale un insieme di
interessi personali di stampo monopolistico73.
Considerati assieme, costituiscono gli uguali privilegi dell’aristocrazia inglese74, quegli
stessi che con la mobilità della fortuna fondiaria si sarebbero inevitabilmente e
progressivamente erosi e riconfigurati.
“In verità era fatale che un giorno o l’altro intervenisse la giustizia regia dal momento
che talvolta un esproprio riguardava l’ordine pubblico”75: ciò accadde circa un secolo e
mezzo dopo la prima stesura della grande carta delle libertà inglesi.
73
Cfr. W. S. McKechnie, Magna Carta: A Commentary on the Great Charter of King John, with an
Historical Introduction, Glasgow 1914, pp. 383-384.
74
Cfr. M. Bloch, La società feudale, cit., p. 225: “Dal vecchio capitolare carolingio alla Magna Charta
(sic), fondamento classico delle libertà inglesi, questa specie di uguaglianza nel privilegio, che si
ripercuoteva così dall’alto in basso, era destinata a restare uno dei più fecondi principi della consuetudine
feudale”.
75
M. Bloch, Signoria francese e maniero inglese, cit., p. 192.
67
Le riforme di Enrico II contenevano quindi in nuce principi opponibili alla figura stessa
del re? La traccia del discorso che seguiamo vuole spostare non tanto la risposta, quanto
i termini stessi della domanda: se le riforme enriciane
– ma più correttamente
dovremmo dire i caratteri del governo dopo la conquista normanna che in esse trovarono
normalizzazione
–
veicolarono l’idea che il potere stesso del re fosse arginabile
mediante il diritto, fu perché esse innanzitutto definirono un ambito giuridico unitario,
comune e legittimo, che rappresentò la cornice entro la quale ogni potere tradizionale fu
costretto ad inserirsi e ad agire.
Come le dighe (turcies) della Loira che lo stesso Plantageneto fece costruire76, le forme
del diritto tramandate dal suo regno offrirono un modello che domava e incanalava i
poteri esistenti (operazione alquanto hobbesiana!), costituendo un’ossatura talmente
solida ed efficace da far sì che questi ultimi, da allora in poi, si impegnassero non tanto
per spezzarla o scinderla, quanto piuttosto per dominarla.
Quella dei grandi è certo concepibile come un’azione against the king; ma la sua vera
portata traspare ancor più nella faticosa lotta per piegare a proprio vantaggio un sistema
di governo che proprio dopo l’epoca di Enrico II non aveva più bisogno della presenza
de re per funzionare.
La loro aspirazione al dominio si realizzò definendo e articolando gli ambiti interni al
quadro: in questo modo specifico risultava possibile controllare il meccanismo della
giustizia regia che, lungi dall’aver annientato gli altri poteri, rimaneva in qualche modo
aperto, flessibile, adattabile.
Vd. R. Fossier, “The rural economy and demographic growth”, in D. Luscombe, J. Riley-Smith, The
New Cambridge Medieval History, vol. IV, p. I, Cambridge 2004, p. 28.
76
68
Non solo. Collocato al termine della fase embrionale del processo di accentramento
iniziato con Guglielmo il Conquistatore e proseguito dai suoi successori, il momento
rappresentava anche l’inizio di una longeva vita che doveva ancora specificarsi,
svilupparsi appieno, maturare.
Che la strategia fosse tale lo dimostra l’articolo della Magna Carta su cui ci siamo
soffermati, e lo dimostra anche, seppur a un livello meno fondante, un'altra clausola ivi
presente la quale introduce, per la prima volta attraverso statuto, una capitale distinzione
giurisdizionale:
Communia placita non sequantur curiam nostram sed teneantur in aliquo loco
certo77.
L’articolo 17 stabiliva che le cause comuni (common pleas) non sarebbero state più
giudicate presso la corte regia, a differenza delle cause in cui la Corona fosse
direttamente coinvolta.
Il punto di partenza era una bipartizione già esistente all’interno della Curia regis
durante il dodicesimo secolo, che registrava la presenza da una parte di una magistratura
fissa che si riuniva regolarmente in assenza del re (in the Bench), e dall’altra di una corte
itinerante che giudicava in presenza del re medesimo (coram rege); stavolta la Magna
Carta si rifaceva ad essa per tracciare i confini giurisdizionali di quelli che sarebbero
77
C. Bemont, cit., p. 51.
69
diventati in futuro i due più importanti tribunali di diritto comune, vale a dire, la Court of
Common Pleas e il King’s Bench.
La rilevanza straordinaria di questo passaggio nell’evoluzione del sistema di common
law è descrivibile nei seguenti termini: la stabilizzazione delle corti di diritto comune
corrisponde all’istituzionalizzazione del principio di delega che aveva da sempre
orientato l’operato dei raminghi re inglesi.
La corte delle cause comuni, uno dei pilastri dello stato inglese, compie tale principio,
superandolo: al nuovo tribunale viene attribuito un proprio ambito di competenza
giurisdizionale circoscritto significativamente alle cause civili, autonomo e separato
definitivamente dalla persona del re.
In questo modo l’amministrazione della giustizia tra privati (liberi, nel senso che
abbiamo sopra chiarito) si ritaglia all’interno dell’attività di governo un vasto spazio nel
quale la figura del signore supremo viene in un certo senso messa tra parentesi,
sottintesa.
Un processo analogo sarebbe stato seguito, ai margini, anche dagli altri tribunali di
diritto comune, a testimonianza non soltanto dell’interconnessione tra le magistrature,
ma soprattutto del fatto che il divenire ordinario e stabile delle procedure e delle corti
doveva passare attraverso questa astrazione fondamentale.
Quando si legge che i communia placita “non seguiranno la nostra corte, ma si terranno
in un luogo fisso”, o quando, come nel quindicesimo secolo, perfino il tribunale coram
70
rege smette di spostarsi al seguito del sovrano, si tratta di un momento decisivo nel quale
il carattere certo e permanente dei luoghi della giustizia è concretamente un tutt’uno con
la certezza e la permanenza delle forme del diritto.
Istituti aventi sede fissa, sganciatesi dalla mobilità del re itinerante, non rappresentano
metaforicamente leggi consolidate e definite in maniera inderogabile: incarnano essi
stessi un concetto di legge che, svincolato dalla discrezionalità propria dell’antica
giustizia regia, si fonda separatamente e in opposizione all’eccezionalità.
Questa tensione verso l’istituzionalizzazione ordinaria alberga in sé la capitale
distinzione tra il re e la Corona78 e appare come una delle concrete manifestazioni della
complessa vicenda storica che vide differenziarsi la persona del sovrano dal sostrato
giuridico che lo accomunava e lo legava alla comunità.
Su un piano concettuale la parola ‘Corona’ si oppone “alla pura physis del re e alla pura
physis del territorio” indicando “la metaphysis politica di cui erano partecipi rex e
regnum o il corpo politico (a cui entrambi appartenevano) nei suoi diritti sovrani”79.
Non ci addentreremo in questa densa e spinosa questione. Ciò che ci preme sottolineare
è come l’assestamento di un sistema di diritto che in origine è schematicamente
pensabile come un atto della voluntas teocratica del re80 (solo schematicamente,
prendendo a modello la sfera della repressione criminale; la breve analisi condotta per il
Cfr. E. H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies. A study in Medieval Political Theology, Princeton
1957, cap. VII (tr. it., I due Corpi del Re, Torino 1989, pp. 269 ss.)
79
Ibid., p. 293.
80
Cfr. W. Ullmann, Principles of Government and Politics in the Middle Ages, London 1961 (tr. it.
Principi di governo e politica nel Medioevo, Bologna 19822, Parte Seconda, cap. III).
78
71
diritto proprietario in ambito civile ha mostrato invece come il piano del compromesso e
l’accordo, quantomeno con i liberi del regno, fosse costitutivo e mai del tutto scindibile
dall’azione del re) richiami poi in vita, sulla via del suo farsi ordinamento, un principio
superiore che vincola sovrano e sudditi: tale principio è la rule of law.
Segnando un punto di non ritorno nello sviluppo della rule of law, le Corti di diritto
comune fecero leva su quello che, seguendo la terminologia di Ullmann, diremmo
l’aspetto feudale della regalità inglese, oppure quello che già Bracton, a metà del
tredicesimo secolo, aveva concepito come jurisdictio81: esse delimitarono un piano di
giustizia ordinaria nel quale l’uguaglianza nel privilegio dei signori inglobava, almeno in
teoria, anche il signore supremo, divenendo tutti in questo modo sudditi della legge.
Ebbene, di quale legge? La risposta non è del tutto agevole.
La prassi giudiziaria che in maniera così efficace aveva reso operante la giustizia regia,
aveva anche elaborato un diritto che non era mai stato concepito come creazione,
rimanendo così nel solco della migliore tradizione giuspolitica medievale82.
La plausibilità politica di un sistema di giustizia centralizzato e legittimato dal re, che
veniva ad inserirsi in un orizzonte giuridico plurale, riconoscente soltanto la garanzia
della memoria e la legittimità del tempo, impose e spinse a mantenere il nodo
inestricabile che legava insieme la procedura e il diritto sostanziale: fu in questo modo
che le forme della giustizia, vestite di regalità, fornirono una mirabile apparenza soltanto
81
82
Cfr. Ch. H. McIlwain, op. cit., cap. IV.
Cfr. P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, 20084, pp.130 ss.
72
alla luce della quale sembrarono dar voce ad un diritto preesistente, silenzioso, ma già
reso venerabile dal passato.
Il re era sì la fontana della giustizia, ma l’acqua che vi scorreva sorgeva prima e
altrove83. Si trattava di un principio antico e in genere valido, ma massimamente palese
qualora la presenza del sovrano nel tribunale fosse soltanto fittizia; quando la
giurisdizione regia si esercitava per delega, ed era il più delle volte, allora era la corte a
‘dire’ o ‘trovare’ il diritto, rammemorando le regole e incorporandole nella sua
sentenza84.
Non stupisce quindi che il momento in cui la finzione secondo la quale ‘ogni
giurisdizione è giurisdizione del re’ divenne fatto istituzionale, ovvero la fase che vide lo
stabilizzarsi delle corti di diritto comune, abbia coinciso con l’elevazione a massima di
tale vetusto principio.
L’apparenza era in sommo grado mirabile perché riproduceva in gran parte la realtà: il
perno dell’attività tecnica di un ceto di giuristi sempre più forte e autonomo, era
effettivamente il rinvenimento della massima di decisione a partire dalla natura dei fatti,
Nel 1765 William Blackstone avrebbe così scritto: “Another capacity, in which the king is considered in
domestic affairs, is as the fountain of justice and general conservator of the peace of the kingdom. By the
fountain of justice the law does not mean the author or the original, but only the distributor” (Book I, Ch.
VII, iii). W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England in Four Books, Philadelphia, 1893, vol. I,
p. 266.
84
M. Bloch, La société, cit. p. 416.
83
73
non una produzione creativa85, e ciò costituì certamente il fondamento di un patrimonio
sapienziale che si consolidò e si tramandò per secoli.
Il sistema dei writs – su cui ci siamo trattenuti – e lo sviluppo del metodo del Case Law
diedero al diritto inglese quell’indelebile impronta giurisprudenziale che lo caratterizza,
insieme al diritto romano e al diritto canonico, come uno dei grandi sistemi giuridici
europei. Le Provisions of Oxford del 1258 dimostrano però come nelle forme vi fosse
anche la sostanza, ovvero come lo ius dicere comportasse tal volta lo ius dare.
Il numero dei writs venne chiuso per timore di una legislazione giudiziaria che, pur nella
stretta connessione con le decisioni dei giudici, di fatto creava istituti nuovi, come si
evince in modo paradigmatico dalla nascita e dall’evoluzione delle assisi possessorie.
Le Disposizioni fissavano così la rigida cornice entro la quale una materia flessibile e
incredibilmente adattabile avrebbe incontrato la capacità interpretativa dei funzionari
non più del re, ma del diritto, grazie ai quali si sarebbe dunque attuato il governo della
legge.
Ma, ancora, di quale legge? Un anacronismo terminologico ci porterebbe a dire la
common law, e pur trovandoci concettualmente nei suoi pressi, l’espressione giusta
sarebbe quella acutamente scelta dai redattori del capitolo 39 della Magna Carta: la lex
terrae.
85
Cfr. G. Radbruch, op. cit., p. 34.
74
Con questo concetto veniva sancita in Inghilterra la centralità per il diritto di un’idea di
rapporti di natura feudale e più specificamente, la validità effettiva del momento
contrattuale, vera essenza del feudalesimo o, come diremo ancora meglio a breve, del
diritto feudale in senso tecnico.
La questione necessita di alcuni importanti precisazioni per essere compresa appieno,
altrimenti la portata del movimento innovativo e al tempo stesso conservativo che era in
atto, rischia di rimanere nell’oscurità.
Per prima cosa bisogna chiarire ciò che la lex terrae non è. Essa non è il diritto
consuetudinario, e neppure Landrecht in senso stretto: sebbene essa inglobi la
consuetudo, riconoscendo sì la maestà e l’importanza di un elemento che è in senso
pregnante
‘costitutivo’
dell’ordine
giuridico
medievale86,
essa
enfatizza
significativamente, come vedremo successivamente, più il suo essere fonte di
legittimazione che non fonte del diritto.
Nonostante in essa sia presente un elemento territoriale imprescindibile – che rimanda
tuttavia al regno intero e non è espressione di una specifica realtà locale – la lex terrae
incorpora anzitutto l’aspetto vincolante del diritto feudale, ovvero, la reciprocità
contrattuale.
A partire da quanto abbiamo affermato precedentemente a proposito della vicenda del
vilainage in Inghilterra, non nuoce ricordare che la sistematizzazione di cui ci stiamo
86
Cfr. P. Grossi, op. cit., pp. 87 ss.
75
occupando in questa fase non fa riferimento al diritto del maniero, il quale “disciplinava
le relazioni tra il signore ed i contadini, la produzione agricola e la vita del castello e del
contado in generale”87, ma riguarda invece il diritto che regolava il possesso feudale e i
rapporti signore-vassallo, ovvero, il diritto feudale in senso tecnico.
Solo in questa sfera, giunta certo ad ampliarsi considerevolmente, vigeva l’aspetto
contrattuale. Va chiarito e specificato ora il significato di quest’ultimo.
Il contratto feudale conferiva uno status: ciò che veniva rimesso alla libera volontà dei
contraenti era il consenso al rapporto88, mentre il contenuto giuridico della relazione, in
quanto predeterminato, rimaneva praticamente indisponibile89.
Nel momento in cui questa specifica nozione di contrattualità s’innalzò a principio
costituzionale nella lex terrae, l’esercizio della libertà dei baroni e del re venne definito
sulla base di un diritto superiore a entrambi, che aveva al proprio interno, nella forma del
reciproco consenso, il criterio di verifica e lo strumento di vicendevole controllo.
Così, lo sforzo congiunto e il comune accordo divenivano i presupposti fondamentali del
diritto sostanziale che i tribunali di common law avrebbero dovuto applicare
ordinariamente; essi ponevano, racchiusi nel termine lex terrae, un sigillo indelebile alla
capacità giuspolitica dei magnati, mentre la funzione monarchica del sovrano veniva
ridotta radicalmente.
87
H. J. Berman, op.cit., p. 288.
“La libertà infatti non consisteva nel non avere alcun signore (tutti lo avevano), consisteva nel poterselo
scegliere”: M. Bloch, Signoria francese, cit., p. 151.
89
Cfr. H. J. Berman, op.cit., pp. 294 ss.
88
76
In virtù dell’enfasi sull’elemento contrattuale del diritto feudale, il re venne inquadrato
paradossalmente nella cornice giuridica determinata dalla stabilizzazione della sua stessa
giustizia, divenendo in questa sfera soggetto dei diritti e degli obblighi connessi allo
status coronae: “agendo attraverso i suoi giudici, il re innalzava una barriera contro la
sua stessa voluntas monarchica”90.
È chiaro come in questo contesto il contenuto della legge dovesse rimandare non più a
quelli che un tempo erano nati come interventi eccezionali decisi unilateralmente dal re,
ma piuttosto ad un sostrato giuridico comune che si sarebbe manifestato in maniera
ordinaria grazie all’applicazione meccanica di regole messe a punto dai common
lawyers.
La certezza verso la quale tendeva la definizione della common law richiedeva fissità,
prevedibilità, continuità; necessitava dunque dell’assestamento di un sistema chiamato
ad incarnare la finzione della perpetua necessitas alla quale era sottintesa proprio “la
perpetuazione di un qualcosa che per definizione indicava un’eccezione, una condizione
eccezionale o una momentanea deviazione dall’ordinario” 91.
In virtù del suo essere agli antipodi dell’eccezione, staccata dall’idea di legge creata o
perfino scritta, intimamente legata alla dimensione della memoria e del tempo nonché a
quella della terra e del sangue, la consuetudine fu il polo materiale verso il quale slittò la
fonte di legittimazione del diritto inglese: essa offrì la base naturalistica capace di
90
91
W. Ullmann, op. cit., p. 225.
E. H. Kantorowicz, op. cit., p. 245.
77
conferire validità – perché era ella stessa paradigma e ripetizione – agli immutabili
schemi sapienziali ai quali i giusperiti avrebbero fatto riferimento.
Ma come può la consuetudine, “fonte viva che rampolla dall’esperienza”92, offrire un
fondamento solido per la costruzione di un apparato giuridico? Ebbene, quando dal
piano dell’effettività, delle pratiche divenute norme grazie alla reiterazione, la
consuetudine viene spostata su quello della validità, allora le sue radici vengono in
qualche modo troncate e la circolazione della linfa che la tiene in vita viene interrotta.
Essa non è più fonte inesauribile di materia giuridica ma piuttosto e ancora una volta,
limite, cornice.
Dalla formulazione rinvenibile già nello Statuto di Merton (1235) della lex come ‘usitata
et approbata’, emerge chiaramente come l’elemento contrattuale, cui abbiamo prima
fatto cenno, abbia piegato a proprio vantaggio e legato indefettibilmente a sé la nozione
di uso continuativo, cogliendovi il consenso tacito, persino inconscio, implicito nella
ripetizione che la caratterizza.
Il fattore sine qua non della legittimità era l’approvazione, e la consuetudine era ciò che i
magnati, esplicitamente o implicitamente, riconoscevano tale.
Ancorati all’assenso della ‘comunità’, statuti e costumi giunsero a formare un corpo di
diritto estremamente flessibile al proprio interno, ma dai contorni altrettanto rigidi.
92
P. Grossi, cit.
78
È importante ravvisare tra i più significativi frutti della cooperazione e dell’accordo tra
re e baroni
– sebbene sorprenda trovare questi armonici principi sullo sfondo di
durissimi conflitti costituzionali – proprio la fissazione di un limite alla “memoria
giuridica” inglese: il capitolo 39 del primo statuto di Westminister e gli statuti detti del
quo warranto del 1289-1290, stabilirono come dies a quo il 3 settembre 1189, giorno
dell’incoronazione di Riccardo I; i tribunali, nel rammentare leggi antiche, non si
sarebbero mai dovuti spingere a ritroso oltre quella data93.
Le corti di common law si affrancarono quindi dal patronato regio e conquistarono
stabilmente il terreno dell’amministrazione ordinaria della giustizia, legittimando la
propria azione sulla base di un principio superiore (venutosi a consolidare sempre più
distintamente nella rule of law) che trovava realizzazione concreta nell’applicazione
meccanica di immutabili schemi sapienziali: la tenuta di questa legittimità dipendeva in
massimo grado dal rigore con cui i giusperiti avrebbero eseguito questa applicazione.
Essi riuscirono a far fruttare in modo pregevole l’adattabilità e l’elasticità interna del
sistema, tenendo ferme le sue forme strutturali, il che rappresentò senza dubbio il fattore
decisivo dell’affermazione della common law: la permanenza delle forme d’azione si
affiancava con successo alla capacità di far rientrare in esse sempre nuove e più
complesse fattispecie.
93
R. C. van Caenegem, European Law in the Past and the Future, Cambridge 2002 (tr. it., I sistemi
giuridici europei, Bologna 2003, p. 19.)
79
Ma proprio l’estremo tecnicismo procedurale ha fatto sì che le corti di diritto comune in
Inghilterra non siano mai state sole, e ciò sembra essere il risvolto istituzionale che mette
in evidenza come l’affermazione del modello giuridico inglese consista, essenzialmente,
nel suo non essere trionfo.
Il loro consolidamento non esaurì tutta la giurisdizione della corona perché implicò la
delimitazione di una sfera d’azione che, in nome dell’autonomia e della certezza, dovette
rinunciare all’amministrazione dell’equity, ovvero al potere di fare giustizia nel caso
concreto che richiedesse una decisione in deroga alla rule of law.
Con la perpetuazione dell’eccezionalità presupposta dalla stabilizzazione delle corti
ordinarie, venne meno proprio il loro potere di decidere sull’eccezione**.
Si trattava di un potere residuo nel quale era ben visibile quella capacità di creare diritto
(ius dare) che i tribunali di common law si alienarono insieme all’identificazione con il
sovrano;
un
potere
elastico
e
discrezionale
che
rimase
così
competenza
dell’amministrazione diretta del re, in forza della sua prerogativa.
Mantenendo il carattere di eccezionalità e sussidiarietà appartenente in origine proprio
alla giustizia regia centrale dalla quale la common law aveva preso le mosse, le
prerogative courts furono il luogo dove rimase in vita l’elemento monarchico che
l’affermazione del diritto comune inglese aveva tenacemente ridotto.
Ancora una volta ciò che merita maggiore attenzione è innanzitutto l’ineliminabile
presenza di sistemi alternativi in grado di provvedere ai casi in cui i meccanismi ordinari
80
si fossero rivelati inefficaci: il concorrere – armonico fintantoché i confini
giurisdizionali si mantennero fluidi – di tribunali straordinari, determinò la
conservazione sul piano istituzionale di una bipolarità strutturale in grazia della quale il
sistema nel suo complesso sarebbe stato in grado, almeno in teoria, di provvedere
all’intero spettro di casi richiedenti giustizia: alla common law divenuto jus strictum
spettava la funzione di far valere la legge nel caso normale; e qualora il rigore di questo
compito, eseguito in specifiche e singolari circostanze, si fosse rivelato sinonimo di
ingiustizia, allora l’equity avrebbe offerto il rimedio destinato a correggere
l’inconveniente94.
In linea di principio i due sistemi, paralleli e non antitetici, avrebbero dovuto integrarsi e
completarsi perfettamente a vicenda; nei fatti, la competizione tra le corti finì per
rivelare tutta la sua carica conflittuale.
“Il segreto del successo degli esperimenti costituzionali nell’Inghilterra del Medioevo
stava nella flessibilità e nella capacità di adattamento della common law e nella saggezza
con cui essa lasciava al re teocratico un certo campo di azione entro il quale la voluntas
regia poteva farsi sentire con tutto il suo peso. L’ampiezza o la limitatezza di questo
campo dipendeva non già da principi ma dai fatti, né occorre specificare quanto fluide
fossero le linee di demarcazione”95.
Con queste parole Walter Ullmann ha efficacemente indicato la sorprendente dialettica
che ha legato la vicenda storica dell’affermarsi della common law al mantenimento di
94
95
Cfr. G. Radbruch, op. cit., p. 31.
W. Ullmann, op. cit., p. 241.
81
una sfera giuridica straordinaria (che potrebbe dirsi anche, e non si tratterebbe di un
mero gioco di parole, una sfera extra-giuridica ordinaria).
Ora, osservando in controluce la questione che ci occupa, ovvero quella del dualismo di
common law ed Equity, i termini assumono qui uno speciale valore: proprio perché
l’ampiezza della giurisdizione di equità dipendeva dai fatti ad essa sottoposti e non da
princìpi, il suo ambito di competenza crebbe enormemente e senza ostacoli non appena
la rigidità delle corti di diritto comune si capovolse da certezza in inefficacia, da
applicazione rigorosa della legge attraverso stabili procedure, in atrofia.
La “saggezza” della common law, nel momento in cui affiorò il potenziale antagonismo
tra i sistemi alternativi, che in verità per più di un secolo avevano condiviso
l’amministrazione della giustizia in campi differenti, dimostrò essere basata
sull’accettazione di una convivenza nella quale rimaneva irrisolta la questione circa la
fonte ultima di legittimità.
La minaccia ai tribunali ordinari divenne concreta e tangibile dal XV secolo, quando fu
evidente che le barriere inattaccabili delle forme d’azione avevano reso insuperabili una
serie crescente di problemi che, sottoposti invece al Cancelliere, trovavano una
soluzione adatta ed equa.
È di non poco interesse il fatto che il consolidamento della giurisdizione di equità sia il
risultato del rapido sviluppo del settore legale della Cancelleria, quel pilastro
istituzionale inglese la cui competenza prima e originaria consistette nel custodire il
Gran Sigillo, ovvero nel confermare l’emanazione dei mandati regi (writs e altri tipi di
82
documenti formali), assumendosi con ciò la direzione e il coordinamento di tutti i
dipartimenti di governo96.
Il segretariato, seguendo un percorso analogo a quello già indicato per le corti di diritto
comune, iniziò a differenziarsi dalla Real Casa sotto Enrico III (1216-1272) e smise
definitivamente di seguire il re, fissando la propria sede in Chancery Lane a Londra, nel
XIV secolo: ancora una volta, la stabilizzazione del domicilio significava la definizione
della propria funzione – nel caso della Cancelleria, quella di governo – separatamente
dalla figura del re.
Questo importantissimo ente, il quale aveva sì “burocratizzato” il governo stabilendo e
conservando regolari formule e procedure amministrative, ma aveva anche contribuito a
mantenere uno sfondo unitario grazie al quale veniva ad evitarsi una divisione troppo
rigida del governo stesso in uffici autonomi, si trovò già nel XIV secolo a dover far
fronte, in nome del re, alle moltissime petizioni che non trovavano rimedio nella
common law e che venivano quindi indirizzate direttamente al sovrano.
Rilevante ci sembra in primo luogo il fatto che il braccio legale del re teocratico, lasciato
libero dalla common law proprio nel campo dell’equità, trovi dimora istituzionale
proprio in quell’organo composto – fino alla Riforma – quasi sempre da ecclesiastici:
la procedura seguita dalla Cancelleria, rapida e poco attenta ai formalismi, era infatti
quella romano-canonistica; anche secondo questa prospettiva andrebbe analizzato il
rapporto di contrapposizione, ma anche di convivenza, tra common law e civil law.
96
Cfr H. J. Berman, op. cit., pp. 442 ss.
83
In secondo luogo, ma forse in primis per importanza, il fatto che questo sistema di
giustizia straordinaria sia nato in grembo all’ufficio “che definiva la pubblica
amministrazione, gli affari di governo, come qualcosa di meno della politica
(rappresentata dalla persona del sovrano) e come qualcosa di più dell’insieme dei singoli
uffici di governo”97; dentro un “superdipartimento” dunque, che demarcava una decisiva
zona intermedia dalla quale si realizzava un controllo orizzontale dell’intero apparato
governativo.
Forzando un poco l’analisi potremmo sostenere che l’equity avrebbe rappresentato a sua
volta una ‘supergiustizia’ la quale, fiancheggiando i tribunali ordinari, sarebbe stata
incaricata di mitigare il rigore della common law, controllandone in un certo senso la
resa effettiva in termini di giustizia.
Non si trattava precisamente di un controllo degli standard di legalità: questo compito
era stato mantenuto significativamente dalle corti di common law che si erano assunte e
avevano mantenuto tale potere prima ancora della loro stabilizzazione, riservandosi
l’emissione dei prerogative writs98; nell’equity era rinvenibile piuttosto uno strumento di
vigilanza flessibile in grado di individuare
– ed eventualmente correggere –
l’ingiustizia nella fattispecie concreta.
Nel seguire i caratteri portanti del marco giuridico inglese, mentre rivolgiamo lo sguardo
in conclusione ai margini lasciati dalla common law al diritto legittimato dalla
prerogativa regia, la completezza dell’analisi e forse anche il rigor di logica
richiederebbero di soffermarsi perlomeno su due ulteriori vicende: la nascita e
97
98
Ibid., p. 443.
Cfr. U. Mattei, op. cit., p. 14.
84
l’affermazione del Parlamento, fondamentale Corte di Giustizia che segnò in maniera
unica lo sviluppo costituzionale inglese; e, inoltre, il fiorire delle corti di prerogativa (la
Court of Star Chamber e la Court of Requests), le quali furono in maniera molto più
netta rispetto alla Court of Chancery, espressione della volontà monarchica del re.
Non solo l’enorme complessità di entrambe le questioni, ma anche una motivazione
strutturale che si procederà subito ad esporre, ci esimono almeno in parte da tale
compito.
Il regno di Edoardo I (1272-1237) fu il periodo di massimo utilizzo della legislazione
diretta mediante statutes, e l’ultima fase in cui vennero attuate profonde riforme
istituzionali dal re senza il concorso del Parlamento.
Il potere di creare diritto (ius dare), potere al quale abbiamo visto rinunciare le corti di
diritto comune, rappresentava dal punto di vista politico un fronte troppo cruciale per
essere lasciato alla semplice discrezionalità del re, e i baroni erano ben consapevoli del
fatto che far valere su questo piano il principio della consensualità feudale avrebbe
significato mantenere un legame giuridico in grado di limitare il re e, in fin dei conti, di
operare un controllo, a parità di livello, delle decisioni centrali per mano dei poteri
locali.
“Il concetto del «re in parlamento» è il punto di arrivo di un lungo cammino dal
feudalesimo al costituzionalismo”99: perciò, pur rimanendo in questo percorso fuori dalla
portata della common law giurisprudenziale, il potere legislativo del King in Parliament
99
W. Ullmann, op. cit., pp. 240-241.
85
rappresenta in maniera superlativa il suo spirito perché incarna sì la prerogativa, ma
della communitas regni, non del re.
È pur sempre vero che lo statute rimane estraneo alla concezione giuridica inglese così
imperniata, come abbiamo più volte visto, sul piano processuale.
Da questa prospettiva il diritto posto con la legge (statute) costituisce un diritto speciale,
straordinario, sottoposto in origine ad un’interpretazione restrittiva e perciò non
applicato solitamente per via analogica100; successivamente, non appena il ruolo politico
del Parlamento aumentò in maniera tale da non lasciargli tempo e modo di dirimere
direttamente ogni dubbio esegetico, e ai common lawyers furono concessi dunque ampi
spazi di discrezionalità, la convivenza tra common law e statutes venne comunque resa a
lungo pacifica101.
Il mutamento dell’interpretazione da restrittiva in estensiva, ma non in analogica,
dimostra come la futura alleanza tra Parlamento e corti di diritto comune avesse radici
profonde: sottoposti entrambi alla rule of law, l’uno proclamava, quando necessario,
aspetti specifici della lex terrae, le altre li interpretavano; in questo modo, non essendovi
integrazione o correzione, anche il carattere creativo del diritto positivo veniva
riassorbito dalla mentalità di common law.
La giurisdizione di equity portava con sé qualcosa di molto meno domabile, ed è per
questo che nella nostra analisi occupa una posizione privilegiata: il principio di equità
100
M. Ascheri, Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo, Torino 20082, cap. VII.
Cfr. G. W. Thomas, James I, Equity and Lord Keeper John Williams, in “The English Historical
Review”, v. 91, n. 360, 1976, p. 515: “[…] in the late thirteenth and early fourteenth centuries common
law courts adopted a policy which denied the extension of statutes beyond their strict words. By the
sixteenth century, however, the process was being reversed”.
101
86
rimandava ad un ambito di giustizia discrezionale e flessibile che nella sua intangibilità
proponeva un antagonismo radicale, spia di una latente ma profonda conflittualità.
Il discorso per le corti conciliari è per certi versi, più semplice.
Come la Court of Chancery, anche le altre corti di prerogativa possedevano una
giurisdizione sussidiaria che forniva rimedio nel caso in cui il diritto comune avesse
fallito, e le loro decisioni erano allo stesso modo un esempio di intervento diretto del
sovrano.
A differenza della prima però, sia la Corte della Camera Stellata che la Court of
Requests rimasero a lungo legate e sovrapposte al Consiglio della Corona:
significativamente fu solo dopo la metà del XVI secolo, quando le spinte centralistiche
dei Tudor si fecero sentire sempre più, che venne definita in maniera più chiara la loro
configurazione ed ampliata notevolmente la loro attività102.
La celerità e l’efficienza iniziale delle loro procedure dimostrò potersi tramutare
facilmente in abuso – il che si verificò puntualmente sotto i primi Stuart, i quali ne
fecero i bastioni dell’assolutismo – e ciò a causa del loro scarso livello di autonomia nei
confronti del re.
Fu proprio questo il motivo per cui tra le prerogative courts solo quella della Cancelleria
sopravvisse al regicidio103.
102
Cfr. H. J. Berman, Law and Revolution II. The Impact of the Protestant Reformations on the Western
Legal Tradition, London 2003 (tr. it. Diritto e Rivoluzione II. L’impatto delle riforme protestanti sulla
tradizione giuridica occidentale, Bologna 2010, p. 385).
103
Può essere utile, al fine di sottolineare il carattere politicamente estremo delle corti di prerogativa ed
evidenziare quindi il rapporto di esclusione non mediabile da esse intrattenuto col Parlamento (al successo
87
La competizione fra le corti è un fenomeno di lunga durata e di vasta penetrazione –
rinvenibile non solo tra tipi diversi di tribunale, ma anche, singolarmente presi, al loro
interno – che offre nel complesso una visuale eccellente sulle vicissitudini inglesi dalla
prospettiva delle istituzioni e delle concezioni giuridiche, e ciò ancor più se considerate
nella specifica contrapposizione tra equity e common law.
In tale concorrenza, così come si presenta fino al XV secolo, vi è il segno di una
domanda sociale che preme in direzione della certezza del diritto, la quale viene posta e
aumenta esponenzialmente nelle sedi in cui trova soddisfazione; vi è inoltre
l’espressione di diversi gruppi di interesse ben consapevoli della corrispondenza
tipicamente medievale tra potere giurisdizionale, potere economico e potere politico; vi è
infine, nel suo oscillante, a volte precario, ma pur sempre durevole equilibrio,
l’espressione di un’astuzia (della razionalità politica inglese, oppure del caso della
storia104) per cui, non consistendo il successo di una giurisdizione nella soppressione
definitiva delle altre esistenti, venne mantenuta una pluralità di sfere che, grazie a
confini fluidi, finirono per rinsaldarsi nel competere, estendendosi e contraendosi
vicendevolmente.
del quale, infatti, non sopravvissero), quanto affermato da Norman Davies, nel suo dibattuto, non sempre
accurato, ma pur pregevole libro, riguardo alla Camera Stellata: “Tutti i discorsi sulle «costituzioni»,
inevitabilmente associati a una monarchia successiva e limitata, lasciano in ombra le dimensioni
dell’autocrazia reale nell’epoca Tudor e nella prima epoca Stuart. Si può sostenere che per i
centocinquantasei anni tra la sua creazione nel 1485 e la sua abolizione nel 1641 il tribunale della Camera
Stellata sia stato più essenziale del parlamento al funzionamento complessivo del governo. Dal 1540, la
Camera Stellata comprese sia il Consiglio privato sia i presidenti dei tribunali, cioè sia il potere esecutivo
sia quello giudiziario, creando quindi un blocco di influenza in sessione permanente in grado di dominare
sulla sfera del parlamento, più circoscritta e più discontinua. In realtà, si potrebbe facilmente obbiettare
che il parlamento non poté mai sviluppare il proprio potenziale fino a quando la Camera stellata fu rimossa
insieme alla filosofia politica che ne costituiva il fondamento”. N. Davies, The Isles: A History, London
1999 (tr. it. Isole. Storia dell’Inghilterra, della Scozia, del Galles e del Irlanda, Milano 2004, p. 470.
104
“Se Irnerio avesse insegnato o Azone avesse scritto un secolo prima, o se un Enrico III, invece di un
Enrico II, avesse seguito Stefano sul torno d’Inghilterra, noi forse useremmo il Digesto di Giustiniano
nelle nostre scuole di diritto”: Ch. H. McIlwain, op. cit., pp. 79-80.
88
L’ampiezza delle une era ai minimi quando, in virtù dell’efficienza quella delle altre era
ai massimi, ma quando l’estensione era tale da far irrigidire e sclerotizzare le seconde,
allora le prime avanzavano in progressione.
Tutto ciò si palesa seguendo le avventure della Court of Chancery, per i motivi che
abbiamo esposto precedentemente, e ancora alla luce di altri: è molto significativo, ad
esempio, il fatto che siano stati proprio i lavori di questa corte a conoscere per primi una
crescita vertiginosa, quando intorno al 1400, l’allentamento dei legami di servitù aveva
fatto sì che la questione degli espropri toccasse i diritti di coloro che per definizione non
erano tutelati dalla common law105.
Allora fu la Corte della Cancelleria a proteggere i copyholds, “tecnicamente al di fuori
della giurisdizione di diritto comune in quanto considerati unfree tenures, cioè
possedimenti di origine feudale anticamente occupati da servi della gleba”106.
In questo mutato quadro, le dispute che cadevano fuori dalle definizioni sostanziali del
diritto comune – e si trattava in questo caso della fondamentale definizione di libertà –
erano il luogo in cui summum ius diveniva summa iniuria: i casi richiedevano dunque
non una giustizia fondata sulla lex terrae, ma necessitavano per l’appunto di un rimedio
in deroga alla rule of law; essi investivano, in una parola, l’equità.
È stato notato come la pluralità di sfere sia orientata verso una convivenza in
disposizione orizzontale, non gerarchica, che pur rivela, se osservata dalla prospettiva di
105
106
Vd. supra, nota 33.
Garavaglia, op. cit., p. 587.
89
una giurisdizione di equità chiamata a temperare il rigore della common law, la presenza
di un’asimmetria.
In merito a questo esercizio l’equity non si trova mai ad operare contra legem, ma sì
extra legem, e in un certo qual modo supra legem.
In questa corte veniva così mantenuto in vita un principio discrezionale che per
definizione non conosceva sanzione legale, grazie al quale si conservava
istituzionalmente la bipolarità caratteristica della regalità medievale e attraverso cui si
intravede la permanenza di quella che è stata chiamata “la difficoltà di tutto il
costituzionalismo”107 dell’età di mezzo.
Il modo in cui questa difficoltà emerse in epoca Tudor raccoglie in una sorta di riflesso
distorto e ingigantito tensioni latenti da secoli, l’affiorare delle quali mise allo scoperto i
potenziali effetti disgregativi del permanere dell’ambiguità e, in ultima analisi, la carica
conflittuale sottaciuta dall’indecisione circa la fonte ultima di legittimità.
Che vi fosse una stretta correlazione con uno scollamento articolato in più livelli
all’interno della società inglese, abbiamo detto nel primo capitolo.
Sul piano della giustizia, la scarsa resa effettiva dei meccanismi pacificatori predisposti
dal sistema dimostrò la loro incapacità di contemperare ancora gli interessi: è vero che
“alla base dell’ingiustizia in Inghilterra non c’era tanto l’imperfezione delle norme
quanto le perversioni che separavano la teoria dalla pratica: la corruzione e la debolezza
delle giurie, la parzialità di sceriffi e giudici di pace, persino le richieste fatte da sovrani i
107
Ch. H. McIlwain, op. cit., p. 95.
90
quali pure, con il giuramento di incoronazione, si erano solennemente impegnati a far
rispettare lo spirito della legge”108; ma nella teoria stessa era rinvenibile una fragilità
strutturale.
Non sembra casuale il fatto che il ruolo teocratico del re medievale sia tornato a farsi
sentire prepotentemente quando il sovrano era divenuto capo supremo della chiesa
d’Inghilterra, e il senso in cui tale funzione mosse proprio nei riguardi della Cancelleria
è estremamente pregnante.
In quel che potremmo pensare come un curioso gioco di specchi, Enrico VIII ebbe
Thomas More come Enrico II ebbe Thomas Becket109: in entrambi i casi i Cancellieri,
martiri in nome dell’opposizione alla supremazia del re, furono messi a morte dal
sovrano seguendo procedure pur sempre legali.
Nei due emblematici scontri tra sovrano e cancelliere si intravvede drammaticamente la
tensione tra i due ordinamenti universalistici attraverso la quale è percorribile l’intera
storia giuridica occidentale.
108
S. Bridgen, New World, Lost Worlds. The Rule of the Tudors, 1485-1603, London 2000 (tr. it. Alle
origini dell’Inghilterra moderna. L’età dei Tudor 1485-1603, Bologna 2003, p. 221.)
109
L’atto di accusa di Hugh de Morville nei confronti di Becket, riportato da M. Ventura, Diritto canonico
e diritti comuni in Europa. «Common Law» e «ius commune» in due comparazioni, in “Quaderni di diritto
e politica ecclesiastica”, 2, 1993, pp. 415-439, merita davvero di essere citato: “Il nostro re vide che
l’unica cosa necessaria era ristabilire l’ordine: frenare i poteri esagerati delle amministrazioni locali… e
dare una sistemazione all’amministrazione della giustizia. Egli voleva che Becket… unisse gli uffici della
Cancelleria e di Arcivescovado. Se Becket fosse andato incontro ai desideri del Re, avremmo avuto uno
stato quasi ideale: avremmo avuto l’unione dell’amministrazione spirituale e di quella temporale sotto un
governo centrale… Ma che cosa avvenne? Appena Becket, ad istanza del Re, venne fatto Arcivescovo, si
dimise dalla carica di Cancelliere, divenne più pretesco dei preti, adottò un tenore di vita ostentatamente e
offensivamente ascetico; affermò immediatamente che esisteva un ordine più alto di quello che il nostro
Re, e che egli stesso come servitore del Re, si erano sforzati per tanti anni di stabilire; e che – Dio sa
perché – i due ordini erano incompatibili” (corsivo nostro). Citato da P. Prodi, Una storia, cit., pp.125126.
91
Da un’angolazione più circoscritta è possibile scorgere anche ciò che qui più ci preme:
la spinta verso il centralismo sotto i Tudor ebbe nell’affermazione della Corte di Equità a
discapito delle corti di diritto comune uno strumento eccellente, perché riattivò con
vigore sul piano giuridico la prerogativa regale rimasta e lasciata-essere ai margini della
common law, ponendo così in primo piano la contrapposizione tra le sfere.
Inizialmente la risposta dei common lawyers non fu volta ad aggravare il conflitto, ma si
orientò verso una correzione interna che, attraverso l’opera legislativa del Parlamento e
il controllo della prassi giudiziaria della stessa Cancelleria, riducesse sempre più le
ragioni a monte del ricorso all’equità110.
La contrapposizione però si faceva sempre più rigida e si trasformava progressivamente
in ostilità dichiarata, dal momento in cui il germe della disarmonia dilagava dove prima
c’era comunione di intenti e coesistenza pacifica. La competizione fra le corti nel XVI
secolo fu il principale motore delle importanti trasformazioni del sistema giuridico e
politico inglese, poiché la sua radicalizzazione spinse nella direzione di una
demarcazione più netta dei limiti tra le giurisdizioni, la quale non poteva non investire
una definizione più precisa dei tipi di giustizia che esse amministravano.
Durante l’era Tudor la Corte della Cancelleria era comunemente descritta come una
court of conscience, e non come una court of law: le corti di legge si fondavano su un
diritto proprio e autoctono, le cui radici affondavano stabilmente nel passato e seguivano
procedure fissate da tempo e consolidate; a livello procedurale il tribunale di equity
applicava invece un diritto civile giammai ritenuto una ripresa rigida del diritto romano,
Cfr. G. Giarrizzo, “Il pensiero inglese nell’età dei Tudor”, in L. Firpo (diretta da), Storia delle dottrine
politiche, economiche e sociali, vol. III, Torino 1987, p. 697.
110
92
ma piuttosto un suo adattamento alla situazione inglese secondo i dettami della
coscienza.
Nel suo essere adattamento vi era tutta la benefica flessibilità di un equità chiaramente
extra-giuridica perché non fondata su un diritto proprio, supra legem perché in grado di
trascendere le leggi in vigore correggendone l’operato qualora si rivelasse ingiusto; il
fondamento della coscienza veicolava però, e si perdoni il bisticcio di parole,
un’infondatezza in virtù della quale rimaneva fuori dalla portata di ogni sanzione o
stabilizzazione legale.
Quando le condizioni politiche lo richiesero, il piano di trascendenza a cui rimandava la
giurisdizione di equità – la cui separatezza, superiorità e totale alterità furono difese da
Becket e More con la propria vita – venne ‘incarnato’ nella figura del re.
L’onda era stata avviata da Enrico VII ed Enrico VIII, sotto i quali l’allargamento della
competenza giurisdizionale della Cancelleria aveva assunto i toni di sfida nei confronti
delle corti di diritto comune; queste però avevano reagito perseverando nella
convivenza, muovendo piuttosto verso l’emendazione endogena in forza della quale si
frenava pacificamente, ma anche in modo insidioso, l’avanzata della giustizia di equità;
l’urto sarà per certi versi irreparabile quando Giacomo e i civilians forzeranno
ulteriormente la questione e arriveranno a definire l’equity non più come un
complemento della common law, bensì come l’esercizio della “coscienza regale” perché
“in the court of equitie, the King governes (like God himselfe) by his owne individuall
93
goodness and Justice, though placed (during his royall pleasure) in the brest of
another”111.
Durante il regno del primo Stuart si notò appena l’assenza di un criterio in base al quale
distinguere tra una giustizia straordinaria e sovraordinata e un operato contra legem; nel
regno di Carlo I, fu chiara la mancanza di un freno legale in grado di evitare la
tramutazione della prima nella seconda.
Il momento più drammatico dello scontro tra common law ed equity fu il famoso dissidio
tra il cancelliere Thomas Egerton, primo barone Ellesmere, ed il più importante di tutti i
giuristi inglesi, Sir Edward Coke112: l’importanza dell’episodio risiede nel fatto che a
partire dalla contrapposizione dei due funzionari, i quali rappresentavano, con una certa
semplificazione, la mentalità dei poli opposti che coesistevano nel quadro giuridico
inglese, iniziò a definirsi più chiaramente il problema della prerogativa regia.
La disputa non riguardò l’esistenza della giurisdizione di equità113, la cui necessità
d’altronde non fu mai negata da alcun giurista, ma il volto minaccioso assunto dalla sua
espansione a discapito delle corti di common law.
Ancora una volta la cartina tornasole fu la certezza giuridica: l’allargamento dell’equity
fu percepito come una vera e propria dichiarazione di guerra alla common law nel
momento in cui lo spostamento del confine della sua giurisdizione non avvenne soltanto
‘in orizzontale’, invadendo quindi settori tradizionalmente riservati ai tribunali di diritto
comune, ma anche ‘dall’alto’, riaprendo i casi già decisi presso le corti ordinarie e
capovolgendone le sentenze.
111
Così il decano di Westminster e Lord Chancellor dal 1621 al 1625 John Williams, citato da G. W.
Thomas, art. cit., p. 525.
112
Vd. infra p.121.
113
Cfr. J. H. Baker, The Common Lawyers and the Chancery: 1616, in “The Irish Jurist”, IV, 1969, p. 370.
94
Fu ciò che fece Ellesmere intorno agli anni dieci del Seicento.
Si trattava della sovversione dell’ordine e della certezza della common law114. Ellesmere
però si faceva portavoce di una delle più consistenti accuse nei confronti dell’operato
delle corti, ovvero e per l’appunto “the incertentye of Judicature”: abbiamo detto circa la
sclerotizzazione del sistema e accennato alla corruzione dei funzionari; è indicativo dello
sviluppo del conflitto però, che tra le cause di tale incertezza Egerton annoveri proprio il
fatto che in tempi recenti le corti abbiano preso a interpretare estensivamente gli statuti e
in generale ad allontanarsi dal rigore della legge, decidendo i giudici in base alla loro
discrezione, “And so confounde the distincte Jurisdictions of comen lawe and of equitye,
challenging and takinge bothe to theym selves”115.
Sullo sfondo dello scontro vi era la rivendicazione, da parte di Giacomo I, del potere
assoluto di cui l’azione della Corte di Cancelleria era espressione, potere che peraltro gli
era riconosciuto formalmente da tempo, come testimonia il seguente brano di uno degli
Year Books del regno di Enrico IV: “There are two manners of power and processes in
the Chancery – the Ordinary and the Absolute power. The Ordinary power is the power
in which certain order is observed just as it is observed in positive law; but the law of
114
Cfr. A. Cromartie, The Constitutionalist Revolution: The Transformation of Political Culture in Early
Stuart England, in “Past and Present”, n. 163, 1999, p. 92.
115
Ellesmere’s breviate for the Privy Council, sept. 1615, citato da G. W. Thomas, art. cit., p. 517.
95
nature has no certain order, but it acts by any means that the truth may be known, and
therefore in its procedure called Absolute”116.
La differenza stava ora però, nel modo in cui il primo re Stuart, messo in primo piano il
nesso legge naturale-legge divina, faceva leva sul suo ruolo teocratico: l’intangibilità
dell’ordine su cui poggia la coscienza reale non rimanda qui, in base al diritto divino,
all’incertezza che i common lawyers avrebbero voluto attribuirle, ma piuttosto ad una
certezza assoluta perché derivata da Dio, insindacabile e non responsabile verso alcuna
istanza umana.
Deducendo i suoi doveri da una legge di natura che è riflesso dell’ordine gerarchico del
mondo, nel quale il re si trova immediatamente posto sotto Dio, ricavando da essa quindi
“corrette similitudini”, Giacomo afferma che il sovrano è rispetto ai sudditi nella
medesima posizione in cui è la testa nel corpo umano, ma soprattutto (e forse in maniera
meno ambigua) sostiene vigere tra loro il medesimo rapporto che intercorre tra un padre
e i suoi figli117: la concezione antropomorfica si applicava forse anche meglio all’ambito
116
Cfr. L. A. Sheridan, Equity, London 1969, p. 3. La Corte di Cancelleria si articolava nel Latin side, che
seguiva le procedure di common law per la composizione di dispute sorte dalle sue attività amministrative,
e nel English side che trattava le cause per cui il diritto comune non offriva rimedio: nella nostra
trattazione abbiamo fatto riferimento solo al secondo, per evitare di complicare ulteriormente il quadro
evidenziando la divisione e la bipolarità all’interno stesso del tribunale. La sostanza del ragionamento
rimane a nostro giudizio immutata, se non addirittura ulteriormente confermata.
117
James I, The Trew Law of Free Monarchies, in Ch. H. McIlwain (a cura di), The Political Works of
James I, London 1918, p. 55.
96
della reciprocità feudale, mentre nel modello patriarcale la verticalità era
inequivocabile118.
La dottrina del diritto divino di Giacomo non era indirizzata tanto ad una giustificazione
di un assolutismo monarchico, quanto piuttosto all’enfasi sulla derivazione diretta dei
diritti del re da Dio119, e ciò perché l’esigenza politica alla quale il sovrano si trovava a
rispondere non implicava l’affermazione dell’illimitatezza dei suoi poteri e la
conseguente rottura della cornice costituzionale preesistente – fuori dalla quale egli non
si collocò120 – ma richiedeva invece di postulare il fondamento della titolarità giuridica
del potere del re, sulla base del quale si sarebbe definita la sua prerogativa.
Come abbiamo tentato di mostrare, si trattava di un principio giuridico che faceva parte
integrante del sistema inglese sin dalle sue origini e che era assoluto (come ben si vede
nella sua veste equitativa) non perché omnipervasivo, ma perché indefinibile nei suoi
confini.
Il modo in cui la giurisdizione di equità è espressione della prerogativa regia illumina i
diversi aspetti della questione: il suo intervento è privo di cardini, nel senso che deve
procedere nel caso specifico ricorrendo di volta in volta ad ogni mezzo necessario a far
Così le parole del Cancelliere Williams: “Should he that is next under God in all causes be subject to
the Courts of his Liege-people and Homagers? He is their common Parent”. Citato da G. W. Thomas, art.
cit., p. 524.
119
Cfr. G. A. Ritter, art. cit. p. 74.
120
F. D. Wormuth, The Royal Prerogative 1603-1649. A Study in English Political and Constitutional
Ideas, Ithaca 1939, p. 93.
118
97
giustizia; ed è inoltre legalmente infondato, perché ha come compito ultimo il
trascendimento delle leggi in vista dell’interesse del demandante.
In questo quadro la fondazione concettuale della prerogativa reale per via divina e
patriarcale era volta a colmare il vuoto di legittimità che la common law aveva lasciato
aperto su due fronti, e non è certamente un caso che ciò avvenga nella fase di incertezza
giuridica apertasi con la successione di Giacomo al trono: il titolo del re fondato sul
volere di Dio, già dalla nascita, parla di una concezione della monarchia nella quale è
rinvenibile l’accentuazione dell’autorità naturale del sovrano – e quindi dei legami
naturali, diretti ed extragiuridici fra re e sudditi – e attraverso la quale si rafforza e si
definisce, inevitabilmente in maniera sovraordinata rispetto al popolo-paese, la nozione
di dinastia.
Ma la regalità feudale in Inghilterra aveva seminato in profondità, e i tempi in cui il
ruolo teocratico del re si era delineato erano lontani e profondamente differenti:
difficilmente si sarebbe potuto affermare un principio dinastico che non fosse stato
legato anche, in un rapporto di reciprocità, alla comunità.
Perciò, già dagli anni ’30, e proprio sottolineando gli effetti e i fini dell’intervento
equitativo del re sul piano del governo, gli autori monarchici avrebbero spostato il
momento fondante della prerogativa dal diritto divino all’interesse della comunità (salus
populi), sull’onda di quanto affermato già dal giudice Fleming nella sentenza sul caso
Bate (1606), aprendo i giochi dunque a quel conflitto costituzionale che abbiamo visto
delinearsi nei grandi processi sotto Carlo I.
98
La polemica circa i poteri della Cancelleria e le riflessioni intorno al rapporto tra legge
ed equità, assume rilevanza nei dibattiti costituzionali, dal momento che investono la
definizione sia del soggetto a cui compete il giudizio nello stato di necessità, sia la
demarcazione del luogo della sovranità legislativa; ma è significativa ad un livello ancor
più ampio e generale, nella misura in cui intorno ad esse si articolano, provenienti dal
fronte della common law, le teorie che tenacemente tenteranno di risolvere in termini
giuridici, il nodo problematico di natura essenzialmente politica circa il criterio di
distinzione tra diritto pubblico e diritto privato.
Davanti al vuoto di legittimità cui abbiamo più volte fatto riferimento, i common lawyers
si sforzeranno di affermare, specularmente rispetto alle teorie del primo Stuart, la
naturalità, l’immutabilità e in fin dei conti la superiorità dei fondamenti del diritto
privato: quando le libertà degli inglesi verranno connotate come diritto ed eredità, la
difesa della proprietà si erigerà a criterio assoluto in base al quale definire il pubblico
bene, e a limite invalicabile di ogni prerogativa; allora i giuristi di diritto comune
forniranno il supporto intellettuale al blocco gentry-puritani-common lawyers che vedrà
ora nel Parlamento e non nell’operato del re, la sede della propria unificazione,
rinsaldando il partito che vedremo alla fine prevalere.
Che la questione riguardasse la titolarità giuridica del potere appare in controluce nelle
parole pronunciate da Thomas Hedley alla camera dei Comuni nel 1610, attraverso le
quali egli si sforzava di tenere distinte la sfera della sovrana prerogativa reale da quella
del profitto e della proprietà dei liberi sudditi, riaffermando con intonazione moderna
99
quella distinzione tra libertà e servitù che abbiamo visto collocarsi agli origini stessi
della common law e che l’opera di Fortescue aveva innalzato a bandiera del libero
inglese contro il francese servo: “Non è tanto più grave perdere la ricchezza, quanto il
potere di tenerla, poiché nulla più della condizione di «villano» (beni e terre in potere del
signore) vale a deprimere mente e carattere al punto che non può servire il paese in
guerra o in pace”.
Nella prima parte dell’intervento di Hedley, così come in quelli successivi di Hakewill e
Fuller, vi è la definizione complessa e l’esaltazione senza riserve della common law: il
fondamento teorico in base al quale si contrapponeva all’immagine del re come legge
parlante, quella della voce suprema del diritto comune inglese, era il medesimo postulato
dai common lawyers nel momento in cui videro minacciata la loro sfera di competenza
da parte delle giurisdizioni alternative.
Fu questo il banco di prova della capacità politica che i giuristi attribuivano, in maniera
sempre più enfatica e crescente dal XVI secolo, alla common law, e del correlato portato
epistemologico in virtù del quale essa venne concepita come scienza universale in grado
di attingere ad ogni tipo di sapere al fine di promuovere il bene comune121.
I primi quarant’anni del Seicento furono l’apice dell’idea secondo la quale le categorie
della common law erano in grado di sistemare questioni politiche, e ciò pur rinvenendo
nella Petition of Right del 1628 quel che è leggibile come il fallimento del tentativo
“[…] a system probably best seen, in fact, as natural law applied to English life, determining the rights
of king and subject in ways so ideally just that there could be no possibility of an appeal to other
principles”. A. Cromartie, art. cit., p. 82.
121
100
dell’antiquaria giuridica di tenere insieme potere regio e regime di proprietà: nel
momento in cui la santità e la protezione assoluta del secondo non solo resero esangue il
primo, ma lo neutralizzarono – prima parzialmente, poi definitivamente – stabilendo il
nuovo luogo della sovranità nel Parlamento, si tracciò il quadro nel quale si riaffermava
“la supremazia del parlamento sulle corti di giustizia, e non già una gerarchia – come
avrebbero voluto Coke e i common lawyers – delle diversi corti, intesa a deprimere le
corti di equità, limitandone l’ambito giurisdizionale”122.
La successiva evoluzione della Court of Chancery mostra però un ulteriore risvolto: se è
vero che non vi fu la gerarchizzazione delle corti in virtù della quale i giuristi di diritto
comune aspiravano a esercitare un altissimo ruolo – politico in verità – che avrebbe
mantenuto l’assetto del sistema, è vero anche che vi fu la normalizzazione e la
stabilizzazione della giurisdizione di equità, nella quale si riconobbe d’ora in poi un
corpo fisso di norme tradizionali collocabile ordinariamente accanto alla giurisdizione di
common law.
E in questo passaggio non si può non cogliere un successo della concezione ‘orizzontale’
del diritto inglese.
La fusione a metà Ottocento dei due tribunali, insieme con il mantenimento della
fondamentale bipartizione concettuale common law/equity che giunge fino a noi, dice
forse di una mentalità giuridica che è riuscita tenacemente a sopravvivere, rinunciando sì
122
G. Giarrizzo, “Il pensiero inglese nell’età degli Stuart e della Rivoluzione”, cit., p. 185.
101
alla decisione politica di ultima istanza123, ma inglobando pure nella cornice ideale della
rule of law l’intero mondo del diritto.
Il moderno principio di legalità e di indipendenza del potere giudiziario incarna
un’assolutezza che smentisce parzialmente la tesi sostenuta dal Cancelliere Williams,
secondo il quale “in every policy there must be a Supreme, that can be judge by none,
for else the process between Party and Party would be circular, or rather infinite…”; solo
parzialmente, perché se è vero che sul piano giuridico la rule of law recide in maniera
netta ogni possibilità di appello a principi altri, è vero anche che essa, sul piano politico,
tace.
Vedremo di seguito, attraverso la voce di alcuni dei suoi autori, come i concetti della
scienza della common law delinearono questo quadro complessivo, per poter così
preparare l’analisi della soluzione hobbesiana all’interno della complessa vicenda storica
e filosofica del diritto inglese.
L’Inghilterra, a differenza degli Stati Uniti, ha scelto a favore della teoria blackstoniana della sovranità
del parlamento contro quella di Coke sulla sovranità del giudiziario, impedendo il controllo da parte delle
corti sulla costituzionalità delle leggi; il quadro è mutato significativamente a partire dalla “constitutional
revolution” messa in atto dalle riforme avviate nel 1997 dal governo Blair. Vd. U. Mattei, op. cit., p. 23
nota, e pp. 51 ss.
123
102
III
Tra custom e reason
Voci della filosofia del diritto nel mondo di common law
Uno degli aspetti più significativi che emerge dalla complessa evoluzione del sistema di
common law è la sorprendente resistenza di quel complesso assetto giuspolitico premoderno, nel quale convivono consensualmente molteplici sfere di potere che si
presentano al contempo definite e aperte, separate e in sovrapposizione.
Si è avuto modo di evidenziare come la spinta centralistica inglese si sia avviata e
imposta insinuandosi originariamente nelle crepe dell’impianto giuridico preesistente,
finendo poi per conferire all’insieme stesso un aspetto nuovo e uno stampo indelebile: il
modo peculiare in cui questo processo avvenne coniugò con tenacia elementi di carattere
opposto, integrandoli in un sistema flessibile che costituiva in se stesso il tratto d’unione,
a livello geopolitico, tra centro e realtà locali, su un piano giuridico e costituzionale –
ma anche filosofico – tra eccezionalità e carattere ordinario delle leggi, tra potere
assoluto e limitato; conservò in sostanza quella bipolarità propria del Medioevo nella
quale coesistono, pur separate e in contrapposizione, trascendenza ed immanenza.
Lo sviluppo del mondo dei concetti del diritto comune inglese indica un percorso per
certi versi analogo, pur se spesso ritmato dal rovesciamento del segno dei termini. Ne
103
anticipiamo la costante a nostro avviso rinvenibile, nonostante le significative differenze,
negli autori che segnarono questo itinerario e che ci accingiamo ora ad affrontare.
In Inghilterra, il linguaggio della common law riuscì ad imporsi docilmente
interiorizzando tutti quegli elementi che rimandavano ad altro e che indicavano un oltre,
conferendo in questo modo spessore teorico tanto alla concezione ‘orizzontale’ del
sistema, quanto al suo spiccato carattere nazionale.
La via battuta fu altamente mirabile.
Questo linguaggio era riuscito ad ammettere pacificamente l’esistenza di un ambito
extralegale (vale, come si è già notato, per la prerogativa assoluta del re, vale, come si
vedrà a breve, per la legge naturale), ma ciò a due condizioni: affermando, in primis,
l’esistenza in sé di una traccia che è allo stesso tempo un residuo di quella trascendenza,
una sorta di segno particolare dell’universale (il quale tratto, rendendosi solo in questo
modo disponibile, viene poi riconosciuto, unitamente al suo manifestarsi interno, come
locale); mantenendo, in secondo luogo, l’alterità di quell’ “extra”, inteso come un ordine
distinto e però confinante, dunque non sovraordinato.
Il consenso intorno a questo linguaggio perdurò fintanto che alla labilità dei confini
teoreticamente definiti corrispose un accomodamento elastico degli intenti e delle
rivendicazioni degli agenti in campo, andando di pari passo, quindi, con la tenuta del
mobile equilibrio dell’insieme. Nel momento in cui l’impossibilità di mantenere
l’armonia fu evidente, allora la sovrapposizione delle sfere e la flessibilità delle
definizioni venne percepita come una componente decisiva dell’aumento di incertezza e
104
insicurezza giuridica che i giuristi di epoca elisabettiana e giacobita avevano
chiaramente avvertito.
Il duro e continuo lavorio degli scrittori inglesi124 si rivela come il tentativo di
modificare e precisare i contorni dei concetti in base ai quali sarebbe stato possibile
spiegare, ma anche orientare e talvolta correggere, il sistema di common law.
La ragionevolezza del diritto inglese: Saint German
Se ci limitiamo a quanto scritto prima del diciassettesimo secolo, Il Doctor and
Student125 di Christopher Saint German è probabilmente l’opera teoretica sul diritto
inglese di maggior rilievo.
Noto per l’aspra e prolungata polemica con More126 che vide, oltre l’intento mediatore,
l’affermazione di un principio di divisione e gerarchizzazione tra giurisdizione laica ed
ecclesiastica, a Saint German va anche il merito di aver messo a punto una vasta,
brillante e soprattutto sistematica teoria del diritto la quale, essendo circoscritta al
contesto nazionale, finiva per dare al diritto inglese l’apparenza di un corpus omogeneo.
È a questa operazione che bisogna guardare se si vogliono trovare le cause del
sopravvivere dell’equity come sistema alternativo rispetto alla common law: senza
l’opera didascalica di Saint German la secolarizzazione dell’equity (avvenuta per
124
Per una panoramica degli autori che inseguito affronteremo, vd. M. Lobban, 8: A History of the
Philosophy of Law in the Common Law World, 1600-1900, in E. Pattaro (ed.), A Treatise of Legal
Philosophy and General Jurisprudence, Dodrecht 2007.
125
La prima parte dell’opera venne pubblicata in latino nel 1528 col titolo Dialogus de fundamentis Legum
Angliae et de conscientia, la seconda parte fu scritta in inglese e pubblicata nel 1530, mentre la traduzione
della prima risale al 1531.
126
Cfr. J. A. Guy, “Thomas More and Christopher St. German: The Battle of the Books”, in A. Fox e J. A.
Guy (a cura di), Reassessing the Henrician Age: Humanism, Politics and Reform 1500-1550, Oxford
1986, pp. 95-120.
105
evidenti motivi durante il regno di Enrico VIII, proprio a partire dal quale –eccezione
fatta per la reggenza di Maria I e l’affidamento dell’incarico a Williams sotto Giacomo I
– vennero esclusi gli ecclesiastici dall’ufficio di Cancelliere e fu bandito l’insegnamento
del diritto canonico dalle Università) avrebbe significato probabilmente il suo totale
assorbimento nei principi e nelle procedure dei tribunali di diritto comune.
Chiaramente indirizzato a sostenere attivamente la Riforma in Inghilterra, il libro di
Saint German si proponeva di fornire “una legittimazione universale alle consuetudini
proprie della sua comunità nazionale”127, calcando così la via battuta da tutto
l’umanesimo giuridico del sedicesimo secolo.
Questa legittimazione passava attraverso la ripresa dello schema scolastico di
articolazione della legge tracciato da San Tommaso128, anche se il riferimento diretto di
Saint German era a colui che fu cancelliere dell’università di Parigi dal 1395 al 1415,
nonché uno dei massimi esponenti delle istituzioni e del pensiero ufficiale dell’epoca,
Jean Gerson129.
La derivazione non è affatto di scarsa importanza, perché indica chiaramente come il
diritto inglese, giunto a dover rivendicare e definire il proprio statuto di fronte a, contro e
sopra il diritto universale della Chiesa, si sia trovato ad accogliere proprio dal diritto
canonico influssi considerevoli, seppur poi declinati in maniera peculiare e significativa:
la giustificazione delle leggi dell’Inghilterra richiedeva innanzitutto di affermare il loro
contenuto di ragione, e per ottenere ciò ci si era dovuti rifare a quel potente modello di
pensiero nel quale la ragionevolezza della legge era un tutt’uno con la sua partecipazione
127
H. J. Berman, Diritto e Rivoluzione II, cit., p. 419.
San Tommaso, Summa Theologica, Ia IIae, quest. 91.
129
Cfr. P. Prodi, Una storia, cit., pp. 182 ss.
128
106
ad una legge più alta, universale ed eterna130: il diritto naturale di San Tommaso
d’Aquino.
La trattazione di Saint German131 inizia quindi, come d’obbligo, dalla legge eterna, che
veniva da lui intesa seguendo il nominalista Gerson, come atto della volontà divina; si
passa poi alla legge di ragione, alla legge divina e infine alla legge umana.
È la seconda articolazione che ci è utile per individuare l’ambito specifico nel quale
Saint German modifica la tradizionale gerarchia scolastica delle leggi.
Il titolo latino del secondo capitolo recita: “de lege rationis que inter doctores vocatur lex
naturae rationalis creature sive ius gentium”.
Un primo elemento va sottolineato a proposito della consueta identificazione tra legge di
ragione e legge di natura, perché Saint German, come l’Aquinate, pur ammettendo un
senso più ampio del concetto di lex naturalis che include tutte le creature – razionali e
non – secondo la definizione di ius naturale di Ulpiano132, la intende in senso proprio133
soltanto come legge di natura delle creature dotate di ragione, le quali partecipano
all’eterna legge di Dio per lumen naturalis rationis134.
Nella versione latina questa specifica definizione collima con lo ius gentium, ma il
riferimento alla nozione del diritto romano cade nella versione inglese dell’opera e non
senza motivo: quando affronterà la legge di ragione, Saint German si distaccherà in
maniera non irrilevante da Tommaso (il quale, valga la pena ricordarlo, pur senza
Cfr. A. Passerin d’Entreves, La dottrina del diritto naturale, Milano 1980, cap. 2.
Cfr. P. Vinogradoff, “Reason and Conscience in Sixteenth-century Jurisprudence” in The Collected
Papers of Paul Vinogradoff London 19642, pp. 190-204.
132
Digesto, I, I, 1: “Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis
proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est.”
133
San Tommaso, Summa Theologiae, Ia IIae, quest. 91 a.2 ad 3: “In creatura autem irrationali non
partecipatur rationaliter, unde non potest dici lex nisi per similitudinem”.
134
Cfr. San Tommaso, Summa Theologiae, Ia IIae, quest. 91 a.2 co.; J. Gerson, Opera Omnia, II, Anvers
1706, p. 202.; Ch. Saint German, Doctor and Student: or, Dialogues between a Doctor of Divinity and a
Student in the Laws of England, Dublin 1792, Ch. 2.
130
131
107
addentrasi nelle difficoltà di una annosa questione, lega insieme in un rapporto deduttivo
discendente, legge naturale e legge umana).
Il giurista inglese procederà invece a stabilire una gerarchia che colloca al vertice la law
of reason primary, comprendente quelle leggi ricavate dalla semplice ragione, i cui
divieti e comandi sono accessibili a tutti gli uomini in ogni luogo ed in ogni tempo, e i
cui contenuti concernono ad esempio, il valore della vita e la personalità umana.
A questa seguirà la law of secondary reason, la quale verrà a sua volta distinta in due
rami, generale e particolare: sarà proprio l’introduzione di quest’ultima suddivisione a
non rendere più possibile la corrispondenza complessiva della legge di ragione con lo ius
gentium. La legge di ragione secondaria generale sembra non creare difficoltà al
riguardo, fondata com’è sulla consuetudine in base alla quale si garantisce la certezza
della proprietà; il passo merita di essere citato per esteso, perché assume un aspetto
ancor più interessante se osservato alla luce di quanto precedentemente sottolineato in
quest’analisi a proposito del diritto proprietario.
The law of a secondary reason general is grounded and derived of the general
law, or general custom of property, whereby good moveable and immoveable
be brought into a certain property, so that every man know his own thing. And
by this branch be prohibited in the laws of England disseisins, trespass in
lands and goods, rescuss, theft, unlawful with-holding of another man’s
goods, and such other […] And because disseisins, trespass in lands and
goods, theft, and other had not been known, if the law of property had not
been ordained; therefore all things that be derived by reason out of the said
108
law of property, be called the law of reason secondary general, for the law of
property is generally kept in all countries. 135
Si legga a fianco la conclusione al capitolo secondo.
Il giurista inglese aveva allora riportato l’opinione secondo la quale la legge che prevede
la comunanza dei beni non è mai stata una legge di ragione: essendo stata valida soltanto
in fasi di estrema necessità136 (“time of extreme necessity”), mutando dunque a seconda
delle circostanze, essa verrebbe a mancare di quel carattere immutabile proprio della law
of reason.
Proseguendo nel ragionamento saremmo portati a negare il carattere di legge di ragione
alla stessa law of property, la quale verrebbe meno in circostanze eccezionali,
rivelandosi anch’essa variabile nel tempo.
Che tipo di legge è dunque la law of property, che ritroviamo ora in un senso che rientra
nello ius gentium, ma non del tutto nella lex rationis? Incrociando i luoghi del testo
potremmo ipotizzare si tratti di una legge in genere, desumibile da quella di ragione, e
perciò riconosciuta generalmente in tutti i luoghi, che però conosce casi limite per i quali
viene meno la sua consueta validità.
Se già nella legge di ragione secondaria generale è ravvisabile una sorta di incrinatura
nel concetto di legge di ragione pura, la lacerazione sembra palesarsi con ancor maggior
chiarezza nel caso della law of secondary reason particular: qui cadono entrambi i
criteri dell’universalità dello spazio e dell’immutabilità nel tempo, perché questa legge
135
Ch. St. German, op. cit., ch. 5.
Ch. St. German, op. cit., ch. 2: “And here is to be understood, that after some men, the law whereby all
thing were in common, was never of the law of reason, but only in the time of extreme necessity. For they
say, that the law of reason may not be changed; but they say, it is evident, that the law whereby all things
should be in common, is changed: wherefore they conclude, that was never the law of reason”.
136
109
riguarda soltanto il regno d’Inghilterra e deriva non dalla sola ragione, ma dalle
consuetudini ivi esistenti.
Il punto teorico è fondamentale per capire la giustificazione che Saint German dà del
diritto inglese in nome del suo contenuto di ragione, o meglio, della sua ragionevolezza:
“si tratta di una «ragione», se così possiamo esprimerci, non già astratta e universale, ma
essenzialmente particolare e storica”137.
Per meglio focalizzare la questione lo Studente ricorre ad un esempio concreto – mossa
certo non irrilevante, che ritroveremo lungo tutto il testo – sottoponendo al Doctor of
Divinity un caso non deciso, da considerare sotto la premessa di una legge
consuetudinaria inglese che è stata anzitutto enunciata.
Il Dottore giunge alla soluzione della vicenda seguendo, inconsapevole, passaggi logici
che corrispondono esattamente a pronunciamenti fatti in passato da giudici inglesi 138, e
ciò perché si tratta, nelle parole dello Studente, di un processo pratico nel quale si
interpreta ragionevolmente il caso a partire dai principi del costume impostosi in
Inghilterra.
L’operazione compiuta da Saint German è chiara: egli mira a giustificare le operazioni
dialettiche del diritto nazionale in base alla loro ragionevolezza, innalzando e
rafforzando così lo statuto della legge inglese. Mentre le altre suddivisioni della legge si
trovano al riparo dalle polemiche poiché il loro contenuto è da tutti sufficientemente
A. Passerin d’Entreves, “La teoria del diritto e della politica in Inghilterra all’inizio dell’età moderna”,
in Saggi di storia del pensiero politico, Milano 1992. L’ispirazione storicistica del diritto inglese sembra
comparire in nuce in Saint German. Vedremo in seguito gli sviluppi di questo indirizzo nelle teorie degli
scrittori successivi, per analizzare infine la critica mossagli da Hobbes e la risposta da parte di uno dei suoi
più importanti rappresentanti, Hale. Vd. infra, pp. 142 ss.
138
Vd. P. Vinogradoff, op. cit., p. 195, nota.
137
110
noto, la legge di ragione secondaria particolare presenta, proprio riguardo alla sua
conoscenza, grandi difficoltà; si tratta di una legge ibrida, che in quanto frutto della
ragione non richiede necessariamente di venir fissata nella legge scritta, presentando di
per sé un certo grado di evidenza, evidenza però non tale da renderla a chiunque
disponibile; in quanto applicata a partire da antichi costumi, da massime e da statuti,
l’interpretazione e la definizione del suo contenuto devono però essere affidate a giudici
professionisti, al parlamento e al re.
Saint German delinea così un quadro composto in primo luogo da immemorabili
consuetudini che costituiscono in senso proprio la common law, conosciute soltanto in
quanto determinate dagli esperti conoscitori dei principi della legge inglese.
Se la certezza della common law è fondata sulla sapienza di giuristi addestrati a una
pratica dimostrativa che non procede only by reason139, la sua forza obbligante è tutta
racchiusa in questo senso di ragionevolezza intrinseca che non è mera ragione, ma
ragione rafforzata da consuetudini accettate da tempo e perciò stesso presumibilmente
buone e necessarie.
Non passi inosservato il fatto che, in quello scollamento dall’immutabilità della pura
ragione che poteva far pensare a un deficit di certezza del diritto comune inglese, Saint
German ritrova in verità un diverso principio di ragione che, seppur imperfetto, finisce
per potenziare la common law, dal momento che si intreccia in essa con una permanenza
duratura nel tempo: come dire che la stessa mutabilità della consuetudine che rende
Ch. St. German, op. cit., ch. 7. L’idea, da qui facilmente deducibile, di una ragione dei giuristi
diversamente intesa, sarà lo spazio in cui troverà dimora il concetto di ragione artificiale. Vd. infra.
139
111
spuria la ragione, rimasta legata ad essa in un intreccio costitutivo, rappresenta
un’aggiunta di valore in quanto mima, avvicinandola, l’eternità perduta.
Vi è in ciò anche un forte tratto di debolezza: proprio in quanto non ancorata alla
semplice ragione, la legge di ragione secondaria particolare basata sulla consuetudine
può essere abolita o modificata mediante uno statuto parlamentare, e ciò non in virtù
dell’essere gli statuti imposizioni di un organismo costituzionale superiore, ma piuttosto
perché al parlamento Saint German attribuisce la suprema autorità interpretativa della
legge naturale e divina, conferendogli quindi non solo – e si ricordi che si tratta del suo
principale intento polemico – la giurisdizione sulle questioni ecclesiastiche, ma anche la
capacità di valutare se e in che misura la common law si discosti da quelle.
Il discorso circa la sovranità del parlamento, concetto di cui il nostro è considerato
precursore140, lo si trova soprattutto negli scritti polemici degli anni trenta, attraverso i
quali egli partecipa attivamente al dibattito nato intorno alla Riforma in Inghilterra.
Esso rappresenta la chiave di volta della soluzione proposta da Saint German al conflitto
di leggi e autorità esploso prima, durante e dopo l’emanazione dell’Atto di Supremazia
nel 1534, e ridefinisce sopratutto il rapporto tra legge umana e legge divina.
Sottratti gli statuti parlamentari ad ogni controllo di validità dalla prospettiva di un
modello di diritto superiore, l’affermazione della corrispondenza delle leggi del regno
alle leggi di Dio poteva sostenersi soltanto sulla base della loro coerenza effettiva e
storica, riproponendo ancora una volta il criterio della durata, accanto a quello
rilevantissimo del consenso tra re, nobili e commons, come segni fattuali della legittimità
Cfr., J. A. Guy, “Thomas More…”, cit., p. 101. Vd. anche J. Golsworthy, The Sovereignty of
Parliament: History and Philosophy, Oxford 1999, p. 71.
140
112
della legge positiva del regno: fino a prova contraria, la ragionevolezza della legge
positiva doveva essere presunta.
Nella lunga campagna contro la giurisdizione ecclesiastica, Saint German era giunto nei
pressi del campo spinoso della coscienza individuale.
Sostenne che in questioni attinenti il diritto, erano da seguire non i dettami dei chierici,
ma sì quelli della legge, e non soltanto (e nemmeno soprattutto) quelli della legge divina
o della legge di ragione pura: la coscienza doveva essere guidata e orientata
principalmente della legge del paese, vale a dire, dai costumi, dalle massime, dagli
statuti, e ciò perché, come egli si spinse ad affermare, il parlamento aveva avuto incarico
non solo sui corpi, ma anche sulle anime dei sudditi141.
Lungo questa via però il giurista inglese si trovò a dover affrontare un tema che
investiva un altro durissimo conflitto tra giurisdizioni, non più la contrapposizione tra
sfera ecclesiastica e temporale, ma quella tra Court of Chancery e corti di common law.
All’interno del quadro delineato da Saint German si apriva però il seguente quesito: se
l’intero sistema di giustizia doveva presupporsi ragionevole, che bisogno c’era di una
giurisdizione orientata a correggerlo? O più precisamente, perché si rendeva necessaria
la presenza di una corte separata che amministrasse l’equità?
Dopo il cancellierato di Thomas Wolsey (1515-1529) – versione embrionale di quello
sovversivo di Ellesmere (1596-1617)142 – Saint German tentò per primo di definire i
Vd. Ch. Saint German, “A Lytle Treatise Called The Newe Addicions”, in T. R. T. Plucknett, J. L.
Barton (a cura di), St. German’s Doctor and Student, London 1974, p. 327.
142
Vd. supra, p. 95.
141
113
rapporti tra common law ed equity battendo la via della conciliazione e del
riconoscimento reciproco tra le sfere.
In questa misura, la risposta alla domanda sopra enunciata si orienterà all’individuazione
della complementarietà tra le corti, e la loro esistenza separata verrà ricondotta soltanto
alla diversità delle procedure in esse seguite e non già a tipi di giustizia diversi e
opponibili, o addirittura gerarchicamente disposti.
Secondo Saint German (il quale parte dal concetto aristotelico di epieikeia,
riprendendolo non direttamente dai luoghi classici dell’Etica Nicomachea143, ma dalla
trattazione di Gerson144, per declinarlo poi in modo originale), la Corte della Cancelleria
provvedeva a offrire rimedio alla parte lesa esclusivamente mediante il writ di
subpoena145, solo e unicamente nel caso eccezionale in cui le corti di diritto comune non
fossero riuscite a fare giustizia tramite le loro procedure ordinarie; il che equivaleva in
verità ad affermare che i pronunciamenti della giurisdizione d’equity non avrebbero
potuto dar luogo a sentenze contro la common law, dal momento che consistevano
piuttosto in un’integrazione attraverso la quale si dava voce alla legge di ragione, nel
caso in cui fosse rimasta silente una volta applicati gli schemi procedurali ordinari.
Per questi passi che costituiscono la ‘fonte madre’ di ogni discorso sull’equità, vd. Aristotele, Etica
Nicomachea, V, 12, 1136b 33; V, 14, 1137a 31 – 1138a 3; VI, 11, 1143a 20. Vd. anche, Retorica, I, 13,
1374a 26 – 1374b 23.
144
Ch. Saint German, op. cit., ch. 16: “And it is called also by some men epieikeia; the which is no other
thing but an exception of the law of God, or the law of reason, from the general rules of the law of man:
when they by reason of their generality, would in any particular case judge against the law of God or the
Law of reason, the which exception is secretly understood in every general rule of every positive law”
(corsivo nostro).
145
Col writ di subpoena, valido ovunque nel paese, la corte ingiungeva al convenuto di comparire e
rispondere alla petizione, pena una consistente ammenda o persino l’imprigionamento; in esso non veniva
precisato il motivo dell’azione, deresponsabilizzando così il postulante. Il procedimento avviato prevedeva
che il Cancelliere, non affrancato da una giuria, potesse ricevere testimonianze direttamente dalle parti in
causa. Abbiamo già avuto modo di dire come la minor formalità delle procedure della Court of Chancery
fosse spesso sinonimo di maggiore efficacia e celerità rispetto all’operato delle corti di diritto comune. Vd.
Garavaglia, op. cit., p. 582.
143
114
Il giurista escludeva così dall’azione legittima della Cancelleria la possibilità di
correggere decisioni già prese nel King’s Bench, nella Court of Common Pleas e nella
Court of Exchequer146; proprio ciò che farà invece Ellesmere generando lo scontro con
Coke.
Ancora una volta il carattere non assoluto e imperfetto della common law lascia aperta la
porta a un suo potenziamento: l’equity non smentisce la ragionevolezza del sistema
perché, alla luce del suo intervento, la mutabilità del diritto comune inglese indica la
possibilità di un completamento che, in fin dei conti, tende a connotare la common law
in modo forse più ampio, ma pur sempre autosufficiente.
Facendo della peculiarità della Court of Chancery la sua specifica procedura, Saint
German non solo collocava l’equità sul medesimo piano della common law in senso
stretto, ma inquadrava la prima, allo stesso modo in cui era inquadrata la seconda, in un
parametro di applicazione pratica prestabilito che, inevitabilmente, conosceva eccezioni
in casi determinati: vi erano dunque circostanze nelle quali la giurisdizione d’equity
nulla poteva.
Questa conclusione ci porta a chiarire il senso esatto in cui l’equità viene considerata
come un tramite della coscienza: la Corte della Cancelleria era una court of conscience
non nel senso che seguiva la coscienza del Lord Cancelliere, ma nella misura in cui la
sua procedura era volta a stabilire, sempre guidata dai principi e dai fondamenti della
legge d’Inghilterra, la vera giustizia sottaciuta dalla common law: la coscienza alla quale
attingeva non presentava un carattere individuale, ma poteva essere intesa piuttosto
come una sorta di “coscienza nazionale” che aleggiava intorno al diritto comune inglese.
146
Cfr. A. Cromartie, art. cit., p. 82.
115
A partire da queste premesse, nessun rimedio equitativo era offerto dunque nei casi in
cui non vi fosse l’evidenza delle prove da sottoporre alla corte, come non era prevista
nemmeno alcuna correzione da parte di essa di massime o statuti: gli occhi della corte di
equità erano ciechi nei casi in cui la ragione (o l’assenza di essa!) si celasse, da una parte
nel margine pur ristretto in cui la coscienza individuale rimaneva insondabile, e
dall’altra in quella sfera in cui la decisione del parlamento era sovrana e insindacabile.
Tanto l’individuo come il parlamento avrebbero potuto in linea teorica, compiere il male
assoluto o l’assoluto bene, agendo arbitrariamente o liberamente, e in entrambi i casi essi
sarebbero stati come demoni o santi non imputabili davanti ad alcuna corte umana.
Nel secondo caso si sarebbe trattato della realizzazione della pura ragione, ed il massimo
bene non conosce accuse e non necessita di tribunali (quando a fare la rivoluzione
saranno i santi147, infatti, chi li potrà giudicare?).
Di fronte invece all’eventuale devianza dalla legge di ragione nessuna sanzione legale è
disponibile.
La soluzione al dilemma che emerge dalle parole di Saint German è pregnante, da
qualunque angolatura la si guardi.
Se la bontà dell’azione del parlamento è da lui provata per via fattuale, affermando
dunque la presunzione della ragionevolezza della sua decisioni in base alla storia, egli
ritrova la bontà dell’uomo elaborando proprio il concetto di coscienza: a monte di
questa, Saint German indicherà la nozione di synderesis148 – giunta fino a lui seguendo
un percorso che parte dal commento a Ezechiele di Girolamo, passa a Alberto Magno e
147
148
Cfr. Walzer M., The Revolution of the Saints: A Study in the Origins of Radical Politics, London 1982.
Cfr. Ch. Saint German, op. cit., ch. 13.
116
da lì a Tommaso149 – ovvero quel potere naturale dell’anima di muovere verso il bene e
discostarsi dal male.
Sulla base di questa facoltà di discernimento, grazie alla quale sono in lui i principi della
legge di ragione, l’uomo sarà in grado di testare in cuor suo la validità delle leggi, e, nel
caso specifico in cui esse si dimostrino ingiuste, egli potrà provvedere a rimediare
secondo il dettame non già della legge, ma della sua personale coscienza.
La nascita del movimento antiquario: Lambarde
Nella figura di William Lambarde (1536-1601) trovano luogo e sviluppo alcuni dei più
importanti aspetti del pensiero di Saint German, dal ruolo centrale del parlamento, alla
complementarietà tra common law ed equità ed al valore della storia come cardine di
legittimità del sistema giuridico inglese.
Da quest’ultimo tema converrà prendere le mosse per comprendere l’importanza di colui
che viene considerato essere il fondatore, e insieme ad Hale uno dei massimi esponenti,
dell’antiquaria giuridica inglese.
L’inizio del movimento antiquario
– che sul piano della storia legale può ben
considerarsi la risposta culturale alla questione posta, ma non risolta, da Saint German,
circa la vetustà degli istituti giuridici inglesi – può datarsi al 1576, anno in cui venne
pubblicata la prima storia di una contea inglese, la Perambulation of Kent: containing
the description, Hystorie, and Custumes of that Shyre150, scritta da Lambarde.
149
P. Vinogradoff, cit.
W. Lambarde, Perambulation of Kent: containing the description, Hystorie, and Custumes of that
Shyre, London 1576. Cfr. G. Burgess, The Politics of the Ancient Constitution, Pennsylvania 1993, pp. 58
ss.
150
117
L’interesse dell’opera, che doveva essere la prima di una serie di studi corografici volti
ad indagare le antichità inglesi contea per contea (ma il progetto venne abbandonato
dopo la lettura del manoscritto della Britannia di Camden151 nel 1585), sta nel suo
rappresentare quel particolare tipo di approccio storico (destinato a diventare un vero e
proprio genere della storiografia del paese) che ha come oggetto circoscritte realtà
regionali entro i cui confini vengono ritrovate le manifestazioni locali che innervano la
vicenda nazionale nel suo complesso.
L’importanza della ricerca intorno a queste declinazioni topiche emerge con tutta la sua
forza se la si osserva alla luce dei presupposti teorici rinvenibili in Saint German: di essi,
tale indagine costituisce una sorta di ricaduta sul piano dei saperi, e risulta evidente
come la progressiva retrodatazione degli istituti, nonché il crescere della certezza delle
conoscenze sui loro tratti specifici, abbia permesso di conferire spessore materiale alla
loro bontà e alla peculiare razionalità che essi incarnano.
In questo senso far risalire la creazione degli organi giuridici all’epoca della conquista
sassone come fa Lambarde nell’Archeion, or, A discourse Upon the High Courts of
Justice in England152, risultava essere un’operazione di enorme rilevanza: la genesi del
sistema veniva situata così in un tempo lontanissimo, e ricollegata inoltre alle usanze di
un popolo le cui radici affondavano in un immemorabile passato che emergeva,
significativamente (e la questione meriterebbe trattazione a sé), dalle pagine di quello
che in tempi più recenti – e per ben altri motivi – è stato definito uno dei libri più
pericolosi mai scritti153, la Germania di Tacito.
151
W. Camden, Britannia, London 1585.
W. Lambarde, Archeion, or, A discourse Upon the High Courts of Justice in England, London 1635.
153
A. Momigliano, Studies in Historiography, New York 1966, pp. 112-113.
152
118
Collocando la nascita della common law prima della conquista normanna, Lambarde
negava l’idea che essa potesse considerarsi risultato dell’azione innovativa di un solo re,
e pur mantenendo la figura della regalità, egli l’intrecciava inscindibilmente ad un
elemento consensuale che risuonava nelle parole dei capitoli settimo e undicesimo
dell’opera tacitiana: “Nec Regibus infinita potestas, de minoribus rebus Principes
consultant, de majoribus omnes”154.
La natura di questa compresenza di elementi è rintracciata nel precorso di formazione
delle corti di giustizia, che, schematicamente, possiamo riproporre come segue:
Lambarde fa nascere il governo quando il popolo, dilaniato da conflitti, si sottomette in
vista della pace, alle leggi e ai comandi di un re; quando questi però volge a proprio
personale vantaggio tali disposizioni, allora il popolo concepisce leggi e precetti di
giustizia che legano il governante; quest’ultimo, allora, si incaricherà di stabilire corti
che offriranno rimedi alle ingiustizie, applicando le direttive provenienti dal popolo
stesso.
Ciò che ci interessa sottolineare, in quanto descrive esemplarmente una tensione che
abbiamo più volte detto essere strutturale, è il fatto che l’esposizione di Lambarde torni
continuamente sia sulla centralità del parlamento insieme con le corti ordinarie, sia sulla
presenza di quel potere “sovrano e preminente”155 di equità, il solo in base al quale il re
può esercitare pienamente l’ufficio di rendere giustizia.
154
W. Lambarde, Archeion, cit., p. 246.
Ibid., p. 68 (tr. it. in N. Matteucci, Costituzionalisti inglesi, Bologna 1962, p. 47) : “Considerando che il
principe di questo regno è l’immediato ministro della giustizia in Dio, e che alla sua incoronazione ha
giurato di rendere ai suoi sudditi aequam & rectam Iutstitiam, non posso immaginare come ciò possa
avvenire in altro modo, se non che, oltre alla sua corte di mero diritto, egli debba riservare a se stesso, o
rimettere ad altri, un certo potere sovrano preminente, col quale egli possa al tempo stesso sopperire alle
mancanze, e correggere il rigore di quel diritto positivo e scritto, che di per sé non è, né può essere fatto,
una regola talmente perfetta, che un uomo possa con essa rettamente misurare la giustizia in tutti i casi che
possano avvenire”.
155
119
Tenendo insieme questa duplice prospettiva, il sistema di diritto inglese è per lui la
realizzazione di un’aurea via di mezzo tra le estreme circostanze nelle quali potrebbe
rivelarsi arbitraria l’azione delle une e dell’altro, e grazie ad essa si congiungono,
secondo precisi criteri, l’esigenza di una giustizia ordinaria che agisca mediante
l’applicazione di determinate forme giuridiche e la necessità di una giustizia equitativa
che integri e mitighi il rigore delle leggi.
Fra questi due estremi, Medio tutissimus ibis, c’è una via di mezzo, che
preserverà al tempo stesso la maestà del re, manterrà l’autorità delle corti
ordinarie, e soccorrerà l’angosciato cliente nel più grave disagio. La qual via
di mezzo, per dirla brevemente, è questa che ho detto: sempre che l’ordinaria
giurisdizione delle corti di common law non venga impedita da tale sconfinata
autorità, ma soltanto (come ho detto) laddove esse non abbiano autorizzazione
ad accogliere il processo, o laddove il corso della loro debita procedura sia
disturbato; o laddove il caso sia tale da meritare di essere ascoltato in più alta
sede; o la parte sia tale da essere incapace di reggere il faticoso corso di un
solenne processo e giudizio; o laddove qualche altra rara, straordinaria, o
importante considerazione indurrà ad adottare questo 156.
La specificazione dei modi in cui questa coesistenza deve avvenire sposta sempre più la
tematica del rapporto common law/equity sul piano costituzionale, e sempre a questo
proposito non sembra irrilevante il fatto che, a differenza di Saint German che rimarca
essere l’equity amministrata innanzitutto dai giudici piuttosto che dal re, Lambarde
pur dicendo della possibilità di delega –
–
enfatizzi proprio l’origine regale della
giurisdizione di equità, definendola propriamente come la “coscienza del principe”.
156
Ibid., p. 121 (tr. it. pp. 49-50).
120
Il pericolo potenziale insito nell’esercizio delle due giurisdizioni insieme alla possibilità
di una loro perfetta associazione e successo nel caso in cui si limitino e si completino a
vicenda, vengono resi con eloquenza quando Lambarde paragona la legge e l’equità a
due piante velenose che se mescolate abilmente, compongono una dolce medicina: “a
most sweet and harmonical Justice”157.
Lo sforzo, tutto teso a dimostrare l’armonia risultante dalla doppia radice di un assetto
giuridico che proprio in virtù della sua “aurea mediocrità” costituiva un sistema naturale
e ordinato, è chiara espressione delle preoccupazioni di fine secolo 158: la sua eco però
giungerà a farsi sentire – il libro, scritto nel 1591, sarà pubblicato postumo nel 1635 –
soltanto quando si accorderà con l’enfasi ideologica che già negli anni precedenti alla
guerra civile, si rivolgeva alla tradizione per recuperare, in realtà rifondandola, l’armonia
perduta: una tradizione che poteva “essere rimessa in piedi solo per mezzo della
soppressione del passato prossimo e il ritorno a un passato più remoto”159.
La legge come ragione artificiale: Coke
Solo a patto di scegliere specifiche e circoscritte ‘linee di lettura’ si può forse aspirare a
rendere, o almeno ad evocare con successo, la complessità e la ricchezza d’implicazioni
del pensiero degli autori che abbiamo scelto di affrontare.
Ciò vale a maggior ragione per un personaggio del calibro di Sir Edward Coke, figura di
primissimo ordine del pensiero giuridico inglese, coinvolto profondamente, come
abbiamo già avuto modo di accennare, nelle vicende travagliate del suo tempo, capace di
veicolare in nome di una passione per la propria disciplina alla quale è difficile trovare
157
W. Lambarde, Archeion, cit., p. 69.
Cfr. supra, I.1.
159
H. J. Berman, Diritto e Rivoluzione I, cit, p. 127.
158
121
eguali, un patrimonio sapienziale che catapultò nella modernità e oltre, un’impronta
medievale che, applicata a tempi nuovi, si caricò di significati inediti.
Nelle pagine che seguono non ci proponiamo quindi di offrire una visione globale della
sua concezione giuridica o un resoconto dettagliato del suo ruolo politico, ma piuttosto
cercheremo di isolare alcuni aspetti che abbiamo già visto posti e in vario modo
sviluppati da Saint German e Lambarde, per mettere a fuoco il modo in cui vennero
collocati e ridefiniti all’interno della sua opera (contro la quale, converrà ricordarlo, si
scagliò esplicitamente lo Hobbes del Dialogue).
Oltre ad essere oggetto del dibattito che lo vuole rappresentante tipico o viceversa voce
eccentrica della “common law mind”160, Coke è stato detto essere esponente di un
conservatorismo rivoluzionario161 e tale definizione ci aiuta più di altre a ricollegare il
discorso su di lui a quanto detto in conclusione al paragrafo su Lambarde: l’urgente
bisogno di una riforma del sistema di giustizia, che è il risvolto, sul piano giuridico, di
una rottura sistemica non più ricomponibile, si trasformò nelle mani di Coke anzitutto in
un impresa letteraria senza precedenti, la quale, attingendo ad un passato remoto, pose le
basi di un assetto nuovo nel quale ebbero seconda vita antichi principi e lontani saperi.
Nei quattro volumi degli Institutes of the Laws of England Coke mise la sua vastissima
conoscenza degli Year Books a disposizione di tutte le generazioni di common lawyers a
venire, traendo fuori da quelli che sono “la forma più misteriosa ed al contempo più
160
Per la prima opinione vd. Pocock, J. G. A., The Ancient Constituition and the Feudal Law: A History of
English Historical Thought in Seventeen Century. A Reissue whith a Retrospect, Cambridge 1987. Per la
seconda, G. Burgess, op. cit.
161
Cfr. H. J. Berman, Diritto e Rivoluzione II, cit, p. 442.
122
caratteristica della letteratura giuridica inglese medievale”162, un patrimonio che
altrimenti sarebbe forse rimasto occulto e silente.
L’opera tuttavia non è una panoramica completa sul diritto inglese disposta in forma di
norme, ma piuttosto un commentario alle sue fonti, teso fondamentalmente a trasmettere
l’arte del ragionamento legale: questa sua forma di glossa comprende già i tratti
caratteristici della concezione del diritto del suo autore.
Il lontano passato al quale Coke rivolge l’attenzione è principalmente e
significativamente l’epoca precedente ai Tudor.
Non che egli neghi il carattere immemore del diritto inglese: per lui, come per gli autori
a lui antecedenti, la notte dei tempi nella quale si perdono le origini della common law
non conosce un inizio fissato nella memoria o riportato nei registri; ma quando egli
guarderà ad un passato ancora più remoto per ritrovare le fasi embrionali delle istituzioni
inglesi, seguendo a ritroso lo sviluppo della common law, il suo approccio storico si
rivelerà approssimativo e spesso insostenibile.
E ciò si spiega perché al Coke giurista non interessa tanto stabilire la storicità dei fatti,
quanto soprattutto rimarcare la continuità ininterrotta di questa storia; e in questo senso,
retrodatare l’origine della common law persino ai tempi di Bruto di Troia, con Fortescue
e contro il Goticismo di Lambarde, significa affermare anzitutto che il diritto inglese è
sopravvissuto inalterato ad ogni conquista e ad ogni conquistatore.
I casi tratti dagli Year Books non tracciavano una linea di partenza, ma erano soltanto la
fonte scelta da cui trarre un corpo organico di principi che si sarebbero ritrovati identici
in tutto l’arco della storia inglese. Sia detto per inciso che, dopo la composizione degli
162
Composti tra il 1270 circa fino al 1535, gli Year Books raccolgono informalmente decisioni, statuti,
dibattiti, riflessioni estemporanee, riportando per ognuno l’anno del regno in cui sono avvenuti. Si tratta di
una sorta di pangea dei generi della letteratura giuridica inglese. Vd. U. Mattei, op. cit., p. 44.
123
Institutes, nessun common lawyer guardò più indietro o fuori da quanto commentato da
Coke. “Si creò immediatamente la tendenza a non andare a guardare il diritto anteriore a
Coke. I vecchi casi da lui citati avrebbero continuato ad essere citati, quelli da lui omessi
non sarebbero mai più stati recuperati”163: l’opera costituì nei fatti, un limite e un
ancoraggio della memoria giuridica inglese.
È stato proprio il carattere paradossale della compresenza nella legge di un elemento
consuetudinario, quindi mutevole, e un aspetto fisso e immodificabile, a dar filo da
torcere agli interpeti di Coke.
Come potevano convivere questi due aspetti?
Abbiamo visto con Saint German e Lambarde come l’ispessimento giuridico e filosofico
dell’elemento consuetudinario abbia implicato il riconoscimento della mutabilità della
legge e portato con sé la necessità di dare a questo carattere un valore positivo e
rafforzativo della common law.
Ora però Coke si trova di fronte alla crisi di un assetto che, fondato su questi mobili
pilastri, non è più capace di armonizzare da sé le intrinseche componenti contrapposte; e
in questa precisa misura non riesce più ad essere garante di certezza, per cui lo sforzo
della sua riflessione volge tutto all’individuazione di fondamenti saldi e immutabili in
grado di contenere la spinta dissolutiva dei mutamenti.
For any fundamental point of the ancient common law and customs of the
realm, it is a maxim in policy, and a trial by experience, that the alteration of
any of them is most dangerous for that which had been refined and perfected
by all the wisest men in former succession of ages and proved and approved
163
T. F. T. Plucknett, A Concise History of the Common Law, Boston 19565, p. 283, citato da U. Mattei,
op. cit., p. 47.
124
by continual experience to be good & profitable for the common wealth,
cannot with great hazard an danger be altered or changed 164.
Il suo conservatorismo è la risposta ad una precisa circostanza politica in cui l’appello
alla natura e al contenuto di ragione della legge inglese era divenuto strumento
sovversivo nelle mani di chi, come Ellesmere e Giacomo, tendeva ad espandere la sua
giurisdizione oltre i limiti prestabiliti dal sistema, indirizzando la monarchia a divenire
più potente di quanto non lo richiedesse il mantenimento dell’ordine sociale esistente165:
ai suoi occhi fu evidente che il richiamo ai precedenti consuetudinari, in mancanza di un
chiaro riferimento ad un fondamento di legittimità, poteva rappresentare una seria
minaccia al potere del diritto e alle libertà individuali. La preservazione di questi ultimi è
il fulcro della riflessione di Coke, ma dovremo precisare in seguito in che modo essi si
debbano intendere.
Sir Edward non dubitò nell’invocare la legge di natura quando si trattò di fare della
fedeltà alla Corona – dovuta in pari modo da tutti i cittadini nati dopo l’incoronazione di
Giacomo in entrambi i suoi regni
166
(Calvin’s case, 1608) – il fondamento della
legittimità della naturalizzazione (sic) dei sudditi scozzesi.
164
E. Coke, Le Qvart Part des Reports del Edward Coke, London, 1604, preface, sig. B2, citato da M.
Lobban, op. cit., p. 35
165
Cfr. B. Manning, art. cit., (tr. it. p. 347) e in generale, supra, I. 1.
166
Cfr. G. Burgess, op. cit., pp. 127 ss. Pur senza poterci soffermare nel dettaglio, il punto che emerge da
quanto afferma Burgess è molto indicativo: nel momento in cui la riflessione giuridica inglese si trova ad
agire in funzione imperialistica, ed è il caso dell’Unione Anglo-Scozzese, essa fa uso di quel jus gentium
che è stato bandito, in modo complesso, articolato e per molti versi ambiguo, dai propri confini.
Interessante notare insieme che dopo la Gloriosa Rivoluzione del 1689, il parlamento inglese “permise
alle prerogative regie di sopravvivere, per esempio, nel controllo delle colonie inglesi d’oltremare” (H. J.
Berman, Diritto e Rivoluzione II, cit., p. 411).
125
Nel giudizio sul caso Calvin, il successo del re nell’affermare un dovere “esistito fin
dall’istituzione del governo e prima della creazione delle legge e del diritto”167, fu
sostenuto da chi, come Coke, ebbe modo di asserire che “before judicial or municipal
laws were made, Kings did decide causes according to natural equity, and were not tied
to any rule or formality of law, but did dare jura”168.
Quale maggior riconoscimento della prerogativa regia! Coke non era un oppositore della
filosofia giuridica di Giacomo: il dissidio sorse quando si fece palese il fatto che
conferire al re la piena titolarità di una tale autorità naturale ed extra-giuridica poteva
condurre sia ad un indebolimento della base dei diritti dei sudditi inglesi (finché si tratto
di quelli dei sudditi scozzesi tale possibilità non sembrò particolarmente problematica),
sia ad una fatale menomazione della common law; fu ciò che avvenne durante lo scontro
con il Cancelliere Ellesmere e in occasione del Bate’s Case.
I due aspetti in verità erano per Coke profondamente intrecciati ed è significativo il fatto
che la difesa di entrambi i diritti, dei sudditi e della common law, rimandi nella sua
argomentazione ad un concetto di proprietà ereditabile, non lontano da quello di cui si
avvaleva Giacomo per difendere la propria prerogativa.
È da questa prospettiva che risulta anzitutto insostenibile considerare la posizione di
Coke come una difesa della libertà in senso astratto dell’individuo: se è vero che egli,
ridefinendo una questione che avevamo visto insinuarsi in Saint German, fa della sfera
individuale dei soggetti un criterio di legittimità e un limite all’arbitrio – si ricordi che
167
168
G. A. Ritter, art. cit., (tr. it., p. 88).
English Reports vol. 77, p. 392, citato da M. Lobban, op. cit., p. 55.
126
egli fu il redattore, insieme a Selden, della Petition of Right – è altrettanto vero che
intende tale sfera come una dimensione del tutto diversa a quella della coscienza.
Quando dice libertà, egli pensa alle libertates feudali, ai beni, alle franchigie e ai
privilegi169; quando ne afferma il carattere fondamentale in nome di una serie di statuti
medievali che vanno dal de Tallagio non Concedendo alla Magna Carta, sta sostenendo
il carattere naturale e inviolabile, per l’uomo inglese, della proprietà privata, e non certo
della ragione individuale.
Tuttavia la difesa delle libertà così intese, nella congiuntura politica dell’epoca,
assumeva un valore costituzionale dalla portata potenzialmente rivoluzionaria: ad
esempio,l’idea tipicamente feudale secondo la quale “la dimora di un inglese è per lui
come il suo castello”, evocata a più riprese sia nei Reports e che negli Institutes, veniva
tramutata in un principio giuridico sulla base del quale sarebbe stato possibile affermare
l’illegalità delle requisizioni ad opera del re170; in generale, Coke stava creando un
fondamento (ben più saldo della memoria giuridica) a cui ancorare la libertà degli
inglesi, intesa come l’insieme dei loro beni e come totale l’arbitrio sulla loro propria
persona e su di essi171; egli stava ridefinendo la storia del diritto nazionale in termini di
Tradizione e Precedente, in base ai quali legittimare e garantire, sempre e solo secondo
l’interpretazione dei giuristi, la proprietà.
“In sostanza Coke pensava in termini di «diritti» non di «diritto»” 172, ma proprio la
tutela di questi diritti concreti richiedeva anche il ripensamento e la riformulazione di
una teoria del diritto che in questi anni stava rivelandosi incapace di dare certezza, e ciò
Nel secondo volume degli Institutes Coke usa questi termini nel commento all’articolo 29 della Magna
Carta; vd. N. Matteucci, op. cit., p. 60.
170
Ch. Hill, Intellectual Origins of The English Revolution Revisited, Oxford 20022, p. 211.
171
Cfr. C. B. Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism, Oxford 1962, ch. III.
172
Ch. H. McIlwain, op. cit., p. 36.
169
127
appunto perché, secondo il fronte antimonarchico, la prerogativa regia aveva invaso
illegittimamente la sfera della proprietà dei cittadini, nella quale veniva a comprendersi
anche il diritto stesso.
La risposta di Coke è perentoria: “La common law ha tanto riproporzionato le
prerogative del re, che queste non possono togliere, né pregiudicare, il retaggio di
alcuno; e il miglior patrimonio che il cittadino possiede è la legge del regno”173.
Seguendo questa direzione, Coke si trovò a spostare il baricentro della riflessione
giuridica da quegli elementi di mutevolezza e dinamicità propri della consuetudine al
polo della ferma ragione, che, da lui concepita in senso innovativo, avrebbe costituito il
perno di una teoria del diritto specificamente inglese, e si sarebbe in verità sganciata in
modo ben più radicale rispetto a Saint German, dall’idea di ragione naturale.
Nel 1607 Sir Edward ebbe a dire al re che “le cause riguardanti la vita o il patrimonio o i
beni e le fortune dei suoi sudditi non erano cose da decidersi in base alla ragione
«naturale», ma in base alla ragione «artificiale» e al giudizio della legge, la quale legge è
un atto che richiede lungo studio ed esperienza prima che un uomo possa attingere alla
sua conoscenza”174.
Riportiamo per intero il celebre brano degli Institutes che definisce il nuovo concetto,
che pure avevamo già parzialmente rinvenuto nella prima citazione qui fatta dell’opera
di Coke, quando si diceva sulla pericolosità di innovare quelle antiche leggi affinate e
perfezionate dai più saggi uomini continuativamente nel tempo.
173
E. Coke, Le Second Part des Reports del Edward Coke, London, 1604 (tr. it. in N. Matteucci, op. cit.,
p. 63).
174
Ibid., p. 56.
128
And this is another strong argument in law, Nihil quod est contra rationem est
licitu; for reason is the life of the law, nay the common law itselfe is nothing
else but reason; which is to be understood of an artificiall perfection of reason,
gotten by long study, observation, and experience, and not every man’s
naturall reason; for, Nemo nascitur artifex. And therefore if all the reason that
is dispersed into so many severall heads, were united into one, yet could he
not make such a law as the law in England is; because by many successions of
ages it hath beene fined and refined by an infinite number of grave and
learned men, and by long experience growne to such perfection, for the
government of this realme, as the old rule may be justly verified of it,
Neminem oportet esse sapientorem legibus: no man out of his own private
reason ought to be wiser than the law, which is the perfection of reason 175.
Coke si trova a sostenere la supremazia della common law in nome della sua razionalità,
ma la sua concezione della legge richiede ora di incorporare pienamente la purezza e
l’immutabilità a cui aveva rinunciato la ragionevolezza di Saint German. La ragione
naturale, tenacemente ridotta alla ragione individuale, viene contrapposta ad una ragione
artificiale inedita che, da sola e pienamente, costituisce il criterio conoscitivo in grado di
dire e interpretare la legge, e la cui essenza consiste in un patrimonio sapienziale creatosi
nel tempo all’interno delle corti e custodito e perfezionato nell’erudizione dei giuristi di
professione.
Coke identifica il concetto di common law con la cornice razionale così definita, o
meglio, col ragionamento giuridico stesso.
175
E. Coke, The First Part of the Institutes of the Laws of England, or, a Commentary upon Littleton,
London 179415, 97b.
129
Si deve certo pensare a quel procedimento non riconducibile interamente alla razionalità
naturale accennato in Saint German, ma la radicalizzazione del motivo fa sì che ora ad
esso venga attribuita una perfezione ed una completezza tali da affermare la supremazia
del diritto comune inglese contro quella di ogni altra istanza, e con ciò, in realtà, la
titolarità giuridica di un sovraordinato potere dei common lawyers.
Il sapere pratico di questi uomini saggi ha “finito e rifinito” la legge, instituendo e
perfezionando un’arte che ingloba ogni aspetto del mondo del diritto nella misura in cui
domina le regole di applicazione concreta dei principi: è evidente che la ragione
artificiale di cui parla Coke trova dimora solo nel luogo e nel tempo della nazione
inglese, perché ciò che in essa vien fissato è il modo specifico in cui il diritto prende vita
in quel determinato contesto176.
Si badi però al fatto che egli pensa ad un’arte in senso alto, che solo lontanamente ha a
che fare con gli artigianali lavorii e che si distingue dalle pratiche locali: il diritto
comune inglese è per lui qualcosa di più e di diverso delle consuetudini regionali nate
nel seno e legittimate dall’uso continuativo delle comunità; esso rimanda invece a
costumi generali definiti e sviluppati esclusivamente nelle corti da esperti professionisti
profondamente conoscitori delle procedure e dei principi.
Con questo tenace sforzo di affermare la supremazia della common law grazie anche al
potente strumento della ragione artificiale
– monopolio di sapienza dei giuristi,
contrapposta e collocata sopra la ragione privata – Coke vuol compiere al medesimo
tempo un’operazione di inclusione e di nuova gerarchizzazione, disponendo gli elementi
in una scala arte-fatta che ha come vertice le prerogative delle corti di diritto comune:
176
H. J. Berman, Diritto e Rivoluzione II, cit., p. 438.
130
queste avrebbero dovuto costituire un potere superiore la cui esistenza si dimostrava
necessaria per ripristinare l’armonia, un’ultima istanza alla quale sarebbe spettata
esclusivamente l’interpretazione dei precedenti, degli statuti, oltre la quale non sarebbe
potuta andare neanche l’equity.
Incarnando assolutamente e perfettamente la ragione, la common law così concepita
escludeva l’esistenza di ogni beyond, e pur riconoscendo l’esistenza di una
discrezionalità pur sempre ineliminabile, avocava a sé la definizione e la salvaguardia
dei limiti entro i quali doveva esercitarsi, ovvero, detto con espressione paradossale,
reclamava l’essere una prerogativa della prerogativa.
Sappiamo che sul piano politico la linea non ebbe successo; sul piano giuridico invece
essa ebbe invece in certo senso lunga vita177.
Ma dal punto di vista filosofico tale idea di ragione racchiudeva il sapere fondante
l’ordine in un mistero talmente ermetico da non poter non rappresentare una sfida aperta
per un pensatore come Hobbes.
Legge naturale e legge positiva in Hooker
Far seguire all’analisi su Coke quella su Richard Hooker non ha certamente una
giustificazione cronologica: Hooker nasce un paio di anni dopo Coke, ma la sua
prematura morte nel 1600 anticipa di trenta anni quella di Sir Edward.
La motivazione di questa scelta è piuttosto di ordine teorico: nella riflessione di Hooker
ci sembra di scorgere una posizione che, pur se collocata prima nel tempo e legata
177
Vd. supra, I.2.
131
inseparabilmente alla vicenda dell’anglicanesimo, supera per finezza, rigore e
originalità, la riflessione del più importante giurista inglese.
Non soltanto: la ripresa di alcuni suoi motivi da parte di Selden e Hale costituirà un
fondamentale contrappunto alle considerazioni sul diritto di Hobbes.
Il “giudizioso” Hooker, così chiamato perché considerato rappresentante eccellente della
moderazione e del buon senso propri dello spirito inglese, fu l’autore di una magnifica
opera apologetica che segnò uno dei principali “punti di partenza per il cammino
intrapreso dall’Inghilterra nel discostarsi dalla corrente principale del protestantesimo
europeo”178: The Laws of Ecclesistical Polity179.
In essa cercò di affrontare e risolvere i problemi sollevati dall’affermazione puritana,
secondo la quale le Scritture avevano definito in maniera univoca e definitiva la forma
del governo ecclesiastico; l’obbiettivo di Hooker era quindi dimostrare “in quale modo si
esplichi la libertà umana nella vita morale, sociale e politica, quali siano i limiti di tale
libertà, e con quali mezzi l’umanità possa giungere allo stabilimento di ottime leggi per
il quieto e bene vivere in terra, che, seppur non direttamente ordinate da Dio, possono
dirsi di possedere indiretta approvazione e sanzione divina”180.
Vi è in Hooker come in Coke l’affermazione della supremazia del diritto, ma le
differenze intorno alla definizione di quest’ultimo sono più che sostanziali.
D. MacCulloch, Reformation. Europe’s House Divided, 1490-1700, London 2003 (tr. it., Riforma. La
divisione della casa comune europea 1490-1700, Roma 2010, pp. 643 ss.)
179
L’opera è composta da otto volumi, i primi cinque dei quali vennero pubblicati con Hooker ancora in
vita; gli ultimi tre dopo complesse vicissitudini e evidenti modifiche, videro la luce, il sesto e l’ottavo nel
1648, il settimo nel 1662. Vd. R. Hooker, Of the Laws of Ecclesistical Polity, in The Folger Library
Edition of the Works of Richard Hooker, vols. 1-3. Cambridge 1977.
180
A. Passerin d’Entrèves, “La teoria…”, cit.
178
132
Troviamo infatti, all’avvio della trattazione del teologo anglicano, una concezione
generale della legge che dipende direttamente da San Tommaso e che delinea un’idea
vasta ed altissima del diritto: essa rimanda all’esistenza di una struttura razionale del
mondo, ad una legge di armonia naturale che proviene da Dio181 e che innerva non
soltanto rapporti gerarchici, ma ogni misura determinante l’azione umana.
Vi sono di quelli che applicano il nome della legge alle sole regole di condotta
imposte da un’autorità superiore. Mentre noi estendendo in un qualche modo
la portata del termine, chiamiamo legge qualsiasi regola o misura che riguardi
le azioni, e con cui queste vengano regolate 182.
Hooker ritrova quindi un principio di diritto naturale universalmente vincolante che non
si colloca in un piano separato, ma è rinvenibile in linea teorica nella e dalla ragione di
ogni uomo: su questa via egli pare rivendicare il ruolo e la dignità della razionalità e
della libertà umana, delle quali egli sembra difendere la capacità di dedurre leggi morali
e politiche a partire da principi ad esse manifesti.
Non solo quindi quella della rivelazione diretta, ma molteplici sono le vie lasciate agli
uomini da Dio per stabilire le leggi che dirigono il loro agire183.
Due dati, uno antropologico e uno gnoseologico, intervengono subito a complicare il
quadro: pur ammettendo una naturale inclinazione nell’uomo alla vita sociale, la sua
volontà, sostiene Hooker, è “inwardly obstinate, rebellious, and averse from all
R. Hooker, Ecclesiastical Polity, I, XVI, 8: “Della legge non si può dire niente di meno che essa
procede dal cuore di Dio, la sua voce è l’armonia del mondo: tutte le cose in cielo e in terra le rendono
omaggio, le più piccole sentendone la mancanza e la maggiori non esentate dal suo potere: e tutti gli
Angeli, gli uomini e le creature di qualsiasi condizione, ciascuna in diversa maniera ma tutte unite in
uniforme consenso, ammirano in essa la madre della loro pace e gioia”. Citato da G. A. Ritter, art. cit., p.
92.
182
Ibid., I, III, 1, citato in A. Passerin d’Entrèves, La dottrina, cit., p. 88.
183
Ibid., II, I, 2: “mentre Dio ha lasciato agli uomini vari tipi di leggi, e da tutte quelle leggi sono le azione
degli uomini in qualche modo dirette”, citato da G. Giarrizzo, “Il pensiero politico inglese nell’età dei
Tudor”, cit., p. 794.
181
133
obedience unto the sacred laws of his nature”184; inoltre, ciò che esige la legge di natura
non è facilmente discernibile e richiede giudizio e una approfondita riflessione. La
capacità della ragione sarà quindi in grado di indicare un modo per uscire da una
situazione di disobbedienza e ignoranza del bene, e tale via è l’associazione politica.
Il passo in cui il teologo descrive la genesi di quest’ultima è fondamentale per
comprendere il modo in cui in questa teoria il principio di ragione naturale così
altamente inteso richieda, nel suo storico e concreto darsi, un fondamento positivo che
ad esso si affianchi, dichiarando esplicitamente l’insufficienza della visione aristotelica e
tracciando, ci sembra chiaramente, i solchi che, pur nella loro diversità, seguiranno
Hobbes e anche Locke.
Per togliere di mezzo queste reciproche offese e torti, non c’era altra via fuor
del comporsi e accordarsi tra loro, organizzando una specie di governo
pubblico e assoggettandosi ad esso: perché coloro ai quali conferirono autorità
di governo procurassero al resto pace, tranquillità e stato felice. Gli uomini
han sempre saputo che in caso di offesa possono difendersi da sé; han saputo
altresì che il diritto di cercar il proprio vantaggio non può esercitarsi con
danno altrui, anzi a tentativi simili tutti gli uomini debbono resistere con tutti i
mezzi; infine essi han saputo che in ragione nessun uomo può pretendere di
determinare il proprio diritto, e procedere a difenderlo nel modo in cui l’ha
determinato, giacché ogni uomo è parziale verso sé medesimo e quelli che
ama: e perciò dispute e conflitti sarebbero infiniti a meno di consentire a
quanto ordinano delle persone a cui si è convenuto dare tale autorità. Senza un
tale consenso non v’ha ragione per un uomo di pretendere di essere signore o
giudice di un altro: poiché, sebbene vi sia secondo Aristotele una specie di
184
Ibid., I, X, 1.
134
diritto naturale nel nobile saggio e virtuoso a governare su quanti hanno
disposizione servile, nondimeno per la manifestazione stessa di questo loro
diritto e una più pacifica soddisfazione di entrambi par necessario l’assenso di
quanti debbono essere governati185.
Indicata nel diritto naturale la base di ogni diritto umano, Hooker guarda ora al
fondamento razionale dell’obbligazione giuridica e politica: tale fondamento è ai suoi
occhi il consenso.
Questo preciso elemento umano è la cifra del suo contrattualismo, il quale corrisponde
non già alla storicità, ma piuttosto ad un’esigenza di razionalità ed evidenza che sola
giustifica e legittima la sottomissione dei consociati (e si noti per inciso che, di questi
consociati, sembra quantomeno insinuarsi l’uguaglianza).
È chiaro però che in esso vi è la traccia profonda dell’esperienza giuridica e
costituzionale inglese nella quale, come abbiamo avuto modo di sottolineare più volte, il
fattore della consensualità permane con tenacia.
Sul fondamento dell’obbedienza Hooker sembra riecheggiare in primo luogo un tema
già presente nell’idea di consuetudine in Saint German: qualora sia possibile stabilire
con prove certe e necessarie che la legge positiva è ingiusta, allora il singolo avrà la
libertà di respingerla in coscienza; ma nella circostanza invece in cui la determinazione
della sua giustezza costituisca una questione di mera probabilità, allora la coscienza
privata dovrà tacere, presumere tale legge giusta e acconsentire al dettato della comunità
che da tempo e fino ad allora l’ha preservata.
185
Ibid., I, X, 4. Citato da G. Giarrizzo, “Il pensiero politico inglese nell’età dei Tudor”, cit., pp. 793-794.
135
Se considerata in funzione antipresbiteriana, la questione assumeva i toni di una critica
al diritto di resistenza e di un’argomentazione che potremmo dire assolutistica: la disputa
circa la miglior forma di governo e la critica alle leggi esistenti sono per Hooker
legittime solo se provengono dall’autore di quella e di queste, quindi, solo se mossa dalla
comunità in toto e non soltanto da una sua parte; finché non si dia questa condizione, il
fine della pace richiede che il governo stabilito sia il detentore del potere di sentenziare
in via definitiva e di costringere successivamente al silenzio le parti in conflitto.
L’idea di sovranità che vien qui abbozzata è per Hooker utilizzabile solo a certe
condizioni, che sono in verità proprio quelle determinate dal consenso, inteso dal teologo
anglicano nel seguente doppio verso: da una parte come manifestazione esplicita di
approvazione personale dell’intera comunità, per mezzo della rappresentanza in
parlamento; dall’altra come tacita espressione di assenso attraverso la consuetudine.
Grazie a questa doppia tenaglia Hooker colloca nella comunità il fondamento della
legislazione positiva, nonché la sede della determinazione dei modi e della forma di
governo; inoltre, configurato in questo modo il diritto degli uomini, la varietà delle leggi
viene correlata alla molteplicità dei fini, per cui la loro mutabilità è riconosciuta e
auspicata purché sia orientata verso il meglio: il moderato Hooker fa sposare così
l’elemento convenzionale con la teleologia aristotelica.
L’eredità dell’antiquaria giuridica: Selden
Desta qualche perplessità vedere come lo sviluppo delle implicazioni filosofiche del
quadro delineato da Coke ad opera di Selden passi attraverso la negazione di alcuni suoi
136
presupposti base e proceda con decisione verso il recupero di elementi strutturali della
common law che in esso erano stati oscurati; in tale operazione l’eco di temi che
abbiamo visto essere cruciali della riflessione di Hooker, gioca ora un ruolo di
primissimo piano.
La fama di John Selden come giurista, antiquario, orientalista e biblista, nonché come
personaggio politico di primissimo piano, è iscritta negli annali della Società degli
Antiquari, nei dibattiti parlamentari degli anni venti del Seicento, e in ogni libro di storia
inglese.
Sono rimaste celebri le parole di Milton, che lo incoronò “the chief of learned men
reputed in this land”186.
Un veloce sguardo ad alcuni dei titoli delle numerose e importanti opere che egli scrisse
basterà forse a far intuire non solo la vastità della sua cultura, ma anche l’impegno con
cui egli intraprese l’indagine storica che caratterizzò la sua avventura intellettuale: vi
troviamo l’edizione annotata di Fortescue, la History of Thites – che gli valse una
convocazione presso il Consiglio Privato, e la successiva ritrattazione e distruzione del
volume – l’Analencton Anglo-Britannicon, la risposta a Grozio contro la libertà dei mari
intitolata Mare Clausum, la Dissertatio ad Fletam che contiene l’importante commento
al passo di Bracton sulla Lex Regia187, il De jure naturali et gentium iuxta Disciplinam
Ebraeorum188.
186
J. Milton, Aeropagitica, in S. Orgel, J. Goldberg (a cura di), John Milton. The Major Works, Oxford
2003, p. 246.
187
Cfr. Ch. H. McIlwain, op. cit., pp. 90-93 e p. 111, nota 9.
188
Cfr. J. Selden, Opera Omnia, London 1726.
137
Ognuna di queste opere ci dice del recupero approfondito di una storia che in Coke era
certo rimasta presente, ma sullo sfondo e in maniera vaga, e che diviene qui invece
terreno, ossia fonte e fondamento della legge stessa.
L’urgenza di fissare un fondamento stabile e immutabile, che portò Sir Edward a
identificare in fin dei conti la legge col ragionamento legale, è chiaramente venuta meno
nella riflessione di Selden, il quale, al contrario, concepisce la legge come un insieme di
norme positive rintracciabili nel tempo, cangianti ed in continua evoluzione, rinvenibile
in due sole manifestazioni: la consuetudine e gli atti del parlamento.
Ricondotto pienamente il diritto alla sua storicità, in Selden l’essenza della legge sembra
perdere l’ancoraggio ad una ragione astrattamente intesa: per lui solo l’indagine della
vita concreta delle istituzioni positive può fornire la materia da cui dedurre una teoria del
diritto che non sarà più esclusivamente inglese, come lo era invece nei principali autori
del mondo di common law, ma che varrà per qualunque sistema di diritto dato.
Discostandosi ancora da chi, come Saint German e Coke, voleva la bontà e la superiorità
della common law basata sull’antichità e sul suo peculiare esser fondata sulla legge di
natura, per Selden il valore di qualunque sistema di diritto è correlato ad una nozione di
tempo qualitativamente inteso: non la pura durata quindi, ma la capacità che esso ha di
adattarsi alle situazioni e migliorarsi nel tempo189.
Tutti gli assetti giuridici sono ai suoi occhi parimenti antichi e a fondamento di ognuno
vi è in ugual modo la legge di natura; ma questa, sarà bene sottolinearlo, non è pensata
189
Cfr. H. J. Berman, Diritto e Rivoluzione II, cit., p. 444.
138
come un insieme completo di principi immutabili e fuori dal tempo, ma sì come un
corpo aperto, limitabile, indissolubilmente legato al suo darsi concreto.
Selden non scioglie dunque la legge positiva da quella di natura, egli in realtà le intreccia
in una maniera talmente costitutiva da far sì che la seconda, intesa in maniera autonoma
e astratta, venga relegata in una zona di inintelligibilità: la conoscenza delle leggi deve
rivolgersi allora alle forme storiche in cui governano con autorità, ovvero ai determinati
contesti in cui esse sono valide.
Nel determinare che cosa fa sì che una legge sia tale, ovvero, mirando al fondamento
dell’obbligatorietà, Selden reintroduce un elemento gerarchico che avevamo visto in
qualche modo dissolversi nella concezione della legge naturale di Hooker.
Non posso davvero immaginarmi cosa significhi diritto naturale, se non la
legge di Dio. Come posso sapere che non devo rubare, che non devo
commettere adulterio, senza che qualcuno me l’abbia detto? Certamente è
perche mi è stato detto così, e non perché io pensi che non dovrei fare tali
cose, né perché voi pensiate che io non debba; se fosse così le nostre menti
potrebbero cambiare. Donde allora proviene il vincolo? Da un potere più alto,
null’altro può legare190.
Analogamente l’obbligatorietà delle leggi positive – le quali alterano, adattandole ai
fatti, le leggi naturali –
passa
necessariamente attraverso l’introduzione di una
asimmetria: in Selden, come in Hooker, il governo delle leggi si fonda sull’elemento del
consenso, che in questi come in quello, si affianca al criterio della conformità al
190
J. Selden, Table Talk, London 1927, pp. 69-70 (tr. it. in N. Matteucci, op.cit., p.71)
139
comando divino e si manifesta in maniera esplicita o tacita, recuperando ancora il valore
legittimante dell’attività legislativa del parlamento e, soprattutto, della consuetudine:
Laws or civil sanctions depend on the express and natural consent of those
who were present and active themselves in making laws or admitting customs
in use; or on the tacit and civil consent of those who surrendered their
decision and power before others, according to the diverse origins and
constitutions of republics, or from the submission of themselves and their
descendants, or by other means, so that they agreed to bind themselves and
their descendants to whatever was decreed, without giving their express and
natural consent to each individual matter 191.
Ancora una volta la storicità di questo consenso sarà per Selden prova e fonte della
validità della legge intera. Nella disputa aperta da Hobbes sul valore normativo del
passato così inteso, prenderà la parola l’allievo Hale.
191
J. Selden, Opera Omnia, cit., p. 607.
140
PARTE SECONDA
Il diritto e la metodologia logico-formale
nella filosofia di Hobbes
141
I
In controluce
La questione del diritto in Hobbes attraverso la critica di Hale
Il Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of England192 di
Hobbes, opera tarda, incompiuta e perciò nella volontà dell’autore non destinata alla
pubblicazione193, contiene la prima critica ragionata e integrale alla common law.
Ad essa ha risposto in un importante documento rimasto inedito fino al 1921194 Sir
Matthew Hale, allievo e amico di Selden, nonché – nelle parole di Holdsworth – “il più
grande scienziato del diritto che l’Inghilterra abbia mai visto”195.
La discussione tra i due risulterebbe in partenza arida e senza sbocchi, considerato il
carattere diametralmente opposto delle premesse fondamentali degli autori: per la nostra
analisi risulta essere invece un ottimo campo di osservazione, poiché in essa si
confrontano le posizioni di chi da una parte aveva colto falle profonde sia nell’“appello
alla ragione” – artificiale – di Coke, sia nell’elemento consensuale implicito nell’
192
HW, Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of England, Oxford 2005.
“The Treatise De Legibus at the end of it is imperfect. I desire Mr. Horne to pardon me that I consent
not to his Motion. Nor shall Mr. Crooke himself get my consent to print it.”: Hobbes ad Aubrey, Agosto
1679, in HW, The Correspondence: 1660-1679, vol. 2, Oxford 1998, p. 772.
194
F. Pollock, Sir Matthew Hale on Hobbes: An Unpublished Ms, in “Law Quarterly Review”, 37, 1921,
pp. 274-303. Sull’impressione che fece l’opera hobbesiana su Hale, si legga quanto dice Aubrey ad un
corrispondente privato: “Judge Hales (who is no greater courtier) haz read it & much mislikes it, and is his
Enemy”. Citato da A. Cromartie, General Intoduction, in HW, Dialogue, cit., p. xvii.
195
W. S. Holdsworth, A History of English Law, London 1922-52, vol. VI, p. 581.
193
142
“appello al contratto” di Selden; ed anche di chi, dall’altra, aveva tentato proprio un
compromesso tra di loro 196.
La risposta di Hale si articola in due blocchi, e ricalca da subito l’andamento della
trattazione hobbesiana.
Il primo, In Caput Primum of Laws in Generall and the Law of Reason, è una presa di
posizione a favore del concetto di ragione artificiale di Coke, contro il quale Hobbes
aveva argomentato in apertura del Dialogue. Non era la prima volta che il filosofo
inglese puntava il dito contro il famoso giurista: già nel XXVI capitolo del Leviathan197,
Hobbes aveva dedicato al celebre passo degli Institutes,198 in cui tale definizione di
ragione artificiale viene fornita, un intero paragrafo nel quale egli si era sforzato di
evidenziare il punto fragile, se non addirittura pernicioso, della questione; la sua critica
va dunque considerata almeno in questi due luoghi.
Nel passo corrispondente del Dialogue la proposizione del problema avviene, concorde
alla vis polemica del testo, in maniera asciutta e diretta: dopo aver concordato con Coke
sulla concezione che identifica legge e ragione, e pure con la sua definizione di equità,
Hobbes fa chiosare al Filosofo:
When I consider this, and find it to be true, and so evident as not to be denyed
by any Man of right sense, I find my own reason at a stand; for it frustrates all
the Laws in the World: for upon this ground any Man, of any Law whatsoever
196
Cfr. A. Cromartie, Sir Matthew Hale 1609-1676. Law, religion and natural philosophy, Cambridge
1995.
197
Lev., p. 140.
198
Vd. supra, p. 129.
143
may say it is against Reason, and thereupon make a pretence for his
disobedience199.
La generica e diafana definizione del giurista porta ad un punto morto200 ogni spinta
conoscitiva perché semplicemente lascia aperta ogni possibilità.
Essa non offre alcun criterio per determinare la rettitudine della legge, o meglio, offre un
criterio talmente vasto e indefinito da non essere distintamente utilizzabile, il che per
Hobbes si traduce concretamente, anzitutto, nella possibilità della disobbedienza ad essa.
La risposta dello Studente riporta la citazione testuale di Coke, specificando quindi che
si tratta di una ragione artificiale perfetta, acquisita con lunga esperienza e dotto studio,
distribuita in tante teste diverse per un lungo succedersi di epoche, finita e rifinita da
sapienti uomini di legge.
Il Filosofo allora ammette insieme al suo interlocutore che la conoscenza del diritto sia
una scienza e un’arte, ma non può concedere il fatto che essa sia qualcosa di diverso
dalla ragione naturale e di coincidente piuttosto con una ragione artificiale resa retta dal
tempo o dalla quantità e la qualità dei suoi artefici.
L’excursus del Filosofo ha certamente una tonalità che potremmo dire anticorporativa201: Hobbes coglie quell’aspetto presente massimamente in Coke, ma
rinvenibile in verità in quasi tutti gli esponenti della common law, che rivendica i
privilegi esclusivi dei giuristi, intendendoli come casta.
199
HW, Dialogue, cit., p. 9.
Così traduce Norberto Bobbio l’inglese “at a stand”. Vd. T. Hobbes, Opere Politiche, Torino 19884, p.
400.
201
Cfr. HW, Dialogue, cit., p. 11: “Sir Edw. Coke for drawing to the Men of his own Profession as much
Authority as lawfully he might, is not to be reprehended…”.
200
144
La questione non è certo riducibile ad astio personale: sul piano dell’educazione
giuridica, l’evoluzione della professione forense in Inghilterra è una storia di monopolî,
e il carattere fortemente elitario del ceto dei giuristi, insieme all’aura sacerdotale che in
maniera così concreta ha connotato la pratica e l’elaborazione teorica del diritto
inglese202, sono fattori che non potevano non essere rilevanti nel momento in cui gli
“oracoli della common law” (l’espressione è di Coke) rivendicavano a sé un potere
supremo nello stato.
In questo senso, il tono del discorso hobbesiano assume una valenza particolare che non
va vista, a nostro avviso, come piatta partigianeria o facile attacco ad una prepotente
categoria di professionisti o, peggio ancora, allo statuto stesso della scienza giuridica.
Proprio in questa direzione sembra in parte muovere la stizzita
– e perciò
particolarmente eloquente – risposta di Hale; nonostante nel complesso essa sollevi una
serie di obiezioni importanti, proprio queste ultime ci soccorreranno successivamente nel
tentativo di chiarire come si configuri nell’insieme la questione del diritto all’interno
della filosofia hobbesiana.
L’aspirazione dei legisti ad essere detentori esclusivi della Summa Ratio non pone tanto,
o meglio non soltanto, il problema contestuale del loro voler essere supremi “senza il
Re”203; se una questione di fondo si pone è quella per cui la riduzione della legge a mera
sapienza ne rimuove il momento autoritativo, all’interno del quale dobbiamo sentir
202
Cfr. J. P. Dawson, The Oracles of the Law, Westport 1968. Vd. anche C. Costantini, La legge e il
tempio. Storia comparata della giustizia inglese, Roma 2007.
203
HW, Dialogue, cit., p. 10.
145
risuonare non soltanto il carattere sanzionatorio verticale, ma anche la possibilità di
accesso e partecipazione204.
Colta da questa prospettiva, la frase che più volte è rimbalzata tra sostenitori e detrattori
di Hobbes ha un’eco diversa: “It is not Wisdom, but Authority that makes a Law” 205. Si
tratta certo di una affermazione radicale, ma si deve leggere la famosa e perentoria
sentenza come risposta ad una posizione altrettanto radicale, che, enfatizzando
l’elemento sapienziale, aveva inglobato dolcemente (e, vorremmo dire, sottaciuto)
l’istanza ‘dura’ che costitutiva parimenti la legge, in modo da aprire scenari teorici nuovi
e vedere il quadro complessivo sotto luce differente.
Si tenga a mente il brano del capitolo 4 del Doctor and Student di Saint German:
And that the law of man be just and rightwise, two things be necessary, and
that is to say, wisdom and authority. Wisdom that he may judge after reason,
what is to be done for the commonalty, and what is expedient for a peaceable
conservation and necessary sustentation of them; authority, that he have
authority to make laws. For the law is derived of ligare, that is to say, to
bind206.
È la congiunzione equilibrata di sapienza e autorità ad essere evidentemente venuta
meno ai tempi di Coke e di Hobbes, ed il filosofo inglese scorge non solo la potenzialità
politica dello spostamento di peso, tutto a favore della prima, della fonte di legittimità;
Cfr. il seguito del passo citato supra, nota 10: “…but to the gravity and Learning of the Judges they
ought to have added in the making of Laws, the Authority of the King, which hath the Sovereignty: for of
these Laws of Reason, every Subject that in his Wits, is bound to take notice at his Peril, because Reason
is part of his Nature, which he continually carryes about with him and may read it, if he will”.
205
Ibid., p. 10. L’espressione “authoritas non veritas facit legem” compare nel Leviatano latino (OL, vol.
III, p. 202) ma non nella versione inglese. Cfr. Lev, p. 143. Cfr. anche OL, vol. II, De Cive, XII, 4.
206
Ch. Saint German, Doctor and Student, cit., ch. 4.
204
146
ma anche la sua debolezza, ovvero, il possibile allentamento della forza obbligante della
legge che ne deriva.
Il sostenere che è sempre e solo la ragione naturale a dare accesso alle arti e alle scienze,
oppure che “il termine ragione legale non è chiaro” perché “le creature terrestri sono
fornite solamente della ragione umana”, dovrà intendersi allora come l’intenzione di
squarciare il velo di un sapere chiuso ed escludente, chiaramente percepito come mero
strumento di potere, recuperando quello che in Hooker si configurava come la dignità
della ragione umana.
Nelle pagine di apertura del Dialogue s’intravede dunque una densa problematica della
filosofia hobbesiana, la quale potrebbe essere descritta come questione relativa ad un
‘principio di trasparenza’, che nella riflessione di Hobbes orienta non solo l’intera
costruzione dello spazio giuridico, sia come dichiarazione e interpretazione della legge,
sia come accessibilità ad essa; ma investe anche, e in maniera portante, la costruzione
stessa del sapere.
Per circoscrizione tematica, la prima questione è quella che ci interessa qui
maggiormente: ma si accenni da subito a quanto si analizzerà per esteso nel capitolo
seguente, ovvero a come, proprio a partire dalla considerazione del ruolo della certezza e
della trasparenza del diritto nella realizzazione di un assetto civile, sia possibile mettere
a fuoco una crepa nell’idea ‘forte’ di scienza e considerare la tensione razionalistica
della filosofia di Hobbes da una nuova, e per certi versi rovesciata, prospettiva207.
Quanto opporrà Hale a Hobbes all’inizio delle sue Reflections non a caso è imperniato
proprio su questo intricato groviglio di questioni.
207
Vd. infra, cap. II.2.
147
La difesa della ragione artificiale di Coke, che però Hale, da ottimo allievo, intende in
maniera più vasta e certo filosoficamente più pregnante, prende le mosse da un’idea di
ragione articolata in tre diversi sensi208: il primo comprende la Subjective reason (dove
l’aggettivo deve tradursi con ‘sostanziale’ e non con ‘soggettiva’, per i motivi che ora
vedremo), che consiste “in the Congruity, Connexion, and fitt Dependence of one thing
upon antoher” e che ben si potrebbe intendere come la ragione nelle cose, come la loro
logica interna209.
Hale insiste su un preciso carattere della ragione così intesa, ribadendolo in ognuno degli
esempi riportarti, da quello dell’ordine della Natura, a quello dell’essere ragionevole
delle Matematiche, a quello della certa, anche se oscura, ragionevolezza della Morale: la
Ragione Sostanziale precede e preesiste ad ogni facoltà ed istituzione umana.
Nella trattazione segue poi “a Facultie cōmon to all reasonable Creatures”, attraverso la
quale l’uomo attinge la conoscenza delle cose e delle azioni, e che, pur essendo uguale
per tutta l’umanità, si orienta e si modella nel suo concreto esplicarsi, in parte a causa del
temperamento, in parte mediante la disciplina, seguendo svariate vie e diversi modi
d’attuazione.
Troviamo infine in terzo luogo, la definizione che più interessa l’argomentazione di
Hale: si tratta dell’incontro tra la facoltà razionale e l’oggetto ragionevole, ovvero
dell’esercizio della ragione applicato ad un oggetto particolare, il quale viene orientato
in direzioni particolari seguendo metodi particolari (l’iterazione è dello stesso Hale).
208
209
F. Pollock, Sir Matthew Hale on Hobbes, art. cit., pp. 286-288.
Cfr. H. J. Berman, Diritto e Rivoluzione II, cit., p. 464.
148
È in virtù della ragione così intesa che si distinguono gli uomini e si dicono essere
Matematici, Fisici, Giuristi e in generale, Artificers: il termine, che si potrebbe rendere
meglio con ‘professionisti’ o ‘esperti’, che non con ‘artefici’ o ‘artigiani’, è da legare al
artificiall che qualifica la ragione di Coke.
Con questa triplice articolazione del concetto di ragione Hale pone dunque la premessa
per indicare la specialità del sapere tecnico degli uomini di legge, la quale verrà poi
immediatamente rafforzata sottolineando la peculiarità dell’oggetto del loro studio; a
questo punto l’attacco a Hobbes sarà frontale.
[…] there is none of so great a difficulty for the Faculty of reason to guide it
Selfe and come to any Steddiness as that of Laws, for the regulation and
Ordering of Civill Societies and for the measuring of right and wrong, when it
comes to particulars. And therefore it is not possible for men to come to the
Same Certainty, evidence and Demonstration touching them as may be
expected in Mathematicall Sciences, and they that pleased themselves wth a
perswasion that they can wth as much evidence and Congruitie make out an
unerring Systeme of Laws and Politiques equally applicable to all States and
Ocassions, as Euclide demonstrates his Conclusions, decive themselves wth
Notions wch ineffectuall, when they come to particular application210.
Hale sta evidentemente puntando a un bersaglio ben più grande che non il Dialogue e
con ciò egli, volente o nolente, manca a nostro parere il punto tra le righe di quelle poche
pagine, quello che abbiamo detto essere la questione dell’accessibilità alla conoscenza
210
F. Pollock, Sir Matthew Hale on Hobbes, art. cit., p.288.
149
della legge civile in generale211, cogliendo invece quello nodale che riguarda lo statuto
scientifico della filosofia civile hobbesiana, sul quale dovremmo successivamente
soffermarci.
Ci basti per ora indicare un punto paradigmatico dal quale risulta palese come le strade
dei due contendenti non abbiano punto di incontro: spiegando il secondo senso di
Ragione, quello della Facoltà delle nature razionali, Hale afferma che nella circostanza
in cui la facoltà è distante dall’oggetto, allora la ragione procede gradualmente e
discorsivamente, mediante deduzioni, illazioni o inferenze, da cosa a cosa; quando
l’oggetto si trova in prossimità alla facoltà, invece, essa procede quasi per saltum, e
l’esempio che egli ivi riporta è, significativamente, quello della vista (“as the bodily Eye
sees”212).
L’intera filosofia hobbesiana è segnata invece dal rigoroso ed ostinato – e in fin dei
conti drammatico – tentativo di fare i conti con il vuoto che presuppone il salto di cui
parla pacificamente Hale, un vuoto che inerisce la conoscenza, giammai la natura213, e
non è forse casuale che gli ambiti in cui tale tensione si manifesti massimamente siano
per l’appunto l’ottica e la filosofia civile.
Quando egli afferma la mancanza di una retta ragione costituita dalla natura, la sua
riflessione non ha precisamente perso o rinunciato alla ragione nelle cose alle quali
rimanda la prima definizione di Hale, ma piuttosto in essa è venuta meno la sicurezza del
Cfr. Lev., 137: “For the knowledge of particular laws belongeth to them, that profess the study of the
laws of their several countries; but the knowledge of the civil law in general, to any man”.
212
Ibid., p. 286.
213
Cfr. OL, vol. 2, De Homine, XI, 11: “La natura non tollera né lo spazio né il tempo vuoto”
211
150
salto, la fiducia nel graduale passaggio, venendosi ad imporre quindi la necessità di
rifondare, su nuove basi e il più saldamente possibile, la certezza.
In ciò, il ruolo svolto a livello sistemico dalla ‘forma’ del diritto avrebbe forse fatto
vedere sotto diversa luce alcuni degli aspetti qui criticati dal giudice Hale:
not but that reason itself is always right reason, as well as arithmetic is a
certain and infallibile art: but no one man’s reason , nor the reason of any one
number of men, makes the certainty; no more than an account is therefore
well cast up, because a great many men have unanimously approved it. And
therefore, as when there is a controversy in an account, the parties must by
their own accord, set up for right reason, the reason of some arbitrator, or
judge, to whose sentence they will both stand, or their controversy must either
come to blows, or be undecided, for want of a right reason constituted by
nature214 (corsivo nostro).
Da questa angolatura è manifesto come il criterio della saldezza non può consistere per
Hobbes nella ragione di un uomo o dall’approvazione di tanti; la certezza a cui qui si
aspira richiede qualcosa in più, perché, prima ancora di essere la fermezza incrollabile
della scienza, è l’assicurazione della risoluzione pacifica del conflitto; e risulta
quantomeno paradossale constatare che proprio alla radice di una speculazione che,
stando a Hale, costruisce nozioni astratte e universali che si rivelano poi errate e
manchevoli quando applicate a circostanze particolari215, vi sia appunto la
preoccupazione primaria della ricaduta nel reale di tale concezioni.
214
215
Lev., pp. 18-19.
F. Pollock, art. cit., p. 289.
151
Hobbes ha negli occhi la crisi dell’assetto giuspolitico inglese, e abbiamo già visto non
solo in quale misura tale crisi fosse una tappa decisiva nel percorso storico di un sistema
di composizione degli interessi dimostratosi non più efficace davanti a mutate
circostanze economiche e sociali, ma anche quanto chiaramente fosse percepita la
necessità, per comprendere e superare tale impasse, di definire le nozioni e le sfere che
orientavano e articolavano l’azione di governo.
Da qui noi non intendiamo certo dedurre la storicità contro l’astoricità sovente invocata
dell’interrogativo e delle risposte che la filosofia hobbesiana pone e offre: indichiamo
qualcosa di meno e per certi versi qualcosa di più, vale a dire, che la sfida che essa
accetta è quella di segnare una via politica che faccia pienamente i conti con il problema
del potere e che risolva il concreto dilemma emerso nell’Inghilterra del Seicento circa il
luogo della sovranità.
Tale intento, in un contesto nel quale proprio il pensiero giuridico aveva giocato un
ruolo fondamentale nel lasciare indecisa la questione contribuendo a dare una sostegno
teorico ad un assetto nel quale erano stati mantenuti armonicamente assoluto e limitato,
eccezionale e ordinario, non poteva non fare i conti con la categoria del diritto.
Ed è infine da notare come alla critica ferrea ad alcuni dei presupposti basilari della
common law inglese, Hobbes congiunga l’assegnazione di un meta-luogo al concetto
stesso di diritto – come possiamo intravedere nella seconda parte della citazione su
riportata – conferendogli alcuni caratteri rinvenibili, almeno in parte, nelle formulazioni
di giuristi come Selden e lo stesso Hale, ma collocando in un punto filosoficamente
fondante soprattutto la nozione di necessità di un limite, di un’istanza ultima che, una
152
volta convenuta, non consenta ulteriore appello, così chiaramente espressa dal giudizioso
Hooker.
Così piena di egoismo e di ostinazione è la nostra natura, che senza una
sentenza definitiva che una volta data possa reggere, e l’imposizione del
silenzio alle parti in conflitto, v’ha poca speranza che simili conflitti possano
chiudersi pacificamente in breve tempo.
E ancora:
Non v’è alcuno sbocco possibile di pace e tranquillità, a meno che la voce
probabile di ogni intera società o corpo politico non prevalga sulle pretese
particolari che si affermano nello stesso corpo 216.
Hobbes avrebbe sottoscritto in gran parte queste affermazioni, non ultima anche quella
del carattere probabile della voce comune, seppur dando forse loro un’intonazione
diversa.
Del teologo inglese è stato detto che “scrisse come un postrivoluzionario, cioè come uno
che guardava indietro alla trasformazione incombente e cercava di riconciliarla con quel
che c’era prima”217; ebbene, Hobbes scrive effettivamente a trasformazione avvenuta, ed
egli la percepisce in una maniera eminentemente strutturale, tale da non poterla
considerare suscettibile di riconciliazione, ma solo di rifondazione.
216
217
Citato da G. Giarrizzo, “Il pensiero politico nell’epoca dei Tudor”, cit., 794.
Cfr. H. J. Berman, Diritto e Rivoluzione II, cit., p. 420.
153
Egli riconosce la mortalità del corpo artificiale dello stato, la sua fallibilità, ma ciò che
ad egli maggiormente preme è costruire su basi nuove.
The use and the end of reason is not the finding of the sum, and truth of one,
or a few consequences, remote from the first definitions, and settled
signification of names; but to begin at these; and proceed from one
consequence to another.218
Rivolta al futuro, la ragione di Hobbes non può trovare saldo fondamento di giustizia e
giustezza in un passato come quello concepito dai common lawyers di cui si presume
acriticamente la bontà, tanto meno se esso viene ad incarnarsi misteriosamente e
pienamente nel sapere tecnico di esperti.
Si potrebbe obbiettare, prima di chiudere questa digressione, che non vi sia niente di più
misterioso e insindacabile del sapere-volontà del sovrano hobbesiano.
Proviamo a rispondere a questa affermazione forse superficiale con un’annotazione che
non ci pare altrettanto banale: mai Hobbes, che pure fa uso frequente dell’aggettivo
artificial qualificando numerosi e sostanziali aspetti dello stato civile, mai lo attribuisce
alla ragione.
In verità quasi mai, ovvero solo in un’unica circostanza. L’eccezione che conferma la
regola è eloquente: nella prima pagina del Leviathan, dove si dipana l’analogia tra
l’uomo naturale e l’uomo dello stato, la quale costituisce una sorta di radiografia del
grande uomo nel celebre frontespizio, egli afferma: “equity and laws [are], an artificial
reason and will”.
218
Lev., p.19.
154
È l’equità a doversi immaginare come una ragione artificiale, anziché le leggi, le quali
sono per Hobbes sempre un atto di volontà: comunque l’aggettivo ha una coloritura
diversa rispetto al termine in Coke. Lo spunto è ricco di significato, ma per ora basti
notare come, ad ogni modo, equity e law si presentino insieme, indicando forse un
binomio radicale e inscindibile.
Ritorniamo ora però al punto di partenza: è erroneo pensare che Hobbes intendesse il
sapere denotato col termine artificial reason come pura e arbitraria espressione della
volontà dei giudici: comprendeva certo che “Coke citava i precedenti giudiziali per
provare l’esistenza di un antico diritto consuetudinario sapienziale, nascente dal
ragionamento di molte generazioni di giuristi dotti”219, come risulta chiaro dal passo del
Leviathan che riporteremo per esteso a continuazione; ma proprio ciò non solo ratificava
la critica alla chiusura e all’oscurità di tale patrimonio sapienziale, ma la arricchiva di
ulteriori e ancor più cruciali elementi.
That law can never be against reason, our lawyers are agreed; and that not the
letter, (that is every construction of it,) but that which is according to the
intention of the legislator, is the law. And it is true: but the doubt is, of whose
reason it is, that shall be received for law. It is not meant of any private
reason; for the there would be as much contradiction in laws, as there is in the
Schools; nor yet (as Sir Edward Coke makes it) an artificial perfection of
reason, gotten by long study, observation, and experience, (as his was.) For it
is possible long study may increase, and confirm erroneous sentences: and
where men build on false grounds, the more they build, the grater is the ruin:
and of those that study, and observe with equal time, and diligence; the reason
219
H. J. Berman, Diritto e Rivoluzione II, cit., p. 468.
155
and resolutions are, and must remain, discordant: and therefore it is not that
juris prudentia, or wisdom of subordinate judges; but the reason of this our
artificial man the commonwealth, and his command, that maketh the law: and
the commonwealth being in their representative but one person, there cannot
easily arise any contradiction in the laws; and where they doth, the same
reason is able, by interpretation or alteration, to take it away. In all courts of
justice, the sovereign (which is the person of the commonwealth,) is he that
judgeth: the subordinate judge, ought to have regard to the reason, which
moved his sovereign to make such law, that his sentence may be according
thereunto; which then is his sovereigns sentence; otherwise it is his own, and
an unjust one220.
L’identificazione tra legge e ragione anche qui sembra pacifica.
Ma il fatto che Hobbes sollevi immediatamente la domanda riguardo chi sia il titolare di
quella ragione ci rimanda subito alla questione della localizzazione del potere legislativo
e in qualche modo ci pone preliminarmente al di qua della Ragione Sostanziale di Hale.
Che la ragione della legge richiedesse la determinazione di un soggetto per poter essere
tradotta concretamente e resa effettiva era un punto che non era sfuggito neppure al
contraddittore di Hobbes, ma la soluzione che quest’ultimo formula è, come vedremo
successivamente, del tutto antitetica, nonché interamente rinvenibile in quel procedere
graduale e armonico della facoltà razionale una volta essa abbia compiuto il ‘salto
conoscitivo’ di cui si è sopra detto.
E’ saliente il fatto che Hobbes, negando la coincidenza tra la ragione della legge e quella
“privata”, faccia riferimento alle Scuole e non agli individui: il rilievo sembra mettere
220
Lev., pp. 139-140.
156
fuori gioco l’obbiezione di Hale che, difendendo Coke e in base all’articolata definizione
di ragione, aveva ribadito il carattere tecnico-corporativo del sapere dei giuristi,
distinguendolo e opponendolo al sapere comune a tutti gli individui.
Ebbene, Hobbes non considera neanche la possibilità che la legge sia espressione di una
razionalità individuale, ma anzi il suo bersaglio è proprio l’idea che la legge sia
espressione della ragione di un gruppo, di una Scuola, per l’appunto.
Si tratta di un elemento che bisogna tenere a mente se si vuol comprendere il senso in
cui Hobbes enfatizza la distinzione pubblico-privato, perché da qui risulta evidente come
“privato” sia in primo luogo “parte” che si differenzia e tende a voler prevalere sul
“tutto”.
Cosa si contesta in questa sede specificamente al concetto di ragione artificiale?
Hobbes impugna l’eventualità che una costruzione sia eretta su false fondamenta. Vi è
qui non solo un sincero riconoscimento della fallibilità221 della ragione, oscurato dalla
fiducia nei precedenti dei common lawyers, ma anche un indizio filosofico del massimo
interesse che tende a sostenere sia la non necessaria bontà delle origini222, sia la
possibilità di perseverare nell’errore e dunque, e ancora la non necessaria bontà della
lunga durata223.
Questa è una delle più rimarchevoli obbiezioni hobbesiane alla venerazione del passato
dell’antiquaria giuridica: fondando ogni sapere su una storia presunta di per sé buona, si
finisce per appiattire ogni conoscenza e per fare dei fatti, di quanto è accaduto, il criterio
unico di giustizia.
221
Cfr. OL, vol II, De Cive, XV, 17.
Cfr., Lev., p. 392. L’amaro contrappunto fattuale che si trova nella Revisione e Conclusione del
Leviathan ci appare indicativo del carattere costruttivo della speculazione hobbesiana: “there is scarce a
commonwealth in the world, whose beginnings can in conscience be justified”.
223
Cfr. HW, Dialogue, p. 100:”But Precedents prove only what was done, and not that was well done”.
222
157
Si neutralizza infine quella differenza di ragioni e soluzioni degli studiosi della materia,
che a detta di Hobbes e significativamente, “sono e devono rimanere discordanti”, quasi
ad accennare alla fertilità critica di un sapere libero, colto e diligente, che si discosti
dall’ortodossia imposta dal tempo antico.
Vediamo a contrario quanto sostenuto da Hale:
For Instance, itt is reasonable for me to preferre a Law made by a hundred or
two hundrd persons of age and wisdome Experience and Interest before a Law
excogitated by my Selfe […] Againe it is a reason for me to preferre a Law by
wch a Kingdome hath been happily governed four or five hund rd yeares then
to adventure the happiness and Peace of a Kingdom upon Some new Theory
of my owne tho’ I am better acquainted wth the reasonableness of my owne
theory then wth that Law224.
Tutto il tono del passo evidenzia la moderazione e il conservatorismo di questo grande
riformatore, che ancora una volta vede o troppo poco, o troppo bene: la ragione della
legge a cui pensa Hobbes non è la ragione di un Self (non quella di lui stesso, come
sembra insinuare Hale, accusando Hobbes allo stesso modo in cui questo aveva accusato
Coke: vanitas vanitatum, et omnia vanitas) inteso come persona particolare.
La ragione che egli invoca è una ragione comune il cui titolare è pensabile solo ed
esclusivamente come persona ficta, proprio perché un’unità sovrastante i particolari è
concepibile solo in maniera fittizia; è sintomatico che in questo luogo del Leviathan, che
ben si sarebbe prestato all’attribuzione della ragione artificiale allo stato, Hobbes ometta
224
F. Pollock, art. cit., p. 291.
158
ancora l’espressione e indichi invece subito la possibilità della contraddizione tra le leggi
dettate dal sovrano: tale circostanza, in nome dell’unità del legislatore, è dal legislatore
stesso risolvibile, giacché egli medesimo ha il potere di risolvere le discordie tra esse,
eliminandole, interpretandole o cambiandole.
Non ci sembra qui essere lontani da quel principio di auto-emendazione più volte
proclamato dalla common law, in virtù del quale essa si era resa pervasiva al cospetto di
altri sistemi di giustizia, ma la differenza sostanziale su cui ci soffermeremo ora, pur se
collocata nel medesimo luogo indicato da Hooker, quello del consenso, consiste proprio
nella diversa individuazione della fonte di legittimità.
La lezione del teologo anglicano ha avuto lunga e sfaccettata vita.
In Hale, come già in Selden, all’origine delle istituzioni governative vi era l’assenso
circa la forma dello stato e le sue qualificazioni interne, ma il suo acuto e profondo senso
storico aveva fatto sì che tale accordo fosse da egli pensato non solo in tutta la sua
concretezza, come un fatto realmente accaduto, reso manifesto da un documento oppure
testimoniato “by long custom and usage”, ma anche come un evento modificabile a
seconda del luogo e del tempo, sempre purché avvenuto attraverso il consenso delle parti
interessate225.
In mancanza di evidenza materiale di un tale accordo tra governanti e governati, ed era
questo il caso del’Inghilterra, l’uso costante doveva considerarsi “the Evidence of what
the Pact shall be presumed to have been”226, e in questo modo si manteneva la storicità
del contratto, ma la si collocava in un zona grigia accessibile alla conoscenza solo in via
presunta.
225
Cfr., M. Hale, The Prerogatives of the King, London 1975.
M. Hale, Extracts from a Manuscript of Sir Matthew Hale Concerning the Government and Laws of
England, citato da M. Lobban, op. cit., p. 68.
226
159
Inoltre per Hale il consenso, pur se inteso come fondamento di ogni legge umana, è
pensato come un atto immediato e presente solo nel caso in cui si tratti della legge
statuaria, ovvero, solo quando consista in un esito del risultato dell’azione legislativa del
re e del parlamento; in tutti gli altri casi si tratta di un consenso implicito, in base al
quale si è comunque tenuti all’obbedienza.
Su questo piano è chiaro come in Hale sia venuta meno l’esigenza di immutabilità che
muoveva Coke.
Egli fa leva invece sulla concezione dinamica del diritto grazie alla quale acquista rilievo
concreto l’idea di un sapere che deve venire ai particolari, modificare il necessario e, in
generale, intercettare le esigenze a seconda delle situazioni, mantenendo (ma adattando e
limitando al contempo) i principi della legge di natura227.
Così concepito il sistema di diritto rappresenta la cornice costituzionale entro la quale
rientra e variamente si articola l’esercizio degli attori politici, e in questa misura intorno
agli anni ’60 del Seicento la voce di Hale chiamava in causa, a partire e secondo il
criterio della antica e fondamentale common law, il principio di limitazione delle sfere di
potere all’interno della stato, in particolare, naturalmente, quella della prerogativa regia.
Si tratta certamente della rivendicazione di una capacità politica dei giudici, ai quali non
viene data la facoltà legislativa, ma sì lo sviluppo giurisprudenziale della legge, e nel
complesso dell’evidenziazione di un ruolo di controllo e vigilanza suprema ad opera dei
lawyers.
Cfr. D. E. C. Yale, Hobbes and Hale on Law, Legislation and the Sovereign, in “Cambridge Law
Journal”, 31, 1972, pp. 121-156.
227
160
Cosa fondava i limiti che tali giuristi erano chiamati a mantenere?
Ebbene era il costume, declinato però in una maniera peculiare che dovremmo
brevemente analizzare: nel custom Hale ritrova un principio di autorità impersonale che
sembra in verità costruirsi in opposizione all’idea di una semplice legge di ragione
attuale richiedente un titolare; il fondamento consuetudinario spalmato nel tempo
conferisce il sovrappiù dell’uso, quindi dell’esperienza ripetuta, sottraendo la pura legge
di ragione all’arbitrarietà di quel pericoloso Self che Hale identifica nel potere sovrano
hobbesiano, e dando al contempo un peso legittimante al consenso tacito di molti in un
lungo arco temporale.
È interessante notare come Hale non lasci nell’inafferrabile mondo delle usanze
l’elemento consuetudinario, il che avrebbe certo reso instabile il fondamento
dell’autorità: se le sue origini si perdono in verità in un sovrapporsi e mescolarsi di
eventi e circostanze, la sua concreta definizione è da ritrovarsi nella convalida legale che
per Hale come per Hobbes, consiste nella loro espressione scritta.
Ci si riferisce non solo gli statuti, ma anche e significativamente ai legal records, nei
quali era rinvenibile quel minimum di certezza e quell’ampio margine di flessibilità
interpretativa sulla base delle quali i giuristi avrebbero mantenuto “the great
Substratum”228, modificando e aggiustando il restante contenuto, adeguandolo alle
esigenze pratiche.
In questa nozione di custom non vi è traccia, se non in un lontano e indefinibile
sottofondo, del consenso delle parti:
l’accettazione della sottomissione alla legge
all’interno di una determinata, ma non immutabile, cornice istituzionale è per Hale già
228
M. Hale, The History of the Common Law of England, Chicago 1971, p. 46.
161
avvenuta, e il compito della preservazione dei fondamenti e della riforma delle loro rese
particolari è riposto interamente nella sapienza degli esperti.
Hale non può certo considerarsi un paradigmatico oppositore di Hobbes 229, per quanto il
deliberato antagonismo delle Reflections polarizzi le posizioni dei contendenti: il
giudice, come il filosofo, vide elementi profondamente critici e atrofizzati all’interno del
sistema di common law, e percepì la necessità di dare un luogo all’autorità per rendere
efficace la legge.
Entrambi compresero, sulla scia di Hooker, l’insufficienza del principio naturalistico a
fondare l’ordinamento civile, ma il plus che essi proposero si differenziò proprio quando
venne collocato dall’uno, dentro e ‘a livello’ dell’ordinamento stesso, nella nozione di
legge come consuetudine positiva; dall’altro, fuori e ‘sopra’ di esso, nell’idea di legge
come comando positivo.
Nel primo e nel secondo senso si riconosce la realtà dell’incertezza delle leggi e degli
inconvenienti delle loro applicazioni: ma Hale affida il criterio di identificazione ed
emendazione ai giuristi, chiamati a mantenere e riformare insensibilmente uno status
quo percepito come buono in sé, e quindi perfezionabile al suo stesso interno; mentre ciò
che Hobbes trova nel potere ultimo del sovrano è la soluzione politica ad un problema
che si trova a monte (o, che dir si voglia, a valle), ovvero una risposta al possibile
conflitto interno ad un assetto non più capace di auto-equilibrarsi: il primo Seicento in
Inghilterra era l’evidenza storica di tale possibilità.
Cfr. E. Campbell, Thomas Hobbes and the Common Law, in “Tasmanian University Law Review”, 1,
1958, p.37.
229
162
Hale rimprovera a Hobbes il fatto che tale potere sovrano, slegato da ogni vincolo, sia
più pericoloso, più arbitrario e più incerto di qualunque inconveniente a cui esso voglia
rimediare, e così dice in conclusione alla sua risposta:
And it is Madness to think that the Modell of Lawes of governmnt is to be
framed according to Such Circumstances as very rarely occurre. Tis as if a
Man should make Agarike and Rhubarb his Ordinary Dyett, because it is of
use when he is Sicke wch may be once in 7 yeares 230.
Hobbes è un pensatore della crisi.
In lui, il caso straordinario o di necessità non è pretestuosamente preso come
fondamento del modello, ma come luogo di osservazione, come nodo storicamente
rilevabile, nel quale è richiesta la decisione circa un’ultima istanza.
In esso egli vede il breakpoint della compagine politica, e quindi, criticamente, a partire
da qui egli si preoccupa di indicare i termini di una rifondazione consensuale che al di là
dello status, tenga insieme gli interessi.
In questa misura il fatto che il contratto in Hobbes, a differenza che in Hale, non sia un
dato storico è estremamente rilevante, perché dimostra come egli stia cercando un
principio logico propulsivo in grado sia di fondare l’obbedienza, sia di assegnare un
ruolo presente e concreto all’assenso degli individui.
230
F. Pollock, art. cit., p. 302.
163
II
Dal metodo geometrico al metodo giuridico
Un’inversione di prospettiva
La faglia nel sistema della scienza e l’infrangersi del modello razionalistico
Attraverso la critica di Hale abbiamo visto in controluce alcuni degli aspetti che
connotano il diritto nella riflessione hobbesiana, constatando come una delle obbiezioni
principali mossa a quest’ultima s’imperni proprio sull’aspirazione a voler definire un
modello giuspolitico sull’esempio della geometria euclidea.
Ciò che ci proponiamo in questa sezione è vedere, analizzando il ruolo e la valenza del
diritto nella costruzione dell’assetto civile, come si possa notare l’insinuarsi di una crepa
nel progetto scientifico hobbesiano, il quale verrebbe così a mostrare una valenza
diversa da quella del modello e un significato che va oltre la sua pretesa sistematica.
164
In virtù della forza con cui il metodo caratterizza e unifica il programma della filosofia
di Hobbes, non rappresenta certo una novità porre all’interno di una ricerca sulla sua
speculazione tale cruciale questione231.
Ripercorrere l’ordine logico-formale dell’opera di Hobbes (ordine che, è bene ricordarlo,
non corrispose a quello cronologico di stesura, che vide prima la composizione del De
Cive nel 1642, poi, a tredici anni di distanza, quella del De corpore e infine quella del
De Homine nel 1656) sembrerebbe una via sicura in vista della restituzione dei principi
deduttivi originari del sistema: tanto lontano e tanto ampiamente si è diffusa
l’illuminazione euclidea del nostro raccontata in modo icastico (anche se forse un po’
troppo sensazionalistico) da Aubrey232!
Si aggiunga a ciò il fascino, anche estetico, che il sistema inevitabilmente continua
ancora oggi a sprigionare, rimanendo doppiamente impresso nel lettore sia per il rigore
dimostrativo, sia, se così possiamo dire, per lo spirito teo-logico che in esso aleggia.
Nello studio della dottrina, da qui procedono molti dei lavori dedicati all’autore; per citare due esempi,
dal vetusto ma sempre indispensabile F. Tonnies, Hobbes. Leben und Lehre, Stuttgart, 1896, al più recente
R. Tuck, Hobbes, Oxford 1998.
232
A nostro parere vale la pena di riportare, almeno in nota, l’intero passo a cui alludiamo: “Aveva
quaranta anni quando si mise a studiare la geometria: il che accadde per caso. Siccome si trovava nella
biblioteca di un signore, c’era lì aperto il libro degli elementi di Euclide, precisamente il 47 El. libri I. Egli
lesse la proposizione. Per Dio...disse (di quando in quando inseriva qualche bestemmia per dare più enfasi
al discorso) questo è impossibile! Quindi legge la dimostrazione, che lo riporta a una precedente
proposizione: legge pure questa. La quale lo riporta a un’altra proposizione, e anche questa legge. Et sic
deinceps in modo che alla fine, per via dimostrativa, rimase convinto della verità in questione. Questo lo
fece innamorare della geometria”. Aubrey, Brief Lives, Oxford 1898 (tr. it., Vite brevi di uomini illustri,
Milano 1989, p.149).
231
165
Il metodo seguito da Hobbes, in pari tempo archeologico e architettonico, non solo
riporta alla luce le antiche colonne di Euclide, ma corrisponde perfettamente anche
all’ordine naturale delle cose, ovvero all’ordine della creazione divina.
Le cose confuse devono essere discusse, distinte, ordinate, contrassegnando
ciascuna con il proprio nome; cioè c’è bisogno di un metodo corrispondente
alla natura stessa delle cose. Questo, poi, era l’ordine della creazione: la luce,
la distinzione della notte e del giorno, il firmamento, gli astri, le cose
sensibili, l’uomo. E dopo la creazione, il comandamento. L’ordine della
riflessione dunque, sarà questo: la ragione, la definizione, lo spazio, gli astri,
la qualità sensibile, l’uomo. E, adulto l’uomo, il cittadino 233.
Può destar sorpresa, invece, il fatto che l’aggettivo privilegiato dalla nostra analisi e da
noi quindi prescelto per qualificare il metodo sia ‘giuridico’ e non il ben più familiare e
ovvio ‘geometrico’.
Si tratta di un’inversione di prospettiva che rovescia, come si può ben vedere, gli estremi
del celebre progetto hobbesiano234 e che dunque muove dalla filosofia civile a quella
naturale.
L’operazione è più complessa di quanto potrebbe sembrare a un primo sguardo, perché
non consiste tanto in una mera evidenziazione estrinseca della priorità della riflessione
politica rispetto a quella logico-matematica (sulla quale del resto si conviene
OL, vol. I, De Corpore, Ad Lectorem (tr. it. Elementi di Filosofia. Il Corpo – L’uomo, Torino 1972, p.
67).
234
Vd. OL, vol. II, De cive, Praefatio ad lectores (tr. it. Opere Politiche, cit., p. 74).
233
166
ampiamente), quanto – piuttosto – nel tentativo di seguire dall’interno le orme di ciò che
il sistema, col suo ordine euclideo, tende ad oscurare. Si tratta, in sintesi, di una specie di
movimento discendente che pone in primo piano l’ombra del sistema stesso.
Iniziando proprio con questo capovolgimento di prospettiva, è di fondamentale
importanza notare come, in modo niente affatto casuale, le due maggiori opere tarde
rappresentino i fasci paralleli di luce che proiettano tale unica ombra comune sullo
sfondo del pensiero dell’autore del Leviathan.
Non è un caso perché è precisamente in esse, ed in particolare nel De homine, che
possiamo riscontrare, a nostro giudizio, le prime crepe nella roccia apparentemente
solida e priva di fessure del sapere scientifico hobbesiano.
Da questo punto di vista la Lettera dedicatoria al Trattato sull’Uomo è un documento di
altissima sincerità – e drammaticità – filosofica. All’età di sessant’anni Hobbes confessa
di aver dovuto combattere con le belve235 prima di riuscire finalmente a portare a
compimento i suoi Elementa Philosophiae.
Il riferimento, come risulta chiaro dal successivo accenno al Demetrio di Plutarco, è
autobiografico e allude alla ‘lotta’ del filosofo contro i denigratori che in quegli anni lo
vollero mettere in cattiva luce agli occhi di Carlo II.
Ma, prestando maggiore attenzione a quanto egli in tale sede afferma a proposito del
contenuto dell’opera, le belve potrebbero assumere anche altre sembianze.
OL, vol. 2, De homine, Epistola dedicatoria (tr. it. Elementi di Filosofia, cit., p. 493: “Risponderò:
ε̉θηριομάχησα. Anche io, infatti, ho i miei Demetri ed Alessandri”). Il riferimento è alla Prima Lettera ai
Corinzi, XV, 32 e a Plutarco, Vita di Alessandro, 54.
235
167
Ma a questa sezione capita che le due parti, di cui è costituita, sono molto
dissimili tra loro: ed invero l’una è molto difficile, l’altra molto facile; l’una si
fonda sulle dimostrazioni, l’altra sull’esperienza; l’una può essere compresa
da pochi, l’altra da tutti. Perciò si congiungono quasi là dove si separano
profondamente (conjunguntur quasi ad praecipitium). Ma ciò era necessario:
lo richiedeva appunto il metodo di tutta quanta l’opera236.
La strenua osservanza del metodo, pietra angolare in virtù della quale si sarebbe portato
a compimento l’ideale unificazione delle scienze, sembra aver condotto Hobbes,
necessariamente e tragicamente, sull’orlo di una sorta di scacco speculativo:
L’uomo, infatti, non è solo corpo naturale, ma anche parte della comunità,
cioè, per così dire, del corpo politico. Per la qual cosa si doveva considerare e
come uomo e come cittadino: cioè gli ultimi principi della fisica si dovevano
connettere con i principi della politica, il più difficile con il più facile 237.
Ci permettiamo di chiosare: così sarebbe dovuto accadere, ma così non fu.
Lo impedirono, come cercheremo di mostrare, non lo scarso tempo a disposizione
dell’autore o la difficoltà estrema del compito stesso – fatto ultimo che Hobbes in verità
nega: “la parte restante era facilissima” –
o altri fattori congiunturali, ma bensì
motivazioni di carattere strutturale: l’intera vicenda “riflette la storia sofferta di un
236
237
Id.
Id.
168
pensiero che sempre più faticosamente svolgeva i momenti particolari di una costruzione
apparsa al suo nascere, esaltante e risolutiva e rivelante invece, col procedere del lavoro,
tutte le difficoltà implicite e le antinomie implicite in un tentativo tanto audace e
ambizioso”238.
Limitiamoci per il momento a rimarcare che l’incontro tanto agognato viene a mancare
proprio tra quelle due discipline delle quali Hobbes si considerava uno dei massimi
promotori, se non addirittura il fondatore stesso; ci stiamo riferendo rispettivamente
all’ottica e all’etica.
Ciò che si insidia nella prima è il rinvio ineludibile al mondo degli oggetti, il quale ne
impedisce in fin dei conti la chiusura tautologica che caratterizza invece ogni scienza
aprioristicamente intesa239.
Tale frattura all’interno della scienza dell’ottica poteva non avere, è il caso di dire di
riflesso, conseguenze fatali su quella dell’etica? Stando alla divisione dei metodi, la
risposta dovrebbe essere negativa. Ci sono infatti due philosophandi methodi,
l’uno dalla generazione agli effetti possibili, l’altro dagli effetti o φαινομένοισ
alla possibile generazione240
e la filosofia civile è più volte e con enfasi ascritta da Hobbes al primo di questi241.
238
A. Pacchi, Introduzione, in T. Hobbes, De Homine, Roma 1972, p. 8.
Cfr. A. Pacchi, Convenzione e ipotesi nella formazione della filosofia naturale di Thomas Hobbes,
Firenze 1965.
240
De corpore, XXV, 1.
239
169
La fondazione della scienza civile e morale coincide dunque, secondo questo ideale
sistemico, con l’enunciazione delle cause a partire dalle quali è possibile ottenere uno
stato civile; queste cause sono i principi o, meglio, gli elementi, che risultano essere
contemporaneamente esito della dissoluzione e inizio della costruzione teoreticaeuclidea e pratica-baconiana.
È fondamentale capire il modo peculiare in cui queste due movenze si saldano insieme,
anche perché è proprio in questo frangente che si ritrova una delle radici primarie della
critica di Hobbes all’antiquaria giuridica.
Nella definizione di scienza nel capitolo decimo del De Homine troviamo di nuovo,
seppur in forma abbreviata, l’esposizione dei due metodi della filosofia; ma il punto si
tinge qui di una considerazione assiologica che risulta per noi massimamente
significativa, perché si afferma essere preferibile dare il nome proprio di scienza soltanto
a quel procedimento dimostrativo in base al quale risulta possibile una progettazione
futura,
[…] giacché giova più sapere in che modo possiamo nella miglior maniera
servirci della cause presenti che conoscere quale fu l’irrevocabile passato.
Perciò a gli uomini è stata concessa una scienza fondata su siffatta
dimostrazione solo di quelle cose la cui generazione dipende dal loro stesso
arbitrio242.
241
242
Cfr. De cive, Epistola dedicatoria, p.139 (tr. it. Opere Politiche, cit., p. 65).
De homine, X, 4.
170
Si badi al fatto che Hobbes non sta negando in toto il valore del procedimento induttivo:
egli lo sta subordinando al processo deduttivo secondo un criterio di valore pratico; ma il
valore del primo è senz’altro riconosciuto, nonché affiancato, a quello del secondo (e di
ciò Hale avrebbe avuto certamente piacere).
Sono anche utili, soprattutto le storie: ed invero forniscono esperimenti sui
quali si appoggiano le scienze delle cause; la storia naturale, così, è utile alla
fisica, mentre le storie civili sono utili alla scienza politica e morale, siano
vere o false, purché non impossibili243.
La bontà della conoscenza storica è ammessa anche nel caso di incertezza, e persino
nella sua eventuale falsità, a condizione che non pregiudichi la plausibilità dell’evento
passato, e quindi, ci pare, sempre che risponda ad un’esigenza di possibilità futura.
Torniamo però alla dimostrazione deduttiva. La scientificità di tale operazione è per
Hobbes garantita, è il caso di rammentarlo, in base al principio del cosiddetto verumfactum:
per il fatto che i principi in forza dei quali si conosce che cosa sono il giusto e
l’equo, l’ingiusto e l’iniquo, cioè le cause della giustizia, in altri termini le
leggi ed i patti, li abbiamo fatti noi stessi 244.
243
244
Ibid, XI, 10.
Ibid., X, 5.
171
Siamo noi medesimi, quindi, a definire i principi del commonwealth, siamo noi i suoi
autori, e in questa
– e solo in questa –
misura è concepibile una scienza civile
aprioristicamente dimostrata.
È la soggettività umana, o meglio, l’intersoggettività, a fornire la necessaria garanzia
dell’oggettività, e quindi della saldezza della costruzione statuale; oltre a ciò, Hobbes
sembra evidenziare come tale garanzia richieda il riconoscimento della propria autorità
nei confronti dello stato, nonché l’assenso presente al accordo che in esso si realizza.
Così apparentemente risolta nei suoi elementi (o piuttosto liquidata una volta per tutte) la
questione, si correrebbe però il rischio concreto di lasciare nell’oblio l’altro piano che
porta Hobbes sempre e di nuovo a fare inevitabilmente i conti con il Giano bifronte della
conflittuale natura umana.
Gli uomini non sono solo autori, ma al contempo costituiscono la materia dello Stato. E
per quanto il tutore dell’uomo-cittadino, lo Stato moderno, tenti di plasmare, disciplinare
e correggere tale ostinata chora, cercando di non lasciar ulteriormente espandersi
l’ombra dell’irrazionale che accompagna inevitabilmente l’uomo-naturale, essa
continuamente tende a riapparire.
Rispetto all’arco giornaliero di vita dell’edificio statuale, si può forse affermare che esso
non conosce mezzogiorno.
172
Proviamo ad avviarci verso alcune prime conclusioni ripercorrendo e integrando i
passaggi dell’analisi fin qui condotta: partiamo da un passo del capitolo sesto del De
Corpore che ben riassume i termini della questione.
La filosofia civile è strettamente legata alla filosofia morale, dalla quale
tuttavia può essere staccata: infatti le cause dei movimenti della mente
possono conoscersi non soltanto con il ragionamento, ma anche con
l’esperienza attraverso la quale ciascuno osserva i propri movimenti. […]
Ormai, da quanto si è detto, risulta che il metodo di filosofare, per quelli che
ricercano semplicemente la scienza, senza proporsi una determinata questione,
è in parte analitico, in parte sintetico, cioè è analitico dai sensi alla scoperta
dei principi, sintetico per tutto il resto245.
Tale affermazione sembra l’inevitabile presa d’atto dell’infrangersi definitivo dell’ideale
unitario della scienza politica, il quale sembra trovare il proprio ostacolo insuperabile nel
residuo di empiricità, nell’ineludibile dato sensibile costitutivo della natura umana.
Si tratta, a ben vedere, di una frattura che era stata in qualche modo preannunciata nel
De Cive e a partire dalla quale Hobbes, giustificando l’alterazione nell’ordine della
composizione del sistema, aveva di fatto affermato l’eccezionalità dello statuto
scientifico della politica.
245
De Corpore, VI, 7.
173
Per questo ho affrettato la composizione di questa terza parte, sospendendo
quella delle altre due; onde è accaduto che quella che doveva essere l’ultima e
riuscita la prima in ordine di tempo, anche perché non mi è parso che avesse
bisogno delle precedenti, fondata com’è su principi propri, provati
dall’esperienza246.
Nella filosofia civile, in cui si troverebbero compossibili l’istanza aprioristica della
scienza con la sua validazione a posteriori, sembra definitivamente compiersi il
fallimento della applicabilità totale del principio aprioristico e forse la tenuta stessa
dell’intera filosofia hobbesiana.
Se questa fosse davvero la nostra conclusione finale, essa risulterebbe senz’altro troppo
drastica. Questo impasse sul cammino metodologico, se così possiamo definirlo, non è
in grado a nostro parere di mettere a tacere definitivamente l’insopprimibile esigenza di
unità, così profondamente radicata nello spirito hobbesiano. Anzi e comunque, tale
resistenza della materia nei confronti dell’ingessatura geometrica, spinge l’anelito di
unità a riemergere per reazione con una potenza ed una capacità dinamica interna
rinnovata, se non addirittura accresciuta.
La concezione di una filosofia etico-politica razionalmente dimostrabile è senza dubbio
una delle più durature conquiste della riflessione hobbesiana.
246
OL, vol. II, De cive, Praefatio ad lectores (tr. it. Opere Politiche, cit., p. 76).
174
Ma anche alla luce dei limiti appena evidenziati alla portata delle nostre affermazioni e
al di là di ogni loro indebita cristallizzazione in modello, questo ramo della filosofia di
Hobbes non può comunque non risentire intimamente di questa sorta di faglia
epistemologica costitutiva, trattandosi di una frattura non geometricamente né in altro
modo rimarginabile.
Per quanto il bisogno di ordine e di certezza – segno così profondo dell’intero secolo –
porti Hobbes a cercare di espungere il più possibile l’empiria dalla filosofia civile, il
dato sensibile mantiene e fa valere la sua duplice natura, massimamente quando preme
l’intento pratico di pacificazione, vale a dire, di costruzione di un ‘sapere’ che coincide
col (ci sia consentita l’espressione) ‘fare’ la pace.
In questa misura la predilezione dell’inglese non può mostrarsi solo nei confronti di un
sapere di tipo tautologico: l’etica e la politica incrociano la realtà laddove la forma retta,
geometrica delle prime, incontra la materia obliqua, fallibile, incerta della seconda.
Questo spazio di incontro che si apre tra quasi-tautologie e quasi-verità di fatto, ci
sembra presentarsi, ed è di massima importanza sottolinearlo, nella forma inequivocabile
del diritto.
La possibilità di questo difficile accordo sia sul piano teoretico che quello pratico
–e
in questo caso i due piani più che convergere, in verità coincidono – è data, secondo
Hobbes, dalla necessità della convenzione; così la concezione di fondo che emerge dai
“precipizi” sia della cognizione che della scienza, è concezione eminentemente
giuridica.
175
Solo la forza argomentativa del contratto è in grado di innestare un meccanismo logico
in grado di rendere duratura la tenuta della costruzione politica: essa è dunque una forza
propulsiva che fa appello ad una natura umana mai convertibile fino in fondo, ma pur
sempre domabile, addomesticabile; una human nature in grado cioè di forzarsi
all’ubbidienza, ed in questa maniera, ri-costruirsi, edificarsi – in certo senso
letteralmente ri-farsi – non dal nulla, ma dalla propria duplice materia, passionale e
razionale. Si tratta in definitiva di un educarsi all’essere uomini e al contempo cittadini,
non uomini-e-basta247.
L’anelito primario di civiltà che così diviene in Hobbes esigenza di certezza è allora
quello del diritto. E ci sembra evidente, infine, che non si tratta di una certezza
scientifica, ma neppure di un’assicurazione soggettiva, piuttosto della ricerca tenace e
inesauribile di una garanzia morale, di un impegno sincero e costante ad accettare la
mediazione giuridica che sola rende possibile la vita in comunità e che costituisce forse
il lascito più importante dell’eredità hobbesiana, non solo in campo politico.
Lasciamo in tal senso lo spazio conclusivo alle stesse parole di Hobbes, che ci sembrano
costituire una sorta di involontario ritratto della sua persona e del senso del suo compito
filosofico:
247
Cfr. OL, vol. II, De Cive, I, 2, nota.
176
Sometimes a man knows a place determinate, within the compass whereof he
is to seek; and then his thoughts run over all the parts thereof, in the same
manner, as one would sweep a room, to find a jewel; or as a spaniel ranges the
field, till he find a scent; or as a man should run over the alphabet, to start a
rhyme248.
Equità: legge civile e legge naturale, moralità e consenso
In conclusione al XXX capitolo del Leviathan si trova un’affermazione in parziale
contrasto rispetto a quanto si legge nella Lettera Dedicatoria al De Homine sopra citata.
Il passaggio è peculiare, non ha corrispondenze né negli Elements né nel De cive, e
affronta un argomento delicatissimo del dibattito politico in Inghilterra ai tempi di
Hobbes – e non solo – quello dei consiglieri del sovrano.
Hobbes vi aveva dedicato l’intero capitolo XXV, ma è proprio qui dove risulta più
enfaticamente rimarcato il tema che ci concerne.
Non potendoci addentrare in questa sede in una questione che, pur avendo importanti
ripercussioni a livello di teoria politica ed investendo questioni che affronteremo
successivamente, resta squisitamente storica
– qualche accenno ad essa, come
sottotraccia, si può trovare nella prima parte di questo lavoro – si noti almeno en
passant come il filosofo inglese colga uno dei punti decisivi intorno al quale si era
annodata tanta della conflittualità esplosa durante il Seicento, ovvero la rivendicazione
dei privilegi dei funzionari superiori in termini di diritti ereditari249.
248
Lev., I, III, 6.
Hobbes rimarca l’incompatibilità di tali privilegi col potere sovrano e indica nel riconoscimento
pubblico del merito personale, indipendente da ogni criterio di nascita, la via virtuosa che deve essere
249
177
Con l’obbiettivo di vanificare la qualità del consigliere in quanto membro della classe
dirigente, Hobbes scrive:
Good counsel comes not by lot, nor by inheritance; and therefore there is no
more reason to expect good advice from the rich, or noble, in matter of state,
than in delineating the dimensions of a fortress; unless we shall think there
needs no method in the study of the politics, (as there does in the study of
geometry,) but only to be lookers on; which is not so. For the politics is the
harder study of the two 250.
È rilevante come la difficoltà della politica, connessa per il suo studio alla necessità non
solo dell’osservazione, ma anche di un metodo, emerga proprio in questo luogo
dell’opera hobbesiana.
Il capitolo Of the Office of the Sovereign Representative nel Leviathan ha visto la
trattazione ampliarsi e specificarsi sensibilmente rispetto alle opere precedenti251, ed in
esso si trova l’ultima delle numerose occorrenze del termine dal quale vorremmo fare
cominciare il nostro discorso: equity.
progressivamente introdotta nello stato. Cfr. Lev., p.184: “but contending for them as a right, they must
needs by degrees let them go, and have at last no further honour, than adhereth naturally to their abilities”.
250
Id.
251
EW, vol. IV, El., IX; OL, vol. II, De cive, cap., XIII.
178
Converrà soffermarci anzitutto su un passo che si trova soltanto nel De Cive, all’inizio
del corrispondente capitolo XIII intitolato De Officis Eorum Qui Summum Imperium
Administrant252.
Si tratta di un distinguo analitico che significativamente scompare dal capolavoro del
’51, e nel quale il diritto del sovrano e il suo esercizio vengono considerati
separatamente.
La sovranità, pur essendo indivisibile in quanto al soggetto titolare, conosce
un’articolazione interna che dà luogo a due momenti potenzialmente scindibili.
Hobbes delinea in una maniera espressiva, che dimostra quanto fosse impressa in lui
l’idea di un cosmo galileiano, le circostanze in cui tali momenti coincidono oppure
vengono scissi:
Quando il diritto (ius) di sovranità e l’effettivo suo esercizio (exercitium) sono
distinti, l’ordinamento dello Stato è simile all’ordinamento naturale del
mondo, in cui Dio, primo motore di tutte le cose, produce gli effetti naturali
ad opera delle cause seconde. Quando invece chi ha il diritto di regnare vuol
essere personalmente presente a tutti i giudizi, le discussioni e gli atti pubblici,
l’ordinamento dello Stato sarebbe simile all’ordinamento del mondo in cui
Dio, oltrepassando l’ordine naturale, volesse intervenire immediatamente a
produrre ogni mutamento nella materia 253.
252
OL, vol. II, p. 297. Non passi inosservato il cambiamento delle parole scelte da Hobbes; nel De Cive il
sovrano è “colui che amministra il sommo potere”, nel Leviathan si tratta del “sovrano rappresentativo”.
Avremmo modo di tornare su questa pregnante nuova qualifica.
253
Ibid., p. 298 (tr. it. Opere Politiche, cit., p. 253.).
179
I doveri del sovrano definiscono i modi in cui il potere sommo è tenuto ad adempiere
concretamente al suo compito caratterizzante, ovvero provvedere alla sicurezza del
popolo (salus populi254). Ribadiamo: è tenuto.
Che la sovranità non sia sottoposta alla legge civile è questione più che nota: il sovrano
assoluto di Hobbes non può essere soggetto, per definizione, ad alcuna limitazione
legale.
Egli però sottosta ad una regola che – solo perché legati alla definizione hobbesiana –
non possiamo affermare essere una legge in senso proprio.
Si tratta ad ogni modo sia di una fondamentale obbligazione morale, di cui diremmo
meglio successivamente, sia di un costitutivo dettame politico che solo garantisce la
tenuta dello stato.
Il punto decisivo è il seguente: il rispetto e il riconoscimento del potere sovrano da parte
del suddito, evento imprescindibile e colonna portante non solo della nascita ma anche (e
forse soprattutto) della vita dello stato, non è imponibile.
E da ciò risulta evidente come la riflessione hobbesiana faccia intimamente i conti con il
punto cieco alla base di ogni compagine politica, vale a dire, col fatto che i cittadini, per
Così nel Levitano latino e nel De cive, dove Hobbes compie un’importante precisazione: il popolo, egli
dice, è da intendersi qui non come la persona civile, ma come la moltitudine dei cittadini che vengono
governati. Si veda dunque come nel suo effettivo esercizio, il potere sovrano debba aver riguardo per i
membri dello stato in quanto membri, non potendo avere a che fare concretamente con la finzione che fa
di essi un’unità omogenea. Quasi a dire che nel momento della sua resa pratica, diversamente da quello
della sua costruzione teorica, lo stato debba continuamente e instancabilmente ‘fare’ e ‘tenere’ quell’unità.
In che modo ciò sia possibile sarà in seguito detto. Cfr. Ibid., p. 299.
254
180
essere veramente vincolati ad essa, debbano ancora prima di conoscere e sottoporsi a
qualunque comando positivo, essere legati ed obbligati “sincerely from the heart”255
all’ordinamento istaurato.
And the grounds of these rights [of sovereignty], have the rather need to be
diligently, and truly taught; because they cannot be maintained by any civil
law, or terror of legal punishment. For a civil law, that shall forbid rebellion,
(and such is all resistance to the essential rights of sovereignty,), is not (as a
civil law) any obligation, but by virtue only of the law of nature, that
forbiddeth the violation of faith; which natural obligation if men know not,
they cannot know the right of any law the sovereign maketh. And for the
punishment, they take it but for an act of hostility; which when they think they
have strength enough, they will endeavour by acts of hostility, to avoid256.
(corsivo nostro)
La ribellione non è sanzionabile per legge, perché essa, in un bizzarro gioco di specchi,
riflette in negativo l’assolutezza del sovrano.
Fuori dai confini del commonwealth ci si trova in una zona in cui non vi è diritto civile,
ma di nuovo e soltanto la forza del diritto naturale: perciò, ed è qui dove è
massimamente evidente la carica politica del precetto a cui sottostà il sovrano, qualora
255
Cfr. Lev., p. 179.
Ibid., p. 175. Cfr., De Cive, XIV, 21, dove il ragionamento viene svolto a proposito del suddito che
viola la legge di natura.
256
181
egli oltrepassi il limite che definisce la sua azione artificiale, allora la punizione naturale
che si vedrà infliggere sarà la ribellione.
La questione viene formulata in questi termini in fondo alla seconda parte dell’opera,
alla fine del capitolo XXXI, Of the Kingdom of God by Nature:
[…] negligent government of princes, [is naturally punished] with
rebellion…For seeing punishments are consequent to the breach of laws;
natural punishments must be naturally consequent to the breach of the laws of
nature; and therefore follow them as their natural, not arbitrary effects 257.
È evidente come, pur non trattandosi di un freno legale, la legge di natura rappresenta un
concreto vincolo all’esercizio del potere sovrano, laddove la sua infrazione corrisponde
al venir meno della fiducia che ad esso è stata accordata e di conseguenza
all’indebolimento del consenso in virtù del quale tale potere è stato innalzato.
In questo preciso frangente della riflessione hobbesiana, in cui vediamo il sovrano
obbligato dalla legge di natura a procurare il bene del popolo, bisogna rintracciare quello
che, capovolgendo il titolo di un famoso studio, potremmo chiamare il volto non
demoniaco del potere.
257
Ibid., p. 193.
182
Che la sua bontà, ma anche il suo proprio utile, consista essenzialmente nel suo essere
principio di equità è immediatamente detto da Hobbes, il quale, specificando e
migliorando l’argomentazione in proposito fatta nel De Cive, compie due importanti
precisazioni: in primo luogo, egli chiarisce come la sicurezza a cui deve provvedere il
sovrano rappresentativo non sia la mera sopravvivenza, ma consista anche in tutte la
altre soddisfazioni della vita a cui ognuno possa attingere con attività lecite e senza
pericolo o danno per il commonwealth; in secondo luogo – ed è ciò che alla nostra
analisi massimamente interessa –
Hobbes delinea il modo in cui il sovrano,
nell’espletamento di tale compito, debba rapportarsi a quell’ “ognuno” sopra indicato.
And this is intended should be done, not by care applied to individuals,
further than their protection from injuries, when they shall complain; but by
general providence, contained in public instruction, both of doctrine, and
example; and in the making and executing of good laws, to which individual
persons may apply their own cases258.
Dietro alla “cura rivolta agli individui” si nasconde la parzialità.
La regola che il sovrano è tenuto a seguire è dunque il principio di equità che Hobbes
aveva indicato come l’undicesima legge di natura259.
Il termine equity, rinvenibile già negli Elements e nel De Cive, usato più frequentemente
nel Leviathan, adoperato chiaramente nel Dialogue, può considerarsi “the dominant
Ibid., p. 175. Cfr. Ibid., p. 159: “The examples of the princes, to those that see them, are, and ever have
been, more potent to govern their actions, than the laws themselves” (corsivo nostro).
259
Cfr. Ibid., p.77; De Cive, III,15; El., XVII, 2.
258
183
moral category in Hobbes’s political and legal philosophy” 260: intorno ad esso
confluiscono tutti quei valori che il sovrano è tenuto a preservare, l’uguaglianza, la
rettitudine, la giustizia.
Ed è appunto dall’amministrazione di quest’ultima che Hobbes avvia la vera e propria
trattazione circa i doveri del sovrano, ma che la questione non si riduca a questa sfera, e
riguardi invece nel complesso e nel vivo l’intero suo operato, risulta evidente dallo
svolgimento successivo dell’argomentazione, nella quale egli significativamente applica
il principio all’imposizione delle tasse, alla carità pubblica, alle punizioni e alle
ricompense.
L’ambito dell’amministrazione della giustizia funge in qualche modo da modello
paradigmatico perché è in tale sede che l’uguaglianza che il sovrano deve riconoscere
assume la vera forma della giustizia ed è più chiaramente evidente in che maniera la
legge civile intrattenga un rapporto con la legge naturale.
Nel Leviathan Hobbes afferma anzitutto che, a dispetto di ogni disuguaglianza sociale, la
legge deve essere applicata in modo eguale a tutti i livelli del popolo, perché solo in
questo modo può venir rispettata l’equità
to which, as being a precept of the law of nature, a sovereign is as much
subject, as any of the meanest of his people261.
L. May, “Hobbes on Equity and Justice”, in C. Walton, P. J. Johnson (a cura di), Hobbes’s ‘Science of
Natural Justice’, Dordrecht 1987, p. 241.
260
184
L’istanza dell’equity come si può ben vedere, non solo rende uguali abbienti e poveri,
ma rende persino eguali sudditi e sovrano, tutti parimenti vincolati da uno standard di
moralità che indica ciò che è giusto fare prima e sopra ogni legge civile; si tratta di un
elemento che apre una profondissima breccia nel famigerato positivismo giuridico
hobbesiano, dal momento che riconosce la presenza di un vincolo superiore che sovrasta
la legge civile.
Come si concilia questa gerarchizzazione con la celebre e problematica affermazione
secondo cui la legge naturale e la legge civile si contengono a vicenda e hanno uguale
estensione?
È stato più volte messo in luce come l’idea di legge intesa esclusivamente come
comando vanifichi ogni rilevanza giuridica e politica della legge di natura, finendo per
ridurre il contenuto dell’ultima alla forma impositiva del primo e annullandone di fatto il
potere obbligante.
Osservando la questione dalla prospettiva dell’equità il rapporto appare quantomeno
ancor più complesso. Sarà di qualche utilità vedere in che maniera il problema emerga
dalle pagine del Dialogue.
Nell’opera degli anni sessanta la cornice è quella del confronto con le voci che
sostengono la sovranità della common law.
261
Lev., p. 180.
185
Ansioso di affermare la titolarità del potere di ultima istanza, come abbiamo altrove
visto, Hobbes si preoccupa di ricondurre entro il confine del diritto civile l’intero spettro
della giustizia, e, per ottenere ciò, risulta evidente come debba venire inglobato non solo
il momento positivo della legge, ma anche quel momento interpretativo che rende conto
e ragione, se così possiamo dire, della lettera del comando.
Che l’argomentazione tenti di fare i conti con questo senso dilatato di diritto emerge
dalle prime pagine della trattazione, quando il Filosofo si sforza di identificare la forza e
il senso proprio della legge con la ragione del sovrano, smantellando il concetto di
ragione artificiale dei giuristi.
Law. You speak of the Statute Law, and I speak of the Common Law.
Ph. I speak generally of Law.
Law. Thus far I agree with you, that Statute Law taken away, there would be
no left, either here, or any where, any Law at all that would conduce to the
Peace of a Nation; yet Equity, and Reason, which [are] Law Divine and
Eternal, which oblige all Men at all times, and in all places, would still
remain, but, be Obeyed by few: and though the breach of them be not
punished in this World, yet they will be punished sufficiently in the World to
come262.
262
HW, Dialogue, p.10
186
E ancora più avanti, quando l’identità della legge civile che aveva visto corrispondere in
se stessa il suo essere somma col suo essere retta, mostra avere ancora una doppia
articolazione:
I say, that, the King Reason, when it is publikly upon Advice, and
Deliberation declar’d, is that Anima Legis, and that Summa Ratio, and that
Equity which all agree to be the Law of Reason, is all that is, or ever was Law
in England 263
Si provi, leggendo queste linee, a tenere a mente quanto abbiamo precedentemente
rilevato nella nostra analisi: Hobbes sta tracciando un quadro nel quale il saldarsi
insieme di giustizia (qui intesa come sfera delimitata dalla legge positiva), ed equità
(intesa come fondamento razionale di ogni legge), connota la legittimità del potere
sovrano e subordina ad essa l’esercizio dei giudici inferiori.
Se questo doppio binario si presenta unificato e non sottoposto a istanze ulteriori,
qualora lo si osservi nella sua assoluta supremazia di diritto, di fatto si intravede in esso
la presenza, accanto alla zona dei comandi e dei divieti sanciti e punibili legalmente, di
un margine di trasgressione che inerisce ad un piano universale e valido, pur se non del
tutto esplicitato nella formulazione delle leggi; si insinua dunque, un tanto di fallibilità
che tale si definisce in rapporto alla pace e la sicurezza della nazione, legge suprema
263
Ibid., p. 19.
187
dello stato che, come si è potuto leggere nel Leviathan, qualora venga infranta sarà
punita non nell’intangibile al di là, ma sul più che terreno fronte della ribellione.
Il sovrano di Hobbes non è semplicemente un principe devoto e timoroso di Dio, egli è
chiamato ad obbedire alla legge divina secondo la pretesa del popolo che a lui ha
conferito fiducia.
Ma ciò qui ci interessa maggiormente è ciò che troviamo al di là di tale scontro estremo.
In questo contesto la possibilità di errare è quella dei giudici subordinati, e in tal senso è
estremamente interessante notare come Hobbes porti immediatamente il discorso sul
piano istituzionale, quasi a voler rendere materiale un meccanismo di temperamento del
rigore della legge scritta che corrisponde in tutto e per tutto al temperamento morale del
sovrano nel momento del suo esercizio pratico.
Nel Dialogue Hobbes spiega la differenza tra giustizia ed equità partendo
significativamente da quella tra Corte di Giustizia e Corte di Equità, ed a questo punto
non potrà non notarsi l’importanza per la sua concezione del diritto di quelle complesse
vicende che videro la competizione e lo scontro tra queste due giurisdizioni; alludiamo
agli eventi avvenuti negli anni della sua giovinezza, di cui abbiamo trattato nella prima
parte di questo lavoro.
188
In un primo momento Hobbes, attraverso le parole del Filosofo, sembra fare ai common
lawyers un’importante concessione, che però viene presto ristabilita a favore della
prerogativa del sovrano.
Ph. You see that the difference between Injustice, and Iniquity is this; that
Injustice is the Transgression of a Statute-Law, and Iniquity the Transgression
of the [Common-Law which] was nothing else but the Law of Reason, and
that the Judges of that Law are Courts of Justice, because the breach of the
Statute-Law is Iniquity and Injustice also.
[…]
La. Seeing all Judges in all Courts ought to Judge according to Equity, which
is the Law of Reason, a distinct Court of Equity seemeth to me unnecessary,
and but a Burthen to the People, since Common-Law, and Equity are the same
Law.
Ph. It were so indeed; If Judges could not err, but since they may err, and that
the King is not bound to any other Law but that of Equity, it belongs to him
alone to give Remedy to them that by the Ignorance, or Corruption of a Judge
shall suffer dammage264.
La pretesa di assorbimento dell’equity nelle procedure stesse della common law era stata
esattamente la rivendicazione fatta dalle schiere dei professionisti dei tribunali ordinari
al seguito di Coke, i quali rinvenivano nella legge già data l’unica fonte del diritto.
264
Ibid., pp. 30-31.
189
Ma il motivo per cui Hobbes, pur ammettendo in teoria l’argomento da loro portato,
finisce per scartarlo, consiste significativamente nel riconoscimento della fallibilità del
giudice, all’errore del quale deve poter offrire rimedio un potere superiore, libero dai
vincoli della procedura legale.
Il problema, è evidente, potrebbe riproporsi all’infinito, perché ogni potere umano è
suscettibile di errore, ma sul piano dell’articolazione istituzionale la risposta di Hobbes,
lo sappiamo, è netta, e soddisfa quel criterio di sicurezza e pacificazione che abbiamo
visto farsi sempre più pressante lungo la sua riflessione.
Ph. […] I am sure you can alledge none but this, that there were a necessity of
a Higher Court of Equity than the Courts of Common-Law, to remedy the
Errors in Judgment given by the Justices of Inferior Courts, and the Errors in
Chancery were irrevocable, except by Parliament, or by special Commission
appointed thereunto by the King265.
La sovranità voluta da Coke è qui non solo puntualmente rovesciata sul piano delle corti,
tra le quali ad essere superiore è la Cancelleria e non le corti di diritto comune, come
avrebbe invece voluto il celebre giurista, ma anche interamente subordinata alla
sovranità del potere supremo, che indicativamente sembra comparire qui nella forma del
King in Parliament.
265
Ibid., p. 61.
190
Si evidenzino ancora altri due elementi.
Il primo consiste nel fatto che il sorgere dell’equity si collochi nel momento applicativo
della legge, lasciando intatta, in teoria, la perfetta corrispondenza della legge in se stessa:
Hobbes intende l’errore come un errore del giudizio e giammai come un errore della
legge, la quale deve sempre presumersi equa; qualora la sua applicazione riveli una
possibile discrasia, allora un’istanza superiore dovrà ripristinare il senso ultimo della sua
interpretazione in modo da rendere efficace il fine per cui è stata posta.
Un secondo aspetto, che a questo si collega, ci pare vada poi sottolineato: l’intervento in
campo giudiziario del supremo potere politico è un intervento eccezionale, che ricorda in
verità quel Dio onnipotente che oltrepassa l’ordine naturale secondo l’immagine del
passo precedentemente citato del De Cive.
Ciò che il buon governo dovrebbe mettere in atto è un virtuoso meccanismo, in fondo
vincolato alla morale, che renda quanto più possibile raro e non necessario il miracolo
del Dio mortale.
Equity is a certain perfect Reason that Interpreteth, and Amendeth the Law
Written; though I Construe it a little otherwise than he [Coke] would have
done; for no one can mend a Law but he that can make it, and therefore I say
not it amends the Law, but the Judgments only when they are Erroneous 266.
266
Ibid., p. 68.
191
Sul piano legale la sovranità dell’equity poggia sull’identità tra legge naturale e legge
civile che realizza lo stato, ma la possibilità che la legge in se stessa possa non essere
retta (e quindi necessiti di un rimedio) viene pur sempre contemplata, anche se riportata
interamente alla giurisdizione del suo autore, e, dovremmo dire in verità, alla sua
coscienza.
L’equità è quindi per il sovrano rappresentante principio morale supremo alla luce del
quale egli deve tenacemente e costantemente guardare al bene cui è orientato il suo
potere; potere che, da questa prospettiva, è forza solo perche è diritto.
Quando Hobbes sostiene l’identità di bene privato e bene pubblico nella persona del
Sovrano egli in realtà delinea un compito che, come rivela proprio il precetto di equità,
si propone di dare una forma giuridica e politica nella quale possa trovare dimora un
consenso non naturalmente dato.
Also if a man he trusted to judge between man and man, it is a precept of the
law of nature, that he deal equally between them. For without that, the
controversies of men cannot be determined but by war 267.
L’undicesima legge di natura, dimostratasi pietra angolare dell’ordine politico, sostiene
la necessità di un contenimento e un temperamento delle passioni, sia del sovrano che
dei sudditi, in forza del quale si riconosca l’uguaglianza e si bandisca la parzialità:
267
Lev., p. 77.
192
l’equità è dunque il fondamento morale su cui poggia lo stato e costituisce – essa, e non
la forza naturale che viene lasciata al sovrano nel contratto – un criterio valido ed
efficace col quale deve misurarsi faticosamente e costantemente l’esercizio del potere in
vista del mantenimento della giustizia.
È evidente come la giustizia che qui si invoca non sia riducibile in ultima analisi alla
positività delle leggi, ma investa piuttosto il nucleo sostantivo della giuridicità: il diritto
come vincolo reciproco, chiamato a legare gli animi prima ancora che le azioni degli
uomini.
La giustizia degli uomini268, tanto di chi è sovrano, come di chi è suddito, è dunque
quella grande morale che consiste nell’esercizio della coscienza come abitudine costante
tesa a frenare e silenziare tutte quelle passioni che riconoscono e tentano di rivendicare
una disuguaglianza aliena alla natura dell’umanità.
Solo il precetto di questa giustizia naturale dispone l’animo degli uomini alla convivenza
pacifica.
Autore, Attore, Autorità
Nel definire la parzialità Hobbes riprende un termine greco del Nuovo Testamento269,
che rimanda ad un preferenza e ad un giudizio di favore per gli uomini basato sulle
apparenze esteriori e non sui meriti.
268
269
Cfr. Ibid., p.75.
Romani 2:11; Efesini 6;9.
193
The observance of this law, from the equal distribution to each man, of that
which in reason belonged to him, is called Equity and (as I have said before)
distributive justice: the violation, acceptance of persons, προσωποληψία 270.
Ritroveremo la radice della parola, seppur connotata in maniera diversa e significativa,
nel XVI capitolo del Leviathan.
Nell’architettonica dell’opera il luogo è la conclusione della parte dedicata all’Uomo,
immediatamente prima dell’inizio della trattazione dello Stato: già questa collocazione,
secondo quanto diremo avanti, è decisamente indicativa271.
Si tratta di un passaggio estremamente delicato, guadagnato da Hobbes per la prima
volta in quest’opera, nel quale si trova la messa a punto di un impianto giuridico in cui vi
è una singolarissima metamorfosi degli uomini, in virtù della quale il passaggio dalla
natura all’artificio è reso teoricamente possibile.
Ci soffermeremo proprio sui termini e i contorni dell’assunzione di questa nuova veste,
che farà dell’uomo un cittadino.
È qui dove inizia il vero e proprio movimento costruttivo della scienza politica, nel quale
troviamo la formulazione di un sistema di categorie nuovo (nel quadro del Leviathan,
270
Lev., p.77.
A. Amendola, Il Sovrano e la Maschera, Napoli 1998, p. 203: “(…) la trattazione della persona si
colloca al crocevia fra la fine del discorso sulla natura umana e l’inizio della “scienza politica”
propriamente detta. La definizione di persona, insomma, in un certo senso, apre il sistema deduttivo che
‘ricompone’ il corpo politico”.
271
194
non certo della tradizione giuridica), grazie al quale Hobbes sposta la prospettiva che ha
orientato l’antropologia delineata nella prima parte dell’opera272.
Partiamo direttamente, come fa Hobbes stesso, dalla definizione della prima di queste
categorie, ovvero, dal concetto di persona:
A Person, is he, whose words or actions are considered, either as his own, or
as representing the words or actions of another man, or of any other thing to
whom they are attributed, whether truly or by fiction. When they are consider
as his own, then is he called a natural person: and when they are considered
as representing the words and actions of another, then is he a feigned or
artificial person273.
La definizione individua un soggetto ritenuto possessore oppure rappresentante di parole
e azioni, rispettivamente, proprie o altrui.
Anche se, come vedremo, la persona non necessariamente coincide con l’individuo, il
presupposto di questa caratterizzazione è l’originaria e stabile attribuzione al singolo, da
parte di altri, della titolarità dei mezzi di deposizione del diritto274: questo è il tacito dato
primo che permette il costituirsi delle persone giuridiche, sia di quelle naturali che di
quelle artificiali.
272
Ibid., p. 195 e ss.
Lev., p. 80.
274
Per il significato propriamente giuridico di own e ownership cfr. W. Sakesteder, “Hobbes: Man the
Maker”, in J.G. Van Der Bend (ed.), Hobbes: His view of man, Amsterdam 1982, pp. 77-88.
273
195
Hobbes delimita così un nuovo spazio concettuale in cui rientra, per definizione, sia
l’assunto individualistico che il postulato di apertura all’intersoggettività. Entrambi gli
elementi si intrecciano in una stretta morsa che tenteremo ora di allentare. Per fare ciò,
riprendiamo ancora il contenuto testuale della definizione.
Facendo leva sulle espressioni “are considered”, “are attributed”, possiamo osservare un
preciso riscontro del presupposto su indicato: il riconoscimento dal di fuori della persona
come agente giuridico appare un fattore strutturale che mette in evidenza il fatto che, per
Hobbes, “la persona è una designazione esteriore”, la quale denota “una proprietà solo
relazionale e percettiva”275; essa viene posta immediatamente in un contesto pubblico.
La cornice tracciata dall’antropologia naturale aveva precluso ogni via uniforme di
approdo ad un ordine intersoggettivo, e l’affacciarsi della morale come strumento ed
apertura ad esso, proprio nella discontinuità del quadro delineato, indicava già
l’indeducibilità e l’infondatezza che caratterizzerà indelebilmente lo stato artificiale, il
solo che renderà tale ordinamento attuabile, ovvero, reale.
Il concetto di persona si innesta proprio in questo iato: esso è una nozione giuridica,
necessariamente sganciata dalla nozione fisica di individuo, a cui si giunge, però,
proprio grazie a uno sdoppiamento interno all’individuo, che determina “un
distanziamento tra il sé e le proprie azioni e parole, di modo che queste possono sia
275
B. Accarino, Rappresentanza, Bologna 1999, p. 53. Cfr. anche A. Amendola, op. cit., p. 201.
196
aderire al soggetto (…) sia staccarsene ed essere attribuite a un altro”276: nel primo caso
abbiamo la persona naturale, nel secondo quella fittizia. Questa precisa scissione
dell’unità fisico-naturale dell’uomo è funzionale al suo divenire artefice del
commonwealth.
Quali sono gli ‘oggetti’ che vengono ravvisati come posseduti dall’uomo?
Essi sono le sue parole e le sue azioni. Lo slittamento rispetto alla trattazione del
capitolo XIV va messo subito in evidenza: là, il possesso dell’uomo (e il diritto ad esso
correlato) era sulle cose; nel patto ivi descritto, parole e azioni compivano un’importante
funzione, che restava però, in fin dei conti, instabile ed insicura. Esse gettavano un ponte
tra il volere e gli oggetti, sostenendo, in maniera drammaticamente debole,
l’adempimento differito del loro trasferimento.
Qui il quadro muta sensibilmente: il ‘dominio’ che la categoria di persona richiede di
riconoscere agli individui è proprio su quei segni visibili della loro volontà, e con ciò
l’argomentazione compie una mossa di formalizzazione risolutiva, che, con un certo
azzardo, potremmo chiamare di concretizzazione dell’astratto.
Lo spostamento compiuto da Hobbes è gravido di conseguenze, perché con esso egli
attribuisce uno spessore definitivamente materiale alle facoltà individuali e, in questo
modo conferisce all’uomo lo statuto nuovo (sempre e comunque nominalistico) di homo
juridicus, caratterizzato originariamente, possiamo così dire, dal dominio di sé.
276
F. Izzo, Forme della modernità, Roma-Bari 2005, cap.2, par. 2.
197
Questo possesso, riconosciuto all’individuo immediatamente nella persona naturale,
mediatamente in quella fittizia, è la forma nella quale il filosofo inglese stabilizza e
cristallizza un nucleo soggettivo di inalienabilità che sarà il fondamento della teoria
dell’autorizzazione.
Proseguiamo seguendo il breve excursus filologico sulla parola persona: anche se
Hobbes ricorda il significato greco di πρόσωπον come viso, egli riconduce interamente il
termine, semplificando di fatto una complessa tradizione che intorno ad esso si era
formata, al significato latino originale di maschera.
È così che in questo luogo viene stabilito il nesso, per noi altamente stimolante, tra
tribunale (l’ambito giuridico per eccellenza) e palcoscenico.
[…] and from the stage, hath been translated to any representer of speech and
action, as well in tribunals, as theatres. So that the person, is the same that an
actor is, both on the stage and in common conversation; and to personate, is
to act, or represent himself, or another; and he that acteth another, is said to
bear his person, or act in his name 277.
La nozione di maschera sigilla l’identificazione tra persona e attore, ponendo a
fondamento di entrambi il concetto di rappresentazione.
277
Lev., p.80.
198
Attraverso di essa prende corpo l’idea del binomio parole-azioni come qualcosa di
assumibile, di indossabile, un’apparenza esterna mobile (giammai, secondo quanto
abbiamo sostenuto sopra, abdicabile): proprio in forza di questo suo carattere
sovrapponibile, artificiale rispetto alla natura immediatamente presentificantesi, la
maschera può coincidere col viso, laddove la persona rappresenta se stessa; ma può
soprattutto non coincidere con esso, nel qual caso l’attore recita in nome di un altro.
È in questa breccia aperta con impetuoso sforzo teoretico che Hobbes può usare per la
prima volta, ed in un senso politico-giuridico assolutamente innovatore, “il termine
repraesentare come sinonimo di personam alicuius gerere”278: la persona artificiale non
sta per un altro, ma agisce in nome di un altro, in un processo rappresentativo che lega
insieme, nella forma del mandato oppure della licenza, due diversi soggetti: l’attore e
l’autore.
Of person artificial, some have their words and actions owned by those whom
they represent. And then the person is the actor; and he that owneth his words
and actions, is the Author: in which case the actor acteth by authority. For that
which in speaking of goods and possessions, is called an owner, and in Latin
dominus, in Greek κύριος; speaking of actions, is called author. And as the
right of possession, is called dominion; so the right of doing any action, is
called Authority and sometimes warrant. So that by authority, is always
278
B. Accarino, op. cit., p. 49.
199
understood a right of doing any act: and done by authority, done by
commission, or license from him whose right it is 279.
Abbiamo riportato per esteso il passo in cui viene definito l’importantissimo trinomio
autore-attore-autorità: sono questi tre vocaboli che affrancano in maniera radicale il
discorso artificialista, tramutando in veste definitivamente positiva i concetti inadeguati
di possesso e dominio.
Il senso dell’argomentazione viene specificato in maniera decostruttiva, il che implica,
per l’analisi, non poche difficoltà. Rovesciamo quindi il passo partendo dall’autore e dal
suo originario diritto.
Nonostante l’analogia con il diritto di possesso di oggetti sia strutturale, il piano
delineato richiede, progressivamente e con forza, una sua propria terminologia.
Al concetto di dominio si sostituirà, quindi, la nozione di autorità: essa è il diritto
dell’autore e riguarda in realtà una sorta di bene immateriale e inalienabile il cui
contenuto è la facoltà che egli ha di agire da sé; l’auctoritas rimanda dunque al “diritto
naturale che ognuno ha su se stesso”280.
279
280
Lev., p. 81.
Y.C. Zarka, Hobbes et la pensée politique moderne, Paris 1995, cap. IX.
200
Con ciò Hobbes compie una “rivoluzione concettuale” dalle conseguenze epocali. Con
questa definizione egli sovverte il senso tradizionale di autorità come dato obiettivo
legato ad un’idea di verità sostanziale, che fungerebbe da principio gerarchico
dell’ordine, e conia un’espressione tutta sbilanciata a favore degli autori-soggetti: in
“conseguenza di questo vero e proprio rovesciamento, il fondamento ultimo della
legittimazione
del
nuovo
ordine
moderno
è
un’auctoritas
autorizzante
individualistica”281.
Questo soggettivo possesso astratto si ispessisce e acquisisce una valenza autonoma ed
un peso effettuale all’interno della logica stringente del sistema concettuale che qui si
delinea.
Se è l’autorità che informa la rappresentazione della persona fittizia (e questo accadrà
quando l’autore riconosca come sue le parole e le azioni messe in scena dal
rappresentante), allora questa verrà considerata come l’attore che agisce con autorità.
In questo peculiare e decisivo riconoscimento di titolarità, vi è un aspetto giustamente
sottolineato, che demarca definitivamente la differenza tra autorizzazione e
trasferimento: la prima è propriamente un tipo di trasmissione che non spossessa gli
individui dal diritto sulle azioni che essi autorizzano, ma costituisce invece un diritto sul
loro proprio diritto.
281
Cfr. G. Preterossi, Autorità., Bologna 2002, p. 56.
201
Ora, e solo ora, viene messo in evidenza il legame sussistente tra questa costellazione
concettuale (persona, rappresentanza, autore, attore, autorità) e la trattazione precedente,
più precisamente, quella concernente i contratti:
From hence it followeth, that when the actor maketh a convenant by authority,
he bindeth thereby the author, no less than if he had made it himself; and no
less subjecteth him to all the consequences of the same. And therefore all that
hath been said formerly, (chap. XIV) of the nature of convenants between
man and man in their natural capacity, is true also when there are made by
their actors, representers, or procurators, that have the authority from them, so
far forth as is in their commission, but no further 282.
Il passaggio vuole apparire, come al solito, pacifico, ma in realtà, alla luce di quanto
abbiamo finora ammesso, comporta una radicale riconfigurazione dei piani.
La condizione per cui il discorso sui patti stipulati da attori può reggere (ovvero avere
una qualche incidenza sulla realtà, muovendo dal piano della finzione giuridica) è tutta
in seno alla teoria dell’autorizzazione.
Analizziamo i principali requisiti che essa contiene.
Il punto di partenza è, come vediamo dal passo citato, il seguente: quando un attore
pattuisce con autorità egli vincola con ciò, in tutto e per tutto, l’autore, e non se stesso.
282
Lev., p. 81.
202
L’unico modo però in cui si può appurare l’effettiva autorizzazione dell’attore da parte
del titolare del diritto, è richiedere che tale autorità sia resa manifesta: così, chi abbia
intenzione di stipulare un accordo con qualcuno attraverso la mediazione di un deputato
è tenuto ad accertarsi dell’autorità283 di cui egli è investito.
Emerge così una prima e imprescindibile condizione dell’autorizzazione: essa deve poter
essere verificabile dai contraenti.
Solo qualora essi richiedano la messa in mostra dell’autorità in nome della quale agisce
il rappresentante, ovvero sollecitino l’evidenziazione del suo carattere di mediatore,
potranno esigere l’adempimento dell’autore.
Si tratta di un principio che sancisce l’esigenza di controassicurazione pubblica; laddove
essa non venga inizialmente pretesa, avrà ruolo un’autorità fittizia che obbligherà invece
soltanto l’attore, annullando in questa maniera la sua funzione di mediatore di una
volontà diversa dalla propria284: nel momento in cui vi è un rappresentante che non recita
che se medesimo, non c’è altro autore che l’attore stesso.
L’eventualità della violazione di una legge di natura da parte di un commissario
autorizzato, ci sembra indicativo in più sensi.
La circostanza che viene descritta esprime in maniera netta alcuni importanti aspetti:
innanzitutto emerge la concretezza della finzione messa in atto dal meccanismo
283
284
Id.
Id.
203
dell’autorizzazione, nel quale il rappresentante è a tal punto svincolato dalle
conseguenze del patto che di fatto egli è completamente irresponsabile delle sue azioni.
Così, perfino nel caso estremo in cui il rappresentato ordini al rappresentante qualcosa
che violi la legge naturale, l’intenzione di quest’ultimo rimane ingiudicabile, a
condizione però che egli sia stato obbligato da un patto precedente a obbedire al suo
comando. Il precetto di stare ai patti contenuto nella terza legge di natura sembra
strutturare l’ordine dell’imputabilità, insinuandosi qui come prioritario rispetto alle altre
leggi naturali.
Questo è quanto Hobbes pone in questo caso sulle regole del rapporto di
rappresentazione tra persone mediante finzione. Una finzione che abbiamo visto
unificare, in virtù del nesso autorizzazione-mediazione-riconoscimento, individui
diversi.
Ora vengono affrontati tre casi in cui la personificazione riguarda “cose inanimate”,
“esseri irrazionali” e “idoli”285, circostanze in cui la finzione in sé non basta a investire
gli attori di autorità.
Quale sarà l’ulteriore sostegno che essi richiedono? La risposta sarà univoca: lo Stato.
Perché accade ciò? Bisognerà, in conclusione, verificarlo caso per caso.
285
Cfr. Lev.p. 82.
204
Il primo riferimento, quello alle “cose inanimate”, è abbastanza chiaro: non avendo
alcuna facoltà autonoma, e tanto meno alcun diritto, non c’è niente in esse che sia
suscettibile di essere chiamato autorità, quindi non vi è nulla che da quelle possa essere
commissionato o delegato.
Potranno compiere ciò, al massimo, i possessori o i governatori di tale cose, su questioni
concernenti il loro uso e mantenimento, ma, come già sappiamo dall’analisi condotta nel
secondo capitolo di questo lavoro, non vi è legittimità e stabilità in tali figure se non
all’interno di uno Stato civile; solo in esso sarà possibile impersonare questi oggetti.
Simile sarà, poco avanti, nel terzo caso, l’argomentazione sugli “idoli”: essi non sono
che finzioni della mente e quindi , dice Hobbes concisamente, “un idolo non è nulla”.
L’autorità in virtù della quale gli dei pagani sono stati impersonati non poteva che
provenire dallo Stato, unica fonte materiale di riconoscimento giuridico in mancanza di
un autore naturale.
Il secondo caso è invece ben più interessante, e in qualche maniera illumina i due che gli
sono affiancati: la questione è come rappresentare esseri privi di ragione, come i bambini
e i folli.
Ciò è possibile, dice Hobbes, attraverso tutori o curatori, i quali tuttavia possono
rappresentare queste persone con autorità solo in forza dell’affidamento di un terzo (lo
Stato), al quale sia stato anteriormente riconosciuto il dominio su di esse.
205
In questo modo il discorso sull’autorità si ricollega ad un giudizio di ragionevolezza
sulle azioni, riposto normalmente nella facoltà calcolante degli individui, che però è
assente e tace negli esseri animati di cui qui si parla.
Estremamente significativo risulta il fatto che, in assenza di un sano principio di ragione
individuale, vero sostegno di ogni singola autorità, non si possa ricorrere
immediatamente ad un’altra ragione naturale che vi si sostituisca, ma si debba passare
attraverso una terzietà artificialmente posta.
La finzione della personificazione e la rappresentazione politica
Il discorso appena svolto ci introduce infine all’analisi dei modi e delle caratteristiche di
quel particolare tipo di rappresentazione giuridica che fonda lo stato civile, ovvero la
rappresentazione politica286.
Nel prosieguo del capitolo sedicesimo del Leviathan si trovano gli estremi di un
singolare meccanismo di autorizzazione, che però si rivelerà poi essere a sua volta
fondamento di ogni altro patto di rappresentanza, in una sintomatica circolarità che lega
insieme diritto e potere.
L’intento è creare qui quell’assetto pubblico che avevamo visto essere condizione del
riconoscimento della persona giuridica: una questione che viene tenacemente inserita in
un orizzonte che, paradossalmente, la richiede come presupposto.
286
Seguiamo qui la tesi sostenuta da Y. C. Zarka, op. cit., cap. IX.
206
La rappresentanza politica è così chiamata a istaurare un ordine che ricomponga su un
piano più alto, del tutto artificiale e indeducibile, quell’unità tra volontà e azioni che lo
stato di natura aveva dimostrato essere inattuabile in solitario, e che il concetto di
persona aveva funzionalmente scisso in seno all’identità empirico-meccanica degli
uomini: ad essa viene chiesta, quindi, la formazione di quel macro-soggetto287, ovvero di
quella colossale e irrevocabile persona artificiale che è il Leviatano.
In tutto questo, si tenga fermo quanto accennato nel paragrafo precedente: il carattere
riconosciuto da Hobbes come interamente convenzionale del sistema di definizioni qui
all’opera, impedisce che l’individuo venga assorbito definitivamente nella “superiore
persona dello Stato”, ovvero che “l’uomo scompaia dietro la maschera della sua persona
‘giuridica’ ”.
Ciò che viene riconosciuta così è “l’insuperabilità della tensione fra dato naturale e
artificio, fra fatto e norma”288.
Rimaniamo però nei limiti dell’argomentazione in questo luogo seguita da Hobbes.
Nel margine di differenza e distanza stabilito tra persona giuridica ed individuo fisico
può aver luogo una circostanza specifica (ed è proprio quella in cui si troverebbero gli
uomini se intendessero farsi insieme artefici del commonwealth!) in cui gli autori del
287
288
Cfr. C. Galli, Spazi Politici, Bologna 2001, p. 44.
A. Amendola, op. cit., p. 220.
207
mandato sono più individui: ma come può una moltitudine di uomini diventare una
persona?
A multitude of men, are made one person, when they are by one man,
or one person, represented; so that it be done with the consent of
everyone of that multitude in particular. For is the unity of the
representer, not the unity of the represented, that maketh the person
one. And it is the representer that beareth the person, and but one
person: and unity, cannot otherwise be understood in multitude289.
Se una molteplicità di uomini viene rappresentata da un’unica persona, allora essa
diviene un’unità: ciò è possibile perché l’idea dell’unicità della persona è una nozione
giuridica, sganciata dal piano naturale in cui vi è l’esistenza esclusiva delle singolarità
materiali; essa fa parte, dunque, di un sistema categoriale secondo, che opera nella
natura (in questo caso, specificamente in quella umana) perfezionandola mediante veri e
propri strumenti concettuali che, come proprio delle finzioni linguistiche, raggruppano e
unificano il molteplice disperso.
In questo modo, dice testualmente l’inglese, qualora il rappresentante della moltitudine
sia un uomo o una persona, essa si farà una. Ma ancora, come può ciò concretamente
accadere?
289
Lev. p. 82.
208
La risposta di Hobbes è pregnante: ciò avviene mediante l’autorizzazione di quel
rappresentante da parte di ogni singolo individuo; il fattore che determina l’unitarietà
della persona fittizia è il consenso solidale e unidirezionale della moltitudine a favore di
un medesimo attore.
Eppure, detto sinteticamente, se la moltitudine (che in verità sembra essere qualcosa di
più caotico e informe che la semplice molteplicità) è concorde, allora essa, dapprima,
non era più tale.
In una prospettiva genetica la circolarità del ragionamento è già qui evidente, perché ciò
che viene a mancare è il primum della costruzione.
La questione muta secondo un’angolatura artificialista, che vede postulati insieme, in
forza di una strenua ricerca di ordine, pluralità e unità, in un complesso e delicato gioco
di specchi, che mira a strutturare le condizioni di possibilità dello stato civile: un intento
teorico che non potrà che assumere la forma di una efficace tautologia290.
Seguiamo ancora, tenendo a mente questi aspetti, il discorso hobbesiano:
And because the multitude naturally is not one, but many; they cannot be
understood for one; but in any authors, of every thing their representative
saith, or doth in their name; every man giving their common representer,
authority from himself in particular; and owning all the actions the representer
doth, in case they give him the authority without stint: otherwise, when they
290
Cfr. C.Galli, cit., p. 91.
209
limit him in what, and how far he shall represent them, none of them owneth
more, tha they gave him commission to act291.
L’artificio giuridico non può non fare i conti con la natura: per questo, esso dovrà
considerare ogni singolo individualmente, identificando ognuno di essi come (ci sia
concesso il gioco di parole) un autore autorizzante la propria particolare autorità.
Il meccanismo compie un movimento retroattivo sul rappresentato che si fa manifesto
con la descrizione dei tipi di autorizzazione, e mette in primo piano il ruolo del
riconoscimento di titolarità: su questo elemento dinamico fa perno l’individuazione dello
spazio e del tempo in cui l’autore è appunto tale.
Nel mandato illimitato ciascun individuo riconoscerà come proprie tutte le azioni
compiute dal rappresentante, e quindi egli non potrà che considerarsi rappresentato in
futuro e per sempre dal rappresentante; nel mandato condizionato, invece, il vincolo
della personificazione sussisterà nei limiti del contenuto stabilito e cesserà nel momento
in cui esso venga messo in atto.
L’attenzione cade ora, di nuovo, sull’unità del rappresentante: quando egli è un uomo la
questione, possiamo così dire, non rappresenta un problema, perché l’unicità che egli è
chiamato a rappresentare non differisce dalla sua identità psico-fisica e, quindi, l’ambito
complessivo delle sue azioni rappresenterà unitariamente gli autori.
È il caso della monarchia, dove il re stesso, da solo, incarna la persona fittizia.
291
Lev. p. 82.
210
L’eventualità in cui il rappresentante non sia un individuo, ma molti, complica la
questione e richiede all’argomentazione di valersi di nuovi elementi.
Indicare il modo in cui si produce l’unità di questo tipo di attore, occuperà Hobbes nei
successivi tre paragrafi del testo.
Il fattore che indefettibilmente sigilla l’unità rappresentativa di un insieme di uomini è la
vox partis majoris.
Seguendo un ragionamento di semplice annullamento matematico, possibile solo in un
estimo di completa uguaglianza dei componenti, sarà la voce della maggioranza l’unica
in grado di neutralizzare le voci dell’opposizione e farsi poi sentire, decretando l’azione
da
compiere,
grazie
al
suo
plus
quantitativo,
ossia
alla
sua
“eccedenza
incontrovertibile”292.
Ora, perché una maggioranza vi sia, è necessario che il rappresentante sia composto da
un numero dispari di uomini: nel caso contrario, l’attore risulterà frequentemente muto e
inutile, visto che tra un numero pari di voci contrarie non ci sarà che un’annichilazione.
Medesimi gli effetti se, all’interno del rappresentante, viene riconosciuto a qualcuno dei
membri la prerogativa di veto (il diritto della “voce negativa”293): egli avrà il potere,
orientato dalle sue opinioni e dai suoi interessi, di zittire le altre voci, rendendo
anch’esso l’attore muto ed inabile.
292
293
F. Toennies, op. cit., cap. VIII, par. 4.
Cfr. Lev. I, cap. XVI, p. 17.
211
In questo preciso frangente ci sembra in definitiva emergere con particolare potenza quel
nesso parole-azioni, instancabilmente riportato nel testo, che lega indissolubilmente la
capacità di agire alla capacità dichiarativa: ciò è massimamente evidente laddove la
deliberazione viene messa in scena da una concreta pluralità di voci tenuta a decidere.
Un aspetto non del tutto pacifico va tuttavia segnalato in margine: il discorso sul
principio di maggioranza che viene qui sviluppato sembra riferirsi al caso di un mandato
illimitato, perché ciò con cui il rappresentante è alle prese è la decisione riguardo ad
un’azione, che, in caso di commissione condizionata, è riposta nella volontà dell’autore.
Concludiamo in ogni caso abbracciando quanto segue: “l’obbiettivo della teoria della
rappresentazione è questo: offrire i mezzi giuridici per pensare il passaggio da una
molteplicità di individui singolari all’unità della persona giuridica”294.
In questo senso essa realizza lo scopo, indicato in apertura al capitolo, di offrire un
nuovo sistema di categorie che funga da ossatura nella costruzione del corpo dello Stato.
Questo nuovo, complesso e potente impianto logico è la pietra miliare del processo di
“giuridificazione del potere”295 all’opera nella teoria hobbesiana; ma proprio tale potere
è richiesto in grado assoluto in seno ad un meccanismo di autorizzazione che necessita,
per essere stabile ed efficace, di un’istanza suprema in grado di garantire le obbligazioni
che da esso conseguono.
Come abbiamo tentato di dimostrare, quest’ultima sarà in grado di realizzare tale
obbiettivo soltanto seguendo il principio-cardine dell’equità.
294
295
Y. C. Zarka, cit.
C. Galli, op. cit., p. 93.
212
BIBLIOGRAFIA
Testi di Thomas Hobbes
The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury, ed. W. Molesworth, 11 vols.,
London 1839-45.
Opera philosophica, quae latine scripsit, omnia, 2 vols., Amsterdam 1668.
The Clarendon Edition of the Works of Thomas Hobbes, Oxford 1983Leviathan, ed. C. B. Macpherson, Harmodsworth 1968.
Opere Politiche, a c. di N. Bobbio, Torino 1959.
Elementi di Filosofia. Il corpo – L’uomo, a c. di A. Negri, Torino 1972.
Leviatano, a c. di Arrigo Pacchi, Roma-Bari 1989.
Testi di altri autori
A.A.V.V., Digesto (Corpus Iuris Civilis) Lion 1558-1560.
Aristotele, Etica Nicomachea, Roma-Bari 1999.
Aristotele Retorica, Milano 1996.
Aubrey, Brief Lives, Oxford 1898, tr. it. Vite brevi di uomini illustri, Milano 1989.
W. Blackstone, Commentaries on the laws of England, London 1793-1795.
W. Camden, Britannia, London 1585.
E. Coke, The First Part of the Institutes of the Laws of England, or, a Commentary upon
Littleton, London 1794.
E. Coke, The institutes of the laws of England, London 1832.
E. Coke, The reports of Edward Coke, Dublin 1793.
E. Coke, Le Qvart Part des Reports del Edward Coke, London, 1604.
F. J. Fisher (a cura di), The State of England Anno Dom. 1600 by Thomas Wilson,
Cambridge 1936.
R. FitzNeal, Dialogus de Scaccario, and Costitutio Domus Regis: The Dialogue of the
Exchequer, and The Establishment of the Royal Household, E. Amt, S. D. Church (a
cura di), New York 2007.
J. Fortescue, The governance of England, Genova 2001.
J. Gerson, Opera Omnia, Anvers 1706.
213
M. Hale, The History of the Common Law of England, Chicago 1971.
M. Hale, The Prerogatives of the King, London 1975.
R. Hooker, Of the Laws of Ecclesistical Polity, in The Folger Library Edition of the
Works of Richard Hooker, vols. 1-3. Cambridge 1977.
W. Lambarde, Archeion, or, A discourse Upon the High Courts of Justice in England,
London 1635.
W. Lambarde, Perambulation of Kent: containing the description, Hystorie, and
Custumes of that Shyre, London 1576.
J. Milton, Aeropagitica, in S. Orgel, J. Goldberg (a cura di), John Milton. The Major
Works, Oxford 2003.
Th. More, Utopia, Leuven 1516.
Ch. Saint-German, Saint-Germans doctor and student, London 1975.
J. Selden, Opera Omnia, London 1726.
J. Selden, Table Talk, London 1927.
W. Shakespeare, Tutte le opere, Firenze 1964.
S. Tommaso, Summa Theologica,Torino 2010.
Studi critici sul pensiero di Thomas Hobbes
A. Amendola, Il Sovrano e la Maschera, Napoli 1998.
Angoulvent A. L., Hobbes ou la crise de l'Etat baroque, Paris 1992.
Ascarelli T., Hobbes e Leibniz e la dogmatica giuridica, in T. Hobbes - G. W. Leibniz, A
Dialogue between a philosopher and a student of the Common Laws of England Specimen quaestionum philosophicarum ex iure collectarum, Milano 1960.
Bermbach U., Kodalle K. M. (Hrsg.), Furcht und Freiheit: Leviathan - Diskussion 300
Jahre nach Thomas Hobbes, Opladen 1982.
Biral A., Hobbes: la società senza governo, in G. Duso (a cura di) Il contratto sociale
nella filosofia politica moderna, Milano 1998.
Brandt R., Der Autor des Leviathan und das Recht gegen den Staat, in Bermbach U.,
Kodalle K. M. (Hrsg.)1982.
Donati B., Il rispetto della legge dinanzi al principio di autorità: critica alla filosofia
civile di Hobbes, Roma 1919.
Euchner W., Auctoritas non veritas facit legem? Zur Abgrenzung von Politik und NichtPolitik bei Thomas Hobbes, in Bermbach U., Kodalle K. M. (Hrsg.)1982.
Ewin R. E., Virtues and rights: the moral philosophy of Thomas Hobbes, Boulder 1991.
214
Finkelstein C. (ed.), Hobbes on law, Ashgate 2005.
Foisneau L., Hobbes e la motivazione della volontà, in Adorno P. F., Foisneau L. (a cura
di) 2002.
Goyard-Fabre S., Le droit et la loi dans la philosophie de Thomas Hobbes, Paris 1975.
Goyard-Fabre S., The metamorphosis of the idea of right in Thomas Hobbes’s
philosophy, in Walton C., Johnson P. J. (ed.) 1987.
Hampton J., Hobbes and the social contract tradition, Cambridge 1986.
Hill Ch., Thomas Hobbes and the Revolution, in Puritanism and Revolution: Studies in
Interpretation of English Revolution of the17th Century, New York 1997.
F. Izzo, Forme della modernità, Roma-Bari 2005.
Jaume L., Hobbes et l'Etat représentatif moderne, Paris 1986.
King P., Thomas Hobbes: critical assessments, 4 voll., London-New York, 1993.
Kodalle K. M., Thomas Hobbes: Logik der Herrschaft und Vernunft des Friedens,
Munich 1972.
Loche A. M., Diritto e legge in Hobbes, in Solinas G., et al. 1978.
Ludwig B., Thomas Hobbes: Recht, Unrecht und die Selbstverpflichtung des Menschen,
in Beckermann A., Perler D. (éds.), Klassiker der Philosophie heute, Stuttgart 2004.
Magri, T., Saggio su Thomas Hobbes, Milano 1982.
May L., Hobbes on Equity and Justice, in C. Walton, P. J. Johnson (a cura di), Hobbes’s
‘Science of Natural Justice’, Dordrecht 1987.
Oakeshott M., Hobbes on civil association, Los Angeles 1975.
Omaggio V., Justus metus. Etica e diritto in Thomas Hobbes, Napoli 2000.
Pacchi A., Convenzione e ipotesi nella formazione della filosofia naturale di Thomas
Hobbes, Firenze 1965.
Pasquino P., Thomas Hobbes, Milano 1994.
Zagorin P., Hobbes and the Law of Nature, Princeton-Oxford, 2009.
Reale M., La difficile eguaglianza, Roma 1981.
Rhonheimer D., Das Recht des hilflosen Lebens: Zum Zusammenhang von
Menschrechten, Existenzrecht, Rechtfähigkeit und Rechtsstaat, in Müller-Schmid P. P.
(Hrsg.)1986.
Roux L., Tricaud F., Le pouvoir et le droit. Hobbes et les fondaments de la Loi, Saint
Etienne 1992.
215
Schmitt C., Scritti su Thomas Hobbes, Milano 1986.
Skinner Q., Hobbes and Republican Liberty, Cambridge 2008.
Skinner Q., Visions of Politics, vol. III, Cambridge 2001.
Sorgi G. (a cura di), Hobbes e la fondazione della politica moderna, Milano 1999.
Tonnies F., Hobbes. Leben und Lehre, Stuttgart, 1896.
Tuck R., Hobbes, Oxford 1998.
Van Der Bend J. G. (ed.), Hobbes: His view of man, Amsterdam 1982.
Viola F., Behemoth o Leviathan? Diritto e obbligo nel pensiero di Hobbes, Milano 1979.
Walton C., Johnson P. J. (ed.), Hobbes’s ‘science of natural justice’, Dordrecht 1987.
Y.C. Zarka, Hobbes et la pensée politique moderne, Paris 1995.
Studi di carattere generale
B. Accarino, Rappresentanza, Bologna 1999.
Adorno P. F., L. Foisneau L., L’efficacia della volontà nel XVI e XVII secolo, Roma
2002.
Armellini S., Saggi sulla premialità del diritto nell’età moderna, Roma 1976.
Ascheri M., Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle
fonti giuridiche, Rimini 1991.
Ascheri M, Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo, Torino 20082.
Berman H. J., Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition,
Cambridge 1983, tr. it., Diritto e Rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica
occidentale, Bologna 1998.
Berman H. J., Law and Revolution II. The Impact of the Protestant Reformations on the
Western Legal Tradition, London 2003, tr. it. Diritto e Rivoluzione II. L’impatto delle
riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale, Bologna 2010.
Bloch M., La société féodale, Paris 1939-40, tr. it. La società feudale, Torino 1974.
Bloch M., Seigneurie française et manoir anglais, Paris 1960, tr. it. Signoria francese e
maniero inglese. Lezioni sulla proprietà fondiaria in Francia e in Inghilterra, Milano
1980.
Bridgen S., New World, Lost Worlds. The Rule of the Tudors, 1485-1603, London 2000,
tr. it. Alle origini dell’Inghilterra moderna. L’età dei Tudor 1485-1603, Bologna 2003.
Brunner O., Per una nuova storia costituzionale e sociale, Milano 2000.
216
Calasso F., I glossatori e la teoria della sovranità: studio di diritto comune pubblico,
Firenze 1945.
Calasso F., Medioevo del diritto, Milano 1954.
Carlyle R. W. e A., Il pensiero politico medievale, Roma 1956.
Carozzi C., Le monarchie feudali: Francia e Inghilterra, in N. Tranfaglia e M. N. Firpo
(diretta da), La Storia: i grandi problemi dal Medioevo all’età contemporanea, Torino
1986.
Cromartie A, Sir Matthew Hale 1609-1676. Law, religion and natural philosophy,
Cambridge 1995.
Curtis M. H., The alienated intellectuals of Early Stuart England, in T. Aston (a cura di),
Crisis in Europe 1560-1660, London 1965, tr. it. in Crisi in Europa 1560-1660. Saggi di
Past and Present, Napoli 1968.
Dahlman C. J., The open field system and beyond, Cambridge 1980.
Davies R., The Isles: A History, London 1999 , tr. it. Isole. Storia dell’Inghilterra, della
Scozia, del Galles e del Irlanda, Milano 2004.
De Benedictis A., Politica, governo e istituzioni nell’Europa moderna, Bologna 2001.
Dumont L., Saggi sull’individualismo, Milano 1993.
Duso G., Il potere : per la storia della filosofia politica moderna, Roma 1999.
Duso G., (a cura di), Il contratto sociale nella filosofia politica moderna, Milano 1998.
Fossier R., The rural economy and demographic growth, in Luscombe D., Riley-Smith
J., The New Cambridge Medieval History, vol. IV, p. I, Cambridge 2004.
Friedrich C. J., The philosophy of law in historical perspective, Chicago 1958.
C.Galli, Spazi Politici, Bologna 2001.
Garavaglia G., Storia dell’Inghilterra Moderna. Società, economia e istituzioni da
Enrico VII alla Rivoluzione industriale, Bologna 1998.
Giarrizzo G., Il pensiero inglese nell’età dei Tudor, in L. Firpo (diretta da), Storia delle
dottrine politiche, economiche e sociali, vol. III, Torino 1987.
Giarrizzo G., Il pensiero inglese nell’età degli Stuart e della Rivoluzione, in L. Firpo
(diretta da), Storia delle dottrine politiche, economiche e sociali, vol. IV, Tomo Primo,
Torino 1980.
Golsworthy J., The Sovereignty of Parliament: History and Philosophy, Oxford 1999.
Gough J. W., Il contratto sociale: storia critica di una teoria, Bologna 1986.
Grossi P., L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, 20084.
217
Hill Ch. (a cura di), Saggi sulla rivoluzione inglese, Milano 1957.
Hill Ch., The Intellectual Origins of English Revolution, Oxford 1965.
Hofmann H., Introduzione alla filosofia del diritto e della politica, Roma 2003.
Hoffman H., Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità
all'Ottocento, Milano 2007.
Ilting K. H., Naturrecht und Sittlichkeit. Begriffsgeschichtliche Studien, Stuttgart 1983.
Loos F., Schreiber H. L., “Recht und Gerechtigkeit”, in Brunner O., Conze W., E.
Kantorowicz H., The King’s Two Bodies. A study in Medieval Political Theology,
Princeton 1957, tr. it. I due Corpi del Re, Torino 1989.
Kishlansky M., A Monarchy Transformed. Britain 1603-1714, London 1996, tr. it. L’età
degli Stuart. L’Inghilterra dal 1603 al 1714, Bologna 1999.
Koselleck R. (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Band 5, Stuttgart 1984. Lobban M.,
8: A History of the Philosophy of Law in the Common Law World, 1600-1900, in E.
Pattaro (ed.), A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence, Dodrecht
2007.
Lupoi M., Alle radici del mondo giuridico europeo : saggio storico-comparativo, Roma
1994.
Malanima P., Uomini, risorse, tecniche nell’economia europea dal X al XIX secolo,
Milano 2003.
Mazzarino S., La fine del mondo antico, Torino 2008.
MacCulloch D., Reformation. Europe’s House Divided, 1490-1700, London 2003, tr. it.,
Riforma. La divisione della casa comune europea 1490-1700, Roma 2010.
Macpherson C. B., The Political Theory of Possessive Individualism, Oxford 1962.
Momigliano A., Studies in Historiography, New York 1966.
Müller-Schmid P. P. (Hrsg.), Begründung der Menschenrechte, Stuttgrat 1986.
J. E. Neale, The Elizabethan Political Scene, in “Proceedings of the British Academy”,
1948 (tr. it. in E. Rotelli e P. Schiera, Lo Stato Moderno, II: Principi e ceti, Bologna
1971).
Passerin d’Entrèves A, La dottrina del diritto naturale, Milano 1980.
Passerin d’Entrèves A., Saggi di storia del pensiero politico, Milano 1992.
Pitkin H., The concept of Representation, Berkeley 1967.
G. Preterossi, Autorità., Bologna 2002.
Prodi P. , Una storia della giustizia, Bologna 2000.
218
Radbruch G., Der Geist des englischen Rechts, Gottingen 1958, tr. it. Lo spirito del
diritto inglese, Milano 1962.
Rawls J., Lezioni di storia della filosofia politica, Milano 2009.
Richardson H. G. e Sayles G. O., The Governance of Medieval England from the
Conquest to Magna Carta, Edimburgo 1963.
Sheridan L. A., Equity, London 1969.
Solinas G., et al., Studi di filosofia e storia della cultura, Sassari 1978.
Steinvorth U. , Stationen der politischen Theorie, Stuttgart 1981.
Stolleis M., Stato e ragion di stato nella prima età moderna, Bologna 1998.
Tawney R. H., Religion and the Rise of Capitalism, New York 1926.
B. Tierney, The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural Law and
Church Law, 1150-1625, Atlanta 1997, tr. it., L’idea dei diritti naturali. Diritti naturali,
legge naturale e diritto canonico 1150-1625, Bologna 2002.
Tronti M. (a cura di), Stato e Rivoluzione in Inghilterra, Milano 1977.
Tuck R., Natural rights theories : their origin and development, Cambridge 1979.
E. M. W. Tillyard, The Elizabethan World Picture, London 1943
Ullmann W., Principles of Government and Politics in the Middle Ages, London 1961,
tr. it. Principi di governo e politica nel Medioevo, Bologna 1982.
Van Caenegem R.C., European Law in the Past and the Future, Cambridge 2002, tr. it. I
sistemi giuridici europei, Bologna 2003.
Walzer M., The Revolution of the Saints: A Study in the Origins of Radical Politics,
Harvard 1982.
Welzel H., Diritto naturale e giustizia materiale, Milano 1965.
Zarka Y. Ch., La questione del fondamento nelle dottrine moderne del diritto naturale,
Napoli 2000.
Zarka Y. Ch., L'altra via della soggettività: la questione del soggetto e il diritto naturale
nel 17. secolo, Milano 2002.
Testi di carattere generale sul diritto inglese
Baker J. H., An Introduction to English Legal History, London 1979.
Bemont C., Chartres des libertés anglaises, Paris 1892.
Blackstone W., Commentaries on the Laws of England in Four Books, Philadelphia,
1893.
219
Burgess G., The politics of the ancient constitution: an introduction to English political
thought, 1603-1642, Pennsylvania 1993.
Costantini C., La legge e il tempio. Storia comparata della giustizia inglese, Roma 2007.
Dawson J. P., The Oracles of the Law, Westport 1968.
Giarrizzo G., COURT vs COUNTRY: la società dell’Europa barocca, in G. Nocera (a
cura di), Il segno barocco: testo e metafora di una civiltà, Roma 1983.
Gough J. W., Fundamental Law in English Constitutional History, London 1955.
Guy J. A., Thomas More and Christopher St. German: The Battle of the Books, in A.
Fox e J. A. Guy (a cura di), Reassessing the Henrician Age: Humanism, Politics and
Reform 1500-1550, Oxford 1986.
Holdsworth W. S., A History of English Law, London 1922-52.
Maitland F. W., A historical sketch of liberty and equality : as ideals of English political
philosophy from the time of Hobbes to the time of Coleridge, Indianapolis 2000.
Maitland F. W., The Forms of Actions at Common Law, Cambridge 1948.
Manning B., The Nobles, the People and the Constitution, in T. Aston (a cura di), Crisis
in Europe 1560-1660, London 1965, tr. it. in Crisi in Europa 1560-1660. Saggi di Past
and Present, Napoli 1968.
Map W., De Nugis Curialium, (a cura di M. R. James), Oxford 1914.
Mattei U., Il Modello di Common Law, Torino 2010.
Matteucci N., Costituzionalisti inglesi, Bologna 1962.
McIllwain H., Costitutionalism: Ancient and Modern, New York 1947, tr. it.
Costituzionalismo antico e moderno, Bologna 1990.
McIlwain Ch. H.(a cura di), The Political Works of James I, London 1918.
McKechnie W. S., Magna Carta: A Commentary on the Great Charter of King John,
with an Historical Introduction, Glasgow 1914.
Laviosa G., La filosofia scientifica del diritto in Inghilterra, Torino 1897.
Plucknett T. F. T., A concise history of the common law, Boston 1956.
Plucknett T. F. T., Barton J. L. (a cura di), St. German’s Doctor and Student, London
1974.
Pocock J. G. A., The ancient constitution and the feudal law: a study of English
historical thought in the seventeenth century: a reissue with retrospect, Cambridge
1957.
Pollock F., Maitland F. W., The History of English Law Before the Time of Edward I,
vol. I, New Jersey 2008.
220
Ritter G. A., «Divine right» und Präerogative der englischen Könige 1603-1640, in
“Historische Zeitschrift”, 1963, tr. it. in E. Rotelli e P. Schiera, Lo Stato Moderno, III:
Accentramento e Rivolte, Bologna 1974.
Smith G. H., A Critical history of Modern English Jurisprudence: a study in Logic,
Politics and Morality, San Francisco 1893.
Stubbs W., The Constitutional History of England, Oxford 1929.
Sumner Maine H., Dissertations on Early Law and Customs, London 1981.
Vinogradoff P., Magna Carta, Clause 39, in Malden H. E. (a cura di), Magna Carta.
Commemoration Essays, London 1917.
Vinogradoff P., Reason and Conscience in Sixteenth-century Jurisprudence in The
Collected Papers of Paul Vinogradoff, London 19642
Wormuth F. D., The Royal Prerogative 1603-1649. A Study in English Political and
Constitutional Ideas, Ithaca 1939.
Articoli
Aranda Fraga F., La teoría de la justicia en el estado natural y en el estado político,
según Hobbes, in “Pensamiento”, 61, 229, 2005, pp. 95-116.
Aymler G. E., Attempts at Administrative Reform 1625-1640, in “English Historical
Review”, vol. 72, n. 283, 1957, tr. it. in E. Rotelli e P. Schiera, Lo Stato Moderno, III:
Accentramento e Rivolte, Bologna 1974.
Baker H. J., The Common Lawyers and the Chancery: 1616, in “The Irish Jurist”, IV,
1969.
Barnow J., Reason as Reckoning: Hobbes’s Natural Law as Right Reason, in “Hobbes
Studies”, vol. XXI, 2008, pp. 38-62.
Bellussi G., Considerazioni sul naturalismo di Thomas Hobbes, in “Rivista
internazionale di Filosofia del diritto”, XXXIX, 1962, pp. 717-744.
Botwinick A., Hobbes’s concept of Law and Representation : some reflections on Past
and Future, in “Journal of social philosophy”, 14, 1983, pp. 34-51.
Campbell E., Thomas Hobbes and the Common Law, in “Tasmanian University Law
review”, 1, 1958, pp. 20-45.
Cromartie A., The Constitutionalist Revolution: The Transformation of Political Culture
in Early Stuart England, in “Past and Present”, n. 163, 1999.
Curran E., Hobbes’s’ theory of rights – A modern interest theory, in “The Journal of
Ethics”, 6, 1, 2002, pp. 63-86.
Farrel D. M., Reason and Right in Hobbes’ Leviathan, in “History of Philosophy
Quarterly”, 1, 1984, pp. 297-314.
221
Foisneau L. e Sorell T., Hobbes et les néocontractualismes contemporaines, in “Les
études philosophiques”, 4, 2006.
L. Foisneau, "Souveraineté et animalité. Agamben lecteur de Hobbes", in Th. Gontier,
Animal et animalité dans la philosophie de la Renaissance et de l’age classique,
Louvaine-la-Neuve, 2005.
Gary D. G., Inalienable Rights and Positive Government in the Modern World, in “The
Journal of politics”, 41, 4, 1979, pp. 1057-1080.
Goldschmidt V., Les renversements du concept d’egalité des Anciens aux Modernes, in
“Archives de philosophie du droit”, t. XVII, 1972.
Goyard-Fabre S., Les effets juridiques de la politique mécaniste de Hobbes, in “Revue
philosophique”, 2, 1981, pp. 189-211.
Grover, R. A., The Legal Origins of Thomas Hobbes’s Doctrine of Contract, in “Journal
of the History of Philosophy”, 18, 2, pp. 177-194.
Hanna R., Persons and Personation in Hobbes’s’ Leviathan, in “Southern Journal of
Philosophy”, 21, 2, 1983, pp. 171-192.
Hofmann H., Zur Lehre vom Naturzustand in der Rechtphilosophie der Aufklärung, in
“Rechtstheorie”, 13, 1982, pp. 226-252.
Kronman A., The concept of an Author and the Unity of the Commonwealth in Hobbes’s
Leviathan, in “Journal of the History of Philosophy”, XVIII, 2,1980, pp. 159-175.
Ladenson R. F., In Defense of a Hobbesian Conception of Law, in “Philosophy an Public
Affairs”, 9, 2, 1980, pp.134-159.
Ollero A., Hobbes y la interpretaciòn del Derecho, in “Rivista internazionale di
Filosofia del Diritto”, 54, 1977, pp. 45-67.
F. Pollock, Sir Matthew Hale on Hobbes: An Unpublished Ms, in “Law Quarterly
Review”, 37, 1921.
Singer M. G., Rights, Duties and Justice in Hobbes, in “Philosophy Research Archives”,
vol. 6, n° 1417, 1980.
Thomas G. W., James I, Equity and Lord Keeper John Williams, in “The English
Historical Review”, v. 91, n. 360, 1976.
Ventura M., Diritto canonico e diritti comuni in Europa. «Common Law» e «ius
commune» in due comparazioni, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 2, 1993.
Viola F., Riflessioni sulla metamorfosi del concetto di autorità, in “Revue européenne
des sciences sociales”, 61, 1982, pp. 63-87.
Yale D. E. C., Hobbes and Hale on Law, Legislation and the Sovereign, in “Cambridge
Law Journal”, 31, 1972.
222