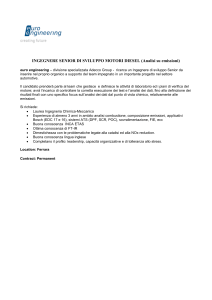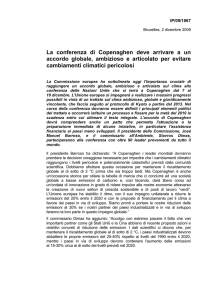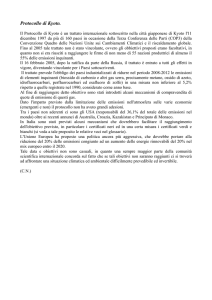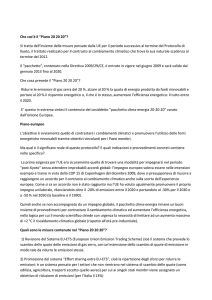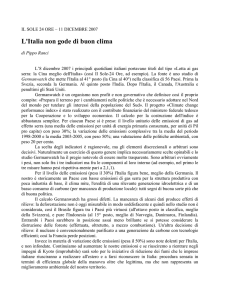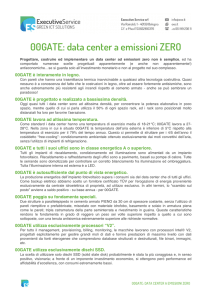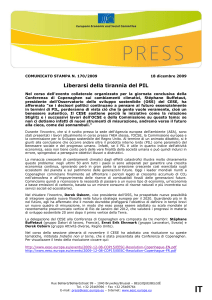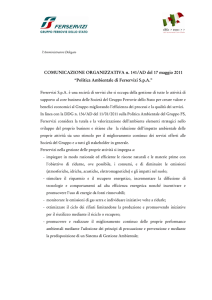Copenaghen e il nuovo ordine mondiale
Umberto Bertelè
21/12/2009
L’accordo raggiunto al termine della conferenza di Copenaghen sul clima può
essere giudicato deludente per diverse ragioni. Lo conferma il fatto che le
Nazioni Unite, organizzatrici del summit, hanno scelto di prendere nota
dell’accordo di Copenaghen, invece che di approvarlo formalmente, e di lasciare
quindi la decisione sull’adesione ai singoli paesi. Ciò è avvenuto dopo che
l’Unione europea, estremamente delusa per i risultati di una conferenza su cui
aveva scommesso molto e probabilmente umiliata per l’esclusione dai colloqui
conclusivi, ha accettato l’accordo in ritardo e con riluttanza.
Anche una serie di paesi in via di sviluppo, capeggiati da Venezuela e Bolivia, si sono rifiutati di
sottoscrivere l’accordo a causa della vaghezza delle promesse di aiuto finanziario e tecnologico da parte
dei paesi più ricchi.
La lista dei punti dove Copenaghen ha fallito può essere sintetizzata rapidamente:
- l’accordo cui si è arrivati, anche se fosse sottoscritto da tutti i paesi, non è legalmente vincolante: i
paesi esprimono cioè delle intenzioni, ma non si impegnano formalmente a rispettarle;
- l’accordo non prevede controlli (soprattutto per la ferma opposizione della Cina): con la conseguenza
che molti paesi, e tra questi forse gli stessi Stati Uniti, avranno difficoltà a far accettare al loro interno
misure ambientali potenzialmente dannose per la competitività mondiale delle proprie imprese;
- l’accordo esprime in maniera vaga l’obiettivo da conseguire entro il 2050 - “non più di due gradi di
aumento della temperatura rispetto all’era preindustriale” invece che “dimezzare le emissioni dei gasserra” - e non stabilisce alcun obiettivo intermedio (ad esempio al 2020) che funga da momento di
verifica dello stato di avanzamento;
- l’accordo parla di un impegno dei paesi ricchi a iniziare a corrispondere a quelli più poveri - prima del
2020 - una cifra complessiva annua dell’ordine dei 100 miliardi di dollari, ma è molto vago sulle modalità
con cui questi soldi potranno essere reperiti.
Impegni da mantenere
Rimangono le promesse della vigilia. Gli Stati Uniti si sono impegnati (anche se l’American Clean Energy
and Security Act (Aces), approvato sul filo di lana dalla Camera, giace senza grandi prospettive al
Senato) a ridurre le emissioni dei gas-serra del 17 per cento entro il 2020, ma assumendo come base il
livello di emissioni del 2005 invece di quello del 1990, cui faceva riferimento il protocollo di Kyoto. Per
questo gli Usa sono stati accusati di scorrettezza dagli europei, in quanto la riduzione - riportata al 1990 sarebbe solo del 4 per cento.
L’Unione europea si è impegnata formalmente (a differenza degli Stati Uniti) a ridurre le emissioni del 20
per cento rispetto al 1990: con una controaccusa però da parte degli Stati Uniti che - riportata al 2005 la riduzione sarebbe solo del 13 per cento (contro il loro 17), a causa dei rilevanti miglioramenti nei paesi
est-europei dopo l’uscita dai regimi filosovietici.
La Cina si è impegnata a sua volta a ridurre del 40-45 per cento - entro il 2020 e assumendo come base
il 2005 - l’intensità delle emissioni rispetto al Pil (la cosiddetta carbon-intensity): più di quanto faranno gli
Stati Uniti nello stesso periodo (come da loro evidenziato), ma senza con questo riuscire a bilanciare
l’incremento delle emissioni legato all’elevatissimo tasso di crescita della loro economia.
L’assenza di accordi legalmente vincolanti lascia ampi margini alle lobbies dei comparti potenzialmente
più danneggiati dall’accordo (prima di tutto quelli che hanno a che fare con l’energia di origine fossile) per
cercare di bloccare la formalizzazione degli impegni o per spingere verso una loro dilazione. Queste
lobbies saranno tuttavia contrastate da quelle che invece dall’economia verde hanno tutto da
guadagnare: perché operanti nel settore delle energie alternative (l’energia eolica, l’energia solare nelle
sue diverse configurazioni e l’energia da biomasse) o dell’energia nucleare o dei beni (quali le auto di
nuova concezione) e dei servizi orientati all’efficienza e al risparmio energetico. Si opporranno le aree
industrializzate che più temono la delocalizzazione degli impianti in paesi tolleranti, mentre saranno
favorevoli quelle per cui l’ambiente può rappresentare un fattore di sviluppo. Potranno nascere pericolose
tentazioni di porre limiti al commercio internazionale, in presenza di forti squilibri - fra le diverse aree nei costi imputabili all’ambiente.
Un nuovo patto
Era realistico aspettarsi molto di più? Guardando alle posizioni assunte dai vari paesi all’approssimarsi
della conferenza di Copenaghen, probabilmente no. Così come è poco realistico pensare che a breve si
possa giungere ad un nuovo accordo organico.
Da quando il mondo si è convinto che siano i cosiddetti gas-serra (la maggior parte dei quali originati nei
processi di trasformazione e utilizzo dell’energia) e non la natura i principali responsabili del
riscaldamento terrestre in atto, l’ambiente e l’energia sono diventati la principale risorsa scarsa su scala
globale. Una risorsa intimamente legata allo sviluppo, per cui il rispetto di un tetto alle emissioni globali
potrebbe verificarsi solo a fronte di un patto che stabilisca, in assenza di un governo mondiale, come
distribuire i doveri di ridurre le emissioni e i diritti di far crescere le economie. Soprattutto in un momento
di impetuosa crescita economica di paesi popolosi come la Cina e l’India, rispettivamente al primo e al
quinto posto mondiale nelle emissioni dei gas-serra.
Alcuni paesi - quelli che stanno crescendo e aspirano a un ruolo mondiale più proporzionato alla loro
consistenza economica e demografica, ma anche quelli, come il Venezuela, che aspirano a più potere
grazie al petrolio - hanno usato la conferenza di Copenaghen come occasione per mettere alla corda i
paesi occidentali e puntare a un nuovo ordine internazionale in cui anche la soluzione dei problemi
ambientali non possa fare a meno del loro consenso.
In questo Copenaghen ricorda gli Stati Generali riunitisi a Versailles nel 1789, quando le classi dominanti
del tempo, la nobiltà e il clero, non più in grado di gestire la voragine finanziaria della Francia, dovettero
chiedere al terzo stato - e quindi alla borghesia emergente - di cooperare alla soluzione dei problemi,
dando inizio ad un nuovo assetto dei poteri.
Umberto Bertelè è ordinario di Strategia e sistemi di pianificazione al Politecnico di Milano.