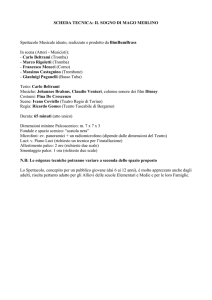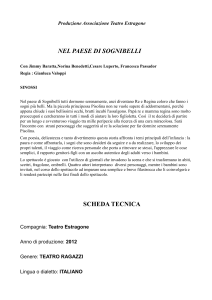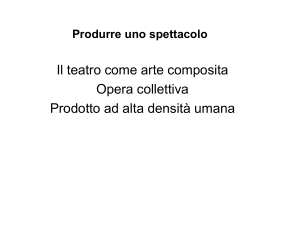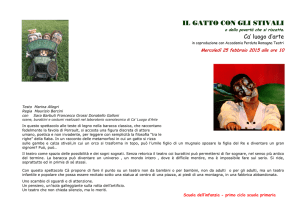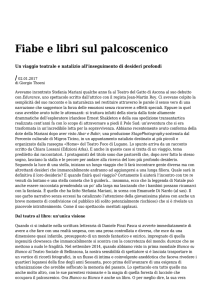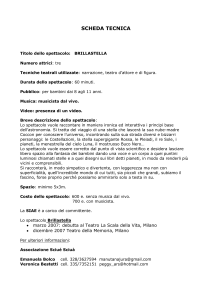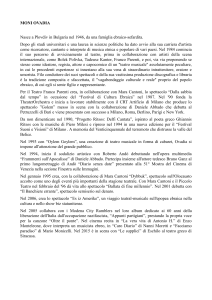1
In scena 2009-2010
NIENTE RESURREZIONI POST-POP, PER FAVORE
Un randomico e assai personale giro d’orizzonte sull’ultima stagione teatrale.
Passando in rassegna “Nel lago dei leoni” dei torinesi Marcido Marcidorjs, la ripresa
di “Bacon” di Enzo Cosimi, “Amleto” secondo il regista Roberto Bacci, “Taking
sides – Processo a Furtwängler” di Ronald Harwood, diretto da Manuela Kustermann,
“Le Nuvole” di Aristofane nella rivisitazione da clownerie colta di Antonio Latella. E
poi “from a to d and back again” dell’amena coppia Daria Deflorian e Antonio
Tagliarini, “Sì, l’ammore no” di Elvira Frosini e Daniele Timpano, altra coppia
metacomica, e infine il ragguardevole “Pornobboy” del gruppo veronese Babilonia
Teatri, incluso nel libro “Iperscene 2” dedicato ai ‘novissimi’ della ricerca teatrale
italica del XXI secolo.
________________________________________________________________________________
di Marco Palladini
Colpi di memoria in ordine (o disordine) sparso su una stagione teatrale (2009-2010) che volge al
termine senza, mi pare, squilli di tromba o travolgenti scoperte. La nostra scena riflette
evidentemente la complessiva mediocrità della situazione generale italica e i tagli alle sovvenzioni
pubbliche – quelli già effettuati e quelli ulteriori, promessi o minacciati – rendono le prospettive
future sempre più grame. Le compagnie sono costrette ad adottare strategie di sopravvivenza
economica che non sono esattamente il miglior viatico all’incremento della creatività e alla volontà
di rischiare su percorsi di ricerca inediti.
► Parto, comunque, per questo randomico e personalissimo giro d’orizzonte teatrale, da un lavoro
visto di recente al teatro Arvalia di Roma: Nel lago dei leoni della formazione torinese Marcido
Marcidorjs e Famosa Mimosa che seguo ormai da un quarto di secolo e, debbo dire, non mi ha mai
veramente deluso, pur negli alti e bassi del suo lungo percorso teatrale. Ciò in forza di una forma
scenico-estetica che non è mai venuta meno, che ha sempre garantito un tasso di riconoscibilità
immediata al gruppo, una sua inconfondibile cifra artistica, sia dal lato interpretativo, sia dal lato
visivo. Quest’ultimo lavoro non apporta novità, ma conferma uno standard espressivo alto nella
teatralizzazione delle “estasi di Maria Maddalena de’ Pazzi”, una suora carmelitana che sul finire
del XVI secolo nel convento di clausura di Santa Maria degli Angeli, sito nel quartiere San
Frediano di Firenze, proruppe in una stupefacente teoria di estasi mistiche che sconvolsero in primis
le sue consorelle. Il regista Marco Isidori è stato conquistato dalla incontinente potenza verbale
delle esternazioni estatiche di Maria Maddalena (al secolo Caterina Lucrezia de’ Pazzi),
cogliendone tutta la dimensione teatrale e fin quasi esibizionistica, e ha quindi elaborato un testo
che ne riprende il flusso logorroico ed esaltato, interpolandolo però con scivolate grottesche, mere
irrisioni, scivolate ludico-infantili, straniamenti di marca brechtiana.
L’epicentro dello spettacolo è però l’interpretazione della bravissima Maria Luisa Abate, di bianco
vestita e costretta su una sorta di sedia metallica di contenzione sospesa su dei fili d’acciaio contro
un candido fondalino, dietro cui di tanto in tanto si affacciano, a far da ironico controcanto
all’invasata santa, tre figurette (Paolo Oricco, Anna Fantozzi e Stefano Re) che agitano simbolici
ventagli e maschere mobili. La scenografia della sempre ispirata Daniela Dal Cin, che richiama
2
anche una sinistra sedia elettrica, fornisce la piattaforma ideale da cui decolla la recitazione ora
singultante, ora canterellata, ora isterica e di testa, ora apertamente parodistica, della Abate che
svaria su una tastiera espressiva larghissima e sempre tenuta perfettamente sotto controllo. È questa
un’attrice tra le migliori in assoluto del nostro teatro (perché dotata di una ben precisa poetica
recitativa) ed è una vergogna, che dopo trent’anni di carriera, non abbia ancora ricevuto un qualche
premio o riconoscimento ufficiale, visto che per solito ne danno ad attrici di gran lunga meno dotate
e significative di lei. Nell’arena del “lago dei leoni”, cioè degli spiriti furiosi che scuotevano la
psiche di Maria Maddalena, la vera unica regale leonessa mi è sembrata lei. Applaudita infine dal
folto pubblico, dove spiccavano numerosi addetti ai lavori, molto, molto a lungo.
► Era da qualche anno che avevo perso di vista Enzo Cosimi, di cui ancora rammento bene il
folgorante debutto nel 1982 con Calore. Lui che è stato per molto tempo una delle più importanti e,
individualmente parlando, più smaglianti espressioni del teatrodanza nostrano, un movimento certo
minoritario e imparagonabile a quelli affermatisi in Germania, in Francia, nei Paesi Bassi o
nell’area anglosassone, ma con diverse figure di sicura qualità.
Mi ha fatto, perciò, assai piacere ritrovarlo questa stagione all’Atelier Meta-Teatro della capitale
con Bacon – punizione per il ribelle, uno spettacolo del 1999, adesso ripreso in una nuova
versione. Un lavoro ispirato alle visioni deformate e deformanti, oniriche-orrorifiche del grande
pittore irlandese Francis Bacon. Cosimi accosta e interpola le immagini stravolte di Bacon con le
suggestioni di un serial killer del primo Novecento: il tedesco Friedrich Harmann, che tra il 1918 e
il 1924 arrivò ad uccidere ventisette persone. Cosimi dà così vita ad un intenso, allucinato percorso
scenico che ha i bagliori dell’incubo, giocando sulle vivide luci radenti di Stefano Pirandello, su
materiali video in bianco e nero, e su una funerea atmosfera dove compaiono neri ombrelli,
maschere mostruose, un sacco da boxe con cui colluttare, e altri oggetti da festino criminale.
Cosimi è solo in scena e la sua performance si esplica in movimenti e gestualità ora lente e
calibrate, ora frenetiche e compulsive. La danza si dà in assenza, il disegno coreutico svolto per
linee orizzontali e diagonali qui si piega ad una mera astanza del corpo teatrico, corpo glorioso e
dannato allo stesso tempo. Una prova felice di un artista maturo che ha perfettamente perimetrato
(un po’ come Danio Manfredini) il suo chiaroscurale mondo omoerotico di riferimento e che nelle
sue uscite soliste raggiunge il diapason della propria poetica.
► Un altro artista di cui non vedevo da molto tempo spettacoli è il regista Roberto Bacci,
fondatore e direttore artistico della Compagnia Laboratorio di Pontedera, nata oltre trent’anni fa e
che è stata per molto tempo il più devoto, strutturato e articolato ensemble italico di seguaci della
linea del “terzo teatro” o teatro antropologico di ascendenza Grotowski-Barba. Assistendo ad una
replica del suo ultimo lavoro Amleto – Nella Carne il Silenzio, mi sono chiesto se sia ancora così.
Ovvero se quella eredità teatrico-culturale e, forse, pure spirituale marchi tuttora una ‘differenza’
negli allestimenti della formazione di Pontedera. Già il fatto che mi ponessi un tale interrogativo è,
evidentemente, la spia che non c’è più una “forma-terzo teatro” riconoscibile, una matrice di segni
teatral-antropologici inconfondibile. Di fatto, questo Amleto di Bacci (ottimo spettacolo, peraltro)
non è distinguibile da tanti altri, più o meno validi, prodotti del corrente teatro di regia critica. Il
tempo delle ideologie è finito, la diversità antropologico-teatrale che si rivendicava era palesemente
legata ad un progetto utopico-politico che si è pressocché dissolto. Sopravvive, credo, la memoria e
la consapevolezza di ciò che si è fatto o provato a fare, ma la teologia scenico-sapienziale di
Grotowski, così come la ricerca spuria, interculturale, ibridata e mitopoietica di Barba, con i loro
rigidi diktat e regole e dure discipline di gruppo risuonano evidentemente allogene ed esogene nel
XXI secolo, come esperienze iper-elitarie nel secolo della moltitudine espansa.
Per venire all’Amleto in questione, il capolavoro shakespeariano qui si configura in uno spazio
scenico ligneo, completamente chiuso, contenente un praticabile mobile multiuso. Indicativamente
siamo in una sala da scherma dove, infatti, sei attori con le bianche divise e le maschere da
schermidori passano il tempo ad incrociare i loro fioretti. L’idea, più che dominante, direi esclusiva
3
della regia, è quella del duello che permea da cima a fondo la tragedia del Bardo. Si scatenano
allora frementi disfide dialettiche, assalti verbali di menti reattive sino al terminale, mortale duello
tra il prence danese e Laerte. Amleto si propone secondo un giovinotto nerovestito e lungocrinito (il
bravo Tazio Torrini) che si muove e si atteggia come una rockstar, esibendo la camicia aperta
sull’aitante petto villoso come un Jim Morrison o un Iggy Pop seicentesco.
Grazie al lavoro di ampio sfrondamento del testo operato dal ‘dramaturg’ Stefano Geraci, ispiratosi
alla riduzione firmata nel 1963 da Gerardo Guerrieri, lo spettacolo corre via veloce, con ritmi
interni schioccanti e neurotici, ma i brani celeberrimi e le parole famose del copione che ciascuno
conosce e ricorda, ci sono tutti e vengono sveltamente, ma incisivamente recitati. Mentre, intanto, si
strascinano vari sacchi di juta che poi si svuotano a terra di foglie secche, e si caprioleggia sopra e
sotto il praticabile, stendendo passerelle come ponti levatoi di un immaginario castello di Elsinore, e
si brandiscono i ‘ferri’ come su una pedana olimpica e si fanno baldanzosamente scintillare le lame.
I sei attori-schermidori (Serena Gatti, Andrea Fiorentini, Francesco Puleo, Debora Mattiello, Luigi
Petrolini, Alessandro Porcu) di volta in volta incarnano Ofelia e la regina Gertrude, l’usurpatore
Claudio e Polonio, lo spettro di Amleto padre e Orazio, Rosencrantz e Guildestern, nonché gli attori
della compagnia dei commedianti coi volti coperti da maschere zoomorfiche, che Hamlet dirige
senza tentennamenti nella sua mirata strategia di disvelamento del complotto che ha portato al
tradimento e al regicidio. Ed è la Carne morente di Amleto che invoca, infine, che si racconti la
verità sulla vicenda e la ragione della sua ‘pazzia’ prima che cali il Silenzio definitivo.
La regia di Bacci funziona benissimo, dando vita ad uno spettacolo ficcante, armonico, senza pause,
teso e pieno di mordente. Ciò che non è facile con un classico messo in scena milioni di volte.
Insomma, se il ‘terzo teatro’ è invecchiato e depassé, il teatro senza aggettivi dimostra che, come
l’araba fenice, è sempre pronto a rinascere dalle proprie ceneri.
► Procedendo di sguincio e a zig-zag nella memoria stagionale, ripesco uno spettacolo firmato in
regia da Manuela Kustermann, che ha assunto la direzione artistica del Vascello di Roma, dopo la
morte lo scorso gennaio di Giancarlo Nanni. Taking sides – Processo a Furtwängler del 76enne
commediografo sudafricano, trapiantato a Londra, Ronald Harwood, è un non eccelso esempio di
drammaturgia giudiziaria intorno al caso del maestro Wilhelm Furtwängler, il più grande direttore
d’orchestra tedesco, rimasto a dirigere imperterrito le predilette musiche di Ludwig van Beethoven
e Anton Bruckner nella Germania nazista fino alla caduta del Terzo Reich.
Harwood costruisce la sua pièce intorno allo scontro tra il maggiore americano Arnold, militare
rozzo e del tutto ignorante di musica, e il sublime musicista che vive come psicologicamente murato
nella sua torre d’avorio. Il primo nella Berlino post-bellica del 1946 cerca, appunto, le prove
giudiziarie che inchiodino Furtwängler al suo ruolo di complice e collaborazionista con il criminale
regime hitleriano; l’altro professa tutta la sua separatezza mentale dalla realtà politica, invoca il
proprio essere sacerdote della religione dell’arte della musica, si appella a ragioni metafisiche
superiori alle miserie della storia. Furtwängler ritiene di servire lo spirito dell’eternità, uno spirito
divino che sovrasta le contingenze del tempo terreno e, dunque, i milioni di morti in guerra, la
Shoah, le aberranti teorie razziste dei gerarchi nazisti, tutto in questa prospettiva diventa
epifenomenico e quasi irrilevante.
Il fatto è che più l’ufficiale yankee si incaponisce e più le prove ‘schiaccianti’ per condannare
Furtwängler non le trova e i due testimomi che riesce a pescare, più che a carico si rivelano in fondo
testi a discarico: il maestro non si è mai iscritto al partito della svastica e le sole relazioni che ha
intrattenuto con Goebbels ed altri capi nazisti, al di là di circostanze mondane, sono state per aiutare
qualche suo amico ebreo a fuggire dalla Germania.
Il problema che, mi sembra, Harwood non riesce a mettere a fuoco nel suo copione, è quello
denunciato da Hannah Arendt della “banalità del male”. Furtwängler è semplicemente un genio
dell’esecuzione musicale, epperò straordinariamente ottuso sotto il profilo morale. Per cui volendo
preservare l’anima superiore, celeste della grande musica tedesca, non vede o si impedisce di vedere
che attorno a lui opera un regime dittatoriale feroce, vòlto allo sterminio di massa. Pur se lui
4
personalmente non è colpevole di alcun crimine, come tantissimi suoi connazionali è eticamente
corresponsabile di non aver fatto nulla per opporsi all’orrore, e questo semplicemente continuando a
fare quello che sapeva benissimo fare, cioè il direttore d’orchestra, non avvertendo che in situazioni
extra-ordinarie occorre fare uno scatto in più, serve fare un salto di coscienza, e proseguire la
propria vita come facendo finta di nulla è, per l’appunto, soccombere colpevolemente e banalmente
“al male”.
Nonostante il suo titolo – Taking sides ovvero “prendere posizione” – il testo di Harwood non
consente a tale nodo cruciale di emergere davvero. Il lavoro si incardina su una alterna dialettica,
quella in fondo manichea tra il ‘democratico’ Arnold e l’altezzoso ‘aristocratico’ Furtwängler, che
poi alla resa dei conti non sa dove andare a parare. Così, l’autoaccusa terminale del musicista suona
stereotipata e inautentica, e il maggiore a stelle e striscie ha certo ragione, ma da ‘testa di legno’ in
divisa cerca una condanna penale riduttiva e, comunque, inadeguata. Pure lui resta molto al di sotto
di quella riflessione filosofico-morale generale, necessaria a comprendere il perché
dell’atteggiamento e delle scelte di Furtwängler e del popolo tedesco obbediente fino all’ultimo alla
croce uncinata.
L’allestimento della Kustermann non sfiorava nemmeno questo fulcro etico-politico, limitandosi ad
una illustrazione registica onesta, ma abbastanza piatta. Furtwängler era incarnato dal niveocrinito
Alberto Di Stasio, attore capace, ma qui poco convincente non per colpa sua, ma per la poca
pregnanza con cui viene tratteggiato il suo personaggio. Sicuramente meglio calibrata la prova di
Giuseppe Antignati (Arnold), anche perché la figura del militare tanto retto quanto stolido, è
monodimensionale, tagliata con l’accetta ed è senz’altro più semplice da impersonare.
Completavano il cast, senza bagliori, Alberto Caramel, Gaia Benassi, Giada Prandi e Antonio
Grosso. La scena di Marco Martucci si disegnava eterotopica tra interni di uffici e sfondamenti
sull’esterno. La colonna sonora, ovviamente beethoveniana e bruckneriana, si ascoltava con pieno
godimento.
► Il più celebrato e iperattivo regista della generazione dei quarantenni, Antonio Latella, si è
avvalso della nuova traduzione di Le Nuvole di Aristofane, firmata dalla giovane e valente
drammaturga Letizia Russo, per procedere ad una originale messinscena che riduce i personaggi e
sintetizza il testo. La straordinaria commedia aristofanesca si dimensiona così come una sorta di
moderna o surmoderna ‘black comedy’ recitata da quattro attori con abiti neri e lunghe, ridicole
scarpe da clown, che trascorrono buona parte del tempo a rincorrersi in platea: la ‘quarta parete’
viene del tutto infranta, proprio mentre l’ingresso della scuola di retorica (il ‘pensatoio’) è
rappresentato da un piccolo teatrino posto sul fondo della scena quale doppio e mise en âbime del
palco del Teatro Argentina di Roma, dove lo spettacolo si svolge. Ciò per far capire che è di noi e di
oggi che si sta teatrando.
E, infatti, la satira (attualissima) del commediografo greco del V secolo avanti Cristo mi sembra che
si sposi benissimo con le modalità di straniamento brechtiano volute da Latella. Così Massimiliano
Speziani, figurando Strepsiade, manovra a vista la marionetta del figlio Fidippide, un osceno
bamboccione, tutto bell’ignudo e col pene scappucciato; per poi successivamente incarnare Socrate,
ambiguo maestro e sottile filosofo, mezzo saggio e mezzo corruttore, ateista convinto. La regia ha
impostato uno stile para-televisivo, cabarettistico-zelighiano per intenderci, dove ogni cosa viene
messa alla berlina, in primis il ‘divino’, presentificato da un pingue attore en travesti (l’ottimo
Maurizio Rippa) che agita le piume di struzzo e intona varie canzoni – da Se stasera sono qui di
Luigi Tenco a Povera patria di Franco Battiato. Mentre gli altri interpreti (ricordo anche Marco
Cacciola e Annibale Pavone) talora interrompono alcune supponenti elucubrazioni pedagogicosapienziali, scapricciando ameni balletti sulle note di “Brasil Brasil”. Le nuvole, nella lettura di
Latella, sono le proiezioni di tutte le pulsioni desideranti dell’uomo, dalle migliori alle peggiori, e
lui le raffigura con una doppia catabasi dal soffitto di una “machinery of skeletons” (per usare un
verso di Allen Ginsberg), una suggestiva macchineria volante di scheletri visualizzati in varie pose.
Sono, ipersimbolicamente, gli scheletri nell’armadio dell’umanità, ovvero gli scheletri delle idee e
5
delle buone intenzioni (andate a male) ma, forse, anche un ironico modo per poter dire: ingrato
mondo non avrai le mie ossa.
Tutto l’inghippo testuale per cui Strepsiade, gravato dai debiti contratti dallo sciagurato figlio
Fidippide, si rivolge a Socrate perché gli insegni le armi della sofistica con cui pensa di poter tenere
a bada i creditori, qui scivola volentieri in una derisoria pagliacciata in cui gli attori con i nasi rossi
da circo elicitano il “discorso migliore” (del tipo parenetico-perbenista-autoritario) mimando il
triviale populismo da piazza (condannato da Aristotele nella Politica come la pessima
‘demagogia’). Quando poi si passa al “discorso peggiore”, ecco che si inchiodano gli umani alla
loro veridica natura, quella brutamente animale-sexuale, ai loro istinti più bassi e vili, e finiscono i
protagonisti tutti assieme a constatare e, persino, ad inneggiare ad una platea di spettatori, specola di
‘humanitas’, tutta indistintamente composta di “rottinkulo”, tutti ‘bifottuti’ e in fondo beati e
contenti o, comunque, non troppo scontenti. Se in Aristofane la critica satirica mostrava la miseria
delle illusorie e fallimentari pretese di Strepsiade, scavalcato dal figlio pelandrone pronto a
bastonarlo per vendicarsi dei colpi ricevuti da piccino (secondo la morale: chi la fa la aspetti), e nel
delineare un mondo corrotto e meschino, travolto da nuove mode, cui teneva bordone anche l’infido
pensatore Socrate, nello spettacolo di Latella lo sguardo acido-satirico si allunga fino al presente,
facilmente vaticinando una ‘humanitas’ incorreggibile, irriformabile, irrivoluzionabile, direi quasi
‘irrespirabile’.
Magari il gioco scenico, come avviene spesso in Latella, è un po’ troppo tirato per le lunghe, per
non dire sbrodolato, ma la cifra brillante, da clownerie colta ed humour noir del regista napoletano
si confà efficacemente alla misura o, meglio, dismisura comica di un genio di 25 secoli or sono, che
aveva capito tutto dei suoi simili, della putredine della società degli uomini e della democrazia
ateniese – che mutatis mutandis rispecchia proletticamente e sostanzialmente, con i suoi vizi e virtù,
quella occidentale odierna. E, poi, si può pure dare alle fiamme la scuola-pensatoio dei maîtres-àpenser, come fa il disgraziato Strepsiade, ma resta che in 2500 anni l’uomo in pratica non è
cambiato per nulla. Così è, se vi (ci) pare. (E oggi non ci sono più neppure i maîtres-à-penser,
semmai à-dépenser).
► Squadra che vince non si cambia, ma anche schema che vince non si cambia. Così, dopo
l’ottimo Rewind, la strana coppia-non coppia formata da Daria Deflorian e Antonio Tagliarini ha
confezionato questa stagione un nuovo singolare spettacolo – from a to d and back again – come
amena pièce di meta-conversazione, liberamente ispirata al libro “From a to b and back again – la
filosofia di Andy Warhol”. Se in Rewind l’omaggio era esplicito e diretto a Pina Bausch e al
trentennale del suo capitale spettacolo Café Müller, qui l’omaggio al più significativo artista della
Pop Art appare maggiormente mediato e soprattutto tangenzialmente rivolto alla sua ‘filosofia’, che
poi sarebbe una sorta di appropriazione d’autore, una vampirizzazione d’artista della realtà e anche
dello stupidario ‘pop’ che innervano e permeano l’esistenza dell’uomo (occidentale)
contemporaneo.
“Pop Life / Everybody needs a thrill / Pop Life / We all got a space 2 fill” cantava un quarto di
secolo fa Prince. “Pop Life” che qui viene sgranata secondo un cicaleccio a ruota libera di
osservazioni, piccole confessioni, subitanei ricordi, agrodolci aneddoti, un cataloghino anche di
avversioni, capricciosità, piccole isterie, manie e minime schisi della vita quotidiana. a come
Antonio e d come Daria prendono spunto dallo stile ‘casual’ e sversato di Warhol per parlare più o
meno sfacciatamente di se stessi, per ostendersi impudicamente in pubblico. Ovvero, come
sottolineano, per esibire la ‘warholità’ che è in loro.
Pur se, magari, la loro vita pop è le milla miglia lontana da quel turbinoso jet set artistico-mondano
newyorkese che insaporiva e rendeva così ‘global’ e mitici i narcisismi e i vezzi e le maniere e le
idiosincrasie del creatore della “Factory”: Drella, come lo chiamavano gli intimi (vedi il disco del
1990 Songs for Drella, che gli dedicarono gli ex Velvet Underground Lou Reed e John Cale). Cioè
un connubio tra Dracula e Cinderella, perché Andy era una Cenerentola della/nella Big Apple che
era diventato il grande Nosferatu dell’arte e della società di massa del suo tempo.
6
Per tornare a Deflorian-Tagliarini, direi che il gioco scenico funziona bene, con loro due disposti
frontali ai lati del palco, su un paio di divanetti in faccia al pubblico. Non si guardano mai e in
compenso e in parallelo si mettono e si tolgono parecchie parrucche identiche per entrambi: tra cui
una biondo-platino in esplicito omaggio a quella che Warhol vanitosamente indossava negli ultimi
anni della sua vita. Il meccanismo ludico e speculare per incastro visivo, dalle parrucche si allarga
anche alle maglie, magliette, t-shirt, chemises dalle sfavillanti paillettes, che i due si rimpallano da
un angolo all’altro della scena. Sempre rigorosamente seduti fanno salotto o ‘salottino’ con aria
pigra e nonchalante come quando Antonio racconta che odia essere avvicinato, toccato, manipolato
da estranei che molestandolo gli provocano una vera crisi nervosa; o quando, dal suo canto, Daria
riferisce di detestare la campagna, con i suoi insetti, i vermetti, e le scomodità, il freddo, i paesaggi
che non le dicono nulla, e intanto sta attaccata al telefonino interloquendo in permanenza con i
genitori o con amici, amanti, colleghi etc.
In questa forma di meta-rappresentazione, bisogna dire che la Deflorian si è scoperta una vena per
l’appunto, metacomica che le ha fatto sicuramente fare uno scatto d’attrice e, ancor più che in
Rewind, qui appare bravissima a cadenzare tempi e modi del suo divagare. Tagliarini si conduce, da
parte sua, con l’atteggiamento sornione del ‘vitellone’ o ‘vitelloncino’ contemporaneo, la cui
attività preferita è di andare a delle rutilanti feste metropolitane e/o metrosexual, di cui il giorno
dopo non rammenta praticamente nulla.
In mezzo ai due protagonisti, ossia al centro del palco opera il percussionista Fabrizio Spera, qui in
veste di deejay che mixa e remixa musiche incrociando tre lettori cd: proponendo un mélange tra
colto (John Cage) e leggero (Brigitte Bardot) e, talora, estraendo vere gemme pop come Baby it’s
you di Burt Bacarach, canzone recuperata anche da Quentin Tarantino nella eccitante colonna
sonora di Grindhouse.
Per concludere, se Pasolini nel famoso, sessantottesco Manifesto per un nuovo teatro, si scagliava
contro “il teatro borghese della chiacchiera”, Deflorian e Tagliarini potremmo dire che redimono un
teatro della chiacchiera post-borghese, montato con stile sciolto, ‘basso’, noncurante, ma assieme
calibratissimo, sempre ironico e controllato, stranito e ludico, figlio di Beckett e di Tati. Dove
soltanto in explicit tra i due si accende un brandello di dialogo diretto, come a voler superare
l’incomunicabilità, l’isolamento di chi vive sopraffatto nella società alienata della moltitudine e
dell’homo consumens (Zygmunt Baumann dixit).
Forse la filosofia pop di Warhol la traduceva bene Prince quando cantava: “Everybody can’t be on
top / But life it aint real funky / Unless it’s got that pop / Dig it” (Vale a dire: Non tutti possono
avere successo, ma la vita non è davvero amena, se non è pop, lo devi capire).
► Disinibito teatro pop o, forse, sub-pop, è pure quello proposto dalla coppia (anche nella vita)
formata da Elvira Frosini e Daniele Timpano in Sì, l’ammore no. Corsivo, saltabeccante spettacolo
che gioca con tutti i luoghi comuni più triti e ritriti sul tema dell’amore. Già il titolo ossimorico
vuole affermare per, poi, subito negare, quasi a far intendere che appena dici “sì all’amore” quello
rapidamente si volatilizza o si trasforma nel suo contrario. Sì, l’ammore no è, del resto,
esplicitamente un titolo agrodolce da canzonetta, perché forse, secondo già sosteneva François
Truffaut, nelle canzonette, pure le più stupide, c’è sempre un fondo di verità. E probabilmente si
coglie l’essenza dell’amore assai più nella subcultura pop che in cento seriosi trattati filosofici.
Partendo da questa idea, non certo inedita né esaltante, della “banalità del bene&male amoroso”
(per parafrasare la Arendt), Frosini-Timpano legano il senso del loro spettacolo al filo musicale
nevralgico e strategico dei motivetti canori sentimentali degli anni ’30, giungendo a Cuore (1963)
di Rita Pavone, e a Cuore matto (1967) e Bada bambina (1969) di Little Tony; ma anche svariando
dalla nazional-fascista Faccetta nera (1935) al nazionalpopolare Claudio Baglioni, con il corredo,
di smielati e incredibili pezzi canzonettari degli anni ’70, tra cui spicca per insuperabile,
sdolcinatissimo superkitsch La prima volta (1976), un brano interpretato-dialogato da Andrea &
Nicole, quasi un Je t’aime moi non plus kako-nostrano in erotica-melliflua versione da
fotoromanzetto rosa su una fanciulla vergine che perde la sua ‘purezza’ (ed era, a pensarci, il tempo
7
del femminismo arrembante, della liberazione sessuale, nonché del ‘Fiat-nam’, delle Brigate Rosse,
delle stragi nere di Stato e dell’assassinio di Pasolini).
Ironizzando e satireggiando su tutta codesta paccottiglia, Frosini-Timpano sembrano quasi
autorappresentare e iconizzare la dualità maschio-femmina in un dinosauro di plastica da tenere al
guinzaglio (lui) e in una bambola gonfiabile da strapazzare (lei). Il lavoro si accende, così,
attraverso i deliranti raptus psicomotori di Timpano e le incursioni in platea come nel Costanzo
Show della Frosini che intervista gli spettatori (“Lei si tocca?”) e le spettatrici (“Lo ha mai fatto per
soldi?”). E il bello è che quelli rispondono seriamente, tutti compunti, invece di mandarla “a
cagare”.
Altre scenette si animano su incontri idealizzati e coups-de-foudre fatali ricalcati sulle novelle
Harmony e con citazioni da “Beautiful”. Salvo improvvisamente svoltare con arrembanti denunce
dell’attuale, ritornante clima patriarcal-maschilista, peraltro rimbeccate da sarcastiche messe alla
berlina dei clichés del vetero-femminismo. Frosini-Timpano sgranano l’intero campionario dei
soliti ometti ultramammoni che danno delle “troje” a tutte le donne, e delle femmine volitive e
‘mangiauomini’ che si sgranocchiano voraci delle grosse, iperfalliche melanzane. Lui con occhialini
neri da nottambulo invero perdigiorno, lei con occhialetti bordati di rosso a cuoricino e vari altri
bizzarri spectacles da fare invidia a Lina Wertmuller.
Frosini-Timpano simmetricamente di bianco vestiti – lui in pantaloni e camicia con cravattina rossa,
lei abito a tubino con le spalline e guantini rouge – montano in definitiva una godibile performance
di mera paratassi scenica, che si impinza di brevi gag ‘denarrative’ ed exploit fisico-gestuali con
rotolamenti plurimi a terra e molte pose plastico-fumettistiche, dove il talento nevrocomico di
Daniele e il sapere coreutico di Elvira finiscono per fare ‘corpo unico’.
Al resto, poi, si sa, non c’è una vera risposta o soluzione: l’amore è una cosa meravigliosa… o no?
► In tema di ‘Pop theatre’ mi pare opportuno citare il volume Iperscene 2 (Editoria&Spettacolo,
Roma 2009, pp. 220, € 20,00) curato da Jacopo Lanteri e dedicato ai ‘novissimi’ della ricerca
teatrale italica del XXI secolo, protagonisti appena emersi o emergenti che si chiamano: Teatro
Sotterraneo, Sonia Brunelli, Ambra Senatore, Muta Imago, Pathosformel, Babilonia Teatri e Dewey
Dell. Il libro appare nella benemerita collana “Spaesamenti” diretta dal critico Paolo Ruffini che,
per l’occasione, firma una densa nota teorico-culturale intitolata Post-pop, ovvero tautologia del
post-adolescente, in cui scrive: “Il Post-pop lo intendo qui non come un movimento artistico, ma
piuttosto un sentire comune e trasversale di molti che inconsapevolmente colgono significati
attraverso un susseguirsi di immagini paradossali, stracariche di cliché (verbali, di movimento e
iconografici)”. E ancora: “Il Post-pop si pone in una diversa collocazione umorale – se vogliamo
anche eccessiva – dove l’opera stessa si definisce nelle vacue forme di un corpo intromesso al
mondo però per frantumarne il valore, per renderne espliciti e forse elementari i segni: non sarà più
un valore-feticcio, un segno indelebile ma, come in un cubo di Rubik, nelle sue infinite possibilità
sarà istantaneo, momentaneo, azzeccato nella combinazione tra consumo simbolico ed esposizione.
Un valore percepito, solo percepito, un segno condiviso in quanto abitudine collettiva”.
La percezione del valore, nel Post-pop, prescinderebbe dunque da qualsivoglia valore d’uso e si
darebbe soltanto in un valore di scambio simbolico-collettivo mobile, nomadico, perennemente
transeunte. Il ‘valore Post-pop’ più che un processo di autovalorizzazione ‘contro’, sarebbe un
rigiocarsi i segni comuni (‘luogocomunisti?’) del mondo percepito per rimbalzarli sul mondo stesso
destituendoli di fondamento e di valore, deprivandoli di senso e di vera intelligenza del reale.
► In questa chiave di puro teatro estremista neo o post-pop (as you like it), mi pare sia
inquadrabile il recente, assai ragguardevole spettacolo Pornobboy del gruppo veronese Babilonia
Teatri. Ideato e diretto da Enrico Castellani e Valeria Raimondi, che pure lo interpretano assieme a
Ilaria Dalle Donne, l’allestimento ha un incipit meramente tautologico con l’affissione di numerose
copie del poster del Pornobboy medesimo su un grande pannello. I tre attori hanno un look del tutto
8
ordinario e casual. L’uomo ha una maglietta rossa con l’effige di Che Guevara, le due donne
indossano t-shirt bianche con le scritte “I Love New York” e “Festival di Santarcangelo”. Scena
spoglia, crude luci fisse, nessuna concessione alle convenzioni del teatro. Praticamente immobile,
l’efferato trio attacca una torrenziale cantilena-cronaca basata su un montaggio freddo, chirurgico,
da ‘nuova oggettività’ di materiali informativi semplicemente prelevati da giornali e tivù.
Via via cresce una paratassi ossessiva ed assassina che rovescia addosso agli spettatori-ascoltatori
tutta la pornografia ‘me(r)diatica’ (cioè mediocratica e videocratica) che avvelena ed opprime
l’intera infosfera pubblica italiota. E l’iniziale effetto da parodia anche divertente e ammiccante, si
trasforma per insostenibile accumulo in un agghiacciante delirio, in un collasso comunicativo di
titoli, domande, elencazioni folli, notiziole, voci, chiacchiere e palaver (Enzensberger dixit) sui fatti
e fatterelli politici-criminali-gossip stampati nel recente inconscio collettivo nostrano.
(Dalle cronichette sulle escort di Berlusconi e i suoi dissidi con la moglie Veronica all’assassinio di
Cogne; dall’uccisione a Perugia della studentessa inglese Meredith con l’angelica-diabolica
Amanda Knox all’ammazzamento di Carlo Giuliani – Genova 2001 – da parte del carabiniere Mario
Placanica, peraltro prosciolto per legittima difesa; a una valanga di altre vicende finite nel tritacarne
mediatico, prese qui e là, come exempla della desolata e desolante oscenità e incultura che oggi
alligna e prospera nel Bel-Brut Paese).
Il tutto viene recitato-vomitato con tono monocorde, neutro, macchinico da tre zombi con la faccia
impassibile; è una sorta di oratorio ‘della crudeltà’ da sottovuoto mentale di tre marionette
pressocché catatoniche e porno-catastrofiche che ci stanno dicendo: noi tre superdeficienti siamo
semplicemente e meramente tutti voi, siamo ossia la presente, demenziale tragedia post-pop e posthuman che vi ostinate a non voler vedere.
Segue nel sottofinale una beota canzoncina da Zecchino d’oro che introduce all’autentico coup-de
théâtre terminale: una rumorosa, rotante turbina sopraelevata si mette in azione e secerne una
spettacolare, madornale colata lavica di candido schiumogeno che finisce per inghiottire
completamente i tre attori-zombi. E quella nivea, enorme quantità di schiuma appare un mostruoso
blob che tracimando e invadendo lo spazio scenico si dà come la macro-simbolica, morbidamortifera morchia e smegma che ha avviluppato l’intera verbosfera mass-comunicativa nazionale e
che sta annichilendo tutti i cervelli tricolori.
Così, la riemersione, in explicit, dei tre interpreti indenni, sembra quasi una stonatura, rispetto
all’apocalittico ‘messaggio-massaggio’ dello spettacolo.
Perché sformati di kako-informazione, come diceva Carmelo Bene, si muore (psichicamente,
intellettualmente, culturalmente, eticamente). E non si resuscita.
Maggio 2010