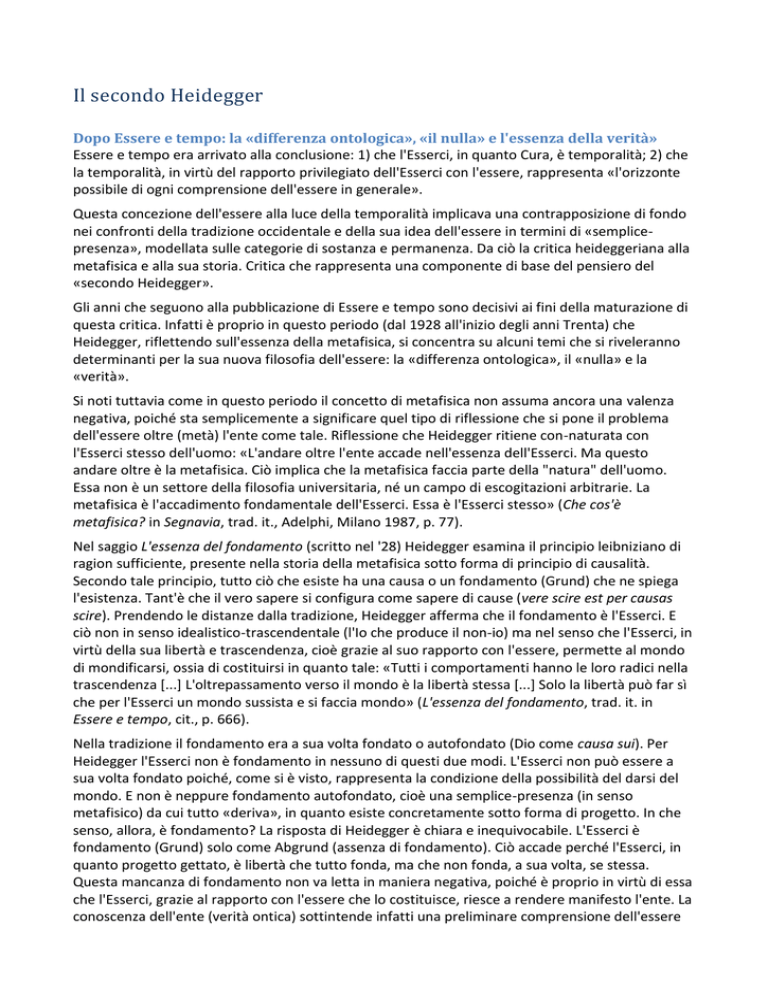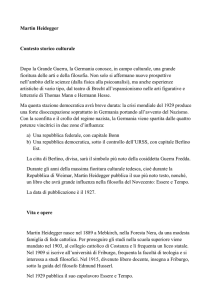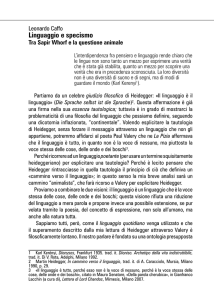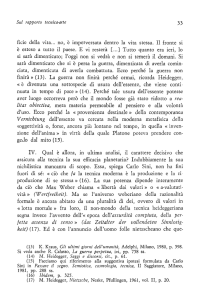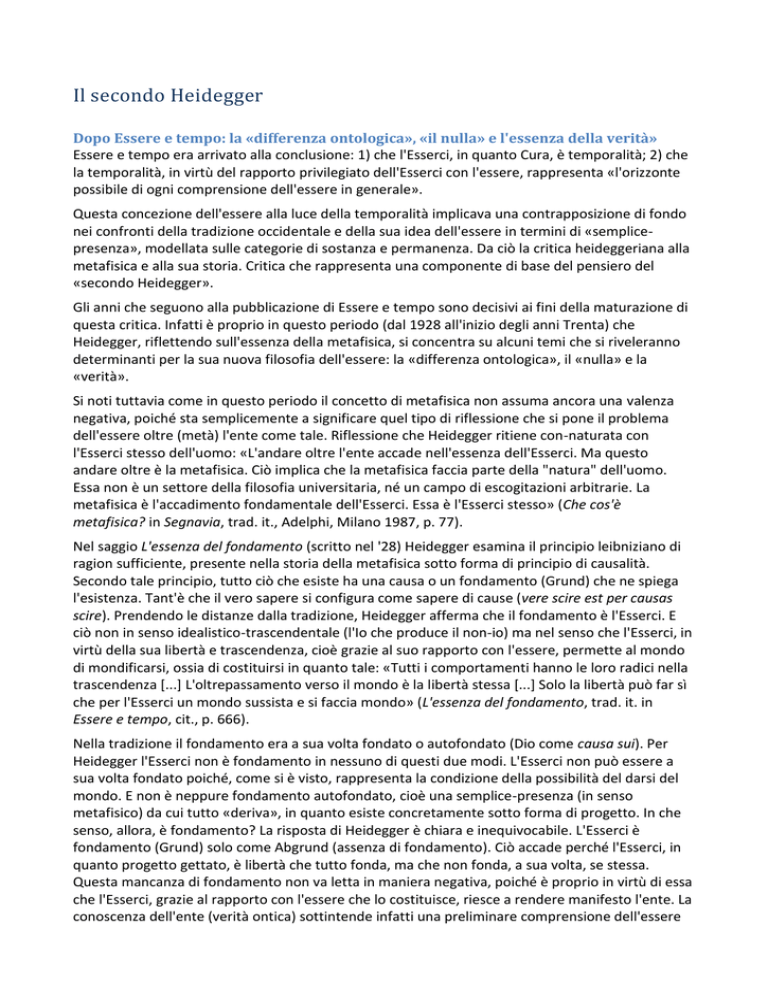
Il secondo Heidegger
Dopo Essere e tempo: la «differenza ontologica», «il nulla» e l'essenza della verità»
Essere e tempo era arrivato alla conclusione: 1) che l'Esserci, in quanto Cura, è temporalità; 2) che
la temporalità, in virtù del rapporto privilegiato dell'Esserci con l'essere, rappresenta «l'orizzonte
possibile di ogni comprensione dell'essere in generale».
Questa concezione dell'essere alla luce della temporalità implicava una contrapposizione di fondo
nei confronti della tradizione occidentale e della sua idea dell'essere in termini di «semplicepresenza», modellata sulle categorie di sostanza e permanenza. Da ciò la critica heideggeriana alla
metafisica e alla sua storia. Critica che rappresenta una componente di base del pensiero del
«secondo Heidegger».
Gli anni che seguono alla pubblicazione di Essere e tempo sono decisivi ai fini della maturazione di
questa critica. Infatti è proprio in questo periodo (dal 1928 all'inizio degli anni Trenta) che
Heidegger, riflettendo sull'essenza della metafisica, si concentra su alcuni temi che si riveleranno
determinanti per la sua nuova filosofia dell'essere: la «differenza ontologica», il «nulla» e la
«verità».
Si noti tuttavia come in questo periodo il concetto di metafisica non assuma ancora una valenza
negativa, poiché sta semplicemente a significare quel tipo di riflessione che si pone il problema
dell'essere oltre (metà) l'ente come tale. Riflessione che Heidegger ritiene con-naturata con
l'Esserci stesso dell'uomo: «L'andare oltre l'ente accade nell'essenza dell'Esserci. Ma questo
andare oltre è la metafisica. Ciò implica che la metafisica faccia parte della "natura" dell'uomo.
Essa non è un settore della filosofia universitaria, né un campo di escogitazioni arbitrarie. La
metafisica è l'accadimento fondamentale dell'Esserci. Essa è l'Esserci stesso» (Che cos'è
metafisica? in Segnavia, trad. it., Adelphi, Milano 1987, p. 77).
Nel saggio L'essenza del fondamento (scritto nel '28) Heidegger esamina il principio leibniziano di
ragion sufficiente, presente nella storia della metafisica sotto forma di principio di causalità.
Secondo tale principio, tutto ciò che esiste ha una causa o un fondamento (Grund) che ne spiega
l'esistenza. Tant'è che il vero sapere si configura come sapere di cause (vere scire est per causas
scire). Prendendo le distanze dalla tradizione, Heidegger afferma che il fondamento è l'Esserci. E
ciò non in senso idealistico-trascendentale (l'Io che produce il non-io) ma nel senso che l'Esserci, in
virtù della sua libertà e trascendenza, cioè grazie al suo rapporto con l'essere, permette al mondo
di mondificarsi, ossia di costituirsi in quanto tale: «Tutti i comportamenti hanno le loro radici nella
trascendenza [...] L'oltrepassamento verso il mondo è la libertà stessa [...] Solo la libertà può far sì
che per l'Esserci un mondo sussista e si faccia mondo» (L'essenza del fondamento, trad. it. in
Essere e tempo, cit., p. 666).
Nella tradizione il fondamento era a sua volta fondato o autofondato (Dio come causa sui). Per
Heidegger l'Esserci non è fondamento in nessuno di questi due modi. L'Esserci non può essere a
sua volta fondato poiché, come si è visto, rappresenta la condizione della possibilità del darsi del
mondo. E non è neppure fondamento autofondato, cioè una semplice-presenza (in senso
metafisico) da cui tutto «deriva», in quanto esiste concretamente sotto forma di progetto. In che
senso, allora, è fondamento? La risposta di Heidegger è chiara e inequivocabile. L'Esserci è
fondamento (Grund) solo come Abgrund (assenza di fondamento). Ciò accade perché l'Esserci, in
quanto progetto gettato, è libertà che tutto fonda, ma che non fonda, a sua volta, se stessa.
Questa mancanza di fondamento non va letta in maniera negativa, poiché è proprio in virtù di essa
che l'Esserci, grazie al rapporto con l'essere che lo costituisce, riesce a rendere manifesto l'ente. La
conoscenza dell'ente (verità ontica) sottintende infatti una preliminare comprensione dell'essere
(verità ontologica). Ne segue, in prima battuta, che l'essere, pur non risolvendosi nell'ente, tende a
configurarsi come la luce o l'orizzonte che, tramite l'Esserci, rende visibile l'ente. Da ciò la nozione
di differenza ontologica, che Heidegger, nella premessa del 1949 alla nuova edizione di L'essenza
del fondamento, prospetta come il messaggio ultimo di questo scritto, ovvero la tesi secondo cui
l'essere non è l'ente e non va quindi (metafisicamente) confuso con esso.
In Che cos'è metafisica? (prolusione del '29) Heidegger non si sofferma sulla metafisica in generale,
ma su un suo problema specifico: il problema del nulla. Problema che, a suo avviso, costituisce la
metafisica stessa, distinguendola dalle scienze particolari. Ogni ricerca scientifica, osserva il
filosofo, ha per oggetto «l'ente stesso — e nient'altro» (ivi, p. 61). Ma che cos'è questo
«nient'altro», questo «niente» di cui la scienza non si occupa? Rifiutandosi di ridurre il problema
del nulla a un nulla di problema («Che cosa può essere per la scienza il niente se non una
mostruosità e una fantasticheria? Se la scienza ha ragione, allora una cosa è certa: del niente la
scienza non vuol saperne niente»), Heidegger sostiene: a) che il niente non esiste solo perché c'è il
‘non’, cioè la negazione, ma, al contrario, c'è la negazione (il «non») solo perché esiste il niente; b)
che il niente viene esperito come «la negazione completa della totalità dell'ente» (ivi, p. 65).
Com'è possibile tale esperienza? Heidegger risponde che ciò avviene nell'angoscia, intesa come
esperienza emotiva del nulla di tutto l'ente, il quale, di fronte all'angoscia, pare dileguarsi e
sprofondare nel non-essere: «Nell'angoscia, noi diciamo, "uno è spaesato" [...] Non possiamo dire
dinanzi a che cosa uno è spaesato, perché lo è nell'insieme. Tutte le cose e noi stessi affondiamo in
una sorta di indifferenza» (ivi, p. 67). Ora, per vivere l'esperienza del nulla noi dobbiamo
trascendere l'ente: «Tenendosi immerso nel niente, l'Esserci è già sempre oltre l'ente nella sua
totalità. Questo essere oltre l'ente noi lo chiamiamo trascendenza» (ivi, p. 70). Trascendenza
grazie a cui l'ente diviene visibile. Infatti, è proprio in virtù di questo procedere oltre l'ente, di
questo «uscir fuori dall'ente, per vederlo dall'alto» che ci è possibile conoscere l'ente in quanto
tale e interrogarci su di esso. In altri termini, il niente, che, in quanto ni-ente, coincide con un
nulla-di-ente (Nicht-des-Seiendes), costituisce lo sfondo originario grazie a cui l'ente diventa
accessibile: «Il niente è ciò che rende possibile l'evidenza dell'essere come tale per l'Esserci
umano» (ivi, p. 71). E poiché lo sfondo originario grazie a cui l'ente diviene visibile si identifica con
l'essere, ne deriva, come dichiara il filosofo in una nota alla quinta edizione (1949) del suo scritto,
che «il niente e l'essere sono la stessa cosa» (ivi, p. 71, nota a), ovvero, com'è detto altrove:
«essere: niente: lo Stesso».
Da ciò il risultato apparentemente paradossale del discorso di Heidegger: l'esperienza del nulla
coincide con l'esperienza dell'essere, inteso come ciò che non è l'ente (differenza ontologica) ma
rende visibile l'ente. In sintesi (tale è il senso complessivo del non facile ragionamento di
Heidegger), l'Esserci, nella sua trascendenza, può fare l'esperienza del nulla (dell'ente) solo a patto
di procedere oltre l'ente, cioè di rapportarsi all'essere, il quale, nei confronti dell'ente, finisce per
configurarsi come il nulla (dell'ente). La connessione tra L'essenza del fondamento e Che cos'è
metafisica? risulta dunque evidente: «La seconda riflette sul nulla, il primo nomina la differenza
ontologica. Il nulla è il nulla dell'ente, quindi l'essere, colto a partire dall'ente» (L'essenza del
fondamento, cit., p. 623).
In Dell'essenza della verità Heidegger affronta in maniera nuova il tema della verità. Già in Essere e
tempo egli aveva contestato il concetto tradizionale della verità come «corrispondenza»
(adaequatio rei et intellectus), mostrando come esso, più che falso, risulti secondario (o derivato).
Infatti, per adeguarsi all'ente, occorre che l'Esserci sia già preliminarmente aperto all'ente o, se si
vuole, occorre che vi sia già un orizzonte, o un ambito aperto, in cui l'Esserci può incontrare l'ente
e l'ente può manifestarsi all'uomo. Heidegger osserva che tale verità originaria coincide con la
libertà, intesa non nel senso (antropologico) del libero arbitrio, ma in quello (ontologico) del
«lasciar-essere l'ente» nel suo disvelamento. Si tratta di una libertà che l'uomo non può
«scegliere», ma che fa tutt'uno con l'Esserci stesso, al punto che «non l'uomo "possiede" la libertà
come sua proprietà ma tutt'al più al contrario» (trad. it. in Segnavia, cit., pp. 143 e 146).
Ne segue che la libertà non discende da un'iniziativa umana, ma si configura come un dono, anzi
come il dono preliminare dell'essere all'uomo. Dono che permette all'uomo di essere ciò che è e
all'ente di manifestarsi. Per cui, mentre in Essere e tempo la verità era ancora pensata in termini
esistenziali, ovvero come un «modo di essere dell'Esserci», coincidente con l'illuminarsi del mondo
per opera del Dasein, dopo la Kehre tende a configurarsi come l'accadere dell'essere stesso, che in
quanto «radura» o Lichtung lascia essere l'ente, rendendolo visibile. Da ciò la polemica contro le
dottrine che hanno ridotto la verità a una «proprietà» dell'uomo, ossia a una facoltà del soggetto,
rappresentata di volta in volta dalla diànoia (Aristotele), dall' intellectus (Tommaso), dal cogito
(Cartesio), dalla volontà di potenza (Nietzsche). Di questa progressiva antropologizzazione e
soggettivizzazione della verità è responsabile Platone (oltre a Dell'essenza della verità, cfr. pure La
dottrina platonica della verità, 1942, e il corso universitario del 1931-32 tenuto all'Università di
Friburgo con il titolo L'essenza della verità).
Mentre i primi filosofi avevano concepito la verità come rivelazione dell'essere, come
determinazione inerente all'essere stesso, di cui esprime la «manifestatività», Platone la
concepisce come una proprietà del conoscere umano. In tal modo, egli capovolge il nesso fra
verità ed essere, fondando l'essere sulla verità, anziché la verità sull'essere. Infatti, avendo
assimilato il vero a ciò che risulta visibile agli occhi dell'intelletto (all'idea), egli ha finito per ridurre
la verità alla «correttezza» del pensare e del volere, ponendo le basi per la sua risoluzione nella
«soggettività del soggetto». L'idea di Platone è uno «sguardo» sull'ente: la verità è la giustezza o la
correttezza di questo sguardo, cioè un carattere che l'essere assume in rapporto all'intelligenza
dell'uomo che conosce. Da questa dottrina all'affermazione di Nietzsche, secondo cui la verità è
una «forma di errore» (umana, troppo umana) c'è un passaggio graduale ma necessario,
coincidente con la storia stessa del nichilismo occidentale.
Secondo Heidegger la verità implica la non-verità, proprio come la luce implica l'oscurità. Un
attestato di tale nesso è costituito dalla parola greca a-letheia, che significa non-nascondimento, a
conferma del fatto che l'illuminarsi della verità implica un cooriginario nascondersi di essa. Tale
circostanza è evidenziata dal fatto che ogni verità di cui parliamo è sempre il manifestarsi di
questo o quell’ente e mai dell'ente nella sua totalità. Questo velamento che precede e
accompagna ogni disvelamento coincide con il mistero stesso dell'essere. Alla non-verità come
vela-mento si connette la non-verità come oblio dell'essere ed errare dell'uomo fra gli enti. Errare
(irren) in cui affonda le sue radici l'errore (Irrtum).
5. La «metafisica», l'oblio dell'essere» e il «nichilismo»
A partire da Introduzione alla metafisica (1935, pubblicato nel 1953) il termine «metafisica»
assume una connotazione esplicitamente negativa. Metafisica è quel pensiero che, pur ponendosi
il problema dell'essere, lo elude subito, limitandosi a un'indagine intorno all'ente «Essa pronuncia
necessariamente e perciò costantemente l'essere. Tuttavia [...] non pensa l'essere nella sua verità»
(Introduzione a «Che cos'è metafisica?», trad. it. in Segnavia, cit., p. 321).
Da Anassimandro a Nietzsche la metafisica è stata soltanto una «fisica», cioè una forma di
pensiero che si è persa fra gli enti, dimenticando l'essere, ovvero la differenza fra essere ed ente.
La metafisica è oblio dell'essere (Seinsvergessenheit). Un oblio che mette capo all'oblio dell'oblio.
Infatti, la metafisica o si è concentrata sull'ente in quanto ente — e allora è stata ontologia — o si
è concentrata sull'ente supremo — e allora è stata teologia. Anzi, a rigore, essa è sempre stata,
costitutivamente, onto-teo-logia, cioè unità inscindibile di ontologia, teologia e logica. Ontologia
perché interessata al fondamento dell'ente. Teologia perché fa dipendere tutti gli enti da
quell'ente fondante supremo che è Dio. Logica perché pensa l'ente in riferimento alla ragione,
instaurando un predominio del pensiero sull'essere. Al punto che con l'idealismo (v. Hegel) il
pensiero diviene l'essere dell'ente. Da tutto ciò la necessità di passare dalla domanda metafisica
intorno all'essere in quanto ente (Seinsfrage) alla domanda post-metafisica intorno all'essere in
quanto tale, ossia in quanto essere (Frage nach dem Sein).
Essendo caratterizzata dall'oblio dell'essere, la metafisica si configura come un tipo di pensiero in
cui, alla fine, dell'essere non ne è più nulla. Da ciò l'equazione fra metafisica e nichilismo: «la
metafisica è la storia nella quale, per essenza, dell'essere stesso non ne è niente: la metafisica è in
quanto tale il nichilismo autentico, (Nietzsche, trad. it., Adelphi, Milano 1994, p. 822). L'Occidente
è, per sua essenza, la terra della sera (Abends-land) o dell'occaso (Occidens), ovvero, fuor di
metafora, lo spazio-tempo del tramonto dell'essere.
La metafisica, per Heidegger, non si riduce a una sezione specialistica della filosofia (da porsi
accanto alla gnoseologia, all'etica, alla logica ecc.) poiché coincide con la prospettiva globale che
sta alla base di tutte le manifestazioni di un'epoca: dall'arte alla religione, dalla scienza all'etica,
dalla tecnica alla politica. Infatti, è sempre attraverso una certa metafisica che una determinata
umanità storica si rapporta al mondo e a se stessa. Tant'è che la storia delle parole-chiave della
metafisica (idea, atto, verità, sostanza, soggetto, spirito, volontà ecc.) coincide con la storia dei
modi con cui l'essere si è rivelato all'uomo e l'uomo si è rapportato all'ente. Al punto che
Heidegger arriva a sostenere che la storia dell'Occidente dipende, in ultima analisi, dalla maniera
con cui si è intesa (e tradotta) la parola «essere». Ne segue che la metafisica, nelle sue varie
forme, non è un accadimento della storia, ma l'accadere stesso della storia.
La metafisica, concepita come progressivo oblio dell'essere, si scandisce in una serie di momenti
(Platone, Aristotele, gli Scolastici, Cartesio, gli idealisti ecc.) che trovano il loro compimento in
Nietzsche, lo studioso che rappresenta non solo lo sbocco della metafisica moderna, ma il punto di
arrivo della metafisica in generale. La filosofia di Nietzsche non è una metafisica, ma l'ultima
metafisica della storia. Anzi, poiché metafisica e storia sono la stessa cosa, Nietzsche rappresenta il
compimento stesso della storia dell'Occidente. Infatti, riducendo l'essere alla volontà di potenza —
e quindi alla volontà creatrice dell'uomo — Nietzsche non ha fatto altro che portare al massimo
grado l'oblio occidentale dell'essere, ovvero la sua propensione a fare, dell'uomo, la regola o la
misura delle cose. Ciò che è iniziato con il platonismo (la riduzione dell'essere a idea o valore) ed è
proseguito con Cartesio (l'identificazione della realtà con la certezza che ne ha il soggetto
pensante) è giunto a termine con Nietzsche, che ha scorto, nella volontà di potenza, «l'intima
essenza dell'essere».
In quanto volontà che vuole essenzialmente se medesima, la volontà di potenza di Nietzsche,
concepita come essenza dell'ente, è una dionisiaca volontà di volontà che non riconosce alcun
essere oltre se stessa (= nichilismo) e che si «celebra», superomisticamente, nell'eterno ritorno di
sé. Da ciò le cinque parole o i cinque «titoli fondamentali» (Haupttitel) che, nella loro
interconnessione, strutturano la filosofia di Nietzsche: «"La volontà di potenza" nomina la parola
per indicare l'essere dell'ente in quanto tale, l'essentia dell'ente. "Nichilismo" è il nome per
indicare la storia della verità dell'ente così determinato. "Eterno ritorno dell'uguale" si chiama il
modo in cui l'ente nel suo insieme è, l'existentia dell'ente. Il "superuomo" designa l'umanità che
viene richiesta da questo insieme. "Giustizia" è l'essenza della verità dell'ente come volontà di
potenza. Ciascuna di queste parole fondamentali nomina contemporanea-mente quello che
dicono le rimanenti» (ivi, p. 747). Poiché la volontà di potenza, che rappresenta il trionfo definitivo
del soggettivismo cartesiano e lo smarrimento completo della differenza fra essere ed ente, trova
la sua incarnazione concreta nella tecnica, Nietzsche, in quanto filosofo del nichilismo è, al tempo
stesso, il filosofo (e il profeta) della tecnica, ossia il teorico del dominio incondizionato dell'uomo
sul mondo. Da ciò l'attualità Nietzsche, che agli occhi di Heidegger, finisce per configurarsi come la
contemporaneità stessa fatta persona: «L'"oggi" — non calcolato secondo il calendario, né
secondo le vicende della storia mondiale [...] è la determinatezza metafisica dell'umanità storica
nell'epoca della meta-fisica di Nietzsche» (ivi, p. 742).
Per cui, contrariamente alle sue pretese, la filosofia di Nietzsche non è né «antimetafisica» né
«inattuale», bensì «metafisica» e «attuale». Metafisica perché si muove all'interno dell'oblio
occidentale dell'essere. Attuale perché rappresenta il punto di arrivo del nichilismo occidentale e
di quella sua espressione planetaria che è la tecnica.
Ne segue che il superamento della metafisica, per Heidegger, non può avvenire tramite Nietzsche
(che non ha compreso l'essenza della metafisica e che è stato vittima, egli stesso, della metafisica),
ma contro Nietzsche e oltre Nietzsche.
6. Essere, uomo ed evento
Sinora si è parlato di essere e di oblio dell'essere. Ma che cosa intende, il secondo Heidegger, per
«essere»? La domanda è legittima, anche se la risposta è problematica. Infatti, per questo filosofo,
non esiste una sorta di «definizione» dell'essere — alla maniera dell'ontologia classica — ma
soltanto una serie di concetti, o meglio, di concetti-metafore (come Lichtung, Ereignis ecc.) più o
meno atti ad «alludere» ad esso. Fra le tesi fondamentali di Heidegger intorno all'essere spiccano
le seguenti:
1) L'essere non è l'ente o un ente (neppure l'ente supremo) ma ciò che entifica l'ente, ovvero che
lo lascia essere e lo rende visibile. In altri termini, l'essere, inteso come la svelatezza che accade è,
in primo luogo, l'orizzonte o la «radura» (Lichtung) al cui interno gli enti diventano manifesti.
Tant'è che l'uomo non può rapportarsi all'ente e a se stesso se non all'interno di una previa
comprensione dell'essere.
Comprensione che sta alla base di tutte le manifestazioni di un'epoca o del complesso dei
significati e dei valori in cui essa si incarna: «la domanda intorno all'essere non è una domanda
qualsiasi: la risposta ad essa predetermina, preconfigura o anticipa ogni nostro ulteriore rapporto
con le cose. La comprensione dell'essere, per quanto più o meno esplicita e consapevole [...] è una
comprensione che "apre" ogni altra possibile comprensione e che condiziona a priori ogni nostro
atteggiamento nei confronti del mondo in cui ci troviamo» (G. Chiurazzi).
2) L'essere, la cui manifestazione privilegiata è il linguaggio, non è una (statica) presenza o una
(stabile) struttura, ma uno storico accadere, cioè un «evento» (Ereignis) che «si dà» (Es gibt), di
volta in volta, in destini e parole-chiave differenti. L'essere fa tutt'uno con la storia dell'essere, cioè
con i vari modi del suo manifestarsi nel tempo, in quanto non è mai qualcosa di diverso dal suo
specifico modo di darsi linguistico e destinale: «C'è essere ogni volta soltanto in questa o quella
impronta destinale: Natura, Logos, Uno, Idea, Atto, sostanzialità, oggettività, soggettività, volontà
di potenza, volontà di volontà» (Identità e differenza, trad. it. in «aut-aut», nn. 187-188, 1982, p.
32). N.B. Implicando l'idea di una temporalità dell'essere, il concetto di «evento» non fa che
ribadire la «connessione» fra essere e tempo. Anzi, l'evento si configura come l'essere stesso, in
quanto tempo originario.
3) L'essere è un «evento» che si manifesta e si nasconde al tempo stesso, poiché il suo presentarsi
(nell'ente) coincide con il suo assentarsi (in se medesimo). Da ciò la fisionomia epocale dell'essere,
in virtù della quale ogni rivelazione dell'essere nell'ente risulta accompagnata da un parallelo
nascondimento dell'essere in se stesso (Heidegger connette il termine tedesco Epoche al termine
greco epoché, intendendo, con quest'ultimo, non la sospensione del giudizio di cui parlano gli
scettici e Husserl, bensì la sospensione della rivelazione dell'essere). In altre parole, la sospensione
(epoche) del donarsi dell'essere in quanto tale, il suo intimo celarsi, è ciò per cui l'essere risulta
«epocale», ossia automanifestantesi per epoche. La metafisica occidentale, in virtù dell'oblio
dell'essere che la caratterizza, è, per eccellenza, l'epoca dell'epoche dell'essere.
4) L'essere-tempo-linguaggio non è le varie epoche, viste nella loro unità articolata di rivelazione e
nascondimento — perché in tal caso l'ontologia di Heidegger si ridurrebbe ad una semplice
filosofia della cultura di stampo storicistico — ma ciò che apre e istituisce le varie epoche e i vari
mondi. Das Ereignis ereignet, l'evento eventualizza, scrive Heidegger, giocando sul fatto che il
verbo tedesco ereignen ha valore attivo e transitivo, significa cioè accadere ma anche «far
accadere» o «istituire» (in questo caso: epoche, mondi e culture).
5) Uomo ed essere sono strettamente congiunti, anzi coessenziali, perché se l'uomo è in quanto
appartiene all'essere, quest'ultimo, a sua volta, è di per se stesso riferito all'uomo. L'uomo non è
mai senza l'essere e l'essere non si dà mai senza l'uomo. Infatti, pur non essendo il risultato di una
creazione (trascendentale) dell'uomo, l'essere si autocostituisce solo in relazione all'uomo: «Il
mondo non può essere ciò che è e come è, grazie all'uomo, ma neppure senza l'uomo. Ciò dipende
[...] dal fatto che quello che [...] con una parola di lunghissima tradizione e dai molti significati ed
ora in disuso, chiamo "l'essere", ha bisogno dell'uomo per la sua rivelazione, custodia e
configurazione» (Ormai solo un Dio ci può salvare, Guanda, Parma 1987, p. 137).
Per indicare questa originaria coappartenenza di uomo ed essere Heidegger adopera il già
menzionato — e per lui basilare — termine Ereignis (evento). L'essere è Ereignis o Evento sia
perché ha il carattere storico dell'accadere e dell'istituirsi temporale di aperture e di mondi
tramite l'uomo, sia perché in tali aperture avviene una reciproca appropriazione/traspropriazione
(Ereignis, da eigen, proprio) di uomo ed essere in virtù della quale essi risultano «consegnati» l'uno
all'altro:
«Dell'"essere stesso" diciamo sempre troppo poco se, dicendo "l'essere", tralasciamo il suo
presentarsi all'essere umano, dando così a vedere di non comprendere che proprio questo essere
entra a far parte dell'"essere". Ma anche dell'uomo diciamo sempre troppo poco se, dicendo
l'essere" (non l'essere-uomo), poniamo l'uomo per se stesso e, dopo averlo così posto, lo
mettiamo in relazione all'essere". Diciamo invece anche troppo, se pensiamo l'essere come
qualcosa di onnicomprensivo, e ci rappresentiamo l'uomo soltanto come un ente particolare tra gli
altri (vegetali, animali), per poi mettere i due in relazione tra loro; infatti, già nell'essere umano è
insita la relazione con ciò che è determinato come "essere" attraverso il riferimento, il riferirsi nel
senso del fruire, e che così è sottratto al suo presunto “in sé e per sé"» (La questione dell'essere, in
Segnavia, cit., pp. 356-357).
N.B. Sebbene la filosofia di Heidegger ruoti, tutta quanta, intorno all'«essere», bisogna dire che,
proprio questo termine, così compromesso con la tradizione filosofica, ha finito, ai suoi occhi, per
risultare insoddisfacente. Come mostrano l'uso della grafia arcaica Seyn o la cancellatura
cruciforme di Sein (che allude alla necessità di difendersi dal modo di pensare metafisico). Questo
spiega il privilegiamento dei concetti di Lichtung e di Ereignis rispetto a quello di essere: «Non c'è
più spazio nemmeno per il nome essere», leggiamo nei Seminari (anche se, di fatto, Heidegger ha
continuato a farne uso). E spiega l'insoddisfazione nei confronti della stessa nozione antimetafisica
di differenza ontologica, che, in quanto <non» fra essere ed ente, sembra pensare l'es-sere a
partire dall'ente, ossia in modo ancora metafisico.
7. La centralità dell'essere e la polemica antiumanistica e antiesistenzialistica
Come si è visto, nel secondo Heidegger assistiamo ad un progressivo spostamento di accento
dall’uomo all'essere, ovvero al tentativo di non pensare più l'essere e il mondo a partire dall'uomo,
ma l'uomo e il mondo a partire dall'essere. E ciò alla luce della consapevolezza secondo cui siamo
su di un piano «dove c'è principalmente l'essere» e non, come vorrebbe Sartre, «su di un piano
dove vi sono soltanto gli uomini», (Lettera sull'«umanismo», cit., p. 287). Al punto che il problema
intorno all'essenza dell'uomo cessa di essere un problema intorno all'uomo per divenire un
problema intorno all'essere. Da ciò l'impostazione antiumanistica che caratterizza il pensiero della
Kehre .
Heidegger considera umanistica ogni dottrina che «spieghi e valuti l'ente nel suo insieme a partire
dall'uomo e in vista dell'uomo» (Sentieri interrotti, trad. it., La Nuova Italia, Firenze 1984, p. 98),
ossia ogni teoria che, facendo dell'uomo la misura dell'essere, subordina l'essere all'uomo. Ne
segue che l'umanismo, all'opposto di quanto si ritiene comunemente, non è una dottrina
«antimetafisica», ma un pensiero che fa parte integrante della storia della metafisica e del suo
oblio dell'essere. Al punto che oltrepassare la metafisica significa oltrepassare l'umanismo e
viceversa.
Contro l'umanismo — e contro il pensiero moderno — Heidegger afferma che l'uomo non è il
«padrone dell'ente», ma il «pastore dell'essere». Lungi dall'essere il «soggetto» dell'ente o colui
che decide dell'essere, “L'uomo è piuttosto "gettato" dall'essere stesso nella verità dell'essere, in
modo che, così e-sistendo, custodisca la verità dell'essere, affinché nella luce dell'essere l'ente
appaia come quell'ente che è. Se e come esso appaia [...] non è l'uomo a deciderlo. L'avvento
dell'ente riposa nel destino dell'essere» (Lettera sull'«umanismo», cit., pp. 283-84). Infatti, non è
l'uomo che, decidendo di se stesso e dell'ente, sostiene e determina l'essere, ma è la storia
dell'essere che «sostiene e determina ogni condition et situation humaine» (ivi, p. 268).
Queste tesi, che formano il nucleo teorico della Lettera, trovano la loro esemplificazione sia nella
ripetizione ontologica dell'analitica esistenziale, sia nella teoria heideggeriana dell'arte e del
linguaggio. Per quanto concerne il primo punto, Heidegger, tramite il già citato processo di
«eventualizzazione degli esistenziali», si sforza di riportare gli esistenziali all'essere in quanto
evento. Innanzitutto, l'esistenza (che Heidegger modifica anche ortograficamente, scrivendo Exsistenz, anziché Exsistenz), cessa di essere il movimento o il progetto con cui l'uomo si rapporta
all'essere per divenire ,Te-statico stare-dentro nella verità dell'essere». Analogamente,
l'inautenticità e la deiezione cessano di essere modalità improprie dell'umano stare al mondo per
divenire modalità improprie del rapporto dell'uomo con la verità, finendo per coincidere con
l'oblio dell'essere: «L'oblio della verità dell'essere a favore dell'imporsi dell'ente, non pensato nella
sua essenza, è il senso di ciò che Sein und Zeit chiama "deiezione"» (ivi, p. 285). A sua volta, il
progetto cessa di essere l'espressione di un'attività umana per divenire la manifestazione di
un'iniziativa dell'essere: «Nel progettare, chi getta non è l'uomo, ma l'essere stesso, il quale
destina l'uomo nell'e-sistenza dell'esser-ci come sua essenza» (ivi, p. 290). Parallelamente, la storia
cessa di identificarsi con il mero compiersi dell'attività umana per divenire «invio di un destino»
cioè storia dell'essere. E così via. Per quanto concerne l'arte (v. par. 8.1) Heidegger lascia intendere
come essa non sia il risultato di una ,creazione» soggettiva dell'artista, ma l'esito di un porsi in
opera della verità stessa, la quale agisce non per iniziativa dell'artista, ma tramite l'artista. Al
punto che l'opera d'arte cessa di configurarsi come una produzione umana per divenire un evento
dell'essere stesso. A proposito del linguaggio (v. par. 8.2), in cui l'antiumanismo di Heidegger
raggiunge il proprio apice, il filosofo afferma che chi parla, nel linguaggio, non è l'uomo, ma il
linguaggio stesso (Die Sprache spricht). Al punto che non è l'uomo ad avere in potere il linguaggio,
quanto il linguaggio ad avere in potere l'uomo (che può pensare solo ciò che rientra nel quadro
linguistico di cui dispone). Con l'evidente conseguenza che, se l'essenza dell'uomo è il linguaggio e
il linguaggio è affare dell'essere, l'essenza dell'uomo non è (principalmente) affare dell'uomo, ma
(principalmente) affare dell'essere.
L'antiumanismo heideggeriano rappresenta un'ulteriore conferma di quanto si è detto circa la sua
concezione dell'essere e dei suoi rapporti con l'uomo. Infatti, dire che l'uomo è un progetto
gettato in cui, chi ‹getta», è l'essere o sostenere che chi parla è il linguaggio, significa ribadire, in
concreto, che l'uomo esiste di volta in volta in orizzonti storico-culturali che precedono la sua
progettualità cosciente. Orizzonti a cui «appartiene», ma di cui non è il ,,soggetto» o l'autore. Più
in particolare, il progetto risulta gettato in quanto il linguaggio che lo costituisce non è una
«creazione» dell'uomo che lo parla, ma qualcosa di «ricevuto», a cui egli risulta «consegnato».
Tant'è che non è l'uomo a disporre delle proprie precomprensioni linguistiche, cioè delle proprie
anticipazioni di senso (che gli sono date e che egli non costruisce e non controlla), ma sono queste
ultime a disporre dell'uomo e delle sue possibilità interpretative.
Per effetto di Sartre, che aveva identificato l'esistenzialismo con l'umanismo, la polemica
antiumanistica si accompagna, in Heidegger, alla polemica antiesistenzialistica. L'esistenzialismo
viene tacciato di essere una filosofia antropologica e umanistica, dimentica del fatto che
«quel che conta è l'essere, non l'uomo» (ivi, p. 268).
In particolare, Heidegger accusa Sartre di essere rimasto all'interno della metafisica tradizionale e
della sua dimenticanza originaria dell'essere: «Sartre 1.. .] esprime così il principio fondamentale
dell'esistenzialismo: l'esistenza precede l'essenza. Qui egli assume existentia ed essentia nel
significato della metafisica, la quale, da Platone in poi, dice: l'essenza precede l'esistenza. Sartre
rovescia questa tesi, ma il rovesciamento di una tesi metafisica rimane una tesi metafisica. Come
tale, anche questa tesi resta, con la metafisica, nell'oblio della verità dell'essere» (ivi, p. 281). La
contrapposizione antiumanistica all'umanismo, puntualizza Heidegger, non significa che tale
pensiero «propugni
l'inumano» e «svaluti la dignità dell'uomo». Semmai è l'umanismo che, mettendo tra parentesi
l'essere, finisce per abbassare l'uomo: «le supreme determinazioni umanistiche dell'essenza
dell'uomo non esperiscono ancora l'autentica dignità dell'uomo. In questo senso, il pensiero di
Sein und Zeit è contro l'umanismo […] perché non pone l'humanitas dell'uomo a un livello
abbastanza elevato» (ivi, p. 283). Infatti, prosegue e ribadisce Heidegger, la dignità di fondo
dell'uomo non risiede nel dominio tecnico dell'ente, ma nella custodia ontologica della verità
dell'essere: «la maestà essenziale dell'uomo non risiede nell'essere la sostanza dell'ente in quanto
suo "soggetto" e nel far dissolve-re, in quanto despota dell'essere, l'esser ente dell'ente nella [...]
celebrata "oggettività". L'uomo è piuttosto "gettato" dall'essere stesso nella verità dell'essere, in
modo che, così e-sistendo, custodisca la verità dell'essere» (ivi, p. 283).
L'antiumanismo heideggeriano non implica una cancellazione dell'uomo a favore dell'essere, come
se nel pensiero di Heidegger, analogamente a quanto avviene nel sistema di Hegel, non ci fosse
più posto per l'uomo, ovvero per le sue iniziative coscienti e la sua libertà. Infatti, pur parlando del
«destino dell'essere» (Geschick des Seins), Heidegger precisa che l'espressione Geschick va intesa
nel senso di insieme (Ge) di ciò che è inviato (schicken = inviare) all'uomo dall'essere, lasciando
intendere come ciò che egli chiama «destino destinante» non vada interpretato in modo (ancora)
metafisico, cioè alla stregua di una struttura necessaria o di un fato inesorabile, bensì (v. il
concetto di Ereignis) come una specie di dono o di appello che non esclude, ma sottintende, una
risposta da parte dell'uomo. L'iniziativa di quest'ultimo, pur essendo antiumanisticamente
ridimensionata, non risulta, per questo, annullata: «Sempre l'uomo è governato dal destino del
disvelamento. Ma non si tratta mai della fatalità di una costrizione. Infatti, l'uomo diventa libero
solo nella misura in cui, appunto, appartiene all'ambito del destino e così diventa un ascoltante
(ein Heirender), non però un servo (ein Ildriger)» (La questione della tecnica, in Saggi e discorsi,
trad. it., Mursia, Milano 1976, pp. 18-19).
Ne segue che l'antiumanismo di Heidegger non deve essere interpretato alla stregua di una
semplice antitesi, o di un puro capovolgimento, dell'umanismo. Non si tratta «di sostituire a una
prospettiva in cui tutto dipende dal soggetto [...] una prospettiva in cui tutto dipenda, invece,
dall'essere, inteso […] come ciò che al soggetto si contrappone» (Vattimo), dimenticando che
l'essere, in quanto Ereignis, è «un accadere che non è mai sovrapersonale, ma neppure personale,
è un fare che non è mai senza subire e un subire che non è privo di responsabilità partecipe» (F.
D'Agostini). Infatti, come si è visto, una prospettiva di questo tipo, essendo costretta a pensare la
relazione uomo-essere sulla base di una contrapposizione metafisica fra soggetto e oggetto,
anziché sulla base di una loro coappartenenza originaria, non coinciderebbe con un
«superamento», ma con un semplice «rovesciamento» della metafisica, ossia con una posizione
interna alla metafisica stessa.
La tecnica
La metafisica trova il proprio compimento nella tecnica, che è la metafisica realizzata a livello
planetario. A partire dagli anni Trenta, anche per influsso di Scheler e di Ernst Jünger, Heidegger
comincia a scorgere, nella tecnica, la figura epocale tipica del nostro tempo, ossia il fenomeno che
qualifica, in tutti i suoi aspetti, la civiltà contemporanea. Fenomeno che egli analizza in una serie di
conferenze del 1949, la più importante delle quali è L'imposizione o L'impianto (Das Gestell),
successivamente riedita con il titolo La questione della tecnica (Die Frage nach der Technik).
L'indagine di Heidegger non verte sulle manifestazioni della tecnica, ma sull'essenza della tecnica.
Essenza che, per il filosofo, «non è affatto qualcosa di tecnico». Da ciò la caratteristica della sua
meditazione, che tende a configurarsi come un pensiero non-tecnico sulla tecnica, avente per
oggetto l'essenza non-tecnica della tecnica. Heidegger dichiara che la tecnica è «un modo del
disvelamento« (La questione della tecnica, in Saggi e discorsi, cit., p. 9). Vediamo in che senso.
A suo giudizio, la tecnica era pensata dai Greci in termini di pro-duzione, ossia come un rendere
manifesto (o dis-velato) ciò che prima non era tale (ad es. chi costruisce una cosa o modella un
calice manifesta, o porta alla presenza, qualcosa che prima risultava assente). Anche la tecnica
moderna, prosegue Heidegger, è un modo del disvelamento, che tuttavia non si dispiega nella
forma della semplice produzione, ma in quella della pro-vocazione (Herausforden), ossia del trarre
fuori dalla natura energia da accumulare e da impiegare. In altri termini, a differenza della tecnica
degli antichi, che si limitava a favorire l'opera della natura e a seguirla nei suoi autonomi
meccanismi, la tecnica dei moderni si configura come un'accumulazione di energia naturale messa
a disposizione dell'uomo:
«Il disvelamento che vige nella tecnica moderna è una pro-vocazione [..,]. Ma questo non vale
anche per l'antico mulino a vento? No. Le sue ali girano sì spinte dal vento, e rimangono
dipendenti dal suo soffio [...] il mulino a vento non ci mette a disposizione le energie delle correnti
aeree perché le accumuliamo. All'opposto, una determinata regione viene pro- vocata a fornire
all'attività estrattiva carbone e minerali. La terra si disvela ora come bacino carbonifero, il suolo
come riserva di minerali. In modo diverso appare il terreno che un tempo il contadino coltivava,
quando coltivare voleva ancora dire accudire e curare [ossia quando l'agricoltura non era ancora
industria meccanizzata]. L'opera del contadino non provoca la terra del campo. Nel seminare il
grano essa affida le sementi alla forza di crescita della natura e veglia sul loro sviluppo» (ivi, p. 11).
Analogamente, la centrale idroelettrica «non è costruita nel Reno come l'antico ponte di legno che
da secoli unisce una riva all'altra. Qui è il fiume, invece, che è incorporato nella costruzione della
centrale. Esso è ciò che ora, come fiume, è, cioè produttore di forza idrica, in base all'essere della
centrale». Da qui la profonda differenza fra il Reno di un tempo, quello di cui parla Hölderlin nelle
sue liriche, e il Reno di oggi: «Si obietterà che il Reno rimane pur sempre il fiume di quella regione.
Può darsi, ma come? Solo come oggetto "impiegabile" per le escursioni organizzate da una società
di viaggi, che vi ha messo su una industria delle vacanze» (ivi, p. 12).
La pro-vocazione tecnica consiste quindi nel fatto che l'energia nascosta dalla natura viene messa
allo scoperto, ossia immagazzinata, trasformata, ripartita ecc. L'energia accumulata assume la
forma di un «fondo» (Bestand) in cui ogni cosa trova la sua precisa collocazione, cessando di
essere un semplice« oggetto» per divenire una «riserva di energia» (obbediente alla logica della
«ordinabilità» e dell'«impiego dell'impiegabile»). Ad esempio, l'aria cessa di essere vento in poppa
per divenire fornitura di ossigeno; il suolo cessa di essere ciclica fecondità naturale per divenire
agricoltura programmata ecc. «Ci sono ormai soltanto risorse: depositi, riserve, mezzi« (Seminari,
cit., p. 141).
Questo modo di considerare la tecnica conduce Heidegger a capovolgere il tradizionale rapporto
fra scienza e tecnica: «il modo corrente di rappresentarsi il rapporto tra scienza della natura e
tecnica dovrebbe essere capovolto: non è la scienza della natura il fondamento della tecnica, bensì
è la tecnica moderna il tratto fondamentale [...] della scienza moderna della natura» (Linguaggio
tramandato e linguaggio tecnico, trad. it., ETS, Pisa 1997, p. 43).
Più profondamente, scienza e tecnica costituiscono aspetti connessi e interdipendenti di
quell'unico fenomeno globale che è la pro-vocazione: «Questo capovolgimento, tuttavia, sebbene
si avvicini alla cosa, non ne coglie il nucleo. Riguardo al rapporto tra la scienza moderna della
natura e la tecnica moderna, bisogna riflettere sul fatto che, quanto vi è di più proprio in
entrambe, la loro comune origine, si nasconde in ciò che abbiamo chiamato il porre che provoca
(ivi, pp. 43-44).
Per descrivere «l'essenza» della tecnica moderna Heidegger usa il termine Gestell. In tedesco
questa parola indica abitualmente una suppellettile, come un piedistallo o uno scaffale. Sulla
falsariga di altre parole (Ge-birg = massiccio di montagne), Heidegger la scompone nel prefisso Ge
(«insieme») e nel verbo stellen («porre»»), attribuendole il significato di totalità del porre tecnico.
Totalità che assume la forma di una gigantesca macchina al servizio della volontà di potenza,
nell'ambito della quale l'uomo, ponendo le cose come oggetto di manipolazione, risulta a sua volta
sollecitato a nuove prestazioni, in una sorta di circolo senza fine.
In quanto modo del disvelamento, il Gestell (che Volpi traduce con «impianto» e Vattimo con «imposizione», termine che unisce la realtà del porre con quella del costringere) non dipende da
un'iniziativa (o da una «macchinazione») umana, ma dall'essere e dal suo destino. Rifiutando la
rappresentazione antropologico-strumentale della tecnica, ossia quella prospettiva che fa, di essa,
un mezzo e un'attività dell'uomo, Heidegger dichiara che «L'im-posizione è un invio del destino
come ogni modo di disvelamento» (La questione della tecnica, cit., p. 18). In altri termini, l'uomo
provoca la realtà, cioè la riduce a «fondo», perché, da un certo punto di vista, è lui stesso provocato in tal senso, ossia perché si trova ad esistere in quello storico e specifico modo del
disvelamento che è il Gestell stesso: «Chi compie il richiedere pro-vocante mediante il quale ciò
che si chiama il reale viene disvelato come "fondo"? Evidentemente l'uomo [...] Ma sulla
disvelatezza entro la quale di volta in volta il reale si mostra o si sottrae, l'uomo non ha alcun
potere [...] Solo nella misura in cui l'uomo è già, da parte sua, provocato a mettere allo scoperto le
energie della natura, questo disvelamento impiegante può verificarsi» (ivi, p. 13).
Passando dall'analisi alla diagnosi, Heidegger sostiene che nel mondo della tecnica alberga un
«pericolo» che non proviene, innanzitutto, dagli effetti mortali che possono avere le macchine, ma
dal fatto che, a causa della tecnica, può andare smarrita: 1) l'essenza dell'uomo; 2) l'essenza della
verità. Per quanto concerne il primo punto, quando il disvelato non si presenta neanche più come
«oggetto», ma solo come «fondo» e l'uomo stesso, nell'assenza di oggetti, appare solo più colui
che impiega e amministra il fondo, allora l'uomo cammina sull'orlo estremo del precipizio, ossia là
dove egli stesso può essere preso solo più come fondo: «E tuttavia proprio quando è sotto questa
minaccia l'uomo si veste orgogliosamente della figura di signore della terra. Così si viene
diffondendo l'apparenza che tutto ciò che si incontra sussista solo in quanto è un prodotto
dell'uomo. Questa apparenza fa maturare un'ulteriore ingannevole illusione [...] per la quale
sembra che l'uomo, dovunque, non incontri più altri che se stesso [...] In realtà, tuttavia, proprio se
stesso l'uomo di oggi non incontra più in alcun luogo; non incontra più, cioè, la propria essenza»
(ivi, p. 21).
Per quanto concerne il secondo punto, quando quella peculiare forma di disvelamento che è l'imposizione viene vissuta come unica forma di disvelamento, ossia quando l'uomo, dando per
scontata l'equazione essere = Gestell, non si accorge che il Gestell è soltanto una modalità del
disvelamento e precisamente la sua modalità nichilistica, cioè quella in cui dell'essere come tale
«non ne è più nulla», allora egli abdica di fatto alla sua essenza di pastore dell'essere e di custode
della verità. In altri termini, in quanto metafisica realizzata, la tecnica coincide con il nichilismo
compiuto, ovvero con quell'estremo oblio dell'essere che si manifesta sotto forma di un dominio
incontrastato della volontà di potenza: nella configurazione del Ge-Stell si compie per Heidegger la
decisione metafisica iniziatasi col pensiero di Platone, nel senso che si arriva alla realizzazione
essenziale del padroneggiamento conoscitivo ed operativo dell'ente da parte dell'uomo pensato
come soggetto-padrone, e quindi alla piena dimenticanza dell'essere. Al punto che se la tecnica è
la metafisica realizzata, la metafisica è la tecnica prefigurata.
«Ma là dove c'è il pericolo, cresce anche ciò che salva»
ripete Heidegger con Hölderlin, intendendo dire che la tecnica, in quanto pericolo supremo,
contiene, in se stessa, anche una chance di salvezza suprema. La tecnica è quindi un «Giano
bifronte», poiché se da un lato il Gestell produce un sempre più frenetico installarsi dell'uomo
nella dimensione nichilistica della tecnica, dall'altro contiene la possibilità di un disvelamento più
originario, in grado di fare spazio alla verità dell'essere. Tant'è che, nell'oscurità del Gestell,
Heidegger scorge «un primo incalzante lampeggiare dell'Ereignis», ossia della luce post-metafisica
dell'essere (Identità e differenza, cit., pp. 13-14), arrivando a sostenere che «l'impianto è, per così
dire, il negativo fotografico dell'evento» (Seminari, cit., p. 139).
In virtù di questo costitutivo rimandare all'essere-evento, di cui la parola poetica è manifestazione
privilegiata, la tecnica non rappresenta una contingenza storica da fuggire romanticamente, ma un
evento destinale da approfondire filosoficamente, cioè da assumere nella sua ambivalenza
originaria di possibile annuncio, nel pericolo, della salvezza. In ogni caso, l'uomo non ha nessun
«potere» sulla tecnica. Infatti, poiché la tecnica non è uno strumento (dell'uomo) ma un modo del
disvelamento (dell'essere), essa costituisce un evento che sfugge alla nostra progettualità. Ecco
taluni testi inequivocabili in proposito:
«La tecnica nella sua essenza è qualcosa che l'uomo di per sé non è in grado di dominare» (Ormai
solo un dio ci può salvare, cit., p. 132).
«L'uomo non ha in mano la tecnica. Egli è il giocattolo di quest'ultima» (Seminari, cit., p. 143).
«L'essenza della tecnica non può essere indotta alla trasformazione del suo destino senza la
collaborazione dell'essenza dell'uomo. Con ciò tuttavia la tecnica non è oltrepassata
umanamente» (La svolta, trad. it., Il Melangolo, Genova 1990, p. 13).
«La tecnica, la cui essenza è l'essere, non si lascia mai sopraffare dagli uomini. Altrimenti l'uomo
sarebbe il signore dell'essere (der Herr des Seins)» (ivi, p. 11).
Di fatto, per Heidegger, di fronte alla tecnica non rimane che «l'attesa», in quella modalità
pensante che è il domandare ontologico, cioè la riflessione sull'essere: «quanto più ci avviciniamo
al pericolo, tanto più chiaramente cominciano a illuminarsi le vie verso ciò che salva, e tanto più
noi domandiamo. Perché il domandare è la pietà del pensiero» (La questione della tecnica, cit., p.
27).
Nelle grandi dottrine politiche del Novecento — «comunismo», «fascismo» e «democrazia
mondiale» — Heidegger scorge soltanto nomi diversi dell'«universale dominio della volontà di
potenza», ossia manifestazioni concomitanti di quella organizzazione tecnica del mondo che
manipola le cose e sfrutta la terra, all'insegna del più sfrenato consumismo: «Gli slogan del maggio
1968 contro la società dei consumi giunsero tanto in profondità da riconoscere nel consumo il
volto attuale dell'essere?» (Seminari, cit., p. 142). Per cui, lungi dal giocare una figura della
modernità contro le altre, Heidegger ha finito per equiparare tutte le manifestazioni della
modernità. Infatti, se negli anni Trenta egli aveva visto nell'hitlerismo una forma di «grande
politica» in grado di cambiare totalmente la Germania e il mondo, in seguito ha finito per scorgere,
nel nazismo, un'espressione conseguente della logica «nichilistica» e «tecnica» della modernità,
pervenendo ad una sfiducia complessiva nella politica — ribadita anche nelle dichiarazioni del
dopoguerra.
Il «superamento» della metafisica e «l'altro pensiero»
La «fine» della filosofia
Heidegger fa coincidere la fine della metafisica con la fine della filosofia: «Il pensiero a venire non
è più filosofia, perché esso pensa in modo più originario della metafisica, termine che indica la
stessa identica cosa» (Lettera sull'«umanismo», cit., p. 314).
Più in particolare, Heidegger dichiara che la filosofia è giunta alla fine (in ihr Ende eingegangen ist)
poiché essa, nata come domanda sulle diverse regioni dell'essere, ha poi specificato il suo
interrogare, sino a smembrarsi nelle singole scienze, lasciando alla cibernetica il compito di
unificare i diversi ambiti del sapere: «La filosofia si dissolve in scienze autonome: la logistica, la
semantica, la psicologia, la sociologia, l'antropologia culturale, la politologia, la poetologia, la
tecnologia [...] La nuova scienza che unifica [...] tutte le varie scienze si chiama cibernetica» (La
questione della determinazione della "cosa" del pensiero, trad. it. Filosofia e cibernetica, ETS, Pisa
1988, p. 31) (1).
La fine della filosofia implica l'avvento di un pensiero essenziale antitetico al pensiero calcolante
della scienza-tecnica: «Il pensare i cui pensieri non solo non calcolano, ma in generale sono
determinati dall'altro rispetto all'ente, lo si chiami pensiero essenziale. Esso, invece di fare i conti
con l'ente contando sull'ente, si prodiga nell'essere per la verità dell'essere» (Poscritto a Che cos'è
metafisica? in Segnavia, cit., p. 263). Tale pensiero essenziale, che non ha nulla a che vedere con la
scienza (in quanto «la scienza non pensa») (2), si concretizza in un «pensiero memorante»
(Andenken) avente lo scopo di mantenere vivo il problema dell'essere, al di là del lungo oblio che
ha caratterizzato la metafisica lungo i secoli: «Memoria è il raccogliersi della rimemorazione
(Andeken) presso ciò che è prima di ogni altra cosa da considerare» (Che cosa significa pensare? in
Saggi e discorsi, cit., p. 91). E questo, come si è visto, all'insegna di un pensiero in grado di attuare
un «salto» (Sprung) al di là della concettualità logica della filosofia e di coniugare pensare e
poetare. Pensare-poetare e poetare-pensare di cui i primi filosofi greci, per quanto concerne
l'antichità, e Hölderlin, per quanto concerne la modernità, sono i più alti modelli. Da ciò l'idea di
un pensiero post-metafisico e post-filosofico capace di incarnare quella nuova ontologia di cui
Heidegger si è fatto banditore.
Il superamento della metafisica (e quindi della tecnica del nichilismo) non è opera dell'uomo. Se
mai è possibile un pensiero postmetafisico, esso non può che scaturire da un diverso accadere
dell'essere. Le affermazioni di Heidegger a questo riguardo sono esplicite. Poiché l'essenza del
nichilismo non è una questione (Sache) dell'uomo, bensì dell'essere, in quanto «l'essere stesso si è
recato nella storia in cui di se medesimo non ne è niente» (Nietzsche, cit., p. 833), ne segue che
l'oblio dell'essere si configura, più profondamente, come un essere-abbandonati dall'essere
stesso: «l'ente è abbandonato dall'essere L..] L'essere stesso si sottrae» (ivi, p. 826). Ma se la
metafisica non si identifica con un «errore» dell'uomo, bensì con la storia o il destino dell'essere
nel suo darsi e sottrarsi epocale, ne segue che l'evento onto-storico del superamento della
metafisica non è il risultato di un progetto umano, ma qualcosa che accade a partire dall'essere,
stesso: «Come e quando sia destino che accada, nessuno lo sa (weiß niemand)» (La svolta, cit., p.
17); «Superare e voler superare il nichilismo [...] significherebbe che l'uomo va da sé contro
l'essere stesso nel suo rimanere assente. Ma chi, o che cosa, sarebbe mai abbastanza potente da
andare contro l'essere stesso [...] e da portarlo a sottomettersi all'uomo?» (Nietzsche, cit., p. 834).
In conclusione, se tutto è nell'essere e dall'essere e il pensiero stesso è dell'essere, nel doppio
senso del genitivo («Il pensiero è dell'essere in quanto, fatto avvenire dall'essere, all'essere
appartiene. Il pensiero è nello stesso tempo pensiero dell'essere in quanto, appartenendo
all'essere, è all'ascolto dell'essere»), ne segue che l'uomo non può esercitare alcuna forma di
padronanza nei confronti dell'essere. L'unica cosa che rimane all'uomo, in quanto tramite attivo (e
non solo passivo) della storia dell'essere, è l'attesa nutrita di pensiero. Infatti la sua essenza, come
sappiamo, «consiste nell'essere l'attendente, che attende l'essere custodendolo in modo
pensante» (La svolta, cit., p. 19).
L'essere e Dio
Da quanto si è detto deriva quel tipico atteggiamento di abbandono alle cose e all'essere
(Gelassenheit) che, in quanto fidente lassen (lasciar essere), si contrappone al protervio wollen
(volere) della soggettività moderna. Atteggiamento che fa tutt'uno con il tenersi aperti per il
mistero (für den Geheimnis) e che il filosofo, sulla base della sua concezione dell'essere come
Abgrund (assenza di fondamento), ossia come profondità o abisso che non è fondato da alcunché,
distingue dalla tradizionale ricerca di procedimenti dimostrativi (procedimenti ai quali oppone il
detto di Silesius: «la rosa fiorisce perché fiorisce»).
«Denken ist Danken»
«Pensare è ringraziare», sostiene Heidegger, connettendo fra di loro Denken (pensare), Danken
(ringraziare) e Gedächtnis (memoria, nel senso dell'Andenken).
Questa concezione del pensare come affidamento e ringraziamento (per il dono dell'essere) spiega
la vicinanza di Heidegger alla problematica religiosa. Vicinanza che egli, ad un certo punto, ha
espresso in maniera sibillina, dichiarando che ormai solo un Dio ci può salvare: «la filosofia non
potrà produrre nessuna immediata modificazione dello stato attuale del mondo. E questo non vale
soltanto per la filosofia, ma anche per tutto ciò che è mera intrapresa umana. Ormai solo un Dio ci
può salvare» (Ormai ecc., cit., p. 136). La portata filosofica di tale espressione non è chiara. Come
non è del tutto chiara la posizione complessiva di Heidegger circa il problema di Dio.
Al di là delle perduranti ambiguità e reticenze, possiamo comunque affermare che Heidegger: 1)
oppone il Dio vivente della fede al Dio astratto dei filosofi, denunciando la sostanza irreligiosa
della metafisica ontoteologica (alla cui divinità «l'uomo non può rivolgere preghiere, né offrire
sacrifici») al punto di ritenere che un pensiero privo del Dio «filosofico» risulti più vicino al Dio
«divino» (Identità e differenza, cit., pp. 35-36); 2) si rifiuti di identificare l'essere con Dio: «che
cos'è l'essere? Esso "è" se stesso [...] L' "essere" non è né Dio né un fondamento del mondo»
(Lettera sull'«umanismo», cit., p. 284). L'essere non è né il Dio dei filosofi (Dio come Causa sui e
Valore sommo) né il Dio delle religioni (il Tu a cui l'uomo si rivolge con le preghiere). L'essere non
crea il mondo (in senso biblico) né lo plasma (in senso platonico).
Certo, l'essere non è Dio. Tuttavia, puntualizza Heidegger, il manifestarsi di Dio può avvenire solo
nella dimensione dell'essere (o dell'Ereignis), poiché soltanto nella vicinanza dell'essere «si compie
[...] la decisione se e come [...] nell'albeggiare del sacro possano cominciare di nuovo ad apparire
Dio e gli dèi» (ivi, p. 291). Infatti, il sacro, che è lo spazio della divinità — la quale è a sua volta lo
spazio di Dio e degli dèi — giunge ad apparire «solo se prima, dopo lunga preparazione, l'essere
stesso viene a diradarsi ed è esperito nella sua verità» (ivi). In altri termini, se l'assenza di Dio si
accompagna all'assenza dell'essere, l'avvento dell'essere si accompagna ad un nuovo (possibile)
avvento di Dio. Niente da stupirsi, poste queste premesse, se la riflessione heideggeriana su Dio
finisce per risolversi nel vago di un'indeterminata attesa. Nell'ambito di questa vaghezza, anche
l'espressione «ormai solo un Dio ci può salvare» — suggestiva metafora per dire che l'uomo non
può salvarsi da solo — non può che risultare indeterminata. Al di là delle supposizioni dei critici,
l'unica cosa certa è che, per Heidegger, il possibile avvento di Dio non può attuarsi né nelle forme
tradizionali dell'ontoteologia metafisica né nelle forme consuete delle religioni positive,
«confessionalmente intese».
Le ambiguità dell'ontologia heideggeriana: le interpretazioni di «destra» e di «sinistra»
Nella teoria heideggeriana del superamento della metafisica alberga un'ambiguità di base. Infatti,
se da un lato Heidegger sostiene che l'essere non è mai afferrabile come tale, cioè sotto forma di
una presenzialità oggettiva di tipo ontico-metafisico, dall'altro ipotizza l'avvento di una nuova età
in grado di procedere oltre il bimillenario oblio che ha caratterizzato la metafisica occidentale.
Analogamente, se da un lato le opere del filosofo documentano lo sforzo di «pensare» l'essere
attraverso l'adozione di un linguaggio evocativo di tipo poetico, dall'altro tendono a suggerire
l'idea secondo cui l'unica ontologia possibile dopo la metafisica è il lavoro interpretativo sulla
storia dell'essere, ovvero il ripercorrimento ermeneutico dei grandi momenti della metafisica
stessa, quali si esprimono nelle sentenze dei pensatori e dei poeti. Da ciò l'esistenza di due letture
di fondo del pensiero heideggeriano: una di «destra» e l'altra di «sinistra» (termini che, in questo
caso, non hanno una valenza politica, bensì filosofica).
La lettura di destra interpreta il superamento della metafisica alla stregua di un «ritorno» o di un
«disvelamento» dell'essere (non importa se in maniera diretta e positiva o in maniera indiretta e
negativa). Ritorno o disvelamento in grado di lasciarsi definitivamente alle spalle il nichilismo
moderno. La lettura di sinistra insiste invece sulla inoggettivabilità strutturale dell'essere, sia nel
senso di una concezione dell'essere come alterità irrisolvibile in identità (v. la filosofia della
differenza di Derrida) sia nel senso di un'ontologia postmetafisica in cui, dell'essere come tale,
ossia dell'essere nella sua presenzialità «forte», non ne è più nulla (v. il pensiero debole di
Vattimo). Lettura che si accompagna alla tesi secondo cui il lavoro di ripercorrimento della storia
della metafisica non si identificherebbe con una sorta di lavoro preparatorio, finalizzato alla
costruzione di una futura ontologia, ma coinciderebbe con «la forma definitiva del pensiero
dell'essere che ci è dato realizzare».
La lettura di sinistra, pur ammettendo che nei testi di Heidegger prevale una lettura di destra,
sostiene che il rischio di quest'ultima è di scambiare, per oltrepassamento della metafisica, una
semplice replica della metafisica della presenza: «Le ragioni per preferire la lettura di sinistra di
Heidegger — che egli stesso, per lo più, non scelse — si riassumono nel proposito di restare fedeli,
anche al di là della lettura dei suoi testi, alla differenza ontologica, cioè al programma di non
identificare l'essere con l'ente. Ora se si pensa, con le interpretazioni di destra, che l'essere possa
"ritornare" a parlarci al di là dell'oblio in cui è caduto; o anche se si ritiene che esso continui per
sempre a sfuggirci solo perché trascende le capacità del nostro intelletto e del nostro linguaggio
[...] in tutti questi casi sembra che si continui a identificare l'essere con l'ente. L'importanza che ha
in Heidegger la nozione […] di "metafisica come storia dell'essere" indica invece nel senso di una
concezione dell'essere in cui la differenza ontologica si attua proprio nel darsi dell'essere come
sospensione e come sottrarsi, (G. Vattimo, Oltre l'interpretazione, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 18).
Lettura, questa, che nel suo estremismo ermeneutico non fa che riproporre il problema della
irrisolta ambiguità ontologica di Heidegger sospeso tra il tentativo di ritornare ad un'origine
perduta oltre le deviazioni della metafisica e il ripercorrimento rammemorante ed errante della
storia delle sue interpretazioni.
In ogni caso, Heidegger ritiene che il rapporto del pensiero post-filosofico con la metafisica non sia
né di (semplice) negazione, né di (dialettico) superamento, bensì di (articolata) accettazionedistorsione. Circostanza che il filosofo riassume con il termine Verwindung: «La metafisica non si
lascia metter da parte come una opinione. Non si può lasciarsela alle spalle come una dottrina a
cui non si crede e che non si sostiene più [...] l'oltrepassamento della metafisica accade come
accettazione-approfondimento (Verwindung) dell'essere [...] la metafisica oltrepassata non
scompare. Essa ritorna sotto forma diversa...» (Saggi e discorsi, cit., p. 46). Pur mantenendo un
nesso letterale con überwinden, «superare», il termine Verwindung allude quindi, in virtù della
famiglia di significati che esso racchiude (guarigione, accettazione, rassegnazione, svuotamento,
distorsione, alleggerimento ecc.), al rimettersi da una malattia (in questo caso: la metafisica) nella
rassegnata consapevolezza che di essa siamo comunque destinati a portare le tracce.
Heidegger e il nazismo
L'adesione di Heidegger al nazismo rappresenta un fatto inquietante, che getta una luce sinistra
sulla sua persona e sulla sua opera. Un fatto enigmatico e «scandaloso» al tempo stesso. Com'è
possibile, ci si chiede, che il maggior pensatore del Novecento (o tra i maggiori del secolo) abbia
potuto avallare, con la propria autorità, un fenomeno aberrante come il nazionalsocialismo?
Com'è possibile che una mente come Heidegger abbia potuto simpatizzare con un regime che ha
assassinato milioni di uomini e che ha eretto il terrore a regola di sopravvivenza? Com'è possibile
che una filosofia di rilievo abbia potuto coesistere con una scelta politica infame, che ha fatto del
suo autore, come sostiene la Arendt, un «potenziale assassino»? L'intelletto comune, scriverà
Marcuse ad Heidegger, «si rifiuta di vedere in Lei un filosofo, dal momento che ritiene che filosofia
e nazismo siano fra loro inconciliabili» (Lettera del 28 agosto 1947).
Queste domande, che non hanno mai smesso di turbare le menti, sono tornate di attualità con
Heidegger et le nazisme (1987) di Victor Farias, un libro assai discusso (e discutibile), che però ha
avuto il merito di riproporre, a livello internazionale, l'interrogativo su quel «passato che non
passa» costituito dal problema dei rapporti «tra un grande pensiero e una piccola biografia» (A.
Marini).
Problema che in Italia e (ancor più) all'estero si è concretizzato in un dibattito che ha coinvolto i
mezzi di comunicazione di massa, a cominciare dai quotidiani e dai settimanali a larga tiratura.
Problema delicato e complesso, reso ancor più intricato dalle ambigue dichiarazioni di Heidegger e
dalla dubbia attendibilità delle sue testimonianze e autodifese. Un problema di cui lo storico della
filosofia, prima di ogni eventuale «soluzione», deve fornire un'adeguata «ricostruzione»,
riepilogando i momenti salienti di un dibattito tuttora in corso. Per fare chiarezza sull'argomento e
per fornire un organico quadro d'insieme (tuttora mancante) su di esso, divideremo la questione
in tre punti, corrispondenti a tre interrogativi di base: 1) quali sono stati i rapporti fra Heidegger e
il nazismo, inteso come movimento e regime politico?; 2) quali sono stati i rapporti fra Heidegger
e il nazismo, inteso come ideologia e «visione del mondo?»; 3) quali sono i rapporti tra la filosofia
di Heidegger e la sua opzione politica?
1) A proposito del primo punto, circolano due interpretazioni di fondo. Secondo una prima lettura
— presente presso i discepoli francesi di Heidegger e, in seguito, incarnata soprattutto da Francois
Fédier — l'adesione heideggeriana al nazismo sarebbe stata temporanea e parziale, cioè limitata al
periodo del Rettorato, e avrebbe il carattere di un incidente di percorso, ossia di uno
sbandamento momentaneo, dovuto a un «errore di giudizio». Errore grave e dalle conseguenze
funeste, da cui Heidegger si sarebbe prontamente ripreso, dando le dimissioni da Rettore e
ritirandosi a vita privata. Anzi, dopo gli anni 1933-34, Heidegger avrebbe praticato una forma di
«resistenza filosofica» al nazismo.
Per una seconda lettura, emblematicamente rappresentata da Farias, l'adesione heideggeriana al
nazismo non avrebbe la forma di uno sbandamento momentaneo, ma di una scelta radicata e
durevole. Heidegger si sarebbe mosso in consonanza con il movimento nazionalsocialista non solo
prima di pervenire al Rettorato ma anche in seguito. Infatti, anche dopo il '34 egli avrebbe
continuato ad essere nazista. Sia pure un nazista «rivoluzionario» e «della prima ora» e quindi
ostile al nazismo divenuto regime. Al punto da scorgere, nel nazismo realmente esistente, «un
sistema della rivoluzione tradita» (R. Safranski). Come puntualizza Farias, Heidegger avrebbe
optato: per la linea rappresentata da Ernst Röhm e dalle sue SA, cercando di dare con il proprio
pensiero una struttura filosofica a tale variante del nazionalsocialismo, in aperta opposizione alla
tendenza biologistica e razzista di Alfred Rosenberg ed Ernst Krieck. Questo contrasto si tradusse
in una violenta lotta personale per la direzione ideologica del movimento nazista.
Nel giugno del 1934 Hitler e la frazione di destra eliminarono Röhm, ponendo così fine a un
progetto le cui richieste massimalistiche avevano rischiato di provocare un intervento militare
appoggiato dal grande capitale industriale e finanziario. L'epurazione ebbe come conseguenza il
crollo di tutto quell'apparato intellettuale e politico che aveva fino allora sostenuto l'azione
politica di Heidegger (segnatamente gli organismi dirigenti del movimento studentesco nazista), e
una frattura tra lo stesso Heidegger, ormai isolato, e la politica ufficiale del Partito.
In tale temperie germina la convinzione del filosofo secondo cui, a partire dal giugno 1934, i nazisti
avrebbero tradito quella verità che era originariamente propria del loro movimento. Agli occhi di
Martin Heidegger sono stati i dirigenti nazionalsocialisti giunti alle posizioni di potere, e non lui, ad
aver abbandonato le autentiche idee naziste. Il regime, da parte sua, gli riservò una vigile
attenzione fino all'ultimo, e anche lo combatté come elemento frazionista, ma non considerandolo
mai un irriducibile avversario.
Martin Heidegger non spezzò mai i legami che lo tenevano organicamente unito al Partito
nazionalsocialista. I documenti conservati negli archivi della NSDAP testimoniano, tra l'altro, di
come egli sia restato tra i militanti effettivi e abbia continuato a pagare le quote d'iscrizione fino
alla fine della guerra, e di come non sia mai stato oggetto di censure né di processi politici di
qualsiasi sorta all'interno del partito» (Heidegger e il nazismo, cit., p. 5).
Il perdurante «nazismo» di Heidegger sarebbe confermato anche da talune testimonianze di
allievi. Tipiche, in questo senso, le dichiarazioni di K. Löwith (a cui Heidegger, nel 1936, avrebbe
ribadito che il nazionalsocialismo era «la via tracciata per la Germania») e di Heinz Bollinger
(«Durante il mio soggiorno a Friburgo [1938-43], tutti consideravano Martin Heidegger un nazista;
per me era Hitler in cattedra»). In attesa di nuovi documenti atti a comprovare o a smentire
questa seconda ipotesi (che oggi trova largo seguito) ci si può chiedere perché Heidegger abbia
prima simpatizzato e poi pubblicamente aderito al nazismo. Nella lettera del 1948, indirizzata a
Marcuse, Heidegger dichiara: «In merito al 1933: io mi aspettavo dal nazionalsocialismo un
rinnovamento spirituale di tutta la vita, una riconciliazione dei contrasti sociali e una salvezza
dell'Esserci occidentale dai pericoli del comunismo».
E nell'intervista del 1966 a Der Spiegel ribadisce: «A quell'epoca non vedevo altra alternativa. Data
la confusione generale delle opinioni e delle tendenze politiche rappresentate da trentadue partiti,
si trattava di trovare una posizione nazionale e soprattutto sociale» (Scritti politici, cit., p. 267). Per
cui, a differenza di Jaspers, che si era chiesto: «Com'è possibile che un ignorante come Hitler possa
governare la Germania?», Heidegger aveva finito per scorgere, nel Führer, l'astro nascente di un
nuovo inizio, cioè l'espressione di una «svolta» capace di tradurre in atto quella «rivoluzione di
tutto l'essere umano» di cui il filosofo parla in un corso su Platone del 1931-32: «Quello che
accadde con la presa di potere da parte dei nazionalsocialisti fu per Heidegger [...] molto di più che
un fatto politico». Fu «un atto nuovo della storia del mondo», «un sovvertimento epocale», «una
rivoluzione metafisica» (R. Safranski). Da ciò l'idealizzazione della figura di Hitler, considerata essa
stessa, al di là di ogni formula o programma di Partito, come l'autentica norma dell'agire: «Che le
regole del vostro essere non siano né formule dottrinali né "idee". Il Führer stesso, e lui solo, è la
realtà tedesca di oggi, ma è anche la realtà di domani e quindi la sua legge» (Scritti politici, cit., p.
149).
In seguito, cercando di minimizzare il proprio abbaglio storico-politico, Heidegger ricorderà come
anche Hölderlin ed Hegel si fossero sbagliati: «Simili errori sono già accaduti a figure più grandi:
Hegel vide in Napoleone lo spirito del mondo e Hölderlin scorse in lui il principio della festa, cui
erano invitati gli dèi e Cristo». Più solida è la replica heideggeriana secondo cui nel 1933-34 il
nazismo non aveva ancora palesato il proprio volto criminale, ovvero l'esortazione, rivolta dal
filosofo ai suoi critici, a non dare «un giudizio sull'inizio del movimento nazionalsocialista a partire
dalla sua fine» (Lettera a Marcuse). Tuttavia, anche questo argomento viene meno nell'ipotesi di
uno Heidegger durevolmente filonazista.
2) L'adesione heideggeriana al movimento politico, economico e sociale nazionalsocialista non si è
accompagnata a una parallela accettazione dell'ideologia ufficiale del regime. Lo stesso Farias
ammette che la fedeltà di Heidegger alla matrice nazionalsocialista risulta «plasmata in una forma
e in uno stile peculiarmente suoi» (op. cit., p. 9). Forma e stile che non sono né quelli del Mein
Kampf né quelli dei suoi teorici di spicco (come Rosenberg, Krieck ecc.). In effetti, fin dal 1933-34,
pur presentandosi come una sorta di autocoscienza filosofica della «missione storica» del popolo
tedesco, Heidegger risulta complessivamente estraneo, o tendenzialmente ostile, a taluni «dogmi»
di fondo della Weltanschauung nazista. Ad esempio, al biologismo razzista (secondo cui il mondo
spirituale e storico di un popolo sarebbe solo l'espressione o la sovrastruttura di una
predisposizione razziale di matrice fisica) e alla concezione politica del sapere (secondo cui il vero
è ciò che risulta utile al popolo). Anche l'antisemitismo, almeno negli scritti pubblici, risulta
assente. In particolare, in Heidegger non si trovano due obiettivi di fondo della politica hitleriana:
«lo sterminio delle razze nocive (la più nociva innanzitutto) e la fabbricazione di una razza di
signori» (F. Fédier). Obiettivi che facevano parte integrante del «nietzscheanesimo» del
nazionalsocialismo.
Il divario fra il pensiero di Heidegger e l'ideologia ufficiale nazista risulta ancor più evidente negli
anni seguenti. In particolare, nelle lezioni su Nietzsche, nell'ambito di una sotterranea
«discussione» (Auseinandersetzung) con il nazionalsocialismo, Heidegger arriva a scorgere, in
quest'ultimo, una manifestazione del nichilismo moderno. Infatti, se ancora durante il corso su
Schelling, nell'estate del 1936, Heidegger aveva citato Mussolini e Hitler come coloro che
avrebbero avviato un «contromovimento» d'opposizione al nichilismo, ora scorge, nel
nazifascismo, un'ulteriore espressione del nichilismo stesso. Tant'è che parlando della «intima
verità e grandezza» del nazismo (come avviene in Introduzione alla metafisica) Heidegger intende
alludere allo storico incontro della tecnica planetaria con l'uomo moderno, cioè al nazismo in
quanto espressione emblematica della civilizzazione mondiale all'insegna della tecnica. Di
conseguenza, «il nazionalsocialismo non gli appare più come un' uscita dalla modernità, ma come
una sua espressione particolarmente coerente. Scopre che lo stesso nazionalsocialismo è il
problema di cui aveva ritenuto che fosse la soluzione. Vede imperversare nel nazionalsocialismo il
furore della modernità: la corsa pazza del tecnicismo, il dominio e l'organizzazione» (R. Safranski).
Al di là di questa diversa maniera «filosofica» di rapportarsi al nazismo, che finisce per essere
ricondotto al destino nichilistico dell'Occidente, Heidegger ha mantenuto, nei suoi confronti, una
perdurante ambiguità. Infatti, non bisogna dimenticare che, proprio mentre sottoponeva il
nazionalsocialismo a una disamina volta a relativizzarne il significato metafisico, egli, come osserva
Farias, continuava a ostentare pubblicamente la propria adesione al movimento e al Partito, di cui,
come si è visto, avrebbe conservato, sino alla fine, la tessera. Inoltre, anche nel dopoguerra, il suo
confronto con il nazismo non ha mai assunto la veste esplicita di una sconfessione radicale e
globale. Anzi, pur accennando, a più riprese, allo «sbaglio> (mein Irrtuim) del 1933-34, egli ha
continuato a mantenere un ostinato silenzio sulle responsabilità e gli orrori del nazismo.
Significative le testimonianze di R. Bultmann, K. Jaspers e O. Pöggeler. Racconta il primo: «Tutto
era stato dimenticato. Se una qualunque ragione l'avesse mai legato al nazionalsocialismo, si
sarebbe ormai dissolta nella disillusione. Non c'era quindi alcun ostacolo fra di noi [...] "Ora — gli
dissi — devi ritrattare per iscritto come fece S. Agostino, non come ultima risorsa, ma per amore
della verità del tuo pensiero". A quel punto il volto di Heidegger divenne come di pietra. Si
allontanò senza dire una parola». Lamenta il secondo: «Non riesce a cogliere la profondità del suo
errore di un tempo: per questo non c'è in lui autentica trasformazione, ma piuttosto un gioco di
proiezioni e di occultamenti». Osserva il terzo: «Heidegger ha mai speso una parola su Auschwitz?
Il linguaggio del suo filosofare è capace di articolare una tale parola? ». Altrettanto duro il giudizio
di Habermas: «Heidegger era il maestro di tutti, Marcuse compreso, il faro a cui guardavamo.
Ebbene, non ha mai detto quella parola di condanna, di rifiuto, o anche solo di rincrescimento che
aspettavamo per poter continuare a stare con lui. Non parlo degli anni di guerra, anni in cui era
lecito perdere la testa, e tutti eravamo pronti a scusarlo per la sua ubriacatura hitleriana; ma di
dopo, dal '45 in poi, quando tutto si seppe dei lager, quando le immagini circolarono in ogni parte
del mondo, ed egli continuò a non dire nulla, anzi... ».
Anzi, l'asserito nesso fra nazismo e nichilismo, in virtù di quel processo che Habermas chiama
«astrazione per essenzializzazione», ha condotto Heidegger ad assimilare lo sterminio degli ebrei
alla meccanizzazione dell'agricoltura: «L'agricoltura è attualmente una industria elementare
meccanizzata; quanto alla sua essenza, la stessa cosa che la produzione di cadaveri nelle camere a
gas e i campi di sterminio, la stessa cosa che il blocco e la riduzione del paese alla fame, la stessa
cosa che la produzione di bombe ad idrogeno».
3) Anche a proposito del terzo punto, esistono due interpretazioni di base. La prima, escludendo
l'esistenza di un rapporto diretto fra il «nazismo» di Heidegger e la sua filosofia, ritiene di poterne
isolare il pensiero dall'impegno politico. La seconda, concependo la filosofia dell'essere come
organicamente connessa alla sua esperienza politica, sostiene che i suoi capisaldi teorici implicano
o riflettono l'adesione al nazismo.
Entrambe queste letture sono insoddisfacenti. La prima, perché, operando un taglio rigido fra
esistenza e filosofia, finisce per scindere la connessione fra vita e pensiero, dimenticando che è
sempre lo stesso uomo che filosofa e compie scelte politiche, per cui è sempre possibile ricercare
che cosa, nel pensiero di Heidegger, abbia potuto motivare la sua adesione al nazismo,
esattamente come è sempre possibile ricercare che cosa, in Hegel, abbia potuto motivare la sua
adesione alla monarchia prussiana. La seconda, perché, evidenziando in maniera altrettanto rigida
la connessione tra filosofia ed esperienza politica, pretende di individuare le costellazioni teoriche
che avrebbero necessariamente prodotto l'adesione heideggeriana al nazismo o che la
rispecchierebbero in maniera altrettanto necessaria.
Questo spiega perché una parte degli studiosi odierni sia — implicitamente o esplicitamente —
orientata verso un terzo modello di lettura. Modello che discorre di nessi possibili — e non già di
connessioni necessarie — tra filosofia e politica e che si sforza di individuare temi o concetti che
avrebbero agevolato o predisposto l'adesione heideggeriana al Terzo Reich o che sarebbero in
potenziale sintonia con la dottrina nazista: «Bisogna allora chiedersi non se tra il pensiero di
Heidegger e la sua adesione al nazismo ci sia un rapporto di deduzione necessaria, ma se [...] nel
primo sono presenti temi e motivi che, in una determinata situazione storica, spingevano, e non
casualmente, in direzione dell'adesione al nazismo, la quale, dunque, non è un fatto meramente
privato, ma ha una sua precisa dimensione filosofica» (D. Losurdo).
Fra i motivi atti a specificare tale connessione si cita ad esempio la teoria della storicità dell'Esserci
sviluppata in Essere e tempo. Teoria che fa uso di concetti come «autenticità», «destino»,
«fedeltà» al proprio popolo ecc. Tant'è che Löwith racconta come Heidegger stesso, nell'incontro
romano del 1936, concordasse in pieno («senza riserve») sul fatto che il concetto di storicità fosse
«alla base» del suo impegno politico. Analogamente, nel concetto della «storia dell'essere», intesa
come un accadere che, pur presupponendo l'uomo, va al di là dell'uomo e delle sue iniziative
consapevoli, si può scorgere una piattaforma teorica atta a favorire un'interpretazione (e una
giustificazione) del nazismo in termini di «evento destinale».
Un altro motivo — forse il più citato — è la sostanziale sfiducia di Heidegger nei confronti della
democrazia moderna. Sfiducia suggerita non solo dalle analisi di Essere e tempo sul mondo
comune del «Si», ma anche — e soprattutto — dalla interpretazione della democrazia come figura
tipica della modernità, strutturalmente connessa ai fenomeni della società di massa e
dell'organizzazione tecnico-nichilistica dell'esistenza: «per Heidegger, l'idea democratica e
l'universo del telecomando appartengono allo stesso destino, quello che si inaugura con
l'emergenza dell'uomo come soggetto e che si compie nell'era della tecnica» (A. Renaut).
L'Europa, afferma il filosofo in un passo delle lezioni su Nietzsche del 1935-36 — che sarà omesso
nel Nietzsche del 1961 — vuole «ancora e sempre abbarbicarsi alla "democrazia" e non vuole
imparare a vedere che questa costituirebbe la sua morte storica. Infatti, come Nietzsche ha visto
chiaramente, la democrazia è solo una varietà del nichilismo» (Nietzsche: Der Wille zur Macht als
Kunst, in HGA, vol. XLIII, p. 193; cfr. Nietzsche, Frankfurt a. M. 1961, vol. I, pp. 182 sgg.).
Interpretazione che, all'epoca di Introduzione alla metafisica (1935), si concretizza in una critica
simmetrica al comunismo sovietico e alla democrazia americana. Critica che risulta in sintonia con
l'ipotesi nazista di una Germania destinata, in quanto impero di mezzo, a salvaguardare l'umanità
dai pericoli dell'Est e dell'Ovest: «Questa Europa, in preda a un inguaribile accecamento, sempre
sul punto di pugnalarsi da se stessa, si trova oggi nella morsa della Russia da un lato e dell'America
dall'altro. Russia e America rappresentano entrambe, da un punto di vista metafisico, la stessa
cosa: la medesima desolante frenesia della tecnica scatenata e dell'organizzazione senza radici
dell'uomo massificato» (Introduzione alla metafisica, trad. it., Mursia, Milano 1968, p. 48). E anche
negli scritti del dopoguerra, Heidegger ha continuato a scorgere, nella democrazia, una
conseguenza della massificazione tecnica del mondo moderno, manifestando, nei suoi confronti,
un perdurante scetticismo: «È per me oggi un problema decisivo [stabilire] come si possa
attribuire un sistema politico — e quale — all'età della tecnica. A questa domanda non so dare
alcuna risposta. Non sono convinto che sia la democrazia» (Ormai solo un Dio ecc., cit., p. 131).
Osservazioni analoghe vengono fatte per altri temi o atteggiamenti del filosofare heideggeriano.
In conclusione, per questo terzo modello, sostenere che tra la filosofia di Heidegger e la sua
adesione al nazismo esistano possibili nessi teorici equivale a escludere che tra heideggerismo e
nazismo esista un rapporto di identità (necessaria) o di estraneità (totale), cioè muoversi in una
prospettiva ermeneutica che, pur rifiutando la tesi secondo cui la filosofia di Heidegger sarebbe,
da cima a fondo, una filosofia nazista, respinge nel contempo l'ipotesi che, in nome di una sua
(presunta) purezza teoretica, la vorrebbe del tutto estranea alle scelte politiche del suo autore.
E tutto ciò senza scorgere, nell'errore fatale di Heidegger, un motivo idoneo a screditare tutta la
sua filosofia. Come scrive Habermas, «il discutibile comportamento politico di un autore getta
un'ombra sulla sua opera. Ma l'opera di Heidegger [...] ha un valore posizionale così elevato nel
pensiero filosofico del nostro secolo che è fuorviante supporre che [...] la sostanza di questa opera
possa essere screditata da valutazioni politiche...» (Il filosofo e il nazista, in «Micromega», 1988, n.
3, p. 99).