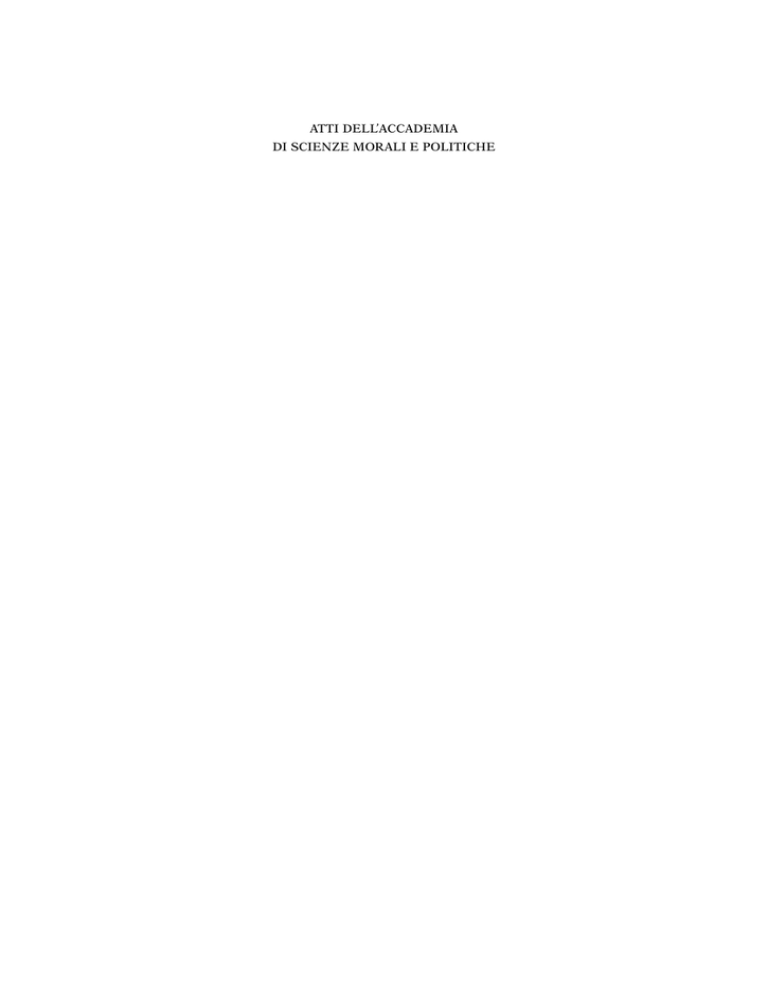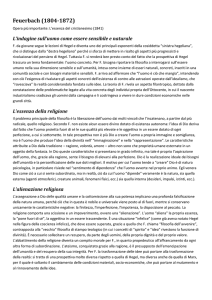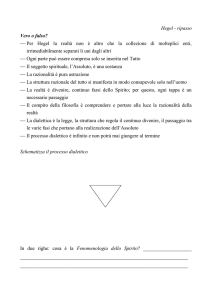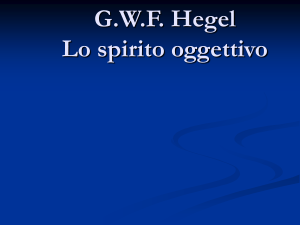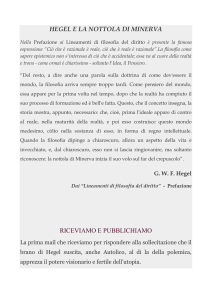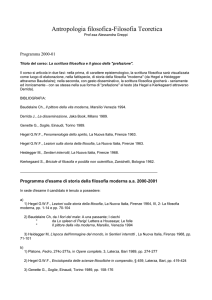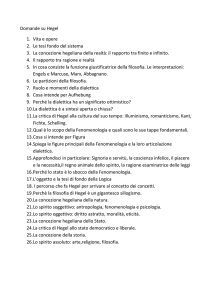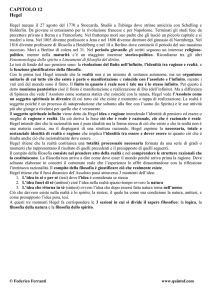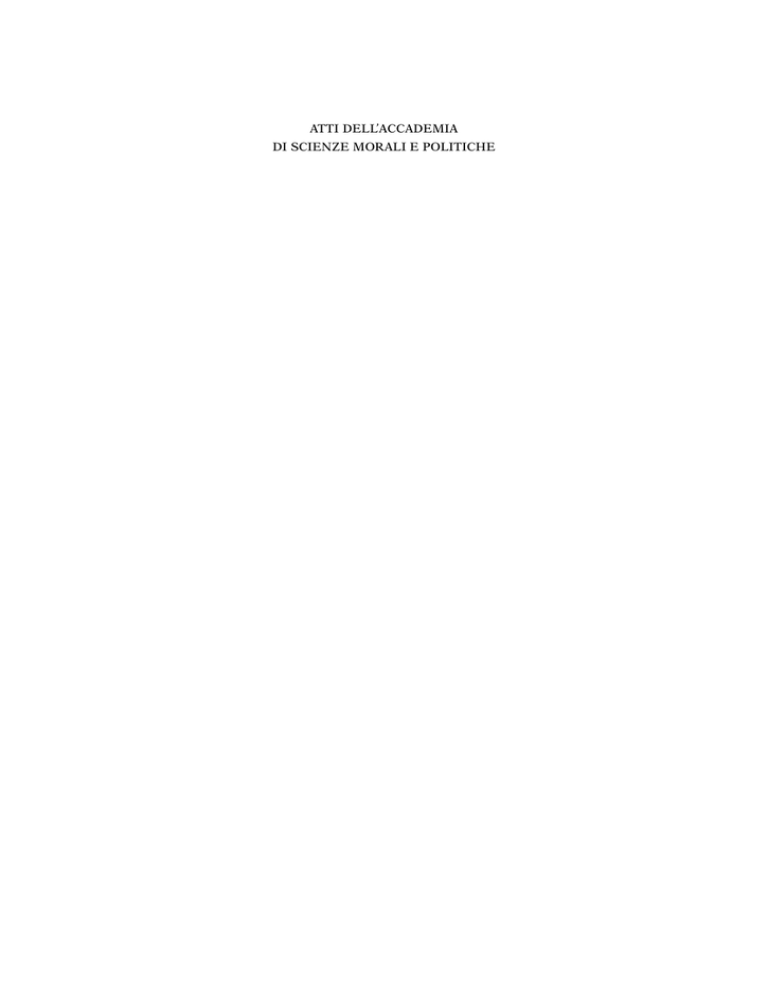
Atti dell’accademia
di scienze morali e politiche
Società nazionale di scienze, lettere e arti in napoli
Atti dell’accademia
di scienze morali e politiche
volume CXVIII - anno 2007-2008
Giannini editore
napoli 2009
Con il contributo della Regione Campania e del Ministero dei Beni Culturali
Direttore responsabile: accademico Aldo Trione
L’’Editorial Board della rivista è composto da tutti i Soci delle due sezioni
dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche.
ISSN: 1121-9270
ISBN-13: 978-88-7431-445-4
Le memorie presentate per la pubblicazione sono preventivamente sottoposte
a una procedura di peer review.
Hannah Arendt e Rahel Varnhagen: una biografia filosofica
5
Hannah Arendt e Rahel Varnhagen: una biografia filosofica
Memoria di Maria Letizia Pelosi
presentata dal socio naz. ord. res. Giuseppe Cantillo
(seduta del 22 febbraio 2007)
Abstract. This work aimed at going through the internal plot of Rahel Varnhagen’s
biography written by Hannah Arendt, starting from the subject of writing about life as
the place where subjectivity is built. The reading reconstructs the actual lives of the two
women through the existential and political meaning of belonging to the Jewish ethnic
group, which, devoid of any ideological connotation, was the “fact” which shaped the
destinies of Rahel Varnhagen, Hannah Arendt and also the book’s writing itself (stopped
in 1933, resumed in 1938, stopped again and eventually published in 1958, when Arendt
had taken refuge in the USA). The idea was to put the book into a theoretical critical context, which would take into account particularly the importance of biography in Arendt’s
work and the relationship between personal destiny and collective history.
I
La redazione del libro di Hannah Arendt Rahel Varnhagen. Storia di una
donna ebrea1 ha una vicenda singolare, che presenta più di un aspetto problematico.
Hannah Arendt comincia a scriverlo nel 1930, mentre ha in corso uno studio
sul romanticismo tedesco. È l’amica Anne Mendelssohn a segnalarle il carteggio e i diari di Rahel Varnhagen, figura di spicco della Berlino romantica tra
fine Settecento e inizio Ottocento2. Una coincidenza che spinge la Arendt ad
abbandonare il lavoro già intrapreso per dedicarsi interamente alla vicenda di
Rahel Varnhagen, «una delle donne a cui i contemporanei avevano riconosciu1
1a ed. inglese Rahel Varnhagen. The Life of a Jewess, Leo Baeck Institute, London-New
York 1957; 1a ed. tedesca Rahel Varnhagen. Lebengeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik, Piper, München 1959; ed. it. Rahel Varnhagen. Storia di una donna ebrea, a cura di L.
Ritter Santini, Il Saggiatore, Milano 1988 (20042­), da ora cit. come RV.
2
Per questa e altre vicende della vita intellettuale, pubblica e privata di Hannah Arendt è
stata consultata la biografia di Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt. For Love of the World,
Yale University Press, New Haven-London 1982; ed. it. Hannah Arendt 1906-1975. Per amore
del mondo, Bollati Boringhieri, Torino 1990, da ora cit. come E.Y-B.
6
Maria Letizia Pelosi
to maggiore altezza d’ingegno»3. Nata nel 1771 a Berlino, dove morì nel 1833,
Rahel Levin, poi Varnhagen dal cognome del marito sposato a un’età piuttosto avanzata, combatté senza sosta per avere un posto nel mondo, contro la
sua origine ebraica, le difficoltà economiche, la solitudine di donna per lungo
tempo non maritata. Nonostante le avversità, Rahel Varnhagen animò uno dei
momenti più fervidi della cultura europea, il suo “Salon” fu tra i più noti e frequentati di Berlino e scrisse per tutta la vita diari, aforismi e lettere, raccolti poi
dal marito August Varnhagen, che costituiscono un imponente “Gesammelte
Werke” di 10 volumi4.
Nel 1933, prima di lasciare la Germania (colpita dall’incendio del Reichstag il 27 febbraio 1933), Hannah Arendt ha completato i primi undici capitoli.
Nell’estate del 1938, a Parigi, sono pronti gli ultimi due, ma il libro su Rahel
Varnhagen viene edito, in inglese, solo nel 1958. Hannah Arendt e il marito
Heinrich Blücher si sono intanto e definitivamente stabiliti a New York nel
1940, a seguito dell’inferocirsi delle persecuzioni antisemite.
Passano dunque quasi trenta anni tra l’inizio della ricerca su Rahel Varnhagen e la sua pubblicazione. Hannah Arendt è ormai una intellettuale affermata,
ha già scritto quella che è considerata una delle sue opere maggiori, Le origini
del Totalitarismo, e sta per licenziare un altro dei testi cardine della sua filosofia,
Vita Activa.
All’interno di una struttura interpretativa che tiene ferme le fasi cronologiche e la vocazione eminentemente politica della produzione filosofica di Hannah Arendt, mi sembra che si possano isolare due questioni riguardanti il libro
su Rahel Varnhagen. La prima, che si interroga sulla distanza o meno, da un
punto di vista contenutistico e formale, della biografia di Rahel Varnhagen dal
resto della produzione arendtiana. La seconda, che tiene conto di quali potrebbero essere state le motivazioni che hanno spinto Hannah Arendt ad approfondire l’indagine su una donna ebrea ai tempi del romanticismo e a pubblicarla
dopo così tanto tempo e addirittura in una lingua diversa dall’originale.
Seguendo un percorso cronologico, in cui eventi storici e politici non fanno
solo da sfondo ma intervengono “concretamente” nel corso della scrittura5, il
3
E. CROCE, Romantici tedeschi ed altri saggi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1962,
p. 31.
4
Rahel Bibliothek – Gesammelte Werke, a cura di K. Feilchenfeldt, U. Schweikert, R. E.
Steiner, Matthes & Seitz, München 1983, 10 vv. Per una traduzione italiana parziale segnalo
l’antologia RAHEL LEVIN VARNHAGEN, Nel mio cuore un altro paese. Una donna ebrea ai
tempi di Goethe, a cura di U. Isselstein, ECIG, Genova 2005.
5
Mi riferisco alle due fughe, prima in Francia, poi negli Stati Uniti, che hanno interrotto
la scrittura della biografia. Altro avvenimento importantissimo fu il venire a conoscenza di
Auschwitz, nel 1943. Di questo Hannah Arendt parla approfonditamente in un’intervista a
Hannah Arendt e Rahel Varnhagen: una biografia filosofica
7
testo su Rahel Varnhagen si può considerare diviso in tre sezioni. La prima,
che va dal primo all’undicesimo capitolo, la seconda, che comprende gli ultimi
due capitoli, e infine la prefazione, scritta per la stampa del libro, nel 1958. La
distanza temporale tra le tre parti non produce fratture nella trama del testo,
soprattutto non sembra che siano venute meno la necessità e l’urgenza delle cose scritte. Ciononostante, le differenze tra le tre sezioni sono evidenti; se
la prima parte del testo si sofferma maggiormente sulle vicende intime e sulla storia personale di Rahel Varnhagen, gli ultimi due capitoli affrontano in
modo più attento e pregnante lo scontro tra le due figure simboliche del paria,
l’ebreo consapevole, e del parvenu, l’arrampicatore sociale, e lasciando quindi
il piano strettamente biografico, per approfondire aspetti più largamente sociali e culturali; mentre la prefazione, dal canto suo, si propone di giustificare la
pubblicazione di un libro scritto in un tempo «lontano almeno la metà di una
vita umana»6. Da questa suddivisione, che ricalca tre distinte fasi cronologiche,
emerge il legame tra storia personale e realtà politica generale, evidente per
quanto riguarda la vicenda di Hannah Arendt, ma altrettanto importante per
la vita di Rahel Varnhagen, e si rafforza il nesso tra scrittura e vita, là dove la
scrittura è sia l’elemento che fonda la relazione tra Hannah Arendt e Rahel Varnhagen, attraverso cui la Arendt comprende e fa la biografia, sia l’espressione
di un percorso esistenziale segnato dalle proprie origini ebraiche. Entrambe
hanno infatti scritto della propria ebraicità, l’una in diari e lettere, l’altra nella
biografia.
Fondamentale per accedere al testo è l’affermazione dell’autrice di voler
«raccontare la storia della vita di Rahel così come l’avrebbe potuta raccontare
7
lei stessa» , affermazione che apre una possibilità interpretativa volta a mettere
in luce una sorta di processo d’identificazione auto-biografica, giocato non solo
sull’ebraicità, ma anche su un rapporto di amicizia ideale.8 L’identificazione
autobiografica non è però un riconoscimento delle proprie esperienze o l’at-
Günter Gaus, Was bleibt? Es bleibt die Muttersprache, in G. GAUS, Zur Person, Piper, München
1965; trad. it. a cura di A. Dal Lago in H. ARENDT, La lingua materna, Mimesis, Milano 1993;
la traduzione dalla versione inglese dell’intervista What remains? The Language Remains: A
Conversation with Günter Gaus si intitola Che cosa resta? Resta la lingua. Una conversazione
con Günter Gaus e sta in Archivio Arendt 1. 1930-1948, a cura di S. Forti, Feltrinelli, Milano
2001.
6
RV, p. 5.
7
RV, p. 5.
8
Per questa interpretazione si veda in particolare E. Y-B, parte I, capp. 2 e 3. Interessante
è anche la prospettiva segnalata da Julia Kristeva, che, a proposito della biografia di Rahel Varnhagen, parla di «un atto catartico, se non autoanalitico». Cfr. J. KRISTEVA, Hannah Arendt.
La vita, le parole, trad. di M. Guerra, Donzelli, Roma 2005, p. 30.
8
Maria Letizia Pelosi
tribuzione di un significato estrinseco alle esperienze dell’altra, ma provare a
far convivere, nello stesso racconto di vita, entrambe le voci. Mentre ne scrive la
storia Hannah Arendt instaura con Rahel Varnhagen un dialogo sotterraneo e nel
silenzio della parola scritta, ne segue i ragionamenti, cammina insieme a lei nella
riflessione di fronte a se stessa e agli altri. In questa relazione di prossimità, e tenendo conto della “narrazione di sé” già compiuta da Rahel Varnhagen con i diari
e le lettere, la Arendt ha scritto la sua vita di una donna ebrea. La scrittura biografica indica qui un modo preciso di intendere il discorso filosofico, in cui non è
importante solo il contenuto narrato, ma la forma, in quanto indice del modo del
pensiero. Che, nel caso di Hannah Arendt, è asistematico, toccato da una profonda impronta personale e vicino all’esistente, con l’intento di non cristallizarsi in
teoria o dottrina, ma di essere guida dell’agire politico. La compenetrazione tra
analisi storica e filosofia fenomenologica, che nella biografia di Rahel Varnhagen
risponde, a mio avviso, all’intento di non voler sovrapporre la voce del soggetto
scrivente a quella del soggetto narrato, è riconoscibile come tratto distintivo di
tutto il pensiero di Hannah Arendt, sempre attento ad affrontare le questioni più
brucianti della vita politica senza astrarre dalle esperienze pratiche e concrete.9
Per questo motivo è particolarmente significativo che Hannah Arendt si sia interrogata sulla condizione dell’ebraicità anche scrivendo la storia di una donna
ebrea vissuta più di un secolo prima di lei.
«Uno scrittore giudica sempre»10 e il giudicare è una facoltà del pensiero;
più esattamente, giudicare è «“la facoltà di pensare il particolare”. Ma pensare
significa generalizzare, quindi il giudicare si rivela come facoltà di combinare,
in modo misterioso, il particolare con il generale»11. La scrittura combina misteriosamente, materialmente, pensiero e vita. La generalizzazione del pensiero
operata dalla scrittura della Arendt ha combinato una vita in particolare, quella
di Rahel Varnhagen, con una storia esemplare che, al modo di un’antica lezione,
ha il difficile compito di spiegare e rendere sopportabili gli eventi della vita e
i suoi esiti. Il giudizio della biografa qui non è quello di porsi al di fuori degli
eventi per poterli osservare e valutare, ma partecipare attraverso il pensiero
9
Segnalo come esempi di questa attenzione costante di Hannah Arendt per la realtà contemporanea, che si traduce in uno sforzo di comprensione plurale e condivisa, il reportage sul
processo al criminale nazista Adolf Eichmann, uscito nel 1963 con il titolo Eichmann in Jerusalem: a Report on the Banalità of Evil (trad. it. La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme,
trad. di P. Bernardini, Feltrinelli, Milano 1964) e l’articolo Reflections on Little Rock, scritto nel
1959 in merito a un controverso episodio di razzismo (trad. it. in H. ARENDT, Responsabilità
e giudizio, a cura di J. Kohn, Einaudi, Torino 2004).
10
I. BACHMANN, Letteratura come utopia. Lezioni di Francoforte, Adelphi, Milano 1993,
p. 18.
11
H. ARENDT, La vita della mente, intr. di A. Dal Lago, Il Mulino, Bologna 1987, p. 565.
Hannah Arendt e Rahel Varnhagen: una biografia filosofica
9
alla storia che lei stessa narra. Come suggerisce Lea Ritter Santini: «si dice che
mettere in ordine i cassetti degli armadi e dei trumeaux sia occupazione femminile che consente a chi la pratica con fiducia e disciplina un tranquillo distacco
dalle proprie inquietudini»12. Tale mettere ordine non è forse paragonabile a
una narrazione, un dare compiutezza a una storia? Nello scrivere o nel narrare
una storia vi è il tentativo di mettere ordine, di dare significato unitario a una
serie di avvenimenti che altrimenti apparirebbero insopportabilmente slegati e
inopportuni. Se il senso della propria storia rimane incompiuto per chi la vive,
la prospettiva del narratore configura la storia come completa e significativa.
La domanda fondamentale sul chi si è può avere una risposta nel racconto della
propria vita fatta da altri, oppure nel racconto di un’altra vita, meglio ancora
se quest’altra vita può diventare esemplare. Nello scrivere il libro su Rahel Varnhagen, Hannah Arendt ha messo alla prova l’impostazione filosofica esistenzialistica, secondo la quale il rapporto tra pensiero ed essere non si dà nella forma della coincidenza, ma nella necessità dell’uno di adattarsi all’altro13. Non si
tratta di un pensiero che crea l’essere, che crea il mondo o la realtà, bensì di un
pensiero che, appunto, instaura un rapporto e dà senso, attraverso il giudizio
o quella particolarissima capacità di comprensione che è la rammemorazione,
il ricordo.
Forse ora è più facile chiedersi perché una giovane donna ebrea tedesca studiosa di filosofia e teologia negli anni ’30 del XX secolo scrive la vita di una donna ebrea tedesca vissuta in un tempo così lontano. Vi è una continuità palese tra
le due figure, ma questa loro assonanza è anche l’elemento problematico della
questione: il libro su Rahel Varnhagen sembra formare anche criticamente un
punto a sé nello sviluppo dell’opera e della filosofia di Hannah Arendt. Tuttavia, questa apparente distanza - come se nella forma del saggio di filosofia o di
teoria politica fosse possibile esprimere un altro pensiero da quello che vive in
una biografia -, non tiene conto del fatto che «la filosofia è sempre anche una
psicologia e una bio-grafia: scrittura della vita come movimento della psyché
vivente. È sempre una figura della vita individua, una strategia (armata e inerme) di quella vita, nella misura in cui ispira tutti i filosofemi e programma tutte
le astuzie della verità»14. Ciò mette in risalto la complessità dell’intreccio tra
L. RITTER SANTINI, I cassetti di Rahel e le chiavi di Hannah, in RV, p. IX.
Il riferimento va alla “filosofia dell’esistenza” cui Arendt dedica uno scritto nel 1946
dal titolo “What is Existenz Philosophy?” (trad. it. in Archivio Arendt 1. 1930-1948, cit. e in
H. ARENDT, Che cos’è la filosofia dell’esistenza?, intr. e cura di S. Maletta, Jaca Book, Milano
2002).
14
J. DERRIDA, «Ho il gusto del segreto» (Cinquant’anni di vita intellettuale cosciente), intervista a cura di M. Ferraris, in “Iride”, n. 12, 1994, p. 321.
12
13
10
Maria Letizia Pelosi
biografia e pensiero filosofico, là dove si ricostituisce il nodo della soggettività.
Perciò la domanda si rinnova: cosa cercava Hannah Arendt quando intraprese
la scrittura della biografia di Rahel Varnhagen? Le riflessioni di Hannah Arendt
sono sospese e accompagnate da citazioni di Rahel Varnhagen, in una sorta di
dialogo a distanza in cui una delle parti non può sentire, ma riesce a rispondere. Una mancanza simile a quella del cantore cieco che, in un passo dell’Odissea
ricordato con una nota poetica da Hannah Arendt in La vita della mente, narra
ad Ulisse un fatto della sua vita, la lite con Achille: «nell’ascoltare, Ulisse si copre il volto e piange. Non aveva mai pianto prima, certo non quando i fatti che
ora sente narrare erano realmente accaduti. Soltanto ascoltando il racconto egli
acquista piena nozione del suo significato»15. Il racconto dell’aedo, come giustamente ha osservato Adriana Cavarero, svela ad Ulisse la sua identità. Ulisse si
commuove perché comprende ciò che non aveva potuto comprendere quando
aveva agìto, afferra cioè il significato di quella vicenda. L’aedo narra ad Ulisse
chi egli sia, così che «la categoria di identità postula sempre come necessario
l’altro»16. Ma l’episodio del pianto di Ulisse esprime anche un altro concetto: «il
significato di ciò che di fatto accade, e appare accadendo, si rivela dopo che è
scomparso: il ricordo, con il quale si rende presente alla mente ciò che di fatto è
assente e passato, svela il significato nella forma di un racconto.»17 La vita della
mente è l’opera incompiuta e postuma, che Hannah Arendt ha dedicato alle attività della mente: pensiero, volontà, giudizio. Nel passo citato ricordo e racconto sono intrecciati, poiché la mente, anche quando è sola, pensa sempre nella
forma del dialogo. Pure Rahel Varnhagen non poteva afferrare il significato di
ciò che le accadeva, e Hannah Arendt non poteva significare gli eventi della sua
vita, fin tanto che il ricordo di ciò che è accaduto non si fosse svolto nella forma
di un racconto, di una storia, dove i fatti appaiono concatenati, è chiara la rete
delle interdipendenze, l’accaduto si svolge in parole ed è pronto per essere detto
ed ascoltato, compreso.
Per raccontare di Rahel Varnhagen, Hannah Arendt non usa chiavi interpretative esplicite, ma lascia che la vita di Rahel Varnhagen scorra venendoci incontro, impedendoci di afferrarla secondo congetture o deduzioni da applicare
più o meno “oggettivamente”. In una recensione il libro è stato definito «una
serra senza finestre», in cui si è come «costretti a prendere coscienza del perso-
H. ARENDT, La vita della mente, cit., p. 221.
A. CAVARERO, Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della narrazione, Feltrinelli,
Milano 1997, p. 31.
17
H. ARENDT, La vita della mente, cit., p. 221.
15
16
Hannah Arendt e Rahel Varnhagen: una biografia filosofica
11
naggio e a sentirlo quasi fisicamente»18 e la scrittura appare lenta, sovraccarica,
statica. Eppure questa scrittura, che indubbiamente non può essere raccolta
in un’unica sintesi, poiché intreccia percorsi tematici complessi e sovrapposti
(l’amore, l’amicizia, l’identità ebraica, i contesti storici e culturali della Germania romantica), mima la problematicità e le stratificazioni della vita e per
questo si sottrae alla possibilità di essere rinchiusa in limiti e misure, mentre
rimane aperta alla variabilità e al fluire degli eventi.
II
Il libro comincia con la confessione di Rahel Varnhagen morente al marito,
la confessione di una sofferenza che diventa conforto, nel momento in cui la si
riconosce:
«Che storia! – Sono una profuga dall’Egitto e dalla Palestina e trovo
qui aiuto, amore e cura da parte Vostra! Con entusiasmo sublime penso
a questa mia origine e alla trama del destino in cui si uniscono le più
lontane distanze di spazio e di tempo: le più antiche memorie del genere umano, allo stato più recente delle cose. Quello che, per tanto tempo
della mia vita, è stata l’onta più grande, il più crudo dolore e l’infelicità,
essere nata ebrea, non vorrei mi mancasse ora a nessun costo»19.
La pena di Rahel Varnhagen, essere ebrea, diventa la sua forza, quando il
peso di una storia che sembra non appartenerle si fa «destino individuale»20;
quando, cioè, l’assunzione della propria appartenenza ebraica raccoglie, in un
unico insieme, la propria storia individuale (il destino) e l’intera storia che la
precede, cominciata «1700 anni prima della sua nascita»21. Ciò la mette in condizione di superare la sua singolarità solipsistica, il suo isolamento, e con essi
quella generica condizione di estraneità cui si era sentita condannata a causa
della sua «nascita infame»22. La sua confessione sul letto di morte narra la gioia
del ritrovarsi; errante per tutta la vita, in un continuo tentativo di andare via da
18
S. BEDFORD, Emancipation and Destiny, in “The Reconstructionist”, 12 dicembre
1958, pp. 22-26.
19
RV, p. 11.
20
RV, p. 11 (c. m.).
21
RV, p. 11.
22
RV, p. 16.
12
Maria Letizia Pelosi
sé, di uscir fuori dalla sua condizione di ebrea, al momento di morire torna a
sé e in questo movimento comprende non solo la sua storia, ma il suo destino
di ebrea. L’ebraicità, che per tutta la vita aveva significato infamia, vergogna,
dolore, ritorna, al momento della morte, come la verità dell’esistenza.
Una donna, migrante e profuga, sia pur simbolicamente, scopre in sé la
questione profonda del divenire, del vivere che non si svolge secondo un tempo
lineare e progressivo, in cui gli eventi si succedono meccanicamente per un’alternanza ovvia di causa e effetto. La vita è piuttosto una stratificazione di plurime esistenze, una composizione di incontri incessanti e inevitabili, che formano una biografia unica e irripetibile. In questa unicità, la condizione dell’essere
ebrea assume una nota di originalità e insieme di esemplarità. Alla luce delle
parole di Rahel Varnhagen, Hannah Arendt mette in relazione quell’insieme
“universale” di eventi e di tempo storici - che non appartiene propriamente alla
individualità di ciascuno, ma che ugualmente gli sta alle spalle e non può essere
ignorato - con la storia, personale e unica, di ciascun individuo, in modo che la
storia diventi «più facile da ricordare se per una volta – ed è molto raro – si può
presentare come destino individuale»23.
Anche se per ragioni diverse, la prefazione al libro, scritta come si è già visto
più di vent’anni dopo l’inizio della ricerca, esprime una nota di sofferenza, che
fa venire in mente le parole dell’incipit: «È sempre penoso quando un autore
parla del proprio libro, anche se il momento in cui è stato concepito è lontano
almeno la metà di una vita umana»24. Abbandonata la Germania nel 1933, Hannah Arendt non potrà più consultare il ricco e inedito materiale che aveva utilizzato per comporre i primi undici capitoli. L’Archivio Varnhagen, come altre
raccolte, andò disperso durante la guerra25. A Hannah Arendt rimanevano solo
alcune copie. Ma un altro avvenimento aveva mutato profondamente le circostanze nelle quali il libro aveva preso forma. La biografia era stata scritta «con
la coscienza della fine dell’ebraismo tedesco»26, questo particolarissimo tipo di
ebraismo che fu un fenomeno unico all’interno della storia ebraica. Hannah
Arendt non poteva prevedere allora le proporzioni che avrebbe assunto la persecuzione degli ebrei in Germania e in Europa, che provocò l’annientamento
fisico del popolo ebraico. La pena confessata all’inizio si accentua: ci sarà anco RV, p. 11.
RV, p. 5.
25
Sarà ritrovato nel 1977 a Cracovia. Si veda D. HERTZ, The Varnhagen collection is in
Kracow, in “The American Archivist”, 44, 1981, cit. da U. ISSELSTEIN, Costruzione e ricostruzione di un’identità. Rahel Levin Varnhagen e i suoi diari, in Ricerche di identità, a cura di C.
CASES, Torino 1985.
26
RV, p. 7.
23
24
Hannah Arendt e Rahel Varnhagen: una biografia filosofica
13
ra qualcuno, si chiede l’autrice, che abbia un interesse non soltanto scientificoaccademico per la storia dell’ebraismo tedesco? In ogni caso, dalla distante
New York e grazie all’Istituto Leo Baeck, sarebbe stato possibile pubblicare
quel manoscritto, che aveva subìto tante peripezie.
Da questo confronto tra due pagine dello stesso libro così distanti nel tempo,
si fa strada l’ipotesi interpretativa di considerare la biografia di Rahel Varnhagen un testo in cui si riverbera anche la biografia di Hannah Arendt. Due modi
diversi di vivere la propria ebraicità si incontrano nel “corpo” della scrittura:
il tentativo fallito di Rahel Varnhagen di assimilarsi, che dimostra ancora la
sua pregnanza storica; e la storia di ebrea in fuga di Hannah Arendt, scandita
proprio dalla scrittura del libro “Rahel Varnhagen”, pubblicato quando oramai
Hannah Arendt ha raggiunto un grande riconoscimento pubblico e lavora a
uno dei suoi libri più significativi: The Human Condition27.
In questa monografia, Hannah Arendt si propone di designare e spiegare
le tre fondamentali attività umane (lavoro, opera, azione) in quanto condizioni della vita degli uomini. Il lavoro e l’opera non sono la natura umana, non
possono rispondere alla domanda sul chi è l’uomo nella sua costitutiva interrelazionalità, ovvero sul significato della vita plurale degli uomini sulla terra (significato che assume in sé il fondamentale concetto di libertà). L’azione invece,
che è esclusiva prerogativa dell’uomo, dipende dalla presenza degli altri, non
si agisce se non mettendo in moto un processo di relazione. A causa di questo
intreccio di relazioni tra gli uomini, l’azione produce storie che, da un punto di
vista esistenziale, danno significato alla vita umana.
Che ogni vita individuale tra la nascita e la morte sia raccontata un
giorno come una storia con un inizio e una fine è la condizione prepolitica e prestorica della storia, la grande Storia senza un inizio e una fine.
Ma la ragione per cui ogni vita umana ci racconta la sua storia, e la Storia diviene alla fine il libro dei racconti dell’umanità, con tanti uomini
che vi parlano e agiscono ma senza autori concreti, è che entrambe, la
vita e la storia, sono risultati dell’azione28.
Hannah Arendt, che amava molto i Greci e ricorre spesso alle loro “mitologie”, rammenta nello stesso testo la figura del daimon, quell’identità distinta
27
1a ed. H. ARENDT, The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago 1958;
ed. it. Vita activa. La condizione umana, intr. di A. Dal Lago, Bompiani, Milano 19974.
28
Ivi, pp. 134-135.
14
Maria Letizia Pelosi
che appare ed è visibile solo agli altri29. E se per i Greci l’essenza del “chi si è”
può cominciare a definirsi solo quando la vita è compiuta, lasciandosi dietro di
sé una storia, per Hannah Arendt la presenza degli altri mi fa nel presente storia
e quindi esistenza. Ciò che si può raccontare, cioè che può essere comunicato
nella relazione, assume la forma della continuità e del ricordo. Nell’impossibilità della comunicazione vi è invece la replica sorda, la dimenticanza, la perdita
della propria storia.
Per tornare alla prefazione a “Rahel Varnhagen”, Hannah Arendt chiarisce
in maniera esplicita cosa abbia significato scrivere la storia di una donna ebrea:
l’intenzione di «raccontare la storia della vita di Rahel Varnhagen, così come
l’avrebbe potuta raccontare lei stessa»30 risponde al desiderio di ripetere ciò che
Rahel Varnhagen aveva realizzato durante la sua vita: rivelare «nella riflessione, di fronte a se stessi e agli altri, sempre di nuovo la propria storia che così
si fa destino»31. La confessione di Rahel Varnhagen sul letto di morte riassume esemplarmente questo atteggiamento. Rahel Varnhagen era riuscita a comprendere la propria identità, restando esposta alla vita «tanto da esserne colpita
“come il cattivo tempo chi è senza ombrello”»32. Abbandonarsi alle eventualità
è l’unica posizione che Rahel Varnhagen può assumere, una posizione instabile
e disorientante, una non-posizione, quella di lei esclusa dal mondo e da questo colpita senza potersi difendere: esclusa perché ebrea, perché donna “senza
grazia”, perché non sa ripararsi dalle sofferenze. Questa vulnerabilità però le
permette di guardare con coraggio alla sua esistenza e, in punto di morte, di
riconoscerne l’autenticità. Hannah Arendt non ricostruisce dunque una storia
con elementi aggiunti «dal di fuori»33, ma ripete il gesto, audace e coraggioso,
di Rahel Varnhagen, di aver raccontato la propria storia in maniera «cosciente
e vulnerabile»34.
III
Un primo nucleo del lavoro su Rahel Varnhagen è contenuto in un testo
presentato a una conferenza su “Rahel Varnhagen e l’ebraicità”. Lo scritto è andato disperso, ma ne abbiamo una significativa testimonianza da Karl Jaspers,
Ivi, pp. 141 e ss.
RV, p. 5.
31
RV, p. 6.
32
RV, p. 5.
33
RV, p. 5.
34
RV, p. 6.
29
30
Hannah Arendt e Rahel Varnhagen: una biografia filosofica
15
professore di Hannah Arendt a Heidelberg35, che così ne scrive in una lettera a
lei indirizzata nel 1930:
L’“esistenza ebraica” viene da Lei oggettivata nel quadro di una filosofia dell’esistenza, e con ciò forse si rischia di uscire di strada quando si
cerchi la radice del filosofare in termini esistenziali. Di conseguenza, il
dipendere-da-se-stessi non trova più un’integrale applicazione pratica, se
esso viene fondato sul terreno del destino ebraico invece di radicarsi in se
stesso. […] Il carattere “ebraico” è una façon de parler oppure la manifestazione di un’“esistenza in proprio” dall’atteggiamento originariamente
negativo, non realtà fondabile sopra una situazione storica, ma destino
la cui soluzione non è custodita nel castello incantato […]36.
Per Jaspers l’ebraicità non può essere una forma di appartenenza originaria,
strutturale; vi sono dati storici del vivere e contesti dai quali non scaturiscono verità immutabili, ma interpretazioni, opinioni, possibilità. In altre parole, essere ebreo non può determinare una oggettività dell’esistenza del singolo,
poiché l’esistenza del singolo non può essere ridotta a un “cosa”, a un oggetto.
L’esistenza, secondo Jaspers, va invece chiarificata, va compresa di essa l’incondizionatezza, l’infinitudine, la possibilità. Anche da ebreo, l’esistenza è sempre
singolare, «è sempre un singolo esistente che sono tanto io stesso quanto un
altro io, il quale nella comunicazione mi si presenta non come per me oggetto,
ma altrettanto come soggetto, cioè come libertà»37. L’uomo dunque non è un’essenza, non ha alcuna oggettività definita. La sua esistenza è un’esistenza possibile, il fatto cioè che egli trascende un essere immutabile e si slancia verso la
possibilità. Dunque non si può fondare l’esistenza sul “terreno” della ebraicità,
a meno di privarla del suo carattere di possibilità o trascendenza.
La risposta di Hannah Arendt è esauriente:
In verità, esiste in un certo senso un’obbiettivazione: ma non già
un’obbiettivazione dell’esistenza ebraica (per esempio, come forma
strutturale), bensì quella di uno storico contesto del vivere, del quale, io
35
Karl Jaspers fu anche relatore della tesi di dottorato di Hannah Arendt Liebesbegriff bei
Augustin. Versuch einer philosophischen Interpretation, Springer, Berlin 1929; ed. it. Il concetto
d’amore in Agostino. Saggio di interpretazione filosofica, trad. e cura di L. Boella, SE, Milano
2001.
36
Jaspers a Arendt, 20 marzo 1930. H. ARENDT-K. JASPERS, Carteggio. 1926-1969. Filosofia e politica, Feltrinelli, Milano 1989, pp. 30-31.
37
G. CANTILLO, Introduzione a Jaspers, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 67.
16
Maria Letizia Pelosi
credo, si possa avere un’opinione (ma non un’idea oggettiva, o qualcosa
di simile). È come se determinate persone si trovassero nella loro popria
vita (e soltanto in tale dimensione, non in se stesse in quanto persone!)
in posizione tale da poter essere paragonate nello stesso tempo a punti
d’incrocio e a oggettivazioni concrete “della” vita. Nel caso di Rahel, a
fondamento della mia oggettivazione c’è già un’autoggettivazione […]38.
Non si voleva dunque “fondare l’esistenza” di Rahel Varnhagen sull’ebraicità. Il testo, che Hannah Arendt considera un lavoro preliminare a una biografia,
vorrebbe dimostrare che proprio dal distacco dall’ebraismo, che Rahel Varnhagen ha così tenacemente perseguito, si dipanano i fili del suo destino, e che
possedere un proprio destino diventa possibile solo in assenza di un terreno originariamente fondato, di un principio immutabile; solo, cioè, perché Rahel Varnhagen si è esposta. Nell’abbandono all’esistente, nell’esposizione consapevole
ai moti della vita, Rahel Varnhagen ha raccontato la propria storia, e ha portato
a compimento il suo destino. Solo allora questo destino ha potuto essere compreso. Come poter raccontare questo complesso percorso esistenziale è il difficile compito che Arendt si propone: «Proprio per questo vorrei scrivere una biografia. L’interpretazione assume qui propriamente il senso della ripetizione».39
Il destino, il trovarsi in una posizione esposta, sono concetti talmente reali che
non possono essere detti in astratto, ma soltanto mediante esempi. In questo
senso Rahel Varnhagen viene considerata da Hannah Arendt un “punto d’incrocio”, un’“oggettivazione”. Oggettivazione qui non significa essere “oggetto”
di un discorso o di un’interpretazione, come potrebbe succedere a un modello
di esistenza ebraica che si voglia indagare “scientificamente”. L’oggettivazione
di Rahel Varnhagen o, come Hannah Arendt la chiama, la sua “autoggettivazione” [Selbstobjektivation]40 non contiene in sé la totalità dell’esperienza ebraica,
né l’intento di Hannah Arendt è di voler accedere, attraverso la figura di Rahel
Varnhagen, alla comprensione della condizione ebraica nella sua interezza (interezza che cancellerebbe le differenze con cui ciascun singolo vive la propria
condizione di essere ebreo). Qui oggettivazione vuol dire piuttosto simbolizzazione, esempio, determinazione concreta e singolare di un principio generale.
Nel caso della biografia di Rahel Varnhagen, questa sua esemplarità, o oggettivazione, viene riconosciuta come tale ed esplorata tramite la sua ripetizione,
Arendt a Jaspers, 24 marzo 1930. H. ARENDT-K. JASPERS, Carteggio, cit., p. 32.
Ib.
40
H. ARENDT- K. JASPERS, Briefwechsel 1926-1969, Piper, München-Zürich 20012, p. 48.
38
39
Hannah Arendt e Rahel Varnhagen: una biografia filosofica
17
tramite cioè il racconto della vita di una donna che si è già raccontata, poiché
si è esposta.
Si potrebbe dire, con una terminologia che non appartiene alla Arendt ma
che dà conto dell’importanza della posta in gioco, che l’idea fin qui espressa
di “oggettivazione” esprime la tensione concettuale tra assoluto e relativo, tra
“norma” generale e situazione particolare, tra fenomeno soggettivo e principio
oggettivo. Il problema che emerge, difatti, leggendo la storia di Rahel Varnhagen, è la difficoltà – a tratti l’impossibilità - di aderire al destino pubblico e
comune a partire dalla propria posizione privata e singolare. Ciò che Arendt,
a mio parere, vuole sottolineare, è che l’ebraicità di Rahel Varnhagen cessa di
essere soltanto un dato personale e si inserisce in un contesto di reciprocità
quando l’“autoggettivazione” diventa piena assunzione della propria posizione nel mondo, anche se questa è quella del paria, dell’emarginato. Sebbene
Rahel Varnhagen sia stata un’“outsider”, ha incarnato più di altre figure a lei
contemporanee, secondo Hannah Arendt, un aspetto fondamentale della storia
degli ebrei tedeschi, cioè che cosa significasse vivere stretti tra assimilazione e
esclusione. Quando questa situazione di lacerazione viene vissuta in maniera
consapevole, senza denegare se stessi e senza farsi incantare dalle lusinghe di
un facile conformismo, essa diventa una situazione di vantaggio, la posizione
del paria. Al tema del paria Hannah Arendt ha dedicato alcune tra le pagine più
interessanti della biografia di Rahel Varnhagen, e altri numerosi scritti.41 Non
potendoci qui soffermare sull’argomento, ritengo comunque importante accennare al fatto che l’esposizione consapevole non può fare a meno dell’autonomia
del pensiero, quel Selbstdenken insegnato da Lessing, il pensare da sé, cui Hannah Arendt farà riferimento costantemente nella sua filosofia.42 Un pensare da
sé che non si riferisce al soggetto nel suo esclusivo individualismo, ma che ha
bisogno al contrario del rapporto con il mondo e con gli altri, con le loro posizioni e le loro opinioni. Un pensiero dunque impossibile nell’isolamento, ma
che dà luogo a un mondo comune quando «è legato a uno spazio a più voci»43.
Rahel Varnhagen, pur desiderando di uscir fuori dall’ebraismo e quindi di assimilarsi, ha mantenuto intatta la capacità di pensare da sé e di relazionarsi agli
altri e al mondo. Ella è rimasta sospesa tra la condizione del parvenu e quella
41
Cfr. in particolare H. ARENDT, The Jew as Pariah: Jewish identity and politics in the modern
age, Grove Press, New York 1978. Alcuni dei saggi qui raccolti sono stati tradotti in H. ARENDT,
Ebraismo e modernità, a cura di G. Bettini, Feltrinelli, Milano 2003 e in H. ARENDT, Il futuro alle
spalle, a cura di L. Ritter Santini, il Mulino, Bologna 1981.
42
Cfr. H. ARENDT, L’umanità nei tempi oscuri. Riflessioni su Lessing, in “La società degli
individui”, 7, Franco Angeli, Milano, 2000, pp.5-30.
43
Ib., p. 29.
18
Maria Letizia Pelosi
del paria fino a quando quest’ultima non è riuscita a prevalere, poiché al conformismo e all’arricchimento Rahel Varnhagen ha sempre preferito le «realtà
vere – un ponte, un albero, un viaggio, un odore, un sorriso»44.
Cominciano dunque da qui, dalla biografia di Rahel Varnhagen, alcune delle vene più profonde della riflessione sulla politica che sarà il segno distintivo
di tutta la produzione successiva di Hannah Arendt. Basta pensare al libro sul
Totalitarismo, scritto in America tra il 1945 e il 1949 con la collaborazione del
marito Heinrich Blücher, che nella prima parte affronta proprio il problema
dell’antisemitismo, con un significativo riferimento alla storia di Rahel Varnhagen, e nel quale è tracciata l’idea per cui la spersonalizzazione della politica,
tipica delle società di massa, coincide con la superfluità dei destini personali,
la loro insignificanza45. La storia di Rahel Varnhagen aveva invece dimostrato
l’importanza profonda del compiersi di ciascun destino individuale di fronte
alla storia.
IV
Si è visto come la storia del testo su Rahel Varnhagen sia fortemente intrecciata con le vicende biografiche e intellettuali di Hannah Arendt. Il manoscritto era tornato nelle mani di Hannah Arendt dopo la guerra grazie a Gerhard
Scholem, al quale era stato spedito dalla stessa Arendt su consiglio di Walter
Benjamin, che così ne parla nel 1939 in una lettera a Scholem:
A me quest’opera ha fatto una grande impressione. Nuota vigorosamente contro la corrente dell’ebraistica edificante e apologetica. Tu sai
RV, p. 215.
1a ed. H. ARENDT, The Origins of Totalitarism, Harcourt Brace, New York 1951; ed. it. Le
origini del totalitarismo, intr. di A. Martinelli, Ed. di Comunità, Torino 19993. Cfr. inoltre E.Y-B,
parte II, capp. 5 e 6. Per il tema della superfluità si veda in particolare F. COLLIN, L’homme
est-il devenu superflu?. Hannah Arendt, Odile Jacob, Paris 1999. Qui si mette in luce come Hannah Arendt considerasse la violenza che si era abbattuta sugli ebrei un fatto senza precedenti,
sintomo di una dissoluzione più generale dei principi della cultura occidentale e di un tempo
in cui “tutto è possibile” e anche la morte diventa indifferente. Per la pregnanza del termine
“superfluo”, si veda anche la risposta di Arendt a Gerhard Scholem, riguardo all’espressione
“banalità del male”: «[...] il male non è mai «radicale», ma soltanto estremo [...]. Esso può
invadere e devastare il mondo intero, perché si espande sulla sua superficie come un fungo.
Esso “sfida”, come ho detto, il pensiero, perché il pensiero cerca di raggiungere la profondità,
di andare alle radici, e nel momento in cui cerca il male, è frustrato perché non trova nulla.
Questa è la sua “banalità”. Solo il bene è profondo e può essere radicale.» Arendt a Scholem,
24 luglio 1963, in H. ARENDT, Ebraismo e modernità, cit., p. 227.
44
45
Hannah Arendt e Rahel Varnhagen: una biografia filosofica
19
benissimo che tutto quello che si poté leggere finora intorno agli «ebrei
nella letteratura tedesca» si era appunto lasciato trasportare da questa
corrente46.
Hannah Arendt racconta, in una lettera a Jaspers del 1952, che furono proprio Walter Benjamin e il marito nell’estate del 1938 a spingerla a finire il libro
interrotto nel 1933. Cosa colpì Benjamin così profondamente? Mentre Scholem
si soffermava sull’alleanza costituitasi sul finire del ‘700 tra ebrei e tedeschi e
sul suo inevitabile fallimento, interesse che Scholem riconosceva diverso da
quello della Arendt, Benjamin metteva in evidenza la capacità di parlare di una
donna ebrea senza cadere nello stereotipo né nell’esaltazione della particolarità. Di non fare cioè di Rahel Varnhagen l’eroina dell’ebraismo, ma neanche di
ridurre la ricerca a una indagine sulla Berlino romantica o sul culto di Goethe,
applicando alla personalità di Rahel Varnhagen categorie funzionali allo scopo.
Benjamin intuì che il libro su Rahel Varnhagen doveva essere una «rappresentazione biografica»47 che si distaccava dal modo abituale della letteratura della
biografia.
In effetti l’intenzione di Hannah Arendt, come lei stessa ripete nella prefazione al libro, non è di scrivere un libro su Rahel Varnhagen, né di interpretare
la storia della sua vita e la sua personalità con categorie aggiunte dal di fuori (la
psicologia, il problema femminile, la Weltanschauung dell’epoca), ma quella di
«prendere più sul serio»48 la storia di quella vita, nel senso di aderire al destino
di Rahel Varnhagen come Rahel Varnhagen stessa era riuscita a fare, portando a compimento la propria storia così come doveva realizzarsi e completando coerentemente il disegno che ogni vita è destinata a tracciare. L’elemento
dell’ebraicità, così forte ed evidente nella biografia, non fa di quest’ultima una
storia della cultura ebrea, ma costituisce in una forma unica e però esemplare
la storia della vita di Rahel Varnhagen.
Nel 1952 Jaspers e Hannah Arendt tornano a discutere del libro. Per il filosofo, esso è solo in parte una biografia, ma è piuttosto una serie di saggi, in
ciascuno dei quali viene affrontato il problema dell’esistenza ebraica:
[…] è come se Rahel in quanto Rahel non attragga né il Suo interesse
né il suo amore di autrice, oppure è come se tramite Rahel lei trattas46
Benjamin a Scholem, 20 febbraio 1939. W. BENJAMIN e G. SCHOLEM, Teologia e utopia. Carteggio 1933-1940, Einaudi, Torino 1987, pp. 277-278.
47
RV, p. 5.
48
RV, p. 6.
20
Maria Letizia Pelosi
se un argomento essenzialmente diverso. L’immagine che prende forma
non è il ritratto di Rahel in sé, ma per così dire soltanto il ritratto degli
accadimenti che scelsero questo individuo come loro sede49.
Per Jaspers il centro è e deve rimanere l’essere umano in sé, non essenzialmente ebreo. Hannah Arendt invece, secondo l’interpretazione di Jaspers,
frammenta l’esperienza di Rahel Varnhagen poiché fa del suo essere ebrea il
punto di partenza per ogni altra esperienza; come se un essere umano, in quanto ebreo, facesse esperienze totalmente uniche e non più propriamente appartenenti alla sua umanità. Si apre qui un nodo teorico che segna un’interessante
disparità di posizioni tra i due pensatori.
Secondo Jaspers, per buona parte del libro la Arendt traduce in ‘linguaggio’,
vale a dire oggettivizza, «il grande fenomeno rappresentato da questa donna che
trema e sanguina, senza casa e senza patria, senza un suo mondo»50. Per di più,
questa traduzione muove da un unico aspetto, l’essere ebrea, mentre le esperienze che Rahel Varnhagen compie non appartengono solo all’ebreo in quanto
tale. Le richieste di Rahel Varnhagen (essere riconosciuta, amata, accettata,
compresa) fanno parte di un’esigenza più largamente esistenziale, piuttosto che
di un carattere esclusivamente ebraico. Rahel Varnhagen stessa era alla ricerca
di una condivisione più definitiva e ‘umana’ (tant’è, si potrebbe aggiungere, che
è Goethe e non un modello ebreo a indicarle una via d’uscita).51 D’altra parte,
se esiste un’oggettivazione della vita di Rahel Varnhagen, si è visto in che modo
Arendt la intenda: Rahel Varnhagen è «mediatrice di voce e di lingua»52, racconta, cioè, l’esperienza della vita, ma non è portavoce dello spirito del tempo,
non rappresenta un’epoca storica. Si prospettano allora due insiemi concettuali: quello di Jaspers, per il quale la vita dell’individuo, ebreo o non-ebreo, uomo
o donna che sia, riunifica le proprie singole esperienze sotto il segno di una
‘cifra’ esistenziale che è comune a tutti gli esseri umani. E quella della Arendt,
per la quale l’essere nata ebrea ha un suo peso specifico e irriducibile e non si
può leggere la storia di una donna ebrea se non a partire dalla sua posizione
nel mondo in quanto ebrea. È questa ebraicità a muovere le fila del destino di
49
Jaspers a Arendt, 23 agosto 1952. H. ARENDT-K. JASPERS, Carteggio. 1926-1969, cit.,
pp. 110-111.
50
Ivi, p. 112.
51
Cfr. ivi, p. 111. «Il Suo libro, con il suo tono generale, dà l’impressione che un essere
umano, in quanto ebreo, non possa vivere una vita normale.» Per i rapporti tra Rahel Varnhagen e Goethe si veda in particolare L. RITTER SANTINI, I cassetti di Rahel e le chiavi di
Hannah, cit.
52
RV, p. 5.
Hannah Arendt e Rahel Varnhagen: una biografia filosofica
21
Rahel Varnhagen, è attraverso di essa che Rahel Varnhagen conosce il mondo,
lo pensa, lo descrive. Non una fondazione ebraica dell’esistenza, quindi, ma
l’ebraicità come condizione dell’esistenza che non può essere trascesa:
Sono ancora oggi dell’opinione che gli ebrei, in condizioni di assimilazione sociale e di emancipazione statale, non potessero ‘vivere’. La vita
di Rahel mi sembra dimostrarlo, proprio perché ella, con straordinaria
irriguardosità e senza mai ombra di falsità, applicava a se stessa qualsiasi esperienza. Ciò che di lei mi ha affascinata è sempre stato il fenomeno
per cui la vita viene vissuta da un individuo come un ‘temporale senza
ombrello’. Per questo, mi sembra, tutto alla fine le diveniva così chiaro.
Ma proprio per questo le era anche così insopportabile53.
Nel caso di Rahel Varnhagen, è la sua esposizione a rendere l’esperienza
dell’‘essere nata ebrea’ attuale, è il modo in cui Rahel Varnhagen vive la propria
ebraicità a rendere quest’ultima esemplare, ‘punto d’incrocio’, di una condizione dello stare al mondo. Non è possibile rendere un’esperienza quale quella
dell’essere nata ebrea fuori da «ciò che in senso storico e dal punto di vista del
suo intimo contenuto spirituale intendiamo per ‘ebraismo’»54.
La Arendt risponde a Jaspers:
Il mio libro in molte sue parti mi è oggi personalmente estraneo, [
]
soprattutto nel tono e nel tipo di riflessione. Non lo è però nelle caratteristiche dell’esperienza ebraica, che io ho inculcato in me stessa con fatica e
pericolo. [
] Rahel è ‘interessante’ poiché si muove attraverso tutte le vicende della vita restando completamente ingenua e insieme disinibita: una via
di mezzo tra il paria e il parvenu. [
] Ciò che avevo in mente o credevo di
fare era continuare a ragionare con lei come lei stessa faceva [
]55.
È ancora l’“esposizione al destino” a fare da chiave di lettura e a permettere
a Arendt di ripetere la storia di Rahel Varnhagen. Nonostante la mancanza di
uno stato sociale, nonostante l’infondatezza della sua esistenza, Rahel Varnhagen, attraverso la sua vita, esponendosi, ha potuto conoscere il mondo e raccontare la sua storia. La ripetizione di questa vita è quello che, più di ogni altra
53
Arendt a Jaspers, 7 settembre 1952. H. ARENDT-K. JASPERS, Carteggio. 1926-1969,
cit., p. 117.
54
Ivi, p. 119.
55
Ivi, pp. 116-120.
22
Maria Letizia Pelosi
suggestione, rimane del senso della biografia («se quanto intendevo non mi è
riuscito, Rahel potrà sembrare giudicata dall’alto»56).
Il dialogo tra i due potrebbe disorientare. Quale posizione assume Hannah
Arendt nei confronti della critica del maestro? Hannah Arendt scrive:
Stimatissimo amico,
la Sua cara, lunga lettera. Questa splendida generosità di dettagli, questa
luminosa e illuminante pazienza, sono il Suo modo di ascoltare e di rispondere nello stesso tempo57.
C’è tutto il legame tra Hannah Arendt e Karl Jaspers, cui andrebbe dedicato uno studio a parte, in questo incipit di lettera. L’ho citato alla fine di questo
testo per lasciare la traccia dell’importanza fondamentale che ha per la filosofa
l’essere al mondo non dell’“Uomo” ma degli uomini: nulla potrebbe esistere
se non ci fosse qualcuno disposto a vedere e ad ascoltare, niente esiste al singolare, ma tutto è fatto per essere percepito, vissuto, detto e raccontato nella
pluralità.
L’esperienza di pluralità costituitasi tra Rahel Varnhagen e Hannah Arendt
ha come fondamento la scrittura biografica, e in questo processo di ricostruzione della vita dell’altra si autoevidenzia la costituzione di un percorso di soggettivazione, ovvero di autocomprensione del proprio destino di donna ebrea.
D’altronde una parte rilevante del corpus degli scritti arendtiani riguarda le vite
di alcuni uomini e donne “esemplari”, che diventa “tipico” di un modo di fare filosofia, dove il genere filosofico è tendenzialmente biografico58. Quello smantellamento della metafisica, che Hannah Arendt sostiene di aver voluto condurre
attraverso il suo lavoro59, si serve evidentemente di uno strumento efficace già
RV, p. 6.
Arendt a Jaspers, 7 settembre 1952. H. ARENDT-K. JASPERS, Carteggio. 1926-1969,
cit., p. 115.
58
La raccolta Men in Dark Times contiene dieci “ricordi” e “narrazioni” di altrettante personalità. L’autrice scrive nella prefazione: “That even in the darkest of times we have the right
to expect some illumination, and that such illumination may well come less from theories and
concepts than from the uncertain, flickering, and often weak light that some men and women,
in their lives and their works, will kindle under almost all circumstances and shed over the
time span that was given them on earth – this convinction is the inarticulate background
against which these profiles were drawn.” H. ARENDT, Men in Dark Times, Harcourt Brace &
Company, San Diego-New York-London 1995, p. IX.
59
«Mi sono apertamente schierata tra coloro che da qualche tempo a questa parte hanno
tentato di smantellare la metafisica (con la filosofia e tutte le sue categorie) […]». H. ARENDT,
La vita della mente, cit., p. 306.
56
57
Hannah Arendt e Rahel Varnhagen: una biografia filosofica
23
con il testo su Rahel Varnhagen, dove la biografia, da sempre esclusa dalla pratica della filosofia (con poche eccezioni), testimonia di un modo del pensiero
che Hannah Arendt ha sempre voluto fortemente storico, concreto, politico.
BIBLIOGRAFIA
Per una bibliografia completa degli scritti di Hannah Arendt si rimanda a S.
FORTI (2006)
Scritti di Hannah Arendt:
Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer philosophischen Interpretation,
Springer, Berlin 1929; trad. it. Il concetto d’amore in Agostino, a cura di L.
Boella, SE, Milano 1992.
The Origins of Totalitarism, Harcourt, Brace & Co., New York 1951; trad. it.
Le origini del totalitarismo, intr. di A. Martinelli, Ed. di Comunità, Milano
1999.
The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago 1958; trad. it. Vita
activa. La condizione umana, intr. di A. Dal Lago, Bompiani, Milano 19974.
Rahel Varnhagen The life of a Jewess, Est and West Library, London 1958; nuova
ediz. ed. by L. Weissberg, The Johns Hopkins University Press, Baltimore
and London, 1997; ed. ted. Rahel Varnhagen. Lebengeschichte einer deutschen
Jüdin aus der Romantik, Piper, München 1959 (200312); trad. it. Rahel
Varnhagen. Storia di una donna ebrea, a cura di L. Ritter Santini, Net, Milano
20042.
Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, The Viking Press, New
York, 1963; trad. it. La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, trad. di
P. Bernardini, Feltrinelli, Milano 2001.
Men in dark times, Harcourt Brace & Co., New York 1968.
Die verbogene Tradition. Acht Essays, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1976; trad.
it. parz. Il futuro alle spalle, a cura di L. Ritter Santini, Il Mulino, Bologna
1981.
The Jew as pariah: Jewish identity and politics in the modern age, ed. by R. H.
Feldman, Grove Press, New York 1978; trad. it. parz. Ebraismo e modernità,
a cura di G. Bettini, Feltrinelli, Milano 20035 e Il futuro alle spalle, a cura di
L. Ritter Santini, Il Mulino, Bologna 1981.
The Life of the Mind, Harcourt, Brace & Jovanovich, New York, 1978; trad. it.
La vita della mente, intr. di A. Dal Lago, Il Mulino, Bologna 1987.
Essays in Understanding 1930-1954. Uncollected and Unpublished Papers,
Harcourt & Brace, New York 1994; trad. it. Archivio Arendt vol. 1. 19301948, a cura di S. Forti, Feltrinelli, Milano 2001.
Responsibility and Judgment, Schoken Books, New York 2003; trad. it.
24
Maria Letizia Pelosi
Responsabilità e giudizio, a cura di J. Kohn, Einaudi, Torino 2004.
Carteggi:
H. ARENDT-H. BLÜCHER, Briefe 1936-1968, hrsg. L. Köhler, Piper, MünchenZürich 1996.
H. ARENDT-K. JASPERS, Briefwechsel 1926-1969, hrsg. L. Köhler und H. Saner,
Piper, München-Zürich 20012; trad. it. parz. Carteggio (1926-1969). Filosofia
e politica, a cura di A. Dal Lago, Feltrinelli, Milano 1989.
Letteratura su Hannah Arendt:
S. BEDFORD, Emancipation and Destiny, in “The Reconstructionist”, 12
dicembre 1958, pp. 22-26.
E. YOUNG-BRUEHL, Hannah Arendt 1906-1975. Per amore del mondo, Bollati
Boringhieri, Torino 1990.
S. BENHABIB, Hannah Arendt and the redemptive power of narrative, in “Social
Research”, vol. 57, Spring 1990, pp. 167-197.
D. BARNOUW, Visible Spaces. Hannah Arendt and the German-Jewish Experience,
The John Hopkins University Press, Baltimore-London 1990.
M. CANOVAN, Hannah Arendt. A reinterpretation of her political thought,
Cambridge University Press, Cambridge-New York 1992.
L. BAZZIidge, MA 1996.
F. COLLIN, L’homme est-il divenu superflu? Hannah Arendt, Odile Jacob, Paris
1999. CALUPO, Hannah Arendt. La storia per la politica, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 1995.
R. J. BERNSTEIN, Hannah Arendt and the Jewish Question, MIT Press, Cambr
S. FORTI (a cura di), Hannah Arendt, Bruno Mondadori, Milano 1999.
S. BENHABIB, The reclutant modernism of Hannah Arendt, AltaMira Press,
Walnut Creek, Ca 2000.
C. CHRISTOPHERSEN, «
es ist mit dem Leben etwas gemeint». Hannah Arendt
über Rahel Varnhagen, Helmer Verlag, Königstein-Taunus 2002.
J. KRISTEVA, Hannah Arendt. La vita, le parole, trad. di M. Guerra, Donzelli,
Roma 2005.
R. VITI CAVALIERE, Critica della vita intima. Soggettività e giudizio in Hannah
Arendt, Guida, Napoli 2005.
S. FORTI, Hannah Arendt tra filosofia e politica, Bruno Mondadori, Milano 2006.
Altra letteratura:
E. CROCE, Rahel e l’ideale della socievolezza, in Romantici tedeschi e altri saggi,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1962.
Hannah Arendt e Rahel Varnhagen: una biografia filosofica
25
U. ISSELSTEIN, Costruzione e ricostruzione di un’identità. Rahel Levin
Varnhagen e i suoi diari, in C. CASES (a cura di), Ricerche di identità, La
Rosa, Torino 1985.
W. BENJAMIN e G. SCHOLEM, Teologia e utopia. Carteggio 1933-1940, Einaudi,
Torino 1987.
J. DERRIDA, «Ho il gusto del segreto» (Cinquant’anni di vita intellettuale
cosciente), intervista a cura di M. Ferraris, in “Iride”, n. 12, 1994, pp. 320330.
A. CAVARERO, Tu che mi guardi tu che mi racconti, Feltrinelli, Milano 1997.
G. CANTILLO, Introduzione a Jaspers, Laterza, Roma-Bari 2001.
R. LEVIN VARNHAGEN, Nel mio cuore un altro paese. Una donna ebrea ai tempi
di Goethe, a cura di U. Isselstein, ECIG, Genova 2005.
La creazione tra ontologia e teologia in Antonio Rosmini
27
La creazione tra ontologia e teologia in Antonio Rosmini
Memoria di Giulio Nocerino
presentata dal socio naz. ord. res. Giuseppe Cantillo
(seduta del 26 aprile 2007)
Abstract. The rosminian philosophy intends to build a strict creationism, able to face the challenges
of the modern thinking, especially those emerging from the philosophical Immanentism of the german
Idealism. Therefore, Rosmini thinks, with severity and notional courage, about the connection infinitefinite, God-world, giving a philosophical and rational shape to the Christian idea of creatio ex nihilo
without, however, deleting the ultimate element of the mystery.
L’esito ultimo del pensiero rosminiano, il suo piú alto contributo, ma anche
i problemi fondamentali, che esso ha proposto e lasciato fecondamene aperti,
si trovano nello sforzo speculativo poderoso e incompiuto della Teosofia. I sei
libri sull’ontologia, scritti tra il 1846 e il 1855, fino a pochi mesi dalla morte,
e intervallati dalla stesura di altre importanti opere, quali l’Introduzione alla
filosofia, la Logica, il Saggio storico critico sulle categorie, l’Aristotele esposto ed
esaminato, il Del divino nella natura, costituiscono una ripresa di tutti i grandi
nodi del pensiero rosminiano e uno sviluppo, nel senso dell’approfondimento
del loro spessore metafisico e della ricerca sia di una stabile e radicale fondazione teoretica sia di un’altrettanto radicale definizione dei limiti di ogni possibile
sapere e di ogni tentata fondazione1.
La dottrina rosminiana della creazione rappresenta, a nostro avviso, il tentativo piú intenso di elevare il teismo creazionista cristiano al livello di progresso
formale e di approfondimento teoretico, che il pensiero filosofico contemporaneo aveva raggiunto nella discussione dei grandi problemi metafisici, o, meglio,
del loro “superamento”, nell’ambito della filosofia classica tedesca e, in particolare, della filosofia hegeliana2. L’ontologia delle forme, elaborata da Rosmini fin
1
Per la tormentata storia redazionale ed editoriale della Teosofia, cfr. C. Gray, Introduzione
in A. Rosmini, Teosofia, EN I, Edizioni Roma, Roma 1938, pp. XI-CXLV (in particolare, le pagg.
XXXIV-XLI).
2
Nella Prefazione alla prima edizione della Wissenschaft der Logik, datata 22 marzo 1812,
Hegel, presentando la völlige Umänderung (completa trasformazione), avvenuta nel pensiero
28
Giulio Nocerino
dal Nuovo Saggio, con la chiara distinzione tra le due forme dell’essere coinvolte
nel processo conoscitivo umano, la forma ideale e la forma reale, e l’adombramento della necessità della loro sintesi in una terza forma, la forma morale,
gli consente di presentare una complessa ricostruzione teoretica, analogica
e ipotetica, del processo creativo con cui l’Assoluto pone, liberamente e dal
nulla, il mondo degli enti finiti e contingenti, intesa a replicare alle soluzioni idealistiche, sostanzialmente immanentistiche (emanatistiche e panteistiche, per Rosmini), del problema del rapporto Uno-molti, finito-infinito,
essere-enti. Proprio muovendo dalla sua ontologia, inoltre, il Roveretano
può sviluppare una della prime critiche del pensiero tedesco, per la cultura
italiana la prima in assoluto, fondata su una conoscenza ampia e, per lo
piú, diretta dei testi.
1. La dottrina della creazione
Rosmini presenta la descrizione della creazione nel secondo libro della Teosofia, L’essere uno. Il concetto di creazione viene introdotto tra i corollari della
dottrina dell’essere iniziale, virtuale e possibile3. La chiarificazione della natura dell’essere uno comporta la comprensione delle sue relazioni con i termini
che lo definiscono e lo compiono, non lasciando che esso resti «uno, solitario,
sterile»4, come nei sistemi degli unitari, cioè dei pensatori che hanno concepito
il Principio come Uno escludente la molteplicità. La ricerca di Rosmini ha inifilosofico nei venticinque anni precedenti, come uno höhere Standpunkt (una piú alta posizione) della coscienza di sé dello spirito, scrive: «Quello che prima si chiamava metafisica è stato,
per cosí dire, estirpato fin dalla radice (mit Stumpf und Stiel ausgerottet), ed è scomparso di fra
le scienze. Dove si ascoltano piú, o dove si posson piú ascoltare le voci dell’antica ontologia,
della psicologia razionale, della cosmologia, o anche di quella che si chiamava teologia naturale? Dove potrebbero ormai destar interesse ricerche come p. es. quella sull’immaterialità
dell’anima o sulle cause meccaniche e finali? Anche delle antiche prove dell’esistenza di Dio
non si parla piú che o semplicemente per la storia, oppure in un intento di edificazione e di
elevazione spirituale. […] Quanto al tentativo d’i g n o r a r e il generale mutamento, anche nel
campo scientifico esso comincia ad andar fallito», (G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, 2
Bde., hrsg. von G. Lasson, F. Meiner, Leipzig 1951, pp. 3, 5; trad. it. a cura di A. Moni, Laterza,
Roma-Bari 1994, vol. I, pp. 3, 5). Ancora, nella Introduzione: «La filosofia critica aveva per vero
dire già trasformata la metafisica in logica» (ivi, p. 32; trad. it. p. 32).
3
Sulla dottrina rosminiana della creazione, cfr. I. Scotucci, La creazione in Rosmini, Studium, Roma 1972; C. M. Fenu, Il problema della creazione nella filosofia di Rosmini, Edizioni
Rosminiane Sodalitas, Stresa 1995; N. Ricci, In trasparenza. Ontologia e dinamica dell’atto creativo in Antonio Rosmini, Città Nuova, Roma 2005.
4
A. Rosmini, Teosofia, 6 voll., a cura di M. A. Raschini e P. P. Ottonello, ENC 12-17, Città
Nuova, Roma 1998-2002, II, n. 315 (d’ora in poi, per la Teosofia indicheremo solo il numero del
libro e quello del/dei paragrafo/i, ovviamente facendo riferimento alla ENC).
La creazione tra ontologia e teologia in Antonio Rosmini
29
zio, quindi, da una concezione dell’essere, che non solo non esclude, ma anzi
postula e cerca di dimostrare che nell’essere stesso, prima della moltiplicazione
mondana degli enti, vi sia una molteplicità coeterna, una molteplicità originaria,
quella delle forme. Il principio della teoria dell’essere uno è, secondo Rosmini,
«la relazione che l’essere, concepito come anteriore a’ suoi termini, ha co’ suoi
termini»5. Da questo principio discendono i tre concetti di essere indeterminato,
essere virtuale, essere iniziale6.
Rosmini riassume i risultati emersi da questa prima prospettiva, in quattro punti: «l’essere indeterminato non è qualche cosa dell’ente contingente, ma
qualche cosa dell’ente necessario ed assoluto»7, cioè è una appartenenza di Dio,
e perciò un elemento divino; l’essere è «la materia dialettica, cioè il primo determinabile di tutti gli enti contingenti», in quanto tale esso è principio dialettico
di tutti gli enti e di tutte le essenze, «non costituisce l’essenza d’alcuno di essi,
ma è soltanto causa e condizione che precede l’essenza di tutti»8; l’essere è il primo determinante, in quanto è «atto primo e universalissimo», è, quindi, «l’atto
che fa sí che l’essenza sia piuttosto questa che un’altra» ed è la «causa determinante universale che determina all’essenza il suo modo di essere»9, e determina
l’essenza di ogni ente possibile; l’essere è l’ultima determinazione, vale a dire
«l’atto pel quale ogni essenza è, e quindi è ultima determinazione di tutte, e cosí
è forma universale di tutte le forme»10.
Una seconda prospettiva consiste nel conoscere «che cosa l’essere conferisca
a’ suoi termini»11. Prima d’intraprendere quest’indagine, Rosmini non tralascia
di proporre alcune riflessioni sul metodo del discorso ontologico, riconoscendo
ai pensatori tedeschi il merito di aver compreso che «il metodo dell’Ontologia
si confonde coll’Ontologia stessa: sicché la scienza qui è il proprio metodo, o
per dir meglio involge il suo metodo in sé medesima»12. L’Ontologia non può
Ibidem.
Di questi tre concetti Rosmini dà alcune compendiose definizioni: «il primo, che è l’oggetto dell’intuito, è considerato unicamente come privo de’ termini, il secondo è considerato
come suscettivo di tutt’i termini, il terzo è considerato come inizio di tutte le entità aventi o
involgenti qualche termine: sempre dunque in relazione co’ suoi termini. Cosí l’essere uno anteriore a’ suoi termini ci si moltiplicò in mano, e ci si moltiplicherà maggiormente, quanto piú
svolgeremo il principio accennato di questa teoria» (Teosofia, II, n. 315). Cfr. P. P. Ottonello,
L’ontologia di Rosmini, Japadre, L’Aquila-Roma 1989.
7
A. Rosmini, Teosofia, II, n. 318.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ivi, n. 319.
12
Ivi, n. 320. Si veda sul tema la Vorrede alla Fenomenologia dello spirito di Hegel (G. W.
F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Werke, 20 Bde., Bd. 3, Suhrkamp, Frankfurt am Main
1970, p. 46; trad. it. a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano 2000, p. 104-105). Anche l’Enciclo5
6
30
Giulio Nocerino
essere preceduta da un discorso sul metodo, perché essa è la scienza che tratta «dell’essere stesso in tutta la sua universalità, e del suo ordine»13. I principi
del metodo, infatti, secondo Rosmini non sono altro che «l’ordine intrinseco
dell’essere considerato in relazione colla mente umana»14; di conseguenza, la
scienza, che si occupa dell’essere e del suo ordine, non può ripetere il suo metodo da altro che dal suo stesso cammino e dal suo procedere. Mentre le altre
scienze possono ricevere i principi metodici dalla scienza (o dalle scienze), che
le precedono nell’organismo del sapere, assegnare all’Ontologia un metodo, che
la precedesse, significherebbe anteporre ad essa un suo brano, un suo frammento, «il che riuscirebbe un guasto e un dilaceramento della scienza stessa»15.
Per comprendere la dottrina rosminiana della creazione e il suo significato
all’interno dell’ontologia delle forme dell’essere è necessario seguire l’articolato
e complesso discorso, che Rosmini dedica al rapporto essere-termini dell’essere e a ciò che l’essere conferisce a questi ultimi, in primis distinguendo tra Ente
infinito ed enti finiti. Rosmini propone due definizioni iniziali dell’Ente infinito
e dell’ente finito: «l’ente infinito è l’essere che sussiste nelle sue tre forme», «l’ente finito è la forma del reale finito che ha l’essere»16. Da queste definizioni, in cui
la dottrina classica della differenza tra l’essere, che è per essenza (Essere infinito), e gli enti contingenti, che sono soltanto per partecipazione, viene declinata
alla luce della distinzione tra le forme dell’essere, emerge in tutta la sua portata
ontologica la distanza tra infinito e finito. «Il subietto nell’Ente infinito – scrive
Rosmini – è l’essere stesso; laddove il subietto nell’ente finito non è l’essere, ma
la forma reale»17; per il Roveretano, l’essere negli enti finiti è solo antesubietto,
è soggetto dialettico, perciò è principio dialettico degli enti finiti, il cui principio
metafisico è l’Essere assoluto creatore, in quanto, come abbiamo visto, è primo
determinabile, ma non soggetto reale. Se lo fosse, lo scoglio del panteismo, cosí
temuto da Rosmini, sarebbe inevitabile, come dimostrano gli esiti idealistici
del trascendentalismo nel pensiero tedesco. Essendo soltanto forma, l’ente finito non è essere per sé, ma solo «per l’essere ad essa [alla forma] aggiunto»18.
In virtú di questo statuto ontologico, l’ente finito è segnato dalla differenza, da
pedia inizia ribadendo la specificità della filosofia quanto al metodo e all’oggetto. Cfr. G.W. F.
HEGEL, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, Werke (Bde. 8-10), 3
Bde., Suhrkamp, Frankfurt am Main 1999, Bd. I, § 1, p. 41; tr. it. a cura di V. Verra, A. Bosi, 3
voll., UTET, Torino 1995-2000, vol. I, § 1, p. 123.
13
A. Rosmini, Teosofia, II, n. 320.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ivi, n. 321.
17
Ivi, n. 322.
18
Ibidem.
La creazione tra ontologia e teologia in Antonio Rosmini
31
un’alterità ontologica intrinseca: «c’è una diversità reale nell’ente finito tra la
forma reale che lo costituisce quel subietto che è, e l’essere che lo fa esistere»19.
In questo esser altro dall’essere, che si fa diversità da sé all’interno di sé, sta la
ragione e l’essenza della finitezza degli enti contingenti; essi sono forma dell’essere a cui deve aggiungersi, nel modo della sintesi, l’essere della forma.
Nessuna diversità reale, nel senso di un’alterità irriducibile, segna invece
l’essere dell’Assoluto, in cui, in quanto «Essere sussistente nelle sue tre forme»,
«non può esserci nessuna reale distinzione tra lui e le sue forme, perché le
forme altro non sono che il triplice atto del suo stesso sussistere»20. Le forme
dell’Essere infinito sono forme sussistenti, secondo Rosmini, la cui filosofia,
qui come altrove, attinge alla Rivelazione cristiana e in particolare al pensiero
trinitario da essa ispirato21. Dalle forme sussistenti dell’Essere infinito22, che, teologicamente, sono le persone della Trinità, vanno tenute distinte le forme che
caratterizzano l’ontologia del finito, che il Roveretano chiama forme categoriche. Queste ultime non sono che l’astratto delle forme sussistenti, esistenti solo
relativamente alla mente che le pensa, di cui l’uomo può formarsi il concetto sia
astraendole dagli enti finiti (dalle idee la forma obiettiva, dai reali sentiti la forma subiettiva, dai «sentimenti che riguardano le obbligazioni morali» la forma
morale), sia attraverso un’astrazione discendente esercitata sul concetto dell’Essere assoluto; quest’astrazione è, ovviamente, posteriore alla prima23.
Da quest’argomentazione discende la distinzione, di grandissimo rilievo nel
pensiero rosminiano, tra termini propri e termini impropri dell’essere: i primi
sono le forme dell’Essere infinito, perfettamente identiche all’essere stesso e
l’una insidente nell’altra (la rosminiana insessione reciproca o circuminsessione
delle forme dell’essere, che giunge alla perfezione di un sintesismo senza residui
soltanto nell’Essere infinito24), dei secondi, invece, è espressione la forma reale
Ibidem.
Ibidem.
21
In chiusura del primo libro della Teosofia, Rosmini fa osservare che certamente non si
possono identificare le Persone della Trinità con le forme dell’essere, «nondimeno non solo si
può dimostrare col raziocinio l’esistenza di Dio, ma ben anco si può conoscere quella d’una
Trinità in Dio in un modo almeno congetturale con ragioni positive e dirette, e dimostrativamente con ragioni negative e indirette» (A. Rosmini, Teosofia, I, n. 191).
22
A. Rosmini, Teosofia, III, n. 955.
23
Per i concetti di astrazione discendente e astrazione teosofica, vedi A. Rosmini, Teosofia,
III, n. 1179.
24
Cfr. M. A. Raschini, Il sintesismo teosofico, in Rosmini: il divino nell’uomo, Atti del XXV
Corso della «Cattedra Rosmini», a cura di P. Pellegrino, Sodalitas - Spes, Stresa - Milazzo 1992,
pp. 167-188; Id., Il principio dialettico nella filosofia di A. Rosmini, Marzorati, Milano 1961; ID.,
Dialettica e poiesi nel pensiero di Rosmini, Marsilio, Venezia 1996; ID., Rosmini oggi e domani,
Marsilio, Venezia 1999.
19
20
32
Giulio Nocerino
costitutiva dell’ente finito. Questa, infatti, riceve l’essere, non ne è momento inseparabile e necessario, come dimostra la contingenza dei reali finiti.
La ricerca «di ciò che l’essere conferisca a’ suoi termini», nel senso dei termini finiti (impropri), si articola, secondo Rosmini, in quattro ricerche speciali:
«1°. che cosa ci abbia d’incomunicabile nell’essere agli enti finiti; 2°. quale sia la
natura della comunicazione dell’essere, e partecipazione delle proprietà dell’essere dalla parte de’ reali finiti; 3°. se l’essere riceva nulla dalla sua comunicazione co’ reali; 4°. quali sieno le proprietà dell’essere comunicabili ai reali finiti e
che in questi si trovano»25.
2. Dall’illimitazione dell’essere alla limitazione degli enti
Dapprima Rosmini pone, come ragione della distinzione tra ciò che dell’essere si comunica ai reali finiti e ciò che non si può comunicare, la limitazione
o finitezza degli enti contingenti, quella stessa limitatezza che rende necessario
l’atto di una volontà intelligente e libera, affinché essi vengano all’esistenza. La
natura dell’essere è segnata dalla comunicabilità, concetto dietro il quale s’intravede quella manifestatività dell’essere stesso, su cui Rosmini si sofferma soprattutto nel quarto libro della Teosofia; i limiti, che incontra la comunicazione
dell’essere ai finiti, quindi, non possono discendere che dai finiti stessi, «dalla
limitazione del reale che costituisce il subietto dell’ente finito»26. Il concetto di
limite diventa il principio universale della ricerca di ciò che si può o non si può
comunicare al finito; ne consegue, ovviamente, che la prima proprietà dell’essere, che non si comunica agli enti contingenti, è proprio la sua illimitazione.
Non solo, però; l’essere non può comunicare agli enti la sua stessa capacità
(virtualità) di comunicarsi, per quanto, vedremo, una forma di comunicazione dell’essere al reale è opera delle intelligenze finite, nell’atto della percezione
intellettiva. Da ciò consegue, sul piano dell’ontologia del finito e delle relazioni
tra i finiti, la particolare modalità secondo la quale essi si rapportano reciprocamente. Infatti, l’azione di un ente finito sull’altro è l’unica modalità del loro
rapportarsi, restando esclusa dalla finitezza della forma reale, che costituisce
il proprio di ogni contingente, la possibilità di comunicarsi all’altro, di manifestarsi, nel senso piú pieno di queste parole. Solo l’essere è manifestativum sui,
solo l’essere è presenza che si comunica, senza bisogno di azione transitiva. An-
25
26
A. Rosmini, Teosofia, II, n. 326.
Ivi, n. 327.
La creazione tra ontologia e teologia in Antonio Rosmini
33
che qui, come altrove, l’ontologia delle forme conferisce al discorso rosminiano
un’originalità, pur nella ripresa di concetti classici: l’ente finito, infatti, si rivela non solo limitato perché determinato, segnato da confini che non affettano
l’infinita universalità dell’essere, ma anche perché costituito da una sola delle
forme, in cui si articola e dialettizza l’essere. L’univocità formale dell’ente finito
ne costituisce un limite, tanto quanto la molteplicità originaria delle forme costituisce la ricchezza ontologica dell’essere.
Oltre l’illimitatezza, vi sono altre proprietà dell’essere, che l’ente finito non
può ricevere: l’aseità (l’essere da sé, il non ricevere l’essere da altro), la comunicabilità dell’essere (l’abbiamo appena visto), l’identità, in virtú della quale l’essere è essere, semplice e uguale a se stesso, mentre l’ente contingente è «duplice,
uguale a se stesso e disuguale, e non uno e semplice e uguale a se stesso come
l’essere»27. Anche qui, l’apporto piú originale di Rosmini emerge dalla dottrina
delle forme dell’essere: se la definizione dell’ente finito come «un reale finito unito coll’essere» rivela immediatamente la differenza, che affetta la costituzione
ontologica degli enti contingenti, il loro essere realtà esistenziata da un essere
che non gli appartiene, la distanza del finito dall’infinito si chiarisce ancor piú,
quando Rosmini afferma che l’ente finito, pur essendo solo forma reale (cioè
sussistendo come ente soltanto nella prima forma dell’essere), partecipa anche
delle altre due, la forma ideale e la morale, ma che esse sono, in lui, qualcosa di
radicalmente diverso da ciò che sono nell’Essere infinito. «Anche l’ente finito –
scrive Rosmini – ha le sue tre forme, ma in una maniera totalmente diversa da
quella in cui è nelle sue tre forme l’ente infinto. L’Ente infinito dicesi ente perché è egli stesso “l’Essere in sé terminato”, ma l’ente finito dicesi ente non perché sia anch’egli “l’Essere in sé terminato”, ma perché è un “reale che partecipa
dell’essere, e che non è l’essere”. L’ente finito dunque è un ente relativo e non
un ente assoluto: e propriamente parlando altro non è, come dicevamo, che un
termine o forma impropria dell’essere stesso, quasi sospesa all’essere»28.
Da quella che abbiamo chiamato l’univocità formale dell’ente finito, cioè il
suo essere soltanto forma reale a cui si aggiunge l’essere, consegue la necessità
di definire il rapporto del finito con le altre due forme dell’essere, di cui esso
pure, in qualche modo, partecipa. «La forma oggettiva dell’ente finito – scrive Rosmini – non è l’ente finito, ma sono le idee determinate, e queste altro
non sono, che l’essere stesso in quanto serve a far conoscere l’ente finito come
possibile, e come sussistente»29; di questa forma oggettiva dell’ente finito par Ivi, n. 329.
Ibidem. Il corsivo è mio.
29
Ivi, n. 330.
27
28
34
Giulio Nocerino
tecipano le intelligenze finite, ma solo nel modo della conoscenza, cioè come
di un «oggetto da esse diverso»30, e non come di qualcosa che ne costituisca
l’esistenza subiettiva, cioè la reale sussistenza. Anche della forma morale l’ente
finito partecipa come di un altro, diverso da sé, come di una comunicazione
dell’amabilità dell’essere: «la forma morale dell’ente finito è una comunicazione
dell’essere stesso morale, cioè dell’essere come amabile»31. Questa comunicazione-partecipazione si realizza quando il soggetto finito intelligente si uniforma, nel suo agire e vivere, «all’essere obiettivo rappresentante ossia facente conoscere tutte le cose»32. Anche qui, come nel caso della forma oggettiva e come
nel caso dell’atto d’essere che lo fa esistere (l’atto di entificazione, per usare il
lessico rosminiano), il soggetto finito è di fronte ad un altro, a quella diversità
reale in sé, immanente alla propria costituzione ontologica, che lo distingue
dall’Essere infinito. La forma morale, infatti, «è ricevuta nell’essere subiettivo
finito, che ne trae la sua perfezione, ma è un altro da lui, perché è l’amabilità e
l’amore dell’essere ordinatissimo in sé, che si mostra all’ente finito senza confondersi, contribuendo l’attività di questo a ricevere in sé quell’amabilità e cosí
perfezionarsi»33.
3. L’essere come principio dialettico e l’Essere come principio metafisico
La relazione delle cose contingenti coll’essere è duplice e si articola dando
luogo ad una dialettica di immanenza e trascendenza, che è uno dei caratteri di
fondo del discorso ontologico rosminiano, e che già si presenta sul piano della gnoseologia. Scrive Rosmini: «la relazione delle cose contingenti coll’essere
virtuale ed iniziale è duplice, l’una consiste in questo, che l’essere deve trovarsi
in esse con alcune sue prerogative acciocché esse sieno, e come tale egli è causa formale, universale, antecedente e susseguente nell’ordine dialettico [questo
costituisce un momento di immanenza dell’essere all’ente], l’altra consiste in
questo, che l’essere deve avere altre prerogative colle quali egli non si trovi nelle
cose, prerogative tuttavia necessarie e proprie di lui, e, come tale, egli è causa condizionale, ossia condizione assolutamente necessaria, acciocché sieno le
cose contingenti [questo è il momento della trascendenza]»34.
Ibidem.
Ibidem.
32
Ibidem.
33
Ibidem.
34
Ivi, n. 336.
30
31
La creazione tra ontologia e teologia in Antonio Rosmini
35
L’approfondimento riguardo alla natura della comunicazione e congiunzione dell’essere coi reali, che occupa l’intero capitolo V della terza sezione del
secondo libro della Teosofia, impegna Rosmini a delineare quel rapporto finitoinfinito, da cui emerge la razionalità e necessità della tesi creazionista e, quindi, di uno dei nuclei fondamentali del teismo cristiano. L’essere iniziale, il cui
concetto è desunto dalla riflessione sull’essere ideale, intuito immediatamente
dalla mente umana ha tre relazioni con il reale: la relazione d’identità, la relazione di causa atto immediata, la relazione di causa atto mediata. Si noti che il
Roveretano tratta qui della causa atto, cioè dell’essere iniziale, non dell’Essere
completo infinito, ultima e vera causa di ogni ente, di cui si predica il concetto
di causa subietto. Il risultato di un’eventuale negligenza di questa distinzione
sarebbe il panteismo, la confusione tra principio dialettico e principio metafisico. L’essere iniziale è, per noi intelligenze finite, essere-atto privo del suo soggetto, in questo senso è essere indeterminato, di cui non vediamo, e non possiamo
vedere, l’esistenza e soggettività proprie35; questo significherebbe, infatti, vedere Dio stesso, come nell’ontologismo giobertiano, almeno secondo la critica che
gli muove Rosmini 36, e non soltanto una sua appartenenza, cioè quell’elemento
divino, ma non Dio nella sua realtà, che è l’idea dell’essere.
Se consideriamo, quindi, l’essere non come soggetto, ma solo come atto,
esso si presenta come «forma universalissima e non propria delle cose, ovvero
forma universale ed unica di tutte le forme finite»37. Questo spiega perché Rosmini possa, senza timore di andare incontro ad esiti panteistici, sottoscrivere,
correggendola, l’affermazione bruniana, per cui ogni ente è piuttosto legato al
tutto che alla sua stessa forma. Il fondo di verità di questa sta nel riconoscimento dell’essere come forma di tutte le forme, e, perciò, possibilità universale degli
enti. Scrive Rosmini, nel sesto libro della Teosofia, Il reale: «l’esistenza oggettiva
[l’esistenza nell’essere ideale-universale] non può mancare giammai agli enti,
35
Cfr. A. Rosmini, Teosofia, II, n. 342. Il soggetto dell’essere, che sia uno degli enti reali
finiti, che sia l’Ens realissimum, resta nascosto
36
Scrive Rosmini: «È falso, che nelle cose percepite si veda Dio stesso, il quale è l’essere
terminato sussistente, e assoluto: quando in esse altro non s’apprende, che l’essere non ideale,
non reale, ma indifferente, cioè anteriore alle sue forme e a tutti i suoi termini, il quale cosí
unito alla realità sensibile, costituisce l’ente contingente reale da noi percepito, che ha l’essere
come materia dialettica e antecedente, e come forma pure dialettica e ultima, non sua propria,
ma comune a tutti ugualmente i reali finiti» (A. Rosmini, Teosofia, II, n. 310). Per la critica di
Rosmini all’ontologismo giobertiano, si vedano in particolare A. Rosmini, Teosofia, II, nn. 308310; Id., Vincenzo Gioberti e il panteismo, a cura di P. P. Ottonello, ENC 21, Città Nuova, Roma
2003; G. Bonafede, Nota sulle forme dell’essere e sull’ontologismo (I-II), «Rivista Rosminiana»,
41 (1948) I, pp. 1-13 e 41 (1948) II, pp. 49-53.
37
A. Rosmini, Teosofia, II, n. 342.
36
Giulio Nocerino
di modo che se mancasse loro non sarebbero piú enti»38. Tutti gli enti devono
partecipare, seppur in modo diverso, dell’esistenza oggettiva, siano essi enti
puramente sensitivi (o, anche, solo lo spazio, la materia, i corpi non sensitivi),
per cui l’essere ideale è solo inizio e non termine, enti intelligenti finiti, «alla cui
intuizione è termine l’essere ideale come un altro, un diverso da essi»39, o Dio,
«a cui l’esistenza oggettiva è termine proprio»40.
4. Creazione divina e creatività umana. Il sorgere dell’intelligenza
Il percorso di pensiero, che conduce Rosmini, e noi che lo seguiamo, alle
pagine della descrizione della creazione, è, in realtà, un lungo approssimarsi alla
formulazione piú precisa e profonda di questa teoria, i cui elementi, le cui tesi e
i cui nodi problematici emergono via via che la Teosofia cresce su se stessa, con
passi avanti e continui ritorni riflessivi, intesi a far emergere l’implicito dei concetti man mano conquistati. Cosí, raggiunta la distinzione tra causa atto e causa subietto, Rosmini avanza nella sua analisi della comunicazione dell’essere
ai reali e della creazione, che in questa comunicazione consiste, sempre avendo
presente quell’analogon (con)creativo, di cui sono capaci le intelligenza finite
anche con il solo percepire il mondo. In qualche modo, e vedremo con quanti
e quali limiti, finanche le intelligenze finite, e tra queste l’uomo, sono cause subietto del reale. L’approfondimento della creazione originaria e assoluta di Dio
e di quella particolare forma di creatività delle intelligenze finite, che Rosmini
chiamerà, alcune pagine dopo queste che stiamo discutendo, creazione completiva, procedono parallele. La prima è modello, oltre che, ontologicamente,
condizione di possibilità della seconda; quest’ultima, d’altra parte, è l’analogo
dell’atto divino di creazione ed è ciò che consente agli uomini di tentare la conoscenza del processo creativo, per quanto soltanto attraverso concetti sempre
approssimativi e ipotesi ardite.
In primo piano, per Rosmini, c’è la differenza tra Essere ed enti, differenza
che egli ribadisce, affrontando la questione «se l’essere riceva nulla dalla sua
congiunzione co’ reali finiti»41. L’atto di creazione è sempre e da sempre in Dio,
come vi è sempre e da sempre il creato «come oggetto veduto e affermato nel
A. Rosmini, Teosofia, VI, n. 2189.
Ibidem.
40
Ibidem.
41
A. Rosmini, Teosofia, II, cap. VI.
38
39
La creazione tra ontologia e teologia in Antonio Rosmini
37
Verbo realmente sussistente e per sé intelligibile ed inteso»42. Rosmini si spinge
a scrivere: «l’atto creativo e l’oggetto finito affermato nel Verbo e col Verbo non
è una mutazione in Dio, ma un’eterna sua perfezione»43. La possibilità del finito
è inscritta nell’Essere stesso di Dio, fin dalla generazione del Verbo, Oggetto assoluto, in cui essa giace, veduta e conosciuta, in forma oggettiva, come vi giace
tutta la realtà infinita di Dio. In Dio, e precisamente nel Verbo divino, Oggetto
sussistente, è tutto l’essere, quindi anche l’essere nella condizione di finitezza.
Quest’ultimo, però, non vi si trova se non come oggetto, come reale oggetto
conosciuto; la sua esistenza soggettiva, invece, è fuori di Dio: «in quanto all’ente finito subiettivamente esistente, questo nulla aggiunge all’Essere assoluto, e
però non è necessario alla sua natura, ma liberamente voluto»44.
In questi passaggi, la Teosofia manifesta il suo spessore e la sua densità teologici, evidenti in vari luoghi dell’opera. Tuttavia il concetto che consente a Rosmini di costruire il suo discorso è sempre quello, rigorosamente filosofico, dell’essere indeterminato: esso oltre ad essere atto puro, scevro del suo soggetto proprio,
«si vede come attuante i reali, e da questo intimo nesso co’ reali, avviene ch’egli
si renda al nostro pensiero subietto dialettico di tutti universalmente i reali, e di
ciascuno di essi»45. L’essere si presenta in una forma di contrazione in relazione
ai singoli enti, a cui si comunica come actus essendi. Questa contrazione dell’essere, in quanto atto, esige qualcosa d’altro rispetto a una necessità logico-metafisica, esige, infatti, un atto libero dell’Essere sussistente. «Nell’essere intuito
dalla mente – spiega Rosmini – c’è 1°. L’essenza: 2°. e l’oggettività o intelligibilità. Come essenza nella sua virtualità è e rimane universale, ma in quanto è atto
ultimo e comune de’ singoli reali contrae questo suo atto veramente ai reali che
lo ricevono, ma quest’atto dell’essere, non è quello che costituisce la sua essenza
necessaria, ma un atto che corrisponde all’atto libero dell’essere sussistente; il
quale di ragione si distingue dall’atto necessario»46. Vi è, ed è particolarmente
significativa, una corrispondenza tra la distinzione di un atto necessario da un
atto libero in Dio e la differenziazione tra l’essere come atto universale e l’essere
come atto contratto, se cosí possiamo dire, nei singoli reali. In Dio, l’atto necessario è «quello pel quale è», l’atto dell’Essere per sua essenza esistente, l’atto
libero, invece, è «l’atto creativo, pel quale è il mondo»47. Nell’essere dell’intuito
intellettuale si ripete questa distinzione: vi è «un atto che risponde all’atto ne A. Rosmini, Teosofia, II, n. 361.
Ibidem.
44
Ibidem.
45
Ibidem.
46
Ivi, n. 362.
47
Ibidem.
42
43
38
Giulio Nocerino
cessario di Dio e quest’è l’essere virtuale; e un atto che risponde all’atto libero di
Dio e quest’è quello col quale egli fa sussistere i singoli reali finiti, che abbiamo chiamato entificazione immediata o mediata»48. Questa vis entificante, che
l’essere-atto, quello che abbiamo definito principio dialettico, esprime comunicandosi ai singoli reali e portandoli all’esistenza, si conserva nell’essere stesso,
quasi thesaurus di creatività, a cui attinge il soggetto intelligente, quando, nella
percezione intellettiva, conferisce l’essere ai reali, compiendo quella entificazione relativa, di cui le intelligenze finite sono capaci.
Anche qui, Rosmini delinea un parallelismo, reso possibile dall’analogia, tra
atto creativo in Dio e creatività degli spiriti finiti: «come Iddio creante fa che
sia in sé, nella sua propria essenza l’atto creativo, cosí l’atto dell’entificazione rimane nel seno dell’essere virtuale e il subietto intelligente lo congiunge al reale
da lui sentito per mezzo dell’affermazione percettiva degli enti reali»49. Per Rosmini, Dio, l’Essere infinito, ha sempre in sé, assunta definitivamente nella sua
natura, la creatività, l’atto creativo, e, quindi, il rapporto all’altro, al finito creato. Proprio qui si colloca uno dei motivi piú forti di similitudine degli uomini,
come di altre possibili intelligenze finite, con il loro Creatore: anch’essi, infatti,
sono creatori, relativamente a sé, del mondo che percepiscono e in cui si muovono. Questa creatività, però, è un dono ricevuto insieme con la comunicazione
dell’essere: in quest’essere, che noi conosciamo e la cui intuizione fa di noi delle
creature intelligenti, si conserva l’atto di entificazione o, per essere piú chiari,
la capacità dell’essere, per sua natura universale, di applicarsi ai reali finiti, di
unirsi con essi in una sintesi anche mediante l’atto umano di percezione e di
farne degli enti, cioè di conferire loro l’atto d’esistenza. Come Dio, conoscendo
i reali, li crea, cosí noi entificandoli rispetto a noi, stessi, li conosciamo anche,
visto che l’essere dell’intuito, con cui li entifichiamo, è lo stesso, in quanto oggetto, che ci consente di conoscerli.
Rosmini si sofferma a considerare la relazione del reale finito con l’atto libero dell’Essere subietto, di Dio, per poi trattare la relazione del reale stesso con
l’essere attuante, quello che produce l’entificazione e che corrisponde, abbiamo
visto, all’atto libero di Dio. Noi sappiamo che «l’atto creativo rimane in Dio e
che ha per suo termine il Verbo divino [chiariamo il linguaggio di Rosmini: termine non significa effetto, in quanto il Verbo si origina dal Padre per generazione e non per creazione; esso è termine, in quanto il libero sguardo creatore di
Dio guarda al Verbo e nel Verbo vede il reale oggetto, cioè in forma ideale, e lo
48
49
Ibidem.
Ibidem.
La creazione tra ontologia e teologia in Antonio Rosmini
39
vede sia come reale infinito, se stesso Assoluto, che come possibile reale finito,
il mondo], nel quale il Padre vede ed afferma ad un tempo l’essere iniziale e il
reale del mondo nella sua forma obiettiva»50. Il mondo, cosí, «veduto e affermato come oggetto», acquista, a causa della energia dell’affermazione divina, in
virtú del fatto che in Dio conoscere e creare, intelletto speculativo e intelligenza
pratica coincidono, un’esistenza soggettiva, relativa a sé e, quindi, fuori di Dio.
A qualcuno di questi enti, però, spetta un destino (nel senso di una Bestimmung,
determinazione) particolare, perché Dio gli «fa apparire, come oggetto, l’essere
iniziale, che diciamo anche essere atto, e con questo lo entifica ad un tempo e
lo fa intelligente»51. Questo reale non solo ha l’essere come essere attuante, ma
come essere presente: è l’anima intellettiva. Essa è costituita da due elementi:
il primo è il sentimento proprio intellettivo, il principio dell’intelletto, che è la
sua realtà soggettiva, la sua sussistenza («il reale costituente il subietto»), l’altro
è «l’essere oggettivo, nel quale contemplando, è»52. L’anima intellettiva sorge,
quindi, dalla «congiunzione sintesizzante dell’essere col reale»53.
L’esistenza dei reali non intelligenti (sensitivi o non), per Rosmini, che rimanda alla Cosmologia la questione della loro essenza e natura, è affidata
all’azione entificante delle intelligenze finite; questo affidamento non è usurpazione, da parte del finito dotato d’intelletto, dei diritti dell’Infinito, quasi un sostituirsi della creatura creativa (con-creatrice) al Creatore primo e assoluto, in
quanto è affidamento (relativo), che Dio stesso fa, del mondo creato ad alcune
creature, elevate alla dignità dell’intelligenza e dello spirito. Rosmini scrive, riguardo agli enti finiti non intelligenti, che «Iddio gl’intuisce e afferma nel Verbo
come vuole che sieno, cioè relativi non a sé, ma agli enti intellettivi: gl’intuisce
e li afferma unitamente con questi, perocché a Dio il mondo è un oggetto solo
e lo fa con un atto solo»54. Il progetto creativo di Dio, e non una hybris umana
ribelle, affida alla relazione con le intelligenze finite l’esistenza stessa del mondo. Rosmini, qui, dà spessore e fondazione metafisici alla biblica consegna del
creato all’uomo, perché ne goda, ma anche lo conservi e governi. L’adamitico
dar nome alle cose le istituisce, le porta all’essere una seconda volta, dopo la
prima creazione divina, fondando cosí un rapporto uomo-mondo, che solo per
deviazione radicale ha potuto assumere il volto del possesso irresponsabile,
A. Rosmini, Teosofia, II, n. 363.
Ibidem.
52
Ibidem.
53
Ibidem.
54
Ivi, n. 364. G. Giannini, La nozione di mondo nella «Teosofia» di Rosmini, «Rivista Rosminiana», 86 (1993) III, pp. 259-274.
50
51
40
Giulio Nocerino
dell’uso violento, cioè stravolgente l’ordine essenziale degli enti, e non quello
della relazione di responsabilità.
Rosmini si interroga sulla questione: se l’essere riceva nulla dalla sua congiunzione con i reali finiti. E alla domanda può rispondere distinguendo tra
la causa subietto d’entificazione infinita, l’Essere sussistente, e la causa subietto d’entificazione finita, le intelligenze finite. I reali finiti, con la loro esistenza, nulla aggiungono all’Essere infinito; è quest’ultimo, invece, che «dà a se
stesso ab aeterno l’ente finito obbiettivo intuendolo nel proprio Verbo, dove è
indistinto»55 e lo distingue da sé soltanto con l’atto dell’affermazione creatrice,
«atto che pure rimane in Dio, indistinto dall’atto con cui Iddio è l’essere»56.
Ancora una volta, Rosmini ribadisce che l’atto di creazione è nell’essenza di
Dio, indistinto dal suo stesso essere. L’atto, invece, con cui il principio intellettivo finito è causa di entificazione, per quanto analogo, non può avere la stessa
profondità e incidenza metafisica. In primis, come abbiamo visto, l’intelligenza
finita non comunica ai reali qualcosa di sé, perché essa non è l’essere, ma solo
ne partecipa. «Iddio solo – scrive Rosmini – afferma qualche cosa di se stesso
cioè il reale finto obbiettivo creando il mondo, perché Iddio è l’Essere stesso.
L’uomo dunque (e dicasi il simile d’ogn’altra intelligenza finita) attribuisce al
reale l’essere, come diverso da sé, l’essere che intuisce, l’essere puramente atto
e non subietto»57. Quest’essere, intuito dalla nostra mente, è essere attuante il
reale finito, poiché, chiarisce Rosmini, esso è «termine dell’affermazione divina
e però ritiene dell’efficacia di questa affermazione realissima»58. L’essere, quindi, che noi intuiamo, ha in sé una vis, che trae dal suo esser originato, in Dio,
da un’affermazione di Dio stesso, per quanto «non ne viene da questo che tal
essere si veda in unione all’affermazione divina, ma solo in relazione co’ reali
finiti che pure sono ad un tempo termini della stessa affermazione»59. L’essere
indeterminato, vero e proprio perno e nucleo fondamentale di tutto il pensiero
rosminiano, fin dalle riflessioni gnoseologiche culminate nel Nuovo Saggio e nel
Rinnovamento, si arricchisce, in tutta la Teosofia, ma in modo particolarissimo
in queste pagine del secondo libro, di una densità e profondità di significati, di
cui Rosmini, con arditezza speculativa e, al contempo, aprendo questioni e problemi destinati ad un continuo approfondimento, cerca di rintracciare l’origine
nell’atto creativo di Dio. Rispetto a quest’atto, come il Roveretano sottolinea, in
Ivi, n. 366.
Ibidem.
57
Ibidem.
58
Ibidem.
59
Ibidem.
55
56
La creazione tra ontologia e teologia in Antonio Rosmini
41
continua, implicita e talvolta esplicita polemica con Gioberti, la nostra mente è
cieca, capace, certo, di coglierne il risultato, l’essere, i reali finiti e la loro sintesi, ma mai di vederlo, di averne percezione diretta60. L’essere virtuale, che le intelligenze finite immediatamente intuiscono, «nella percezione o entificazione
che l’uomo fa de’ reali […], manifesta a lui certi suoi atti relativi ai reali stessi,
che sono nell’affermazione divina»61, cioè rivela di contenere in sé, come possibili, quelle attuazioni, quelle realtà in atto, che l’uomo incontra nella sua esperienza sensibile, attraverso le modificazioni del proprio sentimento. L’affermazione divina, l’atto creante nella sua pienezza e nel suo principio (l’Essere stesso
sussistente) resta al di là dello sguardo umano, a cui pure è dato di coglierne
le innumerevoli tracce, perché di quell’atto gli enti, tutti e ciascuno, portano
il segno nella loro costituzione ontologica, nella forza d’esistere (forza entica)
e, per quelli a cui è donata, nella capacità di intendere e pensare. Per questo,
la riflessione rosminiana sulla creazione, quando sembra potersi concludere,
riprende ad approfondirsi. Non ne va solo, o, forse, non ne va tanto, della conoscenza teologica dell’Assoluto, quanto della conoscenza metafisica del finito,
che da Lui viene. L’interrogazione, finanche indiscreta, dell’opera di creazione
divina è fondamentale, per Rosmini, al fine di comprendere la costituzione ontologica degli enti, il loro ordine, i loro fini; non si tratta di un esercizio di fede
o di teologia positiva, ma di ragione filosofica, illuminata come dall’esperienza
e dalle scienze, cosí, certo, anche dalla Rivelazione cristiana.
L’entificazione relativa, operata dalle intelligenze finite, non fa che imitare
l’ultimo momento dell’atto creativo divino, in quanto essa aggiunge al reale finito il solo essere, «e non punto la determinazione e la forma propria del reale;
poiché il reale, che è il suo sentimento, o l’azione sentita nel suo sentimento, gli
è dato [all’uomo] già in natura pienamente determinato e formato»62. Cosí, con
un procedere abituale in queste pagine e significativo, Rosmini illumina un altro aspetto dell’opera creativa divina e, al contempo, mostra nella similitudine
umana quei limiti, che non lasciano mai colmare la distanza ontologica. La creazione completiva umana, uno dei momenti apicali della somiglianza dell’uomo con Dio, che gli comunica «una similitudine della sua potenza entifica»63,
60
In polemica soprattutto con Gioberti e la sua dottrina dell’intuizione immediata dell’Ente creatore, quindi dell’Assoluto e del suo atto di creazione, Rosmini scrive: «Noi vediamo
l’atto creativo nel suo termine, ma non nel suo principio» (A. Rosmini, Teosofia, II, n. 309). Per
la polemica tra i due, cfr. V. Gioberti, Degli errori filosofici di Antonio Rosmini, 3 voll., a cura di
U. Redanò, F.lli Bocca, Milano 1939; A. Rosmini, Vincenzo Gioberti e il panteismo, cit.
61
A. Rosmini, Teosofia, II, n. 366.
62
Ivi, n. 367.
63
Ibidem.
42
Giulio Nocerino
non è che «la similitudine dell’ultimo atto, che è quello che rende enti i reali già
determinati, ma non la similitudine di quell’atto divino che produce i reali finiti
né in quanto alla materia, né in quanto alla forma»64.
5. Libertà divina e creazione
La fondamentale necessità di opporre al panteismo, secondo Rosmini risorgente nelle filosofie tedesche contemporanee, in particolare nell’hegelismo, un
ripensamento della dottrina classica della creatio ex nihilo, risponde all’idea rosminiana che si debba combattere l’errore, elevando la verità al livello formale
da questo raggiunto. L’elevazione formale, vale a dire il continuo approfondimento speculativo dei concetti, sotto l’impulso dell’errore, cioè delle dottrine
filosofiche, che, deformando ed eludendo l’interezza della verità, ne sviluppano
un aspetto, secondo logiche riduttive e riduzionistiche, è uno dei caratteri fondamentali di quella concezione dinamica del pensiero filosofico, che il Roveretano intendeva proporre e promuovere con l’espressione sistema della verità.
«Si perpetua nell’uman genere – scrive Rosmini, nell’Introduzione alla filosofia
– la tradizione dell’errore a fianco di quella della verità. Ma né l’una né l’altra è
una semplice tradizione, sí un progresso; non un progresso di sostanza, ma di
forma, e propriamente di forma dialettica»65; al fine di comprendere cosa Rosmini intenda per progresso formale dell’errore, si pensi alla differenza di approfondimento dialettico che separa il soggettivismo trascendentale da quello
scettico moderno o dal protagorismo, oppure, per fare ancora un esempio, alla
maturazione filosofica e speculativa che segna il Soggetto unico del pensiero
classico tedesco, ma anche del neoidealismo italiano, rispetto all’unità (unicità)
dell’intelletto agente averroista. Compito del sistema della verità è, per Rosmini, costituire la verità a sistema, non solo ponendola a fondamento dell’ordine
delle scienze, e, con esse, dell’ordine della società, ma anche facendone il luogo
di verificazione, nel senso filosofico dell’elevazione a verità, delle istanze ed esigenze manifestate, magari in forme inadeguate, perché parziali e parzializzanti, dalle diverse filosofie.
Il creazionismo, nella prima metà dell’Ottocento, non ha di fronte l’emanatismo neoplatonico, ma le differenti forme d’immanentismo, rampollate dall’interpretazione soggettivistica del pensiero cartesiano e radicalizzate lungo la li Ibidem.
A. Rosmini, Degli studi dell’Autore, in Id., Introduzione alla filosofia, a cura di P. P. Ottonello, ENC 2, Città Nuova, Roma 1979, p. 16.
64
65
La creazione tra ontologia e teologia in Antonio Rosmini
43
nea di sviluppo egemonica della filosofia moderna, quella da Cartesio a Hegel,
che ha in Nietzsche il suo esito ultimo, sostanzialmente autodissolutorio. Ciò
esige un livello adeguato di penetrazione formale e dialettica dei concetti classici, assunti alla luce delle conquiste speculative della modernità e non ribaditi
secondo modalità ripetitive, e, perciò stesso, necessariamente sterili e subordinate. Non a caso, presentando i dodici corollari, che discendono dalle dottrine
dell’essere come atto di tutti gli enti, come essere attuante, come possibilità
suprema dei reali finiti e come principio dialettico, distinto dal principio metafisico e, al contempo, da esso originato, prima di esporre, nel settimo corollario,
la Descrizione della creazione, Rosmini afferma, brevemente e perentoriamente, il carattere erroneo di emanatismo e panteismo. Dinanzi alla confusione di
Assoluto e contingente, che «fa uscire il contingente dalla sostanza dell’Essere
assoluto»66 (emanatismo), o li «confonde in una sola natura»67 (panteismo),
non basta ripetere, come preventivamente Rosmini fa, che solo Dio crea e che
crea liberamente, ma occorre articolare, a partire dalla mediazione costituita
dall’essere intuito dalla mente umana, l’originarsi del finito in Dio, senza né
eradere il momento indeducibile del libero atto della volontà divina, interpretando nei termini di una deduzione necessaria la posizione dei finiti ad opera
dell’Infinito, né obliterare il rimando all’assolutezza metafisica, fermandosi alla
mediazione dialettica costituita dall’essere nella sua indeterminatezza e immediatezza, come nella hegeliana Scienza della Logica.
«Avendo noi detto – scrive Rosmini – che gli enti finiti che compongono
l’Universo constano di due elementi cioè l’essere iniziale proprio di ciascuno, e
il reale, dedurremo dall’esposta dottrina i corollari che intendono far conoscere
la natura del primo elemento, e poi quelli che intendono far conoscere la natura
del secondo elemento: e poi quelli che riguardano la loro unione»68; conoscere
la natura di questi elementi significa, per Rosmini, conoscere l’atto creativo da
cui hanno origine, esporre le divine operazioni, da cui essi sono posti, «come
fossero distinte e successive», pur nella consapevolezza che, in Dio, «tutto e
sempre è fatto nell’istante»69. «La prima operazione della suprema Intelligenza per riguardo all’essere finito, fu quella che chiamerò l’astrazione divina»70; è
questo l’atto con cui Dio, l’Essere assoluto, astrae, «dall’Assoluto suo oggetto»71,
l’essere iniziale, cioè separa l’inizio dell’essere dal suo termine, dalla sua pienez A. Rosmini, Teosofia, II, n. 456.
Ivi, n. 457.
68
Ivi, n. 458.
69
Ivi, n. 460.
70
Ivi, n. 461.
71
Ibidem.
66
67
44
Giulio Nocerino
za di Essere infinito. In seguito a quest’astrazione, che la Mente divina opera sul
suo oggetto, l’Essere infinito, per trarne l’essere predicabile di tutti i finiti e di
tutte le loro essenze, essa non ha piú come suo unico oggetto l’Essere assoluto
stesso (Oggetto assoluto sussistente), ma l’essere in una sua forma “impoverita”, per quanto necessaria a che possa esistere, oltre l’Infinito, anche il finito.
L’astrazione, che, nell’intelligenza umana, è spesso un’imperfezione utile alla
conoscenza, «in Dio non è altro, che, quasi direi, un soprappiú di perfezione»72,
in quanto gli consente di vedere in sé, nell’essere iniziale, sua appartenenza,
«l’essere finito tutto virtualmente in esso compreso»73. Quest’astrazione, che
Rosmini definisce anche una «visione dell’essere finito nell’infinito»74, è un momento dell’atto necessario, con cui Dio conosce l’essere finito possibile; non è
ancora un atto libero, benché Rosmini parli dell’atto d’astrazione anche come
di un atto libero75, evidentemente oscillando tra la necessità di evitare possibili
scivolamenti in un concetto di creazione necessaria, che contraddirebbe il senso stesso dell’atto creativo, e l’idea che la possibilità dell’essere finito insieda
necessariamente in Dio, perché l’Assoluto, che è Intelligenza di tutto l’essere,
non può non conoscere, e amare, anche l’essere nella sua possibile finitezza. Per
Rosmini, la finitezza, come esistenza indipendente e relativa a sé, esige il salto
fuori dall’Infinito, ma è anche e da sempre, ab aeterno, una possibilità inscritta
nella natura stessa dell’Assoluto.
L’essere iniziale, appartenenza di Dio, è, quindi, un nuovo oggetto, che la
Mente divina dà a se stessa, diverso dall’Oggetto primo e assoluto, ed è già il
frutto di una limitazione del suo sguardo, tanto da portare il segno di questa
limitazione: mentre l’Oggetto assoluto, il Verbo divino, esiste in sé, l’essere iniziale, separato dal suo termine proprio, può esistere solo per e nella mente che
lo pensa, perché «è solo l’inizio d’un ente privo del suo termine, che fa conoscere l’ente finito possibile»76. Certo, l’Oggetto assoluto resta il fondamento di
quest’operazione astrattiva, in quanto è guardando ad esso che Dio crea l’oggetto indeterminato, ma il risultato di questa astrazione divina è diverso dal suo
fondamento. «La proposizione dunque: “l’essere iniziale è contenuto nell’Essere assoluto obiettivo e in esso veduto”, non vuol dire che l’essere iniziale sia
qualche cosa in sé contenuto nell’Essere assoluto in sé, ma vuol dire solamente
che l’essere iniziale, che è nulla in sé, ma è qualche cosa alla mente, è nato
Ibidem.
Ibidem.
74
Ibidem.
75
«Mediante questa operazione l’Intelligenza dell’Essere assoluto liberamente astrasse
dall’Assoluto suo oggetto, l’essere iniziale» (A. Rosmini, Teosofia, II, n. 461).
76
A. Rosmini, Teosofia, II, n. 461.
72
73
La creazione tra ontologia e teologia in Antonio Rosmini
45
da uno sguardo della mente nell’Essere assoluto mediante la limitazione dello
sguardo stesso, sicché questa limitazione non passò nell’Essere assoluto, ma
rimase nello sguardo»77; la limitazione, che nasce dalla separazione dell’inizio
dal termine, dell’essere dalla sua pienezza, appartiene soltanto all’essere indeterminato, all’astratto, non tocca l’Essere assolutamente determinato, l’Infinito,
pur essendo opera della sua Intelligenza. Al centro della costruzione del finito,
cosí, si rivela, in coerenza con il fondamentale idealismo rosminiano, il movimento dell’Intelligenza divina, della Mente infinita, la sua capacità di produrre
l’altro da sé, prima solo ideale, nel caso dell’essere indeterminato, poi anche
reale-esistente, nel caso degli enti finiti. Alla base della possibilità del finito c’è
la dignità, che Rosmini attribuisce all’esistenza mentale (dianoetica), all’essere
per la mente (qui, per la Mente divina), senza di cui sarebbe inintelligibile l’esistenza in sé (anoetica), l’esistenza intesa come sussistenza reale e soggettiva.
L’Oggetto assoluto in Dio, il Verbo, infatti, non ha solo un’esistenza in sé, inalterabile e immodificabile, ma anche un’esistenza «relativa alla mente e ‹ come
› tale prodotta dalla Mente»78. L’Oggetto, Dio stesso da sé inteso, ha, quindi,
una doppia esistenza. «L’Essere assoluto – scrive Rosmini – dovendo essere ente
completo anche nella forma obbiettiva, è uopo che anche in questa forma esista
in sé, cioè subiettivamente, e sia per ciò un subietto, per sua essenza obietto»79.
Per il sintesismo ontologico, però, quest’oggetto non può esistere senza la Mente, come quest’ultima senza l’Oggetto, il suo oggetto essenziale. Cosí si spiega la
duplice esistenza dell’oggetto: esso esiste in sé, ma esiste anche relativamente
alla Mente, che lo pensa. Questa conosce l’Oggetto come è in sé, ma può anche,
con un’attività propria, considerarlo solo nel suo inizio, «e cosí dà a quest’essere
iniziale l’esistenza relativa ad essa, senza che quest’essere iniziale oggetto dello
sguardo libero abbia l’esistenza in sé, sia un subietto»80. Quest’essere, che esiste
solo in relazione ad una mente, che ha solo un’esistenza oggettiva (ideale) e
che della Mente divina è il primo prodotto, è lo stesso essere che viene comunicato alle intelligenze finite, dando loro il proprio incipit ontologico. Rosmini
lo definisce la prima creatura e lo considera il primo momento della creazione; qui, però, torna la difficoltà, che abbiamo evidenziato sopra, in quanto il
Roveretano definisce l’essere iniziale, anche, un’appartenenza di Dio, un lume
increato, coerentemente con l’idea che, come abbiamo visto, la possibilità del
finito sia ab aeterno in Dio, che essa appartenga, in quanto possibilità dell’es Ibidem.
Ibidem.
79
Ibidem.
80
Ibidem.
77
78
46
Giulio Nocerino
sere in tutti i suoi modi, anche il finito, alla natura stessa dell’Assoluto. L’essere
iniziale, spiega Rosmini, chiarendo quella che può sembrare un’oscillazione del
suo pensiero, è qualche cosa dell’Essere assoluto obiettivo, «ma questo qualche
cosa tostoché dallo sguardo della mente si considera a parte, si considera come
un qualche cosa, non è piú lui [Dio stesso, in quanto Essere assoluto obiettivo],
non potendosegli applicare la stessa definizione»81, cioè non potendosi piú considerare l’Essere assoluto stesso, ma solo una sua partecipazione, comunicata
ad altro da lui. Conclude Rosmini: «Tale è la semplicità e l’assolutità dell’Oggetto assoluto, che diminuito di checchessia perde la sua identità, è un altro. Questo appunto è ciò che dà luogo alla creazione, cioè a fare che dalla non esistenza
vengano all’esistenza altri enti, l’ente finito»82.
Il secondo momento dell’atto creativo è segnato dall’intervento dell’immaginazione divina; è il momento della realtà, della posizione, da parte di Dio, della
forma soggettiva (realità) dell’essere finito. Non a caso, il discorso rosminiano
diventa piú difficile, e, se vogliamo, meno convincente, come sempre accade
quando entra in gioco la fondazione della sussistenza, il momento dell’esistenza non solo ideale, ma reale degli enti. Spinto e guidato dall’amabilità dell’essere, anche finito, e dall’amore, l’Essere assoluto immagina e, immaginando,
limita e crea il termine reale dell’essere, in precedenza astratto dall’Oggetto infinito, cioè la realità dell’universo. Separato, nell’astrazione divina, l’essere come
inizio dal suo termine proprio, la pienezza dell’Assoluto nelle sue tre forme, la
Mente divina, operando con quella che, per analogia con l’esperienza umana, il
Roveretano definisce l’immaginazione divina, «col potere libero si porta in tutte
quelle limitazioni dell’Essere assoluto ch’ella vuol creare guidata dall’amabilità
dell’essere limitato»83. «L’istinto dell’Amore – scrive Rosmini – nel mare luminoso dell’Essere assoluto trova tutto ciò che è amabile anche limitato, e a questo si
limita lo sguardo della Mente operante libera»84; con quest’operazione, la Mente divina non solo contempla (immagina) il termine reale limitato, ma lo crea
anche necessariamente, «facendolo esistere non solo relativamente a sé [come
l’essere iniziale astratto], ma ancora in se stesso»85. La Mente divina, infatti,
non potrebbe immaginare il reale finito, senza crearlo; in tal caso, essa s’ingannerebbe, pensando, come reale, ciò che reale non è: «la ragione di ciò si è, che
il termine reale è la forma subiettiva dell’essere, e la forma subiettiva è quella
Ibidem.
Ibidem.
83
Ivi, n. 462.
84
Ibidem.
85
Ibidem.
81
82
La creazione tra ontologia e teologia in Antonio Rosmini
47
per la quale l’ente esiste in sé, non solo relativamente a una mente. Se dunque
il termine reale limitato fosse veduto dalla Mente, e non sussistesse in sé, ella
vedrebbe il falso, prenderebbe un’illusione»86. Essendo questa conclusione impossibile, ne consegue che «la Mente divina operante può far sussistere in sé col
suo sguardo libero il reale ch’essa immagina limitato»87; è questo il mistero della
creazione, che la mente umana non può intendere fino in fondo, ma non può respingere, perché il suo contrario (panteismo, emanatismo) «involge assurdo»88.
La teoria della creazione è misteriosa e inesplicabile, non, però, indimostrabile
e falsa: «non pretendiamo – scrive Rosmini – dunque d’alzare il velo misterioso
che copre l’atto creativo, ma solo descriverlo fin dove è concepibile all’uomo, e
cosí concepito dimostrare, che non involge in se stesso contraddizione, e che in
qualunque altro modo se ne pensi la contraddizione è inevitabile, il che è una
dimostrazione della sua verità»89. Si tratta di un argomento che ripete la sua
persuasività dalla reductio ad absurdum del suo contrario, e complessivamente
di ogni possibile teoria alternativa; come tale, e Rosmini ne sembra consapevole, non ha, e non pretende del resto, la forza delle prove dirette.
Di fronte al mistero della creazione, il Roveretano ricorre, come nel caso
dell’astrazione anche in quello dell’immaginazione divina, all’analogia con le
facoltà dell’intelligenza umana. «Niun’altra facoltà dell’uomo ha piú d’analogia coll’azione creatrice del reale che quella dell’immaginazione intellettiva»90;
quest’ultima, come l’immaginazione divina, riguarda l’esistenza reale degli enti,
ha il suo verbo, scrive Rosmini, riferendosi alla sua dottrina del verbo della mente91, «e in qualche modo crea»92. Tanto l’immaginazione umana quanto quella
divina sono mosse e guidate «da un istinto di amoroso diletto», e danno l’esistenza «ad un oggetto voluto dall’istinto motore»93. La prima, però, è una facoltà
conseguente alla percezione e da essa dipendente; quindi, essa succede al senso
e all’intelletto, che nella percezione si uniscono. L’immaginazione umana dipende dalle percezioni degli enti sensibili, perché compone, in modo molteplice, le
Ibidem.
Ibidem.
88
Ibidem.
89
Ibidem.
90
Ivi, n. 462. Nel libro VI della Teosofia, Il reale, Rosmini dedica il lungo capitolo XXIII alla
trattazione «Dell’immaginazione intellettiva», nn. 2084-2112.
91
Cfr. A. Rosmini, Nuovo Saggio sull’Origine delle Idee, 3 voll., a cura di G. Messina, ENC
3-5, Città Nuova, Roma 2003-2005, t. II, nn. 531-533, pp. 110-112; Id., L’Introduzione del Vangelo secondo Giovanni commentata, a cura di A. Capuzzi, Città Nuova, Roma 2002, pp. 72-76
(si tratta della Lezione XVII, interamente dedicata alle differenze, Rosmini ne elenca nove, tra
il verbo umano e il Verbo divino).
92
A. Rosmini, Teosofia, II, n. 462.
93
Ibidem.
86
87
48
Giulio Nocerino
immagini e le vestigia ricevute da quelle, «e cosí fa esistere novi oggetti, quali
vuole ed ama alla sua contemplazione»94; di conseguenza, essa porta con sé i
limiti della nostra facoltà percettiva, la quale non fa conoscere all’uomo che
gli effetti, che gli enti producono sui suoi sensi, i loro segni, sebbene visti nella
luce universalizzante dell’essere ideale95. «Essendo dunque cosí limitato l’oggetto della percezione – scrive il Roveretano –, e l’immaginazione umana prendendo gli elementi di ciò che produce da questa, questi oggetti creati dall’immaginazione umana non possono esser enti, ma unicamente sensibili segni di enti
da essa variamente richiamati e in novo modo composti»96. L’immaginazione
divina, al contrario, non è una facoltà e tanto meno una facoltà dipendente da
altre potenze antecedenti; in Dio, l’immaginazione è la sua stessa essenza, cioè
«l’Essere e non altro che l’Essere»97. Essa è l’Essere nella sua forma soggettiva
e realissima; quindi, se questo Essere immagina un ente finito, necessariamente
esso dev’essere un vero ente in sé, cioè avere un’esistenza subiettiva e reale, e non
può essere né un accidente, né una modificazione o una passione in Dio, perché
nell’Assoluto non vi sono accidenti, modificazioni o passioni, ma solo essere:
«ciò che dunque immagina non può essere che essere nel suo termine reale»98.
Per quanto in natura non vi sia nulla di simile ad un ente che, immaginando
reale qualcosa, ne ponga l’esistenza, di Dio non si può predicare altra forma di
pensiero e conoscenza del finito, che non sia l’immaginazione creatrice. L’immaginazione divina è, potremmo dire con linguaggio non rosminiano, immaginazione produttiva, laddove quella umana è solo riproduttiva.
Il terzo momento dell’atto di creazione, ancora in analogia con la percezione
intellettiva umana, è la sintesi divina, «cioè l’unione de’ due elementi l’essere iniziale inizio comune di tutti gli enti finiti, il reale finito, o per dir meglio i diversi
reali finiti, termini diversi dello stesso essere iniziale»99. Con questa unione
sono creati i reali finiti, come, con la sintesi di essere intuito e di reale sentito,
essi sono percepiti dalla mente umana. In effetti, il momento della sintesi è già
contenuto nei primi due, astrazione e immaginazione divine; si tratta di un
solo atto, il cui risultato è, però, triplice e perciò analizzabile: essere iniziale,
reali finiti, enti finiti (sintesi di essere e realità). Dall’unione dell’essere iniziale
con il reale emergono sia le essenze o idee sia gli enti finiti, realmente esistenti.
Ibidem.
Cfr. A. Rosmini, Il rinnovamento della filosofia in Italia, 2 voll., a cura di G. Messina, ENC
6-7, Città Nuova, Roma 2007-2008, t. II, nn. 545-574.
96
A. Rosmini, Teosofia, II, n. 462.
97
Ibidem.
98
Ibidem.
99
Ivi, n. 463.
94
95
La creazione tra ontologia e teologia in Antonio Rosmini
49
Infatti, l’essere iniziale è sia essenza dell’essere, essenza attuante (actus essendi), come abbiamo visto, sia intelligibilità, forma oggettiva: «se dunque l’essere
iniziale si considera presente ad ogni reale, in ogni parte del medesimo egli
produce l’ente finito nella forma subiettiva. Ma se l’essere iniziale si considera
nella sua forma obiettiva in quant’è intelligibile, egli estendendosi a tutto intero
il reale, nelle sue minime parti lo rende intelligibile tutto, e questa intelligibilità
de’ reali finiti sono le loro essenze che in quanto si contemplano dalla mente si
dicono idee»100.
Ibidem.
100
Edmund Husserl e la Grande Guerra
51
Edmund Husserl e la Grande Guerra
Memoria di Piero Marino
presentata dal socio naz. ord. res. Giuseppe Cantillo
(seduta del 29 novembre 2007)
Abstract. When the First World War broke out, the philosopher Husserl, who was from
Moravia, thought this war could be the right chance for the German culture to be renewed.
This seems to be confirmed by his lectures on Fichte’s Ideal of Humanity, held at the University of Freiburg in 1917 before military students who were at that time on leave.
First of all, this paper shows how, after the German defeat, Husserl got the idea that
the First World War was the real cause of both the cultural disaster and the barbarization
of Europe. Secondly, it points out that Husserl’s further speculations, after he changed
his mind about the outcomes of the war, were constantly connected to a comprehensive
concept of culture, which should lead to a humanity renewed by means of a philosophical
knowledge based on universally shared principles.
A Maria
La mia patria è un’idea, non è più la geografia!
Nel 1917 Edmund Husserl tenne all’Università di Friburgo tre lezioni per un
pubblico di soldati tedeschi in licenza dal fronte della I guerra mondiale. Tali
lezioni rappresentano con ogni probabilità il documento storico dal quale maggiormente è possibile evincere il legame emotivo e razionale del filosofo moravo
con la cultura tedesca e con la stessa nazione germanica. Le lezioni, che sarebbero state ripetute l’anno seguente presso la stessa Università, portano il titolo
di Fichtes Menschheitsideal1 e rappresentano al tempo stesso il documento più
1
E. Husserl, Fichtes Menschheitsideal. <Drei Vorlesungen>, in Id., Aufsätze und Vorträge
(1911-1921) (Husserliana XXV), a cura di T. Nenon e H. R. Sepp, Dordrecht\Boston\London,
1986, pp. 267-293. La traduzione italiana (che non sarà utilizzata per le citazioni) è E. Husserl,
Fichte e l’ideale di umanità. Tre lezioni, a cura di F. Rocci, Pisa, 2005. E importante segnalare
che, grazie a queste lezioni, il filosofo tedesco ottenne dal Reich il riconoscimento della Croce
di ferro, riconoscimento che solitamente veniva concesso per meriti acquisiti in guerra (cfr. E.
Husserl, Aufsätze und Vorträge (1911-1921), cit., p. XXVIII). Sembra peraltro che Husserl stesso fosse profondamente dispiaciuto per non aver avuto la possibilità di difendere il suo paese
52
Piero Marino
interessante del rapporto tra il pensiero husserliano e quello del padre dell’idealismo2.
Le lezioni si aprono con l’esaltazione delle massime espressioni della spiritualità tedesca dalla Riforma luterana alla Goethe Zeit: «La vita spirituale tedesca dalla Riforma fino all’incirca alla morte di Goethe ci offre un quadro particolare. Da steppe desolate con insignificanti rilievi si sollevano isolati ammassi
montuosi, grandi spiriti solitari: Copernico, Keplero e, dopo una lunga pausa,
Leibniz. Quindi tutto in una volta si erge un’intera catena montuosa di grandi
spiriti, Lessing, Herder, Winckelmann, Wilhelm von Humboldt; nella poesia le
sublimi vette di Goethe e Schiller, nella filosofia il Genio di Kant e della filosofia
da questi suscitata dell’idealismo tedesco, di per sé un possente ammasso montuoso con numerose vette quasi inaccessibili: Fichte, Schelling, Hegel, Schleiermacher, Schopenauer, solo per citare i più noti»3.
Il tema è sin da principio quello della produzione culturale della storia tedesca. Ma, a questo inizio carico di orgoglio per la propria tradizione – che
non è semplicemente la tradizione filosofica, ma abbraccia piuttosto l’intero
ambito della vita spirituale che assurge al suo massimo rigoglio nei decenni a
cavaliere tra sette e ottocento – segue l’interrogativo preoccupato sullo stato
attuale del mondo culturale tedesco. Husserl infatti si chiede se si sia già esaurita «la ricchezza dei valori culturali che irradiano da questi grandi», se si sia
«già concluso in noi l’effetto di quello spirito»4. E la risposta che segue sembra
positiva, giacché si afferma che dalla metà del secolo diciannovesimo gli sforzi
al fronte. Scrive infatti in una lettera a Dietrich Mahnke degli anni della guerra: «Vi avremmo
preso parte, se avessimo potuto!» (E. Husserl, Briefwechsel. Bd. III: Die Göttinger Schule (Husserliana-Dokumente III), a cura di K. Schuhmann, Dordrecht\Boston\London, 1994, p. 403).
2
Tali lezioni non sono le prime tenute da Husserl su Fichte: già nel 1903 e nel 1915, quando era ancora a Göttingen, aveva tenuto dei seminari – poi ripetuti nel corso del 1918 – su La
destinazione dell’uomo (cfr. K. Schumann, Husserl-Chronik. Denk und Lebensweg E. Husserls,
Den Haag, 1977, pp. 75, 194 e 225). Tuttavia la scelta di dare delle lezioni sul pensiero fichtiano
durante il corso della I guerra mondiale rappresenta, da parte del filosofo moravo, una scelta
precisa. Negli anni della guerra, infatti, i riferimenti all’autore dei Discorsi alla nazione tedesca
erano una caratteristica costante delle riflessioni degli intellettuali tedeschi. Si veda a tal proposito l’introduzione di F. Rocci alla già citata versione italiana (pp. 21-31). In queste pagine
la studiosa si occupa anche di mettere in luce le due tendenze storiografiche che, in seno alla
cultura tedesca, tendevano in quegli anni a leggere il pensiero politico di Fichte rispettivamente in senso nazionalistico-conservatore ed in senso progressista. Le opere fichtiane alle quali
Husserl fa riferimento nel corso delle lezioni del ‘17, oltre ai già citati Discorsi alla nazione
tedesca, sono: La destinazione dell’uomo (1800), I tratti fondamentali del tempo presente (1806),
L’iniziazione alla vita beata (1806), le lezioni di Erlagen Sull’essenza del dotto (1805) e le cinque
lezioni berlinesi Sulla destinazione del dotto (1811) (cfr. E. Husserl, Fichtes Menschheitsideal…,
cit., p. 271).
3
E. Husserl, Fichtes Menschheitsideal…, cit., p. 267.
4
Ibid.
Edmund Husserl e la Grande Guerra
53
culturali e la spinta propulsiva dell’idealismo – il quale viene ad identificarsi
implicitamente con il punto più alto della cultura tedesca – arretrano di fronte
al crescente dominio delle scienze esatte e della tecnica5.
La speranza di una nuova stagione culturale e filosofica – non esente anche
da implicazioni di ordine politico – risiede proprio nella nascita di un nuovo
idealismo: «Già dall’inizio del nostro secolo é evidente la disarmonia degli interessi spirituali del presente ed è in questo contesto che, in ambiti più ristretti,
si va diffondendo una nuova posizione verso l’idealismo tedesco, una nuova
comprensione dei suoi sforzi, dei suoi problemi e del suo modo di pensare»6.
In questo contesto il termine idealismo sta ad indicare una forma culturale
nettamente contrapposta ad un atteggiamento di tipo oggettivistico e naturalistico. Idealismo significa propriamente una prospettiva filosofica che metta al
centro dell’analisi il fondamento spirituale del soggetto umano ed il suo agire
essenzialmente storico ed etico. Sicché è abbastanza chiaro come i riferimenti
di Husserl all’idealismo non siano qui da intendersi nel senso specificamente teoretico. Piuttosto «l’idealismo in questo caso è da intendersi come supremazia
del momento spirituale – ideale di contro ad una visione angustamente riduttiva della natura umana»7.
In ogni caso appare chiaro che la riflessione husserliana sulla situazione della Germania della fine degli anni ’10 si configura come segue: il filosofo moravo
si sente intimamente partecipe della cultura tedesca, ne lamenta una crisi eticofilosofica e ne propone un’autentica rinascita. L’occasione di questa rinascita
sta di fronte ad ogni tedesco: è la Grande Guerra. La guerra, che nelle riflessioni
del filosofo moravo sembra determinare la nascita di una nuova era, viene definita come il «grande e grave destino della nostra nazione tedesca. Quale fenomeno! Esso avvolge quasi l’intera organizzazione internazionale, ma a quale
scopo? A nessun altro che annientare la forza della Germania per poi portare al
popolo tedesco vita, opere e azioni più fruttuose […]. Tuttavia una tale epoca è,
e non potrebbe essere altrimenti, per tutti coloro che sono forti e ben disposti,
un’epoca di riflessione interiore e riforma. È un’epoca di intero rinnovamento
delle ideali fonti di energia che una volta sono state dischiuse nel proprio popolo dalle sue più profonde motivazioni spirituali»8.
Cfr. ibid., pp. 267-268.
Ibid., p. 268. Il corsivo é mio.
7
A. A. Bello, L’etica nelle analisi fenomenologiche di Edmund Husserl, in «Fenomenologia
e società», (1991), 14, p. 23.
8
E. Husserl, Fichtes Menschheitsideal…, cit., p. 268. Husserl sembra condividere la posizione nazionalista secondo cui la prima guerra mondiale rappresentava per la nazione tedesca
una scelta di tipo difensivo. Si vedano a tal proposito, oltre alla succitata introduzione di F.
5
6
54
Piero Marino
Qui la guerra, lungi dal rappresentare solo un evento tragico, per Husserl
rappresenta anche la via d’uscita dalla decadenza culturale e morale della cultura tedesca ed il punto di partenza per un nuovo idealismo che propugni valori ed idee in una lotta che è lotta per l’esistenza stessa del popolo e della sua
Kultur. «Idee ed ideali sono di nuovo in marcia, trovano di nuovo cuori disposti.
L’unilaterale modo naturalistico di sentire e pensare perde la sua forza. Morte
e necessità sono oggi educatori»9. Anche la morte cessa di essere un semplice
evento naturale, ma ritorna in tutta la sua tragica sacralità10.
Il popolo tedesco deve puntare a una rinascita della propria cultura culminata nell’idealismo, le cui autentiche caratteristiche Husserl intende mostrare
nel corso delle lezioni. E perché rinasca un nuovo idealismo, l’essenziale è che
le Idee e gli Ideali non siano naturalisticamente fermi, ma, piuttosto, si mettano
in marcia. Marcia che, appunto, è una marcia militare. In questo senso specifico il richiamo all’idealismo è un richiamo di tipo etico-morale11. Solamente
una visione idealistica del mondo, secondo Husserl, permette di allontanare lo
spettro del pensiero naturalistico e meramente tecnico la cui egemonia si lamentava all’inizio della lezione. Non era del resto un caso che il pensiero scientifico di tipo empiristico e genericamente naturalistico – almeno nell’accezione
husserliana del termine – fosse tendenzialmente di origine anglosassone, né
che la cultura positivistica avesse visto la propria fioritura nel mondo culturale
Rocci (alle pp. 9-31), D. Losurdo, La comunità, la morte, l’Occidente, Torino, 1991 e il più recente S. Bruendel, Volksgemeinschaft oder Volksstat, Berlin, 2003.
9
Ibid., p. 269. Il corsivo è mio.
10
Cfr. ibid.
11
L’avvicinamento di Husserl al pensiero di Fichte è stato principalmente motivato da interessi di tipo etico-morale e questo non ha comportato una sua utilizzazione a meri scopi propagandistici, quanto piuttosto la sottolineatura dell’essenzialità del momento etico all’interno
di una filosofia così teoreticamente caratterizzata come la fenomenologia. Per una riflessione
completa sulla rilevanza del momento morale all’interno della fenomenologia husserliana,
che tenga presente anche l’influenza del pensiero idealista, si può far riferimento ai seguenti
lavori: A. Roth, Edmund Husserls ethische Untersuchungen, Den Haag, 1960; R. Donnici, L’idea
di etica scientifica nel primo Husserl, in «Annali della facoltà di Filosofia dell’università di Siena» (1987), 30, pp. 129-165; C. Spahn, Der Etische Impuls der Husserlschen Phänomenologie, in
«Analecta Husserliana», (1988), 55, pp. 25-81; U. Melle, The Development of Husserl’s Ethics, in
«Études Phènomènologiques», (1991), 13\14, pp. 115-136; A. A. Bello, L’Etica nelle analisi fenomenologiche di E. Husserl, cit.; C. Spahn, Phänomenologische Handlungs Theorie. E. Husserls
Untersuchung zur Ethik, Würzburg, 1996; R. Donnici, Intenzioni d’amore di scienza e d’anarchia, Napoli, 1996; U. Melle, Ethik in Husserl, in «Encyclopedia of Phenomenology»(1997), pp.
180-85; I. A. Bianchi, Etica husserliana, Milano, 1999; U. Melle, Edmund Husserl: From Reason
to Love, in J. J. Drummond; L. Embree (a cura di), Phenomenological Approaches to Moral
Philosophy, Dordrecht\Boston\London, 2002, pp. 229-248; U. Melle, Husserls personalistische
Ethik, in B. Centi; G. Gigliotti (a cura di), Fenomenologia della ragion pratica, Napoli, 2004, pp.
327-356; H. Goto, Der Begriff der Person in der Phänomenologie Edmund Husserls, Würzburg,
2004. Sul rapporto specifico tra Husserl ed il pensiero di Fichte diremo in seguito.
Edmund Husserl e la Grande Guerra
55
francese. Come meravigliarsi, dunque, che il conflitto vedesse contrapposti gli
Anglo-Francesi – poi assistiti dall’appoggio degli americani, cosa che Husserl
non manca di lamentare in una lettera ad Hugo Müstenberg12 – agli imperi centrali di Austria e Prussia?
Il vivido sentimento patriottico del filosofo impregna anche alcune lettere
della sua corrispondenza personale e scientifica.
Si pensi, ad esempio, ad una lettera del 1914 a Dietrich Mahnke, in cui Husserl definisce giusta la partecipazione della Germania alla Grande Guerra e si
compiace della scelta dei due figli di arruolarsi volontari e della figlia di prestare servizio come infermiera13. O ancora ad una lettera dello stesso anno a Heinrich Husserl in cui esalta l’importanza dello spirito di sacrificio e dell’amor di
patria14. Per Husserl, nell’agosto del 1914, vale a dire all’inizio delle operazioni
belliche, la vittoria è una certezza: «Questa Germania è invincibile»15. Allo stesso modo, in una lettera del giugno 1915 a Flora Darkow, Husserl scrive che, grazie alla certezza della vittoria finale, i sacrifici vengono sopportati gioiosamente
e che la mobilitazione generale sortisce l’effetto di abolire l’egoismo di classe
perché per suo tramite tutti i ceti sociali si sentono parte integrante del Reich16.
E ancora, in una lettera di questi stessi anni che è il caso di citare nel suo punto
centrale, egli dice: «Il sentimento che la morte di ognuno significa un sacrificio
volontariamente offerto conferisce una dignità sublime e innalza la sofferenza
individuale a una sfera che è al di sopra di ogni individualità. Non possiamo
più continuare a vivere come persone private. L’esperienza di ciascuno concentra in se stessa la vita dell’intera nazione e ciò conferisce ad ogni esperienza il
suo momento tremendo. Tutte le tensioni, le appassionate aspirazioni, tutti gli
sforzi, tutte le afflizioni, tutte le conquiste e tutte le morti dei soldati sul campo
di battaglia – tutto ciò entra collettivamente nei sentimenti e nelle sofferenze di
ognuno di noi»17.
Questo insieme di riferimenti mostra come Husserl fosse pienamente schierato al fianco del suo paese nella guerra condotta contro gli Anglo-Francesi.
Ma, come già accennato, Husserl non è stato per nulla l’unico pensatore e
uomo di cultura tedesco a considerare la Grande Guerra come un’occasione
di riscatto per il proprio popolo. Al contrario quegli anni sono assolutamente
12
E. Husserl, Beilage IX: Aus einen Brief Husserls an Hugo Müstenberg, in Id., Aufsätze und
Vorträge (1911–1921), cit., pp. 293-294.
13
Cfr. Id., Briefwechsel. Bd. III…, cit., p. 402.
14
Cfr. Id., Briefwechsel. Bd. IX: Familienbriefe, cit., pp. 288-289.
15
Ibid., p. 289.
16
Cfr. ibid., pp. 157-159.
17
Ibid., p. 61.
56
Piero Marino
carichi di istanze nazionalistiche e patriottiche da parte dei principali rappresentanti del mondo filosofico e culturale. Nel panorama fenomenologico, ad
esempio, val la pena di far riferimento a Max Scheler – che molto ha scritto sulla guerra e sulle occasioni di rinascita che offriva alla nazione tedesca e all’Europa tutta18 – ma anche ad altri allievi di Husserl, come Adolf Reinach, morto
proprio nel 1917 in guerra e del quale abbiamo la corrispondenza che dal fronte intratteneva col maestro19, o Martin Heidegger. Inoltre, seppure nell’estrema diversità delle posizioni, appaiono tra i sostenitori dello sforzo bellico del
Reich autori di grande rilevanza culturale come Thomas Mann20, Max Weber,
Ernst Jünger, accanto ad insospettabili filosofi come Wittgenstein (che poi ebbe
a cambiare idea nel corso del conflitto). Sulla stessa linea si mosse il filosofo
tedesco Georg Simmel21.
Per ognuno degli autori succitati, e ci si è limitati a fare riferimento ad alcuni
per dare l’idea del contesto in cui si sviluppa la riflessione husserliana sulla guerra,
si davano naturalmente motivazioni di tipo differente. È infatti noto che la concezione che Max Scheler andò a maturare sulla guerra fosse influenzata dalla sua
visione filosofico-religiosa vicina a un certo tipo di cristianesimo di segno marcatamente anti-capitalistico ed anti-liberale, che Max Weber vedesse nella guerra la
lotta della Kultur tedesca contro il predominio del mondo anglosassone da un lato
e di quello slavo dall’altro, e che altri, tra cui Martin Heidegger, Jünger o Simmel si
rifacessero – pur con forti distinzioni che non è il caso di analizzare ora – ad una
certa forma irrazionalistico–esistenziale del pensiero della vita22.
18
Per l’analisi del rapporto tra il pensiero di Max Scheler e la Grande Guerra si è fatto
riferimento a M. Scheler, Der Genius der Krieges und der deutsche Krieg, Leipzig, 1915 e a Id.,
Poltisch-pädagogische Schriften, Bern-München, 1982, pp. 7-250. Si vedano, a proposito della
concezione di M. Scheler, anche K. H. Lembeck, L’Europa e la guerra. Il loro rapporto nella
filosofia di Max Scheler e W. Henckmann, Max Scheler e l’idea di Europa nell’epoca del livellamento, in R. Cristin; M. Ruggenini (a cura di), La fenomenologia e l’Europa. Atti del convegno
Internazionale di Trieste 1995, Napoli, 1999, pp. 345-365 e pp. 305-329.
19
E. Husserl, Briefwechsel. Bd. II: Die Münchener Phänomenologen, cit., pp. 194-204. La corrispondenza è di grande rilevanza in merito all’acceso patriottismo professato da Reinach.
20
Scriveva T. Mann a proposito del rapporto con la cultura francese: «Come se Lutero
e Kant non controbilanciassero almeno la rivoluzione francese. Come se l’emancipazione
dell’individuo dinanzi a Dio e la critica della ragion pura non fossero state un rivolgimento ben
più radicale della proclamazione dei diritti dell’uomo» (T. Mann, Pensieri di guerra, in Scritti
storici e politici, Milano, 1957, p. 45). Sempre nella stessa opera Mann scriveva che Francia
e Inghilterra sono le potenze che «lottano per difendere la causa della democrazia contro la
prepotenza e il militarismo», che combattono per una «Germania democratizzata» e che «ci
vogliono privare del nostro militarismo donandoci in cambio la democratizzazione; e poiché
ci opponiamo, ci vogliono umanizzare con la forza» (ibid., p. 49).
21
Per l’analisi delle posizioni bellicistiche dei succitati pensatori, compreso Heidegger, si è
fatto riferimento al già citato D. Losurdo, La comunità, la morte, l’Occidente.
22
Vedi note 18 e 21. Non mancano neanche gli intellettuali che, impegnati a rispondere all’accusa nemica di militarismo e dispotismo, si richiamano alla libertà tedesca come
Edmund Husserl e la Grande Guerra
57
Ma l’atteggiamento husserliano nei confronti della guerra e dell’appartenenza alla nazione tedesca muta, dopo la fine del conflitto, in un modo che
è opportuno mettere in evidenza. A tal fine facciamo ancora riferimento al
carteggio del filosofo e, segnatamente, allo scambio epistolare con il filosofo
canadese Winthorp Pickard Bell che, oltre ad essere personalmente amico di
Husserl, per il fatto di essere di nazionalità canadese era stato internato nel
campo di concentramento di Ruhleben, nei pressi di Berlino, durante il corso
della Grande Guerra. Tutte le lettere qui di seguito citate mostrano infatti, in
modo evidente, un rilevante mutamento di rotta del filosofo dopo la fine del
conflitto mondiale.
È già significativo che, in una lettera del 1918, Husserl si dichiari contento
dell’inizio della pace perché in essa si dischiude la possibilità della costruzione
di un nuovo mondo spirituale23.
In una lettera del 1919, Husserl deplora poi l’odio che si è venuto a creare
tra le nazioni, odio che, prima della guerra, a suo avviso, non esisteva assolutamente. La notazione è inserita nel contesto di una riflessione sulla crisi e sulla
malattia spirituale del popolo tedesco24. L’odio nazionalistico sarebbe, secondo
Husserl, un veleno diffusosi nel popolo tedesco – e anche nel resto del mondo
europeo – negli anni della guerra e, ancora di più, dopo la sua fine. Qui si parla
della stessa crisi etica, morale e spirituale cui Husserl accennava all’inizio delle
lezioni su Fichte, la quale però, lungi dal trovare risposta nella guerra, si è per
suo tramite addirittura aggravata.
Ancora in questo senso va una lettera del 1921, nella quale si fa riferimento
non solamente allo sviluppo di un nuovo e radicale odio verso i francesi, ma
anche alla pericolosa diffusione dell’antisemitismo25. Il tema dell’antisemitismo
sembra tuttavia colpire Husserl non più delle altre discriminazioni nazionali,
centro pulsante della concezione prussiana dello stato, riallacciandosi così alla tradizione kantiana ed idealista. Si vedano a tal proposito: F. Meinecke, Die deutsche Freiheit in
Preußen und Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, München, 1918 (in seguito in F.
Meinecke, Werke. Brandeburg, Preußen, Deutschland. Kleine Schriften zur Geschichte und
Politik, a cura di E. Kessel, Stuttgart, 1979, pp. 586-602); E. Troeltsch, Die deutsche Idee
vor Freiheit, in Id., Deutscher Geist und West Europa. Gesammelte kulturphilosophische
Aufsätze und Rede, Tübingen, 1925, ristampa anastatica 1966 e M. Wundt, Die Nationen
und ihre Philosophie, Leipzig, 1915.
23
Cfr. E. Husserl, Briefwechsel. Bd. III…, cit., p. 3.
24
Ibid., p. 6: «Chi salva l’autentico essere del popolo tedesco, il suo Eros spirituale, chi
la continuità del suo sviluppo spirituale? Come giganteschi serpenti velenosi si estendono le
forze di un odio, ora freddo, ora incandescente, di quest’odio che in guerra […] non era mai
esistito e che è cresciuto ora, in questi ultimi mesi della rivelazione del senso della “riconciliazione internazionale”, e in maniera inquietante si estende come un fuoco distruttore. Francia
– come viene pronunciata diversamente oggi questa parola!».
25
Cfr. ibid., pp. 22-23.
58
Piero Marino
giacché – essendosi anche convertito al protestantesimo da giovane – egli si era
sempre sentito più tedesco che ebreo26.
In una lettera del ’20, appare la prima radicale critica all’esperienza della
Grande Guerra da parte di Husserl: «Questa guerra, la più universale e profonda colpa dell’umanità in tutta la storia, ha mostrato tutte le idee valide
nella loro oscurità e inautenticità […]. Così l’idea della ”guerra giusta“. La
guerra del presente, divenuta guerra di popolo nel senso più letterale e terribile, ha perso il suo senso etico. Il problema della guerra in relazione al
problema della nazione (la pura idea della nazione in rapporto all’idea della
pura umanità [Menschentum]) deve essere nuovamente analizzato, chiarito
e risolto a partire dalle sue radici»27. La guerra ha perduto dunque il suo
significato etico. Ed è evidente che lo ha perduto per chi – come Husserl –
aveva sperato che da essa sarebbe potuta derivare una rinascita culturale e
spirituale dell’intero popolo tedesco.
Molto nota è anche la lettera scritta a William Ernest Hocking nel 1920, nella quale il filosofo definisce orribile la guerra ma ancora più orribile, soprattutto per la Germania sconfitta, la pace che ne è derivata28. In questa lettera Husserl scrive anche che durante la Grande Guerra la propaganda bellica lo aveva
come paralizzato, e che per questo egli si era rifugiato nella ricerca filosofica,
concentrando i propri sforzi intellettuali verso la costruzione della sua teoria
fenomenologica. Qui si vede come le lezioni su Fichte abbiano di fatto rappresentato una eccezione nella storia personale di Husserl per ciò che concerne
il diretto impegno in vicissitudini di carattere strettamente storico-politico. Si
vede anche come il patriottismo del filosofo, pur avendo risentito delle condizioni del tempo, non fosse mai stato né cieco, né assoluto. Tuttavia, per Husserl, anche la pace, la pace della repubblica di Weimar, è una pace fittizia, che
ha dimenticato e soppiantato ogni ideale.
È inoltre importante notare come, in questa lettera, Husserl sottoscriva a
pieno l’opinione di Bell secondo il quale era ormai diventato assolutamente necessario pensare da cittadini del mondo29.
Tra gli scambi epistolari con gli allievi di Friburgo spicca, invece, una lettera ad Arnold Metzger del 1919 nella quale Husserl analizza esplicitamente, per
26
Da nessuna delle lettere di Husserl risulta che egli si considerasse parte del popolo
ebraico e della sua cultura allo stesso modo nel quale si riteneva tedesco ed europeo. Del resto
Husserl era stato educato in una famiglia ebrea fortemente laicizzata e assimilata (Cfr. K.
Schumann, Husserl-Chronik…, cit.).
27
E. Husserl, Briefwechsel. Bd. III…, cit., p. 12.
28
Cfr. ibid., pp. 162-165.
29
Cfr. ibid., p. 161.
Edmund Husserl e la Grande Guerra
59
la prima e ultima volta, il suo rapporto di pensatore con la guerra: «Io non ho
prodotto alcuno scritto bellico, lo avrei considerato una pretenziosa smanceria
filosofica»30. Ciò mostra come le lezioni del 1917, oltre a rappresentare un’eccezione nel panorama dell’attività husserliana, non siano state affatto percepite
da Husserl come scritti bellici.
Accanto alle lettere è però doveroso segnalare anche lo scritto in cui la condanna husserliana della Grande Guerra appare più esplicita. Nel primo dei cinque saggi sul Rinnovamento, apparso nella rivista giapponese «Kaizo», Husserl
sottolinea infatti quanto segue: «Rinnovamento è l’appello generale nel nostro
tormentato presente, e nell’intero ambito della cultura europea. La guerra, che
dal 1914 l’ha devastata e che dal 1918 non ha fatto che sostituire i mezzi della
coercizione militare con quelli più “raffinati”della tortura psicologica e della
indigenza economica, non meno depravanti dal punto di vista morale, ha rivelato l’intima verità ed insensatezza di tale cultura»31. Qui prenderà avvio la riflessione husserliana circa il possibile rinnovamento e la rinascita della cultura
europea che, nel corso degli anni successivi, assumerà sempre più sembianze
schiettamente filosofiche. Ma il fatto essenziale è che la Grande Guerra, da occasione di rinascita, è diventata, nel giro di tre anni, la causa di una degenerazione culturale che continua ancora nella pace e che appunto necessita di un
autentico movimento di rinascita. Nello stesso testo, un po’ più avanti, Husserl
parla di «scopi egoistici di un nazionalismo totalmente degenerato»32, ed è difficile sostenere che non si riferisca anche alle conseguenze indotte dalla conflagrazione mondiale.
Su questo sfondo non stupisce di ritrovare in una lettera a Fritz Kaufmann
del 1915 – quando la guerra era cominciata da un anno – un chiaro auspicio di
pace. La guerra – dice Husserl – lo ha distrutto psicologicamente e moralmente.
Inoltre il filosofo lamenta di aver già perso in essa molti amici 33. Qui la morte
non è per nulla educatrice, ma piuttosto colei che si porta via gli amici e che
riduce le persone ad un livello di grande prostrazione, morale e fisica. Ed è difficile pensare ad una rinascita conciliabile con una forte prostrazione morale
e psichica.
Ancora in una lettera a Mahnke del 1916 Husserl mostra segni di irritazione e sconforto nei confronti del protrarsi degli scontri bellici34. Del resto, pro-
Id., Briefwechsel. Bd. IV: Die Freiburger Schüler, cit., p. 409.
Id., Rinnovamento. Problema e metodo, in Id., L’Idea di Europa, cit., p. 3.
32
Ibid., p. 6.
33
Cfr. Id., Briefwechsel. Bd. III…, cit., pp. 339-341.
34
Cfr. ibid., pp. 404-407.
30
31
60
Piero Marino
prio nel corso di quell’anno, il figlio minore Wolfgang era caduto in battaglia.
Insomma, dopo i primi due anni di guerra, in Husserl tendono a prevalere il
pessimismo e l’angoscia. La cosa è esplicitamente dimostrata da una lettera di
Husserl del 1921 a Flora Darkow, in cui egli scrive che proprio da quel tempo si
era cominciato a vivere in modo diverso35.
Sempre a Kaufmann, in una lettera del 1920, che appare in perfetta continuità con le lettere precedenti, Husserl scrive che, una volta finita la guerra, si
sente il bisogno ed il dovere di costruire un nuovo mondo36.
In questo senso vanno anche lette le riflessioni husserliane sulla fine del
Reich che appaiono in una lettera del 1918 a Roman Ingarden: «Sono fermamente convinto che il crollo militare della Germania e la rivoluzione non saranno che una fase di passaggio ad una nuova e più bella epoca della storia tedesca.
Che il vecchio regime, in tutti i sensi fallito, sia caduto, è una di quelle necessità
storiche che portano in sé la loro saggezza. Non credo che possa risorgere mai
più. Ciò che si annuncia è davvero una nuova Germania e, in essa, uno spirito
nuovo. Credo nell’avvento di quel puro idealismo di cui ha sete la gioventù e
spero che esso introdurrà la ragione negli affari politici interni ed internazionali. Non si può uscire dalla miseria di questi tempi, se non sullo slancio delle idee,
e questo per la verità lo sentono tutti, tutto il popolo»37. Qui è interessante notare come l’abbandono di ogni speranza di rinascita dell’impero guglielmino non
comporti affatto l’abbandono della speranza di rinascita di quell’idealismo che
nel 1917 serviva a giustificare la partecipazione della Germania alla guerra.
Certo, neanche i passi che mostrano la lontananza di Husserl dalle forme
più radicali della Kriegsideologie mettono in questione il suo forte senso di appartenenza alla cultura e alla nazione tedesca. Questo attaccamento rimarrà
intatto nel tempo, nel corso di tutta la vita del filosofo, anche nei momenti più
bui della storia tedesca38.
Cfr. Id., Briefwechsel. Bd. IX…, cit., pp. 162-164.
Cfr. ibid., p. 344.
37
Id., Briefwechsel. Bd. III…, cit., p. 201. Il corsivo é mio.
38
Ancora nel 1937, vale a dire un anno prima di morire e dopo l’allontanamento dall’Università subito da lui e da suo figlio in quanto non appartenenti alla razza ariana, Husserl, in
una lettera ad Adolf Grimme (ex ministro della Repubblica di Weimar), non solamente lamenta le ingiustizie subite, ma appare seriamente preoccupato per il popolo tedesco, caduto nel
baratro del nazionalsocialismo (cfr. ibid., pp. 106-108). Del resto in altre lettere del 1933 e del
1934 allo stesso Grimme Husserl spiega che, mentre il figlio era partito per Los Angeles su invito di una Università americana, egli si era rifiutato di lasciare quella che riteneva la sua patria
(cfr. ibid., pp. 103 -105) e, in una lettera del 1934 a Friedrich Mittelsten Schedi, si lamenta del
fatto che abbiano osato licenziare suo figlio in quanto non ariano, incuranti della circostanza
che egli fosse un eroe della Grande Guerra (cfr. Id., Briefwechsel. Bd. VII, Wissenschafltlerkorrespondenz, cit., p. 189).
35
36
Edmund Husserl e la Grande Guerra
61
Da quanto si è finora detto, appare senza dubbio chiaro che Husserl ha cambiato in modo radicale il suo giudizio sulla guerra – e soprattutto sulla necessità
di combatterla – proprio alla fine degli scontri, ma che, come del resto buona
parte dell’opinione pubblica tedesca, ha incominciato a manifestare segni di
cedimento e insofferenza già a partire dalla fine del secondo anno di guerra.
A tale mutamento del modo di sentire non furono punto indifferenti gli eventi
tragici che coinvolsero direttamente il filosofo nei suoi affetti familiari ed accademici39.
Tuttavia è particolarmente importante notare come alcuni dei temi portanti
dei discorsi atti a giustificare la partecipazione alla guerra – quali la necessità
di una rinascita, di un rinnovamento autentico di tipo essenzialmente etico o di
un nuovo idealismo – restino invariati anche al termine delle ostilità e nei passi
in cui Husserl critica esplicitamente l’esperienza storica della Grande Guerra.
Segno, questo, di come sia necessario fare un passo indietro, per mettere in evidenza quel sostrato di analisi prettamente filosofiche che ha paradossalmente
guidato sia le riflessioni husserliane in favore della guerra, sia le sue aspre critiche all’esperienza bellica.
La questione, a parer mio, sta tutta nello stabilire cosa intenda Husserl
quando, nella succitata lettera del 1920 indirizzata al canadese Bell, parla di
«significato etico» della guerra, che la «guerra del presente» avrebbe del tutto
perduto. In questa stessa lettera, infatti, Husserl fa riferimento al problema del
rapporto tra l’idea di nazione e l’idea di pura umanità. Qui appare chiaro come
il pensiero husserliano, dopo la fine delle ostilità, si rivolga verso l’idea di una
umanità che non si riduca semplicemente all’appartenenza ad una nazionalità
o ad una cultura, ma che, intesa al singolare, risulti dalla necessaria correlazione delle differenti forme culturali e nazionali. Del resto riferimenti espliciti
alla ricostruzione di un nuovo mondo dopo la fine del conflitto sono presenti in
quasi tutte le lettere precedentemente citate.
Su questo sfondo, acquista rilevanza una lettera ad Adolf Grimme del 1917
che contiene un commento di Husserl allo scritto di quest’ultimo, dal titolo
Gedanken vom Beruf des Deutschen in der Welt und vom Sinn des Krieges. Ein
Fichte-Vortrag zu Gunsten der Kriegswohlfahrtspflege. Il curatore della corrispondenza di Husserl riporta in nota parte dello scritto di Grimme che recita: «La filosofia tedesca legata al nome di Edmund Husserl redime l’umanità
39
Alcuni allievi e colleghi di Husserl persero la vita nella Grande Guerra. Della morte del
figlio, oltre alla naturale tragicità dell’evento, Husserl lamenta il fatto che sia stato seppellito
in quella che, dopo la guerra, era diventata terra francese (cfr. Id., Briefwechsel. Bd. III…, cit.,
p. 406).
62
Piero Marino
dal peso del dubbio su Dio e sul Bene, del dubbio se sia effettivamente meglio
fare il bene piuttosto che preoccuparsi per il proprio benessere; questa filosofia
veramente concreta e quindi scientifica, questa filosofia d’essenza, questa filosofia propriamente tedesca e al tempo stesso schiettamente ellenica ma anche
sinceramente cristiana, della quale Fichte ha profeticamente detto: “Lo spirito
tedesco scaverà nuove profondità e porterà luce e giorno in quegli abissi ricavandone macigni di pensiero dai quali le età future costruiranno case“»40. È
significativo che, nella riflessione di Grimme sul compito della nazione tedesca
nel corso della Grande Guerra, la fenomenologia husserliana non venga semplicemente ricollegata allo spirito tedesco, ma anche a quello ellenico e cristiano,
nonché al compito proprio dello spirito tedesco di dar vita ad una nuova umanità declinata al singolare. Ritorna dunque anche qui, e da parte dell’autore di
uno scritto patriottico diffuso ai tempi della Grande Guerra, il riferimento ad
un’umanità non racchiusa nei confini del popolo e della cultura tedesca.
È anche interessante a questo proposito una lettera scritta nel 1935 da
Husserl all’allora Presidente della Repubblica Cecoslovacca Thomáš Garrigue
Masaryk: «Possa il Suo antico ideale di un’esistenza etica nazionale compiersi
nello Stato al cui vertice l’ha posta la Provvidenza […]: un unico stato nazionale tenuto insieme dall’amore per la patria comune e dall’unità della storia
patria – Uno stato nazionale non separato dalle diverse lingue, ma che si eleva
e si arricchisce attraverso la reciproca partecipazione alle opere della cultura
che si esprimono linguisticamente. A questo ideale mi ha educato già a Lipsia! Possa la Repubblica da siffatte considerazioni etico-politiche diventare
il fondamento etico per il rinnovamento della cultura europea gravemente
danneggiata dalla degenerazione nazionalistica»41. Tralasciando i punti che
concernono l’evoluzione della riflessione husserliana sulla comunità e sullo
stato nel corso degli anni ’20 del secolo, è qui importante notare come, nel
1935, il filosofo faccia riferimento al periodo in cui – ancora studente a Lipsia
– aveva avuto modo di diventare amico di Masaryk. L’augurio che Husserl indirizza alla giovane Repubblica Cecoslovacca (e che non avrebbe avuto modo
di realizzarsi) è quello di poter dare vita ad uno stato in cui diverse culture e
differenti lingue potessero convivere arricchendosi a vicenda ed arricchendo
così la stessa società europea42. È noto come la concezione politica di Masaryk
Ibid., p. 79. Il corsivo è mio.
E. Husserl, Briefwechsel. Bd. I: Die Brentano Schule, cit., p. 120. Il corsivo è mio.
42
Detto per inciso, la lettera è la stessa in cui Husserl raccomanda al Presidente della
Repubblica Cecoslovacca un giovane ed allora sconosciuto filosofo di nome Jan Patocka, che
era stato ospite a casa sua.
40
41
Edmund Husserl e la Grande Guerra
63
fosse di segno marcatamente antinazionalistico, come del resto testimonia la
sua netta opposizione alla I Guerra Mondiale43. Quello che però è essenziale
sottolineare è che Edmund Husserl, ormai vecchio e certamente profondamente deluso ed amareggiato dalla svolta politica del suo paese, in questa
lettera rimarchi come, sin dalla giovinezza, egli sia stato educato alla luce di
ideali opposti a quelli del nazionalismo e piuttosto tendenti ad una concezione
pluriculturale, plurilinguistica e multirazziale dello stato, fondata in ultima
istanza su di una concezione universalistica dell’umanità. Certo non si può
non notare che si tratta della stessa persona che nelle lezioni del 1917 parlava
delle valenze etiche ed educative della guerra. In ogni caso, sono senz’altro
interessanti un altro paio di riferimenti.
In una lettera del 1925 alla Deutsche Akademie, Husserl affronta il tema della missione della cultura tedesca nel mondo. Dopo aver denigrato le attuali forme di nazionalismo, che partono da posizione false ed inautentiche, egli scrive:
«La nazione tedesca, come ogni nazione propriamente detta, ha una missione
divina, non per se stessa, ma in stretta relazione alle altre nazioni. Ciò che di
più puro e di più elevato ha la nazione tedesca, come ogni nazione, assume al
43
Masaryk, che era figlio di un cocchiere slovacco e di una tedesca morava, prima e durante la Grande Guerra aveva guardato con orrore alle posizioni pangermaniche di molti dei
suoi amici e colleghi tedeschi ed austriaci. Proprio allora egli iniziò a battersi con forza per
l’indipendenza di quella che sarebbe diventata la nazione cecoslovacca. Fu proprio lui che, al
termine della Guerra, riuscì a convincere il presidente americano Wilson a dar vita alle nazioni indipendenti dell’Europa centro-orientale. Già prima dello scoppio della Grande Guerra,
Masaryk si era caratterizzato per una posizione politica che può essere definita come “austro
slavismo”. Gli austro slavisti, infatti, si battevano per una sorta di autonomia dei popoli slavi
all’interno dell’impero austro-ungarico. Quando, alla fine della Guerra, fece ritorno a Praga,
fu considerato come un eroe nazionale. Infatti, durante gli anni della conflagrazione, oltre a
divenire professore di filosofia al King’s College di Londra, egli era stato il comandante della
libera armata ceca in Russia e si era a più riprese recato negli Stati Uniti e a Parigi, per esercitare pressioni a favore dell’indipendenza cecoslovacca. Divenuto presidente della neo-nata
Repubblica Cecoslovacca, Masaryk cercò – riuscendoci entro certi limiti – di ispirare il suo
governo a principi di tolleranza ed apertura verso il sapere scientifico e filosofico. La sua concezione politica si rifaceva, in un certo qual modo, al modello democratico americano, ma
coniugato con una valorizzazione dell’educazione e della formazione, il cui compito era quello
di rendere i cittadini della giovane repubblica maturi e responsabili. Masaryk considerava la
Cecoslovacchia come un bastione della filosofia e della cultura. Questa concezione di stampo
fortemente umanistico egli l’aveva derivata dall’influsso del pensiero di Brentano. Del resto,
bisogna tener conto, essa era molto diffusa nell’ambito culturale dell’impero austro-ungarico
– si pensi a Bolzano o Wittgenstein – il contesto filosofico del quale si caratterizzava per una
forte distanza dal pensiero idealista tedesco. Quest’ultimo, con le sue grandiose e metafische
costruzioni filosofiche risulta, infatti, molto diverso dal piano concreto, scettico ed antimetafisco della filosofia diffusa nel mondo austro-ungarico. È abbastanza interessante che proprio la
concezione etico-politica di Husserl si presenti come una sintesi culturale e filosofica tra questi
due mondi. Per questa analisi del pensiero e dell’agire politico di Masaryk si è fatto riferimento
a B. Smith, La verità trionfa: da T. G. Masaryk a Jan Patocka, in «Discipline filosofiche», (1991),
2, pp. 207-226.
64
Piero Marino
tempo stesso rilevanza sovranazionale ed è destinato ad esercitare effetti ideali
anche sulle altre nazioni, innalzandole spiritualmente a questi stessi valori»44.
E precedentemente, a proposito della attuale crisi della cultura tedesca, afferma: «Nel processo di esteriorizzazione [Veräusserlichung] nel quale è incappata
l’evoluzione spirituale europea alla fine del XIX secolo e in definitiva nel logoramento spirituale [seelich] della guerra, il nostro popolo ha lasciato cadere le
grandi forze della sua tradizione nazionale»45. Come si vede, l’analisi della crisi
della cultura tedesca é pressoché la stessa delle lezioni su Fichte, ma l’episodio
distruttivo della guerra è inserito come elemento che ha contribuito a determinarne la decadenza, piuttosto che impedirne la manifestazione. La situazione
di crisi non impedisce però in assoluto che il popolo e la cultura tedesca possano svolgere la loro missione politica e culturale nel mondo.
è importante sottolineare le affinità concettuali tra quanto abbiamo letto
nelle ultime riflessioni husserliane e la parte conclusiva della terza lezione su
Fichte del 1917. Dopo una lunga escursione prettamente filosofica, Husserl
conclude la lezione con un passo che vale la pena di citare per esteso: «Possiamo ora avviarci alla conclusione. Ciò che ancora segue, ed è sicuramente
di estremo interesse, concerne la formazione di particolari ideali di uomo alla
luce di precise idee. E dunque lo straordinario modo in cui Fichte cerca di portare a realizzazione pratica il suo ideale appena abbozzato negli scritti sociopedagogici. Si prendano qui in considerazione, accanto alle lezioni sulla Natura
o compito dei dotti, i Discorsi alla nazione tedesca. In niente la personalità di
Fichte appare più magnificamente, che nel modo in cui questi, negli anni della
più profonda umiliazione della Germania, mostra al popolo tedesco la sua sublime idea di nazione, nobilmente elaborata, fondendola al tempo stesso con
l’ideale di un popolo vero e schietto. E, da ultimo, nel modo in cui egli suscita
in questo popolo la fede che proprio dalla realizzazione del suo più alto destino
nella libertà dovrebbe derivare la salvezza per l’intera umanità. Il Fichte della
guerra di liberazione parla anche a noi. Infatti, nella miseria dei nostri tempi,
c’è solamente una cosa che possa mantenerci forti, invero invincibili, e santificare ogni dolore. È lo Spirito divino dell’Idea e la coscienza degli ideali puri alla
cui realizzazione noi siamo preposti, di quegli ideali che nel nostro popolo tedesco hanno trovato i più nobili e sublimi rappresentanti. Un popolo che ha creato tali spiriti e che, in essi e da essi guidato, ha aspirato così intensamente alla
purezza del cuore, così fervidamente ha cercato Dio e ha personificato gli ideali
44
45
E. Husserl, Briefwechsel. Bd.VIII, Istitutionelle Schreiben, cit., p. 15.
Ibid., p. 14.
Edmund Husserl e la Grande Guerra
65
intuiti in sì sublime forma, deve continuare ad essere la speranza dell’umanità.
Che però ciò avvenga nella viva verità, tale è il nostro infinito compito, di noi
tutti che vogliamo vincere in questa guerra per l’infinita rivelazione delle idee
divine nel nostro magnifico popolo tedesco, il quale, nella realizzazione di tale
compito, continui a crescere a vero splendore, innalzi se stesso e, attraverso sé,
l’intera umanità»46.
In questo passo conclusivo appare assolutamente chiaro come la guerra di
liberazione cui i tedeschi sono chiamati è di fatto una guerra che coinvolge il
concetto universale di umanità e che pertanto non è una guerra che riguarda
semplicemente un popolo o una cultura, ma piuttosto l’umanità intera, universalmente intesa. Da questo punto di vista, non vi è una radicale differenza dalle
posizioni espresse nella lettera alla Accademia tedesca. Infatti, come è stato
notato, «Husserl si ispira al grande idealista47 come al filosofo che, con spirito
universalistico, aveva rinnovato la vita sociale e spirituale di una Germania che
viveva un momento storico tra i più drammatici, sulla base di un pensiero filosofico solido e profondo»48.
Id., Fichtes Menschheitsideal…, cit., pp. 292-293.
Si riferisce naturalmente a Fichte.
48
R. Donnici, Intenzioni d’amore di scienza e d’anarchia, cit., p. 211. Il corsivo è mio. Nel
corso della sua riflessione, Husserl non si è mai confrontato in modo organico e propriamente
critico con il pensiero di Fichte al contrario di quanto ha fatto con il pensiero di Cartesio o di
Kant. Fatta eccezione per le tre lezioni del 1917 è possibile ritrovare, nell’estesissima produzione husserliana, solamente una serie di riferimenti sparsi al suo rapporto con il padre dell’idealismo tedesco. E ciò che principalmente se ne evince è una dichiarata ostilità di Husserl nei
confronti dell’aspetto prettamente teoretico del pensiero fichtiano. Nel 1903, in una lettera ad
Hocking, Husserl mette il suo corrispondente in guardia dalle oscurità concettuali del pensatore tedesco, sostenendo che «anche Fichte ha stravolto i problemi essenziali della critica della
conoscenza ed è caduto perciò in un specie di mitica ed in ultima analisi mistica metafisica
dell’io» (E. Husserl, Briefwechsel. Band III…, cit., p. 150). In un passo del 1924 di Erste Philosophie il riferimento esplicito a Fichte concerne la sua precipitosità teoretica ed il suo cadere in
costruzioni di tipo mitologico dalle quali difficilmente, sostiene Husserl, può risultare un contributo positivo per la filosofia (cfr. E. Husserl, Erste Philosophie (1923-24). Erster Teil: Kritische
Ideengeschichte (Husserliana VII) a cura di R. Boehm, Den Haag, p. 376). Persino nel Fichtes
Menschheitsideal, nel quale Husserl dichiara esplicitamente di riconoscersi nella concezione
fichtiana della soggettività e nella sua dottrina idealistica, considera il filosofo tedesco l’autore
di «costruzioni spesso arbitrarie e astruse» (Id., Fichtes Menschheits…, cit., p. 276).
Al contrario, sembra che Husserl abbia sempre avuto un grande interesse e una forte ammirazione per l’aspetto etico della filosofia di Fichte. Lo dimostrano le stesse lezioni del 1917
ed il fatto (già in precedenza sottolineato) che, ancora prima degli anni ’10 e nel corso di essi,
abbia tenuto dei corsi in merito ad aspetti etici della filosofia fichtiana. Interessante ed emblematica risulta essere, infine, una lettera scritta ad Ingarden nel 1933, nella quale Husserl dice
esplicitamente: «Fichte aveva ragione […], il filosofo o è una persona etica o non è nulla» (Id.,
Briefwechsel. Band III…, cit., p. 294). Tale affermazione suona come un ultimo tributo da parte
del vecchio filosofo moravo al grande pensatore idealista e conferma la lettura tutta in chiave
etico-morale del pensiero di quest’ultimo. Non é possibile, in questa sede, far riferimento alla
estesissima bibliografia che si occupa della relazione tra i due pensatori.
46
47
66
Piero Marino
Sicché, se nel corso degli anni muta certamente il giudizio specifico sulla
Grande Guerra (che da occasione di rinascita diventa uno dei fattori che hanno peggiorato la condizione complessiva della cultura e della nazione tedesca),
non vengono assolutamente smosse due posizioni di fondo. In primo luogo, per
Husserl, la nazione e la cultura tedesca sono parte di un mondo culturale più
ampio, riferimento, questo, che conserva tutta la sua rilevanza sia durante che
dopo la Grande Guerra. In secondo luogo, nel mutare delle valutazioni circa
il significato dell’evento bellico, rimane costante il riferimento ad un concetto
universale di umanità che allontana Husserl dalle posizioni radicalmente nazionalistiche e prettamente propagandistiche di molti dei suoi contemporanei49.
Appare quindi chiaro come tutta la riflessione husserliana sulla guerra (sia
essa favorevole al coinvolgimento bellico o critica dei tragici risultati di esso)
si muova al di fuori di ogni negazione della validità universale del concetto di
uomo e di umanità50. Come ha ben sottolineato Angela Ales Bello, «Husserl
riteneva che quella guerra avesse avuto un significato politico che trascendeva l’ambito di interessi di parte; per questo essa aveva suscitato la reazione
unanime della nazione tedesca»51. E ancora: «In tale prospettiva la guerra non
è da ricondursi ad un conflitto di interessi, secondo una gretta visione utilitaristica che la interpreti come un fatto economico, ma è esaminata alla luce di
un impulso verso il miglioramento e verso la libertà»52. Tale impulso verso il
miglioramento, stando allo stesso Husserl, non concerne un singolo popolo o
una cultura, ma è invece sempre dotato di un respiro più ampio e coinvolge in
modo pieno l’intera umanità.
49
Naturalmente è importante sottolineare che parlare di universalismo non significa in
alcun modo parlare né di internazionalismo, né di cosmopolitismo (per quanto, come già citato, lo stesso Husserl in una delle lettere della sua corrispondenza privata abbia parlato della
necessità «di pensare da cittadini del mondo»). La posizione husserliana, infatti, matura il suo
universalismo sul piano storico e culturale del mondo tedesco e del mondo europeo e, come
appare dalle lezioni che abbiamo tentato di commentare, si muove in tutti i sensi sul piano
della donazione di senso del reale vissuto storico di tale mondo culturale.
50
Cfr. a questo proposito D. Losurdo, La comunità…, cit. Per l’analisi della negazione del
concetto universale di uomo, cfr. pp. 53-71; per il riferimento esplicito alle posizioni husserliane, cfr. pp. 71-79.
51
A.A. Bello, L’Etica nelle analisi fenomenologiche di Edmund Husserl, cit., p. 22.
52
Ibid.
Dalla Daseinsanalyse alla psicosi determinista: Binswanger e Borges
67
Dalla Daseinsanalyse alla psicosi determinista:
Binswanger e Borges
Memoria di Livio Santoro
presentata dai soci corr. naz. Giuseppe Di Costanzo ed Antonello Giugliano
(seduta del 20 dicembre 2007)
Abstract. This essay presents, in the tradition of the psychiatric-phenomenological
current know as Daseinsanalyse, an analysis of Jorge Luis Borges work, in particular the
focus about some of his characters. The general lines of Ludwig Binswanger’s Daseinsanalyse are presented, on which background will be deepened the dynamics that from
one side belong to the gallery of the characters of the Argentinean poet. From the other
side belong to deterministic and organicistic tradition of geisteswissenschaftlich tradition. It will be elaborated, therefore, an interpretative pattern in which the methodological form of the anamnestic and diagnostic Binswanger’s pages is recovered in Borges
characters, in those that we propose to define as psychotic tendencies of several currents
of deterministic thinking. The essay is partitioned in three parts: in the first will be faced
the general questions of Binswanger’s Daseinsanalyse, thought the model at first hideggerian (in the analysis of schizophrenia and of several schizoid pathologies), afterwards
husserlian (in regard to, rather, the definition of melancholy and mania). A second part
of this essay is dedicated to the arrangement of Borges poetic to the formulations of the
Daseinsanalyse. It will be utilised the definitions of time, memory and language as they
appear in the pages of the Argentinean poet. In the last part the focus is on the specific
tracts of Borges characters. It will tried a definition of this characters as psychotic. In
this sense the several pathologies presented will be appear as much particular as specific
possibilities that the existence has to give to itself.
Questo lavoro intende utilizzare la Daseinsanalyse di Binswanger per un’interpretazione “unitaria” dell’opera di J. L. Borges. Il punto di partenza che unisce Borges e Binswanger (il “fondatore” della Daseinsanalyse) è l’affermazione
secondo la quale la realtà scientifica e quella individuale sono per certi versi la
medesima cosa, in un orizzonte che tende ad annullare qualsiasi prospettiva
determinista. In tale prospettiva si afferma la necessità di utilizzare da un lato
le categorie analitiche di una scienza individuale (essendo l’individuo l’oggetto
di studio) quale la psichiatria, e dall’altro le categorie generali della filosofia,
per comprendere da una parte la scienza, dall’altra l’individuo.
I contributi di Borges e Binswanger si propongono di abbattere tutti quegli
approcci programmatici teleologici, deterministi e finalistici che si sono svi-
68
Livio Santoro
luppati nel corso del tempo. La mancanza di fondamento assume infatti nuovi
caratteri che legittimano come risolutiva esclusivamente l’assenza stessa, dunque la possibilità di una molteplicità concettuale che abbia come unico fine
l’abbattimento progressivo di se stessa e la sua continua trasformazione. La
Daseinsanalyse di Binswanger, nascendo da presupposti esplicitamente fenomenologici, si presenta come «svincolata da pregiudiziali teoretiche dichiarandosi “teoreticamente a-teoretica”»1 e rivendica in questo modo il primato del
metodo fenomenologico. Nella Daseinsanalyse, infatti, si opera una ridefinizione della pratica medico-psichiatrica, nella misura in cui essa «si proclama
scienza, anche se non più naturalistica: la riduzione categoriale permette un
atteggiamento di fredda neutralità incompatibile con gli atteggiamenti patici
o analogici delle fenomenologie soggettive». Inoltre la stessa Daseinsanalyse si
propone «come metodo di esplorazione di tutte le manifestazioni del Dasein»2.
Binswanger sostiene che «non si deve dimenticare che lo psichiatra non vuol
solo essere un clinico diagnostico ma vuole anche immedesimarsi nei suoi pazienti e comprenderli»3. Nella Daseinsanalyse accanto alla dimensione clinica
affiora come foriero di significati l’esperire del malato, più che la lettura medica
dell’esperire stesso.
La schizofrenia
È proprio partendo dallo studio della schizofrenia che si possono definire
alcuni capisaldi della Daseinsanalyse. Binswanger cerca di scoprire «le manifestazioni specifiche della condizione d’essere degli schizofrenici»4. Ma, a differenza dell’approccio classico della psichiatria clinica, propone un’impostazione
teorica che si basi non più solo sulla definizione dei sintomi, in una prospettiva
riduzionistica, e sulla sistemazione della cura, bensì affermando una prospettiva che faccia della comprensione il suo principale impianto programmatico.
Una comprensione che rifondi dalla base il rapporto medico-paziente prendendo le distanze da qualsiasi approccio naturalistico.
Binswanger, infatti, utilizza come principi ispiratori basilari per la definizio-
S. Piro, Il linguaggio schizofrenico, Feltrinelli, Milano, 1971, p. 283.
Ibidem, p. 284.
3
L. Binswanger, Über Ideenflucht, 1933, trad. it. di C. Caiano Sulla fuga delle idee, Einaudi,
Torino, 2003, p. 37.
4
S. Piro, p. 284, op. cit.
1
2
Dalla Daseinsanalyse alla psicosi determinista: Binswanger e Borges
69
ne della propria teoria, tra gli altri, concetti quali l’Erlebnis5 e la «mancanza di
contatto vitale con la realtà»6.
Nel periodo in cui si sviluppano i modelli della Daseinsanalyse si assiste, per
così dire, alle esasperazioni manieristiche e all’esaltazione fissata (due patologie
schizoidi) del pensiero scientifico, al tentativo, cioè, di operare una complessa
ricostruzione di un impianto paradigmatico attraverso differenti determinismi.
(E questo parallelo patologizza, a parere di chi scrive, il paradigma scientifico).
In questo senso sarebbe possibile qui definire come determinismi tutte quelle
teorie che negano un reale scorrimento delle cose in maniera naturale (autentica) peccando nella temporalizzazione, sia per assolutizzazione della fase verticale, sia per scollamento del complesso mnème, àisthesis, fantasia7. Questa
prospettiva è riscontrabile anche nell’interpretazione tradizionale di Binswanger dello psicotico, dello schizofrenico e in misura minore delle personalità
schizoidi, con l’esaltazione fissata, il manierismo, la stramberia e la frattura
5
Cfr. W. Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften, 1883, trad. it. di G. A. De Toni
Introduzione alle scienze dello spirito, Bompiani, Milano, 2007.
6
E. Minkowski, La schizophrénie, 1953, trad. it. di G. Ferri Terzina La schizofrenia, Einaudi, Torino, 1998, p. 49. Il contatto vitale con la realtà teorizzato da Minkowsky riprende
Bergson, con l’intento di rivendicare una rifondazione della scienza psicologica e un allontanamento dalla teoria organicista di Bleuler. Si legga ad esempio questo passo: «Il contatto
vitale con la realtà sembra rapportarsi ai fattori irrazionali della vita. I concetti ordinari, elaborati dalla fisiologia e dalla psicologia, quali stimolo, sensazione, riflesso, atto motorio ecc.,
le passano accanto senza raggiungerla, senza nemmeno sfiorarla. […] Il contatto vitale con la
realtà riguarda molto di più il fondo stesso, l’essenza della personalità vivente nei suoi rapporti
con l’ambiente. E questo ambiente, ancora una volta, non è né un insieme di stimoli esterni, né
di atomi, né di forze o energie; è un’onda mobile che ci avvolge da ogni parte e che costituisce
il mezzo senza il quale non potremmo vivere» (ibidem).
7
A partire da Platone le tre fondamentali fonti della percezione pura, àisthesis, mnème e
fantasia, sono sussumibili sotto il nome di phàntasma. Questi tre momenti costitutivi regolano
il primo grado dell’esperienza generale, ossia la percezione immediata, quella che per usare
parole comuni si chiamerebbe percezione del presente. «Ciò che ci viene “immediatamente
dato” è soltanto un caos di “impressioni”. Ma questo caos passa subito al vaglio degli organi
di senso, ne viene filtrato fino a dar luogo a “configurazioni sensibili”» (L. Binswanger, Wahan,
1965, trad. it. di G. Giacometti Delirio, Marsilio, Venezia, 1990, p. 25). Ad esempio per Szilasi
fantasia non ha il significato comune, è bensì la facoltà sia di formare immagini, sia di prescriverle, ossia fantasia è la facoltà di relazionare, prescrivendolo, tutto ciò che non è più attuale.
Se la fantasia ha tali peculiarità di prescrizione e formazione delle immagini percepite, spetta
alla mnème il ruolo regolativo: «la mnème rappresenta il progetto, lo schema delle prescrizioni
dell’immaginazione» (ibidem, p. 27). La mnème è una «ritenzione collettiva in vista dell’identificazione» (W. Szilasi, Philosophie und Naturwissenschaft, Berna-Monaco, 1961, cit. in L.
Binswanger, 1965, p. 27, op. cit.). Àisthesis è conseguentemente il terzo momento della formazione cosciente delle immagini, la sintesi regolatrice delle impressioni sensibili. Nell’esperire
schizofrenico assistiamo al funzionamento distorto dei tre aspetti regolatori, essi non lavorano più in concerto bensì subiscono un vero e proprio scollamento. Precipuamente assistiamo,
nell’esperire delirante, alla disfunzione del momento mnemetico: nel delirio manca la consequenzialità della mnème, e quindi non sono le impressioni ad essere alla mercè dell’individuo,
ma è l’individuo stesso ad essere asservito alle impressioni (ibidem, pp. 24-30).
70
Livio Santoro
eidetica. Il parallelo che qui si vuole definire è tra genere e individuo, considerando come un approccio teorico possa sottostare alla stesse leggi che regolano
la formazione dell’individuo.
Si propone dunque un’interpretazione dei diversi determinismi che va al di
là della definizione tradizionale, basata sull’idea che tali approcci debbano riconoscere fatti e fenomeni, nel tentativo di determinare certe leggi universali di
spiegazione e previsione. In ogni determinismo si possono individuare, infatti,
delle caratteristiche che si avvicinano fortemente a quelle delle psicosi, come si
cercherà di dimostrare nelle pagine seguenti, si pensi ad esempio alla categoria
dell’inautenticità. Il Dasein autentico è infatti vissuto ed esperito lasciandosi
dominare dal mondo, nelle libertà di lasciar-essere-gli-enti e di lasciarsi-coinvolgere-dagli-enti8; il Dasein determinista, così come quello psicotico, invece, appare marcatamente inautentico, poiché sembra avere lo scopo di dominare da sé
gli enti, rovesciando il rapporto che esso intrattiene con gli oggetti.
L’inautenticità del Dasein, come tratto psicotico delle scienze deterministe,
va qui interpretata sullo sfondo della definizione di Binswanger della stramberia:
«La meta, il punto d’arrivo dello sviluppo temporale o dell’estasi nel senso dello
schema orizzontale della temporalizzazione non è il “per” del rimando come
tale, bensì il tempo “vuoto”, cioè né passato né presente né futuro, dell’astrazione o dell’assolutizzazione di un concetto, di un’idea di un principio»9.
Nella stramberia, secondo Binswanger, il Dasein dello psicotico subisce uno
strappo dalla pienezza della vita, tuttavia non vi domina ancora incontrastato il vuoto, il girare nel vuoto, come accade invece negli stadi avanzati della
schizofrenia; accade invece che la totalità dei rimandi del soggetto strambo si
trovi storta, negata all’intersoggettiva concezione di dritto. In questa patologia
i rimandi dell’attribuzione di senso sono dispiegati in maniera inautentica, in
quanto chi ne è affetto non si lascia coinvolgere da nulla, poiché qualsiasi situazione gli resta chiusa, segregata, sorda ai rimandi del mondo. Tutto ciò avviene
perché lo strambo è già in una situazione, nella quale è prigioniero, poiché assolutizza la sua esistenza. Tuttavia nei pazienti che soffrono di questa patologia
esiste ancora una certa consapevolezza dei fatti, che si dispiegano sempre come
storti, di traverso, inautentici. La sostanza della stramberia si estremizza dunque nell’esaltazione fissata, laddove è presente un più alto grado di solidificazio-
8
M. Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, 1943, trad. it. di F. Volpi Segnavia, Adelphi, Milano, 1987, pp. 143-147.
9
L. Binswanger, Drei Formen missglückten Daseins, 1956, trad. it. di E. Filippini Tre forme
di esistenza mancata, Bompiani, Milano, 2001, p. 97.
Dalla Daseinsanalyse alla psicosi determinista: Binswanger e Borges
71
ne dello scopo, in quanto tale caratteristica si somma ad un «preciso scompaginarsi del rapporto tra l’ascesa e il procedere dell’ampiezza»10.
La vita, per Binswanger, non procede infatti solo in senso orizzontale, bensì
contempla una dimensione di scorrimento verticale che considera gli afflati, le
passioni, le ideologie etc. Tale dimensione, vissuta come un esperire naturale,
non porta a momenti di stasi, come invece succede nell’esperire dello schizoide
fissato, che esalta fino a un punto irraggiungibile uno scopo, ovvero un’ideologia, una passione.
Nell’esaltazione fissata esiste uno scarto abnorme, una «sproporzione fra
l’ampiezza dell’esperienza e l’altezza della problematica», nonché un forte «turbamento del rapporto tra la capacità di costruire e la capacità di salire»11. Esaltare uno scopo a un livello sovraumano rende infatti impossibile raggiungere il
compimento stesso della propria esaltazione: per questo lo schizoide costruisce
davanti a sé un muro più alto dell’aspirazione stessa, con il chiaro risultato di
rendere l’ascesa impraticabile e di porvi un ostacolo invalicabile. L’esaltazione
è un sentimento ipertrofico, solidificato in un’immagine assoluta e stabilmente
inamovibile che si rigenera continuamente in modalità autopoietiche. La caratteristica “anormale” dell’esperire schizoide e schizofrenico consiste dunque
in un difetto nella temporalizzazione, nell’incapacità di trovarsi nel fedele dispiegarsi del tempo e dei suoi momenti, nella perfetta assolutizzazione di uno,
ed uno solo, di questi determinati momenti che, data la sua invalicabilità, si
trova ad essere il solo punto di riferimento nell’esperire psicotico; tutto è rapportato a questo momento, tutto esiste in sua funzione. Vige, nelle personalità
psicotiche, una tendenza alla cristallizzazione di un istante che, negando al
soggetto la possibilità di sostare e di muoversi nella legittimità del tempo intersoggettivo, gli impone uno scacco nel progetto del Dasein autentico. Su questo
punto è interessante un passo di Binswanger tratto da Il caso Lola Voss, in cui
l’analisi daseinsanalitica della stortura della presenza è affidata alla descrizione
dell’Improvviso come negazione della continuità12. Lola Voss è una schizofrenica
che ha paura dell’innovazione, del nuovo. Per questa paziente ogni elemento di
novità destrutturerebbe il già precario equilibrio del suo Progetto-di-mondo. Se
per necessità la Voss è costretta a una qualsiasi innovazione, tale innovazione
non deve contemplare nulla del passato, in quanto, nella sua patologica totalità
di rimandi, Lola potrebbe associare a un determinato oggetto nuovo, qualità
Ibidem, p. 17.
S. Piro, p. 285, op. cit.
12
L. Binswanger, Fall Lola Voss, 1949, trad. it. di G. Banti Il caso Lola Voss, in Being in the
world, 1963 trad. it. Essere nel mondo, Astrolabio, Roma, 1973, p. 306.
10
11
72
Livio Santoro
negative provenienti dal passato; Lola non indossa mai vestiti nuovi, e, quando
è costretta a farlo, questi non devono essere rossi, in quanto «il suo ultimo abito estivo lo era»13. La caratteristica della psicosi della Voss si configura come
una drastica stortura della dimensione temporale: la sua patologica totalità di
rimandi la riporta costantemente a un presente sempre attuale, puntiforme, di
per se stesso e nei rimandi che offre all’esperire, nell’inautentico rapporto che
intrattiene con gli altrettanto inautentici passato e futuro14.
La paziente vive un’angoscia esistenziale15 fortissima che si rigenera nella
dimensione della temporalizzazione inautentica, perché «se l’Improvviso è la
“negazione della continuità”, “la totale astrazione dalla continuità, da ciò che
precede e da ciò che segue”, […] questo rivela anche che Lola non “possiede”
né un autentico avvenire né un autentico passato, ma vive di istante in istante
(Jetztpunkt) in un mero e inautentico presente. […] Alla continuità esistenziale,
all’autentico divenire nel senso di un’autentica storicizzazione si sostituisce il
contingente salto sinistro-improvviso da un istante all’altro»16. Da ciò discende
una totale e probante mancanza di libertà17.
Ibidem.
Nella poesia L’altra tigre Borges ci parla di tre tigri: la prima è una tigre fatta di simboli,
la seconda è la tigre fisica che stermina mandrie di bufali, e la terza è la tigre del sogno, ritorno
alla tigre simbolica. Della prima, quindi di tutte, Borges ci dice: «En su mundo no hay nombres ni pasado/ ni provenir, sólo un istante cierto» (J. L. Borges, El Hacedor, 1960 (1) trad. it.
di F. Tentori Montalto, L’Artefice, Adelphi, Milano, 1999, p. 79). In questi versi appare chiaro
come la temporalizzazione della tigre ricalchi il tempo vuoto, cioè né passato né presente né
futuro, dell’astrazione o dell’assolutizzazione di un concetto, di un’idea, di un principio, di cui
parlava Binswanger nella descrizione della stramberia. Per ammissione dello stesso Borges
questa poesia dimostra che l’arte non ci permette di raggiungere le cose (gli enti) ed è dunque
altro rispetto alla scienza.
15
L. Binswanger, 1949, p. 291, op. cit.
16
Ibidem, p. 306. Riprendendo ancora le parole di Binswanger, si nota che il problema in
questione vive naturalmente anche nella pubblicità dell’essere «nella misura in cui la continuità è sinonimo di libertà, di esistenza, di autentico essere-Sé (Selbstigung), e insieme di comunicazione (senza la quale è impossibile un’autentica esistenza), la negazione della continuità
significa la non libertà, l’essere afferrati dallo strapotere dell’Improvviso, e inoltre la mancanza
di indipendenza e di comunicazione» (ibidem, p. 298).
17
L’utilizzo che Binswanger fa delle formulazioni heideggeriane non incontra tuttavia i favori del filosofo di Meßkirch. Basti, in questa sede, il rinvio al passo in cui si discutono, tra gli
altri, i concetti di continuità e progetto-di-mondo: «Continuità, materialità, consistenza non
sono determinazioni di un progetto-di-un-mondo [Weltentwurfes], bensì queste cose si possono mostrare in modo diverso solo all’interno dell’ente dischiuso dal progetto-di-un-mondo.
Binswanger intende […] l’ente che appare in questo e in quel modo, accessibile attraverso
il progetto-di-un-mondo. Questo che di apparente in questo e quel modo non è un diverso
progetto-di-un-mondo. Binswanger scambia l’elemento ontologico del progetto-di-un-mondo
con l’ente possibile, che appare in questo e quel modo, dischiuso nel progetto-di-un-mondo,
vale a dire, con l’ontico. Progetto-di-un-mondo è ambiguo: progettare un mondo, e ciò che
appare sul fondamento di questo progettare. Questo lo si può designare come il progettato.
Questo progettato, Binswanger lo chiama, erroneamente, progetto-di-un-mondo» (M. Heideg13
14
Dalla Daseinsanalyse alla psicosi determinista: Binswanger e Borges
73
La melanconia
I caratteri dell’analisi che Binswanger affida alla descrizione della melanconia, così come sarà per la mania18, sono di matrice squisitamente husserliana.
Nella melanconia e nella mania, così come nella schizofrenia, sono compromesse la continuità e la consequenzialità dell’esperienza poiché «altrimenti non
potremmo parlare di psicosi»19. Chi è affetto da tali patologie è deietto in un
mondo dominato dal terribile in cui regna il sentimento di fine del mondo e di
perdita della realtà. La melanconia e la mania sono storture che si sostanziano
originariamente nella temporalizzazione. La melanconia in quanto appartenente a questa categoria di storture, si inserisce problematicamente nell’interruzione dello scorrere fedele del tempo. Binswanger assume la triade husserliana dei cosiddetti momenti intenzionali costitutivi strutturali del tempo, definendo passato, presente e futuro non già con queste semplici accezioni, bensì
come retentio, praesentatio e protentio. Questi tre momenti non sono separabili
e nell’esperire vivono come simbionti, accusando ognuno gli eventuali difetti
degli altri; se, per esempio, la stortura temporale dovesse interessare l’ambito
del passato (retentio), anche praesentatio e protentio sarebbero compromessi. I
tre caratteri «non sono dunque da considerarsi come pietre isolate nella costruzione dell’oggettività temporale; non sono separabili»20. Oggettività temporale
va qui intesa come la sequenza intersoggettiva degli istanti, che nella comune
concezione del tempo genera l’uomo come creatura temporale. In questo modo
l’esperire trova diretto riscontro esperenziale nella sua intenzionalità conoscitiva e interpretativa.
Il tempo del melanconico è un tempo vuoto fatto di istanti determinati e vacui nell’inconsapevolezza dello scorrimento autentico. Il melanconico assume
un momento, ed uno soltanto, e ad esso tende ad asservire il proprio scorrimento temporale. Nel melanconico non si dipanano i fili della cronologia come
succede invece in chi non è psicotico; la dimensione melanconica resta sempre
ger, Zollikoner Seminare. Protokolle-Gespräche-Briefe, 1987, trad. it. di A. Giugliano Seminari di
Zollikon, Guida, Napoli, 2000, p. 276). Cfr. anche ibidem, pp. 172-178, 279-282, 319-320.
18
Nell’analisi della melanconia e della mania Binswanger ammette di non aver utilizzato
un approccio di tipo daseinsanalitico, ma di aver condotto invece questi studi esclusivamente
sulla base della fenomenologia: «Il termine “fenomenologico” applicato qui alla comprensione
scientifica delle malattie mentali melanconia e mania, sta pertanto a indicare che non si tratta
di studi clinici, ma di contributi alla metodologia psichiatrica» (L. Binswanger, Melancholie
und Manie: Phänomenologische Studien, 1960, trad. it. di M. Marzotto Melanconia e mania,
Bollati Boringhieri, Torino, 1977, p. 19).
19
Ibidem, p. 23.
20
Ibidem, p. 33.
74
Livio Santoro
quella dell’attualità, di una vuota attualità che fissa gli accenti di un’esistenza
completamente datasi all’istante: «vi è l’allentamento totale di questi fili e la
loro lacerazione con la conseguente scomparsa “delle rappresentazioni abituali
a favore di una pura attualità”» 21.
Similmente al difetto della temporalizzazione che, come si è sostenuto, colpisce l’esaltato, nel melanconico uno scarto sostanziale tra i momenti intenzionali costitutivi strutturali causa l’inautenticità del Dasein. Nell’esaltazione
fissata, però, a essere soggetta a fissazione era un’ideologia, una passione; nella
melanconia invece è un istante, più precisamente è l’istante della pura attualità
a essere fissato e a subire quell’astrazione mondana che fa del melanconico uno
psicotico.
Il melanconico vive dunque in una condizione completamente asservita a
un momento e non è in grado, come detto, di oltrepassare la propria fissazione
nemmeno davanti ad un’evidenza; anche un evento futuro è infatti considerato
dal melanconico come già accaduto, come parte imprescindibile da un disegno
che si dipana dall’istante fissato nella sua temporalità. Il melanconico, dunque,
non si lascia convincere dai fatti, la sua realtà è avulsa dalla normale consequenzialità, al punto che egli vive la propria esperienza temporale con vacuità
poiché il momento fissato impera nella sua temporalizzazione.
La psicosi del melanconico sembra collegarsi a quanto è stato già detto sui
determinismi come esaltazioni fissate. Fissando uno scopo irraggiungibile ogni
determinismo solidifica, infatti, un momento protentivo, un inautentico futuro,
una prospettiva vertiginosa e invalicabile. Si afferma, in ogni concezione determinista, un’interrelazione tra le fissazioni che nella psicopatologia portano da
un lato all’esaltazione fissata e dall’altro alla melanconia.
La mania
Se nella melanconia l’analisi fenomenologica sottolinea momenti difficoltosi nella temporalizzazione, nell’esperire maniaco trova che gli ostacoli che
intervengono nella costruzione della temporalità autentica sono difficoltà in21
C. Gentili, Presentazione a Ludwig Binswanger in L. Binswanger, 1960, p. 17, op. cit. Già
Minkowsky aveva notato questo carattere della psicosi melanconica sottolineando come un
suo paziente, Straus, vedesse il proprio futuro come sbarrato e come egli avesse fenomenologicamente una mancanza di protensione verso il futuro per usare le parole stesse del malato
(E. Minkowsky, Etude psychologique et analyse phénoménologique d’un cas de mélancolie schizophrénique, in Journal de Psychologie, vol. 20, 1923, cit. in L. Binswanger, 1960, pp. 44-45,
op. cit.).
Dalla Daseinsanalyse alla psicosi determinista: Binswanger e Borges
75
sormontabili, e non solo momentanee storture. Nella mania tutta la struttura
temporale oggettiva è compromessa e minata alla base perché il suo aspetto
maggiormente problematico si trova ora nell’Essere-con, nell’intersoggettività,
nel mondo comune e nel riconoscimento dell’alterità. Il maniaco vive infatti da
solo con se stesso e riconosce l’altro come alius e non già come alter ego: «mentre nella melanconia il prossimo è ancora un essere umano, sia pure soltanto
un paziente ascoltatore o consolatore, il maniaco non si rivolge primariamente al suo ego, al mondo che gli è proprio, ma, come sappiamo, all’alter ego,
all’altro»22. Nel rivolgersi all’altro attraverso «un difetto di un’appresentazione
generale comune», il maniaco trova che in sé «è turbata anche la costruzione
temporale di una comune oggettività temporale», per cui «l’“altro” perde il carattere fenomenologico di alter ego e diviene semplicemente alius, uno tra i
tanti, un estraneo»23.
Lo squilibrio del maniaco consiste dunque nel fatto che egli esperisce l’estraneo ma non l’èidos24 di estraneità. Il maniaco, perdendo la rappresentazione eidetica dell’alterità, vive l’altro esclusivamente per il suo stesso mondo. L’aspetto
della temporalizzazione ne risulta in questa maniera gravemente compromesso
in quanto viene minata alla base l’intersoggettività dell’Essere-con: «il “difetto della temporalizzazione” e il conseguente “difetto di tempo” del maniaco si
esplicano decisamente sulla costituzione dell’alter ego e pertanto del mondo
comune»25. Il maniaco, percependo una dimensione temporale storta, non vive
il fluire cronologico legittimamente, bensì vive una costante e sparpagliata sequenza di presenti inattuali, di momenti validi solo per se stessi, inconciliabili
tra loro e al di là di loro stessi. Il tempo del maniaco è un tempo frastagliato,
L. Binswanger, 1960, p. 69, op. cit.
Ibidem, pp. 81, 83.
24
Qualsiasi cosa conoscibile esibisce un èidos. L’èidos non è la «visione accidentale che
abbiamo di una cosa o di uno stato di cose» bensì è l’«immagine unitaria di tutte le possibilità
di mutamento (delle metabolài, del passare attraverso le ineluttabili metamorfosi) racchiuse
nell’immagine fondamentale» (W. Szilasi, cit. in L. Binswanger, 1965, p. 46, op. cit.). L’èidos è
l’immagine di un qualsiasi ente che regola e contiene tutte le variazioni delle sue possibilità.
Per cui alla vista di, per esempio, una credenza, non abbiamo solo l’immagine di quella credenza che si osserva nel dato istante, ma abbiamo davanti a noi l’èidos, ossia il contenitore
unitario e strutturante di tutte le credenze in ogni conoscibile possibilità di mutamento. Per
usare ancora le parole di Szilasi: «quando diciamo: “questo è un albero”, “ecco un albero”, non
intendiamo affatto esprimere il modo in cui ci appare proprio questo albero qui (tanto meno
ciò che intendiamo col concetto di albero), ma ci riferiamo a un più profondo “aspetto” che
è visibile in ogni singola immagine d’albero, nel phàntasma, ossia l’aspetto regolativo di tutte
possibili variazioni del modo di presentarsi di un albero» (ibidem). È evidente che la fonte primaria di tale argomentazione è la definizione del concetto, che Platone attribuisce a Socrate:
“l’insieme delle caratteristiche comuni a una serie” (cfr. anche Diogene Laerzio, Socrate in Vita
e dottrine dei filosofi).
25
L. Binswanger, 1960, p. 91, op. cit.
22
23
76
Livio Santoro
inconsequenziale, costantemente appagato dalla possibilità di darsi nel medesimo istante in cui si svolge.
Il maniaco fa della sua esistenza una sorta di gioco in cui le regole non sono
dettate da alcuna istanza. Le regole della vita del maniaco sono infatti in continuo cambiamento, si fondano rifondandosi continuamente senza seguire una
logica apparente; in altre parole non vi è un sistema che sottenda alla regolazione, tutto è dato al progetto maniaco. Il maniaco «non è più il padrone ma lo
schiavo delle presenze attuali»26. Di conseguenza la sua temporalizzazione è un
surrogato dell’oggettività temporale. Il difetto fondamentale è qui nella carenza
della continuità del pensiero, nell’attualità fine a se stessa di qualsiasi pensiero
del maniaco, nella falsità di qualsiasi attribuzione di ruolo all’altro e nell’utilizzo spasmodicamente asservito alla propria individualità di qualsiasi presente,
di ogni presenza.
Il maniaco è un burattinaio, ma è un burattinaio che gioca con figure distorte, fallaci, aliene dall’oggettività temporale e mosse da fili, che ancorché
essere intricati, come succede invero per il melanconico, sono lacerati: «mentre dunque il melanconico vive, per dirla in termini comuni, in un passato o in
un futuro intenzionalmente turbato, per cui non perviene ad alcun presente, il
maniaco vive solo “per il momento”, esistenzialmente parlando, vive, è deietto,
nell’impossibilità di sostare, è dappertutto e in nessun luogo»27. Questa affermazione ripropone la questione della scienza determinista e del suo vivere per il
momento, la cui sostanza alberga nella pura attualità di qualsiasi suo rimando,
nella negazione di qualsivoglia spigolo. Il determinismo può essere in questo
senso considerato una psicosi cronica. Cronica per due motivi: uno letterale,
nel senso che pecca continuativamente nelle sue storture; l’altro etimologico,
nella misura in cui è proprio nella temporalizzazione che le sue storture hanno
maggiore valenza.
La sostanza generale delle psicosi
È dunque la temporalizzazione la misura compromessa nel Dasein dello psicotico. Questione centrale, come abbiamo visto, nell’assolutizzazione verticale
dell’esaltazione fissata; nell’inconsequenzialità dei rimandi nello strambo; nello
scollamento del complesso àisthesis, mnème e fantasia; nella frattura eidetica
26
27
Ibidem.
Ibidem, p. 111.
Dalla Daseinsanalyse alla psicosi determinista: Binswanger e Borges
77
del maniaco; nell’inautenticità del complesso protentio, retentio, praesentatio
del melanconico.
Nello psicotico l’incapacità di percepire la temporalizzazione autentica impedisce l’assunzione intersoggettiva del proprio Dasein, relegando il soggetto
che esperisce una temporalizzazione distorta a essere l’unico abitante del proprio mondo. Nei diversi paradigmi deterministi, invece, questa prospettiva si
afferma nell’esaltazione di una ideologia di scienza, nella misura in cui questa
è posta a un livello intersoggettivo. In altre parole nei determinismi si subordina la temporalizzazione alle ideologie, alle fissazioni. Ogni determinismo, del
resto, propone una visione del mondo asservita a una concettualizzazione antiprospettica e assolutizzante. Si verifica infatti una sublimazione finalistica basata spesso su una vera e propria teleologia.
Nel campo della psicopatologia l’analisi delle psicosi operata dalla Daseinsanalyse porta a una nuova definizione delle stesse, ma non esaurisce qui la
sua importanza, in quanto rischiara determinati orizzonti, dischiusi sulle prospettive della scienza in generale. L’ammissione che, infatti, la psicosi sia una
differente prospettiva, una diversa possibilità di darsi del Dasein, annulla la
fondatezza di qualsiasi fissazione e l’essenza intimamente schematica dei determinismi come scienze universali e universalmente valide. Lo stravolgimento che le teorie organiciste, naturaliste, deterministe subiscono ad opera della
Daseinsanalyse è, di fatto, la demolizione di un metodo valido spesso solo per
se stesso. Non è infatti pensabile che la metodologia di una scienza nata per affermare se stessa possa essere ritenuta valida per il crollo della scienza stessa.
Anche se, ricordando il pluralismo metodologico di Jaspers, non è possibile negare la validità di un qualsiasi metodo all’interno, ed esclusivamente all’interno,
dell’ambito che lo definisce.
La psichiatria (e con essa la Daseinsanalyse) opera a cavallo di diverse unità
d’analisi, il suo oggetto altro non è che colui che ne definisce le regole. Proprio
per questo motivo il prospettivismo si caratterizza fedelmente nella psichiatria,
ma soltanto attraverso l’analisi fenomenologica.
La proposta prospettivista di Ludwig Binswanger, a parere di chi scrive,
consiste nella definizione prospettica del Dasein, in quanto tale concezione non
pone alla base alcun elemento assoluto (alcun dato), non accettando nessuna
forma di organicismo. Lo psicotico vive per se stesso e non può comunicare il
proprio mondo.
Umbratili e nascoste, le regioni della mente dello psicotico sono luoghi
osmotici dato che, se possono rilasciare al di fuori di se stesse le proprie esperienze nel tentativo seppur vano di comunicarle, non possono allo stesso tempo
78
Livio Santoro
essere ridotte a unità d’analisi attraverso i metodi propri della scienza classica
e del naturalismo classificatore.
La fondazione fenomenologico-daseinsanalitica di Borges
A questo punto si può introdurre la nostra interpretazione di Borges. Si sostanzia, con Borges, la consapevolezza di una pluralità di prospettive, ognuna
largamente legittima, ma legittima esclusivamente per se stessa. Si delinea un
rinnovato prospettivismo, un orizzonte che si configura dispiegando tutto il suo
complesso di significatività ponendosi come poetica dell’assenza di fondamento, nella considerazione delle diverse possibilità di dispiegarsi del Dasein. Attraverso tali possibilità si rende quel ruolo, fondamentale, del commiato dall’ontologia: non esiste unità ontologica archetipica, è la pluralità delle possibilità
stesse ad essere ontologicamente archetipica.
L’eterno labirintico girovagare dell’Immortale fino al raggiungimento autistico del mutismo e della regressione scimmiesca è un percorso a ritroso, che
destruttura l’individuo, risolvendosi in differenti allucinazioni, assicurando al
vagabondo la sicurezza dell’autismo, la chiusura all’interno di un sé più intimo
che si allontana dall’intersoggettività solidificandosi nella primitiva dimensione
del silenzio28.
L’autismo è solo una delle patologie che il poeta argentino prende a prestito
dalla psicopatologia per dipingere i propri caratteri come fa, ad esempio, per
descrivere Asterione, il Minotauro, essere ibrido e amorfo di uomo e toro, certo
di trovarsi nel suo labirinto per un disegno di cui lui stesso è stato compartecipe. È in tal senso che il labirinto rappresenta la dimensione speculare dello stesso Minotauro. Un labirinto nel quale porte, corridoi e vicoli ciechi sono esperiti
dal mostro come le innumerevoli stanze della sua reggia principesca.
Il labirinto, in effetti, costituisce uno degli elementi fondamentali nell’esperire dei personaggi borgesiani. È un labirinto che il lettore di Borges può altresì
trovare nelle infinite pagine degli interminabili volumi che occupano l’interno
di innumerevoli biblioteche29. Lo specchio, altro elemento eletto di Borges, è la
rifrazione delle immagini, potenzialmente anch’essa infinita, dunque labirintica. Il sogno, ancora, viene vissuto come esperienza non già esclusivamente
28
J. L. Borges, El Aleph, 1952, trad. it. di F. Tentori Montalto L’Aleph, Feltrinelli, Milano,
2005, pp. 5-25.
29
Cfr. J. L. Borges, El jardin de senderos que se bifurcan, 1941, trad. it. di F. Lucentini Il
giardino dei sentieri che si biforcano in Finzioni, Einaudi, Torino, 1955, pp. 69-78.
Dalla Daseinsanalyse alla psicosi determinista: Binswanger e Borges
79
onirica, ma depositaria di una certa lucidità appercettiva in un labirinto, ora,
del tutto soggettivo30. In tal senso appare cruciale quel passo che Borges affida
ai suoi Frammenti di un vangelo apocrifo per cui «nada se edifica sobre la piedra, todo sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como si fuera piedra la
arena…»31. Del resto quando si asserisce che ogni cosa si edifica sulla sabbia, si
intende un’assenza che è ben figurata della sabbia, che non può crollare come la
pietra, ma che può, però, rifondersi, riformarsi, ristabilirsi, perché non è altro
che un risultato del tempo stesso, e come tale è già stata pietra. In altre parole si potrebbe dire che la sabbia è pietra che diventa fluida negando se stessa.
Pensare in modo deterministico, riducendo la spiegazione a determinati fatti o
dati, è tentare di costruire sulla pietra32.
Il problema fondamentale del tempo
«Ogni soluzione dei problemi filosofici appartiene, riguardata dal punto di
vista storico, ad una situazione attuale ed ha un suo posto in essa: l’uomo,
questa creatura del tempo, trova, in quanto in esso opera, la sicurezza del suo
esserci, poiché egli eleva quanto crea al di sopra del fluire temporale, facendolo
30
La scomposizione, la destrutturazione e la rifrazione sono da considerare come gli elementi concettuali che sottendono agli stati fisici della materia sopra elencati (labirinto, libro
e specchio).
31
«Nulla si edifica sulla pietra, tutto sulla sabbia, ma noi dobbiamo edificare come se la
sabbia fosse pietra». J. L. Borges, Elogio de la sombra, 1969 (1), trad. it. di F. Tentori Montalto
Elogio dell’ombra, Einaudi, Torino, 1971, p. 102.
32
La natura di questa irriducibilità ad uno schematismo statico assiomaticamente determinista è una questione che risulta palese dalle pagine di Borges. Richiamare quel passo,
ormai inalienabile, della nietzscheana Volontà di potenza, risulta immediato: «Contro il positivismo, che si ferma ai fenomeni: “ci sono soltanto fatti”, direi: no, proprio i fatti non ci
sono, bensì solo interpretazioni. Noi non possiamo constatare nessun fatto “in sé”; è forse
un’assurdità volere qualcosa del genere. “Tutto è soggettivo”, dite voi; ma già questa è un’interpretazione, il soggetto non è niente di dato, è solo qualcosa di aggiunto con l’immaginazione,
qualcosa di appiccicato dopo. -È infine necessario mettere ancora l’interprete dietro l’interpretazione? Già questo è invenzione, ipotesi. In quanto la parola “conoscenza” abbia senso, il
mondo è conoscibile; ma esso è interpretabile in modi diversi, non ha dietro di sé un senso,
ma innumerevoli sensi. “Prospettivismo”. Sono i nostri bisogni, che interpretano il mondo: i
nostri istinti e i loro pro e contro. Ogni istinto è una specie di sete di dominio, ciascuno ha la
sua prospettiva, che esso vorrebbe imporre come norma a tutti gli altri istinti» (F. Nietzsche,
Frammenti postumi 1885-1887, si cita da Opere di Nietzsche Friedrich, trad. it. di S. Giametta,
edizione italiana diretta da G. Colli e M. Montanari vol. XIII, Tomo I, Adelphi, Milano, 1975,
7 [60]). L’affermazione nitzscheana si adegua perfettamente all’assenza di fondamento che si
legge in Borges. Il positivismo (determinismo per eccellenza) è un’interpretazione del mondo
e ha senso solo se considerato come tale. Se fosse un tratto individuale Binswanger lo descriverebbe come una possibilità dell’esistenza di darsi alle sue possibilità (L. Binswanger, 1956, p.
59, op. cit.). Il positivismo vive come parzializzazione e solo in quanto parzializzazione.
80
Livio Santoro
durare: in questa luce l’uomo crea con lieto coraggio e con piena energia»33.
Uno degli strumenti più cari a Borges, il paradosso34, è la chiave della temporalità, fondamento dell’assenza, come principale strumento ai fini dell’assunzione generale della mancanza del fondamento. Achille non raggiunge la tartaruga, né il giavellotto raggiunge la sponda estrema dello stadio: dovendo percorrere
i rispettivi tragitti entrambi si trovano a dover costantemente superare la metà dello
spazio, ma lo spazio è scomponibile all’infinito: la metà della metà della metà… I
paradossi presuppongono un infinito attuale che continuamente presentifica le dinamiche dello spazio e del tempo, tale caratteristica rende impossibile percorrere
qualsiasi tragitto perché ogni distanza è scomponibile all’infinito in infiniti presenti:
«c’è un concetto che corrompe e altera tutti gli altri. Non parlo del Male, il cui limitato impero è la pratica; parlo dell’infinito»35. Questo infinito attuale dello spazio e
del tempo è in condivisione tra la logica del paradosso e la mancanza di temporalizzazione autentica che si è visto essere propria dello schizofrenico, del maniaco e del
melanconico. Questi ultimi vivono la propria dimensione del tempo e dello spazio
svincolandosi dall’intersoggettivo, che fa, invece, della temporalità oggettiva il custode dell’esperienza intersoggettiva. Qui infatti si sostanzia la saturazione dell’esperire nel soggetto psicotico, e, nel paradosso della tradizione, così come in quello di
Borges, abbiamo lo stesso sostantivarsi di istanze estremamente soggettive nelle
dinamiche esperenziali. Paradossale è in tal senso la supposizione di un infinito presente, di un infinito attuale dello spazio e del tempo. Sostiene Borges: «Zenone è incontestabile, a meno che non confessiamo la natura ideale dello spazio e del tempo.
Accettiamo l’idealismo, accettiamo la crescita concreta di quanto percepiamo, ed
eluderemo il pullulare di abissi del paradosso»36. È dunque, qui, necessario richia-
33
W. Dilthey, Das Wesen der Philosophie, 1907, trad. it. di G. Penati L’essenza della filosofia,
Rusconi, Milano, 1999, p. 121.
34
Nella filosofia occidentale il paradosso viene introdotto per la prima volta da Zenone di
Elea (V secolo a.C.), che considera due grandi gruppi di argomenti: quelli contro l’ipotesi del
movimento e quelli contro l’ipotesi della pluralità. I paradossi della Freccia, dello Stadio e di
“Achille e la tartaruga” fanno parte degli argomenti contro l’ipotesi del movimento. La sostanza dei paradossi è chiara e tende a negare, contro Eraclito, la reale possibilità di movimento,
in quanto lo spazio suddivisibile all’infinito non può essere percorso nel tempo in tutte le sue
innumerevoli parti. Non ci riesce la freccia scagliata che non raggiungerà il suo obiettivo, né
vi riesce Achille che non potrà mai raggiungere la tartaruga. Tuttavia la freccia e Achille hanno due differenti anche se simili funzioni nella spiegazione di Zenone. Achille viaggia su un
campo originariamente spaziale (per cui lo spazio è infinitamente scomponibile), mentre la
freccia suppone invece una attualità infinita del tempo, e la sua impossibilità di raggiungere la
sua meta e la conseguente sua staticità, stanno a rappresentare la staticità eterna della realtà
sempre ferma in cui la freccia stessa si trova.
35
J. L. Borges, Discusiòn, 1932, trad. it. di L. Lorenzini Discussione, Adelphi, Milano,
2002, p. 123.
36
Ibidem, p. 114.
Dalla Daseinsanalyse alla psicosi determinista: Binswanger e Borges
81
mare gli accenti del paradosso attraverso la concezione heideggeriana, ossia quella
sostanziale identità che in certi momenti il filosofo tedesco assumeva tra spazio e
tempo. Borges riformula su di un terreno rinnovato i paradossi di Achille e della
tartaruga, della freccia e dello stadio; tale riformulazione incontra l’interpretazione
heideggeriana, assumendo questi concetti su di un terreno comune che assimila a
sé spazio e tempo, quella sorta di luogo fenomenologico che è il Dasein.
Tale proposta non considera più il tempo come infinito attuale di un determinato presente, bensì come l’infinito attuale di un determinato momento praesentativo. Ovviamente, ricordando Husserl, tale solidificazione della praesentatio determina la simultanea solidificazione di protentio e retentio, annichilendo
il tempo oggettivo, e soggettivando un inautentico scorrimento temporale. Il
paradosso viene utilizzato da Borges ancora come antidoto a quella concezione
fissata del tempo e dello spazio, un antidoto che utilizza le stesse misure del
veleno nella difesa della propria affermazione.
La supposizione avanzata da Borges, strumentalizzando il paradosso, sottolinea dunque il dispiegarsi del Dasein, come possibilità dell’esistenza nell’innumerevole complesso delle possibilità che l’esistenza stessa ha di darsi, e di
assumere come valido qualsiasi esperire. Il Dasein diventa così un’ipotesi di realtà soggettiva e autorefenziale, soprattutto quando considerata come progettodi-mondo, e, cosa che più di altre ci preme sottolineare, valida in quanto accetta
tutte le altre possibilità oltre a se stessa, in quanto non impone se stessa a un
livello intersoggettivo. La base dell’accettazione di questa affermazione si trova
nella verifica di autenticità di tutte le prospettive che esistono al di fuori di quella che si sostiene, di tutte le possibilità che l’esistenza ha di darsi.
È qui che rincontriamo il problema della temporalizzazione che si conferma
dunque come quello che richiede maggiore attenzione. «Il tempo è la sostanza di
cui sono fatto. Il tempo è un fiume che mi trascina, ma io sono il fiume; è una tigre
che mi sbrana, ma io sono la tigre; è un fuoco che mi divora, ma io sono il fuoco.
Il mondo, disgraziatamente, è reale; io, disgraziatamente, sono Borges»37.
In tale prospettiva l’Esserci heideggeriano diventa un concetto assolutamente temporale, grazie alla concezione dei tre momenti di futuro, passato e presente come sopravvenire (Ankommen) del non-ancora-presente, essere-stato
(Gewesen) del non-più-presente e presenza del presente stesso38. E se, ancora,
37
J. L. Borges, 1960 (2), p. 186, op. cit. Il realismo insito in questa affermazione indurrebbe quindi a non soffermarsi sulla piattaforma opaca della narrazione, bensì a muoversi nel
complesso di una realtà che appare tuttavia squisitamente soggettiva.
38
M. Heidegger, Zur Sache des Denkens, 1963, trad. it. di E. Mazzarella Tempo ed essere,
82
Livio Santoro
il tempo nella concezione di Husserl considera futuro, passato e presente come
protentio, retentio e praesentatio, il tempo di Borges non è altro che lo stesso
tempo che trova mediazione tra Husserl e Heidegger, nella misura in cui esso
appare come l’unica sostanza cui è riducibile l’esistenza umana, perché esso è
l’esistenza umana, in una prospettiva che lo dispiega nelle sue molteplici e infinite possibilità di darsi nella temporalizzazione e nei rimandi dei rispettivi tre
momenti costitutivi, che non sono, lo ripetiamo, distinti e separati tra di loro,
bensì vivono di vita simbionte. «Somos el tiempo. Somos la famosa/ parábola
de Heráclito el Oscuro»39.
Il tempo è per Borges il “mistero fondamentale” (Conversazioni americane): «Il problema del tempo implica quello dell’ego, perché, dopo tutto, cos’è
l’ego? L’ego è il passato, il presente e anche l’anticipazione di quello che verrà,
il futuro»40. Dunque per lo scrittore argentino il tempo costituisce la sostanza
di cui siamo fatti, ma è una sostanza, questa, estremamente problematica poiché implica due elementi cruciali: la memoria e l’eternità. La memoria serve a
Borges per giustificare il tempo individualmente, l’eternità serve per lo stesso
scopo, questa volta però al servizio del genere. Così come la memoria, in quanto
tempo, non è una sola, anche l’eternità non è unica, e, nella Storia dell’eternità
Borges ce ne delinea cronologicamente i tratti, riducendo l’eternità stessa a due
tipi antitetici: il realismo e il nominalismo, due dottrine tra di loro assiali. Esse
avrebbero sognato entrambe il tempo in due differenti sogni: «uno, quello realista, che anela con passione agli immobili archetipi delle creature; l’altro, quello
nominalista, che nega la verità degli archetipi e vuole racchiudere in un solo
istante i dettagli dell’universo»41. Che il tempo non sia esperito, bensì sognato è
un classico gioco borgesiano42.
Guida Editori, Napoli, 1980, p. 119.
39
«Siamo il tempo. Siamo la famosa/ parabola di Eráclito l’Oscuro» (J. L. Borges, El otro,
el mismo, 1969 (2), trad. it. di T. Scarano e I. Carmignani L’altro, lo stesso, Adelphi, Milano,
2002, p. 26).
40
J. L. Borges, Borges at Eighty, 1982, trad. it. di F. Mogni Conversazioni americane, Editori
Riuniti, Milano, 1984, p. 45.
41
Il rapporto tra il sogno realista e quello nominalista con il tempo richiama quella che
la tradizione psicologica definisce corrente logicista e corrente psicologista, correnti tra cui,
si ricordi, Husserl era in continua tensione nella definizione della sua fenomenologia. Il nominalismo che nega la verità degli archetipi è grossomodo un antiapriorismo ascrivibile alla
posizione psicologista per la quale i soggetti spontaneamente attraverso la propria attività
psichica costituiscono il fondamento dei concetti stessi. Mentre il realismo «che anela con
passione agli immobili archetipi delle creature» (J. L. Borges, Historia de la eternidad, 1936,
trad it. di G. Guadalupi Storia dell’eternità, Adelphi, Milano, 2000, p. 31), è caratterizzato dalle
medesime istanze del logicismo nella misura in cui, per quest’ultimo, le verità logiche sono del
tutto indipendenti rispetto a qualsiasi soggetto che le pensa.
42
Su Borges e temporalità si veda anche: A. Giugliano, «Esa ráfaga, el tango, esa diablura»:
Dalla Daseinsanalyse alla psicosi determinista: Binswanger e Borges
83
La memoria
«Il mio racconto sarà fedele alla realtà, o almeno al mio ricordo personale
della realtà, che è poi la stessa cosa»43. «Lo ricordo (io non ho il diritto di pronunciare questo verbo sacro; un uomo solo sulla terra, ebbe questo diritto, e
quest’uomo è morto)»44.
Questi sono gli incipit di due racconti (Ulrica e Funes, o della memoria) in
cui si sostanzia la concezione della memoria del poeta argentino. Dal primo si
evincono i fenomenologismi della memoria borgesiana, ossia l’identità tra la realtà e il ricordo della stessa. La memoria non è altro che la realtà di ciò che si è
vissuto. Il tempo «è la sostanza di cui sono fatto»45; e il tempo è la memoria.
Nella Daseinsanalyse, si ricordi, la conoscenza è una forma di esperienza;
la conoscenza rappresenta un modo dell’Essere-nel-mondo. Rovesciando Kant
la Daseinsanalyse afferma ciò che la conoscenza è: soltanto una forma di esperienza.
Dall’incipit di Funes, o della memoria è possibile desumere la sacralità della
memoria, la quale proprio perché è considerata al pari della vita, rende possibile pronunciare la parola “ricordo”, che equivarrebbe a poter pronunciare la
parola “esperisco”, dunque la parola “vivo”. «Como en los sueños,/ detrás de las
altas puertas no hay nada,/ ni siquiera el vacío./ Como en los sueños,/ detrás del
rostro que nos mira no hay nadie./ Anverso sin reverso,/ moneda de una sola
cara, las cosas./ Esas miserias son los bienes/ que el precipitado tiempo nos
deja./ Somos nuestra memoria,/ somos ese quimérico museo de formas inconstantes,/ ese montón de espejos rotos»46.
Nei versi conclusivi di questa poesia si evidenzia l’essenza della concezione
borgesiana del tempo e della fondazione dell’uomo. Nel passo riportato compaiono numerosi temi classici cari all’autore argentino: la moneta a una faccia
–motivo che poi riapparirà nel racconto Il disco47–, lo specchio, la mutevolezza
Borges e il tango come talismano della temporalità, in: «Annali dell’Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale”. Sezione Romanza», XLVIII, 2006, pp. 97-106.
43
J. L. Borges, El libro de arena, 1975 (1), trad. it. di I. Carmignani Il libro di sabbia, in Il
libro di sabbia, Adelphi, Milano, 2004, p. 20.
44
J. L. Borges, Ficciones, 1944, trad. it. di F. Lucentini Artifici in Finzioni, p. 97, op. cit.
45
J. L. Borges, Otras Inquisiciones, 1960 (2), trad. it. F. Tentori Montalto Altre inquisizioni,
Feltrinelli, Milano, 1973, p. 186.
46
«Come nei sogni,/ dietro le alte porte non c’è nulla,/ Neppure il vuoto./ Come nei sogni,/
nessuno dietro il viso che ci guarda./ Dritto senza rovescio,/ moneta ad un faccia son le cose./
Codeste miserie sono i beni/ Che il precipite tempo ci concede./ Siamo il nostro ricordo,/ siamo
museo immaginario di mutevoli forme,/ mucchio di specchi rotti» (J. L. Borges, 1969 (1), p.
17, op. cit).
47
J. L. Borges, 1975, pp. 95-97, op. cit.
84
Livio Santoro
e, appunto, il ricordo. Il ricordo, in tale prospettiva, diventa una componente fondativa dell’essere umano poiché il tempo, mediato dalla memoria, per
quanto mutevole e soggettivo, contraddistingue l’ipseità dell’essere umano. La
memoria diventa quindi quel luogo fenomenologico di fatti che sono riducibili
solo a se stessi. Si è validi solo per se stessi, nell’identificazione con la propria
storia, con il proprio vissuto e dunque con la propria memoria: «Ricordo la passiflora oscura che teneva nella mano, vedendola come nessuno vide mai questo
fiore, né mai lo vedrà, anche se l’avrà guardato dal crepuscolo del giorno a quello della notte, per una vita intera»48.
La memoria è protensione verso il passato, verso un passato che recupera
le innumerevoli sfaccettature del soggettivo, e che prepara, attraverso un presente indeterminato, all’accettazione di un futuro innumerevole e prospettico.
La peculiare istanza di ogni soggettività all’interno dell’ambito che le compete
rivendica nella memoria la propria unicità in quanto decostruzione e scomposizione, e rivendica altresì nella protensione al futuro la propria specificità di
gestione prospettica dello scopo, ossia dell’assenza di un obiettivo assolutamente fine a se stesso ma relativamente fine a se stesso, è il tema antifinalistico che
stiamo qui discutendo.
La memoria è il crocevia della costituzione dell’uomo, lo sguardo indiscriminato e infallibile, in quanto intrinsecamente si pone come estremamente fallibile, che accompagna come centro di un palindromo assoluto la medesima
costruzione del futuro: secondo le traiettorie del prospettivismo, passato e futuro coincidono. Passato e futuro combaciano attraverso il presente, e in esso
si specchiano dimostrando la costante categoria del vissuto umano: la ricerca.
Una ricerca costantemente tesa all’insolubilità, e che si verifica nell’opera del
poeta argentino nella sfera del linguaggio.
Diciamo con Foucault che «la parola indica: la sua natura, cioè, è di essere nome. […] Tanto che di fronte all’uniformità del verbo – che è unicamente
l’enunciato universale dell’attribuzione – i nomi pullulano, e all’infinito. Ce ne
dovrebbero essere tanti quante sono la cose da nominare. Ma ogni nome aderirebbe in tal caso con tanto vigore alla sola rappresentazione da esso designata,
da impedire persino la formulazione della minima attribuzione; e il linguaggio
precipiterebbe di nuovo al di sotto di se stesso»49.
J. L. Borges, 1944, p. 97, op. cit.
M. Foucault, Les mots et les choses, 1966, trad. it. di E. Paniatescu Le parole e le cose,
BUR, Milano, 1978, p. 113.
48
49
Dalla Daseinsanalyse alla psicosi determinista: Binswanger e Borges
85
Il libro di sabbia e le glossolalie
Pullulare all’infinito dei nomi, il tema del linguaggio. Borges, fidando
nelle innumerevoli fattezze delle parole, affida al suo strumento più prezioso la definizione del pullulare foucaultiano: il Libro di sabbia. «Lo aprii
a caso. I caratteri mi erano sconosciuti. […] Attrasse la mia attenzione il
fatto che la pagina pari portasse (mettiamo) il numero 40.514 e quella dispari, successiva, il 999. […] C’era anche una piccola illustrazione, come
si usa nei dizionari: un’ancora disegnata a penna, come dalla mano di un
bambino. Fu allora che lo sconosciuto mi disse: “La guardi bene. Non la
vedrà mai più”» 50.
Il libro di sabbia non ha principio né termine, è la reificazione dell’assenza, in quanto caleidoscopica infinità di presenze, i suoi caratteri sono
sconosciuti, dunque lo sono anche le parole, e data questa loro caratteristica esse sono senza dubbio infinite, innumerevoli; le pagine sfogliate
non seguono una sequenza logica, e una pagina, se voltata, non è più la
stessa quando vi si ritorna. Questa feconda e imperitura fertilità del linguaggio è l’incomprensibilità della parola del folle. Il linguaggio del folle
è doppiamente incomprensibile: se da un lato è incomprensibile nell’articolazione dei pensieri, nella dissociazione tra zone eidetiche differenti e
incomunicabili, dall’altro lato assume una caratteristica che oltrepassa la
semplice stortura linguistica dell’ebefrenia e della speculare risposta che
sta nell’ecolalia 51. Esistono infatti le glossolalie, tendenze linguistiche che
contraddistinguono certi tipi di schizofrenie: «Nel contesto di un dizionario di psichiatria la definizione più adeguata è quella che inserisce la
glossolalia nell’area delle formazioni neologistiche: considerandola come
espressione psicotica di una lingua incomprensibile e segreta nella quale
la sintassi è allentata anche se ancora presente in forma elementare; ma
riconoscendola (anche) nella sua significazione alternativa di lingua estranea ed enigmatica che nasce in una condizione di estasi religiosa: essendo interpretata in questo caso, come la conseguenza di una ispirazione
che trascende da quella umana»52. Del resto esistono due modalità con cui
J. L. Borges, 1975, p. 99, op. cit.
L’ebefrenia è una patologia in cui l’eloquio del soggetto colpitone è caratterizzato dall’introduzione di paralogismi e neologismi. L’ecolalia, invece, si caratterizza per la tendenza del
soggetto nel ripetere pedissequamente le parole del proprio interlocutore.
52
E. Borgna, Come se finisse il mondo. Il senso dell’esperienza schizofrenica, Feltrinelli,
Milano, 2002, p. 183.
50
51
86
Livio Santoro
la glossolalia si manifesta nel discorso schizofrenico: «nella prima sembra
configurarsi una “lingua” strutturata nella sua enigmatica incomprensibilità, e nella seconda si hanno solo brandelli linguistici estranei a ogni interna
organizzazione»53.
In tale prospettiva l’immagine borgesiana del libro di sabbia assume un
forte valore epistemico. Essa denota la caratterizzazione estremamente
fuggevole di un linguaggio che, sconosciuto, appare costantemente come
differente da se stesso. L’essenza è inafferrabile in quanto priva di qualsiasi
fondamento costitutivo, o meglio, tale essenza è afferrabile solo se intesa
come assenza. Non l’essenza ma l’assenza.
Il linguaggio dello psicotico rappresenta, infatti, una prospettiva alternativa. Borges affida questa caratteristica al suo libro di sabbia, un oggetto
che diventa quasi animato col passare delle pagine: «L’estate declinava quando compresi che il libro era mostruoso. A nulla valse considerare che era
non meno mostruoso di me, che lo percepivo con gli occhi e lo palpavo con
dieci dita dotate di unghie. Sentii che era una oggetto da incubo, una cosa
oscena che infamava e corrompeva la realtà»54.
La proposta che viene affidata al libro di sabbia è una proposta certamente innovativa nella misura in cui non propone solamente una ricodifica
semplice delle strutture linguistiche correnti, cosa che sarebbe avvenuta se
i caratteri in cui lo si legge fossero stati comprensibili, ma spinge verso una
coerenza aliena del linguaggio, una facoltà mai sopita della parola, che la
vuole potenzialmente infinita nella soggettività dell’esperire. Ma sappiamo
che l’esperire soggettivo non è esplicabile, in quanto fa riferimento solo a
se stesso. È la psicopatologia, attraverso l’approccio fenomenologico, che
rende palese questa irriducibilità.
I linguaggi incomprensibili
La continuità linguistica tra la glossolalia come patologia schizofrenica e la
floridezza del linguaggio comune è suggerita anche dall’esistenza di numerose
altre deviazioni linguistiche nelle personalità schizoidi: infatti «a causa dell’eterogeneità del quadro clinico sintomatico e prognostico della schizofrenia, nes-
53
54
Ibidem, p. 184.
J. L. Borges, 1975, p. 102, op. cit.
Dalla Daseinsanalyse alla psicosi determinista: Binswanger e Borges
87
sun singolo fattore eziologico è considerato la vera causa della malattia»55. Il
linguaggio è ora la piattaforma principale56.
Spaziando infatti dall’ebefrenia alla stramberia, fino al manierismo e alla verbigerazione (eloquio sconnesso, affannato e ipertrofico), le personalità patologiche offrono uno sconfinato campo interpretativo considerando che, sia dal
punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, giocano su traiettorie tra
loro estremamente diverse.
Ciò che sottende al detto, infatti, non è ciò che sottende all’esperito.
Nello psicotico «il linguaggio interiore invade tutto l’ambito di espressione
del soggetto che continua sottovoce un monologo incoerente senza rivolgersi
mai a nessuno»57. La chiusura esistenziale del folle all’interno della propria
immaterialità è, dunque, il palese tratto di una tendenza all’irriducibilità. Incomprensibile è quel linguaggio che appartiene solo al mondo che lo ha generato, al fine di essere rappresentazione di una cosa che non è rappresentabile, e
pertanto incomunicabile. Il linguaggio incomprensibile, espressione di questa
particolare condizione, non è una chiusura nella finitezza, è, anzi, una apertura nell’assenza di fondamenti, che si sostanzia nell’accettazione di un’infinità
prospettica.
Il Wittgenstein del Tractatus logico-philosophicus sostiene: «I limiti del mio
linguaggio significano i limiti del mio mondo»58. Quest’affermazione implica
una totale indipendenza linguistica del senso rispetto a una dimensione intersoggettiva, poiché solo nel pensiero, l’unico depositario della fragile costituzione dell’io, alberga la reale sostanza del senso. In questa prospettiva «il pensiero
è la proposizione munita di senso», da cui dunque consegue che «l’uomo possiede la capacità di costruire i linguaggi, con i quali ogni senso può esprimersi,
senza sospettare come e che cosa ogni parola significhi. – Così come si parla
senza sapere come i singoli suoni siano emessi»59.
Valicare tale posizione significa creare uno scarto incolmabile tra l’esperire
55
B. J. Sadock, V. Sadock, Kaplan & Sadock’s Pocket Handbook of Clinical Psychiatry, 2001,
trad. it. di A. Chiò Psichiatria clinica. Kaplan & Sadock’s Pocket Handbook, Centro Scientifico
Editore, Torino, 2003, p. 109.
56
A tale molteplice vastità che viene offerta da questo campo di studio corrisponde naturalmente una molteplicità di metodi di studio. Piro sintetizza i diversi tipi di metodologie adottate nello studio delle psicopatologie linguistiche in: 1) fonetici, 2) morfologici, 3) lessicali, 4)
semantici, 5) pragmatici, 6) fenomenologici, 7) psicoanalitici (S. Piro, passim, op. cit.).
57
M. Foucault, Maladie mentale et psychologie, Paris 1954, trad. it. di F. Polidori Malattia
mentale e psicologia, Raffaello Cortina, Milano, 1997, p. 19.
58
L. Wittgenstein, Tractatus logicus-philosophicus, 1918, trad. it. di A. G. Conte Tractatus
logico-philosophicus, Einaudi, Torino, 1968, p. 63.
59
Ibidem, pp. 20-21.
88
Livio Santoro
dei diversi soggetti. Si è sì sostenuto che le esperienze sono irriducibili se non
a loro stesse, ma si è altresì affermato che la loro irriducibilità tende a sostantivare una linea di generalità che, proprio a livello dell’irriducibile e dell’inesprimibile, fonda la sua riducibilità.
Ancora secondo Wittgenstein «al mio mondo corrisponde infatti il mio linguaggio e non vi è possibilità che io possa ricevere comunicazione di altre esperienze. Il linguaggio, per quanto non è assolutamente corrispondente ai fatti,
non ha significato»60. Per una logica che vuole associare i metodi daseinsanalitici al lavoro di Borges si dovrebbe invece dire che il linguaggio ha sì significato, sebbene non sia lo stesso del pensiero e dell’esperire, ma tale significato si
fonda solo su se stesso, ed è inizialmente valido solo per se stesso. Questa sua
caratteristica, tuttavia, estesa a qualsiasi altra attribuzione di significato, rende
intersoggettiva l’irriducibilità del senso.
Nella consapevolezza di questa riflessione il ritorno alle glossolalie evidenzia una certa coerenza; se infatti «le glossolalie corrispondono a due diverse
sfere semantiche: la prima rimanda ai modi costitutivi di un linguaggio che si
osserva (si osservava) in alcune forme schizofreniche e la seconda ai modi di
essere di un linguaggio religioso (estetico e mistico)»61, queste diverse sfere semantiche, se considerate come uniche padrone del loro campo, darebbero alle
glossolalie due diverse interpretazioni: la prima (schizofrenia) si attesterebbe
sulle citate posizioni del solipsismo di Wittgenstein, la seconda invece sulle teleologiche esperienze del solipsismo cartesiano che sostiene che l’ego deve riferirsi alle evidenze interiori per trovare un fondamento che non sia suscettibile
di dubbio dal quale fare in un secondo momento scaturire la dimostrazione
assiomatica e razionale dell’esistenza di Dio, dunque del mondo. Ma il linguaggio del folle e le glossolalie hanno un possibile senso nel fatto di non possedere
alcuna significatività intersoggettiva.
I personaggi di Borges: una galleria di psicotici
I tratti dell’opera di Borges sopra discussi si affermano e si dispiegano ora
nei suoi personaggi. Analizzarli implicherà le modalità di funzionamento di
quella che, a parere di chi scrive, può essere considerata la concezione prospettivista di Borges. Le sfaccettature psicotiche del Dasein di molti tra i protago-
60
61
S. Piro, p. 36, op. cit.
E. Borgna, 2002, pp. 182-183, op. cit.
Dalla Daseinsanalyse alla psicosi determinista: Binswanger e Borges
89
nisti onirici che popolano le pagine dei racconti borgesiani, possono, secondo
lo schema ermeneutico che si cerca di sostenere, essere interpretati attraverso
l’utilizzo delle metodologie e dei concetti con i quali la Daseinsanalyse analizzerebbe i propri pazienti.
Le psicosi sono rappresentate nei protagonisti di Borges così fortemente che
alcuni di questi possono essere considerati veri e propri manifesti del suo prospettivismo. Con la gestione delle storture, infatti, il poeta argentino giunge a dipingere
una galleria di caratteri creando un mosaico fedelmente prospettivista.
L’obiettivo generale delle prossime pagine sarà quello di sottolineare i tratti individuali come caratteristiche universali, o meglio, universalizzabili. Lo scopo finale
di questa ultima parte del lavoro è utilizzare dunque le categorie individuali della
Daseinsanalyse psicopatologica, e con esse gestire una ricostruzione generale del
prospettivismo borgesiano.
Gran parte dei personaggi di Borges infatti possiede caratteri sussumibili sotto
le psicosi. Si vedrà come sia possibile delineare una caratterizzazione psicotica di
molti personaggi attraverso la frattura eidetica, la creazione di paralogismi dell’ebefrenico, i giochi linguistici, la disfunzione del momento mnemetico nella temporalizzazione, l’irriducibilità del Dasein. I personaggi appariranno come veri e propri
psicotici, o anche assumeranno solo parzialmente le dinamiche delle psicosi. Sempre, però, saranno forieri di un esperire prospettivista e irriducibile. Tracceremo in
questa sede una diagnosi di Emma Zunz e di Ireneo Funes.
Emma Zunz e la melanconia. Le prospettive dell’azione
La storia di Emma Zunz appare semplice: Emma, venuta a conoscenza della
morte del padre, decide di vendicare un’onta che questi aveva subito da un suo
vecchio socio, attuale datore di lavoro di lei. Emma ordisce la sua trama fingendosi prima prostituta con un marinaio che acconsentirà alla sue proposte,
e recandosi poi dal suo capo per ucciderlo. Al giudice dirà che questi l’aveva
prima convocata e che poi aveva abusato di lei, mettendola così in condizione
di compiere un omicidio per legittima difesa. Due momenti spiegano però tutto l’intento borgesiano: «I fatti gravi stanno fuori del tempo, sia perché in essi
il passato immediato rimane come scisso dal futuro, sia perché le parti che li
formano non paiono consecutive»62, e la chiusura del racconto in cui Borges
scrive: «La storia era incredibile, effettivamente, ma s’impose a tutti perché so62
J. L. Borges, 1952, p. 61, op. cit.
90
Livio Santoro
stanzialmente era vera. Vero era l’ accento di Emma Zunz, vero il pudore, vero
l’odio. Vero anche l’oltraggio che aveva sofferto; erano false solo le circostanze,
l’ora e uno o due nomi propri»63.
Le ormai note caratteristiche delle psicosi sono riscontrabili anche in Emma
Zunz, solo che, al contrario di quello che accade per Ireneo Funes (cfr. § successivo), Emma fa del suo Dasein una mano creatrice, cercando di imporre all’intersoggettività la sua psicosi, senza cercare come Funes una chiusura autistica
nel proprio Dasein. Certo, la morte del padre è un evento traumatico, un fatto
grave come lo definisce Borges, e per questo Emma sente la legittimità della
sua reazione.
Ci si chiede dunque se e quanto l’esperienza di Emma Zunz sia riducibile ad
altre istanze che non siano l’esperienza stessa. Del resto la fedeltà della dichiarazione finale di Emma è per Borges sostanzialmente aderente ai fatti, in quanto veri sono l’accento, il pudore, l’odio e l’oltraggio subito da Emma. E accento,
pudore, odio e oltraggio rivendicano legittimamente il loro primato sulle circostanze e sui nomi propri, in quanto questi ultimi dispiegano le loro qualità su di
un piano assolutamente esterno alla sfera esperenziale della delirante Emma.
Emma non agisce con lucidità, la sua reazione alla morte del padre è la dinamica susseguente a un trauma per una personalità psicotica. La morte del
padre, il fatto grave, vive nell’esperire di Emma come l’unico avvenimento degno di essere considerato tale: appena saputo della dipartita del genitore lei
«desiderò di trovarsi già al giorno dopo. Immediatamente comprese che quel
desiderio era inutile, perché la morte di suo padre era la sola cosa che fosse
accaduta al mondo e che sarebbe continuata ad accadere, senza fine. Raccolse
il foglio [la lettera che le annunciava la morte del padre] e andò nella sua stanza. Furtivamente lo ripose in un cassetto, come se in qualche modo avesse già
conosciuto i fatti futuri. Già aveva incominciato a intravederli, forse; già era
quella che sarebbe stata»64.
Da questo momento Emma comincia a vivere in una dimensione storta, rimane asservita al momento della protentio, e, come sarà per Ireneo Funes, soggiogata della determinatezza assolutizzante del suo nuovo Progetto-di-mondo.
Il futuro è già nel presente, a leggere le parole di Borges: Emma è già «quella
che sarebbe stata».
Nella temporalizzazione psicotica di Emma Zunz tutto avviene perché è già
avvenuto, perché nel suo presente vi è già il futuro. A questo proposito appa63
64
Ibidem, p. 64.
Ibidem, pp. 57-58.
Dalla Daseinsanalyse alla psicosi determinista: Binswanger e Borges
91
re esplicativo il fatto che la mattina del delitto Emma fosse “nervosa”: «L’impazienza la svegliò. L’impazienza, non l’inquietudine, e il singolare sollievo di
stare in quel giorno, finalmente»65. Così Emma vive per quel momento, per
quell’atto ed esclusivamente per quello. Come se quell’atto fosse in un certo
senso già accaduto.
Emma è melanconica, la sua temporalizzazione è infatti scalfita definitivamente dal momento della morte del padre, a partire da quell’istante si innesca
un processo che compromette lo stadio protentivo «giacchè nello stile dell’esperienza melanconica, ciò che accadrà domani non è più possibilità aperta, ma
fatto già compiuto o che sta per compiersi»66. Emma si comporta infatti «come
se in qualche modo avesse già conosciuto i fatti futuri»67. In Emma è compromessa la costituzione temporale dell’oggettività temporale. E tale compromissione è del tutto melanconica.
Funes il memorioso: dal paralogismo ai giochi di linguaggio. Le prospettive
della parola
Il “memorioso” Funes è l’archetipo del personaggio borgesiano.
Già il titolo del racconto Funes, o della memoria è una dichiarazione. La
memoria intesa come il contenitore che custodisce l’esperire soggettivo come
ben esprime il già citato incipit: «lo ricordo (io non ho il diritto di pronunciare
questo verbo sacro; un uomo solo sulla terra, ebbe questo diritto, e quest’uomo
è morto), e ricordo la passiflora oscura che teneva nella mano, vedendola come
nessuno vide mai questo fiore, né mai lo vedrà, anche se l’avrà guardato dal
crepuscolo del giorno a quello della notte, per una vita intera»68. La memoria
è depositaria della realtà soggettiva, così succede nel non-psicotico, ma nello
psicotico questo stesso tratto assume dimensioni ipertrofiche. Funes trasferisce
la dimensione della memoria sulla piattaforma del linguaggio. Come per altri
personaggi borgesiani il linguaggio è, nelle sue sfaccettature, la peculiarità di
Funes.
Un incidente costringe Ireneo Funes all’immobilità, nell’oscurità della sua
stanza il ragazzo rimarrà per tutta la sua vita senza che la luce del sole entri
completamente tra le mura che lo ospitano. In questa chiusura autistica Funes
Ibidem, p. 59.
L. Binswanger, 1960, p. 50, op. cit.
67
J. L. Borges, 1952, p. 58, op. cit.
68
J. L. Borges, 1944, p. 97, op. cit.
65
66
92
Livio Santoro
impara il portoghese, l’inglese, il francese e il latino. Due progetti occuperanno
il resto della sua vita. Il primo è quello di sviluppare un sistema innovativo di
enumerazione in cui a ogni numero corrisponda un nome diverso, «in luogo
di settemilatredici diceva (per esempio) “Máximo Perez”; in luogo di settemilaquattordici, “La Ferrovia”; altri numeri erano “Luis Melián Lafinur, Olimar,
zolfo, il trifoglio, la balena, il gas, la caldaia, Napoleone, Augustín de Vedia”.
In luogo di cinquecento diceva “nove”»69. Da questo primo progetto ne consegue un altro, altrettanto laborioso e labirintico, ridurre in un catalogo mentale i suoi ricordi, non superando però il numero di settantamila. Funes ha
ogni ricordo chiaro e indimenticabile, una cosa non rappresenta per lui un
semplice e singolo ricordo, «egli ricordava, infatti, non solo ogni foglia di ogni
albero di ogni montagna, ma anche ognuna delle volte che l’aveva percepita o
immaginata»70.
Entrambi i progetti della mente (psicotica) di Funes, definiscono alcune delle caratteristiche già analizzate, seguendo le tracce binswangeriane, delle personalità psicotiche. Per quanto riguarda la prospettiva enumeratrice bisogna
però ricordare alcuni elementi come Sergio Piro li definisce nello studio del
‘71 sul linguaggio schizofrenico. Quest’ultimo si suddivide, infatti, in quattro
grandi categorie, che si poggiano su un continuum semantico: I) Fluttuazione
dell’alone semantico, II) Distorsione semantica, III) Dispersione semantica, IV)
Dissoluzione semantica71. Funes appartiene proprio alla categoria della distorsione semantica. Infatti la creazione di neologismi, ma soprattutto di paralogismi72, è evidente nel primo progetto del personaggio ombroso di Borges: il
Ibidem, pp. 103-104.
Ibidem, p. 104.
71
Con maggiore precisione: nelle fluttuazione dell’alone semantico abbiamo i seguenti
caratteri: «1)aumento dell’alone semantico di un segno, di una classe di segni, del discorso: parole, frasi o discorsi ambigui, indeterminati, propriamente astratti; 2)restringimento
dell’alone semantico: linguaggio pseudo-astratto, pseudo-metaforico, formalmente astratto»;
nella distorsione semantica: «1)paralogismi; 2)neologismi; 3)linguaggi neologici; 4)forme parcellari; alterazioni fonetiche e verbostrutturali»; per la dispersione semantica: «1)astrazionismo sistematico “a vuoto”; 2)incoerenza, insalata di parole, verbigerazioni; 3)interpretazione
filologica; 4)agrammatismo, paragrammatismo, asintassia; 5)acatafasia; 6)forme attenuate»;
nella dissoluzione semantica, l’ultimo stadio: «1)impulsi verbali; 2)stereotipie verbali; 3)ecolalia; 4)cantilene, litanie verbigeratorie declamatorie; 5)glossomania» (S. Piro, p. 325, op. cit.).
72
I paralogismi, in senso psichiatrico, sono parole che hanno un significato, ma che vengono utilizzate in modo diverso da come dovrebbero. A differenza dei neologismi i paralogismi non sono parole inventate dallo schizofrenico. Esistono diversi tipi di paralogismi, alcuni fanno riferimento a una traslazione semantica, questi «denunciano, ad esempio, in modo
molto netto l’esclusiva impronta semantica del fenomeno: in questi casi il pensiero sembra
abbastanza corretto, mentre l’espressione verbale di esso è visibilmente distorta» (ibidem, p.
476). Può inoltre accadere che la traslazione del significato non sia semantica bensì fonetica,
avvenga cioè «più per analogie fonetiche che per concatenazione di significati vicini» (ibidem).
69
70
Dalla Daseinsanalyse alla psicosi determinista: Binswanger e Borges
93
sintagma “Máximo Perez”, in luogo di settemilatredici, non è altro che un paralogismo, così come lo sono tutti gli altri “numeri” di Funes.
Tale caratteristica del linguaggio si sovrappone alla seconda caratteristica,
che è invece propria del successivo progetto del memorioso Funes. Il ricordare
infatti ogni cosa come diversa, in base all’istante e all’angolatura dalla quale la
si guarda o la si percepisce, può essere collegato a quella che, con Binswanger,
chiamiamo frattura eidetica73. La frattura eidetica può essere distinta a sua volta in due categorie più specifiche, entrambe simili ma contrarie. La prima, di
cui si è già discusso in precedenza, è quella del maniaco che esperisce l’altro
ma non l’alterità, cioè l’èidos di alterità74, la seconda è quella che si propone
per Funes. Essa consiste nell’esperire distintamente tutte le possibilità di mutamento dell’ente, tutte le sue rappresentazioni, le metabolài, ma non riuscire
ad associarle a un’immagine eidetica uniforme e generalizzata. Nel primo caso
abbiamo una chiusura immobilizzante, nel secondo una innumerevole apertura alle immagini eidetiche altrettanto immobilizzanti, data l’impossibilità di
sintesi che ne consegue. È la mnème il momento eidetico fallace nell’esperire di
Funes, che non riesce a dare una regolazione definitiva alle cose, agli enti, alle
loro rappresentazioni e alle loro diverse modalità di apparizione. Tutto appare
in lui come un indistinto calderone di significati. Tale mancanza, che si struttura nelle complesse articolazioni della frattura eidetica, permette a Funes di
elaborare quella enumerazione esclusivamente sua.
La corsa dei due progetti dello psicotico personaggio ideato da Borges tende
da una parte all’infinito, nel caso dell’enumerazione, perché, essendo infiniti,
i numeri abbisognano di un’infinità di nomi; dall’altra parte tende alla standardizzazione dell’infinito stesso, nella misura in cui la sistematizzazione della
memoria in un archivio limitato è per Funes un obiettivo irraggiungibile. I suoi
ricordi tendono infatti all’infinito perché, data l’intima loro essenza annegata
nella frattura eidetica, non possono essere tutti analizzati dallo stesso psicotico.
Funes ammette, con la consapevolezza dell’interminabilità del proprio intento:
«Ho più ricordi io da solo, di quanti non ne avranno avuti tutti gli uomini insieme, da che mondo è mondo»75. Il progetto di Funes è paradossale perché, come
i paradossi, presuppone un’infinita sequenza di presenti attuali, i suoi ricordi
non passano infatti al vaglio del momento regolativo della mnème, e per questo
Altre volte, ed è il caso soprattutto degli ebefrenici, il paralogismo avviene attraverso una concatenazione semantica che è molto simile allo scherzo e ai giochi di parole.
73
L. Binswanger, 1965, passim, op. cit.
74
L. Binswanger, 1960, p. 83, op. cit.
75
J. L. Borges, 1944, p. 103, op. cit.
94
Livio Santoro
si presentificano costantemente nell’esperire psicotico. La successione intersoggettiva della temporalizzazione non appartiene all’esperire di Funes poiché
egli è costretto a vivere segregato in casa dal momento dell’incidente. Vedere
quotidianamente il mondo, esperirlo, sarebbe per lui una pena devastante, lo
sovraccaricherebbe di un’infinità di nuovi ricordi, e lo costringerebbe a classificarli accanto a quegli altri che già lo pervadono come padroni della sua individualità.
Funes è schiavo della sua stessa memoria, vive la sua irriducibile individualità come una rarissima versione del Dasein, vive abbandonato alla messe
irraggiungibile, in quanto irriducibile, di ricordi e di elaborazioni degli stessi:
«Il presente era quasi intollerabile tanto era ricco e nitido, e così pure i ricordi
più antichi e banali»76. La chiusura nell’autismo è una naturale conseguenza
della insostenibilità della pena. Funes non riesce a stanziare nel suo presente, il
momento husserliano è soggiogato, Funes vive in balia delle rappresentazioni
dei ricordi sempre attualizzate.
In questa chiave il secondo progetto di Funes, quello dell’archivio dei ricordi, appare come una richiesta del protagonista alla presentificazione, una
richiesta che, vista l’impossibilità di arginare il pullulare della memoria, cerca
una mediazione tra l’infinito e la finitezza. L’opera è però impossibile, rimanendo perciò incompiuta, già nelle intenzioni iniziali di Funes. Questo non è che
un altro elemento che Funes condivide con la personalità dello psicotico; il suo
secondo progetto, e in misura minore il primo, sono entrambi delle fissazioni
che lo costringono come l’esaltato a essere loro schiavo. Il primo progetto è
meno fissazione del secondo in quanto, almeno, conserva una certa affinità con
l’esperire intersoggettivo. L’essenza dell’enumerazione è infatti infinita, come
infinita è la serie numerica che Funes si impegna a convertire in segni, in paralogismi.
Nella parola e nel ricordo delle cose esiste la distanza che separa Funes dagli
altri. L’esperire di Ireneo è assoggettato alla sua fissazione, egli vive una condizione orrorifica, annegata com’è nel senso del terribile. Il suo Progetto-di-mondo
è ingombrante, tanto che ogni attività gli è preclusa al punto che «gli era molto
difficile dormire. Dormire è distrarsi dal mondo; Funes, sdraiato sulla sua branda, nel buio, si figurava ogni scalfittura e ogni rilievo delle case precise che lo
circondavano»77.
Ibidem, p. 102.
Ibidem, p. 105. La distanza di Funes dal linguaggio dell’intersoggettività si oggettivizza,
nell’opera di Borges, nella testimonianza affidata alla lingua di Tlön, un paese immaginifico
dove non «esistono sostantivi; esistono verbi impersonali, qualificati da suffissi (o prefissi)
76
77
Dalla Daseinsanalyse alla psicosi determinista: Binswanger e Borges
95
Gli abitanti di Babele, l’enorme biblioteca. Le prospettive innumerevoli
Se può esistere un luogo come Tlön (cfr. nota 77), non si può negare la
possibilità di esistenza di un altro luogo squisitamente borgesiano. Un luogo fatto di un numero di esagoni illimitato, all’interno dei quali esistono
innumerevoli copie di libri della stessa grandezza. Il mondo di Babele è una
biblioteca interminabile. I libri di questa biblioteca contengono, ognuno in
quattrocento pagine, tutte le combinazioni possibili di venticinque simboli:
ventidue lettere dell’alfabeto più il punto, la virgola e lo spazio. Non è dato
sapere da chi sono stati scritti questi libri, ma gli abitanti della biblioteca
cercano di decifrarli.
I lettori vagano, errano all’interno delle stanze esagonali della biblioteca
alla ricerca delle “Vendicazioni”, «libri di apologia e di profezia che giustificavano per sempre gli atti di ciascun uomo dell’universo e serbavano arcani
prodigiosi per il suo futuro»78. Tale ricerca è interminabile, e la soluzione
prossima allo zero, in quanto la biblioteca contiene tutte le possibili combinazioni dei venticinque simboli: da un libro con quattrocento pagine di a,
ad uno con quattrocento pagine di z, tra gli estremi un numero di libri che
si approssima all’infinito.
Ovviamente la possibilità di trovare tutto nella biblioteca considera la
possibilità di trovare qualsiasi testo in tutte le lingue, quelle conosciute e
quelle non conosciute. Molti libri sono altresì indecifrabili, la successione
dei loro simboli non appartiene ad alcuna lingua, né passata né futura.
monosillabici con valore avverbiale […] sorse la luna sul fiume [a Tlön] si dice hlör u fang
axaxaxas mlö, cioè, nell’ordine: verso su (upward) dietro semprefluire luneggiò» (J. L. Borges, 1941, p. 14, op. cit.). Questa particolare forma linguistica sarebbe diffusa nell’emisfero
australe di Orbis Tertius, dove si trova Tlön, nell’emisfero boreale, invece, non è più il verbo
l’elemento fondamentale della grammatica, bensì l’aggettivo. Lì si dice in luogo di luna «aereochiaro sopra scuro-rotondo, o aranciato-tenue-dell’altoceleste» (ibidem); si utilizzano cioè degli aggregati di aggettivi, per dire qualsiasi cosa. Se Funes era uno e usava nel suo linguaggio
i paralogismi, a Tlön un popolo intero utilizza un linguaggio neologistico, e lo utilizza, naturalmente, in maniera intersoggettiva. È la sostanza del tempo che, anche a Tlön, modifica le
dinamiche linguistiche, infatti il mondo, per gli abitanti di Tlön, «non è un concorso di oggetti
nello spazio; è [invece] una serie eterogenea di atti indipendenti; è successivo, temporale, non
spaziale» (ibidem). Se a Tlön, dunque, si concepisce «l’universo come una serie di processi
mentali, che non si svolgono nello spazio, ma successivamente, nel tempo» (ibidem, p. 15) ne
consegue che la spiegazione è lì cosa impossibile. Dato che non si concepisce che lo spaziale
perduri nel tempo, «spiegare (o giudicare) un fatto, è unirlo a un altro fatto; ma quest’unione,
su Tlön, corrisponde a uno stato posteriore del soggetto, e non s’applica allo stato anteriore,
dunque non lo illumina». Per cui «ogni stato mentale è irriducibile: il solo fatto di nominarlo – id est, di classificarlo – comporta una falsificazione» (ibidem, pp. 15-16). Torniamo così
all’irriducibilità di cui parlavamo per il singolo Funes.
78
Ibidem, pp. 73-74.
96
Livio Santoro
Babele è il crogiuolo delle lingue, e in quanto tale lì la comunicazione è
fortemente compromessa. Se nell’Orbius Tertius la lingua di soli aggettivi e
quella di verbi e avverbi faceva parlare di linguaggio neologistico, e se Funes invece utilizzava un linguaggio paralogistico, a Babele tutti i linguaggi
esistono, quello di Funes, quello di Orbius Tertius australe e boreale, il nostro e tutti gli altri linguaggi e non linguaggi79.
La biblioteca di Babele è un caleidoscopio di possibilità dell’esistenza
di darsi, se nella lingua vi è l’espressione dell’esistenza. Dunque si può assumere che qualsiasi esperire è valido per se stesso all’interno della biblioteca. La biblioteca contiene sicuramente anche il libro di sabbia, la sua
confutazione e la confutazione di questa confutazione, e così oltre. In essa
sussistono parimenti linguaggi glossolalici, ebefrenici, paranoidi, neologistici, paralogistici, etc.
Per questo la biblioteca è un labirinto, nonostante la sua struttura simmetrica. Infatti «l’universo (che altri chiama la Biblioteca) si compone di
un numero indefinito, e forse infinito, di gallerie esagonali, con vasti pozzi
di ventilazione nel mezzo, bordati di basse ringhiere»80. La simmetria diventa labirintica quando è accompagnata dal disordine. Il disordine della
Biblioteca è infatti un disordine più “metafisico” che strutturale, esiste nei
libri e nelle parole indecifrabili che vi sono scritte.
L’essenza silenziosamente innumerevole della biblioteca genera essenze
costitutive, ma solo nella misura in cui sono tutte valide, come nessuna in
fondo lo è se non per se stessa. I lettori della biblioteca sono rinchiusi all’in79
A questa concezione innumerevole del linguaggio Borges abitua il suo lettore in tutte
le sue opere. È importante notare come tale caratteristica non sia esclusiva solo di questi
racconti citati, ma che appartenga a tutta la speculazione borgesiana. Spesso infatti tale formulazione molteplice del linguaggio si risolve in un’affermazione di estremo soggettivismo.
Va ricordato il caso del racconto Undr, in cui un pellegrino, Adamo di Berna, si arrischia in
un viaggio tra alcune tribù germaniche nelle quali esiste il culto della Parola. La Parola è tutto
ma è impronunciabile, dunque non può neanche essere udita. Dopo innumerevoli tentativi
Adamo riesce ad ascoltarla dal re di quei germani, ma non può ricordarla. Diversi anni dopo
gli viene nuovamente rivelata, e tale Parola è Undr. Undr (che significa meraviglia) è la parola
che contiene tutte le cose, che è tutte le cose. Adamo allora cerca di ripeterla, e, nel farlo, ripete
un’altra parola, che è anch’essa la Parola. Così colui il quale per la seconda volta aveva rivelato
la Parola ad Adamo di Berna sentendo che questi la ripeteva, ma ripeteva una parola differente
gli dice «va bene […] mi hai capito» (J. L. Borges, 1975, p. 73, op. cit.). La sostanza di questa
parola, di Undr e di quella pronunciata da Adamo è la pura irriducibilità del Dasein soggettivo.
Ognuno ha infatti la propria parola in quanto il suo Dasein è irriducibile, la parola rispecchia
ogni soggettività, è di ogni soggettività. In questo modo come accade per la fenomenologia di
Jaspers si rivendica l’impossibilità di comprendere soggettivamente i fenomeni vissuti, poiché
questi determinati fenomeni sono riducibili esclusivamente all’esperire soggettivo di chi li ha
vissuti.
80
J.L. Borges, 1941, p. 69, op. cit.
Dalla Daseinsanalyse alla psicosi determinista: Binswanger e Borges
97
terno della loro fissazione, la ricerca delle “Vendicazioni”.
«La Biblioteca è totale», al suo interno vi si può trovare «tutto: la storia
minuziosa dell’avvenire, le autobiografie degli arcangeli, il catalogo fedele
della Biblioteca, migliaia e migliaia di cataloghi falsi, la dimostrazione della falsità di questi cataloghi, la dimostrazione della falsità del catalogo autentico, l’evangelo gnostico di Basilide, il commento di questo evangelo, il
commento del commento di questo evangelo, il resoconto veridico della tua
morte, la traduzione di ogni libro in tutte le lingue, le interpolazioni di ogni
libro in tutti i libri»81. Tale caratteristica fa della biblioteca il labirinto più
completo dell’opera del poeta argentino, in quanto si sviluppa su un piano
puramente concettuale.
Nella biblioteca tutto è sostenuto e confutato in tutte le lingue e, come
sostiene un pensatore della biblioteca, cui ci si rifà per una sua interpretazione, «non vi sono, nella vasta Biblioteca, due soli libri identici» 82.
Schiavi di questo innumerevole numero di affermazioni e di confutazioni gli abitanti della biblioteca vivono deietti in una dimensione inconciliabile con qualsiasi autenticità del Dasein. La loro presenza si dispiega
in una successione di istanti, che questa volta sono i libri. In definitiva
gli abitanti della biblioteca non intravedono mai la possibilità di risolvere
la propria situazione. Per cui è come se la loro presenza non potesse vivere autenticamente. Come infatti si ricorderà la presenza dovrebbe vivere,
in base alle affermazioni di Heidegger, nella triadicità dei suoi momenti come «sopravvenire (Ankommen) del non-ancora-presente, […] esserestato (Gewesen) del non-più-presente e […] presente stesso» 83. Se nessun
libro, dunque nessun momento, è valido per gli abitanti della Biblioteca,
questi non possono nemmeno vivere un’autentica presenza.
L’Aleph, figura eidetica archetipica
Questo lavoro può, in definitiva, essere letto seguendo la scoperta
dell’Aleph: «Improvvisamente compresi il pericolo che correvo: m’ero lasciato sotterrare da un pazzo, dopo aver bevuto un veleno. [Questi] per
difendere il suo delirio, doveva uccidermi. Sentii un confuso malessere, che
Ibidem, p. 73.
Ibidem.
83
M. Heidegger, 1963, p. 119, op. cit.
81
82
98
Livio Santoro
volli attribuire alla rigidità, e non all’effetto di un narcotico. Chiusi gli occhi, li riaprii. Allora vidi l’Aleph»84. La sostanza dell’Aleph è la sostanza
dell’Innumerevole, «il diametro dell’Aleph sarà stato di due o tre centimetri, ma lo spazio cosmico vi era contenuto, senza che la vastità ne soffrisse.
Ogni cosa (il cristallo dello specchio, ad esempio) era infinite cose, perché
io la vedevo distintamente da tutti i punti dell’universo»85.
L’Aleph è tutte le cose, e tutte le cose sono rappresentate nell’Aleph. In
questo punto indistinto dello spazio che Borges chiama Aleph c’è l’essenza
forte, specifica del prospettivismo del poeta argentino.
La scoperta di questo caleidoscopico tratto dell’universo ha accompagnato la presente ricerca configurando costantemente uno schema triadico.
Nel primo momento l’incontro con la pazzia genera un sentimento di paura e di dolore nel protagonista del racconto. In seconda battuta tale follia
viene assunta come possibilità dell’esistenza nell’atto di chiudere gli occhi
davanti alle possibilità. Nel terzo si configura il riconoscimento dell’infinità prospettica dell’Aleph stesso. In esso si trova ogni cosa e ogni tempo
e si prospetta dunque la soluzione fenomenologica. Questa soluzione può
essere compresa riprendendo l’interpretazione di Heidegger del concetto
preliminare di fenomenologia: «Se esaminiamo concretamente i risultati
dell’interpretazione di “fenomeno” e di “logos”, salta subito agli occhi l’intima connessione che li stringe. L’espressione fenomenologia può essere
formulata come segue in greco: le#gei ta# faino#mena, dove le#gei significa
apofai#nestai. Fenomenologia significa dunque apofai#nestai ta# faino#mena#:
lasciar vedere da se stesso ciò che si manifesta, così come si manifesta da
se stesso. Questo è il senso formale dell’indagine che si autodefinisce fenomenologia. Ma in tal modo non si fa che esprimere la massima formulata
più sopra: “Alle cose stesse!”»86.
Nell’Aleph dunque c’è l’interpretazione delle cose operata dal sano e
quella operata dallo psicotico, entrambe vi convivono come possibilità
dell’esistenza di darsi. Il metodo fenomenologico, grazie alla sua affermazione di essere privo di presupposti, permette di affermare l’innumerevole
molteplicità delle esperienze. Tutte le cose presenti nell’Aleph, e tutti i caratteri dei personaggi di Borges e degli psicotici, sono «ciò che oggi possiamo chiamare modalità dell’esistenza o dell’essere-nel-mondo […] e che
J. L. Borges, 1952, p. 164, op. cit.
Ibidem, p. 165.
86
M. Heidegger, Sein und Zeit, 1927, trad. it. di P. Chiodi Essere e tempo, Longanesi, Milano, 1971, p. 50.
84
85
Dalla Daseinsanalyse alla psicosi determinista: Binswanger e Borges
99
possiamo cercare di comprendere e di interpretare per vie antropoanalitiche
[daseinsanalitiche]»87.
Con gli apporti di Jorge Luis Borges e Ludwig Binswanger si afferma definitivamente quella fondamentale questione per cui nulla è edificabile sulla
pietra, ma tutto lo è sulla sabbia. Il metodo fenomenologico-daseinsanalitico
che entrambi, a parere di chi scrive, utilizzano è un fondamentale indicatore
nell’analisi della presa di coscienza della fissazione psicotica che si è sostenuto
essere alla base dei determinismi e degli idealismi di ogni tempo.
87
L. Binswanger, 1956, p. 45, op. cit.
Il concetto estetico di ripetizione tra mistica e metodo
101
Il concetto estetico di ripetizione tra mistica e metodo
Memoria di Luigi Buonaiuto
presentata dal socio naz. ord. res. Aldo Trione
(seduta del 27 marzo 2008)
Abstract. The concept of Repetition like essence of the aesthetic work; whit Blanchot, Steiner and Gadamer, that even though they not interested in special way to Repetition ontology they expose a lucid and in-depth criticism of her, we propose a view of the
varied approach to this question; from the approach full of poetical pathos of Maurice
Blanchot that we define “mystical” to the approach critical-hermeneutic of Gadamer,
true example of scientific methodology applied to the art work, passing for Georg Steiner
and him aesthetic grammatology that will be trait d’union between the two previous and
opposite formulation. The objective is: to assert the scientific nature of the aesthetic
research without to omit the real ineluctability of the irrational component in aesthetic
semantics; the objective is: to assert the double phenomenology acting in the human and
the ontological increasing of the Mediation concept deriving.
L’estetica ha spesso trovato nel concetto di ripetizione un utile alleato
capace di fornirle interessanti spunti di indagine. Alcuni tra i più influenti
teorici dell’arte del secolo scorso hanno scovato proprio nel concetto di ripetizione la possibilità di intavolare un discorso sull’estetica capace di esulare
dalla troppo generica e fatalista idea di genio, ovvero la possibilità di studiare la semantica dell’arte con un vivo interesse critico capace di valutare
il problema estetico tenendo conto di tutte le variabili in gioco, non dunque
ricollegando l’ontologia dell’opera alla sola semantica del genio (il poeta
vate posseduto dal divino e strumento della sua voce) né tanto meno alla
sola idea materialista dell’opera d’arte come esempio riuscito di applicazione tecnica.
Attraverso le voci di alcuni teorici dell’estetica presentiamo qui un percorso
incentrato sul concetto estetico della ripetizione strutturato in modo da fornire
una spirale progressista di tale problema.
La prima costante del nostro percorso rappresenta quello che potremmo
definire: un accrescimento di metodo, ovvero un costante affinamento delle tecniche di ricerca atte a favorire l’indagine stessa; accrescimento di metodo sta ad
102
Luigi Buonaiuto
indicare qui la capacità di affrontare un problema scovando, passo dopo passo,
tutte quelle che possono essere considerate le variabili attivamente presenti in
una determinata esperienza.
La moltitudine delle variabili attivamente presenti ed in rapporto tra loro
introduce alla seconda costante del nostro percorso: un accrescimento della portata ontologica del concetto di mediazione ovvero la superiorità cognitiva del
processo mediale rispetto a quella delle singole parti attive in esso.
L’altra costante del percorso è ancora una volta considerabile una diretta
escatologia della costante precedente: un approfondimento del concetto di potenza/impotenza; sembra infatti tautologico ricordare qui che un vero processo
mediale può essere considerato tale solo qualora, in esso, le variabili attive si
presentano aprioristicamente sia come entità dotate della capacità, e quindi
del potere, di influenzare e modificare il processo in cui entrano a far parte, sia
come entità influenzabili e modificabili, che possono dunque risultare impotenti rispetto al processo stesso.
L’ultima costante del nostro percorso è: un approfondimento del problema
storico che, alla luce dei suddetti punti, sarà considerato alla stregua del campo
da gioco in cui appunto metodo, mediazione e potenza/impotenza sono gettati
ma non già passivamente assoggettati. Approfondimento del problema storico
dunque metodologicamente indagato in tutti i suoi aspetti costitutivi quali: il
passato, con la sua costanza e la sua potenza sempre rinnovabile, il presente,
con la sua instabilità e la sua volontà di potenza tesa alla propria affermazione all’interno del problema storico più generale, ed il futuro, con la sua ignota
ma sempre ancora conoscibile caratteristica di essere custode sia ideale che
reale dei parti di ogni mediazione. Ed è proprio sul concetto di futuro, di a venire, che sarà possibile ricollegare tutto quanto detto fin ora con la semantica
dell’opera estetica, della sua interpretazione e della sua seducente e problematica parentela con il concetto di assenza.
La mistica della ripetizione
Un interessante tentativo di definire il concetto di ripetizione come genuina
essenza della creazione estetica è quello proposto da Maurice Blanchot; la sua
idea della poiesis come inviolabile residenza dell’ignoto e la teorizzazione del
neutro come unico metodo di approccio veritiero a tale semantica suggeriscono al critico francese un drastico cambio di prospettiva rispetto al tradizionale
concetto di dialettica hegeliana di identità: la poiesis non è più questione di po-
Il concetto estetico di ripetizione tra mistica e metodo
103
tenza, possibilità ed unicità quanto piuttosto esempio lampante di impotenza,
impossibilità ed impersonalità (da intendere qui come pluralità di personalità).
Il punto di partenza di Blanchot è il vero dialogo tra due interlocutori, dialogo attraverso il quale viene alla luce la differenziazione tra teoria dello sviluppo
e teoria della ripetizione, questa poi, se applicata all’estetica della poesia ed
alla sua interpretazione, conduce all’affermazione del mistico carattere neutro della creazione estetica, definita nella sua essenza come infinita ripetizione
dell’ignoto.
1. Il vero dialogo.
Quasi tutti i dialoghi tra due persone consistono nel raddoppiare la stessa
affermazione, afferma Blanchot, non c’è alcuno sviluppo nella loro dialettica
di domanda e risposta, non c’è contrapposizione, non si modifica nulla, eppure
alla fine risulta chiaro che il primo interlocutore impara infinite cose dalla sua
stessa parola ripetuta dall’altro, e non in virtù dell’accordo e dell’adesione, ma
al contrario per l’infinita differenza: avendo infatti riformulato in quanto altro
ciò che aveva detto come io in prima persona è come se fosse stato trasportato
nell’ignoto stesso del proprio pensiero, là dove esso, senza alterarsi, diveniva
pensiero assolutamente diverso.
Dopo aver ascoltato un dialogo del genere, secondo Blanchot, capiamo che
gli uomini non dovrebbero temere la ripetizione, in quanto essa non è il mezzo
per convincere con l’ostinazione e la pre-potenza, ma è la prova che un pensiero, anche se ripetuto, in realtà non si ripete; “la ripetizione fa semplicemente
entrare ciò che si dice nella sua differenza essenziale1”.
Per Blanchot, nel vero dialogo, l’unica costante che accomuna i due interlocutori interessati è l’impulso a volgersi insieme verso l’infinito della parola,
un impulso che contiene in sé l’essenza della parola conservazione, un impulso
neutrale dunque scevro da ogni potenza individuale.
Dire due volte la stessa parola dunque non è amore per l’identità ma rifiuto
dell’identità, perché la stessa parola ripetendosi in un dialogo, subendo uno
spostamento tra l’uno e l’altro, si sviluppa come in se stessa innalzandosi alla
sua vera ignota essenza neutra.
1
M. Blanchot, L’infinito intrattenimento, trad. it. di R. Ferrara, ed. Einaudi, Torino 1977,
p. 455.
104
Luigi Buonaiuto
2. Pensiero che si sviluppa e pensiero che si ripete.
I pensieri che si sviluppano, scrive Blanchot, sono pensieri che si impongono
in virtù delle coordinate storiche in cui si svolgono, tali coordinate non sono mai
solo intellettuali ma sempre anche politiche e sociali; i pensieri che si sviluppano
non si sviluppano secondo le proprie ragioni ontologiche, ma cercano sempre
l’alleanza con l’esterno e la conformità con il nostro ideale di cultura vigente.
I veri pensieri sono invece pensieri di rifiuto, “rifiuto del pensiero naturale e
dell’ordine legale ed economico che si impone come una seconda natura, rifiuto
della spontaneità che, mentre pretende di essere un atto di libertà, è semplicemente un atto abituale, senza ricerca e senza precauzioni2”.
Nella legge dello sviluppo Blanchot vede la chimera della volontà di potenza;
la categoria della potenza, insita nella ragione dialettica, che tutto pretende di
comprendere in sé, è ritenuta inabile ad indagare la nozione neutra di ignoto
che invece può essere compresa nella sua vera essenza soltanto attraverso la
categoria dell’impotenza, attraverso un approccio neutro che, lungi dal voler
tradurre in noto l’ignoto, lo lascia libero di essere quello che è, ignoto, tutelandolo nella sua mistica invisibilità.
E dunque “i veri pensieri non si sviluppano non perché siano immutabili,
eterni e perfetti nella loro formulazione unica, ma perché non tendono a imporsi. Non sono affermazioni di autorità che disprezzano la prova ed esigono
l’obbedienza cieca, al contrario si ribellano alla violenza insita nell’arte di dimostrare e di argomentare3”.
“Nello sviluppo c’è la pretesa di conservare la parola con l’abbondanza…
di un continuum logicamente organizzato (secondo una logica che si ritiene
l’unica giusta), in modo da avere l’ultima parola. La parola che si ripete, invece, rinuncia a priori all’ultima parola, sia perché si suppone già pronunciata,
sia perché parlare equivale ad ammettere che la parola è necessariamente plurale, frammentaria, capace di mantenere sempre, al di là dell’unificazione, la
differenza”4.
3. A rose is a rose.
Poesia e letteratura sono, secondo Blanchot, esempi lampanti di semantiche
che non tollerano l’insistenza di un significato o di un insieme di significati già
Ivi, p. 453.
Ibidem.
4
Ivi, p. 454.
2
3
Il concetto estetico di ripetizione tra mistica e metodo
105
costituiti ed organizzati secondo la coerenza di un discorso unicamente logico.
Nella poesia e nella letteratura tutti i tentativi di espressione possono essere
considerati a rigore come dei veri e propri rifiuti delle risorse dello sviluppo,
scrivere è sempre scrivere senza sviluppare, scrivere è sempre scrivere ripetendo.
Blanchot prende ad esempio un verso di Gertrude Stein: A rose is a rose is
a rose is a rose, questo verso da un lato dice che a proposito di una rosa non
si può dire altro che è la rosa stessa e per questo la dichiara più bella che se
l’avesse chiamata bella, ma d’altra parte con l’ossessività della ripetizione la
spoglia della dignità di un nome unico che l’avrebbe definita nella sua bellezza
essenziale; qui il pensiero di rosa resiste ad ogni sviluppo, è resistenza pura,
manifestazione di quella parola ignota che parla senza inizio né fine semplicemente ripetendosi.
4. La portata ontologica dell’interpretazione.
Per parola che interpreta “si intende una ripetizione dell’opera… ma ripeterla significa cogliere – intendere – in essa la ripetizione che la istituisce come
opera unica”5; questa ripetizione non è l’imitazione di un modello, la duplicazione è di un altro tipo ed è strettamente collegata al tempo futuro: l’opera dice
ciò che dice tacendo qualcosa, c’è nell’opera un vuoto costitutivo a partire dal
quale l’opera, anche se già detta in modo perfetto ed impossibile a ridirsi, tende
irresistibilmente a ripetersi esigendo l’infinita parola dell’interprete che un giorno finalmente saprà mettere fine al silenzio che le è proprio.
La ripetizione del libro ad opera dell’interpretazione “è il processo grazie al
quale una nuova parola, nuova eppure la stessa, introducendosi nella mancanza
che fa parlare l’opera, ha la pretesa di riempirla, di colmarla. Questa parola ha
la sua importanza: si saprà finalmente che pensare”6, tuttavia la parola dell’interpretazione, essendo rivelatrice e riempitiva, è anche una parola usurpatrice:
l’interprete, chiudendo tutti gli interstizi, completa l’opera con questa parola
esaustiva, ma, avendo soppresso il suo spazio di risonanza, avendo violato la
sua identità di scrigno dell’ignoto (traslando l’ignoto in noto), la rende muta e
di conseguenza è esso stesso colpito dal mutismo.
Oppure, afferma Blanchot, può avvenire che l’interprete “nel ripetere l’opera, si limiti a ripeterla a partire da quella distanza che ne costituisca la riserva
5
6
Ivi, p. 517.
Ibidem.
106
Luigi Buonaiuto
e, invece di ostruirla, la lasci anzi vuota, sia per averla indicata circoscrivendola da molto lontano, sia per averne reso l’ambiguità con un’interrogazione che
sarà tanto più ambigua in quanto contiene l’ambiguità, si riferisce ad essa e
finisce per disperdervisi7”.
La realtà dei fatti è evidente per tutti: più un’opera si interpreta, più richiede interpretazioni; “più un’opera intrattiene con il proprio centro rapporti di
riflessione (di raddoppiamento), più si rende enigmatica per questo stesso dualismo8”. È in questo enigmatico raddoppiamento che Blanchot vede l’essenza
della poiesis, nel fatto che la letteratura non si accontenta mai di ciò che legge
ma continua imperterrita a sostituirvi un altro libro che a sua volta ne provocherà un altro; per il teorico francese il libro non può essere definito un racconto immediato quanto piuttosto un confronto di questo racconto con tutti gli
altri dello stesso tipo i quali già occupano l’area letteraria di cui esso vorrebbe
prendere il posto; allo stesso tempo l’eroe di un racconto non può fare altro che
ripetere le gesta di tutti gli eroi che lo hanno preceduto nello infinito spazio letterario, dunque ogni libro, più che l’opera unica ed originaria di uno scrittore
solitario è “una specie di palinsesto in cui possono leggersi giustapposte, intrecciate assieme e talvolta distinte, tutte le versioni di un’avventura millenaria,9”
quella dell’uomo, del mondo e dei loro poliedrici rapporti.
Scrivendo e ponendosi la questione dello scrivere l’autore deve misurarsi
con tremila anni di scrittura, l’essenziale di ogni racconto non sta nell’andare
da un luogo a un altro, da un’avventura ad un’altra, ma da un’interpretazione
ad un’altra, da un interprete ad un altro, ascoltandoli tutti con estrema attenzione ed intavolando un dialogo con ognuno di essi; il racconto non è costituito
da una serie più o meno coerente di eventi, ma da una serie sempre più pingue di interpretazioni che si riferiscono solo alla possibilità dell’interpretazione
stessa, la possibilità di scrivere (e di interpretare) al neutro l’ignoto di ogni racconto, la possibilità di ripetere il neutro gioco dell’ignoto stesso.
5. La mistica del neutro.
Blanchot conclude così: “Ogni pensiero, sviluppandosi, sia pure con concatenazioni rigorose, finisce sempre per presupporre nuovi postulati, incompatibili col postulato iniziale, di cui tuttavia ha bisogno per svilupparsi10”. “Si
Ibidem..
Ivi, p. 519.
9
Ivi, p. 520.
10
Ivi, p. 458.
7
8
Il concetto estetico di ripetizione tra mistica e metodo
107
ha un bell’andare a scovare le definizioni supreme che l’umanità ha messo a
punto da millenni per caratterizzare l’Unico… resta sempre il fatto che tutte
queste profonde identificazioni, anche le più sublimi e le più ricche che possiamo scegliere, invariabilmente ci deludono ancora”11 come se l’arte fosse sempre
infinitamente più di tutto questo, ossia anche infinitamente meno. “Che c’è insomma al di sopra della trascendenza, al di sotto di essa? Ebbene… qualcosa
che è tale che rispetto ad esso ogni valutazione, la più alta come la più bassa,
deroga. Insomma qualcosa che rende indifferente ogni possibilità di valutare, e
con essa ricusa tutti i custodi dei valori, celesti, terrestri o demoniaci che siano,
sia che la loro autorità si fondi sulla ragione o sulla super-ragione… decidiamo di chiamarlo col nome più modesto, il più schivo, il più neutro; decidiamo
di chiamarlo appunto neutro – infatti chiamarlo così equivale probabilmente,
anzi sicuramente, a disperderlo, ma ancora una volta a vantaggio del neutro…
la potenza sovrana non è né trascendente né immanente, ma neutra12”.
Ora, per quanto la ricerca blanchotiana tenti di svincolarsi dall’accusa di
irrazionalismo e misticismo, in virtù di una sorta di antropo-mistica tesa ad
affermare l’impersonalità (pluralità di identità) dell’uomo13, essa resta pur sempre segnata da un nominalismo eccessivamente e volontariamente compresso
sino al limite, che gioca più a favore del tropo dell’invisibilità che non piuttosto
a favore di una reale mediazione tra questo ed il tropo della visibilità.
Ciò che non ci sembra chiaro, tuttavia, in questa estetica della ripetizione, è
come l’autore intenda conciliare il postulato iniziale del suo saggio affermante
che i veri pensieri sono pensieri di rifiuto dell’ordine socio politico esterno e
l’affermazione che per scrivere, l’autore abbisogna di confrontarsi con tremila
anni di letteratura precedente; forse che tremila anni di letteratura, per il semplice fatto di essere letteratura, non possono essere considerate entità esterne allo spirito di un autore di letteratura? O forse si intende dire che tremila
anni di letteratura sono stati il parto unico ed eterno di un’unica spiritualità, di
quell’unico individuo scrivente che rivive e si ripete in ogni individuo scrivente
e che forte di una solitudine essenziale davvero può vantare di potersi definire
alieno dalle coordinate storiche in cui di volta in volta si trova ad abitare?
Ivi, p. 525.
Ivi, pp. 525-526.
13
Francesco Garritano (Sul Neutro; saggio su Maurice Blanchot, Ponte alle Grazie, Firenze, 1992) insiste sul fatto che la riflessione blanchotiana sulla scrittura non costituisce una
sorta di irrazionale fuga dal mondo in quanto la posta in gioco del testo di Blanchot è la messa
in discussione del discorso e del soggetto che lo tiene, messa in gioco tesa ad affermare non
il baratro del nichilismo ma il rifiuto dello stesso attraverso un movimento di contrazione e
limitazione della soggettività che è principio generativo tanto a livello estetico che morale.
11
12
108
Luigi Buonaiuto
Riteniamo senza ombra di dubbio interessante e fecondo di conseguenze il
porre in primo piano, all’interno della semantica estetica, la categoria dell’impotenza e la vena di misticismo in essa insita, tuttavia, consideriamo una carenza
di scientificità l’unicità della prospettiva che, seppur prendendo in esame una
componente fondamentale, quasi la innalza su un podio intangibile lasciando
cadere nell’oblio la categoria della potenza e soprattutto la reale mediazione o
scontro tra le varie entità in campo.
Ripetizione tra mistica e metodo
Georg Steiner ci fornisce un altro interessante esempio di estetica della ripetizione; il suo pensiero, rispetto a quello di Blanchot, prende in esame una più
articolata rosa di categorie attive nella semantica in questione: in prima istanza
l’ontologia della creazione estetica come mistica emulazione da parte dell’uomo
dell’operato divino, poi, attraverso l’interessante dialettica creazione-invenzione
(questa ultima intesa come ri-formulazione, ri-petizione) ed un abbozzo di una
fenomenologia della potenza, riesce ad intavolare un confronto estremamente
fruttifero di conseguenze tra estetica e scienza, fino a postulare la problematicità tutta moderna del concetto estetico e della verità di cui oggi tale concetto
possa rivendicare la detenzione.
1. Pendant Dio – Uomo, l’arte tra infinito e storicità.
Per Steiner la caratteristica fondamentale della natura dell’uomo è la sua
incapacità di concepire ciò che non ha un inizio; l’uomo è l’animale chiedente
che esplora senza tregua i confini del linguaggio e della coscienza nell’attesa di
ottenere una risposta riguardo al concetto di inizio.
La teologia, la filosofia e l’arte possono essere considerate un tentativo di
rispondere a questa domanda, la domanda sull’origine, ed in effetti, all’inizio,
ogni teologia ed ogni filosofia sono una narrazione ontologica, un tentativo di
spiegare l’origine dell’essere.
Anche la creazione estetica è un tentativo di rispondere alla domanda, domanda di tutte le domane, domanda sull’origine, di qui la naturalezza con cui
i creatori di poesia e di arte ricollegano consciamente o inconsciamente la loro
opera al precedente divino.
“Esiste un senso comune secondo il quale qualsiasi produzione umana o
atto estetico ha luogo nel tempo, questo tempo ha evidenti componenti stori-
Il concetto estetico di ripetizione tra mistica e metodo
109
che, sociali e psicologiche. Gran parte dell’arte dipende in modo dimostrabile
da fattori contingenti come la disponibilità di certi materiali, di codici convenzionali, di un pubblico potenziale anch’esso preso in un contesto temporale
preciso”14 ne consegue che la tanto ostentata solitudine essenziale del momento
creativo, in realtà, è ben lungi dall’essere una vera solitudine. La realtà è che
gli artisti prendono il ritmo l’uno dall’altro e soltanto l’idea aristotelica di Dio
può vantare la capacità di generare in una sorta di solitudine ontologica. Tuttavia, pur rendendoci conto che persino il più grande poeta opera all’interno
dei mezzi linguistici preesistenti e con essi, pur sapendo che non è creatore dei
suoi mezzi, pur sapendo che la creazione estetica è fondamentalmente storica
così come storico è il nostro modo di rapportarci ad essa e che la nostra cultura
considera a-storica solo la creazione divina, continuiamo a parlare di creazione, a insistere sull’analogia indefinibile con la creazione stessa, continuiamo ad
insistere sull’idea pregna di misticismo che l’opera d’arte possa essere identificata come una sorta di emulazione, ripetizione da parte dell’uomo dell’operato
divino.
2. Creazione ed Invenzione, volontà di potenza, il medium del linguaggio.
Per illuminare sulla differenza essenziale corrente tra i due tipi di operato
Steiner propone la dialettica creazione-invenzione; mentre “intorno a invenzione si fanno sempre più udibili le associazioni con simulazione, con fabbricazione, con escogitazione, che tendono a virare in direzione della falsità”15, alla
parola creazione associamo una nozione di primario, di originario ed autentico; per conseguenza a invenzione associamo una connotazione di secondario
rispetto a contenuti preesistenti, quelli della creazione. “Percepiamo la creazione come fondamentalmente superiore all’invenzione… il creatore supera l’inventore nelle gerarchie di valore16”.
La realtà è che tutte le elaborazioni umane, dunque anche quelle estetiche,
sono combinatorie, sono degli artefatti composti della selezione e combinazione di elementi preesistenti; queste combinazioni possono essere originali e
senza precedenti diretti ma, persino la più rivoluzionaria delle tecniche artistiche usa inevitabilmente un materiale esistente; allo stesso modo, il linguaggio
è interamente il proprio passato, ed ogni singola parola ci giunge con un carico
14
G. Steiner, Grammatiche della creazione, trad. it. di F. Restine, ed. Garzanti, Milano
2003, p. 69.
15
Ivi, p. 103.
16
Ivi, p. 107.
110
Luigi Buonaiuto
più o meno pesante di precedenti: questo passato determina e sovraccarica il
significato ed i significati di ogni parola di modo che, ontologicamente, quando
parliamo, più che pronunciare una parola, la stiamo ripetendo.
La storicità fa dell’opera estetica un perfetto esempio di invenzione, o anche
di re-invenzione, ripetizione di contenuti già esistenti, dunque perché si continua ad affermare che si crea arte, insistendo sulla somiglianza tra opera divina
ed opera umana? Perché è la creazione che la letteratura, e la poesia soprattutto, rivendicano con insistenza? Perché l’uomo artefice non accetta a-priori
questa sua condizione di impotenza nei confronti della storia, adeguandosi una
volta per tutte al proprio ruolo di eterno ripetitore di Dio o di se stesso?
Steiner fa notare che l’uomo artefice ha inevitabilmente da fare i conti con
la propria volontà di potenza: l’artista si oppone alle pretese dell’infinito ed alla
sua personale condizione di finitezza e tenta di intrappolare l’infinità del contenuto nelle configurazioni limitate dell’opera estetica; ciò è reso possibile dal
linguaggio, questi infatti universalizza, nega l’individualità; nel linguaggio, ciò
che la forma ha reso confinato e momentaneo, tende alla propria specie di universalità. “Grazie a un colpo di magia, la poesia restituisce alla vita, all’incommensurabilità del vissuto, ciò che l’astrazione e la riduzione a una forma locale
e temporanea le ha tolto.”17
La poesia assoluta si dichiara dunque come un paradosso radicale: essa
“vorrebbe sfuggire al fardello storico-sociale e all’elemento prefabbricato, al
ready-made della propria lingua. Nelle grandi poesie liriche c’è un amore-odio
per il linguaggio. Più precisamente, il poeta mira ad attraversare i confini della
sua lingua (di tutte le lingue) per essere veramente il primo ad essersi immerso
in quel mare silenzioso.”18
Se è possibile una pseudo-somiglianza tra uomo e Dio, questa si concretizza
nel linguaggio, nel suo essere mediazione tra contenuto e forma, poiché il finito
della forma contiene contenuti infiniti; l’infinito (a-storico), contenuto di una
forma (storica) finita, fornisce a questa ultima una certa a-storicità; dunque il
linguaggio come medium tra finito ed infinito, ripetendosi continuamente in
questa sua caratteristica mediazione permette di affermare che ci sono vestigia
o prefigurazioni di una creatività autentica nell’invenzione umana.
17
18
Ivi, p. 118.
Ivi, p. 175.
Il concetto estetico di ripetizione tra mistica e metodo
111
3. Poesia ed interpretazione, l’assenza, l’a venire (il valore del futuro).
“La creazione si lascia definire come la libertà attuata che include ed esprime nella sua incarnazione la presenza di ciò che in essa è assente”19.
La forza di persuasione della poesia assoluta implica la presenza latente di
ciò che non è (ancora): la poesia a venire e/o l’interpretazione a venire. Questa
poesia, questa interpretazione ancora da essere implicata nella poesia hic et
nunc, questa poesia/interpretazione assente, questa assenza, questa promessa
di una rivelazione incompleta ma sempre nascente, è il nodo cruciale dell’esperienza estetica, e lo è parimenti dell’esperienza religiosa e mistica.
La poesia è finita ma evoca l’infinito della creazione perché allude alla poesia/interpretazione futura che non è ancora, l’assoluto dalla poesia risiede nella
sua incompiutezza, la poesia è infinita solo perché la sua finitezza introduce
(onde ottenere finalmente compiutezza) alla poesia/interpretazione che sarà.
4. Scienza e Poiesis, sviluppo e ripetizione.
Nelle opere estetiche che si susseguono nel tempo sarebbe insita, come avviene nelle scienze, una spirale progressista che collega queste l’un l’altra: infinite nel complesso, finite se prese singolarmente; tuttavia, mentre il progresso
scientifico è strutturato sul concetto di superamento (un concetto che potremmo facilmente ricollegare allo sviluppo di cui parlava Blanchot), per cui l’invenzione scientifica di un secolo passato viene superata da quella del secolo successivo, e non avrà più alcuna ragion d’essere, nell’opera estetica “Cosa costituisce
un’avanzata rispetto a Omero?”20. Si può davvero affermare che oggi Omero è
stato superato da un altro poeta?
Il linguaggio è il solo mezzo della letteratura, della poesia, dunque questa,
più di qualsiasi altra forma estetica, suggerisce il concetto di perennità, di continua ripetizione. In questo senso sono presenti nell’estetica e nella poiesis una
storia in moto, una fenomenologia dell’aggiunta, dell’accumulo e della ripetizione che non hanno nulla in comune con il superamento scientifico.
Il poeta di oggi non supera Omero rendendolo obsoleto perché il poeta di
oggi non fa altro che ripetere Omero, ripeterlo nella finitezza della forma e
nell’infinità del contenuto, ripeterlo nell’incompletezza che attende di essere
completata dall’opera/interpretazione che è a venire.
19
20
Ivi, p. 124.
Ivi, p. 232.
112
Luigi Buonaiuto
Ri-petere significa chiedere di nuovo, una seconda, una terza, una centesima volta, chiedere alla poesia, al poeta del passato, di parlare ancora; ripetere
la poesia significa chiederle di renderci partecipi ancora una volta all’eternità
prefigurata e solo intuibile della sua incompiutezza.
Nelle arti, nella poesia e nella musica la ripetizione permette di eludere il
tempo; l’a-temporalità rispetto alla storia caratterizza la poiesis e l’interrogazione metafisica, e dunque “il facitore e il pensatore possono, se sono sufficientemente dotati, raggiungere la contemporaneità con i loro predecessori, con i loro
contemporanei e, enigma supremo, con le opere e le intuizioni del futuro21”.
Steiner, grazie al medium del linguaggio, può dunque identificare l’ontologia della poiesis come ripetizione della mediazione linguistica tra le rivendicazioni di potenza dell’infinito e quelle del finito.
5. Ripetizione mistica al vaglio della modernità.
Dall’analisi staineriana risulta chiara l’ineluttabilità di una componente mistica all’interno di un tentativo scrupolosamente metodologico di affrontare il
problema estetico; le Grammatiche della creazione del critico francese ci forniscono un perfetto esempio di mediazione tra teologia ed antropologia per
spiegare il fenomeno della creazione artistica; facciamo qui un vistoso passo in
avanti sia per quanto riguarda l’accrescimento del metodo e del valore del concetto di mediazione sia per quanto riguarda il riconoscimento della nozione di
potenza, tuttavia il libro di Steiner non si conclude qui, l’ultimo capitolo è tutto
pervaso da una sconcertante presa di coscienza rispetto alla quale non risulta
possibile fingere indifferenza.
Nella creazione estetica, scrive Steiner, le retoriche del genio, dell’a-temporalità, della solitudine essenziale e della perennità, sembrano postulare una
sorta di tempo fuori dal tempo che allontana vertiginosamente la semantica
estetica da quella della scienza e della storia; questo postulato ontologico della
creazione ha fornito per anni una ragione sufficiente per coloro che si occupavano di estetica dell’arte, tuttavia, i cambiamenti nell’esperienza della comunicazione, della conoscenza, della generazione del significato e della forma
sono oggi talmente tanti e ricchi di conseguenze che senza un riferimento a
queste stravolgenti alterazioni nell’ambiente e nei mezzi della coscienza umana
qualsiasi studio sulla creazione estetica sarebbe inopportuno e tacciabile di astoricità e carenza di metodo.
21
Ivi, p. 237.
Il concetto estetico di ripetizione tra mistica e metodo
113
Il linguaggio e la sua leggibilità hanno sempre permesso la trasmissione di
significati, l’enunciazione di messaggi e la loro interpretazione sono stati da
sempre una costante dello spirito umano, tuttavia può essere oggi possibile che
questa stabilità possa essere messa in forse, può esserci oggi la possibilità che
“l’animale linguistico che siamo stati, sin da quando l’antica Grecia ci ha definiti così, stia subendo una mutazione22”.
Ogni passo in avanti della scienza corrisponde ormai da lungo tempo ad
un passo in dietro della parola, più la scienza avanza più la poiesis si ritira nel
metaforico e nel letterario. In quella che Steiner definisce pornografia del rumore, la calma dell’isolamento (l’unico approccio possibile all’arte) diventa un
privilegio, nelle nostre società la solitudine è diventata rara se non addirittura
sospetta.
La democrazie ed i consumi di massa, con i loro ideali di conformità, di accettazione e di approvazione condannano la solitudine; la modernità è lo sgretolamento della solitudine: forse questa solitudine aveva i suoi presupposti ed
i suoi modelli religiosi che oggi non esistono più.
Il rimpicciolimento dello stampo spirituale del processo creativo è da inserire nello spostamento dall’individuale al collettivo; oggi il figurino del poeta in
preda alla sua solitudine essenziale è diventato imbarazzante.
Anche lo statuto della morte sta subendo trasformazioni radicali, il concetto di morte, dopo l’ultimo secolo, ma soprattutto dopo le recentissime vicende
politico-militari, è stato inevitabilmente inflazionato rispetto alla sua aurea spirituale originaria, si può ben considerare banalizzato. Il tropo dell’immortalità,
quello che per millenni ha spinto i creatori a creare, sta diventando sospetto; le
rivendicazioni di durevolezza che un autore ha per la propria opera sono oggi
degne di derisione.
Quale futuro per la poiesis in questo mondo che va a rotoli? Sembra chiedersi Steiner.
Noi, invero, ci poniamo una domanda diversa, ovvero: questa compianta
solitudine e questa volgare rumorosità della modernità sono davvero considerabili la chimera della poiesis, o piuttosto non sono queste semplicemente nuove variabili con le quali la creazione artistica e la sua storicità hanno oggi da
confrontarsi? Heidegger e l’heideggeriano Steiner non sono forse troppo convinti che l’ideale della comprensione e dunque della conoscenza siano possibili
soltanto nell’abissale radura della foresta nera che, lontana dal chiacchiericcio
della città, permetterebbe di poter ascoltare in solitudine la forza di alcune pa22
Ivi, p. 242.
114
Luigi Buonaiuto
role fondamentali? Non è forse un siffatto pensiero considerabile alla stregua di
un pregiudizio? Non si può ritenere questo pensiero un rifiuto, ancora troppo
blanchotiano, di mediazione? Un rifiuto del fatto che, defunti nella loro portata
originaria il tropo della solitudine e della morte, sia ancora possibile la poiesis?
Un rifiuto di mediazione con la storia che, non bisogna dimenticarlo, è tutto il
passato alle nostre spalle, ma anche il vivo presente della nostra contemporaneità, con le sue logiche ed i suoi irrazionalismi, il vivo presente che, seppur
incomprensibile utilizzando le tradizionali chiavi di lettura, è pur sempre il nostro presente, quello di noi uomini e donne, esattamente come quello di mille
anni fa? Un rifiuto di mediazione con le giuste pretese di potenza del presente,
e con l’ineluttabile riconoscimento dell’impotenza insita in ogni tradizione?
Il metodo della ripetizione
Il pensiero di Gadamer potrebbe rappresentare un convincente passo in
avanti per il nostro discorso sulla ripetizione; l’analisi gadameriana sul gioco,
sull’ermeneutica, sul valore dei pregiudizi e sul linguaggio fornisce un buon
punto di partenza in direzione di quella essenza della ripetizione estetica che
stiamo cercando di indagare.
Per Gadamer questa essenza è racchiusa nel concetto di mediazione e la
rappresentazione estetica sarebbe per lui da intendere come ripetizione della
mediazione tra tradizione e individuo, in una sorta di serissimo gioco (quasi
una lotta) in cui entrambi rivendicano potentemente e a-prioristicamente le
proprie possibilità di vittoria ed entrambi hanno a-priori coscienza della propria impotenza rispetto al gioco stesso e rispetto all’avversario.
1. Il concetto di gioco come l’essere stesso dell’opera estetica.
Gadamer si chiede che cosa è veramente il gioco.
Il gioco è qualcosa di molto serio; a prima vista non si direbbe, eppure, nel
giocare è riposta una sorta di sacrale serietà, in quanto il gioco è in grado di
raggiungere il suo pieno scopo soltanto qualora il giocatore si immerge totalmente in esso, gioca seriamente, si mette in gioco: “solo la serietà nel giocare fa
sì che il gioco sia interamente gioco”23.
23
133.
H-G. Gadamer, Verità e metodo, trad. it. di G. Vattimo, ed. Bompiani, Milano 2004, p.
Il concetto estetico di ripetizione tra mistica e metodo
115
Il gioco è una danza; il significato originario della parola gioco echeggia il
concetto di danza. Il movimento che è gioco non ha un fine in cui terminare ma
si rinnova sempre in una continua ripetizione; per la definizione essenziale del
concetto di gioco è centrale il movimento dell’andare e venire e questo rende
indifferente chi o che cosa sia che compie tale movimento in modo che il giocatore è assorbito da questa struttura ripetitiva dell’andare e venire.
Il gioco è mediazione, il senso originario del verbo giocare è quello mediale; la reciprocità è essenziale al concetto di gioco, non esiste un vero giocare
solo per sé, perché vi sia gioco non è necessario che vi sia qualcun altro che vi
partecipi, ma occorre necessariamente che vi sia qualcosa d’altro con cui il giocatore possa giocare, un qualcosa che risponda al suo movimento con un altro
movimento.
Il gioco è dunque seria ripetizione della mediazione tra due entità opposte
rivendicanti il proprio potere di vincere la partita.
Ci sono delle regole che prescrivono come si debba svolgere un gioco, se
un uomo decide di giocare egli delimita preliminarmente la propria completa
libertà di iniziativa per adeguarsi alle disposizioni prescritte, si dichiara impotente di fronte al potere del gioco; allo stesso tempo però rivendica a sé il potere
di vincere la partita (non si parla mai infatti di vincere l’avversario) e quello
di inventare il gioco stesso stabilendone le regole se non quello di modificare
queste ultime o di eluderle intelligentemente (il concetto di baro è altrettanto
originario quanto quello di gioco).
L’adempimento di una particolare esperienza ludica rende presente il gioco
stesso, da ciò scaturisce che il gioco è un autentico auto-rappresentarsi, il suo
vero modo di essere è l’auto-rappresentazione della mediazione che esso è.
Quando il gioco si rappresenta diventando spettacolo avviene un mutamento radicale: lo spettatore acquista un ruolo fondamentale; Gadamer definisce
questa rivoluzione come trasmutazione in forma; trasmutazione non è semplice cambiamento, nel cambiamento ciò che muta resta anche, sempre, lo stesso,
nella trasmutazione invece, qualcosa, tutto in una sola volta è qualcosa d’altro
e questo qualcosa d’altro è il suo vero essere in rapporto al quale il suo essere precedente è nulla; ciò che era prima ora non è più e ciò che è ora è il vero
permanente. Ciò che era prima sono i giocatori, ora questi non hanno più un
proprio essere per sé, ciò che ora è è solo ciò che da essi è portato a rappresentazione. La trasmutazione è quindi trasmutazione nella verità, un venire alla
luce del vero essere.
“Il gioco è essenzialmente ripetibile, e in questo senso è qualcosa di
116
Luigi Buonaiuto
permanente,”24 è un tutto conchiuso che raggiunge il suo pieno essere solo
nell’essere ripetutamente rappresentato; Gadamer definisce dunque il gioco
come seria ripetizione della rappresentazione della mediazione.
Abbiamo visto con Gadamer come il concetto di rappresentazione implica
necessariamente il rappresentare per qualcuno, ora, è proprio su questa implicazione che si fonda il peculiare carattere ludico dell’arte; i giochi dell’arte
non si risolvono nel solo rappresentare, ma rimandano contemporaneamente
a coloro che vi assistono partecipandovi, dunque il rimando tipico di ogni rappresentazione nell’arte diventa costitutivo dell’essere dell’arte.
Anche se in generale i giochi dell’arte non hanno a-prioristicamente ed esplicitamente di mira degli spettatori essi tendono a rappresentare una totalità di
senso compiuta per uno spettatore, in essi è lo spettatore a completare la natura
del gioco. Viene quindi in luce l’essenza della metafora del gioco come processo
mediale; uno spettacolo teatrale, ad esempio, è strutturato per essere un mondo
in sé conchiuso, tuttavia è aperto del lato dello spettatore, è solo in quest’ultimo
che acquista tutto il suo significato. Possiamo quindi affermare con Gadamer
che l’essere dell’arte è parte del processo ontologico della rappresentazione e
appartiene essenzialmente al gioco in quanto gioco.
Spesso la tradizione canonizza una particolare rappresentazione estetica
come un modello, il modello detiene di per sé una sorta di volontà di affermare
se stesso con tutta la potenza di una voce definitiva ed autoritaria, tuttavia
questa non è un impaccio alla libera attività degli altri interpreti, è infatti proprio
dell’arte la capacità di mettere in moto una sorta di prosecuzione di creatività,
è proprio dell’arte il sollecitare la volontà di potenza dell’uomo rispetto alle
canonizzazioni della tradizione. Ogni interpretazione/opera nasce da questa
tormentosa tensione che viene ad esprimersi quando due entità opposte
arrivano a rivendicare a sé il diritto alla creazione e che alla fine riescono a
mediarsi le une con le altre; l’interpretazione/opera è il parto di tale mediazione
dove nessuna delle due potenze può imporsi autonomamente rispetto all’altra.
In questo particolare rapporto di scontro-mediazione le opere d’arte
del passato sono rese presenti facendosi contemporanee ad ogni presente.
Contemporaneità dell’opera d’arte significa che qualcosa “che si presenta a noi,
per quanto remota possa essere la sua origine, nel suo presentarsi acquista
piena presenzialità”25; contemporaneità significa che ogni mediazione con il
passato viene superata in una totale presenzialità.
24
25
Ivi, p. 142.
Ivi, p. 160.
Il concetto estetico di ripetizione tra mistica e metodo
117
Nella mediazione con la tradizione l’interprete/artista modifica i contenuti
in direzione della presenzialità, in tal modo l’essere interpretata/rappresentata
dell’opera comporta che il rapporto con l’originale non è affatto una diminuzione
della sua autonomia, è quindi giusto parlare, in rapporto all’originale, di
un aumento d’essere. Tuttavia nonostante tutte le modifiche che può subire
nella rappresentazione essa rimane sempre se stessa; dunque: da un lato “la
rappresentazione ha in modo imprescindibile e incancellabile il carattere di
una ripetizione dell’eguale”26, dall’altro “ogni ripetizione è originaria quanto
l’opera stessa”27, e questo perché non è mai l’opera stessa a ripetersi ma ciò che
in essa si rappresenta: la mediazione tra potenze opposte.
La contemporaneità o presenzialità permette un arricchimento di verità
poiché “all’estatico oblio di sé dello spettatore corrisponde la sua continuità
con se stesso… È la verità del suo mondo, del mondo religioso e morale in cui
egli vive, quella che si rappresenta davanti a lui, ed egli vi si riconosce… ciò che
lo stacca da tutto, gli restituisce anche la totalità del suo essere”28.
L’esempio riportato da Gadamer è quello della tragedia: per Aristotele l’essenza della tragedia risiede nell’effetto sullo spettatore, questi infatti è travolto
da strazio e brividi di ansietà, tuttavia, proprio questi effetti suscitati dalla rappresentazione tragica sono quelli attraverso cui lo spettacolo produce la purificazione da tali passioni. Lo spettatore si ribella al tragico corso degli eventi ed
in questo modo l’effetto della catastrofe tragica si risolve producendo la liberazione dell’animo oppresso. Lo spettatore riconosce nel destino tragico se stesso
ed il proprio essere finito nei confronti del destino (la propria impotenza), di
qui scaturisce una sorta di affermazione della propria situazione, di ciò che è;
lo spettatore, attraverso la tragedia, ritorna a se stesso, “il così è dello spettatore
è una specie di riconoscimento di sé che egli fa, uscendo con tale consapevolezza dalle illusioni in mezzo alle quali, come ogni altro, comunemente vive.
L’affermazione tragica è intelligenza del vero”29, avanzamento nella conoscenza
del vero.
Ciò che vale per il tragico vale anche per il poeta, “la rappresentazione o
l’esecuzione della poesia e della musica non è qualcosa di accidentale ma è invece qualcosa di essenziale, in esse si compie soltanto ciò che le opere stesse
già sono: l’esistenza di ciò che da esse è rappresentato. La specifica temporalità
dell’essere estetico, per cui esso ha il proprio essere solo nell’essere rappresenIvi, p. 155.
Ivi, p. 153.
28
Ivi, p. 161.
29
Ivi, p. 166.
26
27
118
Luigi Buonaiuto
tato, si concreta nel caso della esecuzione-ripetizione come fenomeno autonomo e individuato”30.
L’autentico modo di essere dell’arte, ovvero l’essere rappresentata comporta
che il suo rapporto con l’originale non è affatto una diminuzione della sua autonomia, è quindi giusto parlare, in rapporto all’originale, di un aumento d’essere. Dunque possiamo affermare che nella ripetizione presente dello scontro/
mediazione tra le potenze della tradizione e dell’uomo artefice ciò che emerge è
sempre un avanzamento nella verità.
“L’arte non è mai solo qualcosa di passato, ma è capace di superare, con la
sua peculiare presenzialità di significato, le distanze temporali”31, come insegna Hegel: l’essenza dello spirito storico consiste nella mediazione, operata dal
pensiero, con la vita presente; ora, che questo presente sia la patria romantica
di poeti ispirati dalla solitudine e non piuttosto la caotica e democratica polis
contemporanea con il suo chiacchiericcio ed il suo svilimento del topos della
morte non è una variabile capace di sgretolare la metodologia del percorso gadameriano, ma ne costituisce l’essenza, non ci sarebbe infatti alcuna mediazione e nessun arricchimento di conoscenza se il presente fosse sempre fotocopia
del passato e araldo dei suoi valori canonizzati, e l’arte non sarebbe ripetizione
della mediazione, ma ripetizione e basta, ossessiva e sterile.
2. Lo scontro con i pregiudizi della tradizione.
Gadamer ricorda come Heidegger fondi la circolarità della comprensione
sulla temporalità dell’esserci: in essa il circolo non va inteso come qualcosa di
negativo ma come una possibilità positiva del conoscere più originario, possibilità sfruttata in maniera autentica solo qualora l’interprete comprende che
non deve lasciarsi condizionare dai propri pre-giudizi ma deve far venire fuori
la verità dalle cose stesse.
L’interprete alle prese con un testo abbozza preliminarmente un progetto
iniziale che gli garantisce un significato del tutto, ad interpretazione in corso
ogni revisione a questo progetto comporta la possibilità di abbozzare un nuovo
progetto: attraverso il circolo si smascherano gli errori derivanti dai pre-giudizi
che non trovano conferma nel testo. La verità è data dalla conferma che un pregiudizio può ottenere dal confronto con il testo.
Nella semantica dell’interpretazione si verifica un urto di fronte al testo, un
30
31
Ivi, pp. 167-168.
Ivi, p. 204.
Il concetto estetico di ripetizione tra mistica e metodo
119
urto dettato dalla possibilità contenuta nel testo di fare un uso del linguaggio
diverso da quello che comunemente ci è familiare. Non bisogna certo, mentre si
legge un libro (o si ascolta qualcuno parlare), dimenticare completamente tutti
i nostri pre-giudizi, basta semplicemente essere aperti all’opinione dell’altro,
ascoltare l’opinione dell’altro per metterla in rapporto alla totalità dei nostri
pre-giudizi.
“Chi vuole comprendere un testo deve essere pronto a lasciarsi dire qualcosa
dal testo”32, questa apertura non comporta un oblio di se stessi ma la semplice
presa di coscienza dei propri pre-giudizi. È dunque sul concetto di pre-giudizio
e sul rapporto che con esso si instaura che si fonda l’essenza di verità di ogni
comprensione: la mediazione; il pre-giudizio quindi non è un giudizio falso o
negativo ma un giudizio che attraverso l’elaborazione della mediazione può essere valutato tanto positivamente che negativamente.
Il superamento di tutti i pre-giudizi è una utopia ed è a sua volta un pregiudizio: l’utopia di una reale e totale rottura di continuità con la tradizione;
“l’ideale di una ragione assoluta non costituisce una possibilità per l’umanità
storica. La ragione esiste per noi solo come ragione reale e storica; il che significa che essa non è padrona di se stessa, ma resta sempre subordinata alle
situazioni date entro le quali agisce”33.
Occorre dunque una riabilitazione del concetto di pre-giudizio in vista della
possibilità dell’esistenza di pre-giudizi legittimi dettata da una variabile fondamentale: il riconoscimento da parte dell’uomo, accanto alla giusta rivendicazione di potenza nei confronti della tradizione, anche della propria condizione di
impotenza di fronte ad essa.
Gadamer distingue due tipi di pre-giudizio, il primo è dettato dalla precipitazione, vera origine degli errori in cui incappa la ragione umana, l’altro sono
i pre-giudizi dovuti all’autorità che impone all’individuo di non far uso della
propria ragione; ora, il fatto che l’autorità prenda il posto della nostra ragione e
del nostro giudizio diventando essa stessa fonte di pre-giudizi non esclude che
essa possa anche essere una fonte attendibile di verità. L’autorità non si fonda
sulla sottomissione dell’individuo ma sul suo riconoscimento, sul suo atto di
riconoscere il giudizio altrui superiore al proprio giudizio; il riconoscimento è
un atto della ragione stessa che è consapevole dei propri limiti; “l’autorità non
ha immediatamente a che fare con l’obbedienza, ma con la conoscenza… il suo
vero fondamento è un atto della libertà e della ragione”34.
Ivi, p. 316.
Ivi, p. 324.
34
Ivi, p. 328.
32
33
120
Luigi Buonaiuto
L’autorità produce così pre-giudizi che diventano oggettivi; ciò che è consacrato dalla storia e dalla tradizione detiene un’autorità che diventa universale e
la nostra finitezza storica di individui consiste nel fatto che tale autorità esercita sempre degli influssi sui nostri comportamenti e sulle nostre azioni.
La nozione di classico è un modo eminente dell’essere storico: “l’atto storico
della conservazione che mantiene in essere un certo vero attraverso una sempre
rinnovata verifica… la conservazione nel trascorrere distruttivo del tempo”35. Il
termine classico in questo modo ci dice che in realtà la portata comunicativa
ed ermeneutica di un’opera estetica è illimitata in quanto la comprensione non
è un’azione del soggetto ma “l’inserirsi nel vivo di un processo di trasmissione
storica, nel quale passato e presente continuamente si sintetizzano”36.
Questa sintetizzazione, questa ripetuta mediazione, ci spiega come il contrasto tra tradizione e ragione non scaturisce nella forma assiomatica dell’aut aut
infatti “anche la più autentica e solida della tradizioni non si sviluppa naturalmente in virtù della forza di persistenza di ciò che una volta si è verificato, ma
ha bisogno di essere accettata, di essere adottata, coltivata”37 e resa presente.
È vero che lì dove la vita subisce burrascose modifiche, pur nel preteso mutamento rivoluzionario di tutto, si conserva del passato, che si media al nuovo,
molto più di quanto non si possa immaginare, ma è vero anche che il sovvertimento ed il rinnovamento sono atti di libertà originaria e viva che non si lasciano schiacciare dalla poderosa roccia di Sisifo della tradizione.
Ecco come Gadamer imposta il suo metodo di ricerca: da un lato la tradizione con la sua duplice fenomenologia della potenza e dell’impotenza nei
confronti della ragione, dall’altro la ragione, anch’essa con la sua duplice fenomenologia della potenza ed dell’impotenza rispetto alla tradizione storica, dallo
scontro tra queste due entità si auto-rappresenta una mediazione: si ripete la
mediazione che è l’essenza dell’atto ermeneutico e dell’atto estetico.
Bisogna riconoscere la tradizione come un momento fondamentale dell’atteggiamento ermeneutico, la nostra coscienza è piena di una molteplicità di
voci che provengono dal passato dunque la vera ricerca ermeneutica è mediazione con la tradizione, così come bisogna riconoscere fondamentale per l’atteggiamento ermeneutico la volontà ed il potere rivendicati dall’interprete di
comprendere la tradizione applicandola a sé.
“Il testo per essere compreso in modo adeguato, cioè conformemente a come
ci si presenta, deve venir compreso in ogni momento, ossia in ogni situazione
Ivi, pp. 338-339.
Ivi, p. 340.
37
Ivi, p. 330.
35
36
Il concetto estetico di ripetizione tra mistica e metodo
121
concreta, in maniera nuova e diversa. Comprendere significa sempre, necessariamente, applicare”38.
L’applicazione è possibile esplicitando la tensione sussistente tra l’identità
dell’oggetto da comprendere e la mutevolezza delle situazioni in cui esso viene
di volta in volta compreso.
È questa mediazione l’autentico luogo della comprensione, questa nel suo
essere un atto riproduttivo (ripetitivo) è anche un atto produttivo; il tempo non
è un abisso da scavalcare, esso è riempito dalla trasmissione e dalla tradizione
delle passate mediazioni ed è dunque la ripetizione della mediazione il vero
fondamento ontologico dell’accadere, “non è dunque esagerato parlare qui di
una autentica produttività dell’accadere”39, di una autentica produttività della
ripetizione.
Quando noi cerchiamo di comprendere una determinata manifestazione
storica siamo già sempre sottoposti alla storia degli effetti, alla fortuna ed agli
effetti che tale manifestazione ha avuto nella sua storia passata sino a noi. Avere
coscienza della nostra determinazione storica è avere coscienza della nostra reale situazione, tale situazione limita le possibilità della nostra visione, dunque
potremmo definirla anche orizzonte o limitatezza di orizzonte.
Per comprendere qualcosa bisogna trasporsi in essa, trasporsi non significa
prescindere da sé, bensì innalzarsi ad una coscienza superiore, non prescindere
dal proprio orizzonte ma innalzarsi ad un orizzonte superiore; l’innalzamento
è sempre un atto reciproco, c’è il nostro orizzonte presente che continuamente
mettiamo alla prova con i nostri pregiudizi e di questa messa alla prova fa parte
anche l’orizzonte del passato e della tradizione da cui proveniamo, dunque “la
comprensione è sempre processo di questa fusione di orizzonti che si ritengono
indipendenti tra loro”40.
La vita è ripetizione di mediazione tesa ad un accrescimento di conoscenza,
ovvero ripetizione della mediazione tra potenze/impotenze tese in direzione di
questa fusione di orizzonti, ed il compito dell’ermeneutica è quello di non lasciare che questa tensione-fusione venga obliata in un livellamento dei due momenti ma di esplicitarla consapevolmente; la vita è ripetizione della tensione,
dello scontro tra la potenza/impotenza della tradizione e la potenza/impotenza
del presente.
Heidegger ci insegna dunque che la comprensione è sempre determinata
dal movimento anticipante della pre-comprensione, il circolo non si risolve nel Ivi, p. 360.
Ivi, p. 347.
40
Ivi, p. 356.
38
39
122
Luigi Buonaiuto
la comprensione totale raggiunta ma piuttosto in tale comprensione si realizza; ora, questo circolo, questa ripetitività dello scontro/mediazione, si radica
nell’aver a che fare del comprendente e del compreso con la medesima cosa, nel
loro comune possesso di determinati pregiudizi fondamentali e costitutivi. Ciò
non comporta naturalmente un legame immediatamente valido ed indiscusso,
anzi, si verifica una totale polarità tra familiarità ed estraneità, tuttavia, bisogna ricordare che tale polarità si verifica comunque in riferimento a qualcosa
di detto o scritto: “il linguaggio che la tradizione ci parla, la parola che essa ci
rivolge”41 ed il linguaggio con il quale noi parliamo e attraverso il quale leggiamo i contenuti della tradizione; il linguaggio, il nostro e quello del passato; il
linguaggio: il campo da gioco della ripetizione della mediazione.
3. Ripetizione della mediazione: il medium è linguaggio.
Il problema ermeneutico accade nel linguaggio, esso è il vero medium della
comprensione; il caso della traduzione mette in esplicita evidenza tale caratteristica: dove c’è comprensione non si traduce, si parla, dunque la traduzione è
una sorta di ammissione di inferiorità da parte degli interlocutori.
Il traduttore si rende subito conto della distanza che lo separa da ciò che
deve interpretare e la sua tensione, il suo sforzo, è simile a quello che avviene in
un dialogo; si può dunque parlare di dialogo ermeneutico.
Il dialogo ermeneutico esige però un suo linguaggio, comune a tutti gli interlocutori, questo linguaggio comune non deve essere inteso come uno strumento
atto alla comprensione ma come lo stesso processo di comprensione. Quando
in un dialogo ha luogo una vera comunicazione tra le due persone non avviene
un semplice adattamento reciproco: il testo porta ad espressione un contenuto,
ma che ciò accada dipende in definitiva dall’interprete. L’orizzonte dell’interprete è determinante ma non come punto di vista rigido e da imporre, bensì
come opinione che si mette in gioco al fine di giungere alla fusione di orizzonti
con il testo instaurando una sorta di dialogo con esso.
Ogni interpretazione avviene nel medium del linguaggio che, se da un lato
vuole lasciare che si esprima l’oggetto da comprendere, dall’altro è pur sempre
il linguaggio proprio dell’interprete, quindi, per comprendere il contenuto di un
testo, bisogna in un certo senso tradurlo nel nostro linguaggio, bisogna metterlo in rapporto con la totalità delle opinioni e dei pregiudizi che noi, in qualità
di interpreti, abbiamo. Pensare storicamente significa portare a compimento
41
Ivi, p. 345.
Il concetto estetico di ripetizione tra mistica e metodo
123
quella trasposizione che i concetti del passato subiscono quando cerchiamo di
pensarli, il “pensare storicamente comporta sempre costitutivamente una mediazione tra quei concetti e il proprio pensiero”42.
La tradizione ha la sua verità in questo continuo bisogno di nuove appropriazioni, ognuna delle quali è testimonianza della potenza della situazione
ermeneutica alla quale di volta in volta viene pensata.
“C’è nel linguaggio una tendenza al livellamento, per cui il linguaggio tende
a costringere la nostra comprensione in schemi che noi sentiamo come limiti e ai quali cerchiamo di sottrarci con un atteggiamento critico. Ma la critica che esercitiamo nei confronti del linguaggio non si rivolge alle convenzioni
dell’espressione linguistica come tale, bensì alle opinioni convenzionali che nel
linguaggio si sono cristallizzate. Tale critica non dice dunque nulla di essenziale contro la connessione intima che abbiamo riconosciuto tra comprensione e
linguaggio. Anzi, può addirittura confermare tale connessione. Ogni critica di
questo tipo, che per comprendere cerca di innalzarsi oltre lo schematismo delle formulazioni linguistiche, trova infatti di nuovo la propria espressione nella
forma del discorso. In questo senso, il linguaggio sta sempre al di là di ogni critica dei suoi limiti. La sua universalità va di pari passo con l’universalità della
ragione”43. In questo continuo scontro tra potenze/impotenze polari c’è una costante che sempre si ripete: il linguaggio, esso è la vera mediazione, la costante
che sempre si ripete.
Tra il singolo e il linguaggio sussiste un rapporto reciproco che lascia all’uomo una certa libertà nei confronti del linguaggio. Sul linguaggio si fonda, e in
esso si rappresenta il fatto che gli uomini abbiano un mondo; la lingua possiede
una sorta di esistenza autonoma rispetto al singolo individuo che appartiene a
una determinata comunità linguistica, e lo inserisce in un certo tipo di visione
del mondo, dimostrando l’originale linguisticità dell’umano essere-nel-mondo;
l’uomo tuttavia caratterizza questo suo rapporto con il mondo come libertà
dall’ambiente, l’uomo non è prigioniero di un ambiente rigidamente schematizzato nel linguaggio, egli può innalzarsi al di sopra del mondo attraverso la
libertà di dare nomi alle cose.
“L’uomo è sempre originariamente libero di esercitare in modo vario la sua capacità di parola… il linguaggio è una libera e variabile possibilità dell’uomo”44.
Il carattere linguistico della nostra esperienza del mondo non è dunque una
prospettiva limitante, penetrando in mondi linguistici diversi dal nostro e ab Ivi, p. 456.
Ivi, p. 460.
44
Ivi, pp. 508-509.
42
43
124
Luigi Buonaiuto
bandonando i nostri pregiudizi non neghiamo affatto il nostro mondo; da un
lato quindi il linguaggio non è causa di inerzia dello spirito ma solo la prova che
il nostro finito intuire il mondo e noi stessi avviene sempre nel linguaggio (nel
linguaggio si fa visibile ciò che è reale: la nostra finitezza), dall’altro la potenza
dello spirito umano comporta il mettersi in gioco del contenuto del linguaggio e
della tradizione di cui esso è portatore, mettersi in gioco nelle sue sempre nuove possibilità di senso e di risonanza, che esistono solo per essere ampliate dal
rapporto con ogni nuovo interprete.
è il contenuto della tradizione storica quello che solo fa da criterio e viene
ad espressione ma non esiste una coscienza in cui il contenuto della trasmissione storica appare una volta per tutte definitivo, ogni appropriazione della
tradizione è diversa, ogni appropriazione è l’esperienza di un aspetto della cosa
stessa e l’appropriazione non è una pura riproduzione o ripetizione del testo ma
una nuova creazione.
Il linguaggio è un mezzo in cui io e il mondo si congiungono, si presentano
nella loro originaria congenerità, “così non esiste certamente alcuna comprensione che sia libera da ogni pregiudizio, per quanto la nostra volontà possa
proporsi di sottrarsi, nella coscienza, al dominio dei nostri pregiudizi”45, ed allo
stesso modo non esiste alcun pregiudizio che possa uscire illeso dallo scontro
con la potenza della ragione forte della propria viva libertà.
Viene in luce anche qui la vera essenza dello scontro e della mediazione che
è il linguaggio: vediamo da un lato le convenzioni linguistiche che, se per un
verso detengono un certo potere ed una certa influenza storica sulla ragione,
per un altro verso sono sempre appese ad un filo sottile in balia delle appropriazioni e delle re-interpretazioni e rivoluzioni della ragione; dall’altro lato abbiamo appunto la ragione che se per un verso è già sempre a-prioristicamente integrata nelle convenzioni linguistiche e da esse è limitata, per un altro verso non
accetta mai tacitamente il peso di tali tradizioni e sempre, attraverso la propria
creatività, re-inventa il proprio linguaggio in base alle condizioni storiche a lei
più propizie, quelle contemporanee, presenti.
Parlando dunque di ripetizione del medium linguistico in realtà intendiamo una ripetizione di uno scontro tra polarità opposte ognuna delle quali però
scende in campo con una duplice fenomenologia, quella della potenza e quella
dell’impotenza, ed è dall’intrecciata mediazione tra tutte queste componenti
che nasce il concetto di arte come ripetizione linguistica della mediazione stessa della vita.
45
Ivi, p. 558.
Il concetto estetico di ripetizione tra mistica e metodo
125
“Holderlin ha mostrato che l’invenzione del linguaggio di una poesia presuppone la dissoluzione totale di tutte le parole e le forme linguistiche consuete”46,
quando il poeta, grazie alla sua sensibilità, si guarda intorno, il mondo gli appare come sconosciuto, gli si presenta come per la prima volta, il poeta in questo
momento non accetta nulla come dato. La poesia come creazione riuscita non
è un ideale ma una vivificazione dello spirito, una ripetizione della vitalità dello
spirito; la poesia che ripete il mondo in realtà lo rappresenta nei suoi scontri titanici e nelle sue mediazioni tra potenze/impotenze contrapposte sempre come
una nuova figura, come un nuovo mondo.
Gadamer rintraccia così il fondamento ontologico della vita, con il suo linguaggio come medium tra potenze/impotenze opposte, nell’esperienza poetica
ed il suo metodo si può ben concludere all’insegna dell’esaltazione dell’opera
estetica come metafora viva del mondo, con le sue potenze vive e con i suoi
scontri e le sue mediazioni.
Conclusioni
Ricordiamo le costanti sulle quali è stato impostato questo studio sull’estetica della ripetizione: 1) accrescimento di metodo inteso come affinamento delle
tecniche di ricerca atte a favorire l’indagine stessa, ricercando tutte quelle che
possono essere considerate le variabili attivamente presenti in una determinata
esperienza; 2) accrescimento della portata ontologica del concetto di mediazione, la superiorità cognitiva del processo mediale rispetto a quella delle singole
parti attive in esso; 3) approfondimento della duplice fenomenologia di potenza/impotenza, considerando le variabili attive nell’esperienza sia come entità
aprioristicamente dotate della capacità, e quindi del potere, di influenzare e
modificare il processo in cui entrano a far parte, sia come entità influenzabili e modificabili, che possono dunque risultare impotenti rispetto al processo
stesso; 4) approfondimento del problema storico metodologicamente indagato
in tutti i suoi aspetti costitutivi quali: il passato, con la sua costanza e la sua
potenza sempre rinnovabile, il presente, con la sua instabilità e la sua volontà
di potenza tesa alla propria affermazione all’interno del problema storico più
generale, ed il futuro, come terreno fertile dei parti di ogni ripetuta mediazione
tra passato e presente.
Abbiamo messo in luce in apertura l’interessante intuizione blanchotiana ed
46
Ivi, p. 357.
126
Luigi Buonaiuto
i suoi limiti: la semantica mistica consente infatti un originale approccio per
lo studio dell’opera d’arte, l’identificazione di questa come inviolabile scrigno
dell’ignoto risulta affascinante e degna di essere approfondita, tuttavia, la scarsa mediazione tra mistica e scientificità, tra invisibile e visibile, e l’eccessivo
nominalismo della pagina blanchotiana che se da un lato vuole riflettere sulla
scrittura dall’altro pretende di farlo attraverso un linguaggio quasi poetico, se
non ermetico, lasciano un vuoto che, seppur giustificato dalle stesse intenzioni
dell’autore, elude fin troppo la speculazione scientifica e la reale situazione empirica dell’atto creativo.
Bisogna mettere in evidenza, in questa teoria mistica della ripetizione, la fenomenologia dell’impotenza; il richiamo di Blanchot a non lasciarsi corrompere tout-court dalla continuità onnicomprensiva della dialettica hegeliana è una
intuizione di estrema importanza all’interno della semantica estetica, tuttavia,
per quanto il riconoscimento e la rivendicazione di verità di questa impostazione sia da tenere in debita considerazione, non è possibile, a rigor di metodo,
impostare un’indagine sull’arte basandosi unicamente su tale fenomenologia e
obliare del tutto la fenomenologia della potenza e la reale mediazione che tra
queste si sviluppa.
Ancora, porre l’accento sul tempo futuro quando si affronta il problema estetico e quello della sua interpretazione può essere considerato un buono spunto
di indagine, ma se il tempo passato, i tremila anni di letteratura, vengono considerati alla stregua di un unico calderone di esperienze artistiche che quanto
ad essenza sono facilmente identificate come unico parto di un unico poeta
eterno che scrive serrato nella solitudine più buia e claustrofobia, davvero non
si comprende quale interesse potrebbe destare questo futuro se non quello di
qualificarsi ancora come un’ulteriore dimostrazione di quella unica ignota eternità dello stesso poeta eterno e ontologicamente sempre più solo.
Le Grammatiche della creazione di Steiner rappresentano un fecondo approfondimento di metodo rispetto alla mistica di Blanchot.
Steiner riconosce l’ineluttabilità di una componente mistica all’interno della
semantica estetica tuttavia il suo sguardo fermo sulla realtà gli permette di considerare altrettanto ineluttabile il fatto che ogni produzione umana avviene nel
tempo e dunque che ogni operato umano, per quanto possa essere considerato
un tentativo di emulazione da parte dell’uomo dell’operato divino, può essere
considerato parimenti una riproduzione di operati umani anteriori ed esistenti.
Da questa interessante impostazione metodologica, che sa prendere in esame
la totalità delle variabili in gioco, l’invisibile ed il visibile, Steiner getta le fondamenta della dialettica creazione-invenzione attraverso la quale, rispetto a Blan-
Il concetto estetico di ripetizione tra mistica e metodo
127
chot, riesce ad introdurre una ulteriore variabile intervenente nella semantica
estetica: se infatti da un lato l’uomo può considerarsi un semplice imitatore
del Dio, riconoscendosi impotente di fonte a questa sua propria condizione di
parassitismo, dall’altro egli non accetta mai a-priori questo suo stato di subordinazione essendo insita in lui una volontà di potenza che lo induce a porsi nei
confronti del tempo e del proprio passato con un atteggiamento protagonistico
ed antagonista. Steiner riconosce poi nel linguaggio il vero campo da gioco di
questo scontro: il linguaggio infatti, con la sua doppia identità di forma e contenuto, permette una reale mediazione tra infinito e finito, tra mistica dell’assenza e scientificità della presenza.
Ciò che di Steiner non convince tuttavia è una sorta di pregiudizio nei confronti del presente; l’affermazione che la poiesis ha diritto all’esistenza solo se
deliberatamente ispirata dai tropi della solitudine, del silenzio e della romantica
morte lo porta infatti ad affermare che non sia possibile una reale mediazione
tra il tradizionale simbolismo dell’artista e la presente e vitale esperienza contemporanea nella quale il chiacchiericcio della città e l’inflazione del topos della
morte hanno vistosamente modificato le coordinate esistenziali tradizionali.
Dunque, se Steiner, rispetto all’unidirezionalità di Blanchot, ci permette di
fare un passo in avanti in direzione del metodo con il riconoscimento della
validità della realtà storica al fianco della mistica e della volontà di potenza al
fianco della fenomenologia dell’impotenza presenti nell’atto estetico, allo stesso tempo, il suo rifiuto di intavolare una partita (un serio gioco) con il tempo
presente costituisce un effettivo rifiuto di mediazione che all’interno di un reale
trapasso dalla mistica al metodo pecca di mancata scientificità.
Per parlare di mediazione vera e propria è necessario rifarsi a Gadamer,
per lui infatti l’essenza della poiesis, da mistica ripetizione dell’ignoto inteso al
neutro o da riformulazione umana del precedente divino che trova le proprie
muse nella sola solitudine e nella sola morte, diventa ripetizione della mediazione corrente nello scontro (gioco) tra la duplice fenomenologia di potenza ed
impotenza insite in entrambi i soggetti in questione: la tradizione (la storia, il
linguaggio) e l’uomo.
L’esempio del gioco è qui di fondamentale importanza: affermare che il senso originario del verbo giocare è un senso mediale sta ad indicare che in esso
viene a rappresentazione il reale scontro tra questa duplice fenomenologia propria di ogni singolo concorrente, ed allo stesso tempo sta ad indicare la duplice
fenomenologia propria del gioco stesso che se da un lato ha il potere di stabilire
delle regole limitando la libertà dei giocatori, dall’altro è sempre impotente di
fronte alle modificazioni ed alle reinterpretazioni che il giocatore può mettere
128
Luigi Buonaiuto
in atto nei confronti di queste.
Dall’esempio del gioco Gadamer passa al setaccio il problema storico vero e
proprio dimostrando quanto, all’interno di questo sia presente lo stesso scontromediazione tra duplici fenomenologie opposte: quella della tradizione, aprioristicamente presente e potente attraverso i pregiudizi (che non sono necessariamente falsi), ma sempre anche impotente nei confronti della ragione che mira a
reinterpretarla onde renderla presente e consona al proprio tempo; e la duplice
fenomenologia dell’uomo, sempre invischiato nei pregiudizi della tradizione ed
impotente nei loro confronti, ma mai disposto ad accettarli tacitamente senza
rivendicare a sé il potere di rielaborare ciò che gli giunge dal passato onde riqualificare il suo peso ontologico da unica voce capace di far conoscere la verità
a una delle tante voci in gioco che possono rivendicare verità nella sola presente, concertata, mediazione.
Ancora Gadamer approfondisce il senso della poiesis come ripetizione della
mediazione parlando della capacità del linguaggio di costituirsi come vero medium; l’esempio della pluralità delle lingue e quello della traduzione sono infatti
utili a spiegare quanto la verità del fenomeno ermeneutico non risieda né nella
lingua originale, né tanto meno nella lingua dell’interprete-traduttore, quanto
piuttosto in un suo linguaggio proprio frutto della mediazione tra la potenza
della lingua originale di detenere la sola, autentica verità conoscibile, e la sua
impotenza di adempire a questa sua essenziale natura comunicativa nei confronti di coloro che non siano a-priori inseriti all’interno della visione del mondo di cui essa è esemplare espressione; mediazione dunque tra la potenza/impotenza della lingua originale e la potenza dell’interprete di leggere nell’opera il
senso che gli risulta più confacente al proprio tempo, mediazione ancora tra la
potenza/impotenza della lingua originale e l’impotenza dell’uomo nei confronti
del linguaggio stesso che, sebbene passibile di essere modificato, rivoluzionato
o semplicemente tradotto, resta pur sempre l’unico strumento nelle mani del
traduttore che, seppur fruito del potere di coniare il suo proprio linguaggio originale è già sempre aprioristicamente inserito all’interno del linguaggio stesso
e solo attraverso quest’ultimo può esprimersi.
Analogia e decostruzione nell’Essai di Rousseau
129
Analogia e decostruzione nell’Essai di Rousseau
Memoria di Mauro Senatore
presentata dal socio naz. ord. res. Aldo Trione
(seduta del 27 marzo 2008)
Abstract. The paper focuses on the essential connection between imitation and alteration which Derrida’s reading develops by bringing out the consequences contained in the
elaboration of imitation in Rousseau’s Essai XIII-XIV. Imitation is defined by the function of expressing presence, which consists of the supplement of the structural inability
of presence to give itself to the conservation and transmission beyond its contingency,
and, thus, of its record in the institutional and reproductive form of sign. The record has
brought about since the beginning the alteration prescribed in the resemblance between
presence and sign. The paper presents this originary prescription as the constitutive condition of the concepts of memory and line. The archiving of the example in the signs of
memory, which allows its transmission and good imitation, entails the perversion consisting in the imitation of signs. The line, being the institutional and reproductive form
which grants the communication of passions and the life of art, has exchanged since the
beginning with the forms representing its reproductive essence. This articulation allows
to solicit the systematic elaboration of chromatics, that is, the science of nuances or
analogies, as the historical perversion of the pure and natural origin of art.
Quand les théâtres eurent pris une forme régulière, on n’y chantait plus que
sur des mode prescrits; et, à mesure qu’on multipliait les règles de l’imitation,
la langue imitative s’affaiblissait. L’étude de la philosophie et le progrès du
raisonnement, ayant perfectionné la grammaire, ôtèrent à la langue ce ton vif
et passionné qui l’avait d’abord rendue si chantante.
(Rousseau, Essai sur l’origine des langues, cap. XIX)
Il passaggio alla scrittura
Selon une tradition qui reste ici imperturbable, Rousseau est assuré que
l’essence de l’art est la mimesis. L’imitation redouble la présence, s’y ajoute
en la suppléant. Elle fait donc passer le présent dans son dehors. … Dans les
arts vivants, et par excellence dans le chant, le dehors imite le dedans. Il est
expressif. Il «peint» des passions. La métaphore qui fait du chant une peinture n’est possible, ne peut arracher à soi et trainer au dehors, dans l’espace,
130
Mauro Senatore
l’intimité de sa vertu, que sous l’autorité commune du concept d’imitation.
La peinture e le chant sont des reproductions, quelles que soient leur différences; le dedans et le dehors les partagent également, l’expression a déjà
commencé à faire sortir la passion hors d’elle-même, elle a commencé à
l’exposer et à la peindre1.
La determinazione dell’essenza dell’arte come mimesis situa il discorso sul
canto e sul genere imitativo della musica elaborato da Rousseau nell’Essai sur
l’origine des langues entro una certa tradizione che assume il nesso di imitazione e supplemento. Dunque l’imitazione assolve alla funzione di supplenza
della presenza provocando il passaggio della presenza stessa in ciò che è fuori
o altro. Questa articolazione tradizionale dell’imitazione assicura alla pittura
la posizione di esempio o metafora delle arti, nella misura in cui fa uscire le
passioni da se stesse, nello spazio, nell’elemento esterno ed eterogeneo rispetto
alla loro esistenza singolare e contingente, le espone, le esprime. In particolare,
la funzione espressiva dell’imitazione connette l’essenza delle arti al concetto
di riproduzione, che individua il passaggio o la registrazione delle passioni in
una forma convenzionale e indipendente dalla loro presenza, che ne permette
la conservazione e la trasmissione.
Il rinvio alle funzioni dell’espressione e della riproduzione inscrive il concetto dell’imitazione entro l’articolazione di una certa economia o guerra che
Rousseau descrive in modo esemplare quando spiega il passaggio alla letteratura e alla scrittura in genere.
Le parti que j’ai pris d’écrire et de me cacher est précisément celui qui
me convenait. On n’aurait jamais su ce que je valais2.
Derrida mette a fuoco l’organizzazione economica o strategica in cui viene a
determinarsi il concetto del supplemento della presenza, ad esempio, della parola
contingente e inefficace ad offrirsi alla conservazione e alla circolazione oltre il momento in cui si dà sottraendosi, e l’ambiguità strutturale di questa determinazione,
che si ripercuote necessariamente sul concetto corrispondente dell’imitazione.
J. Derrida, De la grammatologie, Les Editions de Minuit, Paris 1967, pp. 289-90.
Per il testo di Rousseau vedi Derrida, p. 205. Sulla lettura del passaggio alla scrittura
in chiave economica vedi ivi, p. 204: Dans les Confessions, au moment où Jean-Jacques tente
d’expliquer comment il est devenu écrivain, il décrit le passage à l’écriture comme la restauration,
par une certaine absence et par un type d’effacement calculé, de la présence déçue de soi dans la
parole. Écrire alors est le seul moyen de garder ou de reprendre la parole puisque celle-ci se refuse
en se donnant. Alors s’organise une économie des signes.
1
2
Analogia e decostruzione nell’Essai di Rousseau
131
Il ricorso alla scrittura enunciato da Rousseau si presenta come un’unica
operazione non semplice, che comporta l’interdipendenza di due sostituzioni:
passaggio doppio della parola nella scrittura e, ad un tempo, della presenza nel
valore.
L’économie, notons-le, se signale peut-être à ceci: l’opération qui substitue l’écriture à la parole remplace aussi la présence par la valeur: au je
suis présent ainsi sacrifié on préfère un ce que je suis ou ce que je vaux.
Je renonce à ma vie présente, à mon existence actuelle et concrète pour me
faire reconnaître dans l’idéalité de la vérité et de la valeur3.
Nell’operazione economica Derrida individua il progetto della costituzione
dell’idealità o della forma ideale della presenza, alla quale corrisponde il valore,
la forma in cui la parola o l’io si prestano al riconoscimento in genere e, dunque, alla tradizione. In questo riferimento all’idealità introdotto dalla lettura
derridiana del testo si delinea la connessione essenziale tra la costituzione della
forma ideale della presenza, o il valore, e il partito preso della scrittura. La produzione di una forma della presenza che scioglie la presenza stessa dalla sua
condizione di singolarità e contingenza rendendola riconoscibile a prescindere
da ogni riferimento a quella condizione, implica la registrazione della parola
in una forma convenzionale o riproduttiva, come la letteratura o la scrittura in
genere, che la supplisce conservandola e facendola circolare al di là del suo darsi. A partire dall’articolazione di questa implicazione esemplare ed essenziale
di scrittura e valore si deve riconoscere la pertinenza della determinazione del
passaggio alla letteratura come la proposta della più grande riappropriazione
simbolica della presenza4.
A questo punto, tuttavia, bisogna rendere conto della convergenza tra l’opzione teorica per il ricorso alla letteratura e la denuncia pratica della lettera
come forma della perversione della cultura e della comunità. Questa convergenza descrive l’incrociarsi di movimenti distinti e l’accumularsi di predicati
contraddittori in cui si articola la struttura ambigua del supplemento. Derrida
sviluppa la funzione essenziale del supplemento attraverso la relazione di raddoppiamento o addizione della scrittura alla parola, che si profila nel passaggio
alla letteratura.
Ivi, p. 205.
Ibidem.
3
4
132
Mauro Senatore
Nous avions déjà, par anticipation, reconnu une des formes de cette
addition: la parole étant naturelle ou du moins l’expression naturelle de la
pensée, la forme d’institution ou de convention la plus naturelle pour signifier la pensée, l’écriture s’y ajoute, s’y adjoint comme une image ou une
représentation. En ce sens, elle n’est pas naturelle. Elle fait dériver dans la
représentation et dans l’imagination une présence immédiate de la pensée
à la parole. Ce recours n’est pas seulement «bizarre», il est dangereux. C’est
l’addition d’une technique, c’est une sorte de ruse artificielle et artificieuse
pour rendre la parole présente lorsqu’elle est en vérité absente5.
L’addizione del supplemento si presenta come registrazione della parola, o
della sua presenza attuale e immediata, nella forma istituzionale o convenzionale dell’immagine o della rappresentazione, che individua la forma più naturale per assicurare alla parola la conservazione e la trasmissione a prescindere
dalla sua presenza. Questo passaggio della presenza immediata del pensiero
alla parola attraverso la rappresentazione o l’immaginazione costituisce, dunque, la condizione essenziale dell’economia o della guerra per il riconoscimento, cioè per la riappropriazione della presenza stessa come valore.
La minaccia che la funzione del supplemento porta con sé è prefigurata
nella determinazione della scrittura e, dunque, della registrazione nella forma
istituzionale, come tecnica che, facendo uscire la parola fuori di sé, in altro,
nell’elemento riproduttivo e indipendente dalla sua presenza immediata, ne
permette il riconoscimento mediante l’inganno o la simulazione della presenza,
e, dunque, come artificio necessariamente artificioso. La scrittura presuppone
la disponibilità costitutiva della rappresentazione o del segno, della forma istituzionale in genere, a farsi passare o a scambiarsi con il termine assente della
riappropriazione, presenza o cosa stessa. Dunque, come osserva Derrida, l’alterazione della presenza si annuncia come un destino necessario prescritto nel
concetto stesso di supplemento, cioè nell’operazione di sostituzione prevista
entro l’economia della riappropriazione ideale della presenza.
Et il y a une nécessité fatale, inscrite dans le fonctionnement même du
signe, à ce que le substitut fasse oublier sa fonction de vicariance et se fasse
passer pour la plénitude d’une parole dont il ne fait pourtant que suppléer
la carence et l’infirmité6.
5
6
Ivi, p. 207.
Ivi, p. 208.
Analogia e decostruzione nell’Essai di Rousseau
133
L’artificio dell’artificio descrive la stessa prestazione assolta dalla scrittura in
genere, che consiste nella supplenza della finitudine o della debolezza strutturale della parola mediante il passaggio o la registrazione nella forma istituzionale e riproduttiva dell’immagine o della rappresentazione.
L’archiviazione dell’esempio
Derrida si propone di articolare il discorso dell’Essai sull’imitazione a partire dall’ambiguità del concetto di imitazione elaborato da Rousseau nel secondo libro dell’Emile, in cui essa comunica con un’altra ambiguità, che marca lo
statuto del segno. Questa strategia di lettura presuppone la relazione essenziale
tra pedagogia e imitazione, che è in gioco nella determinazione del concetto di
esempio, del metodo di insegnamento, e della funzione dell’imitazione del maestro7. Dunque la lettura del testo dell’Emile si polarizza intorno all’articolazione
del concetto di imitazione entro l’economia dell’apprendimento e del rapporto
tra maestro e fanciullo.
Il problema dell’educazione del fanciullo alla generosità, la liberalità, è prelevato come caso esemplare di quella articolazione, poiché si determina in relazione ad una conoscenza che il fanciullo non possiede e che ha per oggetto il
valore di ciò che si dona e il bisogno del proprio simile.
L’aumône est une action d’homme qui connaît la valeur de ce qu’il donne, et le besoin que son semblable en a. L’enfant, qui ne connaît rien de cela,
ne peut avoir aucun mérite à donner; il donne sans charité, sans bienfaisance; il est presque honteux de donner, quand, fondé sur son exemple et le
vôtre, il croit qu’il n’y a que les enfants qui donnent, et qu’on ne fait plus
l’aumône étant grand. Remarquez qu’on ne fait jamais donner par l’enfant
que des choses dont il ignore la valeur, des pièces de métal qu’il a dans sa
poche, et qui ne lui servent qu’à cela. Un enfant donnerait plutôt cent louis
qu’un gâteau. Mais engagez ce prodigue distributeur à donner les choses
qui lui sont chères, des jouets, des bonbons, son goûter, et nous saurons
bientôt si vous l’avez rendu vraiment libéral8.
7
Ivi, p. 290: La pédagogie ne peut pas ne pas rencontrer le problème de l’imitation. Qu’est-ce
que l’exemple? Doit-on enseigner par l’exemple ou par l’explication? Le maître doit-il se donner
en modèle et laisser faire, ou prodiguer les leçons et les exhortations? Et y a-t-il de la vertu à être
vertueux par imitation?
8
J.-J. Rousseau, Emile in idem, Œuvres Complètes de Jean-Jacques Rousseau, Dalibon,
Paris, 1826, (vol.III), p. 172.
134
Mauro Senatore
Questa presentazione rinvia il caso dell’educazione alla liberalità al problema generale della pedagogia, che consiste nell’educare il fanciullo a fare ciò che
non comprende e, dunque, nel trasformare in adulto, cioè in essere razionale,
colui che non intende ragione9. Rousseau articola il caso secondo le modalità
rigorosamente distinte dell’insegnamento mediato dalla persuasione e di quello
mediato dall’esempio. Come sottolinea Derrida, questi modelli di insegnamento sono dislocati agli estremi della scimmiottatura dell’esempio del maestro,
che individua la forma cattiva e non umana dell’imitazione, la sua perversione,
e della buona imitazione.
D’une part, tout commence par l’imitation et l’enfant n’apprend que par
l’exemple. Ici l’imitation est bonne, elle est plus humaine, elle n’a rien à faire avec lingerie. Les simagrées seraient plutôt du côté de ceux qui, comme
le voudrait Locke, dispensent aux enfants, au lieu d’exemples, des raisonnements sur l’intérêt qu’il y a à être libéral. On ne passera jamais de cette
« libéralité usurière» à la vraie générosité qui ne se transmet que par l’exemple et la bonne imitation: «Maitres, laissez les simagrées, soyez vertueux
et bons, que vos exemples se gravent dans la mémoire de vos enfants, en
attendant qu’ils puisent entrer dans leurs cœurs10».
Il modello persuasivo dell’educazione alla liberalità è identificato da Rousseau con la proposta di Locke di persuadere il fanciullo all’interesse che deriva
dall’essere liberale ricorrendo all’esperienza di restituirgli subito ciò che ha donato11. Questo modello è accusato di pervenire al risultato di una liberalità usuraria per la quale il fanciullo dona solo perché è consapevole della restituzione,
e cessa di donare quando viene meno questa condizione. La liberalità usuraria
9
Vedi ivi, pp. 138-9: Raisonner avec les enfants était la grande maxime de Locke … Le chefd’œuvre d’une bonne éducation est de faire un homme raisonnable: et l’on prétend élever un
enfant par la raison! C’est commencer par la fin, c’est vouloir faire l’instrument de l’ouvrage. Si
les enfants entendaient raison, ils n’auraient pas besoin d’être élevés.
10
Derrida, pp. 291-2. Per il testo di Rousseau citato vedi Emile, p. 173.
11
Sull’educazione alla liberalità mediata dalla persuasione vedi Emile, pp. 172-3: On trouve encore un expédient à cela, c’est de rendre bien vite à l’enfant ce qu’il a donné, de sorte qu’il
s’accoutume à donner tout ce qu’il sait bien qui lui va revenir. Je n’ai guère vu dans les enfants
que ces deux espèces de générosité: donner ce qui ne leur est bon à rien, ou donner ce qu’ils sont
sûrs qu’on va leur rendre. Faites en sorte, dit Locke, qu’ils soient convaincus par expérience que
le plus libéral est toujours le mieux partagé. C’est là rendre un enfant libéral en apparence et avare
en effet. Il ajoute que les enfants contracteront ainsi l’habitude de la libéralité. Oui, d’une libéralité
usurière, qui donne un œuf pour avoir un bœuf. Mais, quand il s’agira de donner tout de bon,
adieu l’habitude; lorsqu’on cessera de leur rendre, ils cesseront bientôt de donner. Il faut regarder
à l’habitude de l’âme plutôt qu’à celle des mains.
Analogia e decostruzione nell’Essai di Rousseau
135
si colloca dalla parte della scimmiottatura, o della forma cattiva dell’imitazione, poiché si presenta come falsificazione o simulazione della vera liberalità,
dalla quale si distingue per la disponibilità a donare cose che non sono care o
non valgono niente.
La corrispondenza di scimmiottatura e liberalità usuraria replica lo schema generale della connessione tra la finzione e l’insegnamento persuasivo, che
Rousseau articola attraverso la critica della persuasione al dovere dell’obbedienza in genere. In questo caso, spiega Rousseau, l’obbedienza viene perseguita ricorrendo a certi supplementi della presunta persuasione, come le minacce o le promesse12. Allora la condizione di interesse induce il fanciullo ad
una serie di operazioni riconducibili sotto il concetto della cattiva imitazione o
della falsificazione dell’obbedienza: simulare la persuasione o la sensibilità alla
ragione del dovere, che pure è preclusa dall’età, nascondere la propria volontà
dietro quella altrui, coprire la disobbedienza, riconoscere il proprio errore solo
quando si è scoperti. Dunque l’insegnamento persuasivo provoca la perversione
dell’educazione, che è necessariamente connessa alla perversione dell’imitazione: simulazione, falsificazione, menzogna, abitudine a coprire un motivo segreto sotto un altro apparente, ad ostacolare la conoscenza del proprio carattere, a
ripagare gli altri con parole vane.
Qu’arrive-t-il de là? Premièrement, qu’en leur imposant un devoir qu’ils
ne sentent pas, vous les indisposez contre votre tyrannie et les détournez de
vous aimer; que vous leur apprenez à devenir dissimulés, faux, menteurs,
pour extorquer des récompenses ou se dérober aux châtiments; qu’enfin, les
accoutumant à couvrir toujours d’un motif apparent un motif secret, vous
leur donnez vous-même le moyen de vous abuser sans cesse, de vous ôter la
connaissance de leur vrai caractère, et de payer vous et les autres de vaines
paroles dans l’occasion13.
12
Vedi ivi, p. 141: En essayant de persuader à vos élèves le devoir de l’obéissance, vous
joignez à cette prétendue persuasion la force et les menaces, ou, qui pis est, la flatterie et les
promesses. Ainsi donc, amorcés par l’intérêt ou contraints par la force, ils font semblant
d’être convaincus par la raison. Ils voient très bien que l’obéissance leur est avantageuse, et
la rébellion nuisible, aussitôt que vous vous apercevez de l’une ou de l’autre. Mais comme
vous n’exigez rien d’eux qui ne leur soit désagréable, et qu’il est toujours pénible de faire les
volontés d’autrui, ils se cachent pour faire les leurs, persuadés qu’ils font bien si l’on ignore
leur désobéissance, mais prêts à convenir qu’ils font mal, s’ils sont découverts, de crainte d’un
plus grand mal.
13
Ivi pp. 141-2.
136
Mauro Senatore
Dalla parte opposta la forma buona dell’imitazione presuppone la trasmissione della vera liberalità, che esige la presenza del cuore, attraverso l’archiviazione dell’esempio del maestro nella memoria del fanciullo. E’ lo stesso Rousseau a riconoscere che questa mediazione contiene in sé la prescrizione dell’alterazione. E proprio nell’articolazione di questa mediazione, che tradisce l’irriducibilità del nesso di imitazione e alterazione, Derrida individua il nucleo stesso
del concetto di pedagogia come apprendimento di ciò che non si comprende e
del rinvio sistematico all’imitazione che lo costituisce.
Mais cette bonne imitation porte déjà en elle-même les prémisses de
son altération. Et tout le problème de la pédagogie dans l’Emile peut s’y
résumer. L’enfant est d’abord passif, l’exemple se grave d’abord dans la
mémoire en attendant d’entrer dans le cœur. Or il peut rester dans la mémoire sans toucher le cœur; et inversement, la ressemblance entre la cœur
et la mémoire fait qu’à son tour l’enfant peut feindre d’agir selon le cœur
au moment où il se contente d’imiter selon le signes de la mémoire. Il peut
toujours se contenter de donner des signes. Dans un premier temps, la
bonne imitation peut être impossible, dans un deuxième temps, elle peut
être détournée de son bon usage. … La possibilité de l’imitation semble
donc interrompre la simplicité naturelle. Avec l’imitation, n’est-ce pas la
duplicité qui s’insinue dans la présence?14
Derrida rileva la passività originaria del fanciullo rispetto all’esempio del
maestro, o alla vera liberalità, che comporta fin dal principio la possibilità
della disconnessione permanente tra i segni e il cuore. Questa passività tradisce l’eterogeneità e l’esteriorità dei segni e della memoria in genere rispetto
all’esempio del maestro. Tuttavia l’archiviazione costituisce anche la possibilità della trasmissione dell’esempio, cioè della presenza del cuore, articolandosi, dunque, come la registrazione di quella presenza in una forma istituzionale e riproduttiva, come i segni della memoria, che ne supplisce la condizione
strutturale di contingenza e singolarità consentendone la conservazione e la
circolazione a prescindere da quella condizione stessa. In questo caso l’archiviazione dell’esempio apre alla scimmiottatura o alla falsificazione della vera
liberalità, che si danno attraverso l’imitazione o la riproduzione dei segni e,
dunque, la simulazione della presenza del cuore15. Questa apertura comunica
Derrida, pp. 292-3.
Vedi Émile, p. 174: Je sais que toutes ces vertus par imitation sont des vertus de singe, et
que nulle bonne action n’est moralement bonne que quand on la fait comme telle, et non parce
14
15
Analogia e decostruzione nell’Essai di Rousseau
137
con la necessità dell’alterazione contenuta nella prestazione dei segni, nell’artificio dell’artificio, che fin dal principio simula la presenza del rappresentato
e si scambia con esso. Dunque la scimmiottatura, la perversione dell’imitazione generata dalla falsificazione della presenza del cuore, o dalla riproduzione dei segni, individua l’alterazione prescritta nella possibilità della buona
imitazione, dell’archiviazione della presenza nei segni della memoria o della
somiglianza tra il cuore e i segni. Inoltre, poiché la possibilità dell’imitazione costituisce la condizione necessaria alla conservazione e alla trasmissione
della semplicità naturale e della presenza e poiché tale possibilità si esplica
mediante l’archiviazione nella forma istituzionale del segno, che implica la
somiglianza tra la natura o la presenza, da una parte, e l’istituzione o il segno,
dall’altra, allora la semplicità naturale e la presenza si sdoppiano fin dal principio nella loro imitazione, che porta con sé la prescrizione della sua alterazione, la scimmiottatura, la falsificazione o la riproduzione16.
Dentro la trama generale del rapporto dell’infanzia all’imitazione e ai segni Derrida rileva anche la questione del rapporto al significante separato o
al feticcio, che viene richiamata da Rousseau nel passaggio in cui giustifica la
liberalità del fanciullo nel donare il denaro con l’incapacità costitutiva a provare passione per ciò che non rinvia ad alcun significato.
L’enfant selon Rousseau, c’est le nom de ce qui devrait n’avoir aucun
rapport avec un signifiant séparé, aimé en quelque sorte pour lui-même, tel
un fétiche. Or cet usage pervers du signifiant est en quelque sorte à la fois
interdit et toléré par la structure de l’imitation. Dès qu’un signifiant n’est
plus imitatif, la menace de perversion devient sans doute plus aigüe. Mais
que d’autres la font. Mais, dans un âge où le cœur ne sent rien encore, il faut bien faire imiter aux
enfants les actes dont on veut leur donner l’habitude, en attendant qu’ils les puissent faire par
discernement et par amour du bien.
16
Rousseau produce uno schema analogo a quello che articola la forma della buona
imitazione quando riconosce alla memoria del fanciullo, che è identificata con la facoltà
passiva e riproduttiva dell’archiviazione, la possibilità di costituire materiale per il giudizio. Cfr. Émile, p. 194: Sans étudier dans les livres, l’espèce de mémoire que peut avoir un
enfant ne reste pas pour cela oisive; tout ce qu’il voit, tout ce qu’il entend le frappe, et il s’en
souvient; il tient registre en lui-même des actions, des discours des hommes; et tout ce qui
l’environne est le livre dans lequel, sans y songer, il enrichit continuellement sa mémoire en
attendant que son jugement puisse en profiter. Questa economia della memoria non è immune dall’alterazione e dall’artificio poiché si tiene sulla somiglianza tra la conoscenza e
la forma istituzionale dei segni nella quale è archiviata, che pure, in altri luoghi, è necessariamente rimossa. Vedi, ad esempio, il caso dell’apprendimento delle fiabe in Émile, p.
195: Émile n’apprendra jamais rien par cœur, pas même des fables, pas même celles de La
Fontaine, toutes naïves, toutes charmantes qu’elles sont; car les mots des fables ne sont pas
plus les fables que les mots de l’histoire ne sont l’histoire.
138
Mauro Senatore
déjà dans l’imitation, le décalage entre la chose même et son double, voire
entre le sens et son image, assure un logement au mensonge, à la falsification et au vice.17
Il feticcio dispiega la vita perversa e artificiosa in cui il segno, sciogliendosi
dalla presenza che interviene a supplire, crea intorno a sé fascinazione e desiderio. La struttura dell’imitazione respinge questa possibilità di vita riconosciuta
al segno nella misura in cui esso è determinato dalla funzione di sostituzione
della presenza, cioè si articola entro la guerra per la riappropriazione ideale
della presenza stessa. E, tuttavia, la stessa struttura dell’imitazione ne ammette
la virtualità infida, ne contiene lo sviluppo sottile, poiché, fin dal principio della
guerra, la supplenza della presenza comporta la conservazione e la circolazione
del segno al di là della presenza stessa. Dunque, le prime forme dell’alterazione,
come mostra lo stesso Rousseau, sono la menzogna, la falsificazione e il vizio,
che si danno come scimmiottatura, o simulazione della presenza; poi viene il
feticcio, che individua un grado ulteriore o secondo di perversione, in cui il
segno, o la forma istituzionale in genere, sopravvive alla presenza stessa, cioè
si conserva e produce effetti a prescindere da qualsiasi rinvio a ciò che rappresenta.
La riproduzione originaria
Comme les sentiments qu’excite en nous la peinture ne viennent
point des couleurs, l’empire que la musique a sur nos âmes n’est point
l’ouvrage des sons. De belles couleurs bien nuancées plaisent à la vue,
mais ce plaisir est purement de sensation. C’est le dessin, c’est l’imitation qui donne à ces couleurs de la vie et de l’âme; ce sont les passions
qu’elles expriment qui viennent émouvoir les nôtres; ce sont les objets
qu’elles représentent qui viennent nous affecter. L’intérêt et le sentiment
ne tiennent point aux couleurs; les traits d’un tableau touchant nous
touchent encore dans une estampe; ôtez ces traits dans le tableau, les
couleurs ne feront plus rien18.
L’ambiguità del discorso sull’imitazione elaborato nell’Essai è tematizzata
Derrida, p. 291.
J.-J. Rousseau, Essai sur l’origine des langues, in Œuvres Complètes (vol.XI), cap. XIII,
pp. 274-5.
17
18
Analogia e decostruzione nell’Essai di Rousseau
139
da Derrida attraverso la lettura della determinazione dell’arte come disegno e
imitazione. In particolare, questa lettura sviluppa le conseguenze della connessione articolata nel testo di Rousseau tra il concetto di tratto, che descrive il
testo significante dell’arte, e quello di stampa, che ne individua la riproduzione
o la copia. La relazione tra questi concetti può essere pensata secondo lo schema generale che tiene insieme nella funzione dell’archiviazione dell’esempio la
possibilità della buona imitazione e la necessità della sua perversione.
L’estampe: l’art naissant de l’imitation, n’appartient a l’œuvre proprement dite que ce qui peut être retenu dans l’estampe, dans l’impression reproductrice des traits. Si le beau ne perd rien à être reproduit, si on le reconnaît dans son signe, dans ce signe du signe qu’est une copie, c’est que dans
la « première fois » de sa production il était déjà essence reproductive. L’estampe, qui copie les modèles de l’art, n’est pas moins le modèle de l’art. Si
l’origine de l’art est la possibilité de l’estampe, la mort de l’art et l’art comme
mort sont prescrits dès la naissance de l’œuvre. Le principe de vie, une fois
de plus, se confonde avec le principe de mort. Une fois de plus, Rousseau
désire lès séparer mais un fois de plus, il fait droit dans sa description et
dans son texte à ce qui limite ou contredit son désir19.
Poiché l’imitazione, che costituisce l’essenza dell’arte, è registrazione della
presenza, ad esempio, della passione, nella forma istituzionale della rappresentazione o del segno, che ne permette la conservazione e trasmissione, e,
dunque, riproduzione, allora ciò che pertiene all’essenza dell’opera deve poter
essere trattenuto nella stampa, cioè nella riproduzione della forma istituzionale
e riproduttiva, riproduzione di riproduzione o segno di segno. Questa conclusione rileva l’alterazione originaria dell’arte o dell’imitazione nella riproduzione o nella stampa, e, dunque, la somiglianza delle passioni con i diversi gradi
della riproduzione, dal segno alla stampa, in cui si configura la possibilità della
comunicazione e della trasmissione delle passioni stesse al di là della loro esistenza immediata e contingente.
Gli effetti, che si propagano a partire da questa lettura del destino dell’imitazione, investono le questioni dell’essenza del bello, della distinzione tra copia
e modello e dell’origine e della vita dell’arte.
In primo luogo, l’articolazione del concetto di bello rinvia ad un’essenza riproduttiva. Se, infatti, il bello consiste nella funzione della riproduzione della
19
Derrida, pp. 296-7.
140
Mauro Senatore
passione o della sua archiviazione in una forma istituzionale, o segno, e, dunque,
della sua somiglianza con la forma o il segno stessi, allora la riproduzione della
forma, cioè la riproduzione della riproduzione, o il segno del segno, o, ancora, la
copia, con la quale è identificata volgarmente la stampa, non deve poter comportare alcuna perdita per il bello. In questo concetto di perdita si gioca tutta l’ambiguità strutturale che è all’opera nell’economia dell’imitazione. In secondo luogo,
se l’arte imitativa e, dunque, il tratto che la descrive sono fin dal principio forma
istituzionale, riproduzione o segno, allora il rapporto di derivazione della stampa
all’arte, che riflette quello più generale della copia al modello, deve poter essere
ribaltato: la copia deve poter essere modello del modello, come il modello deve
poter essere copia della copia. Dunque, ogni segno si sdoppia, per una necessità
strutturale e inflessibile, in segno di segno. Infine, se la possibilità dell’alterazione dell’arte nella stampa è implicata fin dal principio nella funzione espressiva e
riproduttiva del tratto, allora il rapporto tra la vita e la morte dell’arte si articola
nella forma della confusione dei principi opposti e non della loro divisione. Questa forma della confusione della vita e della morte e, dunque, della presenza e
dell’assenza costituisce la struttura fondamentale dei concetti dell’imitazione e
del segno in genere, nella misura in cui la conservazione e la trasmissione della
vita e della presenza è mediata dalla registrazione in una forma istituzionale e
riproduttiva che, fin dal principio, ne simula la presenza.
L’ulteriore determinazione dell’arte come tratto formale consente di connettere il concetto di imitazione ad altre forme, come la tecnica d’imitazione,
il calcolo, la grammatica, la scienza razionale degli elementi o la sistemazione
delle regole, che, secondo la determinazione tradizionale della loro funzione,
garantiscono la riproduzione e, dunque, individuano l’essenza istituzionale e
riproduttiva del tratto e del segno in genere20. Esse sono in qualche modo equi-
20
Per la determinazione della melodia e del disegno come tratto formale, sulla quale
Rousseau fonda la critica dell’estetica sostanzialista che assegna alla materia stessa il potere
di comunicare la passione, vedi Essai, cap. XIII p. 275 : La mélodie fait précisément dans la
musique ce que fait le dessin dans la peinture ; c’est elle qui marque les traits et les figures, dont
les accords et les sons ne sont que les couleurs. Mais, dira-t-on, la mélodie n’est qu’une succes­sion
de sons. Sans doute ; mais le dessin n’est aussi qu’un arrangement de couleurs. Un orateur se
sert d’encre pour tracer ses écrits : est-ce à dire que l’encre soit une liqueur fort éloquente? Sulla
discriminazione tra imitazione e tratto formale vedi ivi, cap. XIII p. 278: Comme donc la peinture n’est pas l’art de combiner des couleurs d’une manière agréable à la vue, la musique n’est pas
non plus l’art de combiner des sons d’une manière agréable à l’oreille. S’il n’y avait que cela, l’une
et l’autre seraient au nombre des sciences naturelles et non pas des beaux-arts. C’est l’imitation
seule qui les élève à ce rang. Or, qu’est-ce qui fait de la peinture un art d’imitation? c’est le dessin.
Qu’est-ce qui de la musique en fait un autre? C’est la mélodie. La lettura a seguire della reazione
di Rousseau al formalismo si propone di delineare le ragioni sistematiche dell’esitazione di
Rousseau tra la critica e l’adesione al concetto di tratto formale.
Analogia e decostruzione nell’Essai di Rousseau
141
valenti alla stampa nella misura in cui rappresentano l’alterazione prescritta
nella funzione dell’espressione e della riproduzione delle passioni.
Si l’art vit d’une reproduction originaire, le trait qui permet cette reproduction ouvre du même coup l’espace du calcul, de la grammaticalité, de la
science rationnelle des intervalles et de ces «règles de l’imitation» fatales à
l’énergie. Rappelons nous: «A mesure qu’on multipliait les règles de l’imitation, la langue imitative s’ affaiblissait.» L’imitation serait donc à la fois la
vie et la mort de l’art. L’art et la mort, l’art et sa mort seraient compris dans
l’espace d’altération de l’itération originaire (iterum, de nouveau, ne vientil pas du sanscrit itara, autre?); de la répétition, de la reproduction, de la
représentation; ou aussi bien dans l’espace comme possibilité de l’itération
et sortie de la vie mise hors d’elle-même21.
Costituendo la condizione della riproduzione originaria, cioè dell’alterazione dell’imitazione in stampa, in cui si determina la vita-morte dell’arte, il tratto
si presta all’economia della comunicazione della passione e, ad un tempo, comporta la dissipazione dell’energia o della forza affettiva dell’arte. Lo schema di
questa perversione originaria è articolato in modo esemplare dalla forma della
moltiplicazione delle regole, che rappresenta la sistemazione teorica dell’imitazione, la sua archiviazione nei segni della memoria e, dunque, la sua disponibilità costitutiva alla riproduzione e alla falsificazione.
La necessità dell’alterazione, contenuta nella formula della riproduzione
originaria, è formalizzata da Derrida nella struttura dello spazio di alterazione
dell’iterazione originaria. Essa può consistere nello spazio stesso, nella misura
in cui costituisce l’elemento esterno ed eterogeneo rispetto alla presenza e alla
vita, la forma istituzionale dell’immagine o della rappresentazione, in cui l’imitazione le fa passare o le esprime, l’analogo per il quale ogni arte è pittura.
A questo punto si deve concludere con Derrida che la reazione contro il formalismo elaborata da Rousseau nei capitoli XIII e XIV dell’Essai è organizzata dal desiderio di rimuovere la necessità dell’alterazione implicata nell’essenza riproduttiva
dell’arte attraverso un’operazione di divisione equivalente a quella registrata nella
discriminazione tra la forma buona dell’imitazione e la sua perversione.
Selon une logique avec laquelle nous somme maintenant familiarisées,
Rousseau va au devant de ce danger en opposant la bonne forme à la mau21
Derrida, p. 297.
142
Mauro Senatore
vaise forme, la forme de vie à la forme de mort, la forme mélodique à la
forme harmonique, forme à contenu imitatif et forme sans contenu, forme
pleine de sens et abstraction vide. Rousseau réagit alors contre le formalisme. Celui-ci est aussi à ses yeux un matérialisme et un sensualisme22.
L’operazione di divisione, in cui si dispiega la logica classica dell’identità
dello stesso e dell’opposizione tra i termini esteriori ed eterogenei, determina l’imitazione e la sua alterazione originaria, cioè le forme che assicurano la
riproduzione, nelle serie opposte della forma buona o vivente dell’arte e della
forma cattiva o priva di energia. Nell’arte della musica i termini della divisione sono la melodia, che individua il genere imitativo della musica e, dunque,
il suo grado puro da ogni alterazione, e l’armonia, che rappresenta il genere
riproduttivo e, dunque, la forma esterna ed eterogenea che insinua la corruzione nell’arte. Questo schema, che sottende all’articolazione della reazione al
formalismo proposta nell’Essai, si presenta come il prodotto dell’unificazione e
della stilizzazione della polemica con Rameau articolata da Rousseau in diverse opere precedenti.
La scienza delle sfumature
Il concetto di formalismo, elaborato da Rousseau nel capitolo dell’Essai dedicato alla melodia presenta un’articolazione esemplare in cui la forma della
perversione della melodia è sviluppata attraverso l’analogia con la pittura23.
Supposez un pays où l’on n’aurait aucune idée du dessin, mais où beaucoup de gens, passant leur vie à combiner, mêler, nuer des couleurs, croiraient exceller en peinture. Ces gens-là raisonneraient de la nôtre précisément comme nous raisonnons de la musique des Grecs. Quand on leur
parlerait de l’émotion que nous causent de beaux tableaux et du charme de
s’attendrir devant un sujet pathétique, leurs savants approfondiraient aussitôt la matière, compareraient leurs couleurs aux nôtres, examineraient
si notre vert est plus tendre ou notre rouge plus éclatant; ils chercheraient
Derrida, p. 298.
Derrida sottolinea la singolarità di questa articolazione in ivi, p. 304: … il n’est pas indifférent que l’argumentation pédagogique qui les [les définitions] soit tout entière empruntée à
l’analogie avec une art de l’espace, la peinture.; e ivi, p. 305: Le chapitre XIII “De la Mélodie” est
presque entièrement consacré à la peinture.
22
23
Analogia e decostruzione nell’Essai di Rousseau
143
quels accords de couleurs peuvent faire pleurer, quels autres peuvent mettre en colère; Les Burettes de ce pays-là rassembleraient sur des guenilles
quelques lambeaux défigurés de nos tableaux; puis on se demanderait avec
surprise ce qu’il y a de si merveilleux dans ce coloris24.
L’analogia tra la musica, o le arti in genere, e la pittura, come arte dello
spazio, insiste sulla funzione espressiva e riproduttiva dell’imitazione, che fa
passare o registra le passioni in una forma istituzionale, esterna ed eterogenea
rispetto alla loro esistenza immediata e contingente, che ne supplisce l’inefficacia strutturale alla conservazione e alla trasmissione. Dunque la necessità della
perversione delle arti, della dissipazione della loro energia o forza affettiva, della loro morte, che marca fin dal principio la somiglianza tra le passioni e le loro
rappresentazioni, è prescritta nell’analogia stessa delle arti alla pittura. Entro
questa articolazione di arte e pittura la determinazione della forma cattiva della
pittura o della forma esterna ed eterogenea che ne comporta la perversione, in
cui si svolge la rimozione dell’alterazione originaria dell’arte, cioè dell’alterazione prescritta nell’analogia delle arti alla pittura, assolve ad una funzione esemplare e, ad un tempo, essenziale. Discriminando il genere imitativo della pittura
dalla scienza dei rapporti tra i colori e delle sfumature, cioè dalla cromatica,
Rousseau intende rimuovere la necessità della perversione implicata nella funzione di supplenza assolta dall’immagine o dalla rappresentazione, e, dunque,
dalla pittura, che costituisce la condizione stessa dell’imitazione e delle arti. La
determinazione della forma di pittura pura da ogni alterazione produce il supporto sul quale articolare il concetto di imitazione, che individua l’essenza delle
arti e dell’arte in genere.
Dunque la perversione della pittura e dell’arte in genere è il risultato della
rimozione dall’imitazione della sua essenza riproduttiva, o della riproduttività originaria del segno in genere, e, dunque, della divisione tra l’imitazione o
l’espressione delle passioni e le forme che consentono fin dal principio la riproduzione dell’imitazione, o del segno. Entro questa prospettiva sistematica si
determinano le proprietà strutturali della perversione.
Il s’agit de montrer d’abord par cet exemple que la science des rapports
est froide, sans énergie imitative (tel le calcul des intervalles dans l’harmonie) tandis que l’expression imitative du sens (de la passions, de la chose
24
Essai, cap. XIII pp. 275-6.
144
Mauro Senatore
en tant qu’elle nous intéresse) est le vrai contenu de l’art. Ne soyons pas
surpris de voir Rousseau ranger alors le dessin du coté de la science et du
calcul des rapports. Le paradoxe est apparent. Par dessin, il faut entendre
condition de l’imitation; par couleur, substance naturelle, dont le jeu est
explicable par des causses physique et peut devenir l’objet d’une science
quantitative des rapports, d’une science de l’espace et de la disposition analogique des intervalles. L’analogie entre les deux arts – musique et peinture
apparaît ainsi: c’est l’analogie elle-même. Ces deux arts comportent un
principe corrupteur, qui étrangement est aussi dans la nature, et dans les
deux cas, ce principe corrupteur est lié à l’espacement, à la régularité calculable et analogique des intervalles25.
La perversione si presenta sotto la forma di una scienza quantitativa che ha
per oggetto i colori considerati come sostanza naturale il cui gioco di combinazioni, rapporti e analogie può essere spiegato, cioè sistemato teoricamente, o
registrato nella forma istituzionale della regola, attraverso il ricorso ai principi
della fisica. Lo statuto della scienza dei rapporti tradisce la necessità sistematica del ricongiungimento nella forma della perversione dell’arte di formalismo e materialismo, operazione quantitativa e ordine sensuale o immediato
degli effetti. La separazione dall’imitazione, in cui si determina il concetto della
scienza dei rapporti, situa la scienza stessa dalla parte opposta al disegno, che
individua il principio dell’imitazione e dell’espressione che trasforma i colori in
segni o immagini, dà loro vita, li anima, li rende capaci di trasmettere le passioni26. La scienza dei rapporti si intreccia alla dissipazione dell’energia dell’arte, o della sua capacità di trasmettere le passioni, combinando la freddezza o
l’astrazione del calcolo con il sensualismo o l’immediatezza del mondo fisico.
Questa combinazione sistematica rinvia all’articolazione della nuova filosofia
europea che Rousseau descrive come la forma di perversione corrispondente
alla riduzione materialistica delle operazioni dell’anima e alla disconnessione
delle passioni e degli effetti morali dai sentimenti umani27.
Derrida, p. 304.
Sul concetto di disegno vedi Essai, pp. 274-5, cap. XIII (vedi supra nota 18)
27
Vedi Essai, cap. XV, pp. 284-5: Que celui donc qui veut philosopher sur la force des sensations commence par écarter, des impressions purement sensuelles, les impressions intellectuelles
et morales que nous recevons par la voie des sens, mais dont ils ne sont que les causes occasionnelles; qu’il évite l’erreur de donner aux objets sensibles un pouvoir qu’ils n’ont pas, ou qu’ils tiennent des affections de l’âme qu’ils nous représentent. Les couleurs et les sons peuvent beaucoup
comme représentations et signes, peu de chose comme simples objets des sens. Des suites de sons
25
26
Analogia e decostruzione nell’Essai di Rousseau
145
Nel testo dell’Essai la perversione della pittura è connessa sistematicamente
alla duplice determinazione della storicità e dell’etnocentrismo attraverso l’analogia suggerita da Rousseau tra la finzione della nazione formalista che giudica
la pittura imitativa e la posizione della modernità europea rispetto alla musica
dei Greci. Questa posizione viene articolata da Rousseau nella voce harmonie
del Dictionnaire de la Musique in cui il sistema dell’armonia, fondato sul principio dell’analogia degli intervalli e del rapporto tra i suoni, è determinato come
perversione storica ed etnocentrica della forma buona della musica, rappresentata dal genere imitativo della melodia.
Quand on songe que, de tous les peuples de la terre, qui tous ont une
musique et un chant, les Européens sont les seuls qui aient une harmonie, des accords, et qui trouvent ce mélange agréable; quand on songe que
le monde a duré tant de siècles, sans que, de toutes les nations qui ont
cultivé les beaux-arts, aucune ait connu cette harmonie; qu’aucun animal,
qu’aucun oiseau, qu’aucun être dans la nature ne produit d’autre accord
que l’unisson, ni d’autre musique que la mélodie; que les langues orientales, si sonores, si musicales; que les oreilles grecques, si délicates, si sensibles, exercées avec tant d’art, n’ont jamais guidé ces peuples voluptueux et
passionnés vers notre harmonie; que sans elle leur musique avait des effets
si prodigieux; qu’avec elle la nôtre en a de si faibles; qu’enfin il était réservé
à des peuples du Nord, dont les organes durs et grossiers sont plus touchés
de l’éclat et du bruit des voix que de la douceur des accents et de la mélodie
des inflexions, de faire cette grande découverte et de la donner pour principe
à toutes les règles de l’art; quand, dis-je, on fait attention à tout cela, il est
bien difficile de ne pas soupçonner que toute notre harmonie n’est qu’une
invention gothique et barbare, dont nous ne nous fussions jamais avisés si
nous eussions été plus sensibles aux véritables beautés de l’art et à la musique vraiment naturelle28.
ou d’accords m’amuseront un moment peut-être; mais, pour me charmer et m’attendrir, il faut
que ces suites m’offrent quelque chose qui ne soit ni son ni accord, et qui me vienne émouvoir
malgré moi. Les chants mêmes qui ne sont qu’agréables et ne disent rien lassent encore; car ce
n’est pas tant l’oreille qui porte le plaisir au cœur, que le cœur qui le porte à l’oreille. Je crois
qu’en développant mieux ces idées on se fût épargné bien de sots raisonnements sur la musique
ancienne. Mais dans ce siècle où l’on s’efforce de matérialiser toutes les opérations de l’âme, et
d’ôter toute moralité aux sentiments humains, je suis trompé si la nouvelle philosophie ne devient
aussi funeste au bon goût qu’à la vertu.
28
J.-J. Rousseau, Dictionnaire de Musique, in Œuvres Complètes (vol.XII), pp. 432-3. Sullo
schema dell’articolazione storica ed etnocentrica della perversione della musica vedi Derrida,
p. 301: L’égarement de Rameau est un symptôme. Il trahit à la fois la maladie de l’histoire occi-
146
Mauro Senatore
La forma buona della musica è individuata dalla convergenza della serie
della melodia, che allinea la musica delle lingue orientali, l’orecchio sensibile
e delicato dei Greci e la civiltà voluttuosa ed appassionata, con la serie delle
bellezze naturali, costituita dal canto degli uccelli e degli altri esseri della natura. Questa convergenza esplica l’esigenza sistematica di identificare il genere imitativo della musica con l’origine naturale e pura da ogni alterazione. La
perversione storica della musica, cioè l’armonia, che fin dal principio coniuga
la forma cattiva e la sua sistemazione teorica, si articola secondo la struttura
generale della trama di formalismo e sensualismo, scienza e materia: essa riannoda nella formula ambigua dell’invenzione gotica e barbara i termini del calcolo degli intervalli, inventato dai popoli del Nord, e dell’ordine dello schianto,
del rumore e della sensibilità dura e rozza.
Nel testo dell’Essai, il discorso fittizio che annuncia i progressi della civiltà
formalista è affidato ad un artista, che riassume i tratti del rappresentante della perversione storica, dall’invenzione della scrittura a quella dell’armonia, da
Theut a Rameau: l’essere straniero e, ad un tempo, teorico dell’arte29. La perversione dell’arte proviene sistematicamente da fuori o da altro, poiché è divisa
dall’origine naturale e pura dell’arte stessa, e si connette necessariamente alla
teoria, alla scienza o alla sistemazione delle regole, che rappresentano le condizioni di riproducibilità, calcolabilità e regolarità previste dalla funzione stessa
dell’immagine e della rappresentazione.
Aussitôt quelque artiste célèbre établirait là-dessus un beau système.
Messieurs, leur dirait-il, pour bien philosopher, il faut remonter aux causes
physiques. Voilà la décomposition de la lumière ; voilà toutes les couleurs
primitives; voilà leurs rapports, leurs proportions, voilà les vrais principes
du plaisir que vous fait la peinture. Tous ces mots mystérieux de dessin, de
représentation, de figure, sont une pure charlatanerie des peintres français,
qui, par leurs imitations, pensent donner je ne sais quels mouvements à
dentale et l’ethnocentrisme européen. Car l’harmonie, selon Rousseau, est une perversion musicale qui ne domine qu’en Europe (en Europe du nord) et l’ethnocentrisme consisterait à la considérer comme un principe naturel et universel de la musique. L’harmonie qui détruit l’énergie de
la musique et en entrave la force imitative – la mélodie – est absente dans les commencements
de la musique (in illo tempore) et dans les musiques non européennes (alibi). On se demandera
si Rousseau, conformément à une schéma que nous connaissons bien maintenant, ne critique
pas l’ethnocentrisme par un contre-ethnocentrisme symétrique et un ethnocentrisme occidental
profond: notamment en revendiquant l’harmonie comme le mal et la science propres à l’Europe.
29
Vedi Derrida, p. 306: Et Rousseau prolonge encore le discours imaginaire de cet étranger
qui n’est en somme que le correspondant – étranger et théoricien de la peinture – d’un musicien et
musicographe français, l’analogue de Rameau.
Analogia e decostruzione nell’Essai di Rousseau
147
l’âme, tandis qu’on sait qu’il n’y a que des sensations. … Moi, je vous ai
montré les grands, les vrais principes de l’art. Que dis-je, de l’art ! de tous
les arts, messieurs, de toutes les sciences. L’analyse des couleurs, le calcul
des réfractions du prisme vous donnent les seuls rapports exacts qui soient
dans la nature, la règle de tous les rapports. Or, tout dans l’univers n’est que
rapport. On sait donc tout quand on sait peindre; on sait tout quand on
sait assortir des couleurs. Que dirions-nous du peintre assez dépourvu de
sentiment et de goût pour raisonner de la sorte, et borner stupidement au
physique de son art le plaisir que nous fait la peinture? Que dirions-nous
du musicien qui, plein de préjugés semblables, croirait voir dans la seule
harmonie la source des grands effets de la musique?30
Il discorso dell’artista e teorico straniero sviluppa in particolare la pretesa
ad assumere i principi del proprio sistema di pittura come i veri principi dell’arte e, in genere, di tutte le arti e di tutte le scienze. Questa pretesa è fondata
sull’ispirazione scientifica del sistema che individua nell’analisi fisica dei colori
e dei loro rapporti il fondamento degli effetti dell’arte31. La scienza della pittura
viene a sovrapporsi alla scienza in genere nella misura in cui si presenta come
analisi e calcolo dei soli rapporti che esistono in natura e, dunque, della regola di tutti i rapporti. Entro l’articolazione di questo sistema è necessario che i
concetti del disegno, della rappresentazione e dell’immagine, che costituiscono la condizione dell’imitazione e, dunque, della trasmissione dei movimenti
dell’anima o delle passioni, siano ridotti a parole vane, chiacchiere. Dunque, la
prospettiva sistematica della determinazione del formalismo come perversio-
Essai, cap. XIII, pp. 276-7.
Svolgendo lo schema della convergenza di scienza e materia Rousseau offre una
duplice rappresentazione degli effetti dell’arte formalistica, che sono articolati nell’ordine
del piacere fisico ed immediato prodotto dal genere artistico non imitativo e, dunque,
inefficace a trasmettere passioni, e nell’ordine del piacere intellettualistico e non naturale
prodotto dai principi del calcolo e della scienza dei rapporti. Vedi, ad esempio, Essai,
cap. XIV, p. 279: L’harmonie proprement dite est dans un cas bien moins favorable encore.
N’ayant que des beautés de convention, elle ne flatte à nul égard les oreilles qui n’y sont pas
exercées; il faut en avoir une longue habitude pour la sentir et pour la goûter. Les oreilles rustiques n’entendent que du bruit dans nos consonances. Quand les proportions naturelles sont
altérées, il n’est pas étonnant que le plaisir naturel n’existe plus ...; e Dictionnaire, p. 433:
Monsieur Rameau prétend cependant que l’harmonie est la source des plus grandes beautés
de la musique; mais ce sentiment est contredit par les faits et par la raison. Par les faits, puisque tous les grands effets de la musique ont cessé, et qu’elle a perdu son énergie et sa force
depuis l’invention du contrepoint; à quoi j’ajoute que les beautés purement harmoniques
sont des beautés savantes, qui ne transportent que des gens versés dans l’art; au lieu que les
véritables beautés de la musique étant de la nature, sont et doivent être également sensibles à
tous les hommes savants et ignorants.
30
31
148
Mauro Senatore
ne della pittura e della determinazione di una forma pura da alterazioni, alla
quale è connessa la possibilità stessa della vita dell’arte in genere, spinge paradossalmente Rousseau a rappresentare l’origine naturale e pura della pittura
mediante la forma istituzionale e riproduttiva dell’immagine o della rappresentazione32.
L’errore dell’artista immaginario è doppio, morale e, insieme, intellettuale,
poiché è generato dalla mancanza di sentimento e di gusto e, nello stesso tempo,
dall’influenza della stupidità e del pregiudizio. La connessione del sentimento,
che si differenzia dalla sensazione per la relazione alla moralità, e del gusto,
che si intende sempre come buon gusto, o come sensibilità morale, incide sulla
ragione umana nella misura in cui la rinvia all’ordine morale e spirituale della
trasmissione delle passioni o della comunicazione della presenza vivente. La
stupidità e il pregiudizio sono predicati della pretesa ad assumere il principio
dei rapporti come la fonte degli effetti della musica. Se la scienza dei rapporti è
divisa dal principio dell’imitazione, allora si determina necessariamente come
esterna ed eterogenea rispetto all’origine naturale dell’arte, cioè come invenzione o artificio. Dunque il sistema dell’artista e teorico straniero deve presentarsi
agli occhi di Rousseau come stupido e pretestuoso.
In un passaggio della presentazione della civiltà formalista Rousseau riconosce ad essa il gusto per le sfumature e per le lunghe gradazioni di tinte, che
non presentano alcun tratto e, dunque, non esprimono nulla33. Queste sfumature, offrendosi come una regolarità calcolabile e analogica, rimandano all’essenza riproduttiva dell’imitazione e dell’arte in genere, rimossa nell’opposizione
tra la scienza dei rapporti e il genere imitativo o espressivo. Derrida suggerisce
per questa scienza il nome di cromatica richiamando la definizione del termine
elaborata da Rousseau nel Dictionnaire.
Chromatique, adjectif pris quelquefois substantivement. Genre de musique qui procède par plusieurs semi-tons consécutifs. Ce mot vient du grec
crwma, qui signifie couleur, soit parce que les Grecs marquaient ce genre
par des caractères rouges ou diversement colorés; soit, disent les auteurs,
32
Derrida rileva questo movimento come l’effetto paradossale di una regola generale che
organizza la critica del sensualismo proposta da Rousseau. Vedi Derrida, p. 296.
33
Vedi Essai, cap. XIII, pp. 275-6: Que si, dans quelque nation voisine, on commençait à
former quelque trait, quelque ébauche de dessin, quelque figure encore imparfaite, tout cela passerait pour du barbouillage, pour une peinture capricieuse et baroque; et l’on s’en tiendrait, pour
conserver le goût, à ce beau simple, qui véritablement n’exprime rien, mais qui fait briller de belles
nuances, de grandes plaques bien colorées, de longues dégradations de teintes sans aucun trait.
Analogia e decostruzione nell’Essai di Rousseau
149
parce que le genre chromatique est moyen entre les deux autres, comme la
couleur est moyenne entre le blanc et le noir; ou, selon d’autres, parce que
ce genre varie et embellit le diatonique par ses semi-tons, qui font dans la
musique le même effet que la variété des couleurs fait dans la peinture34.
Rousseau spiega che il riferimento del termine cromatico ad un certo genere
musicale si fonda sull’analogia che lega gli effetti di questo genere con gli effetti
di varietà o di mediazione prodotti dai colori nella pittura. Dunque l’analogo,
in cui consiste l’elemento cromatico, è di nuovo l’analogia, il rapporto, la regola, la riproduzione, la forma istituzionale e riproduttiva dell’immagine o della
rappresentazione.
Arte e natura
La seule harmonie est même insuffisante pour les expressions qui semblent dépendre uniquement d’elle. Le tonnerre, le murmure des eaux, les
vents, les orages sont mal rendus par de simples accords. Quoi qu’on fasse,
le seul bruit ne dit rien à l’esprit; il faut que les objets parlent pour se faire
entendre; il faut toujours, dans toute imitation, qu’une espèce de discours
supplée à la voix de la nature. Le musicien qui veut rendre du bruit par du
bruit se trompe; il ne connaît ni le faible ni le fort de son art; il en juge sans
goût, sans lumières. Apprenez-lui qu’il doit rendre du bruit par du chant;
que, s’il faisait croasser des grenouilles, il faudrait qu’il les fît chanter: car
il ne suffit pas qu’il imite, il faut qu’il touche et qu’il plaise; sans quoi sa
maussade imitation n’est rien; et ne donnant d’intérêt à personne, elle ne
fait nulle impression35.
L’armonia e, in genere, l’analogia, non contenendo il principio dell’imitazione, disegno o melodia, non sono efficaci ad esprimere la voce della natura,
che in questo caso annoda gli ordini altrove contrapposti dei suoni, o dei ru-
34
Dictionnaire, pp. 202-3. Sulla definizione dell’elemento cromatico vedi Derrida, pp.
304-5: Aussi, dans les deux cas, musique ou peinture, qu’il s’agisse des gammes de couleurs ou
de gammes musicales, d’harmonie de tons comme nuances visibles ou comme nuances audibles,
le calcul rationnel des harmoniques est une chromatique, si on l’entend ce mot au sens large, audelà de ce qu’il spécifie dans la musique, en fait de gamme et de basse. Rousseau ne se sert pas du
mot dans l’Essai, mais l’analogie ne lui échappe pas dans le Dictionnaire … Le chromatique, la
gamme, est à l’origine de l’art ce que l’écriture est à la parole.
35
Essai, cap. XIV pp. 281-2.
150
Mauro Senatore
mori, e dei versi degli animali, rappresentati nel testo dal gracidio delle rane.
Nonostante una certa somiglianza, la forma regolare e calcolabile dell’armonia
o dell’analogia non garantisce la comunicazione della natura. La denuncia di
questa inefficacia insiste sulla divisione tra la forma buona, pura e naturale
dell’imitazione e la sua perversione storica.
L’espressione, o rappresentazione, della natura individua, secondo Rousseau, la condizione in cui i suoni naturali si offrono al riconoscimento, alla comprensione e alla comunicazione con lo spirito, cioè implica la costituzione
dell’ordine morale e spirituale del sentimento e del buon gusto, in cui essi sono
conservati e trasmessi. L’imitazione è efficace ad esprimere o rappresentare la
voce della natura poiché la fa passare nel discorso o nel canto, cioè la registra in
una forma istituzionale che ne supplisce la carenza strutturale garantendone la
comunicazione oltre il suo darsi. Rousseau rileva nella voce della natura, e nella
sua riproduzione semplice, cioè analogica e calcolabile, la mancanza di energia, l’inefficacia essenziale a produrre effetti, come causare sensazioni o lasciare impressioni, che dispieghino l’ordine spirituale e morale della comunicazione. L’essenza dell’arte, dunque, che si determina nell’imitazione, è costituita dal
passaggio o dalla registrazione della voce della natura in una forma istituzionale analoga per prestazione al segno o alla rappresentazione. Per la necessità
infallibile dell’alterazione implicata dall’essenza riproduttiva di questa forma,
essa deve poter essere fin dal principio armonia, o analogia in genere.
Questa articolazione di imitazione e natura offre a Derrida la chiave per sollecitare la rimozione sulla quale si fonda la divisione tra l’origine pura e naturale e la perversione esterna ed eterogenea, che offre lo schema per la divisione
specifica di imitazione e analogia. In questa prospettiva la lettura proposta del
testo si limita a sviluppare le conseguenze inespresse di quella articolazione.
Qu’est-ce que Rousseau dit sans le dire, voit sans le voir? Que la suppléance
a toujours déjà commence; que l’imitation, principe de l’art, a toujours déjà interrompu la plénitude naturelle; que, devant être un discours, elle a toujours déjà
entamé la présence dans la différence; qu’elle est toujours, dans la nature, ce qui
supplée un manque dans la nature, une voix qui supplée la voix de la nature. Il le
dit pourtant sans en tirer les conséquences36.
Se la possibilità di comprendere e comunicare la voce della natura è data
dalla sua registrazione in una forma istituzionale, come il discorso o il canto,
36
Derrida, pp. 308-9.
Analogia e decostruzione nell’Essai di Rousseau
151
che deve essere, per essenza, riproduttiva, regolare o calcolabile, cioè in un’analogia o un segno, allora l’alterazione implicata nella prestazione di questa forma
non individua una perversione storica, esterna ed eterogenea rispetto all’origine naturale, ma è prescritta fin dal principio. Sdoppiando necessariamente la
semplicità naturale nella forma istituzionale e riproduttiva che la supplisce assicurandole la conservazione e la trasmissione al di là della sua esistenza contingente e singolare e, dunque, costituendo l’ordine spirituale e morale della
sua comunicazione, l’imitazione insinua in quella semplicità, dal di dentro, la
frattura di un’analogia o di un segno.
Contributi per una definizione della simmetria in Plotino
153
Contributi per una definizione della simmetria in Plotino
Memoria di Christian Vassallo
presentata dal socio naz. ord. res. Giovanni Casertano
(seduta del 27 marzo 2008)
Abstract. In the numerous studies about the plotinian aesthetics is generally prevailed
the idea that the neoplatonic philosopher categorically rejects an identification between
beauty and symmetry. But a more in-depth analysis of term’s appearances in the Enneads
seems to show that the summetri@a is one of the elements for the full achievement of the
plotinian kalo@n. Naturally, this symmetry is different from the traditional one, beginning
from that of VI-V century (Pythagoras, Polycletus, Plato, the Stoics, till Plutarch): Plotinus’
symmetry, involved in the complex system of the hypostases, isn’t proportioned and regular
in a mathematical sense, but it seems born from the opposites, cohabits with the disorder
and on its nature there are many influences of Heraclitus’ thought.
In esordio, il trattato I, 6 delle Enneadi riprende, estendendola, la terza definizione “socratica” del bello presente nell’Ippia maggiore1. Più in particolare,
per ciò che attiene alle sensazioni, Plotino individua quattro fonti del bello: in
primo luogo la vista (eèn oòyei), poi l’udito (eèn aèkoai^v), le combinazioni di parole
(kata@ te lo@gwn sunqe@seiv) ed ogni genere di musica (eèn mousikh^j kai# aépa@shj)2; procedono quindi, dalla sensazione verso l’alto, altre due fonti: occupazioni, azioni,
disposizioni e scienze belle (eèpithdeu@mata kala# kai# pra@xeiv kai# eçxeiv kai# eèpisth^mai@
te), raggruppate – come pare – in una considerazione unitaria, ed infine la virtù
*Salvo diversa indicazione, le traduzioni dei passi citati sono nostre. L’edizione critica
cui facciamo riferimento per le Enneadi è P. HENRY-H. R. SCHWYZER, Plotini opera, 3 voll.,
Paris - Bruxelles 1951-73 (editio maior).
1
PLAT. HipMa, 297e-298b. Qui Socrate espone ad Ippia, per poi discuterla e rilevarne i
limiti, l’ipotesi che il bello consista in ciò che dia piaceri uditivi e visivi (eiè o° aàn cai@rein héma^v poih^j,
mh@ti pa@sav ta#v hédona@v, aèll è o° aàn dia# th^v aèkoh^v kai# th^v oòyewv, tou^to fai^men eiùnai kalo@n).
2
Sull’eòsti de# kai# che precede quest’ultima espressione si potrebbero fare interessanti osservazioni filologiche con non meno interessanti conseguenze filosofiche. Se l’eòsti de@, espunto
da molti editori, è una classica ripetizione plotiniana, il kai@, come fa notare con arguzia V.
CILENTO, Plotino: Enneadi, vol. I, Bari 1947, pp. 364-365, «è prezioso perché Plotino parla
pure, poeticamente, di un canto senza strumenti (aòjdwn aòneu oèrga@nwn, I, 4, § 118 <79, 25>) e
non ignora la bellezza di una cetra muta (ivi) e tratteggia il tipo ideale del musico (I, 3, § 4 <58,
21-8>) che apre l’anima all’armonia dell’intelligibile. A volte una particella che cade è un’idea
che si perde».
154
Christian Vassallo
(to# tw^n aèretw^n ka@llov). A questo punto, Plotino, riservandosi di mostrare in un
secondo momento se esista oppur no una forma di bellezza che preceda queste
testualmente citate, passa ad un’altra distinzione: quella tra gli esseri belli per
partecipazione (meqe@xei), come i corpi, e gli esseri belli in sé (ta# de# ka@llh auèta@),
come la natura della virtù.
Ma la domanda fondamentale riguarda l’origine misteriosa di quella forza che,
come il filosofo si esprime con una coinvolgente climax, «mette in moto, attrae,
trascina» fino all’estasi della contemplazione gli occhi dello spettatore. La spiegazione tradizionale di tale fenomeno è data dalla simmetria delle parti (summetri@a
tw^n merw^n) fra di loro e rispetto al tutto, con l’aggiunta di un bel colore3, secondo la
3
Insiste molto sul nesso tra simmetria e bel colore (euòcroia) L. STÉPHAN, Symmetria, «Revue d’Esthétique», XIV, 1961, pp. 319-337, in part. pp. 320 ss. Lo studioso distingue innanzitutto
due principali teorie antiche della visione: quella di Empedocle e degli atomisti, da un lato,
che, propendendo per una spiegazione di tipo “meccanicistico”, partirebbero da principi definiti
secondo l’immagine ma sostanzialmente invisibili, da cui deriverebbe il colore; quella dei Pitagorici, di Anassagora, Platone, Aristotele e dello stesso Plotino, dall’altro, che, non riducendo il
visibile al tangibile e individuando la qualità primaria del visibile nel colore, si rifiuterebbero di
far derivare quest’ultimo dall’azione esercitata sull’occhio da immagini invisibili. In questa seconda tesi si riaffermerebbe il significato originario della policromia della statuaria: l’opera scolpita non farebbe altro che conformarsi alla sua natura di oggetto visibile, «comment la priver
de couleur ou ne lui laisser que celles de sa matière». Ne deriverebbe che la bellezza del colore,
l’euòcroia, non può essere disgiunta dalla summetri@a che definisce la bellezza dell’immagine; quella
stessa euòcroia, inoltre, metterebbe in primo piano il problema estetico del rapporto tra le parti e
il tutto, che, in assenza di frammenti di trattati tecnici, come il Canone di Policleto (vd. infra, n.
6) e il De Symmetria et Coloribus di Euphranor (vd. infra, n. 5), e ben prima degli Stoici, ricondurrebbe ad alcuni passi platonici, tra i quali sono da segnalare i due seguenti:
a) PLAT. Soph. 235 d, e (è lo Straniero di Elea a parlare, a proposito della bipartizione della
mimhtikh# te@cnh): «Una prima tecnica che io scorgo in essa è quella del copiare, che si ha soprattutto quando qualcuno, seguendo le proporzioni del modello (kata# ta#v tou^ paradei@gmatov
summetri@av) in lunghezza, larghezza e profondità, e attribuendo inoltre a ogni particolare i
colori appropriati (crw@mata... ta# prosh@konta), dà origine a una copia» (traduz. F. Fronterotta);
b) PLAT. Resp. IV, 420 c-d (parla Socrate, in risposta all’obiezione di Adimanto circa l’infelicità
dei guardiani): «Ora, noi crediamo di plasmare lo stato felice non rendendo felici nello stato
alcuni pochi individui separatamente presi, ma l’insieme dello stato. Subito dopo esamineremo lo stato opposto a questo. Così, per esempio, supponiamo che, mentre siamo intenti a
dipingere una statua, si presenti uno a criticarci e affermi che alle parti migliori della figura
non applichiamo i colori più belli (ta# ka@llista fa@rmaka), adducendo il motivo che gli occhi,
che costituiscono la parte migliore, non sono colorati in vermiglio, ma in nero; ci sembrerebbe di rispondergli bene con queste parole: “Ammirevole amico, non credere che noi dobbiamo dipingere gli occhi tanto belli che non sembrino neppure più occhi; e così per le altre
parti. Devi osservare invece se, colorando ciascuna parte con la tinta conveniente, rendiamo
bello l’insieme (to# oçlon kalo@n) (…)”» (traduz. F. Sartori).
A proposito del primo passo platonico su riportato, lo studioso francese scrive: «La parenté
de cette définition avec celle que rapporte Plotin est étroite: même subdivision selon la figure et
la couleur, même détermination des parties de la figure par la symmetria, même liaison entre
les deux parties de la définition. Il suffit, pour atteindre l’identité, d’interpretér l’euòcroia de la
formule de Plotin par le concept platonicien de convenance qui lui correspond ici», concetto che
sarebbe precisato proprio dal passo della Repubblica. L’idea estetica del predominio del tutto
sulle parti e, a sua volta, della relazione delle parti al tutto – già dei vari Fidia, Policleto, Platone e
degli Stoici – costituirebbe una tradizione ancora viva all’epoca di Plotino, come dimostrerebbe
Contributi per una definizione della simmetria in Plotino
155
consolidata prospettiva stoica4.
In realtà, la speculazione greca sulla simmetria affonda le sue radici in un
tempo ben anteriore al Canone di Policleto (V secolo a. C.)5: ciò tuttavia non
il para# pa@ntwn di Enn. I, 6, 1, 21 (sul punto, cfr. la nostra n. 15). Sempre secondo lo Stéphan, poi,
l’interpretazione platonica dell’euòcroia come esatto equivalente della summetri@a dell’immagine
sarebbe confermata da Plotino (Enn. I, 6, 1, 30-33), per il quale tuttavia «la définition de la
beauté par la symmetria, échouant devant certaines beautés visibles, n’épuise pas l’extension de
son domaine. La simplicité (ou unité et identité qualificatives des parties) est (…) incompatible
avec la multiplicité et la diversité des parties que requiert leur symmetria» (sulla portata di tale
critica plotiniana, vd. infra).
4
Enn. I, 6, 1, 21-23. Per gli influssi stoici, il riferimento è soprattutto all’Etica di Crisippo.
In molti suoi frammenti emerge lo stretto legame fra etica ed estetica nello Stoicismo (sull’estetica stoica, cfr. M. POHLENZ, La Stoa: storia di un movimento spirituale, Milano 2005: per la
bellezza del cosmo, degli esseri, ecc., pp. 194, 278, 314 n., 366 n., 398, 408, 821, 929 n. e 951 n.;
per il bello morale, pp. 408 e 787), come in Stobaeus ecl. II 77, 16 W. = SVF (ed. H. von Arnim)
III, 16: «(…) Tutto ciò che è buono è bello (pa^n aègaqo#n kalo@n), e allo stesso modo tutto ciò che
è male è brutto». Ma sono i frr. 29-37 i più espliciti e sistematici in merito. In Plut. de Stoic.
repugn. c. 13 p. 1039 c. = SVF III, 29 leggiamo: «Anche nel libro Sul bello, per dimostrare che
solo il bello è buono (mo@non to# kalo#n aègaqo#n eiùnai), <Crisippo> si serve di tali ragionamenti: “Il
bene è preferibile, il preferibile è piacevole, ciò che piace è degno di lode e il lodevole è bello”.
E ancora: “Il bene procura diletto, il dilettevole è nobile, il nobile è bello”».
Quanto al concetto di bello come simmetria, invece, sono fondamentali altre tre testimonianze su Crisippo, di cui riportiamo qui di seguito i passi più significativi per il nostro discorso:
a) Diog. Laërt. VII 100 = SVF III, 83: «Per loro, bello è il bene perfetto consistente nel ricevere l’armonia naturale o la perfetta simmetria (para# to# pa@ntav aèpe@cein tou#v eèpizhtoume@nouv
aèriqmou#v uépo# th^v fu@sewv hà to# telei@wv su@mmetron) (…)».
b) Stobaeus ecl. II 62, 15 W. = SVF III, 278: «(…) come la bellezza del corpo è simmetria delle
sue membra fra loro e rispetto al tutto (summetri@a tw^n melw^n kaqestw@twn auètw^j pro#v aòllhla@
te kai# pro#v to# oçlon), così anche la bellezza dell’anima è simmetria della ragione e delle sue
parti fra loro e rispetto al tutto (summetri@a tou^ lo@gou kai# tw^n merw^n auètou^ pro#v <to#> oçlon te
auèth^v kai# pro#v aòllhla)».
c) Galenus de H. et Plat. decr. V 3 (161) p. 425 Mü. = SVF III, 472 [1]: «L’analogia che postula
fra stati fisici e psichici Crisippo non poté dimostrarla per la confusione che egli fa tra la
salute dell’anima e la bellezza (meta# tou^ kai# sugcei^n eièv tauèto#n th#n q è uégi@eian th^v yuch^v kai# to#
ka@llov). Poiché egli distinse accuratamente, per quanto concerne il corpo, la salute come
simmetria degli elementi e la bellezza come simmetria delle parti (th#n me#n uégi@eian eèn th^j tw^n
stoicei@wn summetri@aj qe@menov, to# de# ka@llov eèn th^j tw^n mori@wn) (…)». Id. p. 427 Mü. = SVF III,
472 [2]: «Quanto all’anima, poi, sostenne che è in base alle parti proprie della ragione
(kata# ga#r tou#v oièkei@ouv tou^ lo@gou merismou@v) che essa risulta bella o brutta (…)».
5
Cfr. L. GRASSI-M. PEPE, Dizionario di arte, Torino 1995, s. v. Simmetria, pp. 784 ss.
Già nel VI sec. a. C. lo scultore Teodoro di Samo avrebbe scritto uno dei più antichi trattati
di architettura e, soprattutto, sarebbe stato uno dei primi a mettere in pratica, anche in terra
egizia, la sua teoria della simmetria: secondo la testimonianza di Diodoro Siculo (I, XCVIII,
5-9), le due parti della statua di Apollo a Samo, scolpite una ad Efeso da Teodoro, l’altra nella
stessa Samo da Telecle (suo padre o, secondo altre fonti, suo fratello), riunite, avrebbero combaciato perfettamente proprio per il rispetto di quelle precise regole di costruzione. Dà l’idea
della successiva enorme influenza della speculazione pitagorica sull’estetica quanto Diogene
Laerzio (VIII, 47) ci tramanda circa la misteriosa figura dello scultore Pitagora di Reggio,
il quale sarebbe stato il primo a cercare nelle sue opere ritmo e simmetria (prw^ton dokou^nta
réuqmou^ kai# summhtri@av eèstoca@sqai) e sul cui pitagorismo implicito argomenta J. J. POLLIT, The
Ancient View of Greek Art. Criticism, History and Terminology, New Haven-Londra 1974, p. 21.
Sull’evoluzione storica del concetto, notevoli si rivelano alcuni passi di Plinio il Vecchio, il qua-
156
Christian Vassallo
toglie che la famosa testimonianza galenica sul Canone costituisca una pietra
miliare nella storia dell’estetica antica, soprattutto perché prova la capacità del
grande scultore argivo, secondo Plinio allievo di Agelada, di amalgamare genialmente teoria e prassi. La statua di Policleto che l’autore stesso appellò Canone
dovette questo nome alla perfetta simmetria di tutte le sue parti fra di loro6. Dai
le, ricordando nella sua Naturalis Historia che non esisteva nella lingua latina una parola che
traducesse il greco summetri@a, attesta che lo scultore Lisippo (IV sec. a. C.) l’avrebbe per primo
concepita non più in termini aritmetico-geometrici, bensì ottico-correttivi, poiché <symmetriam> diligentissime custodiit, nova intactaque ratione quadratas veterum staturas permutando; vulgoque dicebat ab illis factos quales essent homines, a se quales viderentur esse (XXXIV,
65). Infine, sempre secondo Plinio, l’efesio Parrasio (secc. V-IV a. C.), celebre rivale di Zeusi,
l’avrebbe per primo estesa alla pittura (XXXV, 67); laddove Euphranor (sec. IV a. C.) sarebbe
stato il primo ad applicarla scientificamente (XXXV, 128).
6
GALEN. de temper. I 9 p. 42, 26 Helmr. = DK40A3: kai# pou@ tiv aèndria#v eèpainei^tai Poluklei@tou
Kanw#n oènomazo@menov eèk tou^ pa@ntwn tw^n mori@wn aèkribh^ th#n pro#v aòllhla summetri@an eòcein oèno@matov
toiou@tou tucw@n. Per la dimostrazione che Crisippo diede della teoria policletea, cfr. ancora GALEN.
de plac. Hipp. et Plat. V p. 425, 14 Müll. = DK40A3, passo da noi già parzialmente riportato sopra
alla n. 3 (= SVF III, 472 [1]), dove in particolare, citando appunto dal Canone di Policleto, si
afferma: to# de# ka@llov ouèk eèn th^i tw^n stoicei@wn, aèlla# eèn th^i tw^n mori@wn summetri@ai suni@stasqai
nomi@zei, daktu@lou pro#v da@ktulon dhlono@ti kai# sumpa@ntwn auètw^n pro@v te metaka@rpion kai# karpo#n
kai# tou@twn pro#v ph^cun kai# ph@cewv pro#v braci@ona kai# pa@ntwn pro#v pa@nta. E che la coincidenza
tra bellezza e simmetria fosse una convinzione generalizzata, non solo tra i filosofi ma anche
tra gli altri dotti, come i medici, lo conferma Galeno stesso (ibid.): to# me#n dh# ka@llov tou^ sw@
matov eèn th^i tw^n mori@wn summetri@ai kata# pa@ntav ièatrou@v te kai# filoso@fouv eèsti@n. Sulla nozione di
“canone” in Grecia e sulla sua applicazione nei diversi campi estetici (in maniera particolare
architettura, scultura ed arte vascolare), si veda W. TATARKIEWICZ, Storia dell’estetica, vol.
I, Torino 1979, pp. 73 ss. Con più specifico riferimento alla pratica artistica, L. GRASSI-M.
PEPE, op. cit., s. v. Canone, p. 128, avvertono che il Canone greco, «sia quello di Policleto, sia
di Lisippo o di altri scultori e pittori, consiste nel misurare l’altezza del corpo umano in base
al modulo rappresentato dall’altezza della testa. Per Policleto la simmetria del corpo umano
corrisponderebbe a sette volte e mezza l’altezza della testa»; laddove, nel De architectura di
Vitruvio (siamo nella seconda metà del I sec. a. C., circa quattro secoli più tardi), il Canone
si trasforma in qualcosa di assai più complesso: Corpus enim hominis ita natura composuit,
ut os capitis a mento ad frontem summam et radices imas capilli esset decimae partis, item
manus pausa ab articulo ad extremum medium digitum tantundem, caput a mento ad summum
verticem octavae, cum cervicibus imis ab summo pectore ad imas radices capillorum sextae, “a
medio pectore” ad summum verticem quartae. Ipsius autem oris altitudinis tertia est pars ab
imo mento ad imas nares, nasum ab imis naribus ad finem medium superciliorum tantundem,
ab ea fine ad imas radices capilli frons efficitur item tertiae partis. Pes vero altitudinis corporis
sextae, cubitum quartae, pectus item quartae (II, I, 2). In J. CHARBONNEAUX-R. MARTIN-F.
VILLARD, Grecia: l’età classica, in AA. VV., Grandi civiltà, vol. IV, Milano 2005, pp. 195-196,
Jean Charbonneaux, evidenziando una certa evoluzione del Canone nella stessa produzione
policletea, sostiene, a proposito del Discoforo, che «la simmetria, cioè il sistema di proporzioni,
resta nella linea delle ricerche intraprese fin dall’epoca arcaica», basata allo stesso tempo «su
rapporti aritmetici semplici – sette volte l’altezza della testa l’altezza totale – e su rapporti
geometrici incommensurabili», sebbene la simmetria ritmica di Policleto sia «fondata su
una profonda conoscenza dell’organismo umano, le cui articolazioni sono sottolineate con
decisione per marcarne la composizione strutturale e la disponibilità all’azione: armonia
sottomessa al Numero, insieme sacro e vivo». Poi, dopo aver scorto in uno dei giovani cavalieri
del fregio ovest del Partenone la prima testimonianza dell’influsso dell’arte policletea (ca. 440
a. C.), avverte che «lo scultore argivo ha in seguito modificato le proporzioni delle sue altre
statue, conservandovi però il medesimo ritmo incrociato. Da qui le proporzioni in scorcio del
Contributi per una definizione della simmetria in Plotino
157
Pitagorici a Plutarco7, fino dunque alla prima metà del II secolo d. C., non vi furono grandi variazioni allo statuto teorico del concetto: solo nel III secolo d. C.
Plotino sconvolse gli schemi e riplasmò una dottrina che già da tempo sembrava non più soddisfare del tutto gli artisti. Sul concetto di simmetria nell’estetica
di Plotino è stato scritto molto e per lo più è prevalsa l’idea che il filosofo neoplatonico rifiuti categoricamente la tradizionale identificazione della bellezza
con essa. Non crediamo che questa sia la giusta via interpretativa e, per dimostrarlo, procediamo all’analisi delle diverse e non numerosissime comparse del
termine in seno alle Enneadi.
Nella prima sezione del trattato Sulle virtù (Enn. I, 2) leggiamo per la prima
volta la parola summetri@a, in seguito – quasi a coronamento – di una lunga
discettazione sulla differenza tra virtù umana e divina. L’oièki@a hé aièsqhth@, si dice
con bella metafora per significare il mondo sensibile, è diversa dalla nohth@: la
prima, infatti, partecipa di ta@xiv e di ko@smov, laddove nel lo@gov non v’è né ta@xiv né
Diadumeno, del 430 circa, e, almeno da quanto si può giudicare dalle copie, i suoi più rigorosi
calcoli d’equazione», aggiungendo che «questa nuova versione del canone è più elastica e più
umana; il gesto del braccio comunica a tutta la statua uno slancio che alleggerisce i volumi,
rende più disinvolto l’equilibrio e favorisce gli scorci», concludendo che «tutto porta ad
attribuire questo rinnovamento all’influenza attica». Commentando la struttura chiastica del
Doriforo (quadratio, secondo l’espressione varroniana), fa un interessante riferimento al fr. 1
D.-K. di Protagora G. BECATTI, L’arte dell’età classica, Milano 20035, pp. 200-202: «Mentre il
sofista Protagora nel suo trattato sulla Verità (Alètheia) proclama “esser l’uomo misura di tutte
le cose”, Policleto studia le proporzioni del corpo umano, vede nel dattilo l’unità di misura
(…)». Invece, per la differente concezione filosofico-ontologica alla base della statuaria di
Policleto e di Fidia, cfr. G. C. ARGAN, Storia dell’arte italiana, vol. I, Firenze 198923, p. 62.
7
Sui concetti di simmetria e di armonia nell’estetica pitagorica, si veda W. TATARKIEWICZ,
Storia dell’estetica, op. cit., pp. 108 ss.; per le fonti, sembrano significativi soprattutto alcuni
frammenti di Filolao sull’armonia: DIOG. VIII 85 [A 1] = DK44B1; STOB. Ecl. I 21, 7 d [p. 188,
14, ergänzt aus NICOM. Harm. 9 p. 252, 17 Jan] = DK44B6; STOB. Ecl. I 21, 8 [p. 189, 17 W.]
= DK44B7; NICOM. Arithm. II 19 p. 115, 2 = DK44B10; THEO Smyrn. 106, 10 = DK44B11;
segnaliamo inoltre, tra le testimonianze sui Pitagorici anonimi (secondo la tradizione aristotelica), per la simmetria: AËT. 13, 8 (D. 280) = DK58B15); per l’armonia: DIOG. VIII 29; 33 =
DK58B1a; ARIST. Metaph. A 5. 985 b 23 = DK58B4; AËT. 13, 8 (D. 280) = DK58B15; ARIST.
Metaph. N 6. 1092 b 26 = DK58B27; ARISTOT. de caelo B 9. 290 b 12 = DK58B35; ARISTOT.
Polit. Q 5. 1340 b 18 = DK58B41 (vgl. ARISTOT. de anima A 4. 407 b 27 = DK44A23); tra le
testimonianze relative ad Aristosseno, per la simmetria: IAMBL. V. P. 163 = DK58D1; STOB. IV
1, 40 H. = DK58D4; IAMBL. V. P. 203; zu § 205 vgl. STOB. Fl. III 10, 66 H. = DK58D8; mentre,
per l’armonia, una delle testimonianze sugli Acusmatici: IAMBL. V. P. 82 = DK58C4. Quanto a
Plutarco, invece, cfr. PLUT. Mor. 13, 45 d: eèn eòrgwj ge panti# to# me#n kalo#n eèk pollw^n oiùon aèriqmw^n eièv
eçna kairo#n héko@ntwn uépo# summetri@av tino#v kai# aérmoni@av eèpitelei^tai (cit. in P. MORENO, Lisippo, I,
Bari 1974, p. 200, n. 66). Il riferimento ai numeri convergenti in un unico momento riecheggia
la perfezione policletea, che si realizza per un punto mediante molti numeri, come si legge
in PHILO Mechan. IV 1 p. 49, 20 (ed. R. Schöne Berl. 1893) = DK40B2: to# euù para# mikro#n dia#
pollw^n aèriqmw^n gi@netai. Utile sussidio pratico per una trattazione filosofica dell’argomento, anche per il vasto apparato di immagini che contiene, è U. ECO (a cura di), Storia della bellezza,
Milano 20054, in part. pp. 72 ss.
158
Christian Vassallo
ko@smov né summetri@a8. Volutamente non abbiamo tradotto questi termini, poiché
in tal modo non avremmo fatto altro che fomentare nuova confusione. Nel nostro
immaginario la simmetria è un po’ sintesi e un po’ sinonimo dei greci ta@xiv e
ko@smov, che con non irrilevante forzatura le traduzioni italiane più accreditate
rendono con “ordine” e “proporzione”. In Plotino la ta@xiv non coincide col ko@
smov e questi due termini, nello specifico, non si riversano concettualmente
nella summetri@a, che, in quanto citata, con cadenza apparentemente apofatica,
soltanto a proposito di ciò che il mondo intelligibile non è e non invece di ciò
che è quello sensibile, deve per forza assumere un valore semantico assai più
pregnante. In realtà, in questo contesto, Plotino non spiega tanto ciò che il
mondo intelligibile non è, quanto piuttosto ciò di cui gli esseri intelligibili non
hanno bisogno e di cui pure noi quaggiù partecipiamo: ta@xiv, ko@smov e oémologi@a,
appunto, oltre naturalmente all’aèreth@9.
Se è così, allora potremmo considerare la summetri@a plotiniana quale sinonimo di oémologi@a, come insieme di parti non quantitativamente ma qualitativamente uguali; e ciò dovrebbe indurci a rimeditare il concetto greco di summetri@a,
che affonda indubbiamente le sue radici nella speculazione pitagorica per approdare poi a Platone e ad Aristotele, ma con uno stretto legame con lo statuto
eidetico dell’aèriqmo@v, che spinse sempre i Greci a privilegiare la geometria alla
matematica in senso stretto. Basterebbe dare uno sguardo al trattato Sui numeri (Enn. VI, 6), dove Plotino, filosofo del III sec. d. C., eredita quell’approccio
qualitativo, o perlomeno pseudo-quantitativo, riproposto in termini medioplatonici e neopitagorici, con riferimento costante, spesso dialettico, ad Aristotele
e alle “dottrine non scritte” di Platone10.
Enn. I, 2, 1, 43-46.
Enn. I, 2, 1, 46-52: Ouçtwv ouùn ko@smou kai# ta@xewv kai# oémologi@av metalamba@nontev eèkei^qen
kai# tou@twn oòntwn th^v aèreth^v eènqa@de, ouè deome@nwn de# tw^n eèkei^ oémologi@av ouède# ko@smou ouède# ta@xewv,
ouèd èaàn aèreth^v eiòh crei@a, kai# oémoiou@meqa ouède#n h§tton toi^v eèkei^ di è aèreth^v parousi@an. Pro#v me#n ouùn
to# mh# aènagkai^on kaèkei^ aèreth#n eiùnai, eèpei@per hémei^v aèreth^j oémoiou@meqa, tauti@.
Circa il rapporto tra attività estetica, teoretica e morale in Plotino, con specifico riferimento al rapporto tra bello e vero e tra bello e bene, si veda F. BOURBON DI PETRELLA, Il
problema dell’arte e della bellezza in Plotino, Firenze 1956, pp. 79 ss.
10
Dedica parte di un suo lungo articolo al rapporto tra la tavola categoriale delineata in
Enn. VI, 1-3 e la concezione plotiniana degli enti matematici – traendo spunto dal volume di
E. CATTANEI, Enti matematici e metafisica: Platone, l’Accademia e Aristotele a confronto, Milano 1996 e in chiara polemica con M. L. GATTI, Sulla teoria plotiniana del numero e sui suoi
rapporti con alcuni aspetti della problematica delle «dottrine non scritte» di Platone, «Rivista di
Filosofia neo-scolastica», LXXV, 1983, pp. 361-384 – M. ANDOLFO, Metafisica e “intermedietà”
degli enti matematici in Aristotele e in Plotino, «Rivista di Filosofia neo-scolastica», LXXXIX,
1997, pp. 181-228, in part. pp. 197 ss. La tesi di fondo dell’Andolfo – che sul piano metodologico-scientifico, specie per il concetto di “numero”, non è del tutto in linea con quanto da
noi affermato sul piano estetico e che pure presenta una sua fondatezza, pur nella contraddittorietà interna dei testi plotiniani riconosciuta dallo stesso studioso – presupponendo lo
8
9
Contributi per una definizione della simmetria in Plotino
159
strutturale anti-aristotelismo delle categorie plotiniane e tuttavia l’oggettiva impossibilità da
parte di Plotino di sottrarsi alla Wirkungsgeschichte aristotelica, mira a dimostrare come il filosofo neoplatonico rielabori originalmente le tesi del Sofista, del Filebo, del Parmenide e delle
“dottrine non scritte” e approdi ad una concezione sostanzialmente quantitativa del “numero”,
sebbene di un certo tipo di “numero”. Quanto ai rapporti, mediati dall’Antica Accademia e dal
Neopitagorismo, tra i numeri plotiniani e i Pitagorici, A. CHARLES-SAGET, L’architecture du
divin: mathématique et philosophie chez Plotin et Proclus, Paris 1982, pp. 175 ss., richiama,
partendo dalle allusioni alle tesi pitagoriche in Enn. VI, 6 (ma per l’analisi puntuale dell’intero
trattato Sui numeri, cfr. cap. II, pp. 105 ss. dello studio), l’immagine e il senso della tetraktu@v:
La posizione plotiniana, secondo Charles-Saget, potrebbe sintetizzarsi nei seguenti punti:
a) come principio, l’unità è connaturata ad ogni numero generato, secondo quanto si legge in
Enn. V, 5, 5, anche quando sopravviene un numero superiore;
b) ogni numero è una struttura, non già una raccolta (une collection), che ci rinvia non alla
sequenza 1, 2, 3, 4 (in greco: a @, b @ , g @, d @ ), bensì alla rappresentazione pitagorica che fa di
ogni numero una figura;
|
|
|
|
c) ogni numero essenziale è un movimento che si radica nell’Uno per poi tornare a Lui, così
come l’intelletto torna al principio per conoscersi ed essere, ciò che richiama l’immagine
dell’avvolgimento successivo dell’unità nello gnomone.
Ora, per evitare equivoci (anche perché il problema è fondamentale per l’estetica) e spiegare che cosa intendiamo quando parliamo, nella nostra ricerca, di approccio qualitativo (ovvero geometrico-razionale) ai numeri, ci sembra doveroso riportare l’autorevole opinione di
C. B. BOYER, Storia della matematica, Milano 1990, p. 63, che può aiutarci a capire meglio
la distinzione effettuata da Diodoro Siculo (vd. infra, in questa stessa nota) tra Greci ed Egizi
a proposito delle simmetria: «In Egitto il numero faceva riferimento alla serie dei numeri naturali e delle frazioni aventi l’unità per numeratore (…). In Grecia il termine numero veniva
usato soltanto per indicare i numeri interi; una frazione non veniva considerata come una
entità unica, ma come un rapporto o una relazione tra due numeri interi. (…) Come ha scritto
più tardi Euclide (Elementi, lib. V, prop. 3), “un rapporto è una sorta di relazione tra le dimensioni di due grandezze della stessa specie”. Una tale concezione, concentrando l’attenzione sulla
connessione tra coppie di numeri, tende a mettere in netto rilievo gli aspetti teorici o razionali del
concetto di numero e a relegare in secondo piano il ruolo del numero come strumento di calcolo
o di misurazione approssimata. Era quindi possibile concepire l’aritmetica come una disciplina
intellettuale, oltre che come una tecnica», ciò che avvenne appunto con i Pitagorici, che «associarono il numero all’estensione geometrica» e «giunsero all’idea di un’aritmetica dei cieli»
(corsivi nostri).
Tratta poi (in maniera abbastanza approfondita e con argomentazioni che sono indirettamente utili per comprendere la novità plotiniana sul tema) del concetto platonico di simmetria, del suo rapporto con i numeri in generale e con la simmetria pitagorica J.-L. PÉRILLIÉ,
«Summetria» des Nombres de la «République», «Revue philosophique de Louvain», CII, 2004,
pp. 35-58, che cerca di mettere in relazione il concetto matematico di simmetria introdotto da
Platone nel libro VII della Repubblica e l’enigma dei Numeri della generazione degli dèi e degli
uomini nel libro VIII della stessa opera. Ma discute dei concetti di analogia e di simmetria
in Platone anche L. STÉPHAN, art. cit., pp. 332 ss., criticando una radicale riduzione della
matematica alla simmetria e mettendo in evidenza, di quest’ultima, il carattere qualitativo;
nell’ultima sezione del contributo, infatti – dopo aver citato i due frammenti rimastici di Po
160
Christian Vassallo
Stando ai testi11, sin dalla sua comparsa l’oémologi@a si accompagna alla
sumfwni@a e dunque, implicitamente, è tenuta da essa distinta12. Accade anche
nel trattato Sul bello, dove pure le occorrenze della parola sono semplicemente
due. In Enn. I, 6, 1, 46, infatti, compare nuovamente l’espressione oémologi@aj te
kai# sumfwni@aj, ma in un senso che sembra rimettere in discussione la conclusione precedentemente raggiunta circa i legami tra oémologi@a e summetri@a. Qui
Plotino s’interroga sul grado di estensibilità della summetri@a ed in particolare sul
significato che essa assume per quella che in precedenza abbiamo considerato
la quinta fonte del bello, nel nuovo passo leggermente rimaneggiata13. Che cosa
vuol dire – si domanda il filosofo – che i qewrh@mata14 siano tra di loro su@mmetra?
Se l’aggettivo fosse sinonimo di su@mfona – obietta a se stesso in un vibrante monologo erotematico – anche fra i qewrh@mata kakw^n vigerebbero paradossalmente oémologi@a te kai# sumfwni@a. Ancora una volta la questione “estetica” si confonde
con quella “etica”, perché, dopo aver premesso che l’aèreth@ è bellezza dell’anima
(ka@llov yuch^v), Plotino tiene a precisare che i su@mmetra che la compongono non
sono quantitativi (wév mege@qh) né tantomeno numerici (wév aèriqmo@v), pur volendo
sostenere che siano parecchie le parti dell’anima.
Ma torniamo alla summetri@a quale concetto prettamente “estetico”. Da Enn.
I, 6, 1, 21 si evince che la riduzione ad essa della bellezza visibile (to# pro#v th#n
oòyin ka@llov) era per Plotino un cliché generalmente invalso al suo tempo15. Tutlicleto e l’opposizione predicata da Diodoro Siculo (Bibl. Hist. I, 98, 9) tra i concetti egizio ed
ellenico di proporzione, e ricordando, a questo proposito, che in E. PANOFSKY, The History of
the theory of human proportions as a reflection of the history of styles, in Meaning in the visual
arts, New York 1957, p. 70, si evidenzi come Diodoro impieghi il termine summetri@a per i Greci,
quello di kataskeuh@ per gli Egizi –, lo studioso così conclude: «Tout ces textes nous invitent à
faire des riserve sur la signification purement mathématique de la symmetria. Prédominance
du tout sur les parties, nullement exclusive d’une réaction des parties sur le tout rendant décisifs le détail infime et l’appréciation visuelle; beauté saisie sous la forme de l’unité (mais est-il
possible de récuser cette unité?); unité naissant de l’identification “positionnelle” des parties,
“dans la mesure du possible”, au moyen d’un usage qualitatif de la proportion étendu à la
totalité des aspects de l’œuvre; la symmetria peut encore être entendue comme un appel à une
mathématique de l’ordre…» (l’articolo si chiude proprio con questi puntini sospensivi, a voler
significare o che l’identità simmetria = matematica non sia punto valida o che sia piuttosto
corretto intendere la simmetria quale modello normativo, esortazione approssimativa, qualitativa, ad un ordine-limite matematico-quantitativo).
11
Le occorrenze del termine oémologi@a in Plotino sono in tutto 6: Enn. I, 2, 1, 18; 46; 48; I,
6, 1, 46; 2, 20; e infine VI, 9, 1, 17.
12
Enn. I, 2, 1, 16-19: àH ouèk euòlogon (...) swfrosu@nhn de# eèn oémologi@aj tini# kai# sumfwni@aj eèpiqumhtikou^ pro#v logismo@n, ktl.
13
Enn. I, 6, 1, 44. Pur rimanendo il riferimento agli eèpithdeu@mata e alle eèpisth^mai, alle
pra@xeiv vengono fatti corrispondere i no@moi, così come alle eçxeiv i maqh@mata.
14
La parola a noi pare sintetizzare tutte le componenti della quinta fonte del bello.
15
Le@getai me#n dh# para# pa@ntwn ktl. Così Plotino comincia a rispondere all’interrogativo fondamentale che si è appena posto: che cosa, cioè, spinga lo sguardo dello spettatore e gli procuri
gioia contemplativa. Di quel cliché estetico parla, rinviando anche alla letteratura latina e alla
Contributi per una definizione della simmetria in Plotino
161
bellezza ciceroniana quale apta figura membrorum, W. TATARKIEWICZ, Storia dell’estetica,
op. cit., pp. 356-57. A proposito del para# pa@ntwn, J. P. ANTON, Plotinus’ Refutation of Beauty as
Symmetry, «The Journal of Aesthetics and Art Criticism», XXIII, 1964, p. 237, n. 4, osserva che
«one supposes here that Plotinus ought to have been more careful than to place everyone but
himself in the opposite camp». Lo studioso sembra sostenere, non con tutti i torti, che proprio
l’assenza di un netta definizione del proprio punto di vista e dei fautori di quello opposto, al
di là delle critiche alla concezione tradizionale del bello, abbia generato dubbi e incertezze
sullo specifico bersaglio della polemica. Anton si limita a citare Bréhier, per il quale Plotino
avrebbe in mente soprattutto la teoria degli Stoici che lo stesso Cicerone tiene presente in
Tusc. IV, 31; Henry, in linea generale dello stesso parere, convinto com’è che Plotino segua
Platone allorquando ripone l’essenza della bellezza, anche di quella sensibile, non, secondo i
parametri stoici, nella simmetria delle parti, ma in un principio immateriale, partecipe della
bellezza ideale del mondo intelligibile, sicché il j’accuse sarebbe indirizzato esclusivamente
agli Stoici, non già ad Aristotele; ed infine Pistorius, che rende invece oggetto delle critiche
plotiniane proprio la Poetica di Aristotele (posizione, quest’ultima, dalla quale, peraltro, Anton
prende esplicitamente le distanze).
A questo proposito, andrebbe meglio chiarita la posizione plotiniana verso il concetto aristotelico di me@geqov. Scrive lo Stagirita: «Ora si noti che un essere vivente che sia bello, e ogni
altra cosa composta di parti, non solo deve avere queste parti bene ordinate, ma deve anche
fornire una grandezza non casuale, perché il bello sta nella grandezza e nell’ordine (to# ga#r
kalo#n eèn mege@qei kai# ta@xei eèsti@n): un essere piccolissimo (pa@mmikron) non può apparire bello,
perché è turbata la visione che dura un tempo quasi impercettibile; e neppure uno grandissimo (pamme@geqev), perché non si ha più una visione d’insieme, e per chi guarda va perduta la
percezione dell’uno e dell’intero (oiòcetai toi^v qewrou^si to# e°n kai# to# oçlon eèk th^v qewri@av), come
se un corpo misurasse diecimila stadi» (ARISTOT. Poët. VII, 3; traduz. C. Gallavotti). A noi
pare che anche in Aristotele il richiamo all’unità sia determinante e che quindi si debba essere
cauti a leggere (come fa la BOURBON DI PETRELLA, op. cit., p. 93) in chiave radicalmente
antiaristotelica il capitolo iniziale del trattato Sui numeri, dove pure Plotino opta risolutamente per una concezione della bellezza per la bellezza, non per le dimensioni: «(…) Ogni cosa è
molteplice quando, non potendo accordarsi con se stessa, si riversa al di fuori e si estende in
guisa sparsa: e qualora, nel suo disperdersi, rimanga completamente privata dell’uno, diventa
molteplicità (plh^qov), venuto ormai meno il principio unificatore delle sue parti; se invece, pur
continuando a disperdersi, conservi una sua certa consistenza, diventa grandezza (me@geqov).
Ma quale insidia si nasconde dietro la grandezza? Sarebbe pericolosa se la cosa divenuta grande percepisse la sua natura, nel qual caso capirebbe di essersi autodissociata e di essersene
andata via lontano. Ogni essere, infatti, non va alla ricerca dell’altro, ma di se stesso: per cui il
viaggio esotico, tranne se necessario, è insensato. (…) Dunque, il desiderio di ciò che è grande
è proprio di chi ignora la vera grandezza e mira non al necessario ma all’esteriorità. (…) È per
la grandezza che un essere si genera, ma è nella misura in cui sulla grandezza fonda la sua esistenza che va in perdizione: solo ciò che è unitario possiede se stesso (oç ti de# eòcei eçn, eòcei eéauto@).
Eppure l’universo è insieme grande e bello (kai# mh#n to# pa^n me@ga kai# kalo@n). Ciò perché non gli fu
permesso di fuggire verso l’infinito, ma fu delimitato dall’Uno: ed è bello non per la grandezza
ma per la bellezza; e fu proprio perché divenne grande che ebbe bisogno della bellezza (kai#
kalo#n ouè tw^j me@ga, aèlla# tw^j kalw^jÚ kai# eèdeh@qh tou^ kalou^, oçti eège@neto me@ga). L’universo, orfano del
bello, tanto più brutto apparirebbe quanto più fosse grande; e così la grandezza è materia del
bello, poiché è molteplice ciò che necessita di ordine (eèpei# eòrhmon oàn tou^to oçswj me@ga, to@swj aàn
katefa@nh aièscro@nÚ kai# ouçtw to# me@ga uçlh tou^ kalou^, oçti polu# to# deo@menon ko@smou). Ciò che è grande
(to# me@ga) tanto più è brutto quanto più è disordinato» (Enn. VI, 6, 1).
In Enn. V, 8, 2, 27-28 Plotino dice che attraverso gli occhi passa soltanto la forma (eiùdov) e
che, insieme ad essa, viene trascinata (sunefe@lketai) nella percezione visiva anche la grandezza (to# me@geqov), non però quella che è grande nella massa, ma quella che tale è divenuta nella
forma (ouè me@ga eèn oògkwj, aèll è eiòdei geno@menon me@ga). C. ASTI VERA, Arte y realidad en la estetica
de Plotino, Buenos Aires 1978, pp. 42-43, dopo aver individuato nelle Enneadi quattro caratteri
intimamente connessi alla Bellezza – determinación, grandeza, vitalidad e simetría – aggiunge
162
Christian Vassallo
tavia, la lettura complessiva di Enn. I, 6, 1, 21-40 non giustifica la postulazione
di un’estetica plotiniana anti-simmetrica, tout court. Plotino, piuttosto, evidenzia le conseguenze assurde di un’equiparazione radicale tra kalo@n e summetri@a.
Infatti – fa notare – dire che il pro#v th#n oòyin ka@llov sia esclusivamente summetri@a
tw^n merw^n pro#v aòllhla kai# pro#v to# oçlon comporta, di necessità, la considerazione
del kalo@n come di un qualcosa di composto (su@nqeton), non di semplice (aéplou^n).
La bellezza, secondo tale ragionamento, riguarderebbe il tutto (to@ te oçlon) e non
ciascuna delle parti (ta# de# me@rh eçkasta)16, con la conseguenza che non parteciperebbero di essa, in quanto aépla^ oònta e dunque ouèk eèk summetri@av eòconta to# ka@
llov, i bei colori, come la luce del sole, l’oro, i bagliori degli astri notturni, il
semplice suono non sinfonico e le particolari disposizioni di un volto.
Probabilmente, proprio in quest’ultimissimo esempio, quello del pro@swpon,
si scorge una possibile soluzione della questione. Perché, ferma restando la
sua simmetria, un volto ci appare talora bello e talora no? Forse, ipotizza il
nostro filosofo, la fonte dell’eèpi# tw^j summe@trwj kalo@n è strutturalmente diversa dal
su@mmetron in sé. In Enn. VI, 7, 22, 25-35 leggiamo:
in parentesi, a proposito della seconda e con esplicito riferimento al passo su riportato, che
«naturalmente se trata de una grandeza cualitativa».
Tornando alla simmetria, risulta ancora abbastanza fondata la posizione di E. DE KEYSER,
Le Signification de l’Art dans les Ennéades de Plotin, Louvain 1955, pp. 103 ss., in part. pp. 106107, dove lo studioso, dopo aver parlato di simmetria con riferimento ad Aristotele, Luciano,
Filostrato di Lemno e Filostrato il Giovane, avverte che «pour l’homme cultivé du début du
IIIe siècle, une œuvre d’art de qualité était celle où tous les éléments formaient un ensemble
harmonieux parfaitement équilibré. Bien que Plotin ait admis que la symétrie était un des
éléments essentiels de la fabrication des objets, du moins dans ses tout premiers traités (V,
9 (5), 11, 13), il ne paraît pas, même à cette époque, en faire un facteur déterminant de la
beauté de l’œuvre d’art. (…) dans le traité Du Beau, il repousse avec éclat la théorie stoïcienne
(I, 6 (1), 1, 19-55). Il affirme, en s’appuyant sur une série d’exemples, que la beauté ne peut
se confondre avec l’harmonie des parties, parce que une chose belle peut être simple, même
dans le domaine sensible et à plus forte raison dans le domaine intelligible ou l’unité est seule
concevable. (…) L’art est essentiellement, pour Plotin, la découverte d’une unité qui se projette
sur une multiplicité, la domine et l’unifie en quelque façon. (…) l’harmonie des proportions est
parfaitement valable comme expression de la beauté, mais ne peut se confondre avec elle. (…)
Plotin appliquera sa théorie de la symétrie à l’œuvre d’art au VI, 7 (38), 22, 24-26, où il traite
de statues (…)» (corsivi nostri). Sempre ASTI VERA, op. cit., p. 45, cercando di chiarire la posizione del De Keyser, afferma: «las leyes simétricas y las armónicas no son la belleza ni tampoco
la forma, pero organizan la presentación sensible de la idea. Y en tanto el eîdos se presente, la
belleza flotará sobre la obra» (corsivi dell’autore). E lo stesso W. TATARKIEWICZ , Storia di sei
Idee, Palermo 2002, p. 175, fa della simmetria un carattere integrante, sebbene non esclusivo,
dell’estetica plotiniana.
16
Per la definizione concettuale di me@rov, pa^n ed oçlon e le differenze tra questi ultimi due
termini, pensiamo sia opportuno un rinvio ad ARISTOT. Metaph. V, 1023 b12-1024 a10. Il
passo supponiamo fosse tenuto ben presente da Plotino. Fondamentali, tuttavia, per la comprensione della logica del tutto e delle parti in Platone, Plotino e Proclo restano le osservazioni
di A. CHARLES-SAGET, op. cit., pp. 71 ss.
Contributi per una definizione della simmetria in Plotino
163
«È innegabile che nel nostro mondo il piacere estetico (to# eèra@smion)
non derivi tanto dalla simmetria quanto piuttosto dalla bellezza che
in essa risplende (ma^llon to# ka@llov to# eèpi# th^j summetri@aj eèpilampo@menon hà
th#n summetri@an eiùnai). Perché, infatti, in un volto vivo rifulge la bellezza,
mentre soltanto un’orma ne rimane in uno morto, prima che la carne e
le sue simmetrie non si consumino del tutto (iòcnov d è eèpi# teqnhko@tov kai# mh@
pw tou^ prosw@pou tai^v sarxi# kai# tai^v summetri@aiv memarasme@nou)? E perché
giudichiamo esteticamente superiori le statue più ricche di vita (zwtikw@tera) rispetto a quelle che privilegiano la simmetria (summetro@tera)? O un
essere vivente, pur brutto, ad una bella statua? In quanto più desiderabile,
e ciò perché animato (yuch#n eòcei), maggiormente informato al bene
(aègaqoeide@steron) e, per così dire, colorato dalla luce che da quello emana
(aègaqou^ aèmhjge@phj fwti# ke@crwstai); sicché l’anima, variopinta, risorge, si
libra e sgrava la sua dimora, che pure rende buona e risveglia»17.
Ma prima di tirare conclusioni, conviene esaminare gli altri luoghi
enneadici che potrebbero meglio chiarire il significato estetico della simmetria,
cominciando da Enn. II, 9, 16, 49-55, dove si trae spunto ancora una volta dal
pro@swpon per sviluppare un più articolato discorso sul ka@llov. Il trattato, com’è
noto, è uno di quelli indirizzati contro gli Gnostici ed in particolare contro il
loro disprezzo del mondo sensibile18.
«Chi ammira una bellezza ben riprodotta in un volto (ka@llov eèn
prosw@pwj euù memimhme@non) è portato lassù,» sostiene Plotino rifacendosi
quasi letteralmente ad uno stupendo passo del Fedro sui sintomi
dell’eros19, «ma chi potrebbe avere un animo così freddo ed apatico da
non sbigottire ed intimorirsi di fronte a tutte le meraviglie del mondo
(su@mpanta me#n ta# eèn aièsqhtw^j ka@llh), alla loro universale simmetria (su@
mpasan de# summetri@an), al loro ordine sublime (th#n mega@lhn euètaxi@an tau@
17
Il carattere corsivo adoperato, nella nostra traduzione, per la simmetria vuole semplicemente evidenziare il forzato compromesso ermeneutico che, di fronte alla complessità del
concetto in esame, siamo stati costretti a stipulare con l’originale testo greco. Salvo indicazione contraria, anche i passi che citeremo in seguito saranno oggetto di una nostra personale
versione.
18
L’esordio della sez. 16 è emblematico poiché, intrecciando come al solito discorso etico
ed estetico, fa dipendere dal disprezzo del ko@smov, dei qeoi@ che lo abitano e degli altri suoi kala@
l’impossibilità stessa di diventare aègaqo@n: e ciò dovrebbe far riflettere quanti leggono in chiave
meramente “misticheggiante” certe affermazioni contenute nella seconda parte di Enn. I, 6.
19
PLAT. Phaedr. 251 a ss., con chiara allusione al celebre fr. 31 V. di Saffo.
164
Christian Vassallo
thn), allo sfavillio delle remote stelle (to# eèmfaino@menon eèn toi^v aòstroiv
eiùdov kai# po@rrwqen ouùsin) e alle conseguenze di tutto questo?».
Nonostante le apparenze, il testo non può essere interpretato secondo i parametri del sublime kantiano20, travagliata mescolanza di sentimenti d’inferiorità e di superiorità dell’uomo al cospetto di ciò che è grande e potente, non
contenuto tuttavia in alcuna forma sensibile, ma nelle sole Idee della ragione.
I su@mpanta ta# eèn aièsqhtw^j ka@llh plotiniani sarebbero kantianamente belli, non
sublimi21, eppure sembrerebbero spogliarsi di quell’aura oggettiva e superba
di cui si cingono in rerum natura per richiamare lo spettatore all’attenzione,
20
«Denn so wie wir dem, der in der Beurtheilung eines Gegenstandes der Natur, welchen
wir schön finden, gleichgültig ist, Mangel des Geschmacks vorwerfen: so sagen wir von dem,
der bei dem, was wir erhaben zu sein urtheilen, unbewegt bleibt, er habe kein Gefühl» (I. KANT,
Kritik der Urteilskraft, § 29): balena quasi involontariamente questo pensiero kantiano, che si
trova nell’Analitica del sublime della terza Critica, mentre si legge il su tradotto passo plotiniano. Ma in realtà, ricorrendo, nella nostra traduzione, all’espressione ordine sublime, più che la
Critica del Giudizio, avevamo in mente l’Anonimo del Sublime. «La natura ci ha giudicato non
un animale dappoco e ignobile, ma introducendoci nella vita e nell’ordine universale come in
una grande festa panegirica (perché fossimo spettatori di tutte le sue opere, pronti alla lotta,
pieni di spirito di emulazione), subito ha generato nell’animo nostro irriducibile amore per
tutto ciò che è eternamente grande e più vicino allo spirito divino in rapporto a noi (panto#v aèei#
tou^ mega@lou kai# wév pro#v héma^v daimoniwte@rou). Perciò, allo slancio della contemplazione e della
riflessione dell’uomo nemmeno l’universo intero è sufficiente, ma spesso la sua immaginazione tende a valicare i confini del mondo che ci circonda; e se uno volga lo sguardo tutto intorno
alla nostra vita, e consideri il ruolo preponderante che ha per noi in ogni cosa quel che è fuori
dalla norma (peritto@n), il grande (me@ga) e il bello (kalo@n), ben presto scoprirà il motivo per cui
siamo nati.» (An. Subl. XXV, 2-3; traduz. F. Donadi). Non è cosa certa, ma è quantomeno cronologicamente plausibile ipotizzare una diretta conoscenza del Peri# uçyouv da parte di Plotino
e della sua scuola (sulla questione rinviamo a R. CANTARELLA, Osservazioni critiche intorno
al Peri# uçyouv, «Revue des Études Grecques», XXXVIII, 1925, pp. 137-166; A. ROSTAGNI, Il
“sublime” nella storia dell’estetica antica, «Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa»,
XI, 1933, pp. 99-119; 175-202, poi in ID., Scritti minori, vol. I, Aesthetica, Torino 1955, pp. 447
ss.; e F. WEHRLI, Die antike Kunsttheorie und das Schöpferische, «Museum Helveticum», XIV,
1957, pp. 39-49). Quanto al concetto di sublime, dallo Pseudo-Longino fino all’Ottocento, si
veda G. CASERTANO (a cura di), Il Sublime: contributi per la storia di un’idea. Studi in onore
di Giuseppe Martano, Napoli 1983 e C. G. NIARCHOS, The beautiful and the sublime: from
ancient Greek to Byzantine art and thought, «Diotima», X, 1982, pp. 81-91, in particolare pp. 85
ss., dove si afferma, facendo – almeno a noi pare – dell’estetica plotiniana qualcosa di molto
più vicino al sublime che alla bellezza, che per i Greci «the sublime is not an imperfection of
the beautiful but a symbolism of the idea within the reality, or even as an idea, which has
descended to reality to become beautiful». Tratta invece dei rapporti tra la concezione della
bellezza e dell’arte in Plotino e in Kant R. POUIVET, Le Beau et l’Art: remarques sur leur rapport
chez Plotin et Kant, «Revue de l’Enseignement Philosophique», XXXVI, 1986, pp. 15-26.
21
La differenza in Kant tra bello e sublime è ben spiegata da F. MENEGONI, La Critica del
giudizio di Kant: introduzione alla lettura, Roma 1995, pp. 89-91. Tuttavia a noi pare di scorgere, mutatis mutandis, una mescolanza dei “sintomi” estetici derivanti dal bello e dal sublime,
kantianamente intesi, in quel meraviglioso passo, sicuramente ignorato da Kant, in cui Plotino
scrive: Tau^ta ga#r dei^^ ta# pa@qh gene@sqai peri# to# oç ti aàn hùj kalo@n, qa@mbov kai# eòkplhxin hédei^an kai# po@qon
kai# eòrwta kai# pto@hsin meq è hédonh^v (Enn. I, 6, 4, 15-17).
Contributi per una definizione della simmetria in Plotino
165
all’intima simpatia. È per questo motivo che Plotino può ben dire che chi rimanga indifferente allo spettacolo su descritto non ha né compreso la bellezza
del mondo sensibile né potuto ammirare quella dell’intelligibile22, poiché per lui
non è concepibile una netta separazione tra quei due mondi, né ontologica né
tantomeno estetica, ma soltanto una loro diversa proporzione “logica”, ferma
restando l’abissale differenza tra il lo@gov plotiniano e la kantiana Vernunft.
Possiamo comprendere ciò rimeditando il passo di Enn. V, 9, 11, dove il
termine summetri@a compare ben quattro volte, in seno ad una specifica trattazione dei rapporti fra dimensione sensibile ed intelligibile. Le arti imitative si
servono di un modello sensibile (aièsqhtw^j proscrw@menai paradei@gmati) imitando
forme (eiòdh) e movimenti (kinh@seiv) e trasformando le simmetrie che contemplano (ta@v te summetri@av a°v oérw^si), ma solo attraverso il pensiero (tw^j aènqrw@pou
lo@gwj). Avevamo prima affermato che la simmetria plotiniana indica un insieme
di parti non quantitativamente ma qualitativamente uguali. Ora, invece, la distinzione tra simmetrie – quella sensibile e quella intelligibile – pare ci riporti
ad una differente proporzione matematica: ma è facile dimostrare che tale proporzione, a prima vista meramente quantitativa, sia di fatto anche qualitativa.
Non nel senso, però, che la simmetria sensibile sia ontologicamente inferiore
all’intelligibile, ma semplicemente per via dell’assenza, nella sua struttura, di
quella “pan-oramica” eidetica che è presente nel mondo intelligibile e che nella
natura stessa, indipendentemente dalle percezioni “estetiche” che gli uomini
possano averne, è nascosta e non mai dominabile in toto dalla mente umana,
che pur lo vorrebbe. L’ipotetica di terzo tipo che compare nel passo in esame è
abbastanza eloquente:
«Se, traendo spunto dalle simmetrie presenti negli esseri viventi (eèk
th^v peri# ta# zw^ja summetri@av), si supervisionasse (eèpiskopoi^to) una loro disposizione universale (tiv eçxiv ... oçlwn zw@jwn), si tratterebbe di una semplice frazione23 della potenza che lassù supervisiona e contempla l’universale simmetria intelligibile (mo@rion aàn eiòh duna@mewv th^v kaèkei^ eèpiskopou@shv
kai# qewrou@shv th#n eèn tw^j nohtw^j peri# pa@nta summetri@an)24».
Enn. II, 9, 16, 55: Ouèk aòra ouòte tau^ta kateno@hsen, ouòte eèkei^na eiùden.
Traduzione “aritmetica” probabilmente non peregrina, se è vero che il termine mo@rion si
riscontra per ben 29 volte nell’Arithmetica del matematico del III sec. d. C. Diofanto, di cui ci
sono giunti soltanto sei libri, sul cui contenuto e sulla cui importanza per la storia dell’algebra
rinviamo a C. B. BOYER, op. cit., pp. 211 ss.
24
È solo per non complicare il discorso già di per sé delicato che accettiamo l’inveterata
consuetudine di rendere il nou^v plotiniano col nostro Intelletto, sempre preferibile allo Spirito
cui ricorrono i critici neotomisti e neoidealisti. Nel caso specifico, confessiamo, ci sarebbe
piaciuto parlare di simmetria noetica.
22
23
166
Christian Vassallo
E, più innanzi, delle stesse arti banausiche – come l’architettura (oièkodomikh@) e la carpenteria (tektonikh@) –, che per definizione hanno a che fare con gli
oggetti sensibili, si dice che solo tramite la simmetria (summetri@aiv proscrw^ntai)
possono esse giungere alle aèrcai@ e alle fronh@seiv del mondo intelligibile; con la
precisazione che proprio a causa di questa mescolanza – uno stato di fatto, non
una menda – tra essenze del nohto@n ed elementi dell’aièsqhto@n, la loro partecipazione all’intelligibile non può che essere mediata dall’uomo.
Non è però un’estetica antropocentrica quella plotiniana, per lo meno non
nel senso tradizionale dell’aggettivo. È stato giustamente sostenuto che nelle
Enneadi permanga l’antica convinzione greca della superiorità della natura
sull’arte25. Nell’esempio su riportato, l’architettura e la carpenteria ubbidiscono
a parametri utilitaristici concepiti dall’uomo ed è per questo che, in esse, soltanto l’uomo può essere il medium con il nou^v. Nella poihtikh# te@cnh in generale,
invece, è la natura, la sua potenza spirituale e artistica a superare di gran lunga
quella umana. Il lo@gov umano, anzi, è quasi un limite per il poihth@v, sebbene
un limite necessario. La bellezza della fu@siv non ha bisogno di una mediazione
“logica” poiché l’eiùdov dimora in essa: la natura vive, per definizione, ed è per
questo che la uçlh, la materia, il suo non essere, costituisce un problema esteticamente tormentoso. L’aiòsqhsiv, secondo questa prospettiva, è la via d’accesso,
dell’uomo che fa e che contempla, all’eiùdov già presente nella fu@siv: l’artista e
l’osservatore disvelano la natura, ma non per questo le donano alcunché. La
loro simbiosi estetica è unilaterale e l’intellettualismo a quella connesso si traduce in una scelta da prendere, una vocazione cui rispondere, un imperativo
cui obbedire.
Ultimamente sono state scritte pagine molto penetranti sul nesso tra estetica e
meontologia in Plotino26. Il nulla – si afferma, con esplicita allusione agli influssi
del Parmenide platonico sulle Enneadi – è il solo predicato che convenga all’Uno27.
Ma questo nulla predicativo è garanzia dell’originaria libertà dell’essere, cui per
definizione la bellezza partecipa: innanzitutto la bellezza del mondo che l’uomo
abita. La bellezza plotiniana sarebbe manifestazione della verità del nulla e solo
25
Sul punto, W. TATARKIEWICZ, Storia dell’estetica, op. cit., p. 359: «L’estetica di Plotino
è spiritualistica, ma non antropocentrica. Nella natura, più che nell’uomo, esistono forze spirituali e creatrici. Soltanto un artista che sia perfettamente padrone della sua arte sarà in grado
di creare come la natura. In essa la bellezza ha la stessa sorgente che ha nell’arte: la natura è
bella in quanto un’idea la illumina; allo stesso modo l’arte è bella quando l’artista le fornisce
l’idea. La natura però, possiede più bellezza di quanta ne possieda l’arte».
26
S. GIVONE, Storia del nulla, Bari 20062, pp. 44 ss.
27
Enn. III, 8, 10, 29-31: òH eèsti me#n to# mhde#n tou@twn w§n eèstin aèrch@, toiou^to me@ntoi, oi§on, mhdeno#v
auètou^ kathgorei^sqai duname@nou, mh# oòntov, mh# ouèsi@av, mh# zwh^v, to# uépe#r pa@nta auètw^n eiùnai.
Contributi per una definizione della simmetria in Plotino
167
tenendo presente questo potremmo comprendere perché la simmetria non sia
in grado, secondo Plotino, di spiegare l’essenza del fenomeno estetico. A questo
punto, chi sostiene tale tesi predica l’estraneità a Plotino della concezione
mimetica della bellezza per asserirne una meramente «catartica e anzi mistica»,
connettendo in tal modo l’estasi all’estetica. Operazione legittima se all’Uno si
rifà come eèpei@kena th^v ouèsi@av, illegittima se non presuppone che quell’eèpe@keina è
anche, per così dire, skia# tou^ mh# oòntov, ombra meontologica, la cui propaggine è la
natura, che è bella e di cui l’uomo è parte riflessiva, che è bella perché informata
al principio indicibile al cui silenzio corrisponde, coevo e remoto a un tempo, il
grido dell’eruzione cosmica, della sovrabbondanza, dello straripamento di cui
anche noi siamo meravigliose ed involontarie escrescenze. Potrebbe l’atavica
simmetria rendere ragione di una bellezza che esplode dalla schizofrenia del
nulla originario e che continua, perennemente, ad essere, per sua anarchica
libertà e senza che ciò lo impoverisca punto, deus in machina delle meraviglie
del mondo? È questa la via per comprendere Plotino quando afferma, come
abbiamo visto, che non è la summetri@a ma l’eèpi# th^j summetri@aj eèpilampo@menon la
scaturigine del ka@llov28. La Grande Teoria platonica, per usare la nota locuzione
di Tatarkiewicz29, viene infranta innanzitutto nella sua facies logica: non più
ordine da ordine, ma genialità nel simmetrico, intelligibile nel sensibile, nulla
nell’essere, cielo in terra. Sim-metria: me@tron che si accompagna ad altro, su@n,
misura che si rivela libera dalle gabbie dell’ordine comunemente inteso. Proprio
a commento di Enn. I, 8, 8, si parla di una «doppia meontologia»: di un nulla
come potenza dell’Uno e come potenza della materia30. Noi però siamo persuasi
che il problema qui non sia tanto meontolgico, quanto piuttosto melogico,
volendo sincopare quel neologismo. Potremmo dire che, esteticamente, la uçlh
plotiniana sia soltanto un limite della pensabilità dell’essere, la traccia logica
dell’assenza del non essere nella realtà sillogica dell’onnipresenza del nulla: un
segno linguistico per esprimere quello che il linguaggio non concepisce né può
dire, ossia ciò che sta al di qua (la materia sensibile) e al di là (l’Uno) dell’essere
(umanamente) intelligibile31. Ma il mistero dell’autoctisi dell’Uno e del processo
Enn. VI, 7, 25-27.
W. TATARKIEWICZ, Storia di sei Idee, op. cit., pp. 147 ss.
30
S. GIVONE, op. cit., p. 54.
31
In Enn. VI, 9, 4, 1 ss. Plotino avverte che la conoscenza (su@nesiv) dell’Uno non si
raggiunge né tramite la scienza né tramite il pensiero ma per mezzo di una presenza superiore
alla scienza: questa è un discorso che scade inevitabilmente nel moltepice (lo@gov ga#r hé eèpisth@
mh, polla# de# oé lo@gov). Aggiunge poi, facendo una osservazione fondamentale sul piano estetico,
che bisogna per questo allontanarsi dalla scienza, dai suoi oggetti e da ogni altra cosa, pur bella
da contemplare (kai# kalou^ qea@matov), dal momento che ogni bellezza è inferiore all’Uno e da
esso deriva (pa^n ga#r kalo#n uçsteron eèkei@nou kai# par è eèkei@nou), come la luce diurna da quella solare.
28
29
168
Christian Vassallo
che innesca è sincronico: è da questa sincronia che prende il via la simmetria
estetica. Per questo motivo Plotino avverte che il primo male è l’aòmetron, il
secondo, per somiglianza o partecipazione, la sua introiezione32.
La simmetria compare per l’ultima volta in Enn. VI, 7, 30. Il passo, che si
rifà al Filebo33, rimette chiaramente in discussione le conclusioni di quanti la
considerano una conseguenza e non una causa del bello34. Nel mondo intelligibile, il nou^v aggiuge al mi^gma la verità e, prima ancora, ciò che conferisce misura (to# metrh^son), se così può intendersi il participio futuro sostantivato. Poi,
citando (peraltro in maniera incompleta e “infedele”35) Platone, Plotino afferma
testualmente che summetri@a e ka@llov, che sono nel mi^gma, approdano da questo
al kalo@n. Il passo sembrerebbe confermare il nostro discorso, poiché appare
evidente la “coabitazione” originaria tra summetri@a e mi^gma, nel senso che la simmetria plotiniana è altro dalla forma ordinata ed ordinante in cui la tradizione
l’aveva da sempre identificata e addirittura si accompagna al disordine. Allora
non è vero quello che in genere superficialmente si sostiene: che cioè la bellezza
Dichiara quindi categoricamente l’Uno ineffabile e indescrivibile (ouède# réhto#n ouède# grapto@n),
riprendendo la celebre affermazione platonica circa le dottrine non scritte (Epist. VII, 341 c
5) e nello stesso tempo giustificandone, con evidente imbarazzo, l’apparente violazione: se,
nonostante tutto, egli parla e scrive dell’Uno, lo fa per condurre l’ascoltatore, il lettore all’Uno
stesso (pe@mpontev eièv auèto@), indicandogli però semplicemente la via, poiché la visione dell’Uno
deve necessariamente essere una conquista personale di chi ha la volontà di contemplarlo.
32
Enn. I, 8, 8, 38 ss., dove si definisce metaforicamente il primo male to# sko@tov, il secondo
to# eèskotisme@non.
33
PLAT. Phil. 64d-e; 65a.
34
J. P. ANTON, Plotinus’ Refutation, art. cit., p. 234. Con riferimento ad Enn. VI, 7, 22,
passo da noi su tradotto e commentato, lo studioso scrive: «(…) it is significant to note that he
views symmetry as an outcome, in fact, one of the outcomes of beauty. Part of his theory is,
then, to demonstrate why and how symmetry is an effect and not the cause of beauty (…)».
Sul concetto di simmetria, poi, con uno sguardo retrospettivo ispirato al pensiero di uno degli
ultimi neoplatonici, si veda T. M. PELEGRINIS, Damascius, symmetry and a means toward
man’s perfection, «Diotima», VII, 1979, pp. 147-151.
35
“Infedele” nel senso che la su@gkrasiv platonica di Phil. 64 d è evidentemente altro dal
mi^gma. Per scongiurare la rovina delle sue parti e di se stessa, secondo Platone la su@gkrasiv deve
ispirarsi al me@tron e, si badi, alla fu@siv del su@mmetron, non al su@mmetron tout court. Non si può
non concludere che, platonicamente, la fu@siv del su@mmetron sia altro dal me@tron. Parlando di
mi^gma, allora, Plotino non può che avere in mente Anassagora, citato esplicitamente in Enn. V,
1, 9, 1 e, soprattutto, in Enn. II, 4, 7, 2, dove si critica la simultaneità (to# açma), che il filosofo
presocratico avrebbe propugnato, tra il mi^gma originario, inteso come uçlh, e il nou^v. «Se quella
mescolanza (to# mi@gma) partecipasse dell’essere (tou^ eiùnai), l’essere verrebbe prima (pro@teron to#
oòn); se invece fosse essa stessa un essere (tou^to oàn), ci sarebbe bisogno di un terzo essere (aòllou...tri@tou) oltre agli altri». Ma la questione della uçlh in Plotino è troppo complessa per poter
essere risolta in una chiosa; per un’analisi puntuale e sistematica del problema della materia
sensibile ed intelligibile nel pensiero plotiniano, rinviamo a J.-M. NARBONNE (Introduction,
texte grec, traduction et commentaire précédé d’un Essai sur la problématique plotinienne
par) Plotin. Les deux matières [Ennéade II, 4 (12)], Paris 1993 e, sul piano concettuale, a J.
ZANDEE, The terminology of Plotinus and of some gnostic writings, mainly the fourth treatise of
the jung codex, Leiden 1961, pp. 18-19.
Contributi per una definizione della simmetria in Plotino
169
plotiniana sia anti-simmetrica, tout court. Essa si fonda invece su un diverso
concetto di simmetria: “rivoluzionario” nel senso etimologico dell’aggettivo, ossia rivolto alle origini. Poiché nel concepimento di una simmetria del genere si
consuma un vero “tradimento” dell’estetica plotiniana verso il magistero platonico e, con ogni probabilità, si nasconde la prova più eloquente di un enorme
influsso su di essa del pensiero di Eraclito36.
36
Sul nesso tra Plotino ed Eraclito, rinviamo alle nostre osservazioni in CH. VASSALLO,
Il bello e l’armonia invisibile: per un’analisi dei rapporti tra Eraclito e l’estetica di Plotino, in
«Incidenza dell’Antico. Dialoghi di storia greca», VI, 2008, pp. 273-284.
Hegel a Stoccarda: l’incontro con la cultura dell’Aufklärung
171
Hegel a Stoccarda: l’incontro con la cultura dell’Aufklärung
Memoria di Mariafilomena Anzalone
presentata dal socio naz. ord. res. Giuseppe Cantillo
(seduta del 29 maggio 2008)
Abstract. In this short essay we’ll try to highlight some issues, the reasons and aspects of the culture of the Aufklärung that in the Stoccarda’s years have influenced the
young Hegel stimulating his interest in the reflection upon the man and upon his skills.
After having shown how most of the authors with whom Hegel has a confrontation in
those years belong to a specific as well as variegated cultural area of the German Enlightment, that of the so called Populärphilosophie, we’ll dwell, in particular, on two between
the first Hegel’ studies of psycho-pedagogic matter, devoted respectively to the works of
J. G. H. Feder and of J. H. Campe. Our aim is that to show how Hegel through the lecture
of their works had not only way to have a confrontation with some lines of the anthropology and of the enlightened psychology but he has also been stimulated towards a matter
that will have not a little space in his formation: that of the upbringing.
Con le ricerche di Dilthey1, gli anni della formazione hegeliana, a lungo trascurati dalla critica, si sono imposti come punto di partenza essenziale per
la ricostruzione della genesi e dello sviluppo della filosofia di Hegel2. Il lungo
lavoro di ricomposizione e di riorganizzazione degli scritti giovanili, portato
avanti dalla Hegel-Forschung nel corso di un secolo3 consente oggi di disporre
1
W. DILTHEY, Die Jugendgeschichte Hegels, Akad. d. Wissenschafen, Berlin 1905, poi in
Gesammelte Schriften, Bd. IV, Teubner, Stuttgart 1968, trad. it. di G. Cavallo Guzzo in Storia
della giovinezza di Hegel e frammenti postumi, a cura di G. Cacciatore e G. Cantillo, Guida
editore, Napoli 1986.
2
Per una ricostruzione delle principali interpretazioni degli scritti giovanili hegeliani oltre al già citato testo di Dilthey, cfr. almeno: T. HAERING, Hegel. Sein Wollen und Werk. Eine
chronologische Entwicklungsgeschichte der Gedanken und der Sprache Hegels, 2. Bde., Teubner
Leipzig 1929-1938; J. HOFFMEISTER, Dokumente zu Hegels Entwicklung, Fromman-Holzboog, Stuttgart 1936, 1974; G. LUKÁCS, Der junge Hegel und die Probleme der kapitalistischen
Gesellschaft, Europa Verlag, Zürich-Wien 1948 (trad. it. a cura R. Solmi in Il giovane Hegel e i
problemi della società capitalistica, Einaudi, Torino 1960); C. LACORTE, Il primo Hegel, Sansoni, Firenze 1959; A. MASSOLO, Prime ricerche di Hegel, Steu, Urbino 1959; A. PEPERZAK, Le
jeune Hegel et la vision morale du monde, Nijhoff, Den Haag 1960, 2ª ed. 1969 ; F. NICOLIN, Auf
Hegels Spuren, hrsg. v. L. Sziborsky e H. Schneider, Meiner, Hamburg 1996.
3
Il lavoro di Dilthey, oltre a stimolare un notevole interesse per la personalità filosofica
del giovane Hegel, pose con forza l’esigenza di un’edizione critica degli scritti giovanili he-
172
Mariafilomena Anzalone
di un complesso di materiali che, oltre a testimoniare l’attenzione hegeliana per
alcune specifiche problematiche, come ad esempio quelle di carattere psicologico, pedagogico e antropologico, permette di risalire con una certa sicurezza
alle correnti culturali e a i pensatori con cui Hegel si è confrontato da studente.
Per quanto si tratti spesso di documenti poco originali, essi gettano una luce
significativa sulle fonti del pensiero hegeliano, consentendo, nel contempo, di
cogliere l’originarietà di alcuni nuclei problematici intorno ai quali Hegel ha
iniziato a tessere la sua trama concettuale4. Uno di questi è costituito dalla volontà, manifestatasi già negli anni di Stoccarda, di riuscire a comprendere nella
maniera più esaustiva possibile i molteplici aspetti della vita degli uomini inserendoli nel più generale quadro di una “storia prammatica”5 dell’umanità che
risalga, come spiega Dilthey, “al di là dei semplici fatti, ai caratteri degli uomini
famosi, ai costumi, agli usi, alla religione, all’intero carattere delle nazioni”6. A
questo scopo Hegel, convinto dell’importanza dell’indagine psicologica sull’anima umana per ogni considerazione di carattere storico7, svolge, appena adolescente, una serie di studi che hanno per oggetto le opere di alcuni esponenti
del tardo illuminismo tedesco riconducibili a quella vasta area culturale che si
suole designare con l’appellativo di Populärphilosophie.
geliani, esigenza, raccolta inizialmente da H. Nohl con l’edizione delle Hegels Theologische
Jugendschriften, (Mohr, Tübingen 1907) e ripresa da J. Hoffmeister nei Dokumente zu Hegels
Entwicklung (Fromman-Holzboog, Stuttgart 1936, 1974). Oggi, grazie al lavoro condotto dalla
Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften nell’ambito dell’edizione critica delle
Gesammelte Werke hegeliane, è possibile accedere a tutti i documenti risalenti agli anni della
formazione hegeliana e, in alcuni casi, anche agli originali da cui Hegel effettua gli estratti. Cfr.
i primi tre volumi dell’edizione critica curati di F. Nicolin, G. Schüler e I. Rill; in questo saggio
prenderemo in particolare considerazione il terzo intitolato Frühe Exzerpte, (Teil I, hrsg. v. F.
Nicolin, in Gesammelte Werke, Bd. III, Meiner, Hamburg 1991, d’ora in poi FrE).
4
Sul valore “dell’enorme lavoro sotterraneo compiuto da Hegel da Stoccarda a Francoforte” per comprendere appieno l’ideale hegeliano degli anni giovanili, cfr. G. CANTILLO, Hegel a
Jena, in ID., Le forme dell’umano. Studi su Hegel, Esi, Napoli 1996, p. 62.
5
Il primo luglio del 1785 annota sul Tagebuch che si sta delineando in lui l’idea di una “storia prammatica” e che essa va intesa non semplicemente come limitata allo studio dei “facta”,
ma aperta alla considerazione “del carattere di un uomo famoso, di un’intera nazione, i suoi
costumi, usi, religione eccetera (…)”, G.W.F. HEGEL, Frühe Schriften, Teil I, hrsg. v. F. Nicolin
und G. Schüler, in Gesammelte Werke, Bd. I, Meiner, Hamburg 1989, pp. 3-33 (d’ora in poi FrS),
trad. it. a cura di E. Mirri in Scritti giovanili, Guida, Napoli 1993, pp. 29-67, (d’ora in poi Sg) p.
32. Queste riflessioni, ispirate probabilmente anche dalla lettura del Lehrbuch der allgemeinen
Weltgeschichte zum gebrauche bei dem ersten Unterrichte der Jugend (1774) di J. M. Schröckh,
uno dei testi più diffusi nelle scuole dell’epoca, mostrano come Hegel considerasse l’indagine
psicologica dell’anima umana una sorta di ricerca preliminare rispetto a quella storica.
6
W. DILTHEY, Storia della giovinezza di Hegel e frammenti postumi, cit., p. 22.
7
Questa convinzione si può evincere anche da uno scritto del 1785 il Colloquio a tre (FrS,
pp. 37-39; Sg pp. 81-84) in cui, analizzando fenomeni e personaggi storici, Hegel cerca di individuare, a volte anche in maniera ingenua e stereotipata, precisi modelli comportamentali che
hanno contraddistinto non solo gli individui ma anche le diverse epoche storiche.
Hegel a Stoccarda: l’incontro con la cultura dell’Aufklärung
173
In questo breve saggio tenteremo di evidenziare i temi e gli aspetti di questo
filone culturale che negli anni di Stoccarda possono aver influenzato il giovane
Hegel sollecitando il suo interesse per la riflessione sull’uomo e sulle sue facoltà. Ci soffermeremo, in particolare, su due tra i primissimi studi hegeliani di
argomento psico-pedagogico, dedicati rispettivamente alle opere di J.G.H. Feder e di J.H. Campe allo scopo di mostrare come, dalla lettura dei loro scritti,
Hegel abbia tratto non solo importanti stimoli intellettuali per lo sviluppo di
una sua autonoma visione della soggettività ma sia stato sollecitato in direzione di una problematica che avrà non poco spazio nella sua formazione: quella
dell’educazione. Nelle riflessioni di questi come di altri studiosi dell’epoca8 Hegel poteva infatti trovare un’analisi delle caratteristiche costitutive delle facoltà
umane che non esauriva in se stessa il suo significato ma era funzionale, se non
addirittura propedeutica, alla possibilità stessa di promuoverne e realizzarne il
perfezionamento mediante l’educazione.
La rilevanza dell’interesse hegeliano per le questioni di carattere educativo è stata particolarmente sottolineata da Gustav Thaulow che nel suo Hegel’s Ansichten über Erziehung und Unterricht9 ha individuato nel “concetto” e
nell’“essenza dell’educazione (…) il centro dell’energia spirituale”, intorno a cui
si orientano e convergono i pensieri, le riflessioni e l’entusiasmo morale della
filosofia hegeliana. Per avvalorare questa tesi Thaulow ha pubblicato nel secondo volume della sua opera10 una raccolta di documenti del periodo di Stoccarda
riguardanti la pedagogia e la psicologia11, documenti che egli aveva rinvenuto
durante una revisione del corpus dei manoscritti hegeliani. Al di là della con8
Esemplare in questo senso è il Versuch über die Prüfung der Fähigkeiten di Christian Garve (1742-1798) da cui Hegel redige un estratto nel 1787 (Exzerpte n° 15 in FrE, pp. 126-162).
In questo testo l’analisi delle facoltà dell’individuo è presentata da Garve come un presupposto
essenziale per l’attività educativa. L’obiettivo di tale esame, però, non può e non deve essere
quello di indicare semplicemente all’uomo la sua Bestimmung, ma, piuttosto, di renderlo maggiormente consapevole delle caratteristiche della sua natura (Beschaffenheit) affinché, cogliendo da sé le proprie potenzialità e i propri talenti, possa più agevolmente realizzarsi ed essere
felice. Del resto, è proprio nella capacità che una ricerca ha di incidere effettivamente nella
vita dell’uomo che risiede, secondo Garve, il suo valore e la sua utilità.
9
G. THAULOW, Hegel’s Ansichten über Erziehung und Unterricht. In drei Teilen. Als Fermente für wissenschaftliche Pädagogik sowie zur Belehrung und Anregung für gebildete Eltern
und Lehrer aller Art aus Hegel’s sämtlichen Schriften gesammelt und systematisch geordnet, Kiel,
Akadem. Buchandlung, 1853-1854.
10
Cfr. G. THAULOW, Zur Gymnasialpädagogik und zur Universität Gehöriges in ID., Hegel’s
Ansichten über Erziehung und Unterricht, cit.
11
Il gruppo di documenti di carattere pedagogico e didattico era indicato sotto un titolo
indecifrabile nel manoscritto, ma che, secondo Thaulow, è sicuramente “Zur Pädagogik”, (cfr.
G. THAULOW, Hegel’s Ansichten über Erziehung und Unterricht, cit., II, sez. I, p. VII). Tali
estratti sono presenti nel terzo volume dell’edizione critica delle Gesammelte Werke hegeliane,
dove sono riportate anche le note editoriali del Thaulow.
174
Mariafilomena Anzalone
divisibilità dell’interpretazione di Thaulow12, il suo lavoro ha avuto non solo il
merito di conservare almeno una parte di questo materiale, non pubblicato da
Rosenkranz, ma ha evidenziato un nucleo di interessi, quello per la pedagogia,
che, se non esclusivo, è sicuramente assai significativo nei primi anni della formazione hegeliana.
Per intendere appieno i termini in cui Hegel può essersi confrontato con tali
problematiche bisogna però tener presente che il problema educativo, nell’orizzonte di pensiero illuminista, volto innanzitutto alla completa emancipazione
dell’uomo mediante la sua uscita dallo “stato di minorità”, non poteva trovare
risposta solo all’interno di un ambito strettamente pedagogico. Esso chiamava
in causa il concetto stesso di Aufklärung e il suo rapporto con una Bildung13
capace di estendersi all’uomo comune declinandosi nei termini pragmaticomorali di un’educazione e formazione popolare14. Ciò diverrà chiaro allo stesso
Hegel che seguirà con grande attenzione il dibattito sviluppatosi sulla Berlinische Monatsschrift15 intorno alla questione “Che cos’è illuminismo”16 e a, pochi
anni dai suoi studi ginnasiali, rifletterà lungamente sulla possibilità di realizzare un’educazione del popolo17 capace di favorire un profondo rinnovamento
spirituale e politico.
12
Secondo Hoffmeister l’interpretazione di Thaulow è condivisibile solo se per pedagogia
si intende una Pädagogik des Menschengeschlechts, e non una teoria dell’educazione in genere.
Cfr. J. HOFFMEISTER, Dokumente zu Hegels Entwicklung, cit., p. 415.
13
Sul concetto di Bildung in Germania cfr. almeno G. BOLLENBECK, Bildung und Kultur.
Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters, Insel Verlag, Frank./M. 1994.
14
Cfr. H. STUKE, Aufklärung, in Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur
politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hrsg. V. O. Bruner, W. Conze, R. Koselleck, I, Stuttgart, 1972, pp. 243-342.
15
Diretta da J. E. Biester e da F. Gedike fu una delle riviste più importanti dell’epoca, anche perché Kant decise di pubblicare su di essa alcuni dei suoi saggi minori.
16
Per una ricostruzione di questo dibattito, cfr. I. KANT, Che cos’è ’illuminismo? Riflessione filosofica e pratica politica, a cura di N. Merker, Editori riuniti, Roma 2006. Il testo raccoglie,
oltre allo scritto di Kant e quello di Mendelssohn, anche gli interventi sul tema proposti da
Hamann, Herder, Lessing, ecc. Hegel lesse sicuramente il saggio di Mendelssohn, intitolato,
Über die Frage: was heisst aufklären? (1784) in cui l’autore mirava ad una definizione immediatamente comprensibile dell’Aufklärung soffermandosi sulla differenza tra il rischiaramento
dell’uomo come tale e come cittadino. A documentare questa lettura hegeliana è l’Exzerpt 21,
(FrE, pp. 169-174) del 1787.
17
L’ideale di una religione popolare che, a partire dal periodo di Tubinga, sarà uno dei
principali motivi del pensiero hegeliano si lega strettamente a quello di un’“educazione del
popolo” che sappia far valere e far vivere nella vita concreta degli uomini i principi religiosi. Su
questo punto cfr. G. CANTILLO, «Privatleben» e senso dello Stato negli scritti giovanili di Hegel,
in ID., Le forme dell’umano, cit., p. 10.
Hegel a Stoccarda: l’incontro con la cultura dell’Aufklärung
175
1. Hegel e la Populärphilosophie
Durante la permanenza di Hegel presso il ginnasio di Stoccarda (17771788), l’istituto iniziò ad aprirsi alle tendenze pedagogiche dei tempi nuovi18,
fino a giungere nel 1796 ad una vera e propria riforma dell’ordinamento scolastico19. Hegel in parte poté beneficiare di questo “nuovo corso” che prevedeva
da un lato l’utilizzo, nell’ambito delle lezioni e dei programmi scolastici, delle opere dei contemporanei e dall’altro, una metodologia didattica finalizzata
ad introdurre un modello educativo capace di promuovere la Bildung des Herzens20, coinvolgendo gli studenti attraverso temi e argomenti piacevoli. Il corso
di studi di Hegel avviene, dunque, in un periodo di transizione in cui lo spirito
illuminista comincia a farsi strada anche negli ambienti più conservatori e tradizionalisti. Nel caso del Realgymnasium, però, per quanto ci fossero delle aperture alla cultura dell’Aufklärung, la formazione scolastica rimaneva di stampo
fortemente umanistico, incentrata com’era sullo studio della cultura classica21.
Come osserva Lacorte, il vero mutamento si ebbe soprattutto nella “maniera” e
nello “spirito con cui gli stessi insegnamenti venivano impartiti”22. C’era infatti una “maggiore franchezza e spregiudicatezza del rapporto che l’epoca della
querelle si era convinta di poter stabilire fra i testi classici e il lettore illuminato, insieme alla superiore dignità concessa dai «moderni» del secolo XVIII
alle nuove scienze sperimentali e agli autori contemporanei”23. La formazione
scolastica hegeliana, come ha rilevato Rosenkranz24, riflette questa compresenza di cultura umanistica e cultura illuminista, compresenza che è possibile riscontrare anche scorrendo i programmi di lezione25. In particolare, per quello
18
Non mancarono all’interno del ginnasio coloro che si opposero alle riforme dettate dal
nuovo indirizzo pedagogico. Tra di essi possiamo ricordare Balthasar Haug, dal 1767 insegnante di religione e di latino, fortemente polemico nei confronti di una pedagogia che giudicava impraticabile oltre che amorale. Cfr. G. LANG, Geschichte der Stuttgarter Gelehrtenschulen, Kohlhammer, Stuttgart 1902, pp. 271 e ss.
19
Cfr. C. LACORTE, Il primo Hegel, cit., p. 61.
20
Cfr. G. LANG, Geschichte der Stuttgarter Gelehrtenschulen, cit., pp. 252 e ss.
21
Sull’importanza della tradizione umanistica nel ginnasio di Stoccarda cfr. F. NICOLIN
(hrsg. v.), Hegel (1770-1970). Leben- Werk-Wirkung, Klett Verlag, Stuttgart 1970, pp. 51 e ss.
22
C. LACORTE, Il primo Hegel, cit., p. 61.
23
Ibidem.
24
“La formazione di Hegel era dal punto di vista dei principi assolutamente basata sull’illuminismo; da quello dello studio sull’antichità classica”, K. ROSENKRANZ, Vita di Hegel,
trad. it. a cura di R. Bodei, Vallecchi, Firenze 1966, p. 32.
25
Cfr. Beiträge zur Geschichte des Gelehrtenschulwesens in Württemberg im 17. und 18.
Jahrhundert in cui è possibile leggere la Übersicht über das Personale, Doktrinale und Disciplinare des Gymnasium, un documento redatto dal rettore del ginnasio che espone l’ordinamento
degli studi alla commissione incaricata di riformare l’organizzazione dell’istituto. Il documento è relativo al 1794 ma confrontandolo con le annotazioni riportate da Hegel e con quelle
176
Mariafilomena Anzalone
che concerne l’insegnamento di filosofia, impartito in latino, si può osservare
che, accanto allo studio di Cicerone e dei suoi dialoghi il programma prevedeva
anche l’utilizzo di opere di contemporanei come il filologo J. A. Ernesti e il già
citato Feder.
Quest’attenzione per le correnti della cultura contemporanea tedesca trova
riscontro nell’ambito degli interessi che Hegel coltivava al di là dei suoi impegni scolastici e che sono documentati innanzitutto dagli Exzerpte redatti da
Hegel per tutto l’arco di tempo che va dagli studi a Stoccarda fino al soggiorno
bernese. Come ci informa Karl Rosenkranz26, tali Exzerpte sono il frutto di un
particolare metodo di studio che Hegel utilizzò fin dai primi anni del ginnasio:
esso consisteva nel redigere estratti di tutte le letture da lui effettuate, sia quelle
condotte per corrispondere agli impegni scolastici che quelle intraprese per un
interesse personale. Tali estratti venivano poi raccolti e ordinati in cartelle che
riportavano sul dorso un’indicazione orientativa degli argomenti contenuti. In
alcuni casi Hegel ricopiava addirittura interi capitoli delle opere, in modo da
possederne una copia. Come abbiamo accennato, non tutti gli estratti redatti
da Hegel ci sono giunti: conservati dalla moglie, dopo la sua morte essi furono
poi affidati al Rosenkranz per la stesura della Hegel’s Leben. Rosenkranz non
accordò a tutti la dignità di stampa e molti di essi, subito dopo la pubblicazione
dell’opera andarono irrimediabilmente perduti. L’incompletezza del materiale
pervenuto, non consente, soprattutto per quanto riguarda il periodo di Stoccarda27, di accertare con assoluta sicurezza l’esistenza di un’unica e predominante
direttrice che orientasse tutte le letture e gli studi hegeliani. Tuttavia, gli estratti
raccolti nell’edizione critica permettono di ricostruire, almeno a grandi linee,
un quadro abbastanza definito e articolato dei riferimenti intellettuali e, in particolare, filosofici del giovane Hegel e di comprendere quali aspetti del dibattito
culturale del suo tempo abbiano svolto un ruolo più o meno decisivo nella sua
formazione28.
fornite dal Lang riguardo al 1784 (Geschichte der Stuttgarter Gelehrtenschulen, cit., pp. 285 e
ss.), si può avere un’idea abbastanza precisa dei programmi scolastici.
26
K. ROSENKRANZ, Vita di Hegel, cit., pp. 28-42.
27
Sul periodo di Stoccarda cfr. almeno: B. TEYSSÈDRE, Hegel à Stuttgart, «Revue philosophique de France e de l’étranger», 150, 1960, pp. 197-227; F. NICOLIN, Der Junge Hegel
in Stuttgart. Aufsätze und Tagenbuchaufzeichnungen 1785-1788, Stuttgart 1970; C. JAMME-O.
PÖGGELER, “O Fürstin der Heimat! Glückliches Stuttgart”. Politik, Kultur und Gesellschaft im
deutschen Südwesten um 1800, Klett-Cotta, Stuttgart 1988; R. POZZO, Hegel “Introductio in philosophiam”. Dagli studi ginnasiali alla prima logica (1782-1801), La Nuova Italia, Firenze 1989.
28
Di grande importanza, in questo senso, oltre agli Exzerpte, sono le indicazioni che possiamo evincere dal Tagebuch di Hegel che, come ha sottolineato Edoardo Mirri, “è un documento veramente prezioso (…) sia per le informazioni che dà sulla vita del ginnasio di
Stoccarda, sia per alcune notizie sulla piccola cronaca della città, sia e soprattutto - se non
Hegel a Stoccarda: l’incontro con la cultura dell’Aufklärung
177
Soprattutto per quel che concerne le tematiche di carattere filosofico e più
specificamente le questioni psico-pedagogiche e antropologiche, Hegel sembra
trovare un considerevole punto di riferimento in un filone ben preciso dell’illuminismo tedesco. Scorrendo rapidamente gli estratti hegeliani possiamo osservare che la maggior parte degli autori con cui si confronta (Mendelssohn, Garve, Feder, Campe), appartengono ad una specifica quanto variegata area culturale, quella della cosiddetta Populärphilosophie. Con questa categoria storiografica si fa riferimento ad un orientamento filosofico dell’illuminismo tedesco
della seconda metà del Settecento29 che, pur nella varietà delle posizioni e degli
interessi, perseguiva l’idea di una filosofia über und für die Welt30, che trattasse
nella maniera più accessibile questioni vicine alla vita degli uomini. Se da un
lato questo movimento fu influenzato dall’empirismo lockiano, dall’altro intese
richiamarsi ai temi e al modo di concepire la filosofia che, agli inizi del secolo,
avevano caratterizzato la riflessione di Christian Thomasius. La svolta da lui
apportata nella concezione dell’uomo, del mondo e dello stesso sapere filosofico, aveva segnato, in effetti, un momento decisivo nella cultura filosofica, tanto
da fare di Thomasius uno dei fondatori dell’illuminismo tedesco31. Opponendosi risolutamente all’astrattezza della filosofia spinoziana e leibniziana, Thomasius aveva rivendicato la necessità di un sapere che fosse utile all’uomo e al suo
vivere in società, proponendo un ideale di cultura e di filosofia che potesse incidere concretamente nel reale non rimanendo confinato all’interno dell’angusto
spazio delle cerchie intellettuali. Da dottrina dell’essere la filosofia diveniva così
“dottrina dell’uomo, della sua Bestimmung, dei suoi rapporti con il prossimo
(…) un’attività finalizzata all’emancipazione intellettuale e morale dell’uomo”32.
addirittura esclusivamente - per la luce che getta sulla prima formazione del giovane”, E.
MIRRI, Introduzione, Sg, p. 21.
29
Per una riflessione sul ruolo della filosofia popolare nella filosofia e più in generale nella
cultura tedesca cfr. H.C.W. SIGWART, Geschichte der Philosophie von allgemeine Wissenschaftslehre und geschichtliche Standpunkt, Bd. 2, Cotta, Stuttgart 1844, pp. 443 e ss.; L. W. BECK,
Early German philosophy. Kant and his predecessors, Cambridge, Mass 1969.
30
Le espressioni Populärphilosophie o Philosophie für die Welt sono spesso utilizzate indifferentemente dagli stessi esponenti di questo movimento. Cfr. le Prefazioni di Garve alle
due edizioni della traduzione del De officiis ciceroniano: Abhandlungen über die menschlichen
Pflichten in drei Büchern, aus dem Lateinischen des Marcus Tullio Cicero übersetzt von C. Garve,
Breslau (1787, II ed. ampliata con Annotazioni; 1783), Teil 1, Die Übersetzung, in Ch. GARVE,
Gesammelte Werke, hrsg. v. K. Wölfel, Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New-York, 1985, III
Abt., Bd. IX; Teil 2 e III Abt., Bd. X.
31
Cfr. R. CIAFARDONE, L’illuminismo tedesco, Loescher Editore, Torino 1983, pp. 12 e
ss. Sul ruolo svolto dalla filosofia di Thomasius nell’illuminismo tedesco che risulta, così, non
del tutto riconducibile sotto l’egida del razionalismo sistematico cfr. M. WUNDT, Die deutsche
Schulphilosophie im Zeitalter der Aufklärung, Hildesheim, Olms 1992.
32
R. CIAFARDONE, Introduzione, in Ch. WOLFF, Metafisica tedesca, Rusconi, Milano
1999, p. XVIII.
178
Mariafilomena Anzalone
Tale ideale di filosofia che Thomasius stesso definiva Welt-Weisheit, sfociava, coerentemente, in una riflessione sulle facoltà dell’individuo che andava compreso “come unità assoluta di tutte le forze fisiche e spirituali”33 perché il problema
antropologico non può trovare alcuna risposta se si mantiene fermo e si accetta
il dualismo cartesiano delle sostanze. L’influsso della speculazione di Thomasius sul pensiero settecentesco conobbe una battuta d’arresto con l’ascesa della filosofia wolffiana e con la conseguente affermazione di un nuovo modello
culturale che teneva conto dello sviluppo del sapere matematico-scientifico e
rivendicava, sulla scia di Leibniz34, il primato della vita intellettuale35. Tuttavia, anche all’interno di questa tradizione, continuò a permanere l’interesse per
l’uomo e per le sue facoltà, basti pensare alla rilevanza che il discorso psicologico assume nella filosofia di Wolff36 e dei suoi seguaci37.
In questo panorama storico-culturale la Populärphilosophie si configura
come ha osservato Ciafardone, nei termini di un movimento caratterizzato proprio dalla “ripresa e dall’approfondimento della problematica filosofica posta
da Thomasius all’inizio del secolo”38. Non che la lezione wolffiana smetta di
agire, anzi: molti tra i filosofi popolari si sono formati alla scuola di Wolff. Tuttavia le questioni metafisiche che avevano contraddistinto la filosofia wolffiana
vengono da loro affrontate in vista di un più generale interesse antropologico
che orienta anche le problematiche etiche e religiose. I filosofi popolari intendono non perdere di vista il contatto con la vita proponendo una Lebensphilosophie39 che concorra a delineare forme di sapere più pratiche e più rispondenti
ai problemi e alle esigenze della nuova borghesia tedesca. Essenziale, in questo
senso, è il carattere divulgativo di tale filosofia la cui “popolarità” vuole essere
33
W. R. JAITNER, Thomasius, Rüdiger, Hoffmann und Crusius. Studien zur Menschenkunde und Theorie der Lebensführung im 18. Jahrhundert, Niegt, Bleicherode am Harz 1939, p. 7.
34
“ (…) nulla giova alla felicità quanto l’illuminazione dell’intelletto e la pratica della
volontà di agire sempre secondo l’intelletto; e tale illuminazione è da cercare specialmente
nella conoscenza di quelle cose che possono elevare il nostro intelletto a una luce sempre più
alta, perché così ne risulta un continuo progresso nella sapienza e nella virtù, e quindi anche
nella perfezione e nella gioia, il cui vantaggio resta nell’anima anche per questa vita”, G.W.
LEIBNIZ, Sulla felicità, in ID., Scritti filosofici, a cura di D. O. Bianca, Utet, Torino 1988, vol.
II, p. 756.
35
Cfr. R. CIAFARDONE, L’illuminismo tedesco, cit., pp. 50 e ss.
36
Cfr. F. MARCOLUNGO, L’intreccio di psicologia empirica e psicologia razionale in Christian Wolff, in AA.VV., Ethos e cultura. Studi in onore di Ezio Riondato, Liviana, Padova 1991,
pp. 303-324.
37
Su questo punto cfr. C. DE PASCALE, Kant: la natura umana tra antropologia e criticismo, «Filosofia politica» 4, 1990, pp. 283-304.
38
R. CIAFARDONE, L’illuminismo tedesco, cit., p. 28.
39
Questa espressione è rintracciabile in una raccolta di scritti di J. A. Ernesti nella quale
alla De philosophia populari, segue la prolusione dal titolo “De philosophia vitae” (cfr. J. A. ERNESTI, Opuscola oratoria, Orationes, Prolusione et, 1767, pp. 189 e ss.).
Hegel a Stoccarda: l’incontro con la cultura dell’Aufklärung
179
una esplicita adesione all’invito di Diderot: “Hâtons nous de rendre la philosophie populaire”40. In effetti l’appellativo “popolare” viene introdotto dal filologo Ernesti che, richiamandosi proprio all’esortazione di Diderot41, delinea il
programma di una filosofia popolare individuandone le caratteristiche basilari
nel rifiuto di ogni inutile sofisma e nell’idea di una “gebildeter Popularität”. La
formazione filologica di Ernesti lo induce ad utilizzare il termine “popolare”
riferendosi alla distinzione ciceroniana42 tra un “genus subtile et acutum” e
un “genus populare” del discorso e a lumeggiare la possibilità di una “subtilis
et erudita popularitas” anche per quel che concerne il discorso filosofico. Esso
deve divenire accessibile per ogni lettore perchè la filosofia, come spiega un altro esponente di questa corrente di pensiero, J. G. Sulzer, è “eine Wissenschaft
für jeden Menschen”43.
Proprio in nome di questa esigenza si sviluppò in Germania un ampio dibattito sulla possibilità di rendere popolare la filosofia, dibattito nel quale intervenne anche Kant. Accusato di oscurità44 all’indomani della pubblicazione della
Critica della ragion pura, egli, pur accogliendo l’esigenza di portare le dottrine
filosofiche “ad una forma divulgativa atta ad esser compresa dalla generalità”
sostenne, però, l’impossibilità di una volgarizzazione o popolarizzazione per
quel che concerne “il sistema di una critica della ragione stessa e per tutto
quanto non può essere determinato se non dalla ragione medesima”45. Anche
Hegel, qualche hanno dopo, si inserirà in questa discussione, rovesciandone,
però, i termini. Sia per i filosofi popolari che per Kant il problema era stato
quello di capire se e in che modo la filosofia potesse divenire patrimonio della
coscienza comune. Per Hegel, invece, già nei primi anni jenesi, il problema sarà
quello di elevare ciò che è popolare, di elevare la coscienza comune al punto di
vista della vera filosofia, di compiere, rendendolo comprensibile, il passaggio
D. DIDEROT, Pensées sur l’interprétation de la nature, Paris, 1754, n. XL.
Cfr. R. MORTIER, Diderot, Ernesti et la ‘philosophia popularis’ in J. PAPPAS (a cura di),
Essays on Diderot and Enlightenment in honor of Fellows, Droz, Genève 1974, pp. 207-230.
42
Sul ruolo di ‘precursore’ svolto da Cicerone rispetto alla filosofia popolare cfr. C. BÖHR,
Philosophie für die Welt. Die Populärphilosophie der deutschen Spätaufklärung im Zeitalter
Kants, Fromman-Holzboog Stuttgart-Bad Cannstatt, 2003, pp. 24 e ss.
43
J. G. SULZER, Vorrede zur deutsche Ausgabe von D. HUME, Vermischten Schriften 2
(1775), p. 7.
44
è nota la vicenda della recensione negativa alla Critica della ragion pura apparsa sulla
«Philosophische Bibliothek» a nome di Garve, ma fortemente rimaneggiata prima della pubblicazione da Feder che, probabilmente, non aveva nemmeno letto l’opera. L’episodio raccontato da Kant nei Prolegomeni è riportato da C. ALTMAYER, Aufklärung als Populärphilosophie.
Bürgerliches Individuum und Öffentlichkeit bei Christian Garve, Röhrig St. Ingbert, 1992, pp.
22 e ss.
45
Cfr. I. KANT, La metafisica dei costumi, trad. a cura di G. Vidari, Laterza, Roma-Bari
1983, pp. 4-5.
40
41
180
Mariafilomena Anzalone
dal contingente al necessario, dal sapere fenomenico a quello assoluto: “l’assoluto deve essere costruito per la coscienza, questo è il compito della filosofia”46.
Tale compito, com’è noto, sarà assolto dalla Fenomenologia dello spirito in cui
Hegel ribadirà che la filosofia, in quanto scienza, deve essere innanzitutto chiara e aperta a tutti. Questo non significa sostenere una totale assenza di difficoltà
per chi si avvicini ad essa: le difficoltà ci sono, ma sono superabili perché il loro
procedimento è determinato e i passaggi concettuali sono chiariti: “Soltanto
ciò che è perfettamente determinato è anche essoterico, da tutti concepibile e
suscettibile di venir da tutti imparato e di essere proprietà di tutti. La via della
scienza è la sua forma intelligibile, via aperta a tutti e per tutti eguale”47.
La convinzione che la filosofia fosse un sapere essoterico e come tale dovesse essere praticata era fortemente radicata nei filosofi popolari che però, come
Hegel rileverà nelle Lezioni sulla storia della filosofia48, solo in pochi casi sono
riusciti a dar vita ad un percorso filosofico autonomo e originale. Dal punto
di vista teorico essi sono rimasti fermi ai contenuti immediati e naturali della
coscienza comune49 ed è questo, secondo Hegel, il loro più grosso limite ma
anche il fattore che, insieme all’accessibilità dei loro scritti, dovuta spesso ad
46
G.W.F. HEGEL, Differenz des Fichte’schen und Schelling’schen System der Philosophie
(Jena 1801), in G.W.F. HEGEL, Jenaer kritische Schriften, hrsg. v. H. Buchner u. O. Pöggeler,
in Gesammelte Werke, Bd. IV, Meiner, Hamburg 1968, trad. it a cura di R. Bodei con il titolo
Differenza fra il sistema filosofico di Fichte e quello di Schelling in G.W.F. HEGEL, Primi scritti
critici, a cura di R. Bodei, Mursia, Milano 1990, p. 18.
47
G.W.F. HEGEL, Phänomenologie des Geistes, hrsg. v. W. Bonsiepen u. R. Heede, in Gesammelte Werke, Bd. IX, Meiner, Hamburg 1980, trad. it. a cura di E. De Negri in Fenomenologia dello spirito, 2 voll., La Nuova Italia, Firenze 1974 (d’ora in poi Fen), p. 11.
48
Cfr. G.W.F. HEGEL, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, hrsg. v. P. Garniron
u. W. Jaeschke, in Vorlesungen. Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte, Meiner, Hamburg
1986-1996, Bde VI-IX, trad. it. a cura di E. Codignola e G. Sanna in Lezioni sulla storia della
filosofia, 4 voll., La Nuova Italia, Firenze 1973, III2, pp. 214 e ss. E’ da notare che Hegel in queste lezioni dedicherà uno specifico paragrafo alla filosofia popolare e, nel contempo, utilizzerà
quest’espressione come strumento interpretativo atto ad indicare un particolare modo di fare
filosofia, privo di valore speculativo ma radicato nell’esperienza umana. Troviamo così, in consonanza con quella che era una filiazione riconosciuta dagli stessi filosofi popolari, un paragrafo dedicato alla Filosofia popolare ciceroniana (ivi, III1, pp. 206 e ss.) all’interno della sezione
dedicata al Rinascimento. L’atteggiamento filosofico ciceroniano, analizzato già nell’Introduzione in rapporto alla filosofia in senso proprio (cfr. ivi I, pp. 107 e ss.) sintetizza per Hegel gli
aspetti essenziali della filosofia popolare anche nell’ambito del movimento filosofico scozzese.
I testi di questi pensatori “sono scritti alla guisa appunto di Cicerone allorché questi vien fuori
col suo insitum est a natura. Questo sentimento morale, e inoltre il buon senso umano, per
tutta una schiera di Scozzesi, come Thomas Reid, Beattie, Oswald sono elevati generalmente
a principi: costoro in questo modo hanno fatto acute osservazioni, ma non c’è traccia in loro
di filosofia”.
49
“Nella filosofia popolare la sorgente è costituita dal cuore, dall’istinto, dalla inclinazione, dal nostro essere naturale, dal nostro senso del giusto e di Dio: il contenuto si mostra
in forma semplicemente naturale”, Ivi, I, p. 108. “La filosofia popolare è la voce della nostra
comune coscienza e la considera come estrema misura”, Ivi, III, p. 214.
Hegel a Stoccarda: l’incontro con la cultura dell’Aufklärung
181
una troppo spinta volontà di semplificazione, ha contribuito a determinarne
l’influenza sulla cultura tedesca dell’epoca.
Senza voler attribuire un valore eccessivo al ruolo che questo movimento ha
avuto nella formazione filosofica hegeliana che pure, nei primi anni del ginnasio, trova nei filosofi popolari uno dei suoi principali punti di riferimento50, ci
sembra opportuna un’osservazione di carattere generale. Come, lo stesso Hegel
affermerà nel 1801, la sua formazione scientifica “è partita dai bisogni più subordinati degli uomini”51, dalle questioni legate al rinnovamento culturale, sociale e politico del suo tempo. Più che l’interesse per astratte dispute dottrinali
è stata la riflessione su problemi pratici e concreti del mondo storico, passato
e contemporaneo, a costituire l’orizzonte entro il quale i motivi principali della
sua speculazione hanno iniziato a prendere forma52. In questo senso la centralità accordata dalla Populärphilosophie al mondano e a tutto ciò che riguarda
l’individuo, unita alla volontà di far agire concretamente il sapere filosofico nella vita degli uomini per migliorarne le condizioni, appare in grande sintonia
con lo spirito che anima le prime ricerche hegeliane. Ma è soprattutto la natura
spiccatamente antropologica e psicologica degli studi condotti da alcuni dei
filosofi popolari più frequentati da Hegel ad andare particolarmente incontro
alla sua sensibilità53 finendo per influenzare anche l’impostazione delle sue prime autonome riflessioni che, come ha osservato Lukács, presenteranno un “carattere fortemente antropologico e psicologico”54.
50
Cfr. W. JAESCKHE, Hegels-Handbuch, Metzler Verlag, Stuttgart-Weimer 2003, pp. 1 e
ss.
51
G.W.F. HEGEL, Briefe von und an Hegel, hrsg. v. J. Hoffmeister u. F. Nicolin, Bde. I-IV,
Meiner, Hamburg 1952-1960, trad it. a cura di P. Manganaro in Epistolario, 2 voll., Guida,
Napoli 1984, I, p. 156.
52
Lo ha evidenziato molto bene Haering che ha sottolineato l’ancoraggio degli interessi
giovanili di Hegel alle concretezza delle questioni, storiche, sociali e morali definendolo, in
questo senso, un Empiriker (cfr. T. HAERING, Hegel. Sein Wollen und Werk, cit., p. 4).
53
Questa sensibilità lo spingeva, secondo la testimonianza di Rosenkranz, ad occuparsi anche di fisiognomica. Proprio Rosenkranz ci informa dell’esistenza di una sezione degli
estratti hegeliani “abbastanza ricca” dal titolo “esperienze di fisiognomica” di cui però non è
riportata la datazione. Il materiale per tali estratti sarebbe stato fornito da alcune opere molto
in voga all’epoca: “Sulla solitudine dello Zimmermann, le Lettere sulla Svizzera del Meiners, i
Trattenimenti cosmologici del Wünsch, le Confessioni di Rousseau e i Viaggi in Germania del
Nicolai. Da questi ultimi è estratta in particolare l’intera caratterizzazione delle fisionomie delle diverse stirpi tedesche, dalla bavarese, della brandeburghese, della tirolese, della viennese,
ecc.”, cfr. K. ROSENKRANZ, Vita di Hegel, cit., pp. 35 e ss. Tra le letture hegeliane riconducibili a tale interesse c’è da ricordare anche quella del Sophiens Reise von Memel nach Sachsen
(1770-1772), in cui abbondavano le descrizioni fisiognomiche.
54
G. LUKÁCS, Il giovane Hegel e i problemi della società capitalistica, cit., p. 63.
182
Mariafilomena Anzalone
2. Hegel e Feder
Tra i primi documenti redatti da Hegel a Stoccarda ci è giunto un lungo
estratto del 1785, intitolato Philosophie. Pädagogik55, la cui fonte è uno scritto
di Feder, Der Neue Emil oder von der Erziehung nach bewährten Grundsätzen
pubblicato circa dieci anni prima56. Come abbiamo già accennato, Hegel ebbe
modo di incontrare le opere di questo filosofo del tardo illuminismo tedesco già
nell’ambito dei suoi studi scolastici, leggendo, nel primo biennio del ginnasio
le sue Institutiones57. Esponente tra i più vivaci della Populärphilosophie, Feder
si caratterizzò per un certo eclettismo58 e, soprattutto, per il palese proposito
divulgativo che animò le sue opere le quali, all’epoca, ebbero larga diffusione59. La sua fama resta legata, però, più che alla sua produzione filosofica, al
rapporto travagliato con Kant60, di cui non colse affatto il valore filosofico, giudicando negativamente e in maniera sprezzante la Critica della ragion pura61.
Cfr. FrE, pp. 6-62.
J.G.H. FEDER, Der Neue Emil oder von der Erziehung nach bewährten Grundsätzen, Erlangen 1774 e 1775 (2 Bde.). Le parti del testo sintetizzate da Hegel sono riportate nell’edizione
critica al di sotto del testo hegeliano, cfr. FrE, pp. 6-62. Al testo di Feder è riconducibile anche
l’estratto n°20 dal titolo Philosophie. Psychologie (cfr. FrE, p. 168) che però sembra più uno
stralcio dell’opera di cui vengono riportati solo i titoli del quinto e del sesto capitolo.
57
J.G.H. FEDER, Institutiones Logices et Mataphyseos, 1777. In proposito cfr. C. LACORTE, Il primo Hegel, cit., p. 68.
58
L’eclettismo fu in realtà uno dei caratteri peculiari del movimento della Populärphilosophie che si contraddistinse per la varietà dei territori di indagine praticati, per il contatto con
la cultura inglese ma anche con quella francese, e per l’apertura agli influssi più vivaci. Quella
di filosofi eclettici fu, in alcuni casi una vera e propria auto-definizione che molti intellettuali
dell’epoca non esitarono ad adottare definendo anche il proprio secolo come “Eclectico-Reformatum” (cfr. J. F. FABRICUS, Abriss einer allgemeinen Historie der Gelehrsamkeit, Leipzig 1754,
III, Hildesheim u. New York 1988, p. 650) e sostenendo che il vero illuminismo fosse eclettico
(cfr. J. W. RECHE, Etwas über den Genius unser Zeitalters in Vermischte Papiere. Zur Beförderung wahrer Aufklärung und Menschlichkeit, Teil I, Düsseldorf 1790, p. 188 e ss.). L’eclettismo,
privato di ogni connotazione negativa, veniva così ad indicare l’ideale di un pensatore libero
e autonomo distinto da un “filosofo di scuola” (sectarius). E, in effetti, tale movimento trovò
nelle accademie, come ad esempio quella di Berlino, più che nelle università il luogo deputato
all’elaborazione del sapere. Sul ruolo dell’eclettismo nell’illuminismo tedesco e in particolare
nei filosofi popolari, cfr. H. HOLZHEY, Der Philosoph für die Welt - eine Chimäre der deutschen
Aufklärung? in H. HOLZHEY-W. Ch. ZIMMERLI (hrsg. v.), Esoterik und Exoterik der Philosophie. Beiträge zu Geschichte und Sinn philosophischer Selbstbestimmung, Basel u. Stuttgart
1977, pp. 131 e ss.
59
A testimoniarlo, oltre alle numerose ristampe dei suoi scritti, è anche la presenza di
Feder in uno degli Handwörterbuch più diffusi all’epoca: cfr. W. T. KRUG, Allgemeines Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften, Leipzig 1827-28, 4 Bde. 5. Bd. 1829-34; 2.
Auflage 1832-1838, Bd. 2, p. 17.
60
Cfr. R. BRANDT, Feder und Kant, «Kant-Studien», 80, 1989, pp. 249-264.
61
è nota la vicenda della recensione negativa alla Critica della ragion pura apparsa sulla
«Philosophische Bibliothek» a nome di Garve, ma fortemente rimaneggiata prima della pubblicazione da Feder che, probabilmente, non aveva nemmeno letto l’opera. L’episodio raccontato da Kant nei Prolegomeni è riportato da C. ALTMAYER, Aufklärung als Populärphilosophie.
55
56
Hegel a Stoccarda: l’incontro con la cultura dell’Aufklärung
183
Professore di filosofia a Coburg e a Gottinga, Feder si impegnò in una battaglia
contro il dogmatismo, di cui risentì anche l’impostazione delle sue opere, volte
per lo più alla chiarificazione di alcuni concetti chiave per la filosofia. In Logik
und Metaphysik62 (1769) si interrogò sull’essenza della realtà attraverso la delucidazione di una serie di fondamentali concetti filosofici: sostanza, causalità,
possibilità, ecc. In particolare, nell’ambito della questione delle sostanze semplici, le monadi, Feder si occupò anche del rapporto tra spirito e corpo. Tale
rapporto era già stato oggetto di riflessione qualche anno prima nei Grundriss
der philosophischen Wissenschaften nebst der nötigen Geschichte zum Gebrauch
seiner Zuhörer63. In questo testo egli aveva affrontato questioni di natura antropologica e psicologica a partire da una precisa presa di posizione metodologica.
Contrapponendosi ai seguaci di Wolff, aveva sostenuto da un lato la necessità
di operare meno considerazioni di natura metafisica quando ci si volgeva allo
studio dell’uomo; dall’altro aveva sottolineato la necessità di indagare la storia
per osservare i comportamenti degli uomini attraverso i secoli, secondo un’impostazione che, a suo avviso, si poteva già trovare in alcuni filosofi antichi.
In Logik und Metaphysik il tema del rapporto corpo-anima viene ripreso:
Feder considera insufficienti tanto quelle posizioni che si limitano ad affermare che l’uomo è una sostanza pensante in un corpo organico, quanto quelle
che si limitano ad una mera descrizione fisica dell’uomo. Piuttosto egli ritiene
utile e necessario considerare corpo e anima “come parti diverse dell’uomo”64.
In questo modo, pur non superando il punto di vista del dualismo metafisico,
Feder sottolinea che la connessione tra corpo e anima è un dato di fatto, o meglio una cosa “der täglichen Erfahrung”65. Agli studiosi non rimane, quindi,
che comprendere dove e in che modo ha luogo tale connessione. La risposta
a questa domanda rappresenta, secondo Feder, uno dei “punti più complessi
della psicologia”66, punto che egli, però, non risolve affatto, accontentandosi di
presentare le possibili alternative.
In campo morale Feder si contrappose all’etica del moral sense. I sentimenti morali, infatti, sono fortemente influenzati dalla tradizione, dall’educazione
e quindi dipendono dalle circostanze. Di conseguenza non è possibile fonda-
Bürgerliches Individuum und Öffentlichkeit bei Christian Garve, Röhrig, St. Ingbert, 1992, pp.
22 e ss.
62
J.G.H. FEDER, Logik und Metaphysik, Göttingen 1769 (1778; 1790).
63
J.G.H. FEDER, Grundriss der philosophischen Wissenschaften nebst der nötigen Geschichte zum Gebrauch seiner Zuhörer, Coburg 1767.
64
J.G.H. FEDER, Logik und Metaphysik, cit., p. 26.
65
Ibidem.
66
Ivi, p. 27.
184
Mariafilomena Anzalone
re l’etica su di essi; piuttosto vanno accolte le tesi razionaliste che, in ultima
analisi, affidano alla ragione il compito di decidere ciò che è giusto e ciò che
non lo è. Nel Lehrbuch der Praktischen Philosophie67 Feder sviluppò le linee di
una allgemeine praktische Philosophie capace di fungere da fondamento tanto
dell’etica che della dottrina del diritto naturale. Tale filosofia pratica conteneva
all’interno la dottrina del volere del bene e della legge naturale68. Proprio alla
dottrina del volere Feder dedicò ulteriori approfondimenti nelle Grundlehren
zur Kenntnis des menschlichen Willens del 1793, testo che ebbe un buon successo e fu adottato anche nel Ginnasio di Stoccarda quando però ormai Hegel era
a Tubinga.
L’opera recensita da Hegel, il Nuovo Emilio è, invece, uno scritto di carattere
pedagogico che ebbe un discreto successo. Pubblicato nel 1768, fu ristampato più
volte, non senza rimaneggiamenti69. Hegel stesso, probabilmente, ne ebbe a disposizione due diverse edizioni, quelle del 1774 e del 1775, in base alle quali è condotto
l’estratto che, sebbene egli abbia letto tutta l’opera, riguarda solo alcune parti.
Il testo di Feder si presenta al lettore come una riflessione sull’educazione dell’uomo, dall’adolescenza alla maturità, secondo il modello presentato da
Rousseau nel suo Emile. Attraverso la sua lettura Hegel entra in contatto, anche
se indirettamente70, con un pensatore che già a partire dagli anni di Tubinga sarà
decisivo nella sua formazione e costituirà un punto di riferimento costante71.
L’articolazione generale del Nuovo Emilio, così come è presentata da Hegel
nell’estratto, non è del tutto corrispondente all’originale, che è strutturato in
due libri. Hegel, invece, suddivide il primo libro in due parti, contenenti ciascuna otto capitoli; il secondo libro, a sua volta, viene indicato col titolo “Drittes
Buch” e contiene nove capitoli con una numerazione diversa rispetto all’originale. Da notare, in particolare, che i primi quattro capitoli sono riassunti molto brevemente da Hegel in una “Summarische Vorstellung des Inhaltes und der
vornehmsten Grundsätze des neue Emils”72. L’estratto diviene più discorsivo a
J.G.H. FEDER, Lehrbuch der Praktischen Philosophie, Leipzig 1770.
Ivi, p. 3 e ss.
69
La prima edizione, nelle intenzioni di Feder, doveva ispirarsi pienamente all’opera di
Rousseau distanziandosene, però, per quanto concerneva la valutazione del ruolo della religione nell’educazione. In seguito, nell’ultima edizione, del 1789, viene meno anche questo unico
elemento di differenza da Rousseau.
70
Rosenkranz, in verità, testimonia l’esistenza di alcuni estratti hegeliani delle Confessioni
di Rousseau che potrebbero risalire già a Stoccarda, cfr. K. ROSENKRANZ, Vita di Hegel, cit.,
p. 35.
71
Cfr. M. DE ANGELIS, Die Rolle des Einflusses von J.J. Rousseau auf die Herausbildung
von Hegels Jugendideal, Peter Lang, Frankfurt am Main 1995.
72
In questi brevi paragrafi che sintetizzano il contenuto dei primi capitoli dell’opera di
Feder, Hegel privilegia una serie di aspetti, trai quali la dimostrazione operata da Feder del
67
68
Hegel a Stoccarda: l’incontro con la cultura dell’Aufklärung
185
partire dall’analisi del quinto capitolo del testo in cui Feder affronta il problema
dell’origine delle differenti capacità di conoscenza presenti negli uomini. Hegel
riporta la questione principale attorno a cui ruota la riflessione di Feder: la causa originaria delle differenti capacità umane va ricercata nel corpo, nello spirito
o in entrambi?73. Certamente i fattori fisici hanno la loro importanza e ciò, secondo Feder, può essere facilmente dimostrato attraverso una storia universale
dell’intelletto umano che osservi come le condizioni climatiche abbiano influito
e influiscano sulle prestazioni intellettuali. Ma nel novero dei fattori fisici vanno
prese in considerazione anche le doti che naturalmente gli uomini possiedono;
a parità di dotazioni fisiche gli individui si differenziano, però, notevolmente
per il modo in cui esercitano e utilizzano queste forze naturali.
Secondo Feder, che Hegel riporta fedelmente in questo punto, “auf Lust und
Neigung kommt das Meiste an”74. I capitoli successivi sono dedicati, di conseguenza, all’analisi delle inclinazioni, degli impulsi e delle passioni dell’uomo.
Era questo un argomento che attirava particolarmente l’attenzione di Hegel che
nel suo Diario andava annotando una serie di riflessioni sulle passioni nocive
per la vita degli uomini75. Feder dedica il sesto capitolo proprio al fondamento
delle inclinazioni e in particolare di quelle che determinano il comportamento
giusto o cattivo, sottolineando che termini come Begierde, Neigung, Trieb vengono spesso usati indifferentemente, ma, in ambito filosofico, essi vanno distinti
e adoperati in maniera appropriata. Hegel sintetizza e schematizza le definizioni date da Feder e si sofferma in particolare sulla configurazione dell’impulso
(Trieb). L’impulso viene definito da Feder “die Richtung der tätigen Kraft etwas
gewisses zu bewirken”76. Ci sono impulsi meccanici che risiedono solo nel corpo, impulsi spirituali che riguardano, invece, “den Richtungen der geistigen
kräfte“ (Hegel li definisce Triebeskräfte) e gli impulsi ciechi, che vengono eccitati da rappresentazioni oscure. Si possono, poi, avere impulsi intellettuali o
razionali: i primi dipendono da rappresentazioni dell’intelletto, i secondi invece
dalla riflessione e da una conoscenza chiara.
Ma quali sono gli impulsi principali dell’uomo? Innanzitutto quello a seguire il piacere e ad allontanare il male. Ma poi c’è anche l’impulso alla simpatia
verso gli altri, quello alla benevolenza, ecc. Tutti questi costituiscono, secondo
un’espressione che è presente in Hegel ma non in Feder, dei “Grundtriebe des
fatto che la religione può essere insegnata già ai bambini di quattro anni e la necessità di un insegnamento che avvenga senza costrizione, in cui anche il gioco svolge un ruolo importante.
73
FrE, p. 11.
74
FrE, p. 16.
75
Cfr. le annotazioni del 22 agosto e del 22 dicembre 1785 in Sg, p. 46 e 51.
76
FrE, p. 17.
186
Mariafilomena Anzalone
Willens” e possono essere sintetizzati sotto il nome di amor proprio (Selbstliebe). Feder analizza anche tutti quegli impulsi che caratterizzano il comportamento umano nelle relazioni intersoggettive (l’impulso all’operosità, quello
all’imitazione, quello a seguire i propri doveri, ecc.) dedicando una particolare
attenzione all’impulso sociale, perchè secondo Feder, Dio stesso ha destinato
l’uomo a vivere in società e solo nel contesto sociale egli può sviluppare le sue
facoltà naturali. Di tutti questi Triebe Hegel riassume la presunta origine e il
ruolo che svolgono nello sviluppo dell’uomo passando poi alla considerazione
degli impulsi propri del vivere sociale e, di lì, alla questione del male. Feder, invece, compie un passaggio intermedio, spiegando che la trattazione della natura umana svolta finora è in qualche modo unilaterale: essa ha preso in considerazione solo gli aspetti positivi della natura, quegli impulsi, quelle inclinazioni
che agiscono positivamente nell’ambito dello sviluppo dell’individuo. Ma nella
vita dell’uomo c’è anche il male ed è doveroso chiedersi se anche esso derivi o
meno dalla natura. Su questo punto Feder, in piena consonanza con le teorie
russoviane, afferma di non aver ancora scoperto nell’uomo degli impulsi fondamentali diretti al male. L’uomo fa del male solo per sua responsabilità e i suoi
errori non sono dovuti nemmeno ad un intelletto che per sua natura è in qualche modo destinato a sbagliare.
Se nell’uomo non ci sono impulsi fondamentali rivolti al male, si potrebbe,
tuttavia ipotizzare che comunque sia presente in lui una tendenza ad una sorta
di compiacimento rispetto all’infelicità altrui, compiacimento che affonderebbe le sue radici già nell’infanzia, quando i fanciulli si divertono a distruggere o
a sottrarre i giochi degli altri, o ad infrangere i divieti degli adulti. Ma secondo
Feder una tale ipotesi non è sostenibile: quella dei fanciulli è solo voglia di affermare e impiegare le proprie forze, priva di colpa da un punto di vista morale.
Non sì può vedere, quindi, in questi comportamenti la traccia di una qualche riprovevole inclinazione alla misantropia. Si può solo affermare che l’uomo ama
in maniera originaria più se stesso che gli altri77.
Ma quale deve essere il ruolo e il compito dell’educazione rispetto alle inclinazioni naturali presenti nell’uomo, rispetto ai Grundtriebe des Willens? Poiché
secondo Feder le inclinazioni si fondano sulla rappresentazione di qualcosa di
piacevole o che ci procura felicità e, a loro volta, le rappresentazioni si destano
in noi a partire dai sensi, le nostre inclinazioni possono essere continuamente
migliorate. Infatti si può sempre agire sulle rappresentazioni attraverso l’edu77
Feder svolge poi una serie di annotazioni su questo tema che Hegel definisce “pratiche”:
esse riguardano il sentimento della simpatia e il modo in cui esso può essere coltivato nei
fanciulli, l’impulso al piacere, ecc.).
Hegel a Stoccarda: l’incontro con la cultura dell’Aufklärung
187
cazione che distoglie da alcuni oggetti mostrando che la felicità e il piacere non
sono da ricercare in essi. Di conseguenza, determinate inclinazioni possono
essere accantonate con gli anni e altre sviluppate. L’importante, afferma Feder,
ripreso fedelmente da Hegel è fondare gute Triebe già nei bambini, in modo che
essi possano accrescere al meglio le loro facoltà.
Questa idea dei gute Triebe, che agiva anche in un altro autore studiato in
quegli anni da Hegel, Mendelssohn78, mostra esemplarmente come anche l’opera
di Feder si ponga nel solco di un’antropologia illuminista, in questo caso di ispirazione russoviana, fiduciosa nella possibilità che l’uomo, per sua stessa natura,
abbia un’esistenza felice e illuminata. Attraverso questa lettura giovanile, Hegel
ha modo di confrontarsi con un’immagine della soggettività in cui la dimensione
naturale, sensibile, non è un ostacolo da rimuovere o un fattore da reprimere, ma
anzi il luogo dal quale partire per educare e formare l’individuo. Proprio la rilevanza attribuita alla dimensione naturale spinge Feder, in conclusione del testo,
ad affrontare il rapporto tra la religione naturale, in cui tutte le tendenze positive
della natura si presentano sotto forma di una voce divina, e il cristianesimo, e a
chiedersi quale ruolo debba avere la religione nell’educazione di Emilio. Si presenta così, in chiusura di questo estratto, uno dei temi che, negli anni successivi,
conquisteranno maggiormente l’attenzione hegeliana, quello del rapporto tra religione naturale e cristianesimo. Hegel riassume i punti chiave della riflessione di
Feder sottolineando quello che per l’esponente della Populärphilosophie è il merito principale del cristianesimo, innanzitutto da un punto di vista educativo: la
religione cristiana “comprende tutte le parti della religione naturale, ma con una
certezza e una precisione che va al di là della ragione”79; essa non si contrappone
quindi alla religione naturale ma anzi ne costituisce un perfezionamento.
3. Hegel e Campe
L’anno dopo l’estratto sul Nuovo Emilio di Feder Hegel ne redige un altro
avente per oggetto problematiche di carattere pedagogico e psicologico, la cui
fonte è costituita dalla Kleine Seelenlehre für Kinder (1784) di Joachim Henrich
Campe (1746-1818). L’autore, studioso di teologia e filosofia, si era particolar-
78
M. MENDELSSOHN, Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele, in ID., Gesammelte Schriften. Jubiläumausgabe (1929-1938), hrsg. v. A. Altmann, Fromman-Holzboog, Stuttgart Bad Cannstatt 1974, Bd. III.1, pp. 5-128. Hegel stesso annota nel suo Diario la lettura di
quest’opera, cfr. Sg, p. 37.
79
FrE, p. 16.
188
Mariafilomena Anzalone
mente dedicato nei suoi lavori alle questioni educative80 aderendo ad una delle
correnti pedagogiche più influenti dell’illuminismo tedesco: il filantropismo basedowiano. Tale indirizzo pedagogico si ispirava all’opera di Johann Bernhard
Basedow (1724-1790), professore di filosofia e autore della Vorstellung an Menschenfreunde und vermögende Männer über Schulen (1768). La notorietà procuratagli da questo testo indusse il principe di Anhalt a chiamarlo a Dessau dove
egli ebbe modo di mettere in pratica le sue teorie educative fondando nel 1774
un istituto scolastico chiamato Philantropium, per alcuni anni centro di grande
importanza nel campo dell’educazione.
La pedagogia basedowiana, riproponendo motivi della filosofia russoviana,
lockiana e del pietismo, si poneva, sostanzialmente, l’obiettivo di verificare sul
campo dell’educazione le idee dell’illuminismo tedesco. La sua principale finalità educativa, di carattere eminentemente pratico, era quella di formare i giovani
per l’esercizio delle professioni borghesi; di conseguenza l’istruzione loro impartita doveva essere sostenuta dal supporto dell’esperienza e orientata praticamente. Dal punto di vista della concreta organizzazione dei programmi scolastici
questo significava privilegiare la conoscenza di discipline come la matematica
o le scienze naturali, e di mettere da parte le lingue morte, come ad esempio il
greco. Tali obiettivi andavano perseguiti con l’ausilio di una metodologia caratterizzata da un lato dalla piacevolezza dell’insegnamento, dall’altro dall’idea che
in ogni processo educativo fosse necessario partire dall’intuizione dell’allievo e,
quindi, dalle sue immediate esperienze percettive sollecitandolo, mediante una
sorta di dialogo socratico, a ricavare da sé risultati e soluzioni. Tale metodologia,
promossa dai filantropi, e condivisa dai maggiori pedagogisti del tempo è alla
base dell’opera di Campe, il quale come rileva Rohbeck “sostenne che l’educatore deve risvegliare rispettivamente la propria forza intellettuale e la capacità di
comprensione dei bambini, e stimolarli al pensiero autonomo. Egli procedette
in questo modo, esemplarmente, nella «Piccola psicologia per ragazzi» (…), in
cui si comincia con racconti ed illustrazioni, e in cui i ragazzi vengono sollecitati
con l’aiuto di dialoghi a trarre conclusioni autonomamente”81.
Il testo, organizzato da Campe come un dialogo tra un padre e un figlio, viene riassunto da Hegel in forma discorsiva: egli tralascia sia gli ultimi dialoghi,
che hanno come tema l’immortalità, sia le parti in cui Campe descrive tutto il
80
Tra le sue opere principali ricordiamo: Die Erfindungs- und Erkenntniskraft der menschlichen Seele (1776); Sittenbüchlein für Kinder aus gesitteten Ständen (1777); Neue Methode, Kinder auf eine leichte und angenehme Weise lesen zu lehren (1778); Über Empfindsamkeit und
Empfindelei in pädagogischer Hinsicht (1779).
81
J. ROHBECK, La didattica della filosofia in Hegel, trad. it. a cura di U. Damiani, in «Comunicazione filosofica. Rivista telematica di Ricerca didattica», n° 2, novembre 1997, p. 3.
Hegel a Stoccarda: l’incontro con la cultura dell’Aufklärung
189
percorso mediante il quale il bambino, discutendo con il padre giunge, di volta
in volta, ad una nuova conoscenza. Prendendo in considerazione solo i risultati
del dialogo educativo esposto da Campe, Hegel li trascrive, poi, sotto forma di
definizioni che riportano, così, in una forma originale, le idee fondamentali del
libro. La scelta hegeliana di omettere le fasi del processo di apprendimento per
esporne solo i risultati effettivi se da un lato riassume e schematizza l’opera in
una breve sequenza di tesi di agile consultazione, dall’altro ne mette un pò in
secondo piano l’aspetto pedagogico, per evidenziare, invece il piano dell’analisi
psicologica che sostiene e indirizza l’intervento educativo teorizzato da Campe.
Per illustrare la sua metodologia pedagogica, infatti, Campe si serve proprio
della psicologia che, intesa secondo i canoni dell’epoca come Seelenlehre, in
quest’opera diviene, ha osservato ancora Rohbeck: “oggetto di insegnamento
didattico e, al tempo stesso, principio metodico dell’istruzione”82.
L’estratto hegeliano si apre, in effetti, proprio con una definizione dell’anima, che è considerata come un’essenza semplice, cosciente di se stessa e capace, mediante l’ausilio dei sensi, di rappresentarsi qualcosa. La facoltà dell’anima che consente di avere rappresentazioni chiare, in cui, cioè, non solo distinguiamo una cosa dalle altre ma siamo in grado di indicarne le caratteristiche
è l’intelletto (Verstand). Nel momento in cui l’anima è in grado anche di riconoscere con chiarezza le cause e gli effetti essa possiede la ragione (Vernunft).
Una volta sintetizzate le riflessioni di Campe sulla facoltà del giudizio, sull’attenzione, ecc., Hegel si sofferma sulla differenza tra memoria, immaginazione
e sensazione. La sensazione, definita come la rappresentazione di qualcosa che
procura piacere o dispiacere, può essere richiamata dinanzi all’anima, la quale
ne ha, quindi, memoria. Ma nel caso in cui l’anima possieda una forte capacità
di immaginazione quest’ultima le può far dimenticare di aver già avuto quella
sensazione persuadendola del contrario. In questo caso, ciò che la sensazione
suscita nell’anima non è più qualcosa di oggettivo.
L’anima, per Campe, possiede anche la volontà libera di cui egli dà una definizione che potremmo definire utilitaristico-strumentale. La volontà è vista, infatti,
come la capacità di riflettere prima di agire, e di considerare, in tal modo, se la
cosa da fare è utile o dannosa. A differenza dell’istinto, in cui si sente il desiderio
di agire senza sapere il perché, la volontà presuppone sempre una valutazione
razionale. L’estratto, che si conclude con un elenco degli istinti e dei sentimenti
che caratterizzano l’uomo, appare, così, più una rapida disamina delle facoltà
82
Ibidem.
190
Mariafilomena Anzalone
dell’anima che una sintesi delle riflessioni pedagogiche di Campe, le quali restano
un pò sullo sfondo proprio per il modo in cui Hegel ha deciso di esporre l’opera.
La duplicità dei piani, psicologico e pedagogico, investiti dal contenuto di questo estratto, spiega l’indecisione dei diversi editori rispetto alla sua collocazione e
catalogazione. Nell’ordinamento degli estratti di cui parla Rosenkranz nella Hegel’s
Leben questo testo viene considerato parte di quella serie di documenti che Hegel avrebbe raccolto nella sezione dedicata alla fisiognomica e alla psicologia83. Il
Thaulow, invece, lo inserisce nell’ambito degli scritti dedicati alla pedagogia, sotto
la parola chiave “anima”84, sostenendo, però, che Hegel avesse raccolto gli estratti
di psicologia e quelli di pedagogia in un unico faldone. Ma, al di là dei problemi di
catalogazione, si può osservare che la rilevanza dell’incontro hegeliano con le teorie
di Campe85 si misura effettivamente, sia rispetto alla pedagogia che alla psicologia e
non solo a Stoccarda, dove Hegel si interessa tanto alla comprensione delle caratteristiche dell’uomo quanto alla possibilità di un loro perfezionamento tramite l’azione educativa. Se gettiamo un rapido sguardo sui riferimenti a questo autore presenti
nelle opere della maturità possiamo notare che Hegel ricorre spesso a Campe come
esponente esemplare della psicologia e della pedagogia in voga alla sua epoca.
Per quanto concerne la pedagogia, il riferimento a Campe è presente soprattutto nel periodo norimberghese, quando questa disciplina diviene un esplicito oggetto di riflessione dato che Hegel si trova ad essere non solo insegnante e rettore
del ginnasio, ma riveste anche il ruolo di “Stadt-schulrat”86. Impegnato tanto sul
piano della didattica87 che dell’amministrazione scolastica88, egli esprime in varie
Cfr. K. ROSENKRANZ, Vita di Hegel, cit., p. 35.
Cfr. G. THAULOW, Hegel’s Ansichten über Erziehung und Unterricht, cit., pp. 81-84. Anche nell’edizione critica dalla Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften si è scelto di mantenere l’indicazione “Seele” proprio per sottolineare la centralità che all’interno del
testo ha l’indagine sulle facoltà dell’anima.
85
Hegel possedeva, e probabilmente ha letto, anche il Väterlicher Rat für meine Tochter.
Ein Gegenstück zum Theophron (1789). Ce ne dà notizia lui stesso in un’annotazione sul Tagebuch dell’11 dicembre 1785. Cfr. Sg, p. 48.
86
Lo Stadt-schulrat (o Lokal-Schulrat) era il consigliere scolastico locale, impiegato cioè
“nell’amministrazione cittadina (allora non esisteva un’amministrazione comunale autonoma)
in rapporto con il regio commissario della città di Norimberga. (…)”, K. GOLDMANN, Hegel
als Referent für das Nürnberger Lehrerseminar und Volksschulwesen 1813-1816, «Zeitschrift für
philosophische Forschung» 11, 1957, pp. 387-94.
87
Come testimonia Rosenkranz “Hegel insegnava filosofia e religione in tutte le classi del
ginnasio” (Vita di Hegel, cit., p. 266). All’impegno che comportavano le numerose ore di lezione,
si aggiungeva, poi quello di organizzare la didattica di tutto l’istituto ginnasiale che comprendeva la Primärschule, il Progymnasium e il Gymnasium vero e proprio. La difficoltà hegeliana
di conciliare gli incarichi didattici con la grande mole di impegni di natura amministrativa è
testimoniata nel suo epistolario (cfr. Ep II, p. 64). Per una ricostruzione dei corsi tenuti da Hegel presso il ginnasio di Norimberga, cfr. P. GIUSPOLI, Introduzione a G.W.F. HEGEL, Logica
e sistema delle scienze particolari (1810-1811), Verifiche, Trento 2001, pp. 50 e ss.
88
Sull’attività svolta da Hegel come rettore del ginnasio di Norimberga e come consi83
84
Hegel a Stoccarda: l’incontro con la cultura dell’Aufklärung
191
occasioni il suo dissenso rispetto alle “grida della moderna pedagogia (…) che indirizza lo sguardo al bisogno immediato, proclamando che come per il conoscere
è l’esperienza il primo, così per le attitudini e l’abilità nella vita pubblica e privata il
considerare le cose teoricamente riesce addirittura dannoso, dovechè nell’esercizio
e nell’educazione pratica sta l’essenziale, quello che unicamente profitta”89. Il rifiuto della stringente prospettiva utilitaristica propria del filantropismo basedowiano
risponde innanzitutto all’esigenza hegeliana di mostrare, come rileva Sichirollo,
che il fatto e il problema educativi sono “più ampi di ciò che solitamente va sotto
il nome di pedagogia e di didattica”90. Essi investono l’uomo nella sua essenza di
soggetto libero, di individuo che si autodetermina, che è per sé, ma che, allo stesso
tempo, deve sempre e comunque educarsi all’universalità, se vuole compiutamente
appartenere alla comunità umana. Hegel stesso, del resto, si definirà acutamente
un philosophischer Pädagog91 che guarda alla pedagogia nel contesto più ampio e
profondo di una Bildung universale che è quella dello spirito stesso.
La polemica con i filantropi può anche essere letta in relazione all’amicizia e
alla collaborazione di Hegel con Friedrich Niethammer. In qualità di consigliere superiore agli studi del regno di Baviera, Niethammer si era fatto promotore
di un progetto di riforma scolastica92 teso ad affermare i principi di un nuovo
umanesimo educativo93 in alternativa, seppur non totale, alle posizioni dei filantropi. Hegel ne condivise molti punti, come ad esempio la difesa dell’inse-
gliere scolastico provinciale, attività “di gran lunga più importante di quanto hanno creduto
editori e storici accreditati” (L. SICHIROLLO, Sulla pedagogia di Hegel, in G.W.F. HEGEL,
La scuola e l’educazione. Discorsi e relazioni (Norimberga 1808-1816), a cura di L. Sichirollo,
Franco Angeli, Milano 1985, p. 19) cfr. K. LANIG, Die pädagogischen Jahre Hegels in Nürnberg
in G.W.F. Hegel als Rektor des Nürnberger Gymnasiums (1808-1816). Festschrift zur Hegelfeier
des Melanchthon-Gymnasiums am 15. Oktober 1966, Nürnberg 1966, pp. 29-48.
89
G. W.F. HEGEL, Wissenschaft der Logik. Erster Band. Die Objektive Logik (1812-1813), hrsg.
v. F. Hogemann u. W. Jaeschke, in Gesammelte Werke, Bd. XII, Meiner, Hamburg 1978, trad. it. a
cura di A. Moni, rivista da C. Cesa in Scienza della logica, 3 vol., Laterza, Bari 1974, I, p. 6.
90
L. SICHIROLLO, «Ein philosophischer Pädagog», in Hegel e la tradizione. Scritti hegeliani, Guerini, Milano 2002, p. 55.
91
G.W.F. HEGEL, Nürnberger Gymnasialkurse und Gymnasialreden (1808-1816) in Gesammelte Werke, Bd. X, Meiner, Hamburg 2006, trad. it. a cura di G. Radetti in Propedeutica filosofica, La Nuova Italia, Firenze 1951 (d’ora in poi Pf) p. 247.
92
Le linee guida di tale progetto vennero esposte in uno scritto del 1808 Der Streit des
Philanthropismus und Humanismus in der Theorie des Erziehungsunterricht unserer Zeit (in
F. I. NIETHAMMER, Philantrophinismus-Humanismus. Texte zur Schulreform, hrsg. V. W.
Hillebrecht, Weinheim-Berlin- Basel 1968). Con quest’opera Niethammer si presentava come
eminente esponente dei cosiddetti “nuovi umanisti” senza porsi, però, in aperta contestazione
del filantropismo.
93
“Ad una formazione utilitaristica orientata verso la specializzazione professionale (…)
egli opponeva la formazione disinteressata alla maniera del classicismo antico, dell’uomo considerato come un tutto spirituale”, B. BOURGEOIS, La Pédagogie de Hegel, in G.W.F. HEGEL,
Textes pédagogiques, trad. par B. Bourgeois, Vrin, Paris 1990, p. 12.
192
Mariafilomena Anzalone
gnamento delle lingue antiche nel ginnasio; tuttavia non esitò, nella pratica didattica, a distaccarsi dal regolamento stabilito da Niethammer nel Normativ94.
In particolare, relativamente all’insegnamento della psicologia, egli rivendicò
la sua autonomia rispetto alle indicazioni del Normativ che rispecchiavano le
modalità consuete di insegnamento di questa disciplina. Appena insediatosi a
Norimberga scrisse a Niethammer: “Nella classe intermedia penso di insegnare
in un certo modo psicologia, ma più come teoria dello spirito che come teoria
dell’anima nella maniera usata fino ad ora, cioè storico-naturale, del tutto non
speculativa o comunque senza alcun concetto”95. Per cogliere a pieno l’obiettivo
del riferimento polemico di Hegel è forse utile richiamare la definizione wolffiana della psicologia come “historia animae”96 che, oltre a classificare ed elencare ciò che osserva dell’anima, sviluppa anche i concetti di facoltà e capacità97.
Come è noto la tradizione wolffiana e della sua scuola esercitò una influenza
straordinaria sulla cultura tedesca dell’epoca e in particolare in ambito antropologico e psicologico98. Essa non può dirsi certamente superata al tempo di
Hegel99 e le sue tracce possono essere rinvenute anche in Campe che, come ha
osservato Rohbeck, partiva proprio “dalla psicologia della capacità di Wolff e
dalla psicologia dell’esperienza di Locke”100.
Il giudizio hegeliano sull’opera di Campe e sulle tradizioni a cui essa in qualche modo era riconducibile viene espresso molto chiaramente nel Parere a Niethammer dove Hegel prende nettamente le distanze dalle elaborazioni psicologiche più in voga all’epoca esemplarmente rappresentate, secondo lui, proprio
94
Niethammer elaborò un nuovo piano di studi generali intitolato Allgemeines Normativ
der Einrichtung der öffentlichen Unterrichtsanstalten in dem Königreiche che avrebbe dovuto
riorganizzare l’insegnamento scolastico dalle scuole elementari fino agli istituti secondari (cfr.
Allgemeines Normativ der Einrichtung der öffentlichen Unterrichtsanstalten in dem Königreiche,
in Monumenta germaniae Paedagogica, Bd. XLII, Berlin 1908, pp. 561-584, ristampato in F. I.
NIETHAMMER, Philantrophinismus-Humanismus, cit. pp. 46-67).
95
Ep, vol. II, p. 50.
96
Ch. WOLFF, Philosophia rationalis sive logica, metodo scientifica pertractata et ad usum
scientiarum atque vitae aptata (1740), in Gesammelte Werke, a cura di J. école, Olms, Hildsheim
1965 e ss., sez. I, p. 51.
97
Ibidem.
98
Cfr. M. LINDEN, Untersuchungen zum Anthropologiebegriff des XVIII Jahrhunderts, Peter Lang, Frankfurt 1976, pp. 27 e ss.
99
Come ha osservato Siep, Hegel svilupperà nella sua psicologia molti degli spunti presenti in Wolff, come quello di “dedurre gradualmente le facoltà dell’anima (…)” e di mostrare
“la loro unità pienamente sviluppata nello spirito”, L. SIEP, La systématique de l’esprit pratique
chez Wolff, Kant, Fichte et Hegel, in AA. VV., «Trieb», tendance, instinct, pulsion, «Revue germanique internationale», 18/2002, p. 107. Su questo tema cfr. anche R. BONITO OLIVA, La «magia» dello spirito e il «gioco» del concetto. Considerazioni sulla filosofia dello spirito soggettivo
nell’Enciclopedia di Hegel, Guerini e Associati, Milano-Napoli 1995, pp. 48 e ss.
100
J. ROHBECK, La didattica della filosofia in Hegel, cit., p. 3.
Hegel a Stoccarda: l’incontro con la cultura dell’Aufklärung
193
dall’opera di Campe letta a Stoccarda: “la psicologia è troppo facile quando
debba esser presa, così trivialmente, quale psicologia affatto empirica, all’incirca come nella psicologia per ragazzi del Campe”101. Nel fare esplicito riferimento allo scritto di Campe Hegel vuole evidentemente mettere in discussione
l’approccio psicologico che costituiva il fondamento più o meno esplicito della sua pedagogia e, più in generale, del filantropismo basedowiano. In questo
modo, attraverso Campe, Hegel critica lo statuto epistemologico della psicologia dell’epoca prendendo le distanze sia dalla psicologia empirica che dalla psicologia razionale102 secondo le quali, come ha spiegato Rossella Bonito Oliva,
“la spiegazione dei meccanismi psichici o spettava a un lavoro di osservazione
scientifica, o, invece, era competenza di una specifica branca della metafisica
che sola era in grado di dare ragione di concetti, quali anima e sostanza, non
riducibili a mero fenomeno”103.
Da questo punto di vista, l’estratto dell’opera di Campe rappresenta una significativa testimonianza dell’interesse giovanile per l’analisi psicologica delle facoltà umane e consente anche di cogliere con più chiarezza le tradizioni
culturali con cui egli entra in contatto su questi temi. In Campe, così come nel
suo maestro Basedow, agisce, lo abbiamo accennato, da un lato la psicologia
empirica di stampo wolffiano e quindi l’idea di una descrizione delle modificazioni della coscienza umana; dall’altro la visione dell’uomo su cui si fonda la
pedagogia lockiana che, rifiutando l’innatismo, pone l’accento sul modo in cui
l’individuo acquisisce dall’esterno le varie nozioni. Proprio le tesi lockiane, accentuate ed estremizzate dalla lettura di Condillac, saranno oggetto, negli anni
della maturità, della critica di Hegel che, pur ritenendo legittima la considerazione dell’elemento sensibile come primario e originario, contesterà l’idea che
a partire dal sensibile tutte le determinazioni ulteriori dell’anima possano es-
Pf, p. 251.
Anche la distinzione tra psicologia empirica e razionale può essere ricondotta a Wolff.
Egli aveva definito la psicologia razionale come la scienza che studia l’anima in generale e le
sue facoltà da un punto di vista razionale, mediante il processo della derivatio a priori, per
tentare di chiarire i problemi rimasti irrisolti anche dopo il ricorso all’esperienza. La psicologia empirica, invece, si configurava come una vera e propria scienza empirica, che indaga
l’anima e le sue manifestazioni servendosi del metodo delle scienze basato sull’osservazione e
sulla sperimentazione. Cfr. Ch. WOLFF, Psychologia rationalis metodo scientifica pertractata,
qua ea, quae de anima humana indubia experientiae fide innotescunt, per essentiam et naturam
animae explicantur, et ad intimiorem naturae ejusque Autoris cognitionem profutura proponuntur (1734), in Gesammelte Werke, cit.; Ch. WOLFF, Psychologia empirica, metodo scientifica
pertractata, qua ea, quae de anima humana indubia experientiae fide constant, continetur et
ad solidam universae philosophiae practicae ac theologiae naturalis tractationem via sternitur
(1732), in Gesammelte Werke, cit., sez. II, vol. V, 1965 e ss.
103
R. BONITO OLIVA, La «magia» dello spirito e il «gioco» del concetto, cit., p. 48.
101
102
194
Mariafilomena Anzalone
sere derivate “solo in modo affermativo”, disconoscendo “il momento negativo
dell’attività dello spirito”104 e finendo per pensarlo come una sorta di magazzino
delle facoltà, come un “sacco”105 in cui possono stare insieme elementi eterogenei e irrelati.
Alla luce di queste considerazioni appare ancora più significativo l’incontro
del giovane Hegel con determinate tradizioni di pensiero a partire dalle quali,
nella constatazione dei loro limiti e del loro valore, egli svilupperà una posizione originale sostenendo, ad esempio, la necessità di una psicologia che abbia
per oggetto non più l’anima ma lo spirito “come spirito secondo le determinazioni della sua attività entro se stesso”106.
Sia l’estratto su Campe che quello su Feder si presentano, così, come importanti testimonianze non solo dell’interesse hegeliano per la comprensione
dell’uomo, delle sue capacità e facoltà ma anche del contesto storico-teorico a
partire dal quale l’interrogazione hegeliana sulle strutture della soggettività ha
ricavato le sue prime risposte. Risposte che, come abbiamo brevemente accennato, saranno ritenute insufficienti e parziali dallo Hegel della maturità ma che
continueranno a costituire lo sfondo culturale col quale egli si confronterà e rispetto al quale cercherà di elaborare una sua autonoma prospettiva di ricerca.
104
G.W.F. HEGEL, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830),
hrsg. v. W. Bonsiepen u. H.-C. Lucas, unter Mitarbeit v. U. Rameil, in Gesammelte Werke, Bd.
XX, Meiner, Hamburg 1992, trad. it. a cura di B. Croce in Enciclopedia delle scienze filosofiche
in compendio, Laterza, Roma-Bari 2002 (nuova ed. con aggiunta delle Prefazioni di Hegel trad.
da A. Nuzzo), § 442, p. 432.
105
Fen I, p. 253;
106
Pf, p. 213.
Investigazioni sulle costanti fondative dell’esistenzialismo positivo
195
Investigazioni sulle costanti fondative
dell’esistenzialismo positivo
Memoria di Silvio Paolini Merlo
presentata dal socio naz. ord. res. Giuseppe Cantillo
(seduta del 29 maggio 2008)
Abstract. On the basis of a terminological comparative reading carried out on Nicola
Abbagnano’s La struttura dell’esistenza, the most systematic work within italian “positive existentialism”, emerges that distinctive solution of this philosophical project it’s not
a derivation of Heidegger or European existentialism, but an application on some existential themes of John Dewey’s Logic and ethical-normative validity near to categorical
imperative in Kant’s ethics. The “existential structure” concept, neuralgic in Abbagnano’s
thinking, that is the existence’s realization movement between indetermination and determination of being, comes mainly from Dewey problem-solving logical process.
Riformulare il significato dell’essere, ridefinire il progetto per un uomo nuovo in quanto esistenza finita, cogliere e chiarire il suo principio costitutivo, i
suoi limiti, i suoi valori, la sua natura interna. Questo, in estrema sintesi, il senso della filosofia di Nicola Abbagnano così come emerge da una serie di analisi
condotte sui principali scritti teorici degli anni Trenta e Quaranta. Lo scopo è
stato sin dal principio quello di rintracciare una possibile chiave di lettura interpretativa che dia del lavoro teorico del filosofo, non sempre adeguatamente
considerato, un quadro complessivo internamente unitario.
Ancora prima che a esigenze di natura filologica, la lettura ha cercato perciò
di dare risposta a una domanda sostanziale: come sia stato possibile che nel
maggiore dei protagonisti dell’esistenzialismo italiano la filosofia dell’esistenza
non abbia costituito un inizio, un punto di partenza dal quale procedere verso
nuove prospettive, ma, al contrario, il punto di approdo di un lungo e articolato
lavoro di elaborazione teorica, in gran parte estraneo all’atteggiamento caratteristico dell’esistenzialismo “classico”, sfociante in una prospettiva chiara e
pressoché definitiva. La domanda deriva, in primo luogo, dall’imponderabilità
del pensiero esistenzialista europeo, incluso quello di Kierkegaard, nell’itinerario filosofico di Abbagnano precedente la stesura de La struttura dell’esisten-
196
Silvio Paolini Merlo
za1, stesura che deve aver avuto corso, date le abitudini di lavoro del filosofo,
in tempi relativamente brevi. Sembra necessario ammettere, malgrado le tarde dichiarazioni del filosofo e i pochi indizi contestuali, non solo indiretti ma
spesso equivoci, che non è possibile sostenere la tesi di un reale accostamento di Abbagnano al pensiero esistenzialista prima del periodo compreso fra
il 1936, anno di pubblicazione de Il Principio della metafisica, e l’autunno del
1939, quando Abbagnano licenzia la prima edizione della Struttura dell’esistenza, stampata alla fine del novembre dello stesso anno. Questo non solo perché
in nessuno tra i molti studi apparsi anteriormente alla Struttura si riscontrano
temi e questioni che possano ritenersi suggestioni o derivazioni più o meno
dirette di quella corrente culturale, ma anche dal momento che Abbagnano
non sembra occuparsi di nessuno di quei filosofi esistenzialisti, tedeschi quanto
francesi e russi, che tra il 1919 e il 1932 introducono nel dibattito europeo una
ripresa delle tematiche kierkegaardiane a fronte di una dissoluzione parallela
di idealismo e positivismo, come sarà invece naturale per altri studiosi italiani,
in primis per Enzo Paci e Luigi Pareyson. A complicare ulteriormente la ricerca genealogica dell’esistenzialismo positivo contribuisce, inoltre, il fatto che
nessuna tra le pubblicazioni di Abbagnano apparse in questo lasso di tempo,
saggi traduzioni e manuali didattici, fornisce segnali utili in questo senso. La
struttura dell’esistenza, a una lettura attenta, evidenzia invece una conoscenza
praticamente perfetta di Sein und Zeit di Martin Heidegger, autore in precedenza citato una sola volta a titolo meramente informativo in uno studio sulle
Meditazioni cartesiane di Husserl2, nonché di molti altri scritti fondamentali
dell’esistenzialismo jaspersiano e kierkegaardiano. L’intento è stato perciò quello di chiarire le ragioni interne, non solo logico-linguistiche ma anche storiche
e culturali, che hanno indotto il pensiero di Abbagnano ad aprirsi all’esistenzialismo in termini così tardivi e apparentemente imprevedibili. Fermi a un livello
di analisi puramente lessicale, si direbbe che La struttura, fatta eccezione per
le problematiche della “norma” e del “valore”, non sia altro che la traduzione
in lingua italiana di Sein und Zeit. Passando invece a una lettura di tipo logicoterministico, come si è tentato di fare, è emerso con una certa chiarezza che
quanto di più originale si trova nell’opera del 1939 non proviene tanto da Heidegger quanto principalmente da Dewey e – in misura minore – da Husserl e,
1
N. Abbagnano, La struttura dell’esistenza, “R. Università di Torino, Pubblicazioni della
Facoltà di Magistero”, serie I, v. 7, Paravia, Torino 1939, oggi in Id., Scritti esistenzialisti, a cura
di B. Maiorca, “Classici della Filosofia”, Utet, Torino 1988, pp. 57-227.
2
N. Abbagnano, Le “Meditazioni cartesiane” di E. Husserl, “Annuario del R. Liceo-Ginnasio
Umberto I di Napoli”, 2 (1932-’33), p. 180. Lo studio è peraltro il solo che Abbagnano abbia
mai dedicato al pensiero di Husserl.
Investigazioni sulle costanti fondative dell’esistenzialismo positivo
197
tramite l’uno e l’altro, ancora una volta, dalla critica della ragione pratica kantiana. La spiegazione, dal punto di vista filosofico, viene cercata nel concetto di
“struttura esistenziale”. Questo concetto, al quale sinora non è stata dedicata la
necessaria attenzione, è non solo il più evidente legame logico congiungente la
fase napoletana con quella torinese, ma il tema fondamentale che, a partire dalla Struttura dell’esistenza, emerge e si chiarisce come il concetto-guida di tutto
il pensiero di Abbagnano.
La ricerca si è articolata in due parti: una prima di impianto analitico, una
seconda di tipo storiografico. Nella prima parte è stata affrontata la lettura sistematica de La struttura dell’esistenza nonché di una serie di altri scritti e interventi composti da Abbagnano fra il 1939 e il 1946, alla luce non solo di Heidegger e Jaspers ma di tutte quelle fonti che Abbagnano ha conosciute, o non
può avere ignorate, negli anni cruciali del passaggio da Napoli a Torino. Nella
seconda, il lavoro svolto da Abbagnano sull’esistenzialismo è stato inquadrato
nell’ambito del contesto storico, sociale e politico-ideologico dell’esistenzialismo italiano, e questo a sua volta riconsiderato sul piano di una configurazione
generale dell’esistenzialismo europeo. Il lavoro di ricostruzione è partito perciò
dall’analisi linguistica e terministica de La struttura dell’esistenza, opera cardine dell’esistenzialismo italiano, cercando di evidenziare proprio in essa, e a
partire da essa, quei riferimenti necessari a comprendere che cosa della cosiddetta Kierkegaard Renaissance sia presente nel complesso disegno filosofico che
Abbagnano andrà costruendo in quegli anni, e perché. Disegno filosofico che,
come è stato mostrato altrove3, risale in larga misura alle ricerche condotte negli anni Trenta a Napoli e che riporta il suo esistenzialismo a una nuova elaborazione trascendentale del pensiero, sulle basi in particolare della ragione pura
pratica kantiana e delle implicanze metafisiche connesse ai nuovi problemi che
essa comporta. L’operazione comparativa è stata condotta a partire da ognuno dei testi fondamentali degli autori che Abbagnano cita direttamente nella
Struttura, e procede pertanto a una lettura comparativa tra le diverse scritture
svolta punto per punto, paragrafo per paragrafo. Il solo autore preso in considerazione nel lavoro di analisi comparativa non espressamente indicato o citato
da Abbagnano è John Dewey, che Abbagnano riscopre e approfondisce negli
ultimi quattro-cinque anni della sua permanenza a Napoli. Sull’importanza di
Dewey nella formulazione del nuovo illuminismo e della cosiddetta svolta neoempiristica degli anni Cinquanta non vi è molto da insistere, e ciò malgrado gli
3
S. Paolini Merlo, Abbagnano a Napoli. Gli anni della formazione e le radici dell’esistenzialismo positivo, premessa di G. Cantillo, “Strumenti e Ricerche”, 17, Guida, Napoli 2003.
198
Silvio Paolini Merlo
alterni giudizi di alcune recenti letture critiche4. Il fatto nuovo che qui emerge è
tuttavia un altro: che l’interesse per le tematiche proprie del nuovo naturalismo
americano, e in particolare per lo strumentalismo di Dewey, che Abbagnano
sviluppa dopo gli anni Quaranta, è già ampiamente presente nella Struttura, e
come tale vi gioca un ruolo assolutamente decisivo.
Si è perciò cercato di risalire dai singoli concetti, ovvero dalle singole funzioni logiche terministiche, alle possibili corrispondenti derivazioni. Se nozioni come “rapporto”, “autorapporto”, “possibilità”, “trascendenza”, possono essere giunte al pensiero di Abbagnano attraverso Kierkegaard, o, come è più
probabile, attraverso sollecitazioni kierkegaardiane filtrate dalla lettura di Sein
und Zeit di Heidegger; se altre, in particolare quelle di “struttura”, di “ente”,
di “coesistenza”, di “fedeltà alla morte”, arrivano direttamente dal pensiero di
Heidegger e di Jaspers, molte tra le più importanti e originali, quelle cioè di
“indeterminazione dell’essere”, di “forma finale”, di “norma”, di “possibilità trascendentale” e di “sistasi”, sembrano avere origini molto differenti, che solo in
parte si possono ricondurre alla fenomenologia o alla tradizione storicistica.
Ognuna di queste nozioni, orbitando attorno a quella di “struttura esistenziale”,
sembra piuttosto condurre a quella convergenza tra pragmatismo deweyano,
metodologia delle scienze neoempiristica ed esistenzialismo positivo, dalla quale
prenderà l’avvio il percorso neoilluministico degli anni Cinquanta, e che nei fatti prosegue il processo di revisione del principio metafisico razionale kantiano
che Abbagnano avvia a Napoli con La fisica nuova e, soprattutto, con Il principio della metafisica. L’elaborazione del concetto di “struttura esistenziale” sembra perciò essersi svolta attraverso due fasi distinte. Inizialmente, l’interesse di
Abbagnano è principalmente quello di fornire al concetto un valore metafisico,
non psicologistico né soggettivistico, considerato all’interno di una prospettiva
4
Ancora nell’Introduzione a N. Abbagnano, Scritti neoilluministici (1948-1965), a cura di
B. Maiorca, “Classici della Filosofia”, Utet, Torino 2001, Pietro Rossi e Carlo Augusto Viano
hanno ribadito il carattere estrinseco e transitorio dell’interesse di Abbagnano per Dewey (pp.
12-15). A ricezioni più sostanziali – per quanto lette come compromissorie e compromettenti
– sembra invece fare riferimento Antonio Santucci nel suo intervento su Abbagnano preparato
per il convegno di Salerno del 1992, ripreso in termini non molto dissimili in occasione del
convegno torinese del 2001 per il centenario. Precisamente nel suo opporre alla metafisica
classica una metafisica naturalistica, Dewey risulta secondo Santucci strettamente connesso
con la ricerca abbagnaniana per una diversa concezione dell’esperienza. Proprio la metafisica
naturalistica di Dewey, accostata da Rorty a Heidegger per il suo tentativo di dissolvere l’ontologia tradizionale, stabiliva in Abbagnano «una connessione ineliminabile tra la filosofia e
la realtà su cui verte, e che questa domanda intorno all’essere non sia estranea o accidentale
alla sua struttura era appunto il tema di fondo dell’esistenzialismo» (A. Santucci, Nicola Abbagnano e il Neoilluminismo, in Una filosofia dell’uomo, Atti del Convegno in memoria di N.
Abbagnano, Salerno 11-13 novembre 1992, a cura di G. Cacciatore e G. Cantillo, Comune di
Salerno, 1995, p. 77).
Investigazioni sulle costanti fondative dell’esistenzialismo positivo
199
etico-normativa dell’essere esistente, ovvero dell’ente in quanto essere singolo
e autonomo, come luogo privilegiato tra l’uomo e lo stato, e, su di un piano più
generale, tra l’ente e l’universo mondo che lo coinvolge5. È chiaro che la normatività, il dover-essere, corregge questo elemento spersonalizzante solo in maniera parziale. In un secondo momento il concetto verrà ristretto al piano applicazionale, e come tale risolto nel suo significato possibilistico e, per così dire,
tecnico-strumentale. Per evitare divagazioni e genericismi, l’analisi si è limitata
a fornire solo i riferimenti testuali più certi e immediati, tentando di evidenziare quell’aspetto essenziale che può utilmente favorire una piena comprensione:
che cioè fra un generico esistenzialismo, o umanismo esistenziale, e una metafisica esistenziale così come formulata da Abbagnano c’è totale diversificazione
e incompatibilità. Non è perciò azzardato sostenere che l’opera del 1939 non
è, o non è ancora e del tutto, un’opera “esistenzialistica”, ossia un’opera le cui
finalità prevalenti sono, come in Kierkegaard Pascal o Nietzsche, quelle di indirizzare l’analisi sul momento prelogico e irrazionale del pensiero umano che
è la vita. La sua impostazione è ancora sostanzialmente orientata, come negli
studi napoletani di logica matematica e di epistemologia generale, su Kant e il
pre-hegelismo e molto meno, o marginalmente, su Kierkegaard, Nietzsche e la
filosofia post-hegeliana. Consapevole del rischio organicista e totalizzante insito nella sua proposta metafisica, Abbagnano provvederà a una correzione etica
del concetto di “struttura esistenziale” mediante l’impiego dei temi della norma
e della coesistenzialità (la convivenza, la comprensione interumana, la transsoggettività trascendentale ecc.), e poi, a partire dall’Introduzione all’esistenzialismo, della decisione, della libertà, e in modo particolare della “possibilità”.
La prima parte della ricerca è giunta pertanto ai seguenti risultati: 1) il concetto di “struttura esistenziale” nasce dal confluire di motivi epistemologici, ricavati dalle implicazioni gnoseologiche messe in campo dalle scienze fisiche, e
5
Un confronto in proposito che metta in chiaro analogie e differenze con la visione mistico-utopica dell’idea di “stato etico” formulata da Gentile, come già da Hegel nei Lineamenti di
filosofia del diritto, e ancora prima da Campanella ne La Città del Sole e da Platone con La Repubblica, per quanto non esaustivo in sé, potrebbe certamente dimostrarsi istruttivo. A proposito di Gentile si veda in G. Gentile, Diritto e politica, “Archivio di studi corporativi”, I (1930),
pp. 1-14, poi in Id., Fondamenti della filosofia del diritto, Opere complete di G. Gentile, Sansoni,
Firenze 19373. Per una collocazione della visione gentiliana dello stato unitario, o stato-tutto,
superiore alle sue parti o ai conflitti di parte, entro le sue matrici spiritualistiche proprie di uno
pseudo-liberalismo antilluministico, si rimanda a N. Bobbio, L’ideologia del fascismo, in Id.,
Profilo ideologico del novecento italiano, “Biblioteca di cultura storica”, 157, Einaudi, Torino
1986, pp. 128-140. Per quel che riguarda Hegel, il riferimento corrispondente si trova in G. W.
F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello stato in compendio,
con le Aggiunte di Eduard Gans, a cura di G. Marini, “Biblioteca Universale Laterza”, 209, G.
Laterza & Figli, Roma-Bari 20044, §§ 257-258, pp. 195-198.
200
Silvio Paolini Merlo
di influssi giunti dal principio trascendentale del pensiero logico formulato dai
neoidealisti inglesi e americani, in particolare da Bradley, intorno al problema
kantiano dell’unificazione del molteplice6; 2) a questi due influssi si somma,
immediatamente, anticipando le stesse analitiche esistenziali di Heidegger e di
Jaspers, il procedimento logico del problem-solving di John Dewey7; 3) quest’ultimo, in particolare, fornisce ad Abbagnano il criterio del procedimento logico
interno caratteristico del moto di realizzazione dell’esistenza costituito dalla
“struttura”, e consente all’esigenza della “norma”, di ascendenza gentiliana, un
recupero dell’autonomia morale dell’imperativo categorico kantiano. Da questi
tre punti, ne è conseguito che: 1) il pensiero di Kant è d’importanza centrale nell’elaborazione filosofica della metafisica esistenziale, un’importanza ben
maggiore rispetto a quella rivestita dai pensieri di Heidegger e di Kierkegaard:
di Kant, ad esempio, è conservata la distinzione tra pensiero e conoscenza,
ignorata dai neoidealisti, e, in campo estetico, la distinzione tra forma e contenuto, respinta da Croce; 2) tra esistenzialismo positivo e neoilluminismo filosofico deve essere elimitata ogni sostanziale divisione teorica: entrambi nascono,
infatti, dalle medesime esigenze logiche e conducono alle medesime conclusioni pratiche; 3) ogni singolo motivo o concetto o funzione logica di tipo categoriale, ivi inclusa la categoria di “possibilità”, sorge per conseguenza e in
forza del concetto di “struttura esistenziale”, e pertanto quella di “possibilità”,
al pari delle altre, tutt’altro che fondamentale, è categoria derivata, desinen6
Per un’utile comprensione del problema dell’unificazione del molteplice, sistematica ma
antimonistica, in una prospettiva etico-trascendentale di tipo kantiano, le opere abbagnaniane di riferimento sono La fisica nuova. Fondamenti di una teoria della scienza, Guida, Napoli
1934, e Il nuovo idealismo inglese e americano, “Biblioteca di Filosofia”, diretta da A. Aliotta,
F. Perrella, Napoli 1927.
7
Oltre a Experience and Nature, Open Court, Chicago 1925, tr. it. Esperienza e Natura, a
cura di N. Abbagnano, “Biblioteca di Filosofia e Pedagogia”, Paravia, Torino 1948, di Dewey
Abbagnano studia a fondo certamente l’attivismo pedagogico elaborato in How we think. A
restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process, pubblicato a Boston
nel 1933, e in modo particolare gli scritti che aprono l’ultima e più fruttuosa stagione degli
studi deweyani di logica applicata, che hanno culmine in Logic, the Theory of Inquiry, H. Holt
& Co., New York 1938, tr. it. Logica, teoria dell’indagine, a cura di A. Visalberghi, “Biblioteca
di Cultura Filosofica”, 11, Einaudi, Torino 1949. Già affrontato da Abbagnano nel biennio
di Filosofia al “Suor Orsola” dell’anno 1927-’28, il pensiero di Dewey torna a essere oggetto
di attenzione nel 1935-’36, in un corso incentrato sul tema dell’Analisi critica della filosofia
contemporanea. Fra i punti del programma di studio, «La logica strumentale del Dewey», la
«Critica del pragmatismo», nonché il «Carattere antimetafisico delle correnti intuizionistiche
e pragmatistiche». Il dato emerge dalle carte d’archivio conservate nell’Istituto “Suor Orsola
Benincasa” di Napoli, raccolte ne I Corsi di Nicola Abbagnano (1926-’27 / 1935-’36), Istituto
Superiore di Magistero Femminile “Suor Orsola Benincasa” in Napoli, Fonti documentarie
raccolte, ordinate e annotate a cura di S. Paolini Merlo, dattiloscritto, s.d. [ma 2001], p. 99. Il
dattiloscritto è oggi consultabile presso la Biblioteca “E. Capocelli” dell’Università degli Studi
“Suor Orsola Benincasa” di Napoli e presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino.
Investigazioni sulle costanti fondative dell’esistenzialismo positivo
201
ziale, incomprensibile se estrapolata dal principio strutturale dell’esistenza; 4)
l’uso, metafisico prima metodologico poi, della nozione di “struttura” trova la
prima formulazione completa nella definizione metafisico-trascendentale che
Abbagnano ascrive al “pensiero” in quanto organismo metafisico pensante ne
Il principio della metafisica8, opera che segna la conclusione del periodo napoletano del filosofo; 5) nella Struttura dell’esistenza Abbagnano non parla ancora
di un “esistenzialismo positivo” ma, appunto, di una “metafisica esistenziale”,
prospettiva che pertanto è più estesa e complessa, e in virtù della quale la “struttura” si comporta come la funzione di un principio antidialettico dell’esistenza
umana; 6) la definizione di “esistenzialismo positivo”, introdotta da Abbagnano
nel 19489 in alternativa alle forme di esistenzialismo “negativo”, o nichiliste, o
senza soluzione, o comunque incapaci di dare alla vacuità dell’esistenza risposte più o meno consolatorie, è in realtà definizione fortemente equivoca se non
accompagnata dall’altra, più precisa, di “esistenzialismo positivo strutturale”,
o da quella, più onnicomprensiva, di “esistenzialismo neoilluministico”. In generale, sembra chiaro perciò che la “struttura esistenziale” riveste una triplice
funzione nell’esistenzialismo di Abbagnano: una prima di tipo metafisico, una
seconda di tipo etico-normativo, una terza di tipo logico e metodologico. Il significato metafisico iniziale viene sollecitato specialmente da Sein und Zeit di
Heidegger, ma il rimando è solo esteriore e conta poco in sé. Il valore normativo
è certamente di derivazione kantiana, per quanto venga favorito, in un primo
momento, da un forte impulso gentiliano. Dal punto di vista del funzionamento
logico, il concetto proviene in larga misura dalla logica di Dewey, e per l’esattezza dal concetto di “giudizio” nella teoria dell’indagine10. Come semplice nozione, la “struttura” deriva da Dilthey per il tramite di Husserl11.
La seconda parte della ricerca ha inteso chiarire meglio l’apparente rischio
“continuista” tra fase napoletana e fase torinese, descrivendo, sia pure nei suoi
più ampi tratti, una situazione di fermento e d’insofferenza che in Italia non ha
inizio con l’ingresso dell’esistenzialismo di Kierkegaard e di Heidegger, e non si
arresta con la proclamazione della Repubblica. L’esistenzialismo europeo na8
N. Abbagnano, Il principio della metafisica, A. Morano Editore, Napoli 1936, §§ 10-23,
pp. 38-65.
9
N. Abbagnano, La filosofia positiva dell’esistenza, «Annuario dell’Università degli Studi
di Torino», 1946-’47 / 1947-’48, pp. 63-85. L’intervento, pronunciato come discorso inaugurale
all’Università di Torino nell’anno accademico 1947-’48, ricompare col titolo L’esistenzialismo
è una filosofia positiva nella monografia N. Abbagnano, Esistenzialismo positivo. Due saggi,
Taylor, Torino 1948, oggi in Id., Scritti esistenzialisti, cit., pp. 511-533.
10
J. Dewey, Logic, the Theory of Inquiry (New York 1938), tr. it. Logica, teoria dell’indagine,
cit., Parte II: La struttura dell’indagine e la costruzione dei giudizi, pp. 151-374.
11
N. Abbagnano, La struttura dell’esistenza, cit., § 5, p. 70 (n.).
202
Silvio Paolini Merlo
sce, come noto, dopo il primo conflitto mondiale: verso la fine degli anni Venti
ha l’avvio in Germania e in Francia, mentre in Italia comincia a circolare e ad
animare gli interessi dei filosofi negli anni Trenta. È forse eccessivo indicare
l’ingresso ufficiale dell’esitenzialismo nella cultura filosofica italiana col libro di
Franco Lombardi del 1936 sul pensiero di Kierkegaard, come proposto da Antonio Santucci12, non solo perché lo studio di Lombardi confermava qualcosa
che era ormai nell’aria, la risposta persino ovvia a una domanda già da tempo
circolante, ma specie perché le sollecitazioni più vere erano già in atto e provenivano dall’interno, da ciò che era già presente e stava rapidamente mutando.
La “filosofia della crisi” fu, in quegli anni e nel nostro paese, soprattutto la crisi
di una filosofia: il neoidealismo di Croce e di Gentile. Il legame fra ricerca di
una nuova metafisica della mente umana e la fine dell’intellettualismo romantico non avviene perciò fuori da quel dibattito ma tutto internamente a esso, e
precisamente nel periodo compreso tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta,
periodo entro il quale, non a caso, si svolge e si conclude l’intera stagione esistenzialistica della filosofia italiana.
In questo ambito è stata perciò tentata una nuova lettura della configurazione generale dell’esistenzialismo europeo che ha individuato, nel panorama
italiano come in quello europeo, l’esistenza di tre grandi correnti dell’esistenzialismo: un esistenzialismo ermeneutico, risalente alle figure di Kierkegaard e
di Nietzsche e risoltosi in una neo-metafisica ontologica di tipo contemplativo
e teistico-assolutizzante, un esistenzialismo umanistico, risalente alla corrente
hegelo-marxistica e risoltosi in un coscienzialismo ontologico attivistico e antiteistico, e infine un esistenzialismo neoilluministico, le cui matrici culturali
risalgono piuttosto a Kant e a Dewey e che si connota come una neo-metafisica
di tipo esistenziale. Le prime due rinviano a un’area comune che è quella di
un esistenzialismo romantico, a sfondo finalistico e ontologizzante, su presupposto spiritualistico e/o materialistico, la terza a un’area che invece è propria
di un esistenzialismo razionalistico, a sfondo trascendentale e su presupposto
empiristico. La configurazione proposta presenta ovviamente il limite di tutte
le schematizzazioni del genere, per cui è bene evidente, ad esempio, che un esistenzialismo “romantico” non è che un differente modo di intendere l’esistenzialismo “razionalistico”, e quest’ultimo a sua volta una diversa visione dell’esistenzialismo “romantico”. Al di là di questo e altri limiti che la configurazione
presenta, ci sembra che la tripartizione possa dimostrarsi di qualche aiuto alla
12
40.
A. Santucci, Esistenzialismo e filosofia italiana, “Saggi”, 21, Il Mulino, Bologna 1959, p.
Investigazioni sulle costanti fondative dell’esistenzialismo positivo
203
comprensione e alla giusta percezione del fenomeno nel suo insieme, in sé di
straordinaria complessità.
Al di là del passaggio da un ambiente come quello napoletano a quello torinese, certamente molto diversi fra loro, è dunque necessario aggiungere che
un preciso trait d’union tra le due fasi del pensiero di Abbagnano esiste, e che
esso è costituito, per l’appunto, da La struttura dell’esistenza. In quest’opera
fondamentale arrivano a condensarsi tutti i temi cruciali emersi dalle ricerche
precedenti, e anche il pensiero dei due massimi esistenzialisti tedeschi, Heidegger e Jaspers, che certamente Abbagnano studia in modo sistematico solo dopo
l’arrivo all’Università di Torino nel 1936, assume un significato completamente
nuovo, di fatto non o non ancora esistenzialistico. Se infatti è corretto ritenere
La struttura dell’esistenza il manifesto più compiuto dell’esistenzialismo italiano, è tuttavia necessario aggiungere che Abbagnano non vi parla ancora di “filosofia dell’esistenza”, e non espone nessuno dei temi affrontati da un punto di
vista che si possa ritenere tipicamente esistenzialistico. Ancora nel 1942, nella
prima edizione dell’Introduzione all’esistenzialismo, Abbagnano definirà il proprio pensiero come un «esistenzialismo strutturalistico o sostanzialistico»13, definizione alquanto contraddittoria. L’analisi terministica apporta perciò un contributo decisivo alla chiarificazione dell’identità del progetto filosofico di Abbagnano: sulla base di essa, l’intenzione fondamentale di chi elabora La struttura dell’esistenza non è la definizione della condizione esistenziale dell’uomo in
rapporto all’essere del mondo, del pensiero o di Dio, ma la ricollocazione del
problema dell’essere come tale in rapporto alla condizione esistenziale. La categoria di “possibilità” assume il ruolo e l’importanza che le compete solo fintanto
non ci si cristallizzi sull’influsso kierkegaardiano della possibilità che no, ma si
passi a coniugarlo e integrarlo con l’accostamento alla possibilità kantiana del
sì, ovvero riconducendolo alla possibiltà trascendentale. Può sembrare un fatto
marginale, ma è invece di capitale importanza: ogni volta che Abbagnano parla
di possibilità intende di fatto un concetto di natura trascendentale, ossia una
possibilità che attua la realizzazione di una struttura esistenziale. Ogni altra
specie di possibilità, “pura”, “infinita”, “contingente”, “potenziale”, è possibilità
fittizia, e come tale senza valore. Il “positivo” della possibilità abbagnaniana,
ovvero il carattere strutturale che essa viene ad assumere nel conteso metafisico
13
L’espressione è contenuta nella prima di due frasi apparse in un saggio pubblicato sulla
rivista di Antonio Banfi «Studi filosofici», II (1941), pp. 113-133, con il titolo Esistenza e sostanza, confluito poi nella prima edizione di N. Abbagnano, Introduzione all’esistenzialismo,
“Idee nuove”, 17, Bompiani, Milano 1942, §18, p. 52, che l’autore deciderà di sopprimere nelle
edizioni successive.
204
Silvio Paolini Merlo
dal quale deriva, proviene non da Kierkegaard ma da Kant. Come spiegare, allora, la confluenza di Kierkegaard e di Kant nel pensiero di Abbagnano? L’unica
spiegazione possibile, a quanto sembra, risiede negli ultimi scritti del periodo
napoletano, e in particolare nel Principio della metafisica, dove il concetto di
“metafisica esistenziale” inteso come “organismo” e come “sistasi” si costituisce
per la prima volta, informando l’esistenzialismo del periodo torinese e tutte le
fasi successive. Da questo punto di vista, La struttura è opera assai meno “torinese” di quanto solitamente si pensi. Sin dalle prime pagine del Principio, pur
senza parlare di una metafisica “esistenziale”, Abbagnano la descrive già come
tale: «Le esigenze morali, religiose, politiche che la speculazione sembra trascurare o non appagare completamente e che quindi si fanno valere al di fuori e
contro la stessa speculazione, sono in realtà estranee soltanto a qualche forma
inferiore ed imperfetta di speculazione; ma non si può escludere che possano e
debbano trovare soddisfazione nell’organismo di una speculazione superiore.
[...] Diceva Pascal: “Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce”. Ma il problema è quello di trovare una ragione, cioè una speculazione metafisica, che
conosca e faccia valere come proprie le stesse ragioni del cuore»14.
Tra i punti che la ricerca non ha potuto affrontare come si sarebbe invece
desiderato vi è soprattutto un approfondimento delle analogie e relative differenze fra il neoilluminismo abbagnaniano e le forme di esistenzialismo francesi
rappresentate da Maurice Merleau-Ponty e Jean Wahl. Riferimenti più puntuali
avrebbero permesso, sia pure sommariamente, di accennare ai loro apporti in
sede di rielaborazione teorica del pensiero post-hegeliano, e dunque di chiarire
meglio, in particolare, che la prospettiva fenomenologica husserliana, rigidamente soggettivistica, non si concilia con l’esistenzialismo di Heidegger e di
Sartre, ma neppure con la fenomenologia esistenzialistica di Merleau-Ponty.
Ciò avrebbe potuto evidenziare, meglio di quanto ora non si sia potuto fare,
l’incompatibilità tra fenomenologia e neoilluminismo, nonché tra fenomenologia ed esistenzialismo. Nella Crisi delle scienze europee Husserl, come Abbagnano, stende una storia critica del pensiero moderno: nel caso specifico di
Husserl da Galileo a Kant15. Non c’è dubbio che anche Abbagnano, a partire da
La fisica nuova del 1934, persegue, quale problema e pungolo fondamentale del
suo percorso, il progetto di come conseguire una filosofia di livello scientifico,
N. Abbagnano, Il principio della metafisica, cit., Introduzione, § III, pp. 14-16, passim.
E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, M. Nijhoff’s Boekhandel en Uitgeversmaatschappij, L’Aia 1959, tr. it. di E. Filippini,
La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, prefazione di E. Paci, “Quality
Paperback”, 23, Net, Milano 2002, Seconda Parte (L’origine del contrasto moderno tra obiettivismo fisicalistico e soggettivismo trascendentale), §§ 8-27, pp. 51-129.
14
15
Investigazioni sulle costanti fondative dell’esistenzialismo positivo
205
capace di sintetizzare il molteplice dei diversi punti di vista particolari entro
una prospettiva più ampia e tuttavia non riduzionistica. In questo, Abbagnano
dimostra di avere in comune con Husserl il punto di partenza e quello di arrivo,
non però il passaggio che collega l’uno all’altro e, soprattutto, non la soluzione
finale. In Husserl manca totalmente la componente problematica e possibilistica che invece per Abbagnano è indispensabile: l’epoché fenomenologica, a suo
dire, torna ad occuparsi di essenze più che di esistenze, ponendo in parentesi
non soltanto il mondo delle contingenze ma, ancora prima, quel giudizio di
esistenza che per estensione riguarda anche, oltre alle cose e alle diverse entità
fisiche, l’uomo con i suoi problemi immediati.
Altro aspetto importante ad essere stato, in larga misura, accantonato è
quello del rapporto di Abbagnano con lo storicismo tedesco, specie con l’uso
trascendentale da esso praticato della nozione di “struttura”. Tuttavia, mentre
nello storicismo tedesco del Novecento la nozione acquista un significato di
tipo finalistico e teleologico, ovvero indica un elemento di apparente mobilità
che, in analogia con l’evoluzionismo positivista, si afferma e progressivamente si invera attraverso il tempo, in Abbagnano, diversamente, come più tardi
nella sociologia di Lucien Goldman, o nell’antropologia di Lévi-Strauss e degli
altri strutturalisti, la “struttura” rappresenta piuttosto un elemento di relativa
stabilità funzionale, da recuperare in ciò che muta16. Dunque, risponde al principio che vede nel movimento la legge interna di una sostanza finita e adattiva.
Ognuno di questi temi, per quanto importante e degno di essere approfondito, è
stato per ora rinviato al fine di dare maggiore risalto alla genesi e all’evoluzione
logico-speculativa del concetto di “struttura esistenziale”. Come e in che misura
questa idea fondamentale, questa costante fondativa abbia potuto mantenersi
salda e vitale pur senza compromettere la libertà della specu­lazione, come cioè
sia riuscita a radicarsi nel cuore stesso di una considerazione filosofica risoltasi
a più riprese in termini schiettamente possi­bilistici e relativistici, è stato l’obiettivo fondamentale dell’intera ricerca.
16
Proprio al fine di evitare ricadute deterministiche o sostanzialistiche Abbagnano sosterrà che, anche nello strutturalismo, «la struttura esige, per conservarsi, che certi rapporti
tra gli elementi che la costituiscono rimangano costanti, e si organizza in vista di garantirli;
ma nell’ambito di tali rapporti esiste un vasto campo di alternative» (N. Abbagnano, Rischi
dello strutturalismo, «Il Giornale Nuovo», 12 settembre 1974, p. 3). Un campionario piuttosto
articolato di alcune tra le principali applicazioni del concetto in sede strutturalista nel quadro
delle scienze umane e sociali è ricavabile dagli Atti del Convegno Internazionale di Baltimora
del 1966, poi raccolti in Aa.Vv., The Structuralist Controversy, The languages of Criticism and
the Science of Man, tr. it. La controversia sullo strutturalismo. I linguaggi della critica e le scienze
dell’uomo, a cura di S. Miletti, R. Macksey e E. Donato, “Le Forme del Significato”, 11, Liguori,
Napoli 1975.
Tra caos e razionalità: elementi di ecologia simbolica urbana
207
Tra caos e razionalità: elementi di ecologia simbolica urbana*
Memoria di Jean-Jacques Wunenburger**
presentata dal socio naz. ord. res. Aldo Trione
(seduta del 26 giugno 2008)
Abstract. 1.The paradox of the founding violence.
The birth of a city represents a violent event which marks a break with the old order
of things, a violence which the city does not remove by law and politics, but creates it
again: concentration of populations, social segregation, economic inequality, conflicts
and disorders. The awareness of this residual violence is historically testified by the recourse to the symbolic order of the rites of foundation, memorial festivities, etc.
The city must produce political and overall metapolitical imagery in order to make
up, to direct and to sublime the violence it generates and to place every citizen into a
historical-geographic particularity which will help to build up psychically and symbolically the space of the being-together.
2. Poetic and symbolic architecture as metapolitics
The city is neither a mimetic copy of politics nor the laboratory for its social plans:
it must join an anthropological independence, a balance between the private and the
public, oikos and cosmos. Citizenship is based on a relationship of coexistence, of horizontal conciliation of freedom and rights; however, the urban space must allow us to live
together in the same environment (cosmos), which is not only the polis. The city must
become a diversified, complex olistic world having the task to answer for the plural expressions of the anthropos (body-soul, understanding but also rationality and imagery,
immanence and transcendence).
In order to make again the city liveable and able to create life, it would be necessary
to re-think the space and to adapt it to the organic, imaginative and cognitive needs of
its inhabitants. The city of man should provide for the anthopological, perceptual, imaginative and cognitive needs of its inhabitants better. Imagery allows us to approach
the anthropological needs of some architectural forms in a sensible, non-rational and
non-argued form.
La politica è l’arte di far convivere individui e gruppi in uno stesso territorio,
intorno a valori e volontà comuni. Com’è possibile pensare, quindi, di abitarla
nella città-Stato politica? Occorre edificare, costruire, pianificare unicamente
*
Traduzione dal francese di Giovanni Tallarico.
Università di Lione Jean Moulin
**
208
Jean-Jacques Wunenburger
per risolvere il problema del legame politico (legame orizzontale costitutivo del
popolo e legame verticale del potere egemonico) e dei bisogni economici e militari? Oppure, la costruzione dello spazio urbano deve “fare legame” in modo
diverso, creando un “ambiente” strutturato e strutturante? Lo spazio della Città
non dovrebbe forse ricorrere a forme simboliche che differiscano dalla politica,
pur inglobando il contratto politico come sussidiario? E in quale maniera?
1- Il paradosso della violenza fondatrice
Il fenomeno urbano si presenta in ogni momento storico come una tappa
della civiltà, come una forma culturale per addomesticare la violenza umana e
sociale, dando vita a una forma di “polis”, di città-Stato, luogo di nascita anche
del fatto politico. Ma, paradossalmente, la politica urbana si trova sempre sotto la minaccia di una nuova violenza che l’istituzione urbana, con i suoi riti e i
suoi miti, non cessa di esorcizzare, simbolizzare e addomesticare.
a- Per la maggior parte delle genealogie, la nascita del politico deriva dalla necessità di porre fine al caos primitivo, alla violenza spontanea dello stato
di natura (Lucrezio, Hobbes), tramite l’istituzione della Legge, dell’ordine, del
potere egemonico. L’avvento della città-Stato politica è inseparabile dalla nascita della città, che appare come spazio di accentramento, concentrazione e
irradiamento del potere, ritenuto in grado di instaurare l’ordine e la pace. La
forma tipo di urbanistica colloca il potere al centro dello spazio civico tramite
la monumentalità e altri fattori.
La città viene fondata il giorno in cui un capo militare, un eroe o un sacerdote decidono di occupare un terreno disabitato per collocarvi un nuovo insediamento, costruito ex novo e destinato a diventare il centro di unificazione di tutti
quei gruppi prima disseminati o dispersi. Così come avviene, già secondo un
rito, per la costruzione di una casa, si sceglie allora con cura il luogo in funzione del rilievo e del paesaggio, si tracciano segni sacri sul terreno, si determinano le orientazioni secondo i valori simbolici dei punti cardinali e si costruisce
un primo grande edificio che sia a misura di un’ambizione nuova, quella degli
uomini destinati a radunarsi per formare una società (mito della fondazione di
Roma da parte di Romolo e Remo1). Così nasce una città, allorché coloro che
possiedono, all’interno di un gruppo, autorità sui loro simili annettono uno
spazio per insediarvi e rendervi visibile il loro potere. I potenti, guerrieri o sa1
Cf. M. Serres, Rome, le livre des fondations, Hachette Littérature, Pluriel, 1999.
Tra caos e razionalità: elementi di ecologia simbolica urbana
209
cerdoti, non si accontentano più di esercitare il loro carisma o la loro magia nel
quotidiano, all’interno di accampamenti o villaggi, ma si stabiliscono in uno
spazio artificiale, separato dalla vita quotidiana ancestrale, da cui riuniranno e
uniformeranno la vita collettiva, dandole un ritmo nuovo.
È per questo motivo che, nel centro geometrico o simbolico del nuovo spazio che diventerà una città, viene innanzitutto costruito il tempio religioso o il
palazzo reale, che segna una trasformazione istituzionale del potere. Tuttavia,
non si tratta ora di costruire nuovamente case a dimensione umana: l’autorità
che pone il proprio marchio sul mondo ha bisogno, prima di tutto, di monumentalità. In effetti, i nuovi luoghi di residenza della sovranità necessitano di
un cambiamento di scala che serva, analogicamente, a segnalarne la funzione.
Sorge allora il monumento, gesto architettonico che consiste nel costruire in
grande, in altezza e profondità, al di là dei bisogni vitali; e il monumento crea
per forza di cose distanze nuove rispetto al terreno, che aprono ampie prospettive. Ora gli edifici non si disseminano né si giustappongono, ma vengono posti
su rocce a strapiombo, su ripiani che danno su vaste spianate. In altre parole, la
verticalità delle pareti e la dilatazione dei volumi che creano maestosità vanno
di pari passo con la creazione di una corte, di una spianata, altrettanti luoghi
vuoti che permettono di vedere il monumento, instaurando una distanza tra
l’architettura del potere (sacerdotale o regale) e le abitazioni dei sudditi. Il cuore di una città è fatto per essere visto e per consentire di vedere tutt’attorno; è
per questa ragione che la città antica è divenuta l’acropoli, luogo sacro, separato dal quotidiano e più vicino al cielo.
Questa spettacolarizzazione del potere nella città determina, per un effetto
meccanico, una vera e propria spirale architettonica. Poiché il nuovo potere
egemonico deve vegliare alla sua salvaguardia, la costruzione del centro politico e sacerdotale comporta la costruzione di bastioni che chiudano lo spazio intorno al Centro sacro. La cinta, punteggiata da porte ben protette, diventa così
un perimetro che assicura il legame tra tutti coloro che si trovano al suo interno
(i cittadini) e respinge tutti coloro che vorrebbero penetrarvi indebitamente (gli
stranieri). L’organizzazione della difesa della nuova città porta in seguito alla
costruzione di edifici militari, depositi di armi, necessari a tutti i difensori della
territorio urbano. L’esercitò formerà quindi la spada di cui lo scettro reale o il
clero hanno bisogno.
Tuttavia, il potere, nel suo palazzo o nel suo tempio, è anzitutto un’istanza
immateriale, luogo dove si manifestano parole, comandamenti e leggi divine o
umane. Esso può continuare a esistere, dotarsi di mezzi coercitivi, soltanto se
la nuova città gli assicura un capitale materiale. La città del sovrano può assi-
210
Jean-Jacques Wunenburger
curare il pieno esercizio dell’autorità solo con l’appoggio di una forza materiale
che gli assicuri un potere: è per questo motivo che intorno ai palazzi e ai templi
fanno la loro comparsa un insieme di mestieri, artigiani e commercianti, che
fanno vivere la corte o la chiesa e che lavorano per l’esercito. Gli edifici destinati
al lavoro occupano progressivamente lo spazio tra l’acropoli e la cinta fortificata, creando così una nuova vita sociale, segnata dalla produzione di beni. E,
dato che gli artigiani hanno bisogno di materie prime per i loro attrezzi e i loro
lavori, faranno appello a commercianti che organizzeranno gli scambi con il
mondo esterno. Così, alle funzioni di sovranità e difesa, nella nascente città si
aggiungono quelle di produzione e scambio. Nascono allora quartieri specializzati che, a differenza del mercato e delle piccole botteghe dell’artigianato quotidiano dell’era pre-urbana, svilupperanno in misura sempre maggiore un’economia di produzione dei beni superflui, che sono però vitali per la classe dirigente
o guerriera. La città si arricchisce, si abbellisce, si specializza nelle arti, mentre
si osserva un continuo incremento delle popolazioni che lasciano le campagne
per occupare i nuovi posti di lavoro.
Con la moltiplicazione di queste nuove classi nasce poi il bisogno di amministratori, di scribi, contabili, architetti, che a loro volta aggiungeranno al
tessuto urbano nuovi edifici specializzati, che disegnano uno spazio intermedio, destinato all’amministrazione della città e dei suoi occupanti. La città si
ingrandisce ancora con altri edifici e quartieri, dedicati al suo funzionamento
e alla sua gestione. Nel corso della sua storia, la città vedrà quindi svilupparsi, con un processo di crescita spontanea o programmata, spazi appositi, dove
guerrieri, mercanti, intellettuali e notabili si ritaglieranno, secondo i casi, la
parte dominante. Così, il paesaggio e la pianta della città si diversificano, con
l’inclusione di spazi e funzioni intermedie tra il centro (palazzo e templi) e la
periferia (insediamento popolare). Con l’aiuto dell’espansione, il centro unico
originario permette la moltiplicazione di altri centri, sviluppando così le forme architettoniche, progettando nuovi quartieri, intorno a nuovi templi, nuovi
mercati, o addirittura altre residenze di corte. Sia essa monocentrica o policentrica, la città tende a specializzare i propri spazi e a subordinare la funzione
abitativa quotidiana a costruzioni dedicate alla perpetuazione, più che della
vita quotidiana, della vita di un apparato di funzionari, ricchi mercanti, caste
di notabili che animano la vita pubblica della collettività. In questo modo, la
città non si sviluppa più al servizio della sua popolazione, dei suoi cittadini e
dei suoi contribuenti (schiavi, soldati, commercianti e artigiani), ma al servizio
dei poteri (politici, religiosi, militari, economici) che le assicurano l’egemonia
su una regione, un territorio, di cui la città diventa così la capitale.
Tra caos e razionalità: elementi di ecologia simbolica urbana
211
Cosa ci insegna allora questa storia anonima e fittizia, simile però a molte
storie reali? Innanzitutto, che la città non risulta dalla semplice crescita di un
villaggio: l’aumento del numero di persone che coesistono in un luogo, così
come l’aggiunta di case non bastano a far accedere una popolazione all’urbanità. Una città non è paragonabile all’età adulta di una persona che ha precedentemente vissuto un’infanzia; la nascita di una città costituisce piuttosto un avvenimento violento, un gesto spettacolare e volontario, che assomiglia più a una
creazione ex nihilo. Con la città, un gruppo sociale inventa una nuova forma di
spazio che gli fa scoprire una nuova forma di vita collettiva. Perciò, la città non
cresce come un albero, ma si impone come un’istituzione, ossia si aggiunge alla
storia spontanea con un’intenzione, un decreto, un contratto, e si colloca in una
topografia e in un calendario. La città appartiene fondamentalmente al campo
degli artefatti, segna una rottura con il vecchio ordine delle cose. Fondando
una città, un gruppo conosce l’equivalente di una mutazione, di un salto, di una
rottura, che è tanto effetto quanto causa. Si crea una città “da zero” solo perché
un gruppo è pronto, maturo per sperimentare un’altra logica di coesistenza, un
altro progetto di vita collettiva. La nascita di una città indica una metamorfosi
mentale, una maturazione che porta a cambiare ambiente, contesto, ma anche
attività, ruoli, obiettivi storici: la città fa infatti nascere eventi, mestieri, statuti,
beni e valori che rompono con la società della disseminazione o dell’agglomerato (che si può chiamare, per semplificazione, mondo rurale).
La città non è dunque un semplice luogo di vita, che concentra uomini e
abitazioni per facilitare solamente la vita in comune, bensì è un’organizzazione complessa e gerarchica la cui prima ragion d’essere è di assicurare la
manifestazione del potere, di stabilizzare i movimenti centrifughi, creando
uno spazio civico. La città è un centro che, lungi dal chiudersi su se stesso
secondo una logica autarchica, mira ad assoggettare degli uomini, a coordinarne le vite e le attività, a conquistare nuovi territori, ad annettere altre
città, inaugurando così la storia politica delle società, vale a dire la storia
di una volontà di potenza, tramite la violenza o il dominio economico. In
un simile contesto, non stupisce che l’insediamento, l’architettura funzionale, vengano lasciati alla libera iniziativa degli abitanti, visto che la ricerca
della bellezza, del comfort e del lusso si concentra essenzialmente intorno
alla residenza e all’opulenza dei signori della Città. Infatti, è storicamente
raro che un piano architettonico si faccia carico dell’insediamento popolare, essendo la città edificata e resa armoniosa con lo scopo prioritario di
imporre e rafforzare i poteri pubblici e non quelli privati, i luoghi di potere
e non quelli dei soggetti al potere. Bisognerà attendere l’era moderna della
212
Jean-Jacques Wunenburger
città pletoriche o alcune figure dotate di autorità illuminata per vedere una
pianificazione delle abitazioni private. Segno che, attraverso la storia, la città
è innanzitutto uno spazio di messa in scena del potere e non una modalità perfezionata della socialità quotidiana. D’altro canto, questo chiarisce la recente
crisi delle città, allorché il potere vi risulta nuovamente disperso o dissolto sotto
la pressione di un insediamento esponenziale, sproporzionato rispetto alle sue
funzioni iniziali.
b- Tuttavia il fenomeno urbano, lungi dal far scomparire la violenza tramite
il diritto e il politico (potere legislativo ed esecutivo), ne ricrea un’altra. Concentrazione di popolazioni, segregazione di alcune posizioni sociali, disuguaglianze economiche espongono persone e cose al conflitto e al disordine (furti, crimini, delinquenza, corruzione, incidenti, ingorghi stradali, rifiuti, inquinamento).
La consapevolezza di questa violenza residuale è attestata storicamente tramite
il ricorso al simbolico: riti di fondazione, feste commemorative, giochi di rivalità ecc. (Carnevale, festa del santo patrono, San Giorgio ecc.2), accanto o al di
sopra della razionalità politica (propria alla procedura di designazione dei governanti, alla deliberazione pubblica sulle volontà, alla polizia pubblica ecc.). I
riti simbolici aiutano a canalizzare la violenza che resiste alla ragione.
Da sempre, infatti, il fenomeno urbano rinfocola la violenza poiché genera
una struttura ansiogena sullo sfondo di una competizione crudele per trovare
un posto al suo interno. Lo spazio urbano accentua l’aggressività, costringe alla
lotta per la vita, mette a nudo le disuguaglianze, suscita invidie ecc. Per questo
motivo, la città ha da sempre istituito dei dispositivi di controllo, gli uni reali
(la polizia, la legge ecc.), gli altri simbolici. Capire il fenomeno urbano obbliga,
infatti, a ricostruire ciò che ha potuto rappresentare in origine la nascita delle prime città. In effetti, ogni assembramento di popolazione in una città, che
pone fine a un insediamento rurale sparso, inaugura una “concentrazione” che
fa nascere a sua volta un’“elevazione” dello spazio intorno a un’acropoli, la quale diventa un fulcro di rappresentazioni celesti. Ogni città, ai suoi albori, mette
in atto profonde rotture antropologiche: in un primo momento rispetto allo
spazio (concentrazione di edifici, nascita di proporzioni monumentali, ristrutturazione di spazi vuoti – spianate, piazze, giardini ecc.), e poi verso la socialità
(concentrazione di abitanti, di attività commerciali, militari, politiche, religiose, nuovi vincoli di vicinato, igienici, di circolazione ecc.). Come testimoniano
2
Cfr., per esempio, il mito urbano di San Giorgio e il drago, in «Cahiers internationaux de
symbolisme», Mons, N. 86-88, 1997.
Tra caos e razionalità: elementi di ecologia simbolica urbana
213
ancora ai giorni nostri gli emigranti che si spostano dal mondo rurale verso un
mondo urbanizzato, la città appare come fonte di mutazioni etologiche dello
spazio, del tempo, quindi del corpo, della percezione, delle sensazioni, delle
passioni sociali, dell’immaginazione e dei saperi.
Questa rivoluzione urbana si accompagna a una profonda ambivalenza dei
significati: alla città deve corrispondere in primo luogo un vantaggio funzionale per l’efficacia del lavoro e degli scambi e soprattutto per la sicurezza delle
persone e dei beni. È per questo che una città viene concepita come spazio
protetto, luogo di rifugio contro le minacce o i pericoli, che contrasta con la
vita “esposta” del mondo rurale3. La fondazione delle città viene d’altronde segnata simbolicamente da riti propiziatori, che legano il loro destino alla protezione divina, alla sicurezza e alla prosperità4. Questo guadagno, tuttavia, ha
come contraltare nuovi costi e nuovi vincoli. Il cittadino, che la abiti per fattori ereditari, per necessità o per scelta, concepisce la città come uno spazio
artificiale dove lo spazio edificato, le attività produttive, le relazioni umane di
prossimità impongono vincoli e persino violenze insospettati fintanto che la
città viene sognata come mondo benefico e benefattore. Non sorprende quindi
che la città generi anche, nella mente dei suoi costruttori e amministratori, un
immaginario mitico che consenta di addomesticarla, di legarsi a essa e di conferirle un’identità e una legittimità. La novità, l’estraneità se non addirittura
la durezza della vita urbana, vissuta e riconosciuta fin dalle sue prime apparizioni storiche, hanno dunque bisogno di essere occultate o compensate da un
sistema simbolico che conferisca loro forma e senso. La città deve produrre un
immaginario politico e, soprattutto, metapolitico, per integrare, canalizzare e
sublimare la violenza che essa genera, volto a inserire ogni cittadino in una sostanzialità storica e geografica che aiuterà a costruire psichicamente e simbolicamente lo spazio dell’essere-insieme. La cultura urbana, politica e religiosa, è
stata quindi sempre inseparabile dalla produzione, condivisione e trasmissione
di miti e riti, che permettono di mediare il sentimento di appartenenza e dare
significato a quella parte maledetta di violenza che occorre accettare per vivere
nell’intimità urbana5.
Oggi, probabilmente, fatichiamo a ricostituire e interpretare questa invenzione simbolica della città, inseparabile da una sua iscrizione in una sacralità,
in un patto sancito con gli dei, per metabolizzare la violenza fondatrice che
Cfr. D. Payot, Des villes-refuges, éditions de l’Aube, 1992.
Cfr. la nostra trattazione in «Mythe urbain et violence fondatrice» in Utopies du lieu commun, «Cahiers internationaux de symbolisme», Mons, 95-97, 2000, pp. 185 ss.
5 Cfr. M. Maffesoli - A. Pessin, La violence fondatrice, éd. Champ Urbain, 1978.
3 4 214
Jean-Jacques Wunenburger
accompagna questa agglomerazione contro natura di un gran numero di individui e di famiglie. Tuttavia i miti urbani hanno, come la maggior parte dei miti,
un rapporto con l’origine, la cui memoria viene rinnovata tramite un vasto reticolato di credenze e riti. I miti di fondazione delle città, di cui si trova ancora
traccia in numerose feste e che animano una scena originaria nella memoria
collettiva, devono consentire di filtrare e unificare gli elementi archetipici, le
trame narrative che aiutano a formare una città, ovverosia una città-Stato “unica”. Il rapporto con la fondazione segnala dunque, più che un interesse per un
passato ormai compiuto, il bisogno di servirsi del passato per creare un legame
attuale. È per questo motivo che i miti urbani comprendono invariabilmente
elementi simbolici: una filiazione tra lo spazio urbano e il mondo invisibile degli dei, con il sito che, per esempio, si vede scelto e investito da un dio che lo
distingue come sacro; una ristrutturazione intorno a un mundus che fa della
ristrutturazione urbana un fulcro di concentrazione di forze, un luogo di rottura ontologica che conferisce un’essenza nuova all’assembramento spaziale di
persone in uno stesso luogo; un rito fondatore associato a un sacrificio (omicidio rituale), come se il nuovo ordine della città potesse risultare soltanto da
un disordine di grandi proporzioni, scongiurato e poi vinto. L’omicidio mitico
fondatore fa riferimento alla violenza antropologica, o perfino cosmica, su cui
si costruisce il nuovo ordine urbano, e con questo ricorda quanto la città riattualizzi una dialettica natura/cultura, legge/trasgressione senza la quale non è
possibile produrre l’istituzione. In altre parole, questa mitologia urbana, che è
viva da secoli, fa capire come la pace civile connessa con il progetto urbano si
possa ottenere solo a prezzo del superamento di una nuova violenza. Questa
violenza instauratrice, che è al tempo stesso distruttiva e occasione di un’istituzione creatrice, non è, significativamente, violenza inter-sociale, memoria di
una qualche guerra tribale, continuazione di violenze che contrappongono da
sempre clan e popoli in epoca pre-urbana. La violenza fondatrice viene rappresentata simbolicamente come violenza tra parenti, tra fratelli o persino gemelli,
e rimanda dunque a una violenza intra-sociale, intestina: è l’immagine stessa
della violenza che circola nella società endogamica, nello spazio chiuso della
città. La città, certamente, pone fine alla violenza esogena, ma a prezzo di una
nuova violenza, quella dell’urbanità stessa, dei vicini e dei parenti, che si ri-dice
e ri-gioca nella forma mitica di una lotta tra fondatori, ossia tra gli abitanti di
una medesima città-Stato. Questa violenza tra gli Stessi, e non tra lo Stesso e
l’Altro, iscrive quindi nella memoria della città il riconoscimento di un pericolo primordiale e, allo stesso tempo, la sua esorcizzazione rituale per il tramite
di un ordine nuovo, scaturito dalla città stessa. Per costituire davvero un cor-
Tra caos e razionalità: elementi di ecologia simbolica urbana
215
po unico, gli abitanti di una città sono condannati a produrre una comunità
che non derivi soltanto da una qualche solidarietà pragmatica, da un interesse
condiviso o da un’empatia di fusione, che possono sempre dissolversi. Infatti,
lo Stesso non sorge da una semplice concentrazione, che esacerba paradossalmente il conflitto, ma da una trasfigurazione che esige innanzitutto il sacrificio
dell’Altro. La società urbana accede dunque all’ordine cittadino e alla pace civile solo indicando e espellendo da sé il negativo che la corrompe nel suo seno. La
città appare così, originariamente, come un pharmakon, nel senso greco di focolaio di violenza che agisce come malattia e come soluzione, un rimedio contro il disordine. I miti urbani, in particolare i miti di fondazione, rompono in
questo modo con ogni logica identitaria immediata, e iscrivono il fatto urbano
in una simbologia della coincidentia oppositorum, poiché testimoniano l’alleanza indissolubile tra la pace e la guerra, tra il bene e il male, che così congiunti,
regolati e sublimati, sanciscono il patto fondatore.
Le società, optando per l’avventura urbana, non hanno quindi esitato a riconoscerne la sfida, una sfida che porta a giocare simbolicamente con il fuoco:
intensificare i rischi per dominarli meglio, assorbire il conflitto per meglio addomesticarlo. In questo senso, la disumanità e l’artificio della città, legati alla
promiscuità, all’insalubrità, alla dipendenza, alla miseria generata dal lavoro,
al controllo ecc., creano le condizioni di una nuova socialità, quella che troverà pieno compimento nel civismo o nella cittadinanza politica. Inversamente,
viene ricordato come la socialità urbana, lungi dall’essere acquisita una volta
per tutte, resti minata dal male e dalla violenza che possono, in ogni momento,
distruggerne il fragile ordine contribuendo, al tempo stesso, alla sua rigenerazione.
2- L’utopia urbana come strumento del progetto politico
a- Questo fallimento del politico nel ridurre la violenza intra-urbana, soprattutto in seguito al declino della protezione mitica e rituale, ha portato in
realtà a un rilancio urbanistico, sotto forma di utopia6. L’utopia si prefigge di
trovare lo spazio ideale che consentirebbe di superare, di realizzare il politico
sradicando definitivamente la violenza. L’Utopia risulta allora dall’alleanza del
principe e dell’architetto intorno a un progetto di razionalizzazione integrale
dell’abitare.
6
Cfr. il nostro L’utopia ou la crise de l’imaginaire, éd. universitaires, Paris, 1979.
216
Jean-Jacques Wunenburger
b - L’utopia occidentale è consistita nel credere che la ristrutturazione razionale della città avrebbe permesso di rafforzare la missione del politico, di produrre uno spazio che avrebbe soppresso le relazioni violente e al limite perfino
assorbito il politico; una buona città sarebbe una città senza Stato, in cui lo
spazio modelli e regoli i sudditi senza un potere visibile. L’obiettivo degli urbanisti e degli architetti utopisti è di far coesistere funzionalmente gli abitanti, di
evitare incidenti, tensioni, violenze.
La proiezione in uno spazio-tempo utopico permette di liberarsi da dati e costrizioni propri alla storia del presente e del passato e di ricombinare, in piena
libertà, i parametri della vita collettiva a partire da norme poste come assoluti
non empirici. Questa funzione di modellizzazione dei testi utopici permette di
produrre modelli che consentono di visualizzare, simulare altre organizzazioni
di edifici, di quartieri o di città. Ne consegue che generalmente questi paesaggi
e modelli urbani utopici ignorano le particolarità del clima, della geografia e
della storia dei luoghi, della psicosociologia degli abitanti. Nell’utopia, è tanto
più facile procedere a una riforma dei costumi e delle istituzioni quanto più si
prescinde dalla vita banale, triviale, con le sue imperfezioni e disfunzioni, le sue
passioni e i suoi desideri. Lo spazio della città urbana è allora, in senso letterale, « u-topico » e « u-cronico », vale a dire privato di un radicamento spaziotemporale, liberato dai vincoli del reale particolare. La città utopica, raccontata, dipinta o disegnata, evolve in una sorta di aria rarefatta, di immaterialità
trasparente, in cui tutte le forme appaiono come in assenza di gravità. La posta
in gioco di questi esercizi iconografici è appunto, a costo di questa derealizzazione, di mettere in risalto, di mettere in scena delle forme pure, liberate dai
loro effetti perversi, dalle loro derive empiriche ecc. L’immaginario utopico della città diventa così una sorta di purificatore delle forme, che permette di trattare la città nella sua idealità, come se essa non esisterà mai; essa può quindi
diventare un medium per elaborarla e renderla completamente disponibile per
la realizzazione del progetto di razionalizzazione politica.
Il genere utopico, nato con Tommaso Moro, da cui prenderà in prestito
numerosi codici retorici, tenta chiaramente di confezionare piante di città, di
fabbricare modelli di società che permettano di abbandonare le imperfezioni
umane constatate nel corso della storia delle società politiche. Tuttavia, questo
quadro della società ideale non necessita tanto di una trasformazione effettiva del reale, di un cambiamento radicale della natura delle cose, quanto di un
semplice cambiamento di punto di vista. Il metodo utopico7, infatti, consiste
7
Cfr. L. Marin, Utopiques, jeux d’espace, éd. de Minuit, 1973.
Tra caos e razionalità: elementi di ecologia simbolica urbana
217
essenzialmente in un esercizio ottico che deve permettere di guardare la realtà
umana in una luce viva, che ha il potere di eliminare l’ombra, di stanare ciò che
è nascosto, vale a dire metaforicamente i mali di una società. In questo senso,
l’utopista non inventa nulla di veramente nuovo, ma chiarifica, purifica il vecchio con giochi di riflessione e inversione, che rientrano essenzialmente nel
campo degli effetti di specchio e di luce. La Città, vista nella piena luce dell’utopia, può così paragonarsi a un dispositivo ottico, di solo vetro, che assicura una
trasparenza di ogni sua parte e ne facilita la visione panoramica e integrale.
Questa simbologia della luce solare, di una luce di mezzogiorno senz’ombra,
comporta d’altro canto un’evidente dimensione etica, nella misura in cui gli
uomini, esposti alla vista, posti sotto il controllo di uno sguardo che vede tutto,
si lasciano andare meno facilmente al vizio, all’errore, al peccato. Infatti, essere
esposti alla luce, essere sempre visibili, spinge a voler figurare bene, ad agire
bene e vivere bene, senza farsi notare: il solare diventa così l’emblema della virtù civica. In questo modo, gli abitanti della nuova Città, non potendo più sfuggire agli sguardi, interiorizzeranno senza violenze le norme della vita buona. È
per questo motivo che Campanella dispone la città in terrazze sul fianco di una
collina, come un anfiteatro, allestisce sale comuni per rafforzare la socialità e
istituisce confessioni pubbliche il giorno del grande culto solare. La Città è in
questo modo pura o purificata, perché vengono banditi tutti gli angoli e i recessi
invisibili, luoghi del vizio, del male, perché tutto si deve fare in pieno giorno,
in pubblico.
Queste tendenze culturali che generano l’utopia convergono con la nuova
filosofia, che trova nel cartesianismo l’esposizione canonica del suo metodo.
La ragione può, in effetti, sperare di affrancarsi dall’empirismo aristotelico e
dal panpsichismo rinascimentale, che mescola l’anima e il corpo tramite un
metodo nuovo, che riterrà vero soltanto ciò che la mente avrà colto attraverso
evidenze e idee «chiare», vale a dire integralmente descrivibili, e «distinte»,
ossia in grado di discriminare rispetto a tutto ciò che viene loro associato da
analogie ingannevoli8. La nuova scienza è così invitata a partire da rappresentazioni pure, svuotate dei propri sovraccarichi sensoriali, allo scopo di procedere per decomposizione, per inventario degli elementi, per sviluppo di ragioni
necessarie, per poi dedurne enunciati nuovi e veri. Trionfo di un ordine intellettuale luminoso, imposto da uno sguardo non ostruito da limiti empirici, il
cartesianismo sviluppa nella sfera della conoscenza del mondo la medesima
utopia dei promotori di città solari, ripuliti dalle loro scorie da un potere ocu8 Espressioni riprese da R. Descartes, Discours de la Méthode, Garnier-Flammarion.
218
Jean-Jacques Wunenburger
lare. È significativo come, in questo senso, Cartesio esprima simultaneamente
la sua delusione nei confronti delle città antiche, sovraccariche di un disordine
labirintico e rese illeggibili da modifiche successive, e il suo gusto per la recente
arte (monarchica) della creazione di nuove città, tutte d’un pezzo, chiare, ariose, simmetriche e geometriche, a immagine della ragione.
L’utopia si è così imposta come tecnologia sociopolitica, che sposa le nuove
forme di una razionalità, ormai desiderosa di “ispezionare” il mondo per esaltare la potenza dell’uomo sulla Natura, una volta separata da Dio. Scienza e
politica dell’età classica saranno quindi segnate dalla stessa procedura utopica,
nel tentativo di ottenere effetti di sapere o di potere tramite uno sguardo nuovo,
che si astrae dalle contingenze empiriche e vi sostituisce una modelizzazione
unidimensionale. Questa modellizzazione diventerà un’ausiliaria della nuova
filosofia politica, che sogna di rinchiudere i cittadini in una città geometrica,
trasparente, calcolata, civilizzata, vero spazio dello Stato moderno.
I valori di uguaglianza, giustizia e felicità acquistano un senso solo all’interno di società chiuse, senza eccessi né eccedenze. Come sottolinea G. Lapouge, la comunità tradizionale, che vive accanto agli dei, si trasforma in un
corpo sociale, forgiato di sana pianta sul modello dei corpi fisici, dotati delle
leggi semplici e uniformi della fisica scientifica9. Questo regime netto, proprio
dell’immaginazione utopica, si ritrova chiaramente nel modo di vita delle città
ideali. La felicità collettiva, infatti, non si colloca più in una sorta di nicchia
ecologica o in una città celeste spirituale. L’utopista moderno sogna invece una
città costruita a partire da una pianta scientifica e funzionale, fortificata contro
le minacce esterne da numerose difese invalicabili e suddivisa, al suo interno,
in isolati e quartieri separati, specializzati, protetti, per l’igiene e la sicurezza,
da ogni iniziativa individuale. Anche quando lo spazio urbano profano riattualizza nuovamente un paesaggio di tipo edenico (giardino cittadino), si tratta ora
di un luogo chiuso in se stesso, indifferente alle variazioni della vita. Standardizzazione dell’insediamento, sorveglianza delle attività, vincoli delle attività
produttive, interiorizzazione delle medesime leggi da parte di tutti i cittadini,
sono altrettanti indici di un immaginario diurno che separa, irrigidisce, oppone
gli elementi.
L’immaginario dell’utopia moderna si irrigidisce così in una configurazione
unidimensionale e riduttiva, che rifiuta lo spazio delle asimmetrie, delle irregolarità, così come il tempo dei ritorni, dei ritmi molteplici. Come ha mostrato, ad esempio, J. Gabel, l’immaginario utopico è riconducibile a un pensiero
9
Cfr. G. Lapouge, Utopies et civilisations, G. de Montfort, 1998.
Tra caos e razionalità: elementi di ecologia simbolica urbana
219
socio-centrico, bloccato su opposizioni irriducibili e inconciliabili, che de-dialettizzano il tessuto della società complessa, che immobilizzano e atomizzano
un ordine ribelle a ogni vita spontanea, a ogni flusso di eventi, a ogni azione
imprevedibile10. L’immaginazione utopica non è allora disgiunta dalle produzioni appiattite e stereotipate di alcuni disturbi psicopatologici. Non sorprende
quindi che si possano riscontrare, come ha fatto E. Mühlmann, sintomi paranoici in alcuni messia sociali, desiderosi di accelerare l’avvento di un mondo
perfetto, o individuare, come F. Laplantine, sintomi schizofrenici in certi
riformatori ossessivi, che irrigidiscono il sociale in programmi minuziosi.
Saremmo anche tentati dal dire che, lasciando libero corso ad aspirazioni
utopiche, l’uomo occidentale abbia aderito a un quadro sociopolitico devitalizzato, monocorde, magicamente strappato alle forze centrifughe della
differenza e del cambiamento; e, più profondamente, che l’utopia abbia
partecipato a un indebolimento della potenza del sogno, a una decalcificazione della funzione dell’irreale. L’utopia, infatti, non è morbosa perché ci
distoglierebbe dal reale, bensì perché ci condanna a idealizzare prototipi di
socialità e urbanità più poveri del reale stesso.
3- L’architettura poetica e simbolica come metapolitica
Non bisognerebbe forse rinunciare alle utopie spaziali e dar vita a un
urbanismo alternativo simbolico, mitico e sacro? La città non è la copia
mimetica del politico, non è soltanto il laboratorio dei suoi progetti sociali:
essa deve accedere a un’autonomia antropologica, essere il regno dell’abitare, equilibrio del privato e del pubblico, dell’oikos e del cosmos, di Estia
et di Ermes. Se la politica deve rendere possibile la convivenza tra i cittadini, non dovrebbe strumentalizzare l’insediamento, né risolvere i propri
problemi e realizzare i suoi valori (uguaglianza, libertà civica ecc.) tramite
l’abitare. La cittadinanza si basa su una relazione di coesistenza, di conciliazione orizzontale delle libertà e dei diritti; tuttavia, lo spazio urbano deve
consentirci di vivere insieme in uno stesso Ambiente (cosmos), che non sia
soltanto polis. La città deve diventare un mondo differenziato, complesso e
olistico, con il compito di rispondere alle espressioni plurali dell’anthropos
(corpo-anima, intelletto; ma anche razionalità e immaginario, immanenza
e trascendenza), e quindi non si limita a socializzare e a garantire l’accesso
10
Cfr. J. Gabel, La fausse conscience, éd. de Minuit, 1962.
220
Jean-Jacques Wunenburger
alla società politica. La città non si limita a metterci in relazione con gli
altri, ma ci unisce al Tutto cosmico, al visibile e all’invisibile; essa è un medium della sensibilità, dell’immaginazione, del sapere ecc. (sport, onirismo,
biblioteche e templi non si giustificano soltanto con e per la cittadinanza). Il
cittadino è più che un cittadino. Per rendere la città di nuovo abitabile e creatrice di vita, converrebbe quindi
ripensarne lo spazio per adattarlo ai bisogni organici, simbolici e spirituali dei
suoi abitanti. La città umana dovrebbe rispondere meglio – non tramite piani di
sviluppo ecologici – ai bisogni antropologici percettivi, immaginativi e cognitivi
dei suoi abitanti. Sarebbe opportuno reintrodurre, invece della città funzionale
e utopica, per esempio, una spazialità sacra, un « ethos » mitico, forme ed eventi poetici e onirici, istanze di mediazione di senso e di valori.
A tale scopo, non sarebbe il caso di rivalutare e riattualizzare gli immaginari
delle città non utopiche, delle città sognate, che permettono all’immaginazione
di esprimere alcuni bisogni profondi della condizione antropologica in ambiente urbano? La pittura delle città immaginarie diviene così memoria culturale
dell’urbanità umanistica, che non si riduce più ai determinanti socio-economico-politici11. La città ha generato storicamente un ricco e abbondante patrimonio mitico di costruzione e pianificazione degli spazi, che dovrebbero costituire
un patrimonio riutilizzabile per noi urbanisti di oggi. Edificare grandi palazzi
e templi per i Principi e gli dei, dotare di monumenti le grandi funzioni istituzionali (giustizia, esercito ecc.), organizzare le attività economiche e le abitazioni private intorno a un sistema catastale di lotti di terreno ordinati secondo
i punti cardinali, creare grandi spazi vuoti in luoghi traboccanti di case, sono
altrettanti atti immaginativi, invenzioni inedite, che producono nuovi oggetti
da percepire, concettualizzare e immaginare. Le facciate, le strade, le piazze, i
monumenti, le torri, le prospettive e i panorami, le rive, i giardini e le colline,
riuniti in un tutto, fanno della città un dispositivo artificiale che suscita emozioni, visioni, attese, sogni nuovi rispetto all’ambiente di un mondo agrario,
dove gli artefatti costruiti rimangono spezzettati, separati e su scala umana. Gli
architetti della città, dilettanti o pianificatori di Stato, possono trasformare gli
ordini in progetti a geometrie variabili all’infinito. Così, la piazza diventa luogo di incontro del profano e del sacro, del secco e dell’umido, dell’aperto e del
chiuso, dell’alto e del basso ecc. Avendo come scopo la circolazione, lo scambio,
l’aerazione, il raduno, essa funziona anche come soggetto « formiste », a partire
11
Cfr. il nostro studio in La ciutat que mai no existit. Arquitectures fantastiques en l’art
occidental, CCC de Barcelone, 2003.
Tra caos e razionalità: elementi di ecologia simbolica urbana
221
dal quale è possibile sperimentare mille combinazioni possibili, così come un
soggetto narrativo può finire col declinarsi in infinite combinazioni di storie.
Ciascuna unità della forma urbana può giocare il ruolo di modulo, che può essere più o meno isolato o integrato e, in quest’ultimo caso, stabilire relazioni od
opposizioni tra le più svariate con l’ambiente architettonico. Queste saranno,
come ogni opera d’arte più o meno riuscita, estetica, funzionale, razionale o carica di elementi parassitari, o addirittura di misteri, a prima vista inutili.
La città è quindi da sempre mediatrice di immagini, in quanto stimola l’immaginazione, innanzitutto quella del costruttore, che può fabbricare tale o tale
parte in base a una diversità di modelli possibili, e in seguito quella dell’abitante o del viaggiatore, che prolunga la logica e l’equilibrio delle forme tramite
sensazioni, percezioni e rêverie che allargano la sua mente. Le opere di questo
immaginario, siano esse letterarie, poetiche, grafiche o pittoriche, servono così
da archivi o testimoni di questa immaginazione urbanistica, di creazione o ricezione, che illustra la diversità delle città possibili, non ancora realizzate, o
che oggettivizza derivazioni narrative o visuali ispirate a paesaggi urbani reali;
questi paesaggi corrispondono a un certo numero di invarianti e vincoli simbolici, non solamente funzionali o economici o politici, vale a dire razionali..
Gli invarianti che sorgono da tutte le città sognate rinviano certamente a
bisogni profondi e irreprimibili, nel senso in cui la psicologia del profondo rimanda i temi delle rêverie all’esistenza di archetipi psichici, che sarebbero matrici universali destinate a orientare e inquadrare in modo simile le produzioni
di immagini. L’immaginario permette, infatti, in una modalità sensibile, non
razionale, non argomentata, di avvicinarsi alla necessità antropologica di certe forme architettoniche. In questo modo, la piazza non è un semplice luogo
non costruito, ma un vuoto, che ristabilisce la luce solare, apre visioni panoramiche, crea centri di irradiamento, per consentire l’aggregazione di cittadini
disseminati nei loro quartieri pianificati, per ricreare in maniere cinestetica
l’essere-insieme. All’inverso, una città senza recessi, senza nicchie, senza spazi
oscuri, non potrebbe soddisfare i bisogni di solitudine che coesistono col bisogno sociale di vedere ed essere visti. L’architettura urbana ideale valorizza così
spazi di separazione, di inatteso isolamento (vicoli ciechi, stradine, panchine
sotto un albero ecc.) che offrono occasioni per l’intimità, il segreto, il microscopico. L’iconografia di arcate e gallerie non testimonia soltanto l’ingegnosità di
architetti che hanno trovato una soluzione per mettere passanti e acquirenti al
riparo dalle intemperie, ma testimonia anche la misteriosa attrazione per forme architettoniche miste, che materializzano la continuità tra il dentro e il fuori, tra ciò che è esposto e ciò che è protetto, a cavallo tra la piazza e la caverna.
222
Jean-Jacques Wunenburger
Le gallerie aperte sulla strada (come quelle di Bologna) costituiscono in questo
modo spazi in cui convivono l’arte della casa (con le sue facciate) e quella delle
arcate monumentali, in un nuovo insieme dove il sedentario e il nomade, il residente e il viaggiatore sono molto vicini tra loro. La pittura urbana dei secoli
scorsi ci ricorda anche come l’elevazione nelle città non sia soltanto una risposta utilitaria per guadagnare spazio, bensì una maniera stilistica e simbolica
per aprire l’orizzontalità dell’aggregazione umana su una trascendenza, quella
del potere umano (campanile, torre campanaria, torre di guardia) o dell’onnipotenza divina (cattedrale, moschea). La città infatti, che condensa il molteplice, deve anche portare i segni della sua unità, che proviene dall’alto. I paesaggi
urbani, popolati di colonne, torri, punte, costituiscono così l’immagine di una
gerarchia dove le funzioni triviali della sussistenza e della coesistenza sono subordinate a istanze superiori, quelle delle autorità, della doppia sovranità regale e sacerdotale, oggi rimpiazzate dai grattacieli, immagini dei nuovi poteri
della società del commercio. Insomma, l’estetica ornamentale delle facciate,
tramite l’incastro dei pieni e dei vuoti e lo sbalzo di cornicioni sofisticati, indica
che le forme architettoniche non possono ridursi a superfici e angoli, ma che la
pietra guadagna a essere tagliata, scolpita, messa in rilievo e traforata per formare composizioni geometriche, che « frattalizzano » e ricapitolano in qualche
maniera l’ordine complesso della città intera. I primi piani pittorici sui dettagli
decorativi di colonnati e frontoni, che spesso formano, da soli, dei quadri, ricordano come la città abbia bisogno di ordine estetico, poiché i giochi gratuiti
di decorazione delle pietre funzionano per l’occhio e la memoria come simbolo
della perfezione complessa del tutto e della vittoria della volontà, del lavoro,
della ragione sul disordine spontaneo delle cose.
L’arte delle rappresentazioni, idealizzazioni e mitizzazioni urbane testimonia quindi le potenzialità estetico-simboliche di alcune disposizioni, in realtà
poco utilizzate nella storia concreta delle città. L’arte diventa così laboratorio
di esplorazione di innovazioni e valorizzazioni oniriche di realtà architettoniche che spesso non hanno avuto seguito, ma che potrebbero soddisfare bisogni
e attese arcaiche. Così, numerose disposizioni atipiche, rare o marginali, che
hanno sedotto i pittori urbani, ci potrebbero indicare soluzioni urbanistiche dal
forte valore aggiunto, che potrebbero forse rivoluzionare l’arte della convivenza
in città. Il fascino immaginario che rivestono città come Bruges o Venezia, due
utopie realizzate, suggerisce per esempio come le città acquatiche potrebbero creare un benessere urbano, combinando pietra e acqua, e sostituendo alle
automobili la barca. Creare case lungo i canali, o aprire una casa su un canale
costituirebbero opzioni tecniche dai forti vincoli tecnici ed economici, certa-
Tra caos e razionalità: elementi di ecologia simbolica urbana
223
mente, ma genererebbero un altro «essere al mondo» del cittadino. Allo stesso
modo, la frequenza artistica delle costruzioni a cupola e a volta non indica soltanto il peso delle tradizioni religiose, ma potrebbe suggerirci che queste forme
rotonde, inglobanti, nel senso proprio ammalianti, collocano un sublime nel
quotidiano, incurvando e smussando le forme che intersecano il basso dall’alto
(soffitto, tetto). In maniera più familiare, l’onnipresenza di fontane e giardini
ricorda come l’architettura urbana, per via del suo rinchiudersi nell’artificiale,
non potrebbe escluderci dalla nostra appartenenza vitale alla natura12. L’arte ha
così, per lungo tempo, anticipato, confortato, legittimato la creazione di spazi
verdi nel cuore delle città. L’intreccio tra vegetale e terreno edificato dà luogo a
molti tentativi di composizione nelle nuove città ma che, forse, soddisfano solo
raramente il senso paesaggistico dei giardini che gli artisti hanno progettato e
valorizzato nei loro quadri.
In questo modo, la libera esplorazione delle immagini di città, parziali o
globali, lungi dal ridursi a un esercizio di fantasia, può obbligarci a entrare in
una nuova fenomenologia ed ermeneutica urbana. L’immagine permette appunto di rompere con i dati di fatto, di resistere alle pretese necessità storiche,
di trasgredire le abitudini e le norme. Lungi dall’essere mimetica, l’immagine
paesaggistica della città permette di entrare in uno spazio per metà oggettivo e
per metà soggettivo, in una relazione di non-separazione tra soggetto e oggetto,
vale a dire tra l’uomo e il suo ambiente urbano. L’immagine è innanzitutto la
risultante di una fenomenologia dell’ “essere al mondo”, che coglie e concentra
i bisogni e i desideri dell’abitazione, nel senso del radicamento in un mondo artificiale. Essa apre poi la strada a un approccio ermeneutico, che induce a non
prendere l’immagine alla lettera (il che è spesso irrealistico, se non addirittura
assurdo), bensì a coglierne lo spirito. Se leggiamo e rileggiamo bene, guardiamo e riguardiamo l’immagine fantastica, ci si rivela allora un’altra intelligenza
dei luoghi, delle forme, degli spazi e dei volumi, che ci potrebbe consentire di
guardare con occhi diversi la nostra arte di vivere la città. Nell’immagine fantastica si potrebbe vedere perfino una sorta di scienza visionaria dell’ideale di
una città (più che delle città ideali, troppo abbandonate alle pulsioni e all’irrazionalità), vale a dire della forma più compiuta possibile, dal punto di vista
dell’uomo, di ciò che potrebbe essere lo spazio, costruito in accordo con i suoi
bisogni topologici. L’immaginario opera così una sorta di ritorno all’originario,
all’arcaico, a quei bisogni elementari dell’ “essere al mondo” e dell’abitare, che
12
Cfr. C. Younes-Th. Paquot (éd.), Philosophie, ville et architecture. La renaissance des quatre éléments, La Découverte, 2002.
224
Jean-Jacques Wunenburger
agisce come nutrimento spirituale, una riserva di possibili da costruire o ricostruire, e infine un aiuto alla decisione per tutti i responsabili della nostra arte
di vivere nello spazio. Le città sono così punti di arrivo per progetti tecnici, ma
anche punti di partenza per l’immaginario. La città, del passato o del futuro,
diventa uno spazio di accoglienza di sogni e frustrazioni, sullo sfondo di una
nostalgia di qualcosa che si è perduto per sempre. La città, oggetto di pulsioni
contraddittorie verso le origini perdute e verso un futuro inaccessibile, costituisce davvero un mondo di transizione tra il reale e l’irreale.
La città « eutopica » come condizione del politico
È all’interno di una totalità differenziata che potremo ricongiungerci meglio
con gli altri13. La città pacificherà i suoi abitanti quando essi troveranno nel
suo spazio una realizzazione spirituale. Quando ognuno sta “bene nel mondo”,
il mondo in comune diviene fonte di felicità. Quando l’uomo sarà integrato
in questa città, microcosmo del mondo, si ritroverà pienamente suo membro.
L’architettura e l’urbanistica simbolica, trattando l’uomo su un piano metapolitico, contribuiscono in definitiva a un’armonizzazione della polis, ma senza i
suoi propri mezzi (ordine, ragione, trasparenza). La kallipolis (città bella) diventa la condizione dell’agathos polis.
Tali prospettive pratiche aiuterebbero forse la città a non cedere di fronte
al caos delle attuali megalopoli, di cui la politica ha perso il controllo e che
diventano focolai ansiogeni, ma anche a non essere preda di una razionalità
utopica, due fattori che costituiscono altrettanti destini mortiferi per ogni città.
Pensando una vera urbanizzazione antropo-cosmica, si eviterebbe di consegnare la gestione dello spazio alla razionalità tecnocratica, statalista, politica, e si
renderebbe, al tempo stesso, questo spazio simbolico compatibile con la realizzazione della politica come essere-insieme.
13
O. Mongin, Vers la troisième ville, Hachette, 1995.
La concezione dell’Islam nelle Lezioni sull’Estetica di Hegel
225
La concezione dell’Islam
nelle Lezioni sull’Estetica di Hegel
Memoria di Lorella Ventura
presentata dal socio naz. ord. res. Giuseppe Cantillo
(Seduta del 26 giugno 2008)
Abstract. Hegel’s view about Islam is expressed mainly in his Berlin’s Lectures, because while he was in Berlin his knowledge of the extra-european countries pointedly
increased. In Hegel’s Aesthetics the Islamic art is mainly represented by Arabic and Persian poetry. Hegel’s opinion about them is very positive. In particular in persian poetry
(“pantheism”) he appreciates the capability of seeing the whole finitude as an image and
a part of the Absolute, with many similarities to his speculative philosophy. He appreciate also Arabic poetry and “character”, because of its autonomy, individual freedom.
From this point of view, Islam sometimes appears to be closer to Hegel’s philosophy than
Romanticism and the “philosophy of intellect”. The comparison between Persian and
Romantic poetry, for instance, shows on the side of Islam a kind of “theoretical freedom”
and happiness and on the other side an unsatisfied individual who is self-centered and
thus constantly unhappy.
1. Le Lezioni del periodo berlinese
Hegel ha iniziato ad interessarsi di Oriente e di mondo extra europeo negli
ultimi anni della sua vita, con grande passione. Questo interesse e il progressivo
arricchimento delle sue conoscenze si rispecchiano nei corsi di lezione del periodo berlinese, grazie anche alla recente edizione critica. La visione dell’Islam
che ne emerge non è statica, né univoca, ma presenta una serie di sfaccettature
che restituiscono l’immagine di un oggetto complesso, oltre che di un materiale
vastissimo da gestire. Vi sono diversità diacroniche, successive trasformazioni,
ma anche diversità dovute alla differenza degli ambiti tematici oggetto di lezione.
Prima di passare all’analisi dettagliata delle Lezioni sull’Estetica, dunque, traccerò un breve panorama dei concetti relativi al fenomeno Islam che emergono negli
altri ambiti: filosofia della storia, storia della filosofia e filosofia della religione.
Nelle Lezioni sulla filosofia della storia l’Islam appare come “fanatismo”
* Nel corso del testo saranno adottate le abbreviazioni indicate nella Bibliografia.
226
Lorella Ventura
dell’Uno astratto, che è insieme causa di successi senza eguali e di instabilità. Qui Hegel si occupa delle vicissitudini dell’Islam storico, da Muhammad
attraverso il califfato fino agli Ottomani, legando quella che vede come una
grande mutevolezza nelle fortune di individui e regni, alla caratteristica intrinseca dell’Islam, vale a dire alla sua astrattezza. Come religione, l’Islam non
arriva al livello del cristianesimo proprio per la sua concezione di Dio come
astratto, come Uno, che lascia fuori del sostanziale l’individuo e anche la processualità e la storia, diversamente dalla concezione trinitaria cristiana. La
mancata compenetrazione di individuo e sostanziale è la causa di tanti dei
mali del mondo musulmano, nel quale vi sono però anche elementi positivi,
tra i quali la nobiltà della cavalleria, la poesia e la possibilità che vi siano individui “estremi” sia nel bene che nel male. L’Islam non fa parte del mondo
orientale, ma rappresenta una “rivoluzione” per l’Oriente (che è legato ancora
ad elementi esteriori) ed è collocato all’interno della trattazione del mondo
cristiano-germanico. Questo elemento della “rivoluzione”, insieme all’esigenza
di realizzare nel mondo Dio pensato come astratto Uno, fa pensare alla rivoluzione francese così come è letta da Hegel nella Fenomenologia dello spirito.
Questo accostamento è suggerito anche dallo stesso Hegel, in diversi punti,
anche se mai trattato esplicitamente. è però già sufficiente per mostrare che
la valutazione dell’Islam da parte di Hegel è sostanzialmente positiva, come si
riscontra anche nelle altre Lezioni.
Nelle Lezioni sulla storia della filosofia Hegel afferma che la filosofia araba,
come anche la scolastica, è interessante solo dal punto di vista storico. Sottolinea, quindi, il ruolo di mediazione degli Arabi e degli Ebrei tra il sapere greco
e il mondo occidentale, citando brevemente alcuni dei principali pensatori del
mondo musulmano medievale, considerati prevalentemente nel loro ruolo di
“commentatori” di Aristotele. Egli entra anche nel dettaglio di quella che considera la “filosofia araba” e i cui tratti fondamentali ricava dalla descrizione (critica) di Maimonide1 di alcune dottrine dei teologi del kalām, identificandoli con
la “filosofia araba” nel suo complesso. L’idea di fondo che ogni cosa potrebbe
essere in altro modo se e quando Dio lo volesse è vista da Hegel come spinoziana, orientale, panteistica proprio perché sottopone l’individuo ad una necessità
estranea e soprattutto fa sparire il mondo di fronte a Dio. La filosofia araba si
mostra così nel suo carattere “medievale” ed è accostata alla scolastica: ambe-
1
Moses Maimonides, Liber More novochim. Doctor perplexorum […] in linguam latinam
perspicuè & fideliter conversus, à Johanne Buxtorfio, Fil. Basileae 1629 (nella biblioteca di Hegel). Trad. it. a cura di M. Zonta, La guida dei perplessi, Utet, Torino 2003.
La concezione dell’Islam nelle Lezioni sull’Estetica di Hegel
227
due mancano di separare filosofia e fede.
Nelle Lezioni sulla filosofia della religione l’Islam è pressochè assente tra le
religioni storiche è citato nella trattazione dell’Ebraismo e presentato come una
sua universalizzazione, oppure è paragonato alla religione dell’intelletto. Questo accostamento, molto interessante, è presente in maniera esplicita solo nel
corso di lezioni del 1824, ma in maniera meno evidente richiamato anche in altri luoghi (non solo nelle Lezioni sulla filosofia della religione). Il punto è l’astrattezza dell’idea di Dio e il suo rapporto col finito. In un certo senso Hegel suggerisce che l’Islam sia superiore, perché in esso non si mette al centro di tutto
l’individuo singolo; d’altra parte, la libertà individuale è un elemento essenziale
del mondo moderno e passaggio obbligato per arrivare allo spirito, quindi Hegel finisce per recuperare queste posizioni, che per un altro verso critica2.
Troviamo anche un riferimento a Gialāl ad-Dı̄n Rūmı̄ a proposito del panteismo. Rūmı̄è richiamato esplicitamente anche nell’Enciclopedia, dove Hegel polemizza contro l’accusa che si rivolge alla filosofia, di sostenere che l’essere delle
cose mondane sia Dio, che “Dio sarebbe perfino tutto, e tutto sarebbe Dio”3.
Questo non è un “panteismo”, ma una visione che nessuno ha mai seriamente
sostenuto. Hegel si volge ad Oriente e mostra che questo tipo di posizione non
si trova neanche nel panteismo indiano, che considera “grossolano”, e tantomeno in quello musulmano. Se si vuole avere un esempio della coscienza dell’Uno
“nella più bella purezza ed elevatezza”, infatti, bisogna rivolgersi ai musulmani
e in particolare a Rūmı̄, dove “vien messa in rilievo l’unità dell’anima con l’Uno,
e anche questa unità come amore; siffatta unità spirituale è un’elevazione sul
finito e sul volgare, una trasfigurazione della naturalità e della spiritualità, nella quale ciò che v’ha d’estrinseco e di transitorio nella natura immediata come
nello spirito empirico e terreno, viene sceverato e assorbito”4. Non c’è identificazione di Dio con il mondo, la divinizzazione del mondo; così come nelle filosofie eleatica e spinozistica, che non attribuiscono verità al mondo e sono più
che altro “acosmismi”. Il difetto comune a tutti questi sistemi è che essi concepiscono l’assoluto solo come sostanza e non arrivano a pensarlo come soggetto
2
Cfr. K. Rosenkranz, p. 394. A proposito del rapporto di Hegel alla mistica persiana, afferma: “gli era infinitamente congeniale in quanto dissolveva il soggetto in semplice accidente
della sostanza fornito di un sentimento affermativo della propria esistenza e procedeva seriamente sulla strada del panteismo, senza ritegno, senza imbarazzo, senza malinconia, senza
riluttanza a sacrificarsi al Tutto”, aggiungendo poi che questo non significa che Hegel avesse
abbracciato il panteismo, ma “è invece vero il contrario, in quanto egli non si stancò di rimproverare all‘oriente la mancanza di libertà soggettiva”. Cfr. anche Schulin (1998), p. 183: nella
poesia musulmana Hegel ritrova la sua filosofia in forma immediata.
3
Enc. § 573, p. 518.
4
Enc. § 573, p. 522.
228
Lorella Ventura
e come spirito. Si profila però anche una differenza tra sostanza spinoziana e
Uno musulmano: nelle rappresentazioni orientali, e specialmente musulmane,
“l’assoluto appare come il genere assolutamente universale, che dimora nelle
specie, nelle esistenze, ma in modo che a queste non spetta realtà effettiva”5.
Possiamo pensare che, nel superare ciò che c’è di transitorio nel mondo e nello
spirito terreno, rimanga un elemento di determinatezza-individualità (ad esempio nell’anima che si unisce a Dio), di soggettività, per quanto ancora “debole”,
che manca alla visione spinozistica o indiana. Si evidenzia, così, quel carattere
“positivo” del “panteismo” persiano che si vedrà anche nell’Estetica.
Nell’accusa di panteismo rivolta alla filosofia si uniscono la “pietà” (la teologia pietistica è qui rappresentata in particolare da Tholuck) e la “vuota” filosofia intellettualistica, che pretendono di essere opposte, ma in definitiva sono
molto simili poiché usano gli stessi strumenti concettuali, che gli permettono al
massimo a concepire l’identità di finito e infinito come identità indifferenziata,
e partono dallo stesso presupposto dell’indeterminatezza e dell’inconoscibilità
di Dio.
2. Il contesto e le fonti della visione hegeliana dell’Islam
Gli scritti di Hegel e in particolare le Lezioni berlinesi si estendono per un
lungo arco temporale e partecipano delle tensioni e dei fermenti culturali del
tempo. Hegel non si sottrae alla discussione e alla polemica, in ogni campo.
Si è già detto della polemica sul panteismo e sulla filosofia di Spinoza, della
critica al deismo illuminista, del giudizio sulla rivoluzione francese. L’Oriente
in generale si riaffaccia anche nel confronto con Schlegel, Humboldt e Jacobi,
sotto forma di “India”, per diventare fulcro di argomentazioni storiografiche,
linguistiche, morali, teoretiche. Così come i popoli extraeuropei, in particolare
gli africani, si prestano a offrire lo spunto per un argomento tipico di Hegel
contro l’idealizzazione dello stato di natura, che egli considera uno stato di ingiustizia assoluta.
Pur con tutte le limitazioni di prospettiva e di approfondimento delle conoscenze, Hegel si è quindi a più riprese e da più punti di vista imbattuto nel
mondo culturale extraeuropeo e si è tematicamente occupato del mondo orientale ed anche dell’Islam. Egli ha certamente fatto una serie di letture dirette, ma
in primo luogo è venuto a contatto con quelle nozioni sull’Oriente musulmano
che “circolavano” negli ambienti colti e scientifici del suo tempo, attraverso i
5
Enc. § 573, p. 524.
La concezione dell’Islam nelle Lezioni sull’Estetica di Hegel
229
racconti dei viaggiatori e dei missionari, la letteratura, l’opera lirica. Un Oriente
che era da un lato immaginato e dall’altro sempre meglio conosciuto e questa
migliore conoscenza si ripercuoteva a sua volta sull’immaginazione. Hegel era
un fruitore di queste sempre nuove informazioni e rappresentazioni, accrescendo vistosamente le sue conoscenze fino ad essere in grado di parlarne con una
certa cognizione di causa. Le fonti forniscono immagini, valutazioni e anche
dati storici. Da parte di Hegel vi è, come per altri argomenti, una rielaborazione, anche nei casi in cui l’aderenza ai “dati” oppure la somiglianza a posizioni
di altri autori risultino massime.
Tra gli autori più significativi figurano Goethe, Voltaire, Herder. Goethe in
particolare con il suo West-östlicher Divan con le importanti Noten und Abhandlungen; Voltaire con il suo Essai sur les moeurs et l’esprit des nations et sur les
principaux faits de l’histoire depuis charlemagne jusqu à Louis XIII, oltre che nel
celebre Le fanatisme ou Mahomet le Prophète del 1741. Herder nelle Ideen zur
Philosophie der Geschichte der Menschheit, così come anche in Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit e in Vom Geist der Ebräischen
Poesie, solo per fare alcuni esempi. Vanno inoltre ricordati gli illuministi in generale, che senza dubbio hanno contribuito a creare una certa “atmosfera” e conoscenza diffusa. L‘immagine dell‘Islam, infatti, cambia vistosamente alla fine
del ‘600 e inizi ‘700, con figure come Reland, Ockley, Boulainvilliers, per poi arrivare a Montesquieu, Rousseau, Lessing. Uno dei fattori fondamentali di questo mutamento è interno, vale a dire la polemica contro il fanatismo cristiano e
in favore della tolleranza religiosa. Nel campo dell‘orientalistica vera e propria
e delle traduzioni spicca la figura di J. von Hammer-Purgstall (1774-1856), austriaco, formatosi nell‘Accademia orientale di Vienna. La sua rivista “Fundgruben des Orients”6, che si avvale di collaboratori molto importanti, tra i quali anche Eichhorn e Von Diez, in Germania apre la strada agli studi sull’Oriente islamico. Tra le sue opere principali, oltre a studi sull’Impero Ottomano7, vi sono la
traduzione del Divan di Hā fez8, posseduta da Hegel e la traduzione dell’‘Antar,
di cui Hegel parla. Sembra che Hegel non avesse presenti, invece, la sua traduzione dello Shāhnāme di Firdusi e la raccolta di poesia persiana Geschichte der
6
Fundgruben des Orients bearbeitet durch eine Gesellschaft von Liebhaber, I-VI, Wien
1809-18.
7
Des osmanischen Reiches Staatsverfassung, Wien 1813; Geschichte des Osmanischen Reiches, großentheils aus bisher unbekannten Handschriften und Archiven, 10 voll., Pesth, Hartleben 1827-35. Secondo Bonacina (2003), importante fonte storica sull‘Impero Ottomano è
anche The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 12 Bde, Fleischer, Leipzig 1821
di Gibbon, che Hegel possedeva.
8
Mohammed Schemsed-din Hafis. Der Diwan. Aus dem Persischen zum erstenmal ganz
übersetzt von Joseph von Hammer-Purgstall, 2 Bde, Stuttgart und Tübingen 1812-1813.
230
Lorella Ventura
Schönen Redekünste Persiens (Wien 1818). Altre fonti importanti per quanto
riguarda le traduzioni sono F. Rückert e J. Görres. Da Rückert Hegel prende tra
l’altro le traduzioni delle opere di Rūmı̄ 9 e delle Maqāmā t di Harr e da Görres
la traduzione parziale dello Shāhnāme di Firdusi10. Altra figura di orientalista
molto importante per Hegel è William Jones, in particolare la rivista Asiatic Researches, che, pur essendo incentrata sull’India, trattava anche le altre culture
asiatiche e ospitava i lavori più significativi degli orientalisti inglesi, come W.
Jones stesso, F. Wilford, H.T. Colebrooke11. Anche il teologo Tholuck, oltre ad
essere oggetto delle critiche sopra ricordate, a dire dello stesso Hegel gli ha fornito utili notizie storiche12. Un discorso a parte va fatto per la conoscenza della
filosofia “araba” (o meglio “islamica”) medievale, per la quale Hegel ricorre ad
opere di storia della filosofia contemporanee13, oltre che alla Guida dei perplessi
di Maimonide. Infine, delle fonti molto importanti sono costituite dai resoconti
di viaggio e dalle opere dei geografi14, a sottolineare ancora una volta il desiderio di recepire informazioni, anche se poi queste spesso non venivano trattate
con il senso critico che oggi ci aspetteremmo.
9
Mewlana Dschelaleddin Rumi, in “Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1821”, Tübingen
1821.
10
Heldenbuch von Iran, aus dem Schah Nameh des Firdussi, 2 Bde, Berlin 1820.
11
Asiatic Researches or, Transactions of the Society Instituted in Bengal for inquiring into the
History and Antiquities, the Arts, Sciences, and Literature, of Asia, Bde 1-11, London 1806-1812
- ristampa dell’edizione Calcutta 1788. Cfr. Hulin, p. 221. Importante anche Poesos Asiaticae
commentariorum libri sex, Lipsiae 1774 (1777 riedizione di Eichhorn).
12
Cfr. Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, parte prima, a cura di V. Verra,
UTET, Torino 1981, pp. 89-107 (prefazione alla seconda edizione, 1827) e Enc. § 573 nota 12,
p. 524. Tre sono i lavori di Tholuck citati da Hegel: Blütensammlung aus der morgenländischen
Mystik, nebst einer Einleitung über Mysthik überhaupt und Morgenländisches insbesondere, Berlin 1825; Die Lehre von der Sünde und Versöhner, oder die wahre Weihe des Zweiflers, seconda
edizione Hamburg 1825; Die spekulative Trinitätslehre des späteren Orients, Berlin 1826.
13
J. Brucker, Historia critica philosophiae, Tomi I-IV, Lipsiae 1742-1744 (Hegel possedeva
l’edizione del 1756). J. G. Buhle, Geschichte der neuern Philosophie seit der Epoche der Wiederherstellung der Wissenschaften, 6 Bde, Göttingen 1800-1804; Lehrbuch der Geschichte der
Philosophie und einer kritischen Literatur derselben, 8 Bde, Göttingen 1796-1804. W. G. Tennemann, Geschichte der Philosophie, 11 Bde, Leipzig 1798-1819; Grundriss der Geschichte der
Philosophie für den akademischen Unterricht, 4. vermehrte und verbesserte Auflage oder 2.
Bearbeitung von Amadeus Wendt, Leipzig 1825. D. Tiedemann, Geist der spekulativen Philosophie, 6 Bde, Marburg 1791-1797 (Hegel possedeva i voll. 1-3).
14
Ad esempio C. Ritter (Die Erdkunde im Verhältnis zur Natur und zur Geschichte des Menschen, oder Allgemeine vergleichende Geographie als sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physikalischen und historischen Wissenschaften, 2 Bde, Berlin 1817-18) o J. Bruce
(Travels to discover the source of the Nile in the Years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 and 1773,
Edinburgh senza data).
La concezione dell’Islam nelle Lezioni sull’Estetica di Hegel
231
3. L’Islam nelle Lezioni sull’Estetica15
La bellezza artistica è un’estrinsecazione e rappresentazione del vero per
l’intuizione sensibile: fine dell’arte è, infatti, la raffigurazione sensibile dell’assoluto ed essa è al grado più basso del percorso di autocomprensione dello spirito
che include anche religione e filosofia. Così, lo sviluppo dell’arte dipenderà non
solo dal grado di corrispondenza e compenetrazione tra il contenuto e la forma,
in termini di adeguatezza, ma anche dal contenuto stesso, dall’idea che un popolo (del quale l’artista fa parte) ha di volta in volta dell’assoluto. Il “vertice” è
rappresentato dall’idea, la soggetto-oggettività, l’assoluto pensato come spirito.
L’inizio dell’arte è connesso con la religione, perché essa è la prima interprete
delle rappresentazioni religiose, prima del momento “prosaico”, distaccato. Ma
perché vi sia vera arte c’è bisogno che la coscienza produca da se stessa sia la
propria concezione dell’assoluto sia il lato oggettivo dell’unione con l’esistente: all’arte è intrinseco un contenuto sostanziale, che è colto dallo spirito in
un’esteriorità prodotta dallo spirito (non nell’esteriorità immediata della natura
o nei feticci). Lo stretto legame tra arte e religione è mostrato anche dal fatto
che Hegel le ha quasi sempre trattate insieme, dallo scritto sulla Differenza del
1801 fino alla religione artistica (Kunstreligion) della Fenomenologia dello spirito e dell’Enciclopedia di Heidelberg del 1817, separandole poi quando tenne il
suo primo corso di Filosofia della religione (1821)16.
15
Hegel ha tenuto dei corsi di estetica a Heidelberg nel 1818 e a Berlino nel 1820-21, 1823,
1826, 1828-29. Le Lezioni di Estetica sono il frutto dell’elaborazione, da parte del discepolo e
storico dell’arte Hotho (1802-1873), delle Nachschriften degli uditori e del manoscritto di Berlino, usato da Hegel come base per le lezioni. Hotho dichiara di avere trascurato il manoscritto
di Heidelberg, perchè distante dalle lezioni di Berlino (e più vicino all’Enciclopedia del 1817).
Attualmente si sta procedendo alla pubblicazione separata dei diversi quaderni degli uditori.
Si hanno a disposizione pochi appunti di Hegel di Heidelberg e Berlino, la Nachschrift di von
Aschenberg del corso del 1820-21 e quella di Hotho del 1823, molto più materiale per i corsi
del 1826 e del 1828-29. Vi sono vistose differenze nella sistemazione, prima fra tutte la suddivisione complessiva, che da due parti (le forme dell’arte erano incluse nella prima) passa a tre
nel corso del 1828-29. Questa suddivisione è ripresa da Hotho, che è dunque costretto a spostamenti. Vi sono inoltre modifiche nella sistemazione dell’arte simbolica, che riguarda proprio
l’Oriente, soprattutto perché le conoscenze di Hegel si sono accresciute. Resta da vedere (ed è
infatti oggetto di dibattito) se queste modifiche siano importanti dal punto di vista della teoria
generale o siano solo degli accrescimenti dei contenuti e degli aggiustamenti più che altro
formali in un percorso con delle tappe dal significato storico-spirituale ben preciso.
16
Cfr. Schneider (1991) e Kwon (1992), che si confronta con Schulin (1998). Si veda anche
Cantillo (1996), che mostra due eccezioni rilevanti: nella filosofia dello spirito della Jenaer Realphilosophie del 1805-6 e nell’Enciclopedia filosofica di Norimberga del 1808 arte e religione
sono separate, come poi sarà dalle lezioni berlinesi in poi. Sul significato da attribuire a questo
mutamento di forma non vi è accordo tra gli studiosi.
232
Lorella Ventura
Hegel nelle lezioni di Berlino distingue tre diverse forme di arte, secondo il
grado di “sviluppo” dell’idea e il conseguente rapporto che si instaura tra l’idea
e la sua raffigurazione. In questo caso non si tratta di un progresso, poiché la
forma più alta, perfetta, si realizza nell’arte classica, non in quella romantica17.
La prima forma è quella simbolica, che caratterizza i popoli orientali. L’idea è
ancora priva di chiarezza, dispersa nell’esteriorità alla ricerca del senso e per
questo la sua espressione artistica rimane una ricerca di raffigurazione, uno
sforzo verso la forma, che si esprime nel simbolo. La seconda è quella classica,
fiorita in epoca greco-romana. L’idea, che è arrivata a cogliersi come libera soggettività infinita, spirito, trova la sua espressione adeguata nella figura umana.
L’arte qui raggiunge la sua perfezione, ma questo contenuto, nato dal rapporto
di armonia immediata tra individuo e stato in Grecia, tramonta quando questa
situazione cambia e l’individuo non si ritrova più immediatamente nell’universale. La libertà e il valore del soggetto sono il nuovo contenuto, che si è affermato nel cristianesimo e ha bisogno di una nuova forma di espressione. La forma
d’arte romantica ha come contenuto l’interiorità soggettiva. Questo significa
anche una mancanza di oggettività, necessità, che fa sì che l’arte abbia perso il
suo ruolo di espressione immediata della verità. Epoche e popoli precedenti vi
trovavano perfettamente espresso il sostanziale, vissuto immediatamente come
il vero e il divino, ma il mondo moderno non conosce più questa immediatezza
e in questo senso l’arte ha il carattere di un passato. Questa la nota tesi della
cosiddetta “morte dell’arte”, che trova il suo senso se compresa da questa prospettiva e si collega anche alla funzione della mitologia (di qui l’interesse principale di una eventuale attribuzione a Hegel del Primo programma di sistema
dell’idealismo tedesco).
4. L’arte simbolica e le sue variazioni nei diversi corsi
Il simbolo è l’inizio dell’arte, in qualche modo solo pre-arte rispetto all’autentica realtà dell’ideale che è la forma d’arte classica. Esso è un’esistenza esterna immediatamente data all’intuizione, ma che deve essere presa in senso più
ampio e universale. A differenza del segno, nel quale il legame tra significato
ed espressione è arbitrario, indifferente, il simbolo non ha questa indifferenza, poiché l’arte consiste proprio nella relazione e nella “concreta compene17
Cfr. Cantillo (1996), p. 144: “Lo spirito artistico, per Hegel, non segue nella sua storia il
tragitto del progresso, ma segue piuttosto l’opposto tragitto del regresso e della decadenza”.
Questo è più evidente nella Filosofia dello spirito jenese, dove sono solo l’arte classica e romantica e non quella simbolica.
La concezione dell’Islam nelle Lezioni sull’Estetica di Hegel
233
trazione reciproca di significato e forma”18. Il simbolo non deve essere del tutto inadeguato al suo significato, ma neanche completamente corrispondente.
“Da qui deriva che il simbolo, secondo il suo concetto, rimane essenzialmente
ambiguo”19. Dunque, un’immagine che ha un significato è chiamata simbolo
solo se questo significato non è espresso (come nel paragone) o non è già chiaro; nonostante l’indeterminatezza, il simbolo è però chiaro per abitudine a chi
si trova entro una determinata cerchia di rappresentazioni convenzionali, invece crea difficoltà a chi voglia interpretarlo dal di fuori. L’arte del mondo orientale è così arte simbolica, caratterizzata dal contrasto incessante fra adeguatezza e inadeguatezza di significato e forma. Ma soprattutto vi è il contrasto tra
il contenuto qui espresso e quello della “vera” arte, perché l’assoluto è ancora
pensato come sostanza e non come soggetto, come sarà nella plasticità dell’arte
greca e poi in quella romantica20. Dunque nell’arte simbolica i lati sono uniti,
ma in una unificazione insufficiente, poiché è la stessa concezione dell’assoluto
a non permettere di pensarlo come “soggetto”, cioè come dispiegato e vivente
nelle differenze, nel sensibile, nella singolarità. D’altro canto, anche l’arte romantica soffre di inadeguatezza tra contenuto e forma, ma con accentuazione
del momento soggettivo, a scapito del sostanziale.
Diversamente dalla trattazione dell’arte classica, quella dell’arte simbolica
subisce profonde trasformazioni tra un corso e l’altro, sia dal punto di vista
dell’organizzazione formale che del progressivo arricchimento dei contenuti.
Nella partizione interna dell’arte simbolica vi sono differenze vistose: dalla partizione in tre sezioni del 1820-21 e 1823, infatti, si passa a quella in quattro del
1826 e a quella in cinque del 1828-29. Hotho ha mantenuto la tripartizione dei
primi due corsi, ma con i contenuti degli ultimi due corsi.
Nel corso del 1820-2121 la forma d’arte simbolica è tripartita: 1) il “primo
grado” del simbolico (la Natursymbolik), nella quale include Persia, India, Egitto (in particolare la personificazione delle tre divinità principali Iside, Api, Osiride). Tra i tre momenti Hegel non ha ancora sviluppato differenze fondamen-
VAe I, p. 395; Estetica, p. 344.
Ivi, p. 397; ivi, p. 346. Cfr. D’Angelo (2000), pp. XXII-XXIII: la caratterizzazione del
simbolo attraverso l’ambiguità, la non perfetta adeguazione di forma e contenuto, distingue
Hegel da Schelling e Goethe.
20
Più che l’idea di un Dio personale, è la concezione del ruolo del finito e del singolo
nell’assoluto a fare la differenza. Si veda ad esempio Sul famoso episodio del Mahā bhārata, p.
165, la vuotezza di contenuto fa sì che Brahma sia una mera personificazione: “Brahma rimane, secondo la sua interna determinazione, l’essere astratto, l’universale, la sostanza priva in sé
di soggettività; non è perciò il concreto, né lo spirito”.
21
Per questo corso e di quello del 1828-29 mi rifaccio in particolare a Kwon (1992) e
D’Angelo (2000).
18
19
234
Lorella Ventura
tali; 2) la “vera simbolica”, nella quale tratta l’arte egizia da un punto di vista
più generale; 3) il grado dell’esser altro del significato e dell’espressione o la
simbolica nella sua particolarità. In questo corso Hegel non tratta del sublime
all’interno dell’arte simbolica, ma nell’arte classica.
Il corso del 1823, dove si ha la tematizzazione del nesso tra simbolico e mitologia, è di nuovo tripartito, ma in modo diverso dal precedente: 1) il simbolo
in generale e Persia, India, Egitto; 2) il sublime: con esempi dalla poesia sacra
degli Ebrei e una citazione veloce degli Arabi, ma senza panteismo dei Persiani
(di persiano citato solo Firdusi in un altro punto22); 3) il paragone. “Sublime”
è anche la poesia sacra indiana e sono definite “panteismo” sia la religione dei
Parsi, sia quella indiana.
Nel corso del 1826 la materia è quadripartita: 1) Persia; 2) India; 3) Egitto; 4)
momento della dissoluzione dei due lati, spirituale e sensibile: a) sublime della
poesia ebraica; b) sublime “positivo” del “panteismo orientale”; c) simbolismo
del paragone.
Il corso del 1828-29 è suddiviso in cinque parti: 1) simbolo in generale; 2)
arte e mitologia persiana e indiana, di nuovo riunite come nel 1823; 3) sublime:
panteismo della poesia maomettana e poesia sacra degli Ebrei (come nei Werke); 4) Egitto; 5) simbolismo del paragone.
Queste suddivisioni non sembrano intaccare la sostanza del discorso di Hegel, anche e soprattutto se si raffrontano con le altre Lezioni o con la Fenomenologia dello spirito. Con questo non si vuole dire che Hegel abbia forzato determinati contenuti entro uno schema rigido, perché in parte lo schema cambia,
come cambia tutto quello che ha a che fare con l’”esteriorità” e con i contenuti
empirici, che sicuramente si arricchiscono. Solo che è difficile affermare che il
senso, la griglia concettuale che orienta il discorso di Hegel cambi nel tempo.
Alcuni dei punti in discussione sono l’influenza di Creuzer23 sulla tripartizione
del simbolico e il presunto mutamento del rapporto tra arte e religione sancito
col passaggio dalla Kunstreligion alle lezioni separate di Estetica e di Filosofia
della religione24. Senza addentrarmi nell’analisi dettagliata, direi che i concetti
Cfr. Est. 1823, p. 89: l’azione epica che nasce da un conflitto.
In particolare della seconda edizione della Symbolik und Mythologie der alten Völker,
besonders der Griechen, edizione totalmente rivista e ampliata, 7 voll., 1819-1822.
24
Cfr. Kwon (1992), che riassume i termini del problema e non vede modifiche sostanziali
tra l’impianto concettuale della Fenomenologia dello spirito e quello delle Lezioni. In questo
modo ridimensiona l’influenza di Creuzer, che avrebbe soprattutto fornito ad Hegel il modo di
determinare meglio dei concetti che già aveva presenti. Gadamer, Schneider, D’Angelo, tra gli
altri, tendono invece ad attribuire all’influenza di Creuzer lo sviluppo di una teoria del simbolo
legata al mondo orientale, con la conseguente tripartizione delle forme d’arte in simbolicaclassica-romantica al posto della bipartizione classica-romantica (più comune, legata al ro22
23
La concezione dell’Islam nelle Lezioni sull’Estetica di Hegel
235
fondamentali e soprattutto i loro nessi non subiscono mutamenti sostanziali.
Detto questo, bisogna comunque dire che la ricognizione (per quanto breve)
delle successive modifiche che subisce la trattazione delle forme simboliche è
interessante sia dal punto di vista della genealogia di certe idee hegeliane e della
determinazione delle possibili fonti di queste, sia anche perché nel caso di Hegel anche la posizione è a volte molto significativa. In particolare, per questa ricerca mi sembrano significativi alcuni accostamenti tra Islam ed altri momenti
storici o forme artistiche. Purtroppo solo quando tutte le Nachschriften saranno
pubblicate potremo avere un quadro completo da questo punto di vista.
Con la necessaria prudenza e con la costante consapevolezza degli spostamenti di esempi e citazioni che potrebbe aver operato Hotho, penso sia comunque possibile rintracciare un percorso abbastanza chiaro, che va nella direzione
di una soggettività e autonomia del soggetto-poeta persiano-arabo-musulmano,
che però, a paragone del soggetto romantico, non si stacca dal sostanziale (e dal
mondo) e non lo nega.
5. Presenza e collocazione dell’Islam nell’Estetica
Il riferimento a momenti artistici del mondo musulmano è costante nelle
pagine dell’Estetica nella sua edizione a stampa più diffusa e tradotta in italiano, con citazioni ed esempi che mostrano una buona conoscenza da parte di
Hegel, soprattutto della poesia e in generale della letteratura araba e persiana.
Trascurate sono invece l’architettura e la miniatura (come d’altra parte anche
altre espressioni artistiche di altri popoli ed epoche) e si nota la quasi totale
assenza di riferimenti alla Turchia25. Inoltre, solo la poesia persiana è esplicitamente “musulmana” (anche per distinguerla dall’arte persiana precedente),
mentre quella araba include sempre anche quella pre-islamica. Questo anche
perché, nonostante lo stretto legame sopra ricordato tra arte e religione, in questo contesto Hegel distingue e argomenta su basi non propriamente religiose,
ma su un più generale elemento spirituale-culturale: un popolo, una “cultura”
e la concretizzazione nelle opere d’arte della sua particolare idea del divino e
manticismo). Gli argomenti di Kwon sembrano convincenti, anche perché non c’è dubbio che
già nella Fenomenologia dello spirito vi sia una parte dedicata al mondo pre-classico con molti
elementi strutturali che si trovano nelle successive lezioni, nonostante non vi sia la successiva
ricchezza di contenuti.
25
Una delle poche eccezioni è il riferimento al modo di vestire dei Turchi: le vesti lunghe
ed ampie degli orientali sono “del tutto incompatibili con il nostro modo di vita, così vivace
e così pieno di occupazioni, ma si adattano solo a gente che, come i Turchi, se ne sta seduta
tutto il giorno con le gambe incrociate o che cammina lentamente e con estrema gravità” (VAe
II, pp. 406-407; Estetica, p. 835).
236
Lorella Ventura
dell’uomo (la perfezione è costituita dalla Grecia: gli dei rappresentati in figura
umana e l’uomo in generale come soggetto dell’arte).
Poiché è difficile distinguere tra l’argomentazione di Hegel e gli interventi di
Hotho (anche ammettendo che non siano totalmente fuorvianti, ma anche solo
come spostamenti di alcuni esempi), è molto difficile collocare esattamente alcuni riferimenti all’Islam nell’argomentazione di Hegel. D’altra parte, le trattazioni più lunghe e articolate, nelle quali ai fenomeni artistici del mondo musulmano è affidato un ruolo ben preciso, mi sembrano abbastanza affidabili.
La collocazione principale dell’arte islamica (la poesia) è nell’arte simbolica, in particolare nel momento mediano del “simbolismo del sublime”, che si
colloca tra simbolismo incosciente (momento iniziale, in cui la coscienza artistica parte dall’identità immediata tra significato e forma reale) e simbolismo
cosciente (esplicito mettere in relazione: paragone, simbolo saputo come simbolo). Il simbolismo del sublime è a sua volta suddiviso in due momenti: uno
affermativo, il “panteismo dell’arte” (che può arrivare a comprendere poesia
indiana, poesia dei musulmani soprattutto persiani, mistica cristiana); l’altro
negativo, l’arte del sublime vera e propria, che è la poesia ebraica. Dalla considerazione dei diversi corsi che abbiamo visto sopra saltano subito agli occhi dei
particolari: nel corso del 1823 (e presumibilmente anche in quello del 1820-21),
mancano riferimenti alla poesia persiana (tranne un cenno nel 1823 a Firdusi),
mentre vi è un cenno agli Arabi e alla loro autonomia. Del panteismo dei persiani musulmani si parla nel 1826 e 1828-29 e non prima26. Inoltre, nei due corsi
è posto in posizione diversa (prima o dopo l’Ebraismo). Questo non cambia la
valutazione dell’arte islamica e del fenomeno “Islam” in generale da parte di
Hegel, ma mostra il suo interesse e l’arricchimento delle sue conoscenze.
Nell’Estetica vi sono anche altri luoghi dove si parla di poesia musulmana,
accostata ad altri momenti artistici: la poesia romantica; il modo di poetare dei
“meridionali” (spagnoli e italiani); gli eroi greci dell’epos, con la loro autonomia; il Divan di Goethe e le traduzioni di Rückert.
6. Il sublime e la poesia musulmana persiana
Nel sublime inizia il superamento del rapporto simbolico vero e proprio,
perché il significato diventa cosciente ed è ora la sostanza universale, il “tutto
26
Nelle Lezioni sulla filosofia della religione (1821, Manuskript) Hegel parla già di Rū mı̄.
Ma è il corso delle Lezioni sulla filosofia della storia del 1822/23 ad essere indicato spesso come
spartiacque e punto d’inizio di una nuova collocazione e articolazione del mondo orientale
(cfr. Schulin (1998), p. 79; Bonsiepen (1981), p. 198 e Kwon (1992), p. 52 n. 36).
La concezione dell’Islam nelle Lezioni sull’Estetica di Hegel
237
compenetrante”. Questa posizione si divide in due secondo il rapporto della sostanza con la finitezza dell’apparenza. Vi è un rapporto positivo, il “panteismo
del sublime”, dove la sostanza è “il tutto e l’Uno liberato da ogni particolarità,
è immanente ai fenomeni determinati come anima che li produce e li vivifica, è
intuita in questa immanenza come affermativamente presente, è colta ed è resa
manifesta dal soggetto che rinunzia a se stesso immergendosi amorosamente
in questa essenzialità immanente in tutte le cose”27. Nell’arte panteistica la sostanza è vista come immanente in tutti i suoi accidenti creati, che per questo
si mantengono affermativi, “sebbene in ogni singolo debba essere rappresentato e sublimato solo l’Uno e divino. Per questo anche il poeta, che in ogni cosa
contempla ed ammira quest’Uno, immergendo e le cose e se stesso in questa
intuizione, è in grado di conservare un rapporto positivo con la sostanza a cui
collega tutto”28. Vi è poi anche un rapporto negativo, perché la sostanza si eleva oltre i singoli fenomeni e oltre il loro insieme. Questa la poesia ebraica, che
vede l’intera creazione solo come un “accidente” della potenza di Dio, una parvenza. Il sublime in generale è infatti “il tentativo di esprimere l’infinito senza trovare nel regno dei fenomeni un oggetto che si mostri adeguato a questa
rappresentazione”29. Il significato non è visto come spiritualità concreta, ma
come un “interno” in sé essente, che non trova la sua vera espressione nel finito.
Esso è l’Uno in sé sostanziale, puro pensiero che è solo per il puro pensiero ed
è concepito come sostanza, forza creatrice di tutte le cose.
Hegel distingue il significato di “tutto” come ogni cosa presa nella sua singolarità empirica, dal “tutto” del panteismo, che “non è questo o quel singolo,
ma il tutto nel senso del tutto, cioè dell’unico sostanziale che è, sì, immanente
nelle singolarità, ma è contemporaneamente astrazione dalla singolarità e dalla
sua realtà empirica”30. Si parla non del singolo, ma dell’”anima universale”, del
“vero e perfetto” presente anche in questo singolo. Il panteismo così inteso è
proprio dell’Oriente. Il divino è immanente negli oggetti ed è ciò che eccelle in
essi, ma d’altra parte “essendo l’uno questo ed altro ed altro ancora ed operando
in ogni cosa, le singolarità e particolarità appaiono come superate e caduche”31.
Infatti non ogni singolo è l’Uno, ma l’Uno è tutte queste singolarità che si fondono in un insieme per l’intuizione. Questo si esprime ad esempio nella poesia
indiana come una enumerazione e un cambiamento di forme del divino32. Ma
VAe I, pp. 415-416; Estetica, p. 363.
Ivi, p. 469; ivi, p. 411.
29
Ivi, p. 467; ivi, p. 410.
30
Ivi, p. 470; ivi, p. 412.
31
Ivi, p. 471; ivi, p. 413.
32
Nel corso del 1823, dove non si parla di panteismo musulmano, vi sono il panteismo dei
27
28
238
Lorella Ventura
è nell’islamismo che il panteismo orientale è sviluppato “in modo più alto e più
soggettivamente libero”33, in particolare dai Persiani. Compare qui un “rapporto peculiare da parte del soggetto poetante”, che rinuncia alla propria particolarità e così si immerge completamente nell’eterno e nell’assoluto “riconoscendo e sentendo in ogni cosa l’immagine e la presenza del divino”34. Di qui una
“serena intimità”, una “libera felicità”, una “voluttuosa beatitudine propria agli
orientali”35. Qui “si sfiora” il misticismo: Hegel pensa in primo luogo a Rūmı̄36 e
alle traduzioni di Rückert. Il centro di tutto è l’amore per Dio, “con cui l’uomo
identifica se stesso nella dedizione più illimitata, vedendo in ogni regione del
mondo lui, l’uno a cui tutto riferisce e riconduce”37. In questo tipo di panteismo
“l’immanenza del divino negli oggetti eleva l’esistenza mondana, naturale ed
umana ad una propria e più autonoma maestà”38. Lo spirituale ha vita autonoma nei fenomeni naturali e nei rapporti umani, e così li anima e spiritualizza e
fonda un rapporto particolare dell’anima del poeta con gli oggetti che canta.
“Riempito di questa maestà vivificata, l’animo è in se stesso quieto, indipendente, libero, autonomo, ampio e grande; e di fronte a questa identità affermativa con sé, viene ad immedesimarsi con l’immaginazione,
nella stessa calma unità, con l’anima delle cose, saldandosi in intimità, la
più felice e lieta, con gli oggetti della natura e la loro magnificenza, con
la persona amata, con il coppiere, in generale con tutto ciò che è degno
di lode e di amore”39.
Anche il romanticismo mostra una simile immedesimazione, “ma nell’insieme, specialmente nel Nord è più infelice, priva di libertà e piena di
struggimento”40, oppure chiusa in se stessa, suscettibile, depressa, triste. Gli
Parsi, che consiste nella riconduzione della molteplicità a un’unità fisica: la luce e quello indiano, che considera divino quello che è vivente, venera come superiore una potenza pensante.
33
VAe I, p. 473; ivi, p. 415.
34
Ivi, p. 474; ibidem.
35
Ibidem.
36
Sul “panteismo” di Giala
¯ l ad-Dī n Rū mī , si veda Bausani (1980), in particolare pp. 19-21:
considerarlo panteista è doppiamente sbagliato perché da un lato non pensa un’unità indifferenziata Dio-mondo (vi sono creazione e distruzione da parte di un Dio attivistico e arbitrario)
e dall’altro non sostiene la possibilità di “indiarsi” senza intermediari (il Profeta, il Maestro).
Mi pare comunque che questo non sia inconciliabile con quello che intende Hegel quando
parla di “panteismo”, nel quale include Rū mī , ma anche Ha¯ fez.
37
VAe I, p. 474; Estetica, p. 416.
38
Ibidem.
39
Ivi, p. 475; ibidem.
40
Ibidem. Cfr. anche ivi, pp. 528-529; ivi, pp. 464-465.
La concezione dell’Islam nelle Lezioni sull’Estetica di Hegel
239
orientali invece, e principalmente i musulmani persiani, possiedono “una libera intimità felice”41. Offrono apertamente e con letizia tutto il loro io a Dio e a
tutto ciò che è degno di lode, ma in questa offerta conservano appunto la “libera
sostanzialità” che mantengono anche rispetto al mondo circostante. “Quando
l’orientale soffre ed è infelice, considera la sua sofferenza come decisione inevitabile del destino, rimanendo sicuro di sé e senza sentirsi oppresso, suscettibile
o di umore nero”42. Hegel cita Ha¯ fez, che “anche nel dolore rimane imperturbato come nella felicità”43. Un’altra differenza è nel modo di usare le immagini (pietre preziose, rose, usignoli): nella poesia occidentale in modo prosaico,
mentre per i Persiani “la rosa non è un’immagine o un semplice ornamento,
non è un simbolo, ma essa stessa appare al poeta come animata, come fidanzata che ama, ed egli si immerge con lo spirito nell’anima della rosa”44.
Molto interessante è il fatto che Hegel dichiari non solo di apprezzare il Divan di Goethe, ma di considerarlo nettamente superiore alle sue “malinconiche
poesie giovanili”45. In tarda età Goethe, preso “da quest’ampia serenità senza
turbamento”, “compenetrato dal soffio dell’Oriente, si è volto, pieno d’immensa
beatitudine e nell’ardore poetico del sangue, a questa libertà del sentimento che
perfino nella polemica non perde la sua bellissima imperturbabilità”46. Non “un
gioco né insignificanti artifizi di società”47, ma questo “libero sentimento nel
suo abbandono”48.
Nei Werke, Hegel ricorda lo “splendido panteismo” della poesia persiana recente, menzionando il fatto, ripreso da von Hammer, dell’invio di una poesia di
33.000 distici dall’attuale scià di Persia all’imperatore Francesco. Questa poesia
racconta le imprese dello scià e al poeta che l’ha composta è stato dato lo stesso
nome dello scià49. Tutto qui. L’interesse si concentra qui sulla poesia e sembra
VAe I, p. 475; ivi, p. 416.
Ibidem; ivi, p. 417.
43
Ibidem.
44
Ivi, p. 476; ivi, pp. 417-418.
45
Ivi, p. 477; ivi, p. 418.
46
Ibidem.
47
Ibidem. Si veda su questo GS-SK 2, dove le autrici argomentano come questa idea sia
“estranea” a Hegel e a loro dire probabilmente inserita da Hotho, come un’eco del dibattito
contemporaneo.
48
Ibidem.
49
Ivi, p. 476; ibidem. L’opera, lo Shāhenshāhnāme, tradotta da von Hammer (J. von Hammer-Purgstall: Fath-Ali Han Saba Kasani: Das Schehinshahname oder das Buch des Königs der
Könige. Übers. und hrsg. von Joseph von Hammer-Purgstall, Wien 1819) è citata da Hegel anche
nelle Lezioni sulla filosofia della religione, sempre a proposito del panteismo. Cfr. Vorlesungen
über die Philosophie der Religion, hrsg. v. W. Jaeschke, Meiner, Hamburg, 1993, vol. II, p. 5,
nota righe 103-104: nel testo si dà Schah nameh, la nota avverte che “sotto la riga” era scritto
anche Schahinschahnameh.
41
42
240
Lorella Ventura
che il panteismo sia espresso nella poesia stessa, nel suo contenuto. Leggendo
invece le versioni del 182650 la cosa appare sotto un’altra prospettiva e il panteismo è piuttosto da ricercare nel fatto che al poeta di corte lo Scià Fath-Ali abbia
dato lo stesso suo nome, “indem er sein Bewußtsein ist, ihn ausspricht”51. In Kehler, dopo aver detto che la poesia era stata scritta dal poeta persiano di corte,
al quale lo scià aveva dato il suo stesso nome, vi è aggiunto tra parentesi “Auch
dies [ist] Pantheismus”52. Inoltre, vi è anche un paragone con i 66.000 distici
dello Shā hnā me di Firdusi. Questa lettura rende certamente il brano più interessante e comprensibile. Hegel mette in rilievo il collegamento tra concezione
della poesia orientale e il rapporto di sovranità, rapporto che aveva già delineato
nell’Ebraismo (nel 1826 l’Ebraismo precede il panteismo musulmano), dove si
ha un Signore assoluto che domina il creato quasi “annullato” e mette in rilievo
la differenza con il panteismo, dove l’esistenza mondana ha un ruolo diverso.
7. La poesia ebraica e il rapporto tra Ebraismo e Islam
Il sublime vero e proprio, come si diceva, è rappresentato dalla poesia ebraica, che esprime un rapporto negativo tra il Signore e creatore e il mondo delle creature. Lo spirituale è completamente separato da sensibilità e naturalità
(concezione dell’essenza di Dio come assolutamente spirituale e privo di immagini). Il creato non ha autonomia di fronte a Dio: non lascia apparire l’essenza,
al massimo la fa “balenare”53. Natura e figura umana ci stanno davanti dedivinizzate e prosaiche: il finito è fissato definitivamente e ogni cosa è prosaicamente al suo giusto posto, a differenza di ciò che si può vedere ad esempio in India.
Questo fa sì che vi sia posto per i miracoli, diversamente dall’arte indiana, dove
tutto è miracolo54. Niente nel mondo può pretendere autonomia: l’individuo
deve solo riconoscere nullità delle cose e di se stesso ed esaltare Dio. L’uomo
acquista tuttavia un posto più libero e autonomo, perché vi sono la Legge e la
differenziazione perfetta e chiara di umano e divino, finito ed assoluto. Questa
dedivinizzazione del mondo, il suo aspetto umano e prosaico, accomuna Ebrei
e Arabi. Nelle lezioni del 1823 (diversamente da quelle successive) troviamo
questo accostamento (Ebrei-Arabi) proprio nel sublime, a proposito del mondo
dedivinizzato e la conseguente autonomia parziale del finito. L’uomo è più au Ae Kehler, p. 93; Ae von der Pfordten, pp. 131-132.
Ae von der Pfordten, p. 132.
52
Ae Kehler, p. 93.
53
VAe I, p. 481; Estetica, p. 422. I termini sono “scheinen” ed “erscheinen”.
54
Cfr. Ae von der Pfordten, p. 130, dove dice “egiziana”, mentre in Ae Kehler, p. 91, dice
“indiana”.
50
51
La concezione dell’Islam nelle Lezioni sull’Estetica di Hegel
241
tonomo perché è comunque creato dalla potenza dell’essenza, anche se poi sparisce di fronte a Dio. Questa autonomia è visibile negli Arabi: “L’indiano come
persona non è nulla. Nella poesia sublime l’individuo si sente sì dipendente dal
Signore, ma per altro verso anche autonomo. Questo si mostra nel libero eroismo (Tapferkeit) degli Arabi”55.
Alcuni tratti dell’Ebraismo fanno pensare anche a caratteristiche dell’Islam.
In primo luogo l’Uno e la negazione di tutti i particolari. Però l’Islam qui non è,
come nelle Lezioni sulla filosofia della religione, la religione dell’Uno nel senso
“fanatico” e più universale dell’Ebraismo56, ma è piuttosto l’Ebraismo che “supera” l’Islam dal lato della negatività, intesa non come universalizzazione, ma
come una sorta di “mestizia della finità”, negazione assoluta.
La trattazione dell’arte musulmana è concentrata soprattutto sulla poesia.
Oltre che nel soggettivo apprezzamento di Hegel e nelle sue conoscenze, questa
centralità della poesia ha una sua ragione oggettiva nella proibizione, che accomuna musulmani ed ebrei, di rappresentare Dio e le figure umane. L’arte deve
porre al centro delle sue raffigurazioni prima di tutto il divino, ma questo “fissato per sé come unità e universalità, essenzialmente è solo per il pensiero ed,
in quanto in se stesso senza immagine, si sottrae al formare e configurare della
fantasia”57. Con una tale concezione di Dio non vi è posto per l’arte figurativa e
“soltanto la lirica è in grado, nell’elevarsi a Dio, di cantare le lodi della sua potenza e magnificenza”58. è per questa concezione di Dio che gli Ebrei e i Turchi
non hanno potuto “manifestare come i cristiani, in maniera positiva, per mezzo dell’arte, il loro Dio”59. In questo passo tale concezione è accostata a quella
dell’essere supremo, definita “morta astrazione dell’intelletto non razionale”60.
L’arte islamica è inoltre spesso affiancata all’arte romantica, in quanto espressione di un ruolo “peculiare” del soggetto e in ambedue è centrale il ruolo che
gioca la poesia, arte distante dal sensibile, tipicamente romantica, ma anche
tipicamente “sublime”61.
Est. 1823, p. 137.
Cfr. VAe II, pp. 64-65; Estetica, p. 526, dove parla della limitatezza del Dio ebraico in
riferimento non all’Islam, ma al politeismo: “Solo il limitato dio nazionale ebraico non può
sopportare altro dio accanto a sé, perché deve essere tutto in quanto è l’uno”.
57
VAe I, p. 230; Estetica, p. 199.
58
Ibidem.
59
Ivi, p. 101; ivi, p. 83. Nell’Islam non c’è una preoccupazione per l’arte in generale, che è
intesa nel senso di “artigianato” e in modo funzionale, mentre c’è una centralità della parola
(Dio insegna i nomi delle cose e per questo gli uomini sono superiori agli angeli) e ad essa è
affidata la possibilità di perfezione.
60
Ibidem.
61
Nel panteismo indiano: “Colà dove il panteismo è puro, non vi è arte figurativa che lo
possa rappresentare” (ivi, p. 471; ivi, p. 413). Nella poesia ebraica: dove è impossibile tracciare
55
56
242
Lorella Ventura
Qui si ripete in parte una situazione presente anche nelle Lezioni sulla filosofia della religione e nelle Lezioni sulla filosofia della storia: da un lato una collocazione “orientale” o “semitica” dell’Islam e dall’altro una “occidentale”. Solo
che qui sembra che poesia araba e persiana a volte si dividano, anche come
collocazione, nel senso che, mentre la poesia persiana musulmana è spesso ravvicinata anche a quella indiana (oltre che alla ebraica e araba, per esempio nei
momenti dello sviluppo dell’epica o della lirica), la poesia araba è nettamente
separata dalla indiana e ravvicinata a quella ebraica (oltre che alla persiana).
Inoltre, il fatto che uno di questi accostamenti, e precisamente quello del 1823
proprio nel sublime, sia stato poi di fatto superato (tanto che non è menzionato
neanche da Hotho nella versione a stampa), potrebbe suggerire un possibile ridimensionamento del peso dell’Ebraismo nella concezione dell’Islam.
8. L’autonomia individuale degli Arabi
In Oriente in generale domina il sostanziale e non si arriva al “principio della
libertà e dell’autonomia individuali”62 o all’”autodeterminazione di essere liberamente responsabili dei propri atti e delle loro conseguenze”63 (per questo non
c’è posto per lo sviluppo dell’arte drammatica). Questo vale anche per la poesia
musulmana, “sebbene per un verso in essa si possa già affermare più energicamente l’autonomia individuale”, per l’altro verso “è l’unica potenza sostanziale
a sottomettersi tanto più conseguentemente ogni creatura e a deciderne la sorte
in inesorabili cambiamenti”64. Nell’Islam la sottomissione del soggetto a Dio è
“tanto più astratta quanto più astrattamente universale è l’unica potenza dominante che governa tutto e non lascia posto infine ad alcuna particolarità”65.
Da un lato la sottomissione a Dio, dall’altro fin troppa autonomia, in certi casi
“arbitrio”, proprio perché si parla di un Dio astratto, indeterminato.
L’aspetto dell’individualità, qui solo accennato, è riproposto da Hegel in diversi passi. Ad esempio, nel paragone tra l’autonomia degli eroi greci a quelli
immagini sufficienti di Dio “può esserci solo la poesia della rappresentazione che si estrinseca
con la parola” (ivi, p. 480; ivi, p. 423). Anche nell’arte romantica la poesia ha una funzione
fondamentale: ad esempio è l’unica in grado di esprimere “l’interiorità occupata solo con se
stessa” (VAe II, p. 172; ivi, p. 621), tipica della cavalleria e delle sue virtù. Sulla poesia cfr. anche
Cantillo (1996), che sottolinea la sua preminenza rispetto alle altre arti romantiche, pittura
e musica, e nota che “forse si può rilevare talvolta la tendenza a riconoscere alla poesia una
potenza di unificazione superiore a quella dello stesso pensiero” (p. 158).
62
VAe III, p. 534; ivi, pp. 1347-48.
63
Ibidem; ivi, p. 1348.
64
Ivi, p. 535; ibidem.
65
Ibidem.
La concezione dell’Islam nelle Lezioni sull’Estetica di Hegel
243
dell’antica poesia araba: “nessun ordinamento stabilito una volta per tutte li tiene insieme come sue semplici particelle”66. Anche lo Shāhnāme di Firdusi ci presenta figure simili, così come nell’Occidente cristiano emergono nel rapporto
feudale e nella cavalleria, e negli eroi saraceni67. A proposito dell’autonomia, nel
confronto con l’arte classica, dove è centrale il momento individuale, l’Ebraismo è “superato” dall’Islam degli Arabi proprio nella direzione dell’autonomia
del singolo. Come si è visto, infatti, l’arte del sublime, affermativa o negativa,
è doppiamente insufficiente, per via del pensiero di Dio come indeterminato
e astratto e per la conseguente incapacità dell’apparenza reale di presentare
l’assoluto in una forma concreta. Ma, accanto al sublime, vi è anche un’altra
concezione che è incominciata in Oriente. Essa è “la concezione della libertà,
dell’autonomia, dell’indipendenza interna della singola persona in sé, nella misura in cui l’Oriente permette lo sviluppo di questa tendenza” ed è la concezione
dominante presso gli Arabi, “che nei loro deserti, nell’infinito mare delle loro
pianure, sovrastati da un puro cielo, dipendono, di fronte a tale natura, solo dal
proprio coraggio e dal valore del proprio pugno, e dai loro mezzi di sostentamento, il cammello, il cavallo, la lancia e la spada”68. Questa è una “incipiente
autonomia dell’individualità”, alla quale si lega “una fedele amicizia, generosa
ospitalità, sublime nobiltà d’animo, ma egualmente un infinito piacere per la
vendetta ed un ricordo indistruggibile di odio, che, con passione implacabile
e insensibile crudeltà, cerca modo di appagarsi”69. In questo gli Arabi si differenziano non solo dalla concezione indiana, ma anche dal “panteismo della
posteriore poesia musulmana”70: l’autonomia del carattere personale e anche
degli oggetti, ai quali è lasciata la loro realtà immediata. Quello “che avviene in
questo ambito appare come umano e mantenuto in una cerchia umana”71, non
vi è posto per il fantastico ed il prodigioso, e i fatti avvengono secondo la connessione necessaria delle cose. In effetti in questo Arabi ed Ebrei si somigliano.
Hanno una affine concezione “prosaica” degli oggetti reali e anche “la ferma
VAe I, p. 245; ivi, p. 212 traduzione lievemente modificata.
Si noterà qui un piccolo errore. Mentre in Kehler, p. 45 è citato esplicitamente
lo Shāhnāme, von der Pfordten, p. 86, parla di “eroi della poesia araba” e la nota dei curatori
avverte che qui ci si riferisce all’opera di Firdusi, ma certamente non si tratta di un arabo. E’
molto improbabile che la confusione nasca da Hegel.
68
VAe II, p. 16; Estetica, p. 484.
69
Ivi, p. 17; ibidem.
70
Ivi, pp. 16-17; ibidem. “Posteriore” fa pensare a una successiva decadenza della poesia
araba o al fatto che qui voglia riferirsi alla poesia pre-islamica o immediatamente degli inizi
dell’Islam. Cfr. però anche ivi, p. 175; ivi, p. 624 (Arabi e religione musulmana) e VAe III, pp.
398-399; ivi, p. 1228 (il periodo precedente e appena successivo alle conquiste).
71
VAe II, p. 17; Estetica, p. 484.
66
67
244
Lorella Ventura
autonomia del carattere, il carattere selvaggio della vendetta e dell’odio”72. Però
poi si distinguono perché oggetti e carattere-sentimenti per gli Ebrei non hanno
autonomia di fronte a Dio: lo stesso odio è rivolto “al servizio di dio come vendetta nazionale contro interi popoli”73. La differenza tra Arabi (musulmani) ed
Ebrei non è nell’universalizzazione, ma nell’autonomia individuale e nel maggiore valore del mondo prosaico delle cose.
9. Poesia romantica e poesia musulmana persiana
Il momento soggettivo-individuale emerge anche nella poesia persiana. Nelle liriche d’amore di Hā fez si vede, infatti,
“tutta la viva individualità del poeta, che muta di contenuto, atteggiamento ed espressione fin quasi all’umorismo. Ma nelle sue poesie non
c’è nessun tema particolare, nessuna immagine oggettiva, nessun Dio,
nessuna mitologia – e anzi, quando si leggono queste libere effusioni, si
avverte che gli orientali in generale non potevano avere né pittura né arte
figurativa; - egli passa da un oggetto all’altro, si volge in tutte le direzioni,
ma si tratta sempre di una scena in cui in bella franchezza, senza desideri e rimpianti c’è messo dinanzi, in puro godimento, occhi negli occhi,
anima dinanzi ad anima, l’uomo intero con il suo vino, le sue osterie, le
ragazze, la corte, ecc.”74.
Queste parole mostrano bene la somiglianza e la differenza tra poesia musulmana persiana e poesia romantica moderna: nella poesia musulmana come
nella romantica manca la mitologia ed è al centro l’individualità, ma il volgersi
in tutte le direzioni e una sorta di “beatitudine” sono estranei allo spirito romantico e sono invece tipicamente orientali. Questi caratteri si ritrovano poi
anche in Goethe e Rückert.
La poesia orientale, con la sua serenità spensierata, espansione libera da
desideri, “immaginosità” che si volge in ogni direzione, si differenzia dalla interiorità nordica concentrata in se stessa. La sua “teoretica libertà”75, infatti,
non rimane prigioniera dei suoi desideri immediati e si soddisfa della fantasia,
delle rappresentazioni. Queste caratteristiche accomunano Hāfez con il Goethe
Ibidem.
Ibidem.
74
VAe III, p. 428; Estetica, p. 1254.
75
Ivi, p. 459; ivi, p. 1281.
72
73
La concezione dell’Islam nelle Lezioni sull’Estetica di Hegel
245
del Divan. Hegel afferma addirittura che Persiani e Arabi costituiscono uno
“splendido modello anche per il presente e per la soggettiva intimità odierna”76.
Un modello per un certo tipo di atteggiamento spirituale che consiste in un effondersi dell’animo nell’oggetto, che rimane un “soggettivo movimento arguto
(geistreiche) della fantasia e del cuore; una trovata che però non è solo accidentale ed arbitraria, ma è un movimento interno dello spirito, che si dedica interamente al proprio oggetto e lo conserva come interesse e contenuto”77. Non si
tratta di nominare semplicemente l’oggetto, ma di un “sentimento profondo, un
acuto motto di spirito (Witz) una riflessione sensata ed un movimento arguto
della fantasia”, che “animano e ampliano anche ciò che è minimo”78. Un immedesimarsi dell’animo con la situazione e un indugiare che trae dall’oggetto
“qualcosa di nuovo, di bello, di valido in se stesso”79.
Hegel evidenzia in questi brani la caratteristica di unità individuale-sostanziale per lui tipica della poesia musulmana. Non sembra quindi casuale che
questo tipo di atteggiamento sia attribuito anche a spagnoli e italiani nel passato80 e soprattutto al Goethe del Divan e a Rückert nei tempi moderni. Per tutti
potrebbe valere lo stesso tipo di “modello” (Hegel non lo dice esplicitamente).
Fra i poeti moderni principalmente Goethe nel suo Divan e Rückert si trovano
su questo piano di “libertà arguta”81 e allo stesso tempo di intima profondità
soggettiva della fantasia. “In generale nelle produzioni di questo genere non
troviamo né nostalgia soggettiva, né desiderio, né innamoramenti, ma un puro
trovare piacere negli oggetti, un inesauribile effondersi della fantasia, un gioco
innocente” e inoltre libertà, intimità e letizia dell’animo, che “elevano l’anima,
con la serenità del configurare, ben oltre ogni penoso intreccio con la limitazione della realtà”82. In un altro luogo dell’Estetica, Hegel mette in rilievo il lato
“orientale” e quello “occidentale” (e “tedesco”) di Goethe e del Divan. Egli ha
introdotto l’Oriente “nella nostra poesia odierna” e l’ha reso “appropriato al nostro modo di vedere” e “ha sempre tenuto presente di essere un occidentale ed
un tedesco”. In questo modo ha fatto “risuonare” il carattere orientale di situa-
VAe II, p. 241; ivi, p. 682.
Ivi, p. 240; ivi, p. 681.
78
Ibidem; ivi, p. 682.
79
Ivi, p. 241; ibidem.
80
Cfr. ad esempio VAe II, p. 241 e III, p. 398; Estetica, pp. 682-683 e p. 1228.
81
VAe II, p. 242; Estetica, p. 683: “geistreichen Freiheit”.
82
Ibidem. Sulla valutazione del Divan di Goethe si veda GS-SK 2 (in particolare pp. 5859), dove le autrici sottolineano che la lode per il Divan (e solo per il Divan, distinto dalle altre
opere di Goethe) ha una ragione “storico-spirituale”, più che estetica, poiché Goethe riesce
in un’opera di mediazione culturale, di trasmissione di ciò che è sostanziale per una cultura
attraverso la propria sensibilità soggettiva.
76
77
246
Lorella Ventura
zioni e rapporti, “al contempo però ha pienamente rispettato la nostra coscienza odierna e la propria individualità”83.
Tornando al confronto con la lirica romantica, tenendo ferma la somiglianza con quella orientale (per il comune immergersi fino all’intimità di particolari
stati d’animo e situazioni), Hegel evidenzia anche le differenze, a vantaggio
della lirica romantica dal lato della soggettività, della libertà del soggetto. La
lirica orientale, infatti, si differenzia da quella occidentale perché “l’Oriente,
conformemente al suo principio universale, non raggiunge né l’autonomia individuale e la libertà del soggetto né quella interiorizzazione del contenuto, la
cui infinità costituisce in sé la profondità dell’animo romantico”84. All’Oriente
manca la libertà del soggetto (concreta, non solo teoretica) e il suo valore infinito, che si afferma col cristianesimo e nell’arte romantica. La coscienza soggettiva, rispetto al suo contenuto si mostra da un lato immersa immediatamente
nell’esterno e nel singolo e dall’altro si annulla di fronte a ciò che è sostanziale.
Rispetto alla forma, troviamo in gran parte la descrizione immediata di quella
“immedesimazione irriflessiva”85 con cui il soggetto si mostra nel suo annullarsi
di fronte agli oggetti ed alle situazioni. Per questo acquista spesso un tono più
“oggettivo” rispetto alla lirica romantica in particolare. Perciò nell’insieme la
lirica orientale ha il carattere di una “elevazione che è tipica dell’inno, specialmente presso gli Ebrei, gli Arabi e i Persiani”86. Come nell’Ebraismo si esalta
la creatura, per poi farla sparire dinanzi all’inesprimibile superiore maestà di
Dio; oppure, come nella poesia persiana, “la fantasia non si stanca di disporre
in una preziosa collana almeno tutto quel che vi è di amabile e di bello, collana
che essa offre in dono a colui che per il poeta è l’unico degno di valore, si tratti
di un sultano, dell’amata o di una osteria”87.
Come forma di espressione si incontrano soprattutto metafora, immagine
e paragone. Quello che manca in quanto a “libertà interiormente concreta”, lo
troviamo compensato dalla libertà dell’espressione, che partendo da una sem83
VAe I, p. 356; Estetica, p. 309. Cfr. GS-SK2 (in particolare pp. 56-57): Hegel riflette
sull’arte come opera e sull’artista come individuo storico, concentrandosi sul sostanziale, ed è
lontano dall’esaltazione romantica del “genio” soggettivo. Nei Werke, in particolare nel brano
citato, l’accento cadrebbe troppo sul lato soggettivo e “nazionale”, rivelando l’intervento di Hotho e delle tendenze contemporanee, soprattutto se si confronta con il brano corrispondente
tratto da una Nachschrift del 1828/29, non ancora pubblicata: “Goethes westmorgenländischer
Divan entsprang daraus, daß ein westlicher Mensch Östliches aufnimmt, daher der schickliche
Name. Man fühlt da die östliche Unabhängigkeit der Freihet in den kleinsten Dingen. Das Substantielle daran ist auch für uns gegenwärtig” (Jag. Bibl. 1828/29 Ms. 83; in GS-SK 2, p. 56).
84
VAe III, pp. 462-463; Estetica, pp. 1284-85.
85
Ivi, p. 463; ivi, p. 1285.
86
Ibidem.
87
Ivi, p. 464; ivi, p. 1286.
La concezione dell’Islam nelle Lezioni sull’Estetica di Hegel
247
plicità di immagini e paragoni, “giunge fino alla più incredibile arditezza e alla
più sottile ingegnosità di combinazioni nuove e sorprendenti”88. In un altro
passo, sempre a proposito del paragonare, si vede che certa soggettività è legata
alla morbosità: l’orientale, “nel suo internarsi, è meno preoccupato di sé, quindi
è privo di spasimi e nostalgia; il suo desiderio rimane una gioia più oggettiva
per l’oggetto dei suoi paragoni, quindi più teoretico”89. Egli guarda intorno a
sé con animo libero, la sua fantasia è “libera da ogni concentrazione semplicemente soggettiva, immune da ogni morbosità” e “si accontenta della rappresentazione comparativa dell’oggetto stesso, specialmente se questo deve essere
lodato, esaltato e trasfigurato nel paragone con ciò che vi è di più splendente e
di più bello”90. Mentre l’Occidente “è più soggettivo e più languido e bramoso
nei suoi lamenti e dolori”91.
In definitiva, da questo confronto sembra esca vittoriosa la poesia orientale.
Per Hegel “la forma orientale della coscienza è più poetica nell’insieme di quella occidentale, fatta eccezione per la Grecia”, perché “la cosa principale resta
sempre l’indiviso, l’uno, saldo, sostanziale, e questa concezione, anche se non
si spinge fino alla libertà dell’ideale, è di per sé la più solida”92. Per questo loro
tener fermo “come nucleo vero e proprio soltanto all’unica sostanza rispetto
a cui il resto appare meschino e caduco e nulla più rimane alla passione e al
desiderio”93 i poeti orientali, musulmani, vanno celebrati. Un aspetto interessante è che per Hegel questa concezione del mondo teoretica è più vicina alla
vecchiaia che alla gioventù e così in questo senso (dal punto di vista del naturale, della capacità di creare un “libero” tutto partendo dalla propria soggettività,
cosa per la quale c’è bisogno di indipendenza, di un libero sguardo) l’età matura si mostra migliore di quella giovanile per le esigenze dell’arte, come mostra
anche l’esempio di Goethe.
10. L’epica
Un ruolo molto particolare riveste l’epos, che “porta ad intuizione il nucleo sostanziale del contenuto di un popolo”94. Il suo sviluppo storico su scala
Ibidem.
VAe I, p. 528; ivi, p. 464.
90
Ivi, pp. 528-529; ivi, p. 464.
91
Ivi, p. 529; ivi, p. 465.
92
VAe III, p. 246; Estetica, p. 1093.
93
Ivi, p. 273; ivi, p. 1117. Cfr. anche Ae von der Pfordten, p. 223 e Ae Kehler, pp. 197-198,
in cui cita anche Hā fez e parla di vecchiaia “europea”.
94
VAe III, p. 394; Estetica, p. 1225.
88
89
248
Lorella Ventura
mondiale è quindi molto importante ed è articolato in tre fasi principali: epos
orientale, epos classico e poesia epico-romantica. Come per la scultura, troviamo l’epos nella sua forma compiuta in Grecia e prima e dopo questa non più
raggiunta perfezione vi sono fasi di sviluppo che non sono di natura subordinata e inferiore, ma sono necessarie, perché la cerchia dell’epos include in sé
tutte le nazioni.
Quando si vuole parlare di epica, bisogna che si parli dei libri particolari,
le “bibbie” dei popoli, come è ad esempio il Ramayana per gli indiani o sono i
poemi omerici per i greci. Queste bibbie dei popoli non sono tutte epopee, ma
vi sono ad esempio la Bibbia, il fondamento della religione cristiana, così come
il Corano presso i musulmani; questi libri però si concentrano solo sul lato
religioso. Nelle versioni del 1826 Hegel parla anche dell’‘Antar, che considera
l’epos degli arabi, dove appare la loro Tapferkeit (il “libero eroismo”)95. A questo
proposito, va notato che vi è un’importante distinzione tra il poeta preislamico
‘Antara (e la sua opera) e il “romanzo di ‘Antar”, che pretende di raccontarne le
gesta leggendarie, nel quale confluisce materiale di diverse epoche e tradizioni,
un romanzo “cavalleresco” che non può essere fatto risalire all’epoca preislamica, né ad un solo autore96. In von der Pfordten e in Kehler è presente invece
una certa confusione tra poeta e romanzo. Von der Pfordten parla dell’‘Antar
come epica (il romanzo di ‘Antar) e come poeta preislamico, quasi sovrapponendoli: “Die Indier haben den Ramajana, die Araber haben den Antar, der vor
Mohammed lebte, der Dichter fällt in die Zeit Al Hadids, im Jahrhundert vor
Mohammed”97. Kehler parla del romanzo di ‘Antar come “epica dei maomettani”, di un poeta antecedente di cento anni Muhammad, poi aggiunge: “der
Dichter fällt in die Zeiten Harun al-Rashíds”98 (laddove Kehler parlava dell’epoca di un non ben definibile “al Hadid”). Questo evidente errore di datazione
probabilmente è dovuto alla confusione tra il poeta e il romanzo di ‘Antar (il
romanzo stesso si autoattribuisce la nascita nell’epoca di Hārūn al-Rashíd). Nel
seguito continua, dicendo che von Hammer l’ha tradotto da venti anni senza
trovare un editore. L’aggiunta “[er ist] noch nicht so vom arabischen Fanatismus ergriffen”99 ripropone un problema di datazione, visto che il “fanatismo”,
con il quale è da intendersi presumibilmente un riferimento all’Islam (“musul Cfr. Ae von der Pfordten, p. 232 e Ae Kehler, pp. 206-207.
Cfr. Encyclopédie de l’Islam voci: Sırat ‘Antar e ‘Antara, dove si parla anche del ruolo di
von Hammer nel far conoscere in Europa il romanzo (già menzionato da D’Herbelot nella
Bibliotèque orientale).
97
Ae von der Pfordten, p. 232.
98
Ae Kehler, p. 206.
99
Ae Kehler, p. 207.
95
96
La concezione dell’Islam nelle Lezioni sull’Estetica di Hegel
249
mano” più che “arabo”), all’epoca della nascita e della progressiva formazione
del romanzo di ‘Antar si era già manifestato, mentre ovviamente non lo era
all’epoca del poeta ‘Antara. Non è facile dire se la confusione sia dovuta a Hegel
oppure agli uditori.
La poesia in Oriente è in generale più originaria, perché rimane più vicina al
modo sostanziale di concepire e al dissolversi della coscienza singola nell’unico
tutto. Come abbiamo visto, poiché “il soggetto non può elaborarsi fino all’autonomia del carattere individuale”100, manca un’evoluzione della poesia drammatica, perciò troviamo, oltre alla lirica, soprattutto poemi epici.
La poesia epica orientale è cinese, indiana, e infine ebraica, araba e persiana. Presso gli Ebrei solo leggende e storie poetico-religiose o racconti didatticoreligiosi. Gli Arabi, invece, sono “veri poeti per natura e fin dall’inizio”101. Già
i canti lirici che raccontano gesta d’eroi, i Mu‘allaqā t, che in parte risalgono
all’ultimo secolo prima del Profeta, raccontano le condizioni originarie degli
arabi ancora pagani: onore della stirpe, sete di vendetta, ospitalità, amore, avventure, melanconia, “ora con rapido e scattante ardire e con lussureggiante
foga, ora con calma assennata e dolce morbidezza”102.
“Questa è in Oriente la prima vera poesia, senza fantasticherie e senza
prosa, senza mitologie, senza dei, demoni, genii, fate e altri esseri orientali, ma dotata di figure consistenti, autonome e, sebbene abbia tratti
stravaganti, eccentrici, e giochi con immagini e paragoni, è umanamente
reale e saldamente in sé conchiusa”103.
VAe III, p. 395; Estetica, p. 1225.
Ivi, p. 398; ivi, p. 1228.
102
Ibidem. Hegel afferma che possono ricordare il carattere romantico della cavalleria
spagnola e non concede apertamente l’influenza degli arabi sugli spagnoli come invece nelle
Lezioni sulla filosofia della storia. Inoltre, nega esplicitamente l’influsso dell’architettura araba
su quella gotica (propriamente cristiana, germanica), anche se la loro parentela sembra “verosimile” (Cfr. VAe II, pp. 347-348; Estetica, pp. 780-781. Cfr. anche Est. 1823, p. 220: l’architettura moresca, in cui predomina la forma a ferro di cavallo, ricompresa sotto quella gotica, in cui
predomina l’arco acuto). Anche a proposito della versificazione, Hegel sostiene che sia sbagliato attribuire l’origine della rima agli Arabi e che “si può pensare anche ad una prima comparsa
indipendente di un nuovo genere di versificazione” (VAe III, p. 307; Estetica, p. 1147). Questo
non solo riguardo alla rima: “anche nella poesia araba si trova già di per sé un’eco del principio
romantico, secondo cui i cavalieri dell’Occidente al tempo delle crociate espressero poi ben
presto la medesima disposizione d’animo” (ivi, p. 307; ivi, p. 1147). Cfr. anche Est. 1823, p. 272:
la rima presente nella lingua araba, ma più antica del contatto con l’Occidente.
103
VAe III, p. 398; Estetica, p. 1228. Si noti: “umano”, “autonomo”, “reale”. Anche VAe II,
p. 17; ivi, p. 484.
100
101
250
Lorella Ventura
“Dopo le vaste e fortunate conquiste degli Arabi musulmani, questo carattere eroico originario si altera, però, a poco a poco”, e nel corso dei secoli, lascia
il posto a “fiabe istruttive e a massime di serena saggezza”, oppure ai favolosi
racconti delle Mille e una notte o, infine, ad avventure come le Maqā mā t di
Harı̄rı̄, tradotte da Rückert, piene “di spirito ed arte giocosa sia per l’assonanza
e le rime che per il senso e il significato”104.
Sulle Mille e una notte Hegel torna in diversi punti, sempre con un accento
critico, perché poco amante del “favoloso”, del “fantastico”, il “magico” che interviene al di fuori di ogni connessione deterministica ma anche razionale delle
cose. Il “portentoso” può essere usato nelle letterature cristiana e musulmana
per spiegare l’accadere “indifferente”:
“Quando alla natura e al mondo umano si toglie ogni carattere divino
e quando si ha solo la coscienza dell’ordinamento prosaico delle cose,
difficilmente entro questa concezione si può evitare il pericolo, specialmente nelle fiabe, di dare un’interpretazione portentosa a quel che è in sé
e per sé accidentale ed indifferente nelle circostanze esterne”105.
Non tutte le circostanze possono essere chiarite tramite la catena di causaeffetto e così sono riunite in un unico termine (un essere magico o soprannaturale: genio, angelo ecc.). Nelle Mille e una notte questo avviene “senza necessità
e interna razionalità” e risulta così “un semplice gioco della fantasia”106. Nelle
versioni von der Pfordten e Kehler del 1826107 Hegel prende come esempio di
epica le Mille e una notte e le fiabe arabe in generale, per mostrare come il contesto non perfettamente razionalizzato, “indifferente”, fantasioso, esalti l’agire,
le qualità e la volontà umane. Oggetto dell’epica non è un sentimento, ma l’universale, das Sittliche, un fine riconosciuto universalmente come valido, ma non
ancora fissato nella società, ma solo nel “petto” dell’individuo. L’epica si distingue dal romanzo, la cosiddetta “epica moderna”, perché l’eroe del romanzo si
104
Ivi, p. 399; ivi, p. 1228. Si noti che questa parte sugli Arabi non è presente nella versione del 1823, né in quelle del 1826 (von der Pfordten e Kehler), dove, come si è visto, parla
piuttosto dell’‘Antar.
105
VAe III, p. 367; Estetica, p. 1200.
106
Ibidem. Cfr. anche l’accostamento con l’opera moderna, caratterizzata dal “fasto sensuale” del canto, decorazioni, costumi, al quale corrisponde come contenuto il fantastico e
favoloso staccato dalla connessione intellettuale. Ma quando questi artifici sensibili sono usati
fino in fondo, non dobbiamo prendere del tutto sul serio il contenuto drammatico, e invece
conservare “un’impressione analoga a quella che riportiamo nella lettura delle leggende delle
Mille e una notte” (ivi, p. 518; ivi, p. 1333).
107
Ae von der Pfordten, pp. 239-240; Ae Kehler, pp. 216-217.
La concezione dell’Islam nelle Lezioni sull’Estetica di Hegel
251
muove invece in un contesto in cui l’eticità (das Sittliche) e il diritto (das Rechtliche) sono divenuti rapporti fissi e l’individuo agisce in modo ad essi conforme.
Hegel ricorda qui una descrizione, presa da von Hammer108, del modo in cui
i beduini egiziani, seduti in circolo, ascoltano un racconto accompagnandolo
con esclamazioni. Queste mostrano che è l’umano ad attirare la loro attenzione
e partecipazione e, nella ripetitività, fanno pensare al coro o alla ripetizione di
versi in Omero.
La poesia persiana fiorisce invece nell’epoca posteriore alla trasformazione
dovuta all’islamismo, in cui lingua e nazionalità sono giunte a nuovo sviluppo.
Lo Shā hnāme di Firdusi, poema epico che parla del passato più remoto delle
leggende e miti dell’antica Persia, non “può dirsi un’epopea vera e propria, perché non pone a suo centro una ben definita azione individuale. Il succedersi
dei secoli non è indicato differenziando con precisione il tempo e il luogo, e
particolarmente le più antiche figure mitiche e le vaghe e confuse tradizioni si
muovono in un mondo fantastico […], mentre d’altro canto compaiono poi reali figure storiche”109. Come musulmano era libero di maneggiare la sua materia,
ma proprio per questa sua libertà, per la distanza tra lui e il mondo di leggenda
che descrive, gli manca quella base solida delle produzioni individuali che caratterizza gli originari canti eroici degli arabi e soprattutto la vitalità immediata assolutamente necessaria all’epos nazionale. Hegel cita poi altri grandi poeti
come Nezāmi, Sa‘di e Rū mı̄.
11. Dio, individuo e mondo
Per Hegel il lato del mondo e dell’eticità non è staccato dall’assoluto. Egli
critica aspramente le posizioni religiose interne al cristianesimo, che separano e oppongono il bene come servizio di Dio e il bene in quanto eticità di un
popolo, dunque su questo punto il bersaglio polemico è in primo luogo certo
“fanatismo” cristiano. Anche nell’Estetica si trova questo tema: la separazione
tra fede e mondo crea un fanatismo che va contro tutti i sentimenti determinati dell’umanità, le inclinazioni e relazioni etiche, i rapporti e doveri del cuore,
108
Von Hammer fu segretario e traduttore dell’ammiraglio inglese Sir William Sidney
Smith, che combattè contro i francesi in Egitto. In Ae von der Pfordten si parla della sua partecipazione alla spedizione “francese” in Egitto, mentre in Ae Kehler si parla, correttamente,
di quella inglese. Questa non è l’unica discrepanza del genere tra le due versioni.
109
VAe III, p. 399; Estetica, p. 1229. Firdusi in Ae Kehler, p. 207 accostato alla religione
della luce: “teils mohammedanischer Geist, teils dennoch auch das Licht der Perser [ist] darin
gehalten, [es ist] aber mehr phantastisch”. Inoltre, in Ae von der Pfordten, p. 232, vi è un‘imprecisione: Ghazna diventa “Kadzea”.
252
Lorella Ventura
come famiglia, amore, stato, professione. Parla di “fanatismo della santità”,
un “mostruoso egoismo”110 che ottiene solo il fine soggettivo della salvezza del
singolo.
Nella cavalleria questo atteggiamento negativo che l’animo esclusivamente
religioso ha nei riguardi dell’umano come tale viene superato e la singolarità
soggettiva diviene libera per se stessa come singolarità. Le tre virtù principali
(onore soggettivo, amore, fedeltà) non sono esattamente qualità e virtù etiche,
per via della loro soggettività, ma, riunite insieme, costituiscono il contenuto
principale della cavalleria e il “punto di passaggio dal principio dell’interno religioso all’ingresso di questo nella vita spirituale mondana”111. Questo è il terreno
dell’arte romantica, che non ha più di fronte una oggettività presupposta, è “libera” e questo comporta che sia in larga misura arbitraria e accidentale. Negli
individui troviamo solo dei “gradi di eroismo” nei riguardi di amore, onore,
valore, fedeltà, che “dipendono principalmente dalla cattiveria o dalla nobiltà
dell’anima”112. In quest’ultima frase sono riconoscibili le caratteristiche attribuite all’individuo musulmano nelle Lezioni sulla filosofia della storia (dove, tra
l’altro, la cavalleria è vista nel suo rapporto di derivazione dall’Islam). Dunque
non sorprende che Hegel affermi che questa forma dell’arte romantica è di casa
in due emisferi: in Occidente, dove la poesia si basa sull’interiorità che è divenuta centrale, e la mondanità è solo uno dei lati, sottoposto a quello superiore
della fede; in Oriente, dove vi è la “prima espansione della coscienza che si dischiude alla liberazione dal finito”113. Ed è “specialmente l’arabo, che come un
punto, che non ha dinanzi altro che il suo arido deserto e il suo cielo, si apre vigorosamente allo splendore ed alla prima estensione della mondanità, pur conservandovi al contempo la sua libertà interna”114. In Oriente è la religione maomettana che “ha reso puro, per così dire, il terreno, ha scacciato ogni idolatria
della finitezza e della fantasia ma ha dato all’animo la libertà soggettiva che lo
riempie tutto”115. Nella religione musulmana la mondanità non è solo un’altra
sfera come per l’arte occidentale, ma cuore e spirito, mondo e fede sono “in sé
conciliati in lieta vitalità e, quasi mendicanti, si trovano felici a godere nella glorificazione teoretica dei loro oggetti, ad amare, ad essere soddisfatti e beati”116.
VAe II, pp. 164, 165; Estetica, p. 614.
Ivi, p. 172; ivi, p. 621.
112
Ivi, p. 175; ivi, p. 623.
113
Ibidem; ivi, p. 624.
114
Ibidem.
115
Ibidem.
116
Ivi, p. 176; ibidem.
110
111
La concezione dell’Islam nelle Lezioni sull’Estetica di Hegel
253
La libertà soggettiva musulmana non si chiude in un punto egoistico e singolare, legata al finito, ma è quella di un animo che si apre al contatto con gli
oggetti e con Dio, in un atteggiamento prevalentemente “teoretico”, al di fuori
dei desideri soggettivi e precedente ogni configurazione oggettiva di Dio. Una libertà “astratta” e non “concreta”. Ciò nonostante, il rapporto tra Dio, individuo
e mondo che esprime la poesia musulmana va nella direzione di una “peculiare”
unità più che di una scissione. Il rapporto con il mondo è positivo: non vi è separazione netta e fanatica tra Dio e mondo. D’altra parte, il “panteismo” non va
neanche inteso come unità indifferenziata, ma, come si è visto sopra, nel senso
di un vedere nelle cose un elemento “divino”, che le spiritualizza, le eleva. Si
potrebbe pensare al passaggio dalla negazione assoluta del finito alla negazione
della negazione. Non c’è neanche uno sprofondare delle cose o della coscienza
in Dio, che corrisponde alla visione di Hegel della sostanza di Spinoza, criticata
proprio per la sua mancanza della necessità della differenza e del finito. Inoltre,
a proposito di sostanza, la differenza tra concepire l’assoluto come sostanza o
come soggetto non sta nella personalità-impersonalità di Dio. Nel senso che
Dio può ben essere immaginato come un Io, un interlocutore come a volte in
Rū mı̄117, o Amante-Amato, ma non è soggetto perché non è pensato come differenziato in se stesso, determinato, “incarnato”. Anche se non pensa l’assoluto
come soggetto e spirito nel senso hegeliano, soprattutto qui nell’Estetica l’Islam
si mostra “più avanti” della filosofia di Spinoza, nella direzione dell’autonomia
dell’individuo e del mondo, persino nel suo lato “panteistico” persiano, tanto è
vero che il sublime musulmano è “positivo”118.
Allora il “panteismo musulmano” si avvicina alla concezione hegeliana perché suggerisce l’idea di un divino che non esclude il mondo. Qui converge effettivamente con l’Islam “reale”, così come nell’idea che il divino non si risolve nel
mondo ma lo “spiritualizza”, non solo nel senso che il mondo è creato e conservato da Dio, ma anche nella “presenza” di Dio nel mondo, se non altro vissuta
come “necessità”. Il poeta dunque interpreta questo sentimento dell’accordo
tra Dio, mondo e uomo. Il fatto che emerga l’individualità del poeta si accorda
con quella che è la visione del sostanziale e questa centralità dell’individualità
somiglia (con le differenze che abbiamo visto) a quella romantica.
Infine sulla differenza tra poesia araba e persiana. Non vi sono molte indicazioni da parte di Hegel su questo punto. Gli Arabi sono lodati per la loro
Cfr. Bausani (1980), p. 13.
Cfr. invece Bonsiepen (1981), p. 202, che sostiene che la poesia di Rūmı̄ per Hegel trova
la sua grandezza nella vicinanza con Spinoza, ma anche il suo limite, perché così è dato solo
l’inizio del filosofare.
117
118
254
Lorella Ventura
“prosaicità” e per il carattere “eroico”, l’autonomia individuale. I persiani per
il “panteismo” e le immagini raffinate. In un certo senso non vi è grande differenza perché (pur nella distanza di stili e di condizioni storico-sociali e anche
naturali119) mi pare che ambedue rappresentino momenti artistici che per Hegel hanno espresso la valorizzazione del soggetto in un quadro di armonia tra
individuo e universale. Probabilmente la differente sfumatura riguarda l’idea
che hanno del mondo, che appare più o meno “prosaico”120, nel senso della valorizzazione dell’immediatezza degli oggetti e così anche dell’individuo.
L’idea di prosaicità è presentata: 1) in contrasto con l’arte indiana121; 2) in
contrasto col sublime in generale e con la poesia indiana e persiana in particolare122; 3) in contrasto con la stessa letteratura araba posteriore, del tipo
“fantastico” come le Mille e una notte123. D’altra parte, come si diceva sopra,
gli Arabi sono caratterizzati principalmente come popolo, che si esprime in
una determinata forma artistica con la stessa efficacia prima e dopo l’islamizzazione, mentre il fiorire della poesia persiana è dovuto alla modifica radicale
portata dall’islamizzazione. Essi sono poi comunque accostati ai Persiani musulmani: ambedue i popoli sono “modelli” di un determinato tipo di poesia e
di atteggiamento spirituale124 e partecipano del fenomeno Islam, anche se in
modo diverso125.
119
Nell’epos vi è accordo essenziale tra individuo e ambiente esterno anche naturale: l’arabo è “uno con la sua natura e va compreso solo in relazione con il suo cielo, le sue stelle, i suoi
torridi deserti, le sue tende, i suoi cavalli. Infatti egli è a suo agio solo in questo clima, sotto
questo pezzo di cielo, in questi luoghi” (VAe I, p. 330; Estetica, p. 287).
120
Questa caratteristica è messa in evidenza da Hegel e molto apprezzata, anche se non
influenza la “posizione”: nel 1828/29 l’Ebraismo (con la sua caratteristica di prosaicità) segue
il panteismo dei musulmani persiani, nel 1826 invece lo precede.
121
Cfr. VAe I, p. 482; Estetica, p. 423: la prosaicità dell’Ebraismo rappresenta la prima vera
possibilità che vi siano miracoli.
122
Cfr. VAe II, pp. 17-18; ivi, p. 484: accanto al sublime e alla sostanzialità dell’unico Dio,
in Oriente è nata anche “la concezione della libertà, dell’autonomia, dell’indipendenza interna
della singola persona in sé, nella misura in cui l’Oriente permette lo sviluppo di questa tendenza. Noi dobbiamo cercarla come concezione dominante presso gli Arabi. […] Qui, a differenza
della mollezza e dell’indifferenza indiana e del panteismo della posteriore poesia musulmana,
si palesa l’autonomia più contegnosa del carattere personale, e anche agli oggetti viene lasciata
la loro immediata realtà delimitata e stabilita”.
123
Cfr. VAe III, p. 398; ivi, p. 1228: quella degli Arabi è “in Oriente la prima vera poesia,
senza fantasticherie e senza prosa, senza mitologie, senza dei, demoni, genii, fate e altri esseri
orientali, ma dotata di figure consistenti, autonome e, sebbene abbia tratti stravaganti, eccentrici, e giochi con immagini e paragoni, è umanamente reale e saldamente in sé conchiusa”.
124
Cfr. VAe II, p. 241; Estetica, p. 682: Persiani e Arabi sono uno splendido modello anche
per il presente e per la soggettività intimità odierna, nello splendore “orientale” delle loro immagini e nella libera beatitudine della fantasia che si occupa dei suoi oggetti in maniera del
tutto teoretica.
125
Cfr. ivi, pp. 175-176; ivi, p. 624;. Il momento soggettivo in Oriente è rappresentato dagli
Arabi. Ma in generale è la religione musulmana che ha “purificato” l’Oriente dall’idolatria e
La concezione dell’Islam nelle Lezioni sull’Estetica di Hegel
255
Certamente nella sua visione del “panteismo” persiano c’è una dose in più
di atteggiamento “speculativo”, nel senso della riconduzione (ma senza assorbimento) del particolare all’universale e probabilmente questo colpiva molto positivamente Hegel. Ma anche certi tratti che vedeva nella poesia araba potevano
invece soddisfarlo dal lato inverso, quello della realtà immediata che non sparisce di fronte all’infinito, ma in qualche modo (certamente non completamente
soddisfacente dal punto di vista di Hegel) ha una sua dignità e positività. Sullo
sfondo, ma senza emergere mai esplicitamente, c’è l’Islam come appare nelle
Lezioni sulla filosofia della storia e nelle Lezioni sulla filosofia della religione e si
ripetono alcune “ambiguità” che abbiamo già avuto modo di notare sul ruolo
dell’individuo, che oscilla tra gli estremi di un’autonomia che sfiora a volte l’arbitrio “sfrenato” e di una sorta di “beatitudine” e nobilissima libertà interiore
che viene dal fatto di percepire nelle cose e negli avvenimenti del mondo un
destino-necessità non cieco, ma opera di Dio.
BIBLIOGRAFIA
Opere di Hegel citate e abbreviazioni
Ästhetik, in Werke in zwanzig Bänden, hrsg. v. E. Moldenhauer e K. M. Michel, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1971, voll. XIII-XV (VAe); Vorlesungen über
die Ästhetik, hrsg. v. F. Bassenge, Aufbau-Verlag, Berlin 1955; trad. it. a cura di
N. Merker e N. Vaccaro, Estetica, Einaudi, Torino 1997 (Estetica); Vorlesung
über die Philosophie der Kunst (Berlin 1823), Nachschrift von H. G. Hotho, hrsg.
v. A.Gethmann-Siefert, Meiner, Hamburg 1998, in Vorlesungen, Ausgewählte
Nachscriften und Manuskripte, Bd. 2, Meiner, Hamburg 1998; trad. it. Lezioni
di estetica : corso del 1823. Nella trascrizione di H. G. Hotho. Traduzione e introduzione di P. D’Angelo, Laterza, Roma-Bari 2000 (Est. 1823); Philosophie
der Kunst oder Aesthetik. Nach Hegel im Sommer 1826. Mitschrift Kehler, hrsg.
v. A. Gethmann-Siefert und B. Collenberg-Plotnikov. Unter Mitwirkung von F.
Iannelli und K. Berr, Fink Verlag, München 2004 (Ae Kehler); Philosophie der
Kunst. Vorlesung von 1826, hrsg. von A. Gethmann-Siefert, J. Kwon und K.
Berr, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005 (Ae von der Pfordten); Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, trad. it. di B. Croce, Laterza, Bari
dalla finitezza, nella direzione della libertà soggettiva. Cfr. VAe III, p. 399; ivi p. 1228: l’islamizzazione ha fatto sentire il suo influsso benefico soprattutto sulla letteratura persiana; anche
presso gli Arabi vi sono cambiamenti e il “carattere eroico orginario” si altera, però continuano ad essere prodotte opere degne di nota, come le Maqāmāt.
256
Lorella Ventura
1963 (Enc.); Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse
1830, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1970; Enciclopedia delle scienze filosofiche
in compendio, con le aggiunte a cura di von Henning, Michelet, Boumann, UTET
(in particolare qui: Parte prima. La scienza della logica, a cura di V. Verra, Torino
1981; Parte terza. Filosofia dello spirito, a cura di A. Bosi, Torino 2000); Vorlesungen über die Philosophie der Religion, hrsg. v. W. Jaeschke, Meiner, Hamburg
1993; Sul famoso episodio del Mahā bhā rata noto come Bhagavad-Gı̄ tā , di Wilhelm von Humboldt, (Berlino 1826), in Due scritti berlinesi, trad. it. a cura di G.
Pinna, Liguori, Napoli 1990, pp.113-182.
Letteratura secondaria
Encyclopédie de l’Islam, II ed., Leiden 1954-60; Bausani, A., Introduzione,
in Gialā l ad-Dı̄ n Rū mı̄ , Poesie mistiche, BUR, Milano 1980; Bonacina, G., Introduzione. La storia narrata da Hegel, oggi, in G. W. F. Hegel, Lezioni sulla Filosofia della storia, Laterza, Bari 2003; Bonsiepen, W., Altpersiche Lichtreligion
und neupersische Poesie, in Hegel in Berlin, hrsg. von O. Pöggeler, Statsbibliotek
Preussischer Kulturbesitz, Berlin 1981, pp.196-204; Cantillo, G., L’arte nella filosofia dello spirito della Jenaer Realphilosophie, in Le forme dell’umano, ESI,
Napoli 1996, pp. 119-176; D’Angelo, P., Introduzione, in G. W. F. Hegel, Lezioni
di estetica: corso del 1823. Nella trascrizione di H. G. Hotho, Laterza, RomaBari 2000; Fück, J., Die arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20.
Jahrhunders, Otto Harrassowitz, Leipzig 1955; Gethmann-Siefert, A.; Stemmrich-Köhler, B., Von Hammer, Goethe und Hegel über Firdausi : Literaturkritik,
Geschichtsbild und kulturpolitische Implikation der Ästhetik, in Welt und Wirkung von Hegels Ästhetik, hrsg. v. Annemarie Gethmann-Siefert, Hegel-Studien/
Beiheft 27, Bonn, Bouvier 1986, pp. 295-325 (GS-SK 1); Gethmann-Siefert, A.;
Stemmrich-Köhler, B., Faust: die "absolute philosophische Tragödie" – un die "gesellschaftliche Artigkeit" des West-östlichen Divan. Zu Editionsproblemen der Ästhetikvorlesungen, in "Hegel-Studien", XVIII, 1983, pp. 23-63 (GS-SK 2); Hulin,
M., Hegel et l‘Orient, Paris, 1979; Kwon, Jeong-Im, Die Metamorphosen der "symbolischen Kunstform", in Phänomen versus System, Hegel-Studien/Beiheft 34,
Bouvier, Berlin 1992, pp. 41-89; Pinna, G., L‘Estetica, in Guide ai filosofi. Hegel a
cura di C. Cesa, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 201-236; Rosenkranz, K., Vita di
Hegel, a cura di R. Bodei, Arnoldo Mondadori, Vicenza 1974; Scarcia Amoretti,
B., Il mondo musulmano, Carocci, Roma 1998; Schneider, H., Eine Nachschrift
der Vorlesung Hegels über Ästhetik im Wintersemester 1820/21, in "Hegel Studien", XXVI, 1991, pp. 89-92; Schulin, E., L‘idea di Oriente in Hegel e Ranke, a c. di
M. Martirano, Liguori, Napoli 1998; Stemmrich-Köhler, B., Die Rezeption von
La concezione dell’Islam nelle Lezioni sull’Estetica di Hegel
257
Goethes West-östlichem Divan im Umkreis Hegels, in Kunsterfahrung und Kulturpolitik im Berlin Hegels, Hegel-Studien/Beiheft 22, Bonn, Bouvier 1983, pp.
381-396; Valentini, F., Arte, religione e sapere assoluto in Hegel, in Senso e storia
dell‘estetica, Nuova Pratiche Editrice, Parma 1995, pp. 201-225.
Heidegger: scienza originaria ed esperienza paolina della vita
259
Heidegger: scienza originaria ed esperienza paolina della vita
Memoria di Maurizio Filippo Di Silva
presentata dal socio corr. naz. Renata Viti Cavaliere
(seduta del 18 dicembre 2008)
Abstract. The purpose of this article is to explain Heidegger’s interpretation of Pauline epistles. It begins with the analysis of Heidegger’s first years of teaching in Freiburg
(1919-1923) and explains Heidegger’s idea of philosophy as Urwissenschaft through
Heidegger’s criticisms to psychology and the notions of hermeneutische Intuition and formale Anzeige. The article goes on analyzing Heidegger’s reflections on Paul’s epistles and
explains the Heideggerean meaning of Pauline announcement and waiting of paroysºa.
It testifies an authentic comprehension of Da-sein.
Obiettivo del presente saggio è tracciare il senso delle indagini heideggeriane relative all’esperienza paolina della vita. L’ambito d’indagine delineato
indica un luogo ben specifico dell’itinerario filosofico heideggeriano: gli anni
di insegnamento friburghesi 1919-1923. Al fine di penetrare nel “proprio” delle
analisi della Fenomenologia della vita religiosa sarà così necessario delineare,
in primis, il senso del percorso speculativo degli anni in questione. Traccia
decisiva per una comprensione preliminare di tale momento del pensiero heideggeriano e prezioso indice della direzione dell’analisi è ciò che emerge in una
pagina de L’idea della filosofia e il problema della visione del mondo. In un luogo
decisivo del Kriegnotsemester il filosofo osserva: “Siamo andati attraverso la povertà del deserto e vi persistiamo invece di conoscere eternamente le cose, di
comprenderle osservandole e di guardarle comprendendo. «[…] e Dio il Signore
fece crescere l’albero della vita […] nel mezzo del giardino – e l’albero della conoscenza del bene e del male»”1. è sotto il segno dell’uscita dal deserto della
teoria, dove non c’è più traccia di vita, dove è possibile affermare unicamente
di avere “tra le mani solo un mucchio di cose”2, che vanno intese le riflessioni
heideggeriane qui considerate. Questo allontanamento dal pensiero teoretico
1
M. Heidegger, L’idea della filosofia e il problema della visione del mondo, in Per la determinazione della filosofia, a cura di G. Cantillo, Guida, Napoli, 1993, pp. 64-65.
2
Ivi, p. 73.
260
Maurizio Filippo Di Silva
guarda al giardino della vita storica come meta del suo percorso. Compito del
saggio sarà così delineare lo sforzo heideggeriano in questione e centro di tale
tentativo sarà chiarire la natura del theorein e delineare la torsione heideggeriana della fenomenologia husserliana come costituirsi di una scienza non oggettivante delle esperienze vissute da intendersi come scienza originaria. Il presente
lavoro si struttura pertanto in due momenti: anni friburghesi (psicologia – intuizione ermeneutica – indicazione formale – ermeneutica dell’effettività) e Fenomenologia della vita religiosa (epistole paoline). Saremo così fedeli al cammino
heideggeriano immergendoci nel suo svolgimento.
1. Heidegger a Friburgo: 1919-1923.
La scelta di muovere nella presente indagine dalle riflessioni heideggeriane
relative alla psicologia è motivata dal rilievo che esse assumono per la nostra
riflessione. Esse rappresentano infatti un momento determinante nello sforzo
di comprensione del teoretico e nel tentativo di delineare alcuni aspetti essenziali dell’idea di filosofia come “scienza che conosce le esperienze vissute non
come qualcosa di oggettivo”3. La psicologia è infatti, per Heidegger, la scienza
oggettivante degli Erlebnisse. Essa condivide con la filosofia l’ambito d’indagine
pur accedendo alla stesso con un diverso approccio metodologico. Dalla caratterizzazione della psicologia emergerà pertanto ciò che la filosofia non è.
Le analisi heideggeriane relative alla scienza della vita oggettivante muovono dalle due configurazioni assunte dalla stessa nel suo tempo: la psicologia empirica e la fenomenologia (psicologia descrittiva). La prima è intesa da
Heidegger come scienza dello psichico. Oggetto della psicologia empirica è il
3
Ivi, p. 75; per un quadro relativo agli anni di insegnamento friburghesi 1919-1923 mi
limito a richiamare alcuni tra gli studi più rilevanti in merito: A. Ardovino, Heidegger. Esistenza ed effettività, Guerini, Milano, 1998; G. Bruni, Heidegger e l’essere come fatticità, vol. I,
La temporalità vuota, il dominio della celatezza, l’eclissi dell’altro, ETS, Pisa, 1997; A. Fabris,
L’«ermeneutica della fatticità» nei corsi friburghesi dal 1919 al 1923, in F. Volpi (a cura di), Guida a Heidegger, Laterza, Roma-Bari, 1997; S. Galanti Grollo, Esistenza e mondo. L’ermeneutica
della fatticità in Heidegger, il Poligrafo, Padova, 2002; M. Gardini (a cura di), Heidegger e la
fenomenologia dell’esistenza, Quodlibet, Macerata, 2000; T. Kisiel, Das Entstehen des Begriffsfeldes «Faktizität» im Frühwerk Heideggers, in «Dilthey Jahrbuch», IV, 1986-1987, pp. 91-120; E.
Mazzarella (a cura di), Heidegger oggi, Il Mulino, Bologna, 1998; E. Mazzarella, Ermeneutica
dell’effettività. Prospettive ontiche dell’ontologia heideggeriana, Guida, Napoli, 1993; V. Perego,
La genesi della fenomenologia ermeneutica nel primo Heidegger, in «Rivista di filosofia neoscolastica», XC, 1998, nn.1-2, pp. 51-77; S. Poggi, La logica, la mistica, il nulla, Edizioni della Normale, Pisa, 2006; D. Vicari, Ontologia dell’esserci. La riproposizione della «questione dell’uomo»
nello Heidegger del primo periodo friburghese (1916-1923), Zamorani, Torino, 1996.
Heidegger: scienza originaria ed esperienza paolina della vita
261
flusso delle esperienze vissute. Metodo d’indagine della stessa è l’esperienza
psicologica: l’esperire vivente è dunque conosciuto a partire dal modo in cui lo
stesso si manifesta nell’approccio indicato. Lo scopo conoscitivo della psicologia empirica è duplice: individuare gli elementi ultimi delle singole esperienze
vissute e determinare le leggi che ne regolano il costituirsi. Le esperienze vissute sono pertanto immerse nella successione temporale e sottoposte a regolarità
nomologiche: esse sono dunque processi. La fenomenologia husserliana è invece intesa da Heidegger come scienza descrittiva degli Erlebnisse. La conoscenza
delle esperienze vissute non coincide in questo caso con l’individuazione delle
leggi che ne determinano il costituirsi bensì con la descrizione delle stesse.
Via metodologica propria della psicologia descrittiva è la descrizione riflessiva. Senso unitario dell’approccio metodologico delle due configurazioni della
psicologia è la rappresentazione e la constatazione delle esperienze vissute. Ma
il rappresentare e il constatare costituiscono il metodo adeguato ad afferrare
il flusso dell’esperire vivente come tale? Può dunque la psicologia cogliere gli
Erlebnisse? Heidegger non manca di sottolineare come tale via d’accesso alla
vita sia inadatta al suo scopo. è la presa di distanza dal puro vivere a segnare
il fallimento dello sforzo della psicologia empirica e della fenomenologia husserliana: è la natura oggettivante e de-vitalizzante dell’approccio scientifico a
rendere impossibile cogliere la vita in se stessa.
Sarà dunque compito della fenomenologia heideggeriana indicare la via
d’accesso ad essa. Indicazioni determinanti in tal senso emergono da quanto il filosofo tedesco afferma nelle pagine del Kriegnotsemester. Qui Heidegger
osserva: “è necessario sin da ora chiarire contemporaneamente il carattere
fondamentale della posizione metodologica, dato che ci troviamo ancora nella
fase preliminare del metodo fenomenologico. Dobbiamo dunque attuare in piena vitalità l’esperienza vissuta del mondo-ambiente e dopo attuarla nel vedere,
nell’osservarla, e dopo osservare questo stesso osservare e studiare il come del
primo osservare. L’assolutezza del vedere non si può ottenere con un colpo, con
un artifizio o un gioco di prestigio ma innanzitutto eliminando radicalmente tutte le relatività (che sono poi essenzialmente preconcezioni teoretiche)”4.
Come emerge con evidenza, la visione fenomenologica è possibile solo nella
piena distanza dal teoretico. è dunque essenziale per la comprensione del progetto fenomenologico heideggeriano analizzare preliminarmente la natura del
theorein. Determinante per cogliere il senso heideggeriano del teoretico è muovere da un rilievo presente in un luogo del Kriegnotsemester: “Naturalmente non
4
Ivi, p. 93.
262
Maurizio Filippo Di Silva
ho bisogno di dedurre la sensazione di marrone come, prima, la causa che è nel
mondo esterno; la sensazione è essa stessa presente, ma solamente in quanto
ho distrutto l’elemento ambientale, lo ho cancellato, me ne sono distolto, ho
messo fuori gioco il mio io storico ed ho fatto teoria, primariamente nella presa
di posizione teoretica. Questo carattere primario è tale solo se faccio già teoria,
quando c’è un atteggiamento teoretico, il quale, per sua natura, è possibile solamente come distruzione dell’esperienza vissuta del mondo-ambiente”5. Il teoretico è dunque, per Heidegger, l’atteggiamento di vita che si attua nel distaccarsi
dal vivere immediato. Esso, come tale, deriva dall’atteggiamento naturale e non
può che costituirsi in un sempre rinnovato allontanamento da esso. Al fine di
cogliere al meglio il senso di tale presa di distanze dall’esperienza vissuta del
mondo-ambiente è necessario delineare i caratteri costitutivi di quest’ultima. Il
vivere ambientale è segnato dall’incontro immediato con il significarsi del mondo: “Nell’esperienza vissuta del vedere la cattedra mi si offre qualcosa a partire
da un mondo-ambiente immediato. Questa ambientalità (la cattedra, il libro, la
lavagna, il quaderno di appunti, la stilografica, il bidello, il corpo degli studenti,
il tram, l’automobile, etc., etc.) non sono cose con un determinato carattere di
significato, oggetti, e per di più concepiti come significanti questa e quest’altra
cosa; al contrario l’elemento significativo è il carattere primario, mi si offre immediatamente, senza un detour intellettuale che passi per il concepire le cose.
Vivendo in un ambiente, mi si significa dappertutto e sempre, tutto è mondano,
«si fa mondo», il che non coincide con il «ha valore»”6. L’incontro con il darsi
del significato, l’ er-fahren, è dunque l’aspetto essenziale dell’esperire vivente. In
esso non c’è alcuna traccia di scissione tra io e mondo. Il mio io “risuona” nel
vivere immediato: puro vivere la vita nel darsi del mondo.
Alla luce dell’individuazione dei caratteri essenziali del vivere immediato è
ora possibile cogliere e chiarire il senso del prenderne le distanze. Primo passo
di tale distacco e luogo genetico della scissione soggetto-oggetto è il prendere
conoscenza: “Il prender cognizione: stadio preliminare (forma embrionale del
teoretico). Esso non esce fuori dall’esperienza di vita naturale. La situazione
naturale non viene scossa. Nel prendere cognizione non ci sono i dati di fatto
come tali ma il «che cosa» nel suo mero esser-così”7. è nella consapevolezza di
ciò che si incontra che viene a segnarsi il primo iato dalla vita: non già il pieno
consumarsi di una frattura, ma il primo rompersi di un nesso originario. L’allon Ivi, pp. 81-82.
Ivi, pp. 70-71.
7
M. Heidegger, Sull’essenza dell’università e dello studio accademico, in Per la determinazione della filosofia, cit., p. 195.
5
6
Heidegger: scienza originaria ed esperienza paolina della vita
263
tanamento dalla vita trova nella riduzione del mondo a dato il primo passo oltre
il vivere ambientale. La presa di distanza dal vivere si accresce ulteriormente
nel cancellare il carattere di significato che si dona originariamente nell’esperire vivente. In tale sforzo il mondo è ridotto a cosa: “La cosa è ancora presente
solo come tale, cioè è reale, esiste. La realtà non è dunque una caratterizzazione
ambientale, ma è una caratterizzazione insita nell’essenza della cosalità, una
caratterizzazione specificamente teoretica. Ciò che è significativo è decostruito,
svincolato dalle interpretazioni fino ad arrivare a questo resto: l’essere reale”8.
Coessenziale al distanziarsi dal vivere ambientale è il de-storicizzarsi dell’io. Il
resto dell’io storico è l’io teoretico. Esso ha di fronte a sé un mondo ridotto a
fatto e opera tracciando metodicamente collegamenti tra queste ultime vestigia
di mondo. Del mondo non c’è più traccia: c’è solo la realtà.
Il teoretico va dunque pensato a partire dal suo radicamento nel vivere del
quale costituisce una sempre aperta possibilità. L’oggettivazione del mondo ne
è la sua più evidente manifestazione. Tale atteggiamento nella sua piena attuazione cancella la traccia essenziale della vita: il significato. Nel teoretico non
c’è dunque né vita né mondo. Le scienze oggettivanti sono diretta espressione
di ciò. Sono ora chiare le ragioni dell’inadeguatezza della psicologia empirica
e della psicologia descrittiva nell’afferrare la vita stessa. In esse gli Erlebnisse
sono strappati alla dinamicità del loro fluire e ridotti ad oggetti di un soggetto.
L’atteggiamento teoretico rende impossibile accedere all’esperire vivente nella
sua purezza. Spetta dunque alla fenomenologia cogliere la vita in se stessa.
Come può d’altronde la fenomenologia, come scienza delle esperienze vissute, cogliere la vita come tale se ogni conoscere richiede una presa di distanza
dal conosciuto? Com’è anche solo possibile parlare delle esperienze vissute senza oggettivarle? La distanza tra vita e sapere appare incolmabile. Dove c’è vita
non c’è conoscenza, dove c’è scienza tutto è esangue. è nella direzione di un
sapere vivente che si indirizzano gli sforzi heideggeriani qui considerati. La via
heideggeriana verso la vita assume ora i tratti del salto nel mondo: “Stiamo al
crocevia metodologico che decide in generale sulla vita e la morte della filosofia,
stiamo sull’orlo di un abisso: o si precipita nel nulla, cioè nell’assoluta fattualità, oppure riesce il salto in un altro mondo, o, più esattamente: nel mondo”9.
Alla luce delle considerazioni relative al teoretico è ora possibile delineare
il “proprio” dell’approccio fenomenologico heideggeriano. Il vedere fenomenologico è stato caratterizzato da Heidegger come non teoretico. Esso va dunque
8
M. Heidegger, L’idea della filosofia e il problema della visione del mondo, in Per la determinazione della filosofia, cit., pp. 84-85.
9
Ivi, p. 63.
264
Maurizio Filippo Di Silva
inteso come immerso nel vivere stesso. Esso non fa della vita un oggetto: è un
osservare vivente. Il vedere vivente è l’intuizione della vita stessa: “Il problema
metodologico fondamentale della fenomenologia, la domanda circa il modo
della esplorazione scientifica della sfera dell’esperienza vissuta è subordinato al
«principio dei princìpi» della fenomenologia. Husserl lo formula così: «Tutto
ciò che si dà originalmente nell’«intuizione» [...] è da assumere come si dà»”10.
Ma come può tale intuire non fare dell’intuito un oggetto? Come può parlarne
senza oggettivarlo?
Come evidente, le critiche natorpiane alla fenomenologia husserliana sembrano poter colpire nel segno anche nei confronti delle pretese conoscitive della
fenomenologia heideggeriana. La natura dell’osservare e del dire viventi va colta a partire da un approfondimento del senso del “principio dei princìpi”: “Se
si intendesse con il principio una proposizione teoretica allora la denominazione non sarebbe congruente. Ma già il fatto che Husserl parli di un principio
dei princìpi, dunque di qualcosa che precede tutti i princìpi, sul quale non può
ingannare nessuna teoria, mostra che esso non è di natura teoretica, anche se
Husserl non si esprime in proposito. Esso è l’intenzione originaria della vita
verace, l’atteggiamento originario dell’esperienza vissuta e della vita come tali,
l’assoluta simpatia della vita, identica con la stessa esperienza”11. L’intuizione
non teoretica è dunque l’intenzione originaria del (genitivo soggettivo) vivere:
l’esperire. Essa coglie la vita nel suo darsi. Quest’ultima è dunque fenomeno: il
suo mostrarsi è il significarsi. Essa è l’evento: “(caratterizzazione dell’esperienza vissuta come evento – un che di significativo, non qualcosa di oggettuale)”12.
Perché la vita si manifesti è necessario che sia lasciata essere. Il mondo e la
vita sono privi di senso solo per un pensiero irrigiditosi nel teoretico: il nichilismo è un problema tutto interno al pensiero rappresentativo. Lo stesso cogliere
ciò che si mostra non deve uscire dalla vita stessa. Esso deve dunque esperire
vivendo l’esperienza vissuta. Il senso del principio husserliano può dunque essere racchiuso, per Heidegger, nell’esortazione a immergersi nella vita. Nessun
distacco dalla vita nel conoscerla, nessun atto riflessivo che allontani la vita da
10
Ivi, pp. 102-103. Sul problema della fenomenologia negli anni friburghesi confronta:
M. Gardini, Heidegger verso le «cose stesse» di Husserl, in M. Gardini (a cura di), Heidegger e
la fenomenologia dell’esistenza, cit., pp. 75-109; F. Hogemann, Heideggers konzeption der Phänomenologie in den Vorlesungen aus dem Wintersemester 1919/1920 und dem Sommersemester
1920, in «Dilthey Jahrbuch», IV, 1986-1987, pp. 91-120; R. Lazzari, Fenomenologia come scienza dell’origine. Osservazioni sulle prime lezioni friburghesi di Heidegger, in M. Gardini (a cura
di), Heidegger e la fenomenologia dell’esistenza, cit., pp. 15-38.
11
Ivi, p. 103.
12
Ivi, p. 68.
Heidegger: scienza originaria ed esperienza paolina della vita
265
se stessa. è qui che si consuma il distacco da Husserl ed è qui che emerge la
debolezza delle critiche natorpiane.
Il coglimento originario del vivere nella sua purezza, l’intenzione originaria
della (ora genitivo soggettivo e oggettivo) vita è l’intuizione ermeneutica: “L’esperienza vissuta dell’esperienza vissuta – appropriante che si porta con sé – è quella
comprendente, è l’intuizione ermeneutica, la costituzione fenomenologica originaria del pre- e del ri-correre, dalla quale è escluso ogni porre teoretico-oggettivante, trascendente. L’universalità dei significati verbali significa primariamente qualcosa di originario: mondanità dell’esperienza vissuta esperita in modo
vivente”13. Nel vivente incontro con il significarsi della vita noi ne cogliamo la
radicale dicibilità: nessuna traccia di ricaduta nel teoretico dunque. La vita è
accessibile in se stessa. Via d’accesso al vivere è lo sprofondarsi nello stesso. La
vita può dunque essere colta solo vivendo.
Strumento essenziale per l’accesso originario all’esperienza vissuta è l’indicazione formale. In essa diventa manifesto lo sforzo heideggeriano di liberare l’indagine fenomenologica dalle tracce del theorein. Più specificamente la minaccia
del teoretico per l’indagine fenomenologica è qui costituita dalla concettualità
corrente che nella sua teoreticità esprime determinazioni proprie di obietti e
non di fenomeni. Nell’accesso alla vita in sé è dunque necessario prendere le
distanze da tale quadro concettuale e dall’accedere teoretico ad esso. è tale la
specifica finalità dell’indicazione formale che assume dunque, come compito
principale, quella di tutelare l’accesso alla vita da deformazioni teoretiche e di
indirizzare lo sforzo fenomenologico in modo originario. Heidegger definisce
l’indicazione formale “l’uso metodico di un senso che fa da guida all’esplicazione fenomenologica. I fenomeni sono esaminati in relazione a ciò che il senso
formalmente indicante reca in sé”14. Nel suo carattere di guida dell’indagine
l’indicazione formale non determina alcuna immissione di idee preconcette nel
contesto dell’esplicazione. Essa mira unicamente a impostare originariamente l’indagine. Tale strumento svolge una funzione di liberazione del fenomeno
da ogni possibile preconcezione teoretica. è dunque dalla vita effettiva e, più
precisamente, dall’inautenticità nella quale essa giace che è necessario muovere per accedere alla vita nella sua autenticità. L’esplicazione fenomenologica
si configura così come un accesso all’originario dall’inautentico. L’indicazione
Ivi, p. 109.
M. Heidegger, Introduzione alla fenomenologia della religione, in Fenomenologia della
vita religiosa, Adelphi, Milano, 2003, p. 90. Sull’indicazione formale confronta J. Van Buren,
The Ethics of «formale Anzeige» in Heidegger, in «American Catholic Philosophical Quarterly»,
LXIX, 1995, pp. 151-170.
13
14
266
Maurizio Filippo Di Silva
formale assume così il compito di impostare tale iter. Essa mira all’esplicazione del fenomeno: “Che cos’è la fenomenologia? Che cos’è il fenomeno? Anche
quest’ultimo può essere indicato qui solo in termini formali. Ogni esperienza
– sia come esperire sia come esperito – può «essere colta nel fenomeno». Si può
cioè domandare: 1) del «che cosa» originario che in esso è esperito (contenuto),
2) del «come» originario in cui esso è esperito (riferimento), 3) del «come» originario in cui il senso del riferimento è attuato (attuazione). Queste tre direzioni
del senso (senso del contenuto, senso del riferimento, senso dell’attuazione)
non stanno però semplicemente l’una accanto all’altra. Il «fenomeno» è totalità
di senso secondo queste tre direzioni. La «fenomenologia» è esplicazione di
questa totalità di senso: essa fornisce il «løgoq» dei fenomeni, cioè il «løgoq» nel
senso del «verbum internum» (non nel senso della logicizzazione)”15. Compito
della scienza originaria è dunque esplicare fenomenologicamente il fenomeno
secondo le direzioni di senso indicate. Esse non vanno intese come dimensioni
del fenomeno separate che trovano un’unità artefatta nel corso dell’indagine,
ma, al contrario, costituiscono nella loro relazione l’unità vivente della vita.
Centro dell’accesso vivente alla vita è la determinazione del senso dell’attuazione: “Fenomenologia del formale (considerazione originaria del formale stesso
ed esplicazione del senso del riferimento all’interno della sua attuazione)”16.
Esso si configura come cuore della totalità di senso fenomenale e come storicità vivente dell’esserci. L’essere dell’ente che noi stessi siamo non assume così i
contorni né della regione dell’ente nella quale siamo inseriti (generalizzazione)
né del senso del riferimento dell’atteggiamento teoretico (formalizzazione), ma
non è altro che il senso dell’attuazione della vita effettiva. Adatta al suo accesso
si rivela essere unicamente un’ontologia intesa come ermeneutica dell’effettività.
La ricerca heideggeriana giunge dunque a configurarsi come un’analisi
dell’essere dell’esserci che procede secondo il metodo ermeneutico. Ma cosa intende Heidegger per ermeneutica? In un passo di Ontologia. Ermeneutica dell’effettività Heidegger afferma: “Nel titolo dell’indagine seguente l’ermeneutica non
è utilizzata nel significato moderno e in generale non come dottrina, per quanto
generalmente intesa, della interpretazione. Il termine, in connessione con il suo
significato originario, indica piuttosto: una determinata unità dell’esecuzione
dello ®rmhne¥ein (del comunicare), ossia dell’interpretare la effettività che porta all’incontro, alla vista, alla presa e al concetto”17. Il significato originario di
Ivi, pp. 98-99.
Ivi, p. 98.
17
M. Heidegger, Ontologia. Ermeneutica dell’effettività, a cura di E. Mazzarella, Guida,
15
16
Heidegger: scienza originaria ed esperienza paolina della vita
267
®rmhne¥ein cui Heidegger fa in questo passo riferimento è quello di cui c’è traccia negli scritti di Platone e Aristotele. L’®rmhne¥ein è lì inteso come lo s-velare, il
rendere manifesto l’essere dell’ente: il metodo ermeneutico non è dunque altro
che la fenomenologia stessa. L’essere dell’esserci da s-velare fenomenologicamente è il vivere effettivo: “Effettività è la denominazione per il carattere di essere del «nostro» «proprio» esserci”18. Si è conformemente all’essere nel nostro
esser-ci: “Essere-transitivo: essere la vita effettiva!”19. L’esistenza c’è dunque nel
suo storico esser-ci e costituirsi come possibilità sempre aperta di sceglier-si
o di incontrare la propria rovina: “L’essere della vita effettiva si distingue per
il fatto che esso è nel Come dell’essere dell’esser-possibile di sé stesso”20. L’ermeneutica dell’effettività si configura così come autointerpretazione della vita
effettiva. Essa sottrae l’esserci all’autoestraneazione da cui è colpito e lo apre
a se stesso. L’®rmhne¥ein è la radicale possibilità dell’esser-desto dell’esserci nei
suoi confronti. Tale coglimento originario di sé, accedendo alle strutture originarie dell’esserci effettivo, sancisce il crollo delle categorie tradizionali della
vita storica: “Apparirà tuttavia chiaro che tramite l’esplicazione dell’esserci effettivo sarà fatto saltare tutto il tradizionale sistema delle categorie: a tal punto
saranno radicalmente nuove le categorie dell’esserci effettivo”21. Le categorie non
teoretiche della vita sono gli esistenziali. Il progetto heideggeriano dell’ermeneutica dell’effettività assume così i contorni dell’annuncio del vivere effettivo.
Il senso del termine “ontologia” presente nel titolo perde ogni equivocità e
assume ora contorni ben specifici e definiti: “Come annotazione per il primo
annuncio dell’effettività. La denominazione più prossima: Ontologia”22.
Vive dunque nel percorso filosofico heideggeriano di questi anni lo sforzo
di afferrare l’essere dell’esserci. Con queste ultime indicazioni il cammino che
conduce fuori dal deserto del teoretico è compiuto. D’altronde tale fine non
manca di assumere i contorni di un nuovo inizio. è alla luce del quadro delineato che è ora possibile avvicinare le analisi dedicate da Heidegger alle epistole
paoline.
Napoli, 1992, p. 24.
18
Ivi, p. 17.
19
Ibidem.
20
Ivi, p. 25.
21
M. Heidegger, Introduzione alla fenomenologia della religione, in Fenomenologia della vita
religiosa, cit., pp. 88-89.
22
M. Heidegger, Ontologia. Ermeneutica dell’effettività, cit., p. 9.
268
Maurizio Filippo Di Silva
2. Fenomenologia della vita religiosa.
Alla luce delle considerazioni relative al percorso filosofico heideggeriano
negli anni di insegnamento friburghesi 1919-1923 è ora possibile delineare il
senso e la natura del confronto del filosofo tedesco con le epistole paoline. L’interesse heideggeriano per il cristianesimo è ben più che qualcosa di occasionale. Esso attraversa gli anni di formazione del pensatore tedesco ed emerge ora
negli sviluppi filosofici del periodo qui considerato. è all’interno dello sforzo
di pensare la vita nella sua purezza che assume senso l’incontro filosofico con
il cristianesimo delle origini. L’esperienza protocristiana della vita e, seppur in
un primo già percepibile distacco, Agostino, attestano infatti un afferramento
originario del vivere stesso. Il primo cristianesimo assume così un valore paradigmatico per la ricerca heideggeriana: esso rappresenta infatti un modello
di sapere vivente. è tale distanza dal teoretico a suscitare l’attenzione di Heidegger e a indirizzare la ricerca del pensatore tedesco verso le epistole paoline
e le Confessioni agostiniane; in esse Heidegger trova traccia del coglimento
originario di alcune tra le strutture essenziali dell’esserci stesso delle quali sarà
possibile rinvenire la presenza nell’analitica dell’esserci di Sein und Zeit. Allo
stesso tempo, però, l’analisi delle Confessioni non manca di individuare i segni
dell’avvenuta teoretizzazione della coscienza cristiana della vita sotto il segno
della penetrazione delle categorie dell’ontologia neoplatonica. Viene così a costituirsi quel nesso tra grecità e theorein che fornirà al pensatore tedesco la griglia concettuale decisiva nel misurarsi con la problematica dell’ellenizzazione
della coscienza cristiana della vita.
La seconda fase della presente analisi si soffermerà sulle interpretazioni
fenomenologiche heideggeriane delle epistole paoline. Obiettivo della stessa è
chiarire gli specifici risultati della protofenomenologia dell’esserci dell’apostolo. L’attenzione dell’indagine si indirizzerà al senso dell’attesa cristiana della
paroysºa da intendersi sotto il segno della lotta per il sé della cura autentica e
della temporalità originaria. In essa è rinvenibile, per Heidegger, traccia della
vita effettiva.
2.1. Paolo
Nel tentativo di chiarire il senso dell’esplicazione fenomenologica delle epistole paoline è essenziale sviluppare i motivi sottesi al primo concreto strutturarsi della ricerca heideggeriana. In un passo introduttivo dell’analisi fenomenologica della I lettera ai Tessalonicesi Heidegger osserva: “Ora, però, non
Heidegger: scienza originaria ed esperienza paolina della vita
269
prendiamo più in considerazione il contesto storico obiettivo, bensì cogliamo
la situazione come se scrivessimo la lettera insieme a Paolo: compiamo insieme
a lui l’atto di scrivere – ovvero di dettare – la lettera”23. L’esplicazione fenomenologica mira dunque ad accedere al senso stesso dello scrivere paolino. Esso
emerge considerando adeguatamente alcuni elementi presenti nelle analisi heideggeriane dedicate all’epistola ai Galati. In un luogo decisivo della stessa Heidegger afferma: “Nella Lettera ai Galati Paolo è in lotta con gli Ebrei e con gli
Ebrei cristiani. Abbiamo quindi a che fare con la situazione fenomenologica
della lotta religiosa e della lotta come tale”24. è il termine lotta nella sua duplice ricorrenza a costituire l’elemento decisivo per le nostre indagini. La lotta
con gli Ebrei è lo sforzo paolino di affermare l’esperienza cristiana della vita
nella sua originarietà. Il senso a essa proprio emerge alla luce dell’esistenza di
Paolo: “Paolo può essere visto nella sua lotta con la sua passione religiosa nella sua esistenza come apostolo, caratterizzata dalla contesa fra la «legge» e la
«fede»”25. L’esistere di Paolo coincide con il suo essere apostolo. Nell’annuncio
del Vangelo si rende visibile il sempre rinnovantesi sforzo paolino di avere il
proprio sé: “L’esigenza fondamentale dell’avere-Dio è l’opposto di ogni cattiva
mistica. Decisivo diventa non lo sprofondamente mistico, lo sforzo particolare,
bensì sopportare la debolezza della vita. Per Paolo la vita non è un mero flusso
di esperienze vissute, poiché essa è solo nella misura in cui egli ce l’ha”26. L’esistenza di Paolo colta nella dinamicità della sua attuazione si rivela essere cura
autentica: il suo esistere è strutturalmente lotta per il sé. Heidegger racchiude
tutto ciò nell’espressione “Paolo è in lotta”27. Essa indica la natura dell’esperien23
M. Heidegger, Introduzione alla fenomenologia della religione, in Fenomenologia della vita
religiosa, cit., pp. 126-127. Sull’interpretazione fenomenologica delle epistole paoline confronta: C. Angelino, Il religioso nel pensiero di M. Heidegger, Introduzione all’edizione italiana di M.
Heidegger, L’abbandono, il Melangolo, Genova, 1983, pp. 9-24; A. Ardovino, Heidegger interprete di Paolo. L’esperienza effettiva della vita e il senso della temporalità in quanto tale, in «Annali
di scienze religiose», I, 1998, pp. 305-336; P. Colonnello, Tempo, contrattempo e kairòs, in E.
Mazzarella (a cura di), Heidegger oggi, cit., pp. 319-326; F. Costa, Heidegger e la teologia, Longo,
Ravenna, 1974; A. Molinaro (a cura di), Heidegger e San Paolo: interpretazione fenomenologica
dell’Epistolario paolino, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2008; V. Pinto, Storicità ed effettività dell’io ed esperienza cristiana originaria della vita: Paolo e Agostino nei corsi di
Heidegger del 1920-1921, in «Atti dell’Accademia di scienze morali e politiche», Vol. XCVIII,
Napoli, 1987, pp. 165-193; U. Regina, Servire l’essere con Heidegger, Morcelliana, Brescia, 1995;
L. Savarino, Heidegger e il cristianesimo. 1916-1927, Liguori, Napoli, 2001; L. Savarino, Filosofia e temporalità, in M. Gardini (a cura di), Heidegger e la fenomenologia dell’esistenza, cit., pp.
39-73; T. Sheehan, Heidegger e il suo corso sulla Fenomenologia della religione, in «Filosofia»,
III, 1980, pp. 431-446.
24
Ivi, pp. 106-107.
25
Ivi, p. 107.
26
Ivi, p. 140.
27
Ivi, p. 110.
270
Maurizio Filippo Di Silva
za esistenziale paolina e il senso dello scrivere dell’apostolo. Né la lotta religiosa
né la stesura delle epistole si rivelano dunque essere meri episodi nell’esistenza
dell’apostolo: essi poggiano al contrario sull’esserci stesso di Paolo e ne sono
diretta espressione.
L’esistere paolino, come cura autentica, poggia sul sapere originario della
propria fatticità: “Riguardo all’atteggiamento fondamentale di Paolo si veda
Fil, 3, 13: autocertezza della posizione nella propria vita – frattura nella sua
esistenza – comprensione storica originaria del proprio sé e del proprio esserci. Partendo da qui si compie la sua opera di apostolo e di uomo”28. In esso la
vita è colta nella sua originarietà: “Il sapere riguardo al proprio essere-divenuti
pone all’esplicazione un compito del tutto particolare. Su questa base si determinerà il senso di una fatticità che è accompagnata da un sapere specifico. Noi
separiamo l’uno dall’altra il sapere e la fatticità, ma questa è coesperita in modo
originario”29. Il sapere effettivo coglie l’esserci come possibilità sempre aperta
di realizzar-si o di perder-si. L’esserci è sempre chiamato a una decisione in cui
ne va di se stesso. è il proprio essere-divenuti che è in pericolo e per il quale si
è chiamati a decidere: “Fratelli, io non pretendo di averla già afferrata; questo
dico: dimenticando il passato e protendendomi verso l’avvenire, mi lancio verso
la mèta, al premio della celeste chiamata di Dio in Cristo Gesù”30 .
è in tale vigile sapere che si tiene la vita ed è nell’intrascendibilità del consapevole rischio per il sé che vive l’angoscia dell’apostolo: “Paolo vive in un’angustia particolare che gli è propria in quanto apostolo, ossia nell’attesa del Secondo Avvento del Signore. Questa angustia articola la specifica situazione di
Paolo. Ogni attimo della sua vita si determina in base a essa, sicché egli, nonostante la gioia che lo anima in quanto apostolo, è costantemente sottoposto a
una sofferenza”31. L’angoscia per il sé assume dunque i contorni dell’angustia
per la paroysºa.
Che rapporto c’è tra la cura autentica e il Secondo Avvento del Signore?
Cosa va inteso per paroysºa? Tale termine ha una storia che ne attesta l’evoluzione non solo semantica, ma anche concettuale. Con il termine paroysºa,
va pensato, nell’orizzonte concettuale specificamente cristiano, “il ritorno del
Messia già comparso”. Ma come va inteso tale ritorno? Quando avverrà? E’
precisamente sul senso e la natura della risposta paolina alla seconda doman-
Ivi, p. 112.
Ivi, p. 134.
30
Paolo, Lettera ai Filippesi, 3, 13.
31
M. Heidegger, Introduzione alla fenomenologia della religione, in Fenomenologia della vita
religiosa, cit., p. 138.
28
29
Heidegger: scienza originaria ed esperienza paolina della vita
271
da che Heidegger costruisce la propria interpretazione fenomenologica della I
lettera ai Tessalonicesi. A partire da essa sarà inoltre possibile dare risposta alla
prima questione sollevata. Nelle analisi dedicate alla I epistola ai Tessalonicesi
Heidegger osserva: “Si tratta delle questioni seguenti: 1. Come stanno le cose
riguardo ai defunti, che non vivono più la paroysºa (4, 13-18)? 2. Quando si attua la paroysºa (5, 1-12)? Affrontiamo dapprima la seconda questione. Soltanto
in base al «come» della risposta possiamo capire in che modo Paolo intenda la
domanda”32. Heidegger nota fin da subito come la risposta paolina alla domanda relativa al “quando” della paroysºa si caratterizzi per la natura della stessa.
In essa l’apostolo non indica uno specifico momento in cui il Secondo Avvento
del Signore avrà luogo né afferma di non sapere quando essa avverrà, ma richiama due diversi modi di essere nel vivere effettivo: la cura inautentica e la
cura autentica. La prima è propria di quanti sono assorbiti dal mondo: “Coloro
che in questo mondo trovano quiete e sicurezza sono coloro che si attaccano
al mondo, poiché esso offre loro pace e sicurezza. «Pace e sicurezza» caratterizzano la modalità del riferimento di coloro che parlano così”33. Essi vivono
nella piena dimenticanza di sé e nella massima distanza dal giorno del Signore:
“Un’improvvisa rovina li sorprende (5, 3: tøte aʺfnºdioq aªto¡q ®fºstatai œleuroq).
Essi ne sono colti di sorpresa, non se la aspettano. O piuttosto: la loro attesa
è proprio quella conforme all’atteggiamento; il loro attendere si assorbe in ciò
che la vita arreca loro. E poiché vivono in questa attesa, la rovina li colpisce in
modo che non possono sfuggirle. Non possono salvare se stessi perché non hanno se stessi, perché hanno dimenticato il proprio sé, perché non hanno se stessi
nella chiarezza del sapere autentico. Perciò non possono né cogliere né salvare
se stessi”34. Ad essi Paolo contrappone quanti vivono alla luce della coscienza
vigile di sé e nell’angosciante sforzo di decider-si per la propria autenticità. Essi
sono nel giorno del Signore: “5, 4: Ême¡q d™, Ωdelfoº, oªk ®st‚ ®n skøtei: «Ma voi,
fratelli, non siete nelle tenebre». Òna Ô Ôm™ra Êm˙q ˜q kl™pthq katalåbë, «onde quel
giorno vi sorprenda come un ladro». Ôm™ra ha un doppio senso: 1) rispetto alla
tenebra significa la «luce» del sapere di se stessi (Ême¡q yiŒoÁ fvtøq ®ste 5, 5); 2)
Ôm™ra significa «giorno del Signore», ossia «giorno della paroysºa»”35. Come
emerge chiaramente la domanda relativa al “quando” del giorno del Signore
diviene una domanda relativa al “come” del mio vivere. Si è nel giorno del Signore nel decider-si per il proprio sé. Nello sforzo di essere ciò che siamo noi
Ivi, pp. 139-40.
Ivi, p. 144.
34
Ibidem.
35
Ibidem.
32
33
272
Maurizio Filippo Di Silva
entriamo in quella relazione vivente con Dio che è la paroysºa: “paralambånein
non significa un appartenere, bensì un accogliere raggiungendo un’interazione vivente con Dio. L’essere presente di Dio si riferisce fondamentalmente al
cambiamento di vita (peripate¡n). L’accogliere è in se stesso un cambiamento
dinanzi a Dio”36.
“La ricomparsa del Messia già comparso” non è dunque un evento non ancora verificatosi del quale porsi in attesa aspettando che avvenga: “A tutta prima si potrebbe pensare che il comportamento fondamentale nei confronti della
paroysºa sia un attendere e che la speranza (®lpºq) cristiana ne sia un caso speciale. Questo è però falsissimo! Mediante la semplice analisi della coscienza di
un evento futuro non giungeremo mai al senso del riferimento della paroysºa”37.
L’attesa cristiana è uno sforzo costante di essere nell’interazione vivente con
Dio: è questa la radice dell’imminenza della paroysºa. Chi è nella luce riconosce
l’Anticristo. Solo nell’essere servi di Dio siamo in sua presenza.
La domanda sul “quando” si è rivelata una domanda sul “come”. Ciò è stato
d’altronde possibile proprio in quanto il “come” è un “quando”: “Decisivo è il
modo in cui mi rapporto a ciò nella vita autentica. Ne risulta il senso del «quando?», il tempo e l’attimo”38. La cura autentica prefigura così la direzione da
seguire per accedere alla temporalità originaria. Si apre la via per cogliere una
temporalità dell’esserci altra dall’inautentico essere nel tempo dell’esserci stesso. Essa è l’attimo: “«Tempo e attimo» (5,1: «perÁ t©n xrønvn kaÁ t©n kair©n», usati
sempre insieme) pongono un problema particolare all’esplicazione”39. L’attimo
non è in alcun modo riconducibile al tempo della concezione inautentica. Esso
non è l’istante e mantiene un’alterità radicale dal tempo come successione ordinata di istanti: “In precedenza, in termini formali, abbiamo specificato che «la
religiosità cristiana vive la temporalità». Si tratta di un tempo senza un proprio
ordine e senza punti fissi, eccettera. è impossibile cogliere questa temporalità
in base a un qualsiasi concetto obiettivo di tempo. Il «quando» non è in nessun
modo concepibile in termini obiettivi”40. è dalla decisione per il sé autentico che
dobbiamo procedere verso il tempo autentico. In essa il proprio passato non
è in alcun modo alle spalle, ma è operante nel presente: “Ora, l’essere-divenuti
non è un avvenimento qualsiasi nella vita, bensì è costantemente coesperito, in
modo che il loro essere attuale è il loro essere-divenuti. Il loro essere-divenuti
Ivi, p. 135.
Ivi, p. 143.
38
Ivi, p. 140.
39
Ivi, p. 143.
40
Ivi, p. 145.
36
37
Heidegger: scienza originaria ed esperienza paolina della vita
273
è il loro essere attuale”41. L’esserci si appropria del passato ed esso determina il
suo aprirsi al futuro. Nella decisione per il proprio sé l’esserci si muove verso
un futuro che, in quanto il suo sé originario, è già stato. L’attimo è il senso della
decisione e viene a configurarsi come luogo dell’articolarsi di passato e futuro. Esso è la temporalità originaria. In esso vive il cristianesimo delle origini e
lo stesso Paolo nel suo essere apostolo nell’angosciante attesa della ricomparsa del Messia già comparso: “Qui: kairØq synestalm™noq. Resta ancora soltanto
poco tempo, il cristiano vive costantemente nell’«ancora-soltanto» che accresce
la sua angustia. La temporalità concentrata è costitutiva della religiosità cristiana: un «ancora-soltanto»; non c’è tempo per rimandare”42. La risposta di Paolo
alla domanda relativa al “quando” della paroysºa appare adesso in tutta la sua
portata. E l’irriducibilità del tempo cairologico al tempo obiettivo e, parimenti,
l’essere il kairØq il senso stesso dell’esserci, a determinare la risposta di Paolo. è
l’insufficienza del “quando” a esprimere l’attimo a spingere Paolo a rispondere
in merito al momento della paroysºa con un “come”, ben sapendo che il senso
di questo “come” è un “quando” altro e irriducibile al tempo obiettivo.
Alla luce di ciò il senso della risposta paolina diviene un’esortazione ad essere servi di Dio e a vivere nell’attesa della paroysºa: “La risposta di Paolo alla domanda sul «quando» della paroysºa consiste dunque nell’esortazione a vegliare
e a essere sobri”43. La lotta di Paolo per il sè coincide dunque con il richiamo ai
Tessalonicesi a vegliare. Essi, accogliendo la predicazione paolina, hanno fatto
proprio il “come della condotta di vita cristiana”44 e il comportar-si nella vita
effettiva: il loro vivere è ora volto verso Dio e via dagli dei. I Tessalonicesi sono
coloro che sono divenuti e che hanno un sapere vivente di ciò. L’esortazione di
Paolo è così un richiamo ad essi a restare nella loro vigile angoscia: “L’accogliere (d™xesuai) è un porsi-dentro la necessità. Questa angustia è un elemento
caratteristico fondamentale, una cura assoluta nell’orizzonte della paroysºa,
vale a dire del Secondo Avvento alla fine dei tempi”45. La cura autentica di Paolo
coincide così con il suo richiamo ai Tessalonicesi ad essere il proprio sé.
Ivi, p. 134.
Ivi, p. 162.
43
Ivi, p. 146.
44
Ivi, p. 135.
45
Ivi, p. 138.
41
42
ELENCO E RIPARTIZIONE DEI SOCI
PER ORDINE DI ANZIANITà
CONSIGLIO DIRETTIVO
Tessitore Fulvio, Presidente
Villani Pasquale, Vice Presidente
Assante Franca, Segretario
Massimilla Edoardo, Tesoriere
SOCI EMERITI (posti 4)
SEZIONE DI SCIENZE MORALI
SOCI NAZIONALI ORDINARI RESIDENTI (posti 14)
1) Guarino Antonio, prof. emerito di Diritto Romano nell’Università di
Napoli “Federico II“ - Via Aniello Falcone, 403/ter - 80127 Napoli (tel.
081.667729).
2) Masullo Aldo, prof. emerito di Filosofia Morale nell’Università di
Napoli “Federico II” - Viale Michelangelo, 21 - 80129 Napoli (tel.
081.5568328).
3) Del Treppo Mario, già prof. ord. di Storia Medioevale nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Manzoni, 228 - 80123 Napoli (tel.
081.7691432).
4) Casavola Francesco Paolo, già prof. ord. di Storia del Diritto Romano
nell’Università di Napoli “Federico II” - Via Vincenzo Padula, 2 - 80123
Napoli (tel. 081.5756522).
5) Ajello Raffaele, già prof. ord. di Storia del Diritto Italiano nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Napoli, 63 - 80078 Pozzuoli (NA) (tel.
081.5262554).
6) Scirocco Alfonso, già prof. ord. di Storia del Risorgimento nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Manzoni, 116 - 80123 Napoli (tel.
081.645056).
7) Venditti Antonio, già prof. ord. di Diritto Commerciale nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Petrarca, 40 - 80122 Napoli (tel.
081.5755436).
8) Cantillo Giuseppe, prof. ord. di Filosofia Teoretica nell’Università di
Napoli “Federico II” - Via San Giovanni Bosco, 47 - 84100 Salerno (tel.
089.790821).
9) Lissa Giuseppe, prof. ord. di Filosofia Morale nell’Università di Napoli
“Federico II” - Via R. Galdieri, 8 - 84100 Salerno (tel. 089.721598).
10) Di Vona Piero, già prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università
di Napoli “Federico II” - Salita Arenella, 19 -80129 Napoli (tel.
081.366107).
11) Trione Aldo, prof. ord. di Estetica nell’Università di Napoli “Federico
II” - Via Pietro Castellino, 141G - 80131 Napoli (tel. 081.5451035).
12) Vitolo Giovanni, prof. ord. di Storia Medioevale nell’Università di
Napoli “Federico II” - Piazza Annunziata, 45 - 80142 Angri (SA).
13) Rao Annamaria, prof. ord. di Storia Moderna nell’Università di Napoli
“Federico II” - Vico Canalone all’Olivella, 21 - 80135 Napoli (tel.
081.5648805).
14) Lomonaco Fabrizio, prof. ord. di Storia della Storiografia filosofica
nell’Università di Napoli “Federico II” - Via Pietro Giannone, 33/a 80141 Napoli (tel. 081.457603).
SOCI NAZIONALI ORDINARI NON RESIDENTI (posti 8)
1) Federici Vescovini Graziella, prof. ord. di Storia della Filosofia
nell’Università di Parma - Via dei Renai, 11 - 50122 Firenze (tel.
055.243019).
2) Vegetti Mario, prof. ord. di Storia della Filosofia antica nell’Università di
Pavia - Via Giambattista Bassoni, 6 - 20123 Milano (tel. 02.4694384).
3) Cotroneo Girolamo, prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università
di Messina - Via Maffei, 15 - 98100 Messina.
4) Cesa Claudio, prof. emerito di Storia della Filosofia nella Scuola Normale
di Pisa - Via Martiri di Scalvaia, 19 - 53100 Siena (tel. 0577.283687).
5) Nuzzo Enrico, prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università di
Salerno - Piazza Porta Rotese, 18 - 84100 Salerno.
6) Levra Umberto, prof. ord. di Storia del Risorgimento nell’Università di
Torino - Via Casale, 143/2 - 10099 S. Mauro Torinese (TO).
7) Lenoci Michele, prof. ord. di Storia della Filosofia contemporanea
nell’Università Cattolica di Milano - Corso Genova, 16 - 20123 Milano. SOCI CORRISPONDENTI NAZIONALI (posti 14)
1) Labruna Luigi, prof. ord. di Storia del Diritto Romano nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Chiaia, 149/A - 80121 Napoli (tel.
081.425885).
2) De Lorenzo Renata, prof. ord. di Storia Contemporanea nell’Università di
Napoli “Federico II” - Via Mosca, 4 - 80129 Napoli (tel. 081.5564464).
3) Figliuolo Bruno, prof. ord. di Storia medioevale nell’Università di Udine
-Parco Carelli, 62 -80123 Napoli.
4) Di Marco Giuseppe Antonio, prof. ord. di Filosofia della Storia
nell’Università di Napoli “Federico II” - Gradini S. Nicola da Tolentino,
7 - 80135 Napoli (tel. 081.400202).
5) Viti Cavaliere Renata, prof. ord. di Filosofia teoretica nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Donizetti, 1/e - 80127 Napoli (tel.
081.5789878).
6) Montano Aniello, prof. ord. di Storia della filosofia nell’Università di
Salerno -Via Montessori, 19 - 80011 Acerra (NA) (tel. 081.5201483).
7) Pellegrino Bruno, prof. ord. di Storia moderna nell’Università di Lecce
- Via delle Bombarde, 20 - 73100 Lecce (tel. 0832.309410).
8) D’agostino Guido, prof. ord. di Storia moderna nell’Università di
Napoli “Federico II” - Parco Comola Ricci, 23 - 80122 Napoli (tel.
081.642217).
9) Muto Giovanni, prof. ord. di Storia moderna nell’Università di
Napoli “Federico II” - Via Ligorio Pirro, 20 - 80129 Napoli (tel.
081.5783609).
10) Musi Aurelio, prof. ord. di Storia moderna nell’Università di Salerno Via Canalone all’Olivella, 21 - 80135 Napoli (tel. 081.5496170).
11) Rambaldi Feldmann Enrico, prof. ord. di Storia della filosofia morale
nell’Università di Milano - Viale Argonne, 41 - 20133 Milano.
12) Giugliano Antonello, prof. ord. di Storia della Filosofia contemporanea
nell’Università di Napoli “Federico II” - Strada Gianturco Emanuele,
36 - 80055 Portici (Na) - (tel. 081.471053)
13) Verde Giovanni, prof. ord. di Diritto processuale civile nell’Università
Luiss Roma - Via T. Angelini, 21/c - 80129 Napoli.
SOCI STRANIERI (posti 7)
1) Nowocki Andrej, prof. di Storia della Filosofia nell’Università di LublinSowinskiego 7 m. 25 - 20040 Lublino (Polonia).
2) Trinidade Santos José Gabriel, prof. di Filosofia nell’Università Nova di
Lisbona - Rua Soeiro Pereira Gomes, Ed. America, Bloco A, ap. 405 1600 Lisboa (Portogallo)
SEZIONE DI SCIENZE POLITICHE
SOCI NAZIONALI ORDINARI RESIDENTI (posti 13)
1) Galasso Giuseppe, prof. emerito di Storia medievale e moderna
nell’Università di Napoli “Federico II” - Via Napoli, 3/d - 80078 Pozzuoli
(NA) (tel. 081.5262947).
2) Tessitore Fulvio, prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università
di Napoli“Federico II” - Via Santo Strato, 14 - 80123 Napoli (tel.
081.5755411).
3) Villani Pasquale, prof. emerito di Storia Contemporanea nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via F. Cilea, 183 - 80127 Napoli (tel.
081.5604368).
4) Abbamonte Giuseppe, già prof. ord. di Diritto Amministrativo
nell’Università di Napoli “Federico II” - Viale Gramsci, 6/a - 80122
Napoli (tel. 081.663383).
5) Villone Betocchi Giulia, già prof. ord. di Psicologia nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via dei Mille, 61 - 80121 Napoli (tel.
081.415741).
6) Cacciatore Giuseppe, prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via L. Cassese, 12 - 84100 Salerno (tel.
089.222848).
7) Casertano Giovanni, prof. ord. di Storia della Filosofia Antica
nell’Università di Napoli “Federico II” - Salita Sant’Antonio a Tarsia,
28 - 80135 Napoli (tel. 081.5445089).
8) Assante Franca, prof. ord. di Storia economica nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Manzoni, 132 - 80123 Napoli (tel.
081.7145844).
9) Mazzarella Eugenio, prof. ord. di Filosofia Teoretica nell’Università di
Napoli “Federico II” - Via Orazio, 27 - 80122 Napoli (tel. 081.666275).
10) Acocella Giuseppe, prof. ord. di Etica sociale nell’Università di Napoli
“Federico II” - Via S. Giovanni Bosco, 47 - 84100 Salerno.
11) Massimilla Edoardo, prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Matteotti, 18 - 80078 Pozzuoli (Na).
12) Conte Domenico, prof. ord. di Teoria e storia della storiografia
nell’Università di Napoli “Federico II” - Traversa Antonio Pio, 64 - 80126
Napoli (tel. 081.7281122).
SOCI NAZIONALI ORDINARI NON RESIDENTI (posti 8)
1) Vassalli Giuliano, prof. emerito di Diritto Penale nell’Università di
Roma - Via della Conciliazione, 44 - 00193 Roma (tel. 06.564074).
2) Giarrizzo Giuseppe, prof. emerito di Storia Moderna nell’Università di
Catania - Via Orto dei Limoni, 60 - 95125 Catania.
3) Bertolino Rinaldo, prof. ord. di Diritto ecclesiastico nell’Università di
Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino.
4) Rossi Pietro, già prof. ord. di Filosofia della Storia nell’Università di
Torino -Via Carlo Alberto, 59 - 10123 Torino.
5) Sasso Gennaro, già prof. ord. di Filosofia teoretica nell’Università di
Roma “La Sapienza” - Via Sant’Alberto Magno, 1 - 00153 Roma.
6) Graziani Augusto, prof. ord. di Economia Politica nell’Università di Roma
“La Sapienza” - Via Ascensione, 5 - 80121 Napoli (tel. 081.418329).
7) Talamo Giuseppe, prof. ord. di Storia del Risorgimento Università di
Roma “Terza Università”, Via Alpi, 8/A - Roma (tel. 06.8554970).
8) Scarcia Amoretti Bianca Maria, prof. ord. di Islamistica nell’Università
di Roma “La Sapienza”, Via Cameria, 3 - 00179 Roma.
SOCI CORRISPONDENTI NAZIONALI (posti 14)
1) Rascio Raffaele, prof. ord. di Istituzioni di Diritto Privato nell’Università
di Napoli - Parco Comola Ricci, 21 - 80122 Napoli (tel. 081.660632).
2) Savignano Aristide, prof. ord. di Istituzioni di Diritto Pubblico
nell’Università di Firenze - Corso Mazzini, 15 - 50132 Firenze (tel.
055.2476301).
3) Barbagallo Francesco, prof. ord. di Storia Contemporanea
nell’Università di Napoli “Federico II” - Riviera di Chiaia, 207 80121 Napoli (tel. 081.408346).
4) Gaetani D’aragona Gabriele, già prof. ord. di Economia agraria
nell’Università di Napoli Parthenope - Piazza S. Maria degli Angeli, 1 80132 Napoli (tel. 081.7645732).
5) Mazzacane Aldo, prof. ord. di Storia del diritto italiano - Via Orazio,
22 - 80122 Napoli.
6) Di Costanzo Giuseppe, prof. ord. di Storia della filosofia nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Girolamo Santacroce, 25 - 80129 Napoli
(tel. 081.5563963).
7) Papuli Giovanni, prof. ord. di Storia della filosofia nell’Università di
Lecce - Via Vecchia Manifattura Tabacchi, 34 - 73100 Lecce.
8) Scocozza Antonio, prof. ord. di Lingua, cultura e istituzioni dei paesi
di lingua spagnola nell’Università di Salerno - Via Delle Filande, 24 84080 Pellezzano (SA) (tel. 089.274189).
9) Mascilli Migliorini Luigi, prof. ord. di Storia moderna nell’Università
“L’Orientale” - Via A. D’Isernia, 31 - 80122 Napoli (tel. 081.661334).
10) Russo Luigi, prof. ord. di Estetica nell’Università di Palermo - Via
Giovan Battista Lulli, 4 - 90145 Palermo.
11) Donadio Francesco, prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Castiello, 20 - 80024 Cardito (NA) (tel.
081.8321387).
12) Mazzetti Ernesto, prof. ord. di Geografia politica ed economica
nell’Università di Napoli “Federico II” - Piazza Donn’Anna, 9 - 80123
Napoli (tel. e fax 081.7646467).
13) Santoni Francesco, prof. ord. di Diritto del lavoro nell’Università
di Napoli “Federico II” - Riviera di Chiaia, 264 - 80121 Napoli (tel.
081.7611341).
SOCI STRANIERI
(posti 6)
1) Stein Peter, prof. ord. di Storia del Diritto Romano nel Queen’s College
di Cambridge - Queen’s College, Cambridge CB3.9ET (Gran Bretagna).
2) Vovelle Michel, prof. emerito di Storia moderna nell’Università di
Paris-Sorbonne - 3 avenue Villemus, 13100 Aix en Provence (Francia).
Indice
Maria Letizia Pelosi, Hannah Arendt e Rahel Varnhagen: una
biografia filosofica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 5
Giulio Nocerino, La creazione tra ontologia e teologia in Antonio
Rosmini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
27
Piero Marino, Edmund Husserl e la Grande Guerra. . . . . . . . . . . »
51
Livio Santoro, Dalla Daseinsanalyse alla psicosi determinista:
Binswanger e Borges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
67
Luigi Buonaiuto, Il concetto estetico di ripetizione tra mistica e
metodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 101
Mauro Senatore, Analogia e decostruzione nell’Essai di Rousseau. . » 129
Christian Vassallo, Contributi per una definizione della simmetria
in Plotino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 153
Mariafilomena Anzalone, Hegel a Stoccarda: l’incontro con la
cultura dell’Aufklärung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 171
Silvio Paolini Merlo, Investigazioni sulle costanti fondative
dell’esistenzialismo positivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 195
Jean-Jacques Wunenburger, Tra caos e razionalità: elementi di
ecologia simbolica urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 207
Lorella Ventura, La concezione dell’Islam nelle Lezioni
sull’Estetica di Hegel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 225
Maurizio Filippo Di Silva, Heidegger: scienza originaria ed
esperienza paolina della vita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 259
Regist. Tribunale di Napoli n. B/2317 del 14 agosto 1954
Officine grafiche napoletane Francesco Giannini & Figli S.p.A.
Proprietà della testata: Accademia di Scienze Morali e Politiche,
via Mezzocannone, 8 - 80134 Napoli
Direttore responsabile: accademico Aldo Trione
Finito di stampare nel mese di maggio 2009