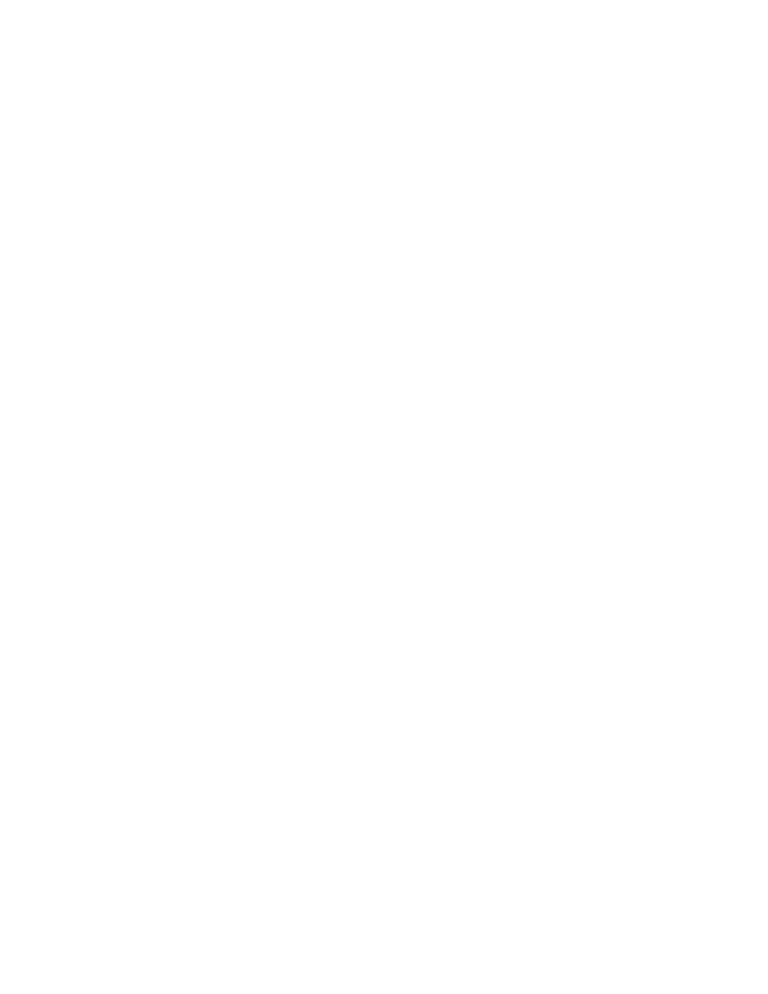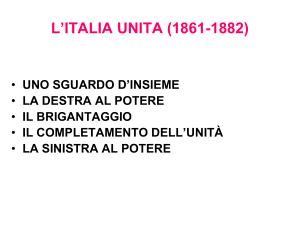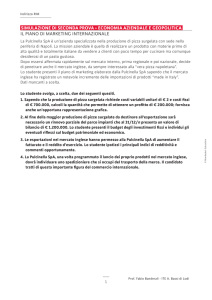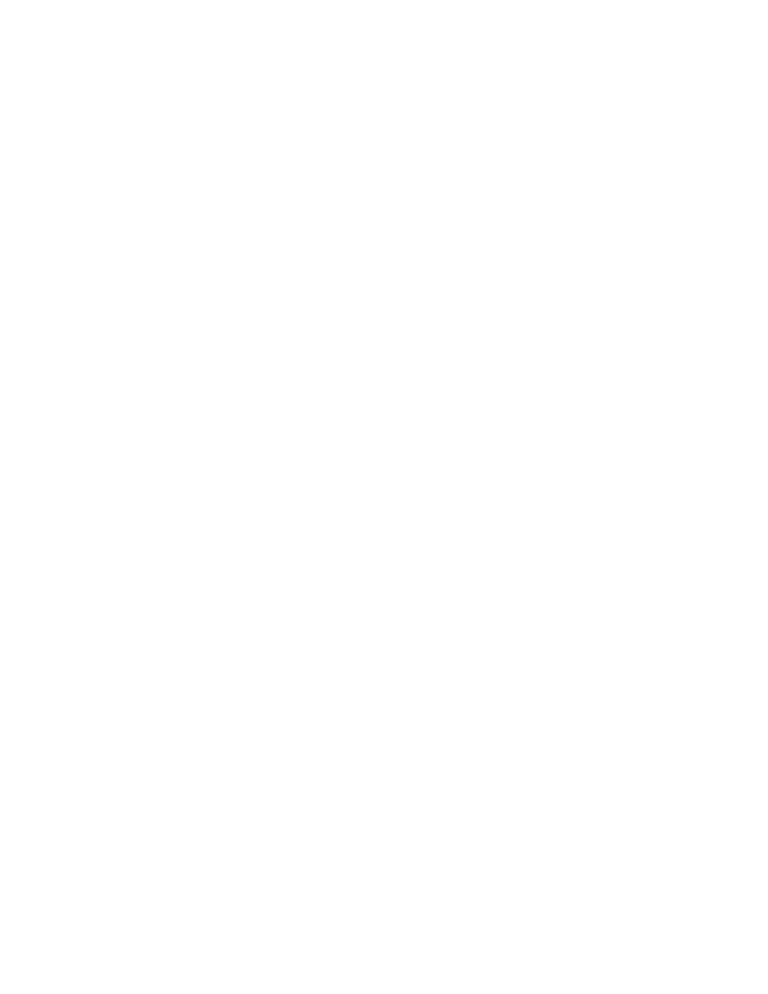
Q
UADERNI
di antropologia e scienze umane
Semestrale del Laboratorio Antropologico
Dipartimento di Scienze umane, filosofiche
e della formazione dell’Università di Salerno
del
con la collaborazione de
La Rete
Associazione per l’integrazione
dei saperi antropologici, letterari, filosofici e psicologici
Quaderni
Direttore
Simona De Luna
Direttore responsabile
Mirella Armiero
Condirettore
Domenico Scafoglio
Comitato Scientifico
Annamaria Amitrano (Università di Palermo)
Giulio Angioni (Università di Cagliari)
Claudio Azzara (Università di Salerno)
† Rocco Brienza (Università di Trieste)
Antonino Buttitta (Università di Palermo)
Giovanni Casadio (Università di Salerno)
Alicia Castellanos Guerrero (Università Autonoma Metropolitana del Messico)
Luigi M. Lombardi Satriani (Università La Sapienza di Roma)
Gilberto Lopez y Rivas (Instituto de Antropología e Historia, Messico)
Sebastiano Martelli (Università di Salerno)
Pablo Palenzuela (Università di Siviglia)
Gianfranca Ranisio (Università Federico II di Napoli)
Luigi Reina (Università di Salerno)
Domenico Scafoglio (Università di Salerno)
Enzo Segre (Università Autonoma Metropolitana del Messico)
Vito Teti (Università della Calabria)
Redazione
Caterina Camastra (UNAM, Città del Messico/ Morelia)
Patrizia Del Barone (Laboratorio antropologico UNISA)
La rivista si avvale della consulenza di referees che esaminano gli articoli in “doppio cieco”
Laboratorio Antropologico – DISUFF Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 84084 Fisciano (Sa)
[email protected]
La Rete – Associazione per l’integrazione dei Saperi Antropologici, Letterari, Filosofici e Psicologici
Piazza Gerolomini n. 103, 80138 Napoli
[email protected]
ISSN 2282-2968
Autorizzazione richiesta al Tribunale di Nocera Inferiore (Ruolo Generale n. 2247 del 2015)
Stampato per conto della Guida editori
Q
UADERNI
anno
COMICITÀ E POLITICA
III • numero 2 – anno IV • numero 1
ANTROPOLOGIA E STORIA/2
DICEMBRE 2016
Editoriale, 7
ANT ROPOLOG I A D E L C O M I C O
domenico scafoglio
Comici politici al tempo di Grillo, 11
patrizia del barone
Gli ossimori di Trump as trickster, 25
ANT ROPOLO G I A E S TO R I A
simona piera de luna
Per una riscrittura del brigantaggio postunitario. Il problema
delle fonti, 29
helga finter
L’opera lirica, la lingua e l‘unità nazionale: Appunti su Verdi e
Wagner, 61
vincenzo m. spera
La ricerca delle origini. L’invenzione delle feste dopo l’Unità, 69
anna maria musilli
Voci strozzate. Nota sulla lingua dei migranti, 89
domenico scafoglio
- simona piera de luna
Antropologia del brigantaggio, 95
A N T ROPOLOGIA E L E T T E R AT U R A/ T E S T I
rosa troiano
L’antropologia poetica di Vincenzo Padula. Storia e testo della
Notte di Natale, 153
A RCH IV IO DI ANT RO POL OG I A D E L C OM I C O
domenico scafoglio
Pulcinella come trickster, 177
COMMEMO R AZI O N I
Perché ricordare Rocco Brienza, 195
R ASSEGNA D I S T U D I
Pulcinella. L’eroe comico popolare nell’area euromediterranea
(G. Ranisio), 201; G. Agamben, Pulcinella (D.S.), 204; D. De
Masi, Mappa mundi (A.M. Musilli), 206; “Bruzio” di Padula,
nuova ristampa anastatica (L. Imperato), 207.
NOT IZIAR IO L I B R I / E V E N T I
Reseña del V Congreso Internacional de Mitos Prehispánicos en
la Literatura Latinoamericana (Q. Mata Trejo), 211
Presentazioni (A.M.), 215
Uscita della rivista “Inflexiones” (C.C.), 217
6
E
DITORIALE
D
ei blocchi tematici di cui si compone questo numero doppio dei “Quaderni di
antropopogia e scienze umane”, quello dedicato alla comicità forse appare più
radicato nell’attualità, in un momento storico in cui un comico di professione,
come Grillo, fonda un partito che ormai si candida a governare l’Italia e Trump,
il politico miliardario da molti inserito tra i trickster contemporanei, diventa l’uomo più potente del mondo vincendo la corsa alla presidenza degli Stati Uniti. Quello che sembrava soltanto una questione di storia culturale, filologica, mitografica si è rivelato un problema politico
fondamentale per il destino di Stati e di popoli. Per noi non si tratta di inseguire avvenimenti
che corrono precipitosamente verso esiti imprevedibili né di tener dietro alle mode del momento, perché queste realtà sono state fatte oggetto di analisi già da qualche lustro negli studi
di alcuni collaboratori legati alle tematiche e agli interessi scientifici e culturali della nostra rivista, che abbiamo cominciato a riproporre nel nostro archivio di antropologia del comico. Basterebbe pensare agli studi sui trickster del mondo, presentati nel ponderoso volume recensito
in questo numero, che contiene i testi con cui una quarantina di studiosi italiani e stranieri di
diversa provenienza (Corea, Brasile, Portogallo, Messico, Germania, Iran) si sono incontrati a
Napoli per restituire in una luce diversa, partendo da Pulcinella, le figure comiche che godono
di un grande successo popolare, che le trasforma in eroi culturali, incarnazione del genius loci,
del lato solare e di quello oscuro dei loro popoli, insomma i trickster (Pulcinella. L’eroe comico
nell’area euromediterranea, Collana Scientifica dell’Università di Salerno, 2015). Questo giro
tra i carnevali e i buffoni del mondo per un verso ha rafforzato l’idea del carattere universale
del trickster, o per lo meno di un trickster particolare, identificabile con l’eroe comico popolare delle narrazioni, del teatro, del cinema, dei carnevali, per un altro ha consentito di avviare
un discorso , su basi antropologiche e transdisciplinari, su un fenomeno nuovo, quello delle
figure contemporanee che contaminano comicità e politica. Su questo fenomeno, che sembra
configurarsi come un ritorno e una metamorfosi del trickster tradizionale, erano già stati spesi
giudizi che non uscivano quasi mai dal reticolo categoriale della politica o, al più, della storia
del costume. Categorie come “populismo” sono servite soltanto per cercare di superare il disorientamento prodotto da un fenomeno radicalmente nuovo e dirompente e per liquidare con
7
Q
uaderni
disinvolta leggerezza eventi che non si riescono ancora a controllare e nemmeno a capire del
tutto. Ancora una volta è la politica a prestare o imporre le sue cifre alle scienze socili, quando dovrebbero essere le scienze sociali a fornire o suggerire alla politiche strumenti nuovi di
conoscenza e di critica. Questo rende ragione del nostro interesse a tentare di approfondire,
in quest’ultimo numero doppio dei “Quaderni”, la natura e la funzione del trickster nella strutturazione delle istituzioni fondamentali della società. Un discorso antropologico, che parte da
alcune intuizioni brillanti di Yeats, per disegnare forse troppo laconicamente una bozza dell’evoluzione del tipo comico in esame, per arrivare nell’età contemporanea alle figure del comico
che fa politica e/o del politico che si fa comico: una metamorfosi tutta postmoderna, che non
solo sconvolge radicalmente il modo tradizionale di fare comicità, ma introduce nella vita
politica, civile e nel costume elementi di innovazione e di rischio prima insospettati. Insomma
si tratta di aprire più che concludere una visione non ideologica sul tema, che, rifiutando la
tendenza politicamente diffusa a condannare il fenomeno come forma dannosa e pericolosa di
populismo, dischiuda la possibilità di dimostrare, al di là di ogni indulgente compiacimento,
che gli eroi comici continuano ad esistere nel mondo contemporaneo, perché sono una necessità della cultura, e possono contribuire a modificare la realtà, riscrivendo le regole dello scambio sociale: era questa la funzione del trickster mitologico e storico, che nelle trasformazioni
postmoderne riacquista la forza dirompente di dare voce ad alcuni lati dei desideri e della coscienza collettiva, per dare vita a una nuova rappresentanza capace di congiungere ciò che era
stato tradizionalmente disgiunto, unificando pubblico e privato, politica e morale. La politica
dovrà fare i conti con questa realtà, al di là delle buffonerie e delle trasgressioni linguistiche e
culturali, almeno in queste sue istanze più sane e realistiche.
Anche il brigantaggio viene qui riproposto come uno degli interessi dei “Quaderni” che coprono l’area dell’antropologia nei rapporti con la storia. I modi di concepire e scrivere la storia
in maniera diversa riescono utili, quando ricerca e scrittura portano i segni di un lavoro solido
e competente, che li rendano degni di rispetto. Tuttavia chi frequenta il confine, in cui la storia
aspira a saldarsi con l’antropologia, difficilmente condividerà l’idea che il ricercatore debba,
occupandosi, per esempio, di storia del Mezzogiorno – lo diciamo con le parole di Rosario Romeo, in riferimento a quella che fu la capitale del Reame – “tenersi sul filo di una mai raggiunta
adeguatezza a ciò che si faceva ‘altrove’, fosse questo un altrove nordico e italiano o straniero”,
col risultato di schiacciare l’immagine della storia del Mezzogiorno dei secoli XVIII-XIX “su
quella dell’Europa avanzata e moderna”, e condannare “i suoi momenti più alti a un ruolo
irrimediabilmente arretrato e inferiore”. Parole sacrosante, che denotano una sensibilità già
antropologica, almeno nel proposito di oggettivamente demolire la scala etnocentrica che forzatamente unifica e confonde le storie e le culture, in nome di una sola storia e di un’unica
cultura, all’interno delle quali esistono livelli avanzati e arretrati, sviluppati e sottosviluppati,
superiori e inferiori. Ma basta, per chiudere il problema, sostenere che le culture rimaste a un
“livello inferiore” hanno comunque “una funzione a sé stante”? Forse non basta del tutto, anche se siamo a un solido punto di partenza: il funzionalismo antropologico lo ha pensato prima
degli storici. Ma le culture non vivono da sole: soprattutto nel mondo globalizzato, guardano
alle altre, interagiscono, comparano, mettono in discussione il loro modo di stare al mondo.
8
antropologia e storia
/ 2 – comicità e politica
Nell’ottica funzionalista la scala della discriminazione in qualche modo permane, e permarrà
finché non si prenderà in considerazione quanto una qualsiasi cultura, indipendentemente dai
rapporti di forza e di dominio, abbia contribuito a restituire all’umanità il suo diritto alla vita,
alla libertà, alla creatività, indipendentemente dal modo, ogni volta diverso, in cui è riuscita a
farlo; e quanto ancora avrebbe contribuito a restituire, se fosse sopravvissuta al destino della
dominazione e all’asservimento. Sposare l’idea della multilinearità storiografica comporta l’assunzione di una serie di problemi complessi e di non facile soluzione. La certezza da cui partire
è che la direzione, che ha preso la Storia, non è stata sempre quella giusta, e sicuramente non
era inevitabile. In molti casi avremmo potuto sostenere che “poteva andare diversamente” o
“si poteva fare meglio”. I discorsi, che la rivista va facendo in più occasioni sull’unificazione
nazionale, sulla guerra civile denominata brigantaggio e sulla costruzione culturale dei valori
patriottici e identitari vanno in questa direzione.
Sui rapporti tra l’antropologia e la letteratura i nostri “Quaderni” si sono già impegnati sia
lungo il versante della teoria che dei testi. Tra le ascendenze della teoria avevamo trascurato
l’antropologo Clide Kluckhohn, che, dopo avere brevemente spiegato, già nel 1949, le diverse
metodologie con cui gli studi umanistici e quelli antropologici indagano gli stessi problemi,
concludeva che “l’antropologia tratta i particolari nell’ambito degli universali”, tuttavia “bisogna subito riconoscere che i grandi romanzieri e drammaturghi, basandosi sulle lunghe tradizioni della loro arte, sono assai più abili degli antropologi nel mettere a nudo la causa prima
delle azioni umane. Se un mio amico volesse conoscere in breve tempo la mentalità dei contadini polacchi, io gli manderei certo il romanzo I contadini di Ladislao Reymont e non il classico
di scienze sociali Il contadino polacco di Thomas e Znaniecki. Le migliori monografie di Malinowski sui Trobrianders non sono all’altezza di La mia Antonia di Willa Carther o Black Lamb
and Gray Falcon di Rebecca West, quando si tratta di comunicare con realtà immaginativa i
meccanismi interiori di una società e le motivazioni degli agenti individuali al suo interno”. Il
discorso si sposta allora sui testi. Dopo decennali chiusure nei confronti della letteratura, non
pochi antropologi sono ritornati a Kluckhohn, con altra consapevolezza e diversa sapienza
argomentativa, e non trovano più eccenrico o impertinente l’uso delle opere letterarie nella
ricerca sociale e culturale, fino ad ammettere la legittimità (se non la necessità) di contaminazioni controllate, che arricchiscano e allarghino, senza mettere in crisi i fondamenti teorici
della identità delle diverse aree della ricerca scientifica. I “Quaderni di antropologia e scienze
umane” anche in questo numero ribadiscono la loro fedeltà al dialogo interdisciplinare, con
nuovi contributi, oltre il campo, sopra evocato, che da tempo denominiamo antropologia del
comico. In questa direzione va la pubblicazione del testo dell’antropologo e scrittore Vincenzo
Padula, con rigore filologico per la prima volta presentato nelle sue varianti e con cura amorosa
commentato linguisticamente e stilisticamente, col risultato di accrescere notevolmente l’intellegibilità di un capolavoro che apparttiene sia alla letteratura che all’antropologia. Potremmo parlare di “antropologia in versi” o “antropologia poetica” e inserirlo tra i precedenti più
significativi delle sperimentazioni poetiche degli scienziati sociali, alle quali abbiamo dedicato
il secondo numero dei nostri “Quaderni”. Siamo d’accordo con Lacan, quando sostiene che
i testi letterari possono essere assunti, per la loro “effervescenza” e “sovradeterminazione”,
9
Q
uaderni
come luogo privilegiato e irrinunciabile dell’indagine conoscitiva, che per Lacan è la psicoanalisi e per noi è soprattutto la ricerca antropologica. Vincenzo Padula percepiva i limiti delle
scienze sociali, proprio mentre contribuiva a fondarle nell’Italia meridionale della metà del
secolo XIX, e, mentre faceva il suo lavoro di antropologo, non rinunciava a quello di scrittore,
e contaminava con molta frequenza l’attività antropologica con l’arte del poeta, per rimediare a
quello che, nella rappresentazione scientifica della cultura, della religione, del mito, irrimediabilmente si perde, ossia – lo diciamo con la complicità di un grande antropologo storico, quale
è E.P. Thompson – “una parte del significato e tutta la sua forza psichica coercitiva”.
10
Comici politici al tempo di Grillo
Domenico Scafoglio
Metamorfosi del trickster
nel mondo globalizzato
D
elle molteplici forme della comicità, assumiamo qui come
oggetto del nostro interesse
quella dell’eroe comico presente nella varietà delle culture umane. Gli
antichisti hanno adoperato la prima volta la
denominazione di “eroe comico” per indicare i personaggi ribelli delle commedie di
Aristofane, noi lo accostiamo al termine trickster, inizialmente usato dagli etnologi per
indicare una figura mitologica delle culture
primitive, il “burlone divino”, il demiurgo
del mito amerindo dal comportamento gioiosamente trasgressivo, intelligente e stolido,
cultore degli eccessi e insieme provvido ordinatore della vita e benefattore degli uomini.
Da qualche decennio questo termine è diventato nel linguaggio comune l’appellativo
del personaggio comico con caratteristiche a
lui affini, presente su scala planetaria, lungo
l’asse diacronico e quello sincronico, in una
molteplicità di versioni somiglianti e insieme
dissimili, segnato dalle caratteristiche dell’universalità e dell’etnicità, della differenza
culturale e del fondo comune che unifica le
culture. Una carta di identità, quella del trickster, etnica e cosmopolitica al tempo stesso.
La stessa ricerca etnologica, che alla figura mitica del trickster primordiale ha de-
dicato approfondimenti importanti, sembra
suggerire la sua straordinaria analogia di
comportamenti e funzioni con una tipologia di figure comiche di epoca storica (salvando ovviamente differenze di significati,
valori, linguaggi, narrazioni), che godono
di ampia popolarità e sono fatte oggetto di
un investimento emotivo e fantasmatico,
che le trasforma in miti di identificazione
collettiva. Le conferme, che la comparazione interculturale fornisce in merito alla
presenza su scala planetaria di personaggi
comici di natura tricksterica, ossia dotati di
caratteristiche inequivocabilmente simili a
quelle dei “burloni divini”, risultano troppo
importanti per resistere alla tentazione di riconoscere in esse l’eterno riproporsi di immagini archetipiche profondamente radicate nella esperienza degli uomini, come una
necessità della cultura, istituzionalmente
legate all’organizzazione culturale che rende
possibile l’esistenza e il funzionamento delle
società. Sono stati psicoanalisti come Jung e
mitologi influenzati dalla psicoanalisi come
Kerényi, i primi a riconoscere l’universalità
del trickster o per lo meno la sua persistenza
nella storia, al di là delle fasi di obsolescenza, come sintomo nevrotico sempre pronto
a svilupparsi nelle forme di un’esperienza
fondamentale della cultura, soprattutto in
momenti particolari segnati dalla crisi della
società e dal diffuso disagio esistenziale, che
11
Q
uaderni
spinge a dilatare i limiti della coscienza, ad
appropriarsi delll’esperienza delle culture
“altre” e delle classi inferiori. Dopo l’esperienza, per noi fondamentale, della pubblicazione del volume del 1992 su Pulcinella1,
di questi aspetti si è tornato a discutere nel
Convegno napoletano del 2008, da noi voluto e dedicato all’eroe comico popolare
nell’area euromediterranea, con risultati che
si possono leggere in alcuni saggi del volume
degli Atti, da poco pubblicati2. In quell’incontro, denso di contributi internazionali,
si produssero e confrontarono per la prima
volta riflessioni e materiali nuovi sulla presenza delle figure tricksteriche nelle più lontane aree del pianeta, e per un altro verso si
consolidò la rappresentazione del trickster
come l’eroe comico popolare, sua reincarnazione ogni volta similare e diversa nella
storia delle culture del pianeta.
Già in alcune relazioni di quel convegno
venivano colte alcune sorprendenti trasformazioni del “briccone” originario nel mondo moderno e nella postmodernità, quali il
suo assumere la forma imprevista del comico prestato alla politica o, viceversa, del politico che mima i modi se non il mestiere dei
comici per fare politica oltre che per puro
divertimento. Abbiamo fatto tesoro di quella esperienza per rileggere in questa chiave,
con gli approfondimenti di metodo suggeriti
dalle situazioni più recenti, il fenomeno dei
comici contemporanei che ci sono sembrati
più vicini al modello delle figure tricksteriche tradizionali e dei mondi che essi rappresentano, secondo percorsi quali la riflessio-
1
2
12
ne sui tratti “arcaici” e le forme nuove del
fenomeno dei comici politici, la grammatica
culturale dei nuovi linguaggi comici, la trasgressione comica al tempo della censura e
in un mondo detabuizzato, per tentare alla
fine di dare qualche risposta alla domanda:
cosa sommerge, realisticamente, la risata?
Prudenza suggeriva nel convegno sopra ricordato di non spingere l’entusiasmo
della ricerca e della riflessione oltre un certo segno, dal momento che ci trovavamo,
sì, nel momento culminante in cui Grillo,
Berlusconi e Bossi riscrivevano in chiave
radicalmente nuova i modi e le forme della
comunicazione politica, ma al tempo stesso
su questa inedita contaminazione di comicità e politica gravava un senso di irrealtà,
che faceva pensare a un rapido esaurimento
della fiammata. Invece la storia questa volta
è andata dalla parte più inconsueta e il modello politico del burlesco violatore di tabù
continua a segnare fortemente della sua
presenza la vita politica, con nuove, impreviste trasformazioni, come quelle che hanno
segnato il passaggio da Bossi a Salvini o da
Berlusconi a Renzi, e come, fuori dell’Italia,
l’apparizione del fenomeno Trump. I comici
politici e i politici comici sembrano effettivamente aspirare a reiterare parte delle funzioni che si ritrovano nel mitico trickster,
il divino burlone, ordinatore della vita e al
tempo stesso trasgressore, vittima e salvatore, eroe culturale capace di incarnare i lati
luminosi e quelli oscuri della realtà, senza
mettere a rischio la tenuta complessiva del
sistema culturale.
D. Scafoglio - L.M. Lombardi Satriani, Pulcinella. Il mito e la storia, Milano, Leonardo, 1992. Ved. gli approfondimenti successivi di D. Scafoglio, Per una antropologia del comico a partire dal Carnevale in Il Carnevale e il Mediterraneo, Atti convegno, Bari, Progredit, 2010, pp. 1-11; Pulcinella, Roma, Newton Compton, 1996.
D. Scafoglio (a cura di), Pulcinella. L’eroe comico nell’area euromediterranea, Università di Salerno 2015.
antropologia e storia
La struttura archetipica
In quanto necessità della cultura, il buffone si ritrova, come abbiamo anticipato,
nella quasi totalità dei popoli di tutti i tempi
e l’etnologia ci viene incontro per aiutarci a
dimostrare la sua presenza tra gli archetipi
che hanno fondato la civiltà. Per semplificare ci serviremo quasi unicamente dell’opera di William I. Thompson, che utilizza
il modello degli opposti psicologici di W.B.
Yeats, liberandolo dall’impostazione misticheggiante, e si serve come esemplificazione
narrativa di un celebre film di ispirazione
etnografica3. Secondo il racconto nel gruppo umano primario dei cacciatori lavorano
insieme il capo, lo sciamano, il cacciatore e
il buffone, i quali agiscono come “opposti
complementari”, che preservano l’equilibrio
della struttura. Il buffone è cacciatore come
tutti gli altri, con la specificità di prendersi
gioco “dell’autorità del capo e della prestanza fisica del cacciatore”. In particolare nel
gruppo esistono due forze simmetricamente
opposte: lo sciamano e il buffone rappresentano il modo ideativo, mentre capo e
cacciatore sono il lato operativo e “realizzano le possibilità precluse agli altri due”. I
ruoli non sono statici, perché, necessitando,
il buffone può prendere il posto dello sciamano e così via. Inoltre tutti e quattro sono
impegnati nel loro ruolo a tempo parziale, perché devono lavorare al tempo stesso
come cacciatori. Pur avendo diverse funzioni e competenze, ed essendo ciascuno nel
suo campo diversamente bravo o forte,”tutti
3
/ 2 – comicità e politica
e quattro devono cacciare e lavorare insieme, quindi non si verifica quella estrema
divisione della fatica che finisce col dividere
gli uomini”. Questa struttura era destinata
a una secolare permanenza, conservando i
suoi elementi di base nonostante le sue trasformazioni storiche e l’evoluzione, a volte
profonda, dei singoli componenti.
Quello che non sembra sviluppato nel
modello di Yeats è il riferimento alla natura
trasgressiva del buffone, che marca la sua diversità, socialmente riconosciuta e accettata,
nei confronti del gruppo col quale coopera e
solidarizza. In tutte le culture i comportamenti irregolari della figura istituzionalizzata del
buffone sono infatti normalmente consentiti,
se non culturalmente previsti e controllati: nei
miti degli indiani d’America il trickster è un
violatore di tabù, in primo luogo del tabù del
sangue: l’incesto, che egli ha consumato con
la sorella, prefigura i suoi comportamenti
successivi, il suo andare contro tutte le regole umane e divine, e questi ultimi sono a loro
volta figura e ripetizione dell’incesto originario. I buffoni sacri dell’America latina, che costituiscono il corrispettivo rituale del briccone
divino nelle mitologie amerinde, evocano ritualmente l’infrazione dei tabù. Ma anche nel
mondo desacralizzato la comicità sotto tutti i
cieli si dispiega nel segno dell’eccesso, dell’inversione, dei rovesciamenti.
La violazione delle regole costituisce il
gesto fondante, dal momento che su di essa
il personaggio comico costruisce la sua immagine e il suo potere. Fino alle soglie del
mondo contemporaneo la trasgressione ri-
William I. Thompson, All’orlo della storia, introdotto da Elémire Zolla (tr. it., Milano, Rusconi, 1972), spec. alle
pp. 168-82. L’opera di W.B. Yeats è A Vision (New York, 1956). Il film cui Thompson fa riferimento è The Hunter di
John Marshal, un gioiello della cinematografia di ispirazione etnografica.
13
Q
uaderni
sulta notoriamente connessa col sacro, dal
momento che grazie ad essa il trasgressore
acquista potere (originariamente, il potere
magico insito nel sangue). Ma anche in contesti desacralizzati, come i nostri, il personaggio comico deve la sua forza e il suo prestigio alla capacità di andare all’incontrario,
esercitare una sorta di violenza bianca sui
personaggi d’autorità, cimentarsi nell’esercizio della parodia dei costumi e miti collettivi. Tutto questo sarebbe incomprensibile se
non ipotizzassimo l’esistenza di una delega
collettiva al personaggio comico a trasgredire, peccare, sbagliare, colpire in nome di
tutti. È un meccanismo analogo a quello con
il quale le società affidano il compito di rappresentare i loro desideri nascosti alle figure di confine (stranieri, vagabondi, nomadi,
marginali, irregolari ecc.), immaginati diversi nel peccato e nel disonore. Il confronto
con l’alterità è una condizione della trasgressione comica, e insieme il momento e l’occasione in cui l’altro si rivela come lo stesso,
la parte oscura di sé. Anche se sta dalla parte
opposta, “l’individuo è costretto a riconoscere che egli non è solo se stesso, ma ha dentro
di sé gli equivalenti di tutte le cose contro cui
combatte”4. Perché, come già scriveva Sorokin più di mezzo secolo fa, egli “ha tanti
io sociali quanti sono i diversi strati e gruppi
sociali con i quali viene a contatto”5.
Il comico è l’altro e lo stesso
Questa natura “altra” del buffone rende
ragione del fatto che il comico viene da un
4
5
14
altrove. Il teatro comico è il luogo della differenza, perché il personaggio comico è in
vario modo esterno alla cultura in cui opera,
anche quando l’altrove da cui proviene è del
tutto immaginario. Il teatro ateniese nasce
sotto l’influenza di un teatro popolare periferico, le farse megaresi, che forniscono i
modelli comici fondamentali, pur nella loro
gossolanità provinciale; megarese è ancora il
personaggio comico degli Acarnesi di Aristofane; una forte impronta contadina ebbero analogamente nelle città magnogreche
le farse fliaciche; il più antico teatro conosciuto a Roma, le Atellane, era considerato
di origine osca, anche se è ancora da dimostrare che questa extraterritorialità era reale e che si trattava veramente di Osci e non
(come a noi sembra) di Romani mascherati
da Osci. Nel teatro latino di imitazione greca i personaggi comici erano schiavi, quindi
stranieri: nel Poenulus di Plauto il comico è
un cartaginese; nelle corti e nelle piazze delle città medioevali si esibivano buffoni che
venivano (o si immaginava che venissero)
dalle campagne, insieme ai giullari girovaghi; le maschere della Commedia dell’Arte
dei secoli XVII-XVIII erano opera, anch’esse, di teatranti ambulanti di diversa provenienza, ed erano solitamente maschere etniche, che rappresentavano in forme tipiche le
virtù, ma soprattutto i vizi, presunti o reali,
delle culture locali viciniori. La stesso può
dirsi del successivo teatro delle maschere:
in quello napoletano – sono esempi – Don
Pancrazio rappresentava comicamente il
tipo del pugliese, Ponzevere quello genovese, Giangurgolo si faceva provenire dalla Ca-
W.I. Thompson, All’orlo della storia, cit., p. 191.
P. Sorokin, Society, Culture and Personality, New York, 1962, p. 345.
antropologia e storia
labria, Arlecchino da Bergamo. Nello stesso
teatro colto degli attori le figure comiche
sono frequentemente stranieri: nel Borghese
gentiluomo di Molière il comico è un turco;
nel teatro portoghese il personaggio comico
è un negro della Guinea. Singolare la storia
di Pulcinella: la maschera fu inventata dai
napoletani, i quali però la dissero sempre venuta da Acerra o da Ponteselice o Giffoni o
Benevento, ossia da contesti rurali e periferici; a Roma Pulcinella ebbe una vita teatrale, oltre che carnevalesca, molto intensa nei
secoli XVII-XVIII, e per i romani era la maschera napoletana, anzi del napoletano. Lo
stesso si può dire del Pulcinella migrato a (e
qualche volta bandito da) Venezia. In Francia Pulcinella diventa Polichinelle, e ha una
storia teatrale di oltre tre secoli, abbastanza
importante, ma è quasi sempre sentito, sia
pure residualmente, come napoletano.
Nel teatro di figura l’eroe popolare iraniano Pahlavān Kačal era fatto provenire
dalla parte dell’Iraq inglobata nello Stato
persiano, e apparteneva perciò alla nazione iraniana, pur essendo etnicamente iraqueno; il Punch inglese era percepito come
italiano di origine, almeno nei primi tempi
della sua storia, quando si chiamava ancora
Poncinello; Karagoz ha messo radici in tutti i paesi islamici del Mediterraneo, ma ha
origini inequivocabilmente turche. Il motivo della provenienza esterna è indicativo
innanzitutto del fatto che il teatro comico
è stato storicamente il teatro dell’etnicità,
almeno nel senso che la frizione etnica e
culturale (interno/esterno, città/campagna,
centro/periferia, selvaggio/civilizzato) ha
giocato un ruolo importante nella genesi
psichica e culturale del riso. Anche ai nostri
giorni i personaggi comici sono collegati socialmente, culturalmente, espressivamente a
/ 2 – comicità e politica
contesti regionali, dialettali, periferici, d’emigrazione, e sono portatori di una diversità
che è, vistosamente, una diversità etnica: riesce difficile immaginare, per esempio, Lino
Banfi senza il suo dialetto pugliese, o Totò
spogliato della sua napoletanità, o Benigni
senza la cultura antropologica toscana.
La provenienza esterna allude altre volte a un altrove sociale e può rispecchiare
tensioni tra ceti, classi, gruppi: nella Roma
dell’epoca classica i personaggi comici erano
schiavi; gli Zanni della Commedia dell’Arte
erano servi; Pulcinella è stato per i ceti privilegiati di Napoli il portatore della cultura
del “popolo minuto”; i personaggi ridicoli in gran parte del teatro europeo dell’età
moderna sono servi; il loro perfetto corrispettivo romanzesco era il popolano furbo,
il furfante intelligente, lo sciocco, il picaro,
lo stolto.
Ma la rappresentazione comica è anche
il teatro della estraneazione della differenza
interna. Il personaggio comico può provenire miticamente dagli Inferi. Il motivo rinvia
più direttamente alla diversità che preme
ai confini interni della cultura, alla parte
oscura di ogni società. Connotazioni diaboliche si riscontrano nelle figure comiche
di tutti i tempi, nelle mitologie che le concernono e nei comportamenti che esse manifestano: dall’Aldilà si immaginano venuti
i buffoni sacri delle Americhe; un demone
era Arlecchino e diabolico era l’universo
delle maschere della Commedia dell’Arte;
secondo Filippo, re di Francia, che si riferiva a convinzioni diffuse, “tanto è dare a
li buffoni, quanto sacrificare a li demoni”.
Nelle mitologie napoletane Pulcinella ha
origini inferiche, essendo un diavolo benigno uscito dal Vesuvio, bocca dell’Inferno,
in seguito all’invocazione di due fattucchie15
Q
uaderni
re. In alcuni dialetti italiani “stirune” indica
al tempo stesso lo stregone e l’istrione, ossia il comico teatrale. L’origine esterna del
personaggio comico indica dunque le forme
della diversità culturale (connotata, sia pure
ambiguamente, in senso negativo), che concretamente può essere, di volta in volta, la
cultura del mondo rurale, l’esperienza delle
classi inferiori e il lato diabolico dell’uomo,
con la tendenza a confondere le tre cose in
una sola. Come nel Carnevale, l’extraterritorialità (vistosamente segnalata dai linguaggi
corporei, verbali, comportamentali) indica
l’impossibilità di una identificazione totale
con figure e azioni che si avvalgono del nostro segreto consenso e della nostra intima
condivisione, nella misura in cui li sentiamo
parte di noi stessi.
Specializzazioni storiche e contaminazioni
I trickster politici
Secondo il modello antropologico di
Yeats interpretato da W.I. Thompson, nella
società agricola il surplus economico avvia
una crescente specializzazione che porta alla
suddivisione delle funzioni originarie presenti nel gruppo dei cacciatori, sia perché
per controllare il suo rapporto con l’ambiente e gestire l’economia urbana l’uomo ha bisogno di accumulare un numero crescente
di informazioni, sia perché la ricchezza consente la specializzazione delle attività e delle
professioni, che accrescono la distanza tra i
ruoli delle persone. Lo stesso effetto producono altre trasformazioni, come il passaggio
dagli individui alle istituzioni, con la conseguente “routinizzazione del carisma”: dallo
sciamano si passa alla religione, dal capo allo
Stato, dal cacciatore all’esercito, dal buffone
16
all’arte nel senso più ampio del termine, che
include l’arte comica. Gli specialisti ora lavorano a tempo pieno ognuno nella propria
istituzione. Non solo: in ogni istituzione generata dalla specializzazione si ripropongono ulteriori specializzazioni secondarie: se il
campo religioso è sincronicamente articolato nelle funzioni del Vescovo, del Teologo e
nel Mistico, quello del buffone si divide nei
vari ruoli artistici, dando vita anche ai differenti ruoli comici: satira, intrattenimento,
umorismo, ecc.
Ai nostri giorni la figura del trickster
porta a un limite che sembra estremo la
scomposizione, già iniziata in epoca storica,
della sua fisionomia originaria, la quale per
un verso moltiplica ulteriormente le tipologie della comicità, per un altro produce una
inedita confusione di ruoli e funzioni tra gli
statuti della comicità e ciò che comico non è.
Per quanto riguarda il primo aspetto, se Paolo Villaggio realizza fino al massimo dell’esasperazione la figura del buffone che “prende le botte”, incarnando il lato sacrificale
dell’eroe comico, Beppe Grillo ne incarna il
lato aggressivo che si esercita nella denuncia
derisoria e violenta della degenerazione politica, Alberto Sordi si è specializzato nella
rappresentazione grottesca dei vizi e virtù
del carattere nazionale, Maurizio Crozza
nella derisione del malcostume, della corruzione politica, del mercato malato del mondo globalizzato, rinfrescando con coraggio e
spudoratezza i modi coraggiosi e le metafore
della trasgressione sessuale ambiguamente
algolagnica. Erede, in area napoletana, di
Pulcinella può considerarsi Totò, per certi
versi a lui somigliantissimo, soprattutto nel
gioco verbale e nella logorrea, mentre Massimo Troisi ha fatto del farfuglio pulcinellesco il suo principale strumento espressivo.
antropologia e storia
Di solito i comici, anche quando acquistano
una notorietà nazionale o planetaria, emergono ancora oggi da realtà regionali, da cui
traggono le proprie maschere linguistiche ed
etniche che fanno la loro differenza culturale
e rendono possibile il gioco comico; vivono
anch’essi in una dimensione eroica, testata
dal loro successo, dalla loro popolarità e dal
rapporto intenso di affezione col pubblico.
Se Pulcinella nella sua regione è una sorta di
nume tutelare, un destino analogo, sia pure
senza il contorno delle mitologie “arcaiche”
che hanno accompagnato la fortuna della
maschera napoletana, è toccato agli attori
più amati dalla gente. La loro popolarità è il
segno più vistoso del riconoscimento della
loro funzione positiva e della loro trasformazione in miti di identificazione collettiva.
Negli ultimi decenni sono avvenuti nella sfera del comico altri mutamenti radicali.
Come effetto dei processi di scomposizione
della sintesi originaria, aspetti e funzioni
del trickster si ritrovano nelle nuove figure,
ambiguamente negative o positive, innocue
o perverse, che popolano il territorio della
comicità, come l’Ubu di Jarry e il Joker del
ciclo di Batman, discussi nel Convegno del
2008. Ma il fenomeno più vistoso dei nostri
giorni è forse quello dei comici prestati alla
politica e dei politici che in veste di showmen ripropongono le performances dei personaggi comici. Nel passato vicino e remoto
la comicità si è il più delle volte accompagnata alla politica, i giullari interpretavano
anche la protesta collettiva, il re aveva accanto a sé il buffone, che era anche il suo
alter ego; ma era inconcepibile che il giullare diventasse signore, se non nelle finzioni
dell’arte o della vita, e che il re prendesse il
posto del buffone, se non occasionalmente e
per gioco. Nella cultura tradizionale era pos-
/ 2 – comicità e politica
sibile che il comico si occupasse di politica,
ma era vietato che il politico assumesse in
maniera sistematica i comportamenti buffoneschi del comico. Il ribelle assume molto
frequentemente la giocosità provocatrice e
derisoria del buffone, ma lo fa finché rimane
un ribelle: l’identificazione dell’antipotere
col potere segnerebbe forse la fine dell’esperienza comica.
Allargando lo sguardo dalla finestra di
casa nostra, abbiamo esteso la ricognizione
di questo tricksterismo contemporaneo ad
altre nazioni, col risultato di essere sorpresi
e confortati dal ritrovamento di non pochi
casi che ci sembrano legittimare l’ipotesi
della loro comune appartenenza a questo
fenomeno proprio della tarda modernità
e della postmodernità. Ci è sembrato che
qualcosa di non trascurabile unisse ai comici-politici italiani Ernesto Morales Cabrera,
detto Jimmy, laureato in business e diventato un divertente showman televisivo, eletto
nel 2013 presidente del Guatemala col favore delle Destre e uno slogan rassicurante (“Per vent’anni grazie a me avete riso,
se sarò presidente non vi farò piangere”).
Erano gli anni in cui in tutto il mondo occidentale cominciavano ad accadere fatti
simili, come l’elezione-bomba alla Presidenza del Brasile, nel 2010, di Francisco Everaldo Oliveira Silva, (per sua madre Tirica,
“l’imbronciato”): di famiglia poverissima,
diventato artista di strada, ha cavalcato l’antipolitica con slogan molto semplici – era semianalfabeta – del tipo “Votate il deputato
vestito da pagliaccio, assai meglio che dare
il voto a questi pagliacci vestiti da deputato”.
Le prime avvisaglie del fenomeno erano apparse già qualche decennio prima, ad opera
del meno fortunato Coluche, ossia Michel
Colucci: attore comico nemico dei politici,
17
Q
uaderni
ebbe un successo straordinario, che lo convinse ad annunziare nell’ottobre del 1980 la
sua volontà di candidarsi alle elezioni per la
Presidenza della Repubblica francese, ma
ebbe molti nemici nel mondo politico che
contava, a cominciare dai comunisti (meritò
invece l’appoggio di intellettuali come Deleuze, Touraine, Guattari) che lo indussero
a desistere. Sappiamo tutti che Arold Schvarzenegger non è propriamente un attore
comico, ma forse per gli americani lo è, per
avere interpretato qualche commedia (Junior; Un poliziotto alle elementari), con cui
ha riscosso un successo che lo ha aiutato a
diventare Governatore nel 2000, confermato 2006. Il travestitismo è la connotazione
più vistosa che accomuna questi personaggi
ai trickster tradizionali: a seconda dei casi,
da orso, da Pussy Riot o da Darth Vader si
vestiva in Islanda Jólakvedja Jons Garr, che
sfondò in politica trattando temi croncreti
usando argomenti e linguaggi non molto diversi da quelli di Grillo, Francisco Everaldo
Oliveira Silva indossava camicie fiorite e e
un cappello pagliaccesco. Una sorta di travestimento – corpo e abbigliamento – è anche quello di Trump, che, pur costituendo
un caso a parte, anche per questo, oltre che
per la sua stravaganza buffonesca e l’assenza
di ritegno sembra partecipare dell’universo
dei politici-trickster.
Normalmente il fenomeno su cui stiamo
cercando di riflettere viene classificato come
populismo, un termine già dall’uso incerto
nel linguaggio politico tradizionale e del tutto inadeguato a descrivere o soltanto vagamente indicare un fatto radicalmente nuovo
nella società contemporanea, che presenta
una molteplicità e varietà di sfaccettature,
che rendono difficile la ricerca di un comune denominatore. Di solito si usa il termine
18
populismo (letteralmente, “il popolo come
modello”), in questo e in molti altri casi, per
designare spregiativamente i propri avversari, indicando cose diverse, variamente combinate, indipendentemente dal problema se
esse siano vere o false, autentiche o simulate
e strumentali; per lo più indicherebbe un
movimento di protesta che deve il suo successo alla capacità di ascoltare la “pancia”
scontenta della popolazione, ma destinato
a dissolversi in breve tempo per assenza di
programmi concreti, caratterizzato da paura
e intolleranza nei confronti degli stranieri e
da rancore verso le élite, da una antipolitica
fine a se stessa, potenzialmente distruttiva
o disgiuntiva, o dal rifiuto dei compromessi che livellano le differenze a vantaggio di
una reciprocità di privilegi e di interessi personali o di gruppo. Meno frequentemente
sono state negli anni passati evidenziati gli
aspetti costruttivi di almeno alcuni di questi
presunti populismi, come il loro progetto di
democrazia diretta, le rivendicazioni civili, la lotta alla corruzione e agli sprechi, la
domanda di giustizia sociale, la difesa dei
ceti deboli, la protezione dei beni e dei patrimoni comuni, il controllo delle banche, la
lotta ai poteri forti, la conquista del potere
per cambiare la società e assicurare stabilità
politica. Ma le nostre riflessioni vanno oltre
una lettura strettamente politica, che peraltro meriterebbe ben altro approfondimento,
e una più netta distinzione della specificità,
della storia, delle trasformazioni e del destino dei singoli personaggi e movimenti.
In America spettacolo e gossip non sono
rimasti estranei al modo di fare politica,
perché in democrazia la politica ama forme
rassicuranti di gaia socievolezza: i politici
sanno che, divertendo il popolo, si dà l’impressione di essere a lui vicini, e a volte lo
antropologia e storia
sono veramente. Ma questi precedenti americani, che prima di Trump, pur nella forma dell’intrattenimento, hanno rispettato
il modo corretto di fare politica negli Stati
Uniti, nella loro moderazione non facevano
prevedere quello che è successivamente accaduto in Italia a partire dagli anni Novanta del secolo passato, quando Grillo da un
lato, Berlusconi dal lato opposto e Bossi da
un altro orizzonte riproponevano in maniera diversa e in forme assolutamente inedite
i comportamenti trasgressivi che andavano
molto più avanti della democratizzazione
della comunicazione politica e stravolgevano il bon ton dei discorsi tradizionali, mimando, con esiti diversi, le forme aggressive
e spudorate e lo spirito dell’antipolitica. La
radicalizzazione dell’aggressione comica al
potere o ad alcune forme di potere, che ha
segnato e segna ancora gli ultimi lustri della
vita pubblica italiana, è stata alimentata dalla perdita di credibilità di uno stile di comunicazione politica, quello del “politicamente
corretto”, percepito come mendace e noioso
e di fatto autoritario e lontano dalla gente,
e dal discredito delle rappresentanze politiche che non riescono più ad avvalersi delle
tradizionali maschere linguistiche, perché
sprofondate nella corruzione e nell’illegalità, e private del potere che conta a vantaggio
delle lobby transnazionali e del potere finanziario. Il discredito dell’intera classe politica
accresce l’influenza dei comici, i quali non
si limitano più a fiancheggiare e supportare
i potenti, oppure a contrastarli, ma si inseriscono nel vuoto della comunicazione che
essi hanno prodotto, aspirando a svolgere
una funzione di supplenza.
Tutto questo può sembrare non completamente nuovo (si pensi – ma è solo un
esempio, forse il più significativo – ad Ari-
/ 2 – comicità e politica
stofane, ai cui personaggi ribelli la passione
libertaria e antitirannica ha fatto meritare
per la prima volta il riconoscimento di “eroi
comici”) (5), ma è invece nuovo nel fatto che
i comici che afferiscono a questa categoria
non sono solo guitti di successo, ma anche
politici di rango, che all’anomalia sociale di
essere imitatori dei comici aggiungono l’estremismo di un linguaggio aggressivo, irriguardoso e osceno, e di azioni simboliche
e realistiche che offendono il senso comune
della misura e del pudore, in contrasto cogli
stili comportamentali e linguistici dei ceti
superiori e delle figure pubbliche e con la
moderata licenza delle strategie comunicative e verbali con cui la comicità ha storicamente aggirato le interdizioni linguistiche
ed etiche.
Questi mezzi hanno consentito a Beppe
Grillo di costruire un partito con lazzi, insulti, aggressioni verbali, rivelazioni e indiscrezioni scandalose, e a Silvio Berlusconi
hanno permesso di giocare con le pratiche
erotiche spregiudicate e contro legge e con
le oscenità linguistiche che hanno osato “abbassare” e irridere donne e uomini rispettati
e potenti (chi non ricorda la “culona” teutonica?), in gara a volte col più elementare e
greve machismo buffonesco di Bossi.
Perché i comici
Il nuovo ruolo dell’informazione
Nella strutturazione dei ruoli fondamentali dell’organizzazione sociale e nelle sue
trasformazioni nel tempo l’informazione
svolge una funzione e un ruolo sempre più
determinanti. Se “l’ambiente è un campo
di energia che sostiene l’organismo dell’individuo”, l’informazione è il mezzo di cui
19
Q
uaderni
l’individuo dispone per accumulare energia
e quindi controllare la natura e il mondo
sociale. Le società complesse si distinguono
dalle altre, perché hanno accumulato una
maggiore quantità di energia, e possiedono le informazioni che hanno accelerato il
loro sviluppo. Siamo nell’era del dominio
dell’informazione, e, mentre cade a pezzi la
retorica tradizionale della politica, e i politici perdono la credibilità e perfino la dignità
del ruolo tradizionale di informatori/formatori, i comici, grandi comunicatori, capaci di
suscitare il riso che ha la forza di produrre
forme o illusioni di consenso, comunque
di sintonia, guadagnano un vantaggio che
li proietta nell’agone politico. In questo
contesto alcuni politici, di solito diversi dai
professionisti della politica e in vario modo
transfughi dalle secche del linguaggio politicamente corretto, mimano i modi e gli eccessi della comunicazione comica.
Nella misura in cui i comici riempiono
il vuoto dell’informazione politica ormai
screditata e di quella giornalistica, compromessa con poteri sempre più sentiti come
inaffidabili e corrotti, la loro nuova funzione modifica contenuti e forme del loro lavoro: i comici politici diventano ora in primo luogo informatori, produttori di analisi,
e le connotazioni comiche si aggiungono,
come complemento e strumento, a discorsi
che sono frutto di studio e preparazione e
seguono una logica a loro modo stringente nel rappresentare e interpretare la realtà
sociopolitica e fare critica sociale. Valgano
gli esempi italiani di Grillo e Crozza e, su
un altro versante, le indagini e le rivelazioni
spregiudicate di Trump sull’operato di Hil-
6
20
lary Clinton, che hanno fatto crescere la sua
possibilità di diventare l’uomo più potente
del mondo.
Sotto alcuni aspetti il rapporto dei comici con la censura, per quanto la pressione di
quest’ultima sulla politica e la produzione
letteraria e teatrale sia oggi notevolmente
allentata, riproduce residualmente le condizioni tradizionali: nel 1848, quando vennero
eliminate le misure censorie di Metternich,
Heine commentò: “Come farò adesso, non
posso più scrivere, non posso, perché abbiamo eliminato la censura. Come può scrivere
senza censura un uomo che ha sempre vissuto con la censura?”)6. In effetti, “Quando
un’opera letteraria … tocca campi tabù in
un determinato ambiente sociale, il sistema
dei divieti stimola la fantasia dell’artista a
trovare dei segni per cifrare la propria intenzione”: si scatena cioè l’arte del camuffare,
l’abilità della doppiezza, dei trasferimenti
metaforici, delle allusioni, dell’inserimento
di segnali ambivalenti e ambigui nel testo.
Questo sapere, che ha una storia immemorabile, si ritrova in parte nell’arte comica
contemporanea, nonostante l’indebolimento delle forme tradizionali di censura, ma
ormai non ne costituisce forse l’elemento
determinante. Anche se le più gravi forme di
intervento censorio sono oggi superate, ne
sono nate di nuove, più subdole e meno facilmente percepibili. Le nuove forme di divisione del lavoro, delle specificità e delle aree
di competenza, nel modo in cui sono concepite e realizzate, favoriscono la formazione
di nuove situazioni censorie, peraltro non
del tutto sconosciute nel passato. Al primo
posto nel campo televisivo c’è la distinzione
V. Zmegac, Creazione letteraria e consumo sociale, tr. it., Napoli, Pironti, 1980, p. 68.
antropologia e storia
tra quelli che possono gestire l’informazione, e quelli che devono solo fare spettacolo
o satira senza ispirarsi alle contraddizioni e
alle lacerazioni della realtà, e la divisione dei
generi e dei linguaggi è la nuova tecnica con
cui si ripropongono le istanze del controllo
e della censura. A soffrirne è soprattutto la
satira, perché la divisione del lavoro vigente
nella televisione prevede o vieta a chi fa satira di occuparsi di politica, e chi fa intrattenimento non può occuparsi di informazione.
Le nuove vie della comicità post-censura
sono perciò quelle battute dai comici che
congiungono ciò che era disgiunto, operano
contaminazioni di generi e di settori istituzionalmente autonomi, mimano, inventano,
riscrivono linguaggi, mescolando politica,
intrattenimento, informazione, musica, balletto, caricatura, riflessione e aggressione,
dilatando e arricchendo gli stessi territori
classici della satira, rinnovando per molti
versi i fasti della Commedia dell’arte.
Di fronte alle difficoltà o all’impraticabilità di questo percorso, rimane l’abbandono
della televisione e dei luoghi di spettacolo
ufficiali per mettersi in proprio, fare lavoro di nicchia, ma, soprattutto, ritrovare la
piazza, dove i comici raccolgono l’eredità
emotiva e simbolica del Carnevale e della
Commedia dell’Arte. La piazza torna a rendere liberi, consentendo di parlare e dialogare direttamente e senza mediazioni con la
pancia oltre che con la coscienza della popolazione, e dove la piazza finisce ha inizio il
web. Hanno seguito il loro esempio i politici
con vocazioni tricksteriche, che in qualche
modo nella piazza c’erano già, e, paradossalmente, è ora la televisione ad inseguire la
piazza. La libertà dei nuovi comici consente
l’innalzamento del livello della trasgressione
oltre ogni limite nella critica sociale, poli-
/ 2 – comicità e politica
tica, ecologica e del costume, usando come
sberleffi o come pietre i registri osceni della
comunicazione e inglobando nell’aggressione comica la vita e la persona degli avversari.
Ritorno delle forme arcaiche del trickster?
Il fenomeno almeno sotto alcuni aspetti può essere letto come un “ritorno” delle
forme arcaiche del trickster, come il sintomo nevrotico dormiente, che, nel suo improvviso risveglio, ripropone paure arcaiche
e antiche domande di salvezza, l’angoscia
degli assilli quotidiani e la speranza di millenaristici rivolgimenti. I comici-politici e i
politici-comici hanno infranto il codice che
impone la separazione di privato e pubblico,
personale e politico, emotivo e razionale, a
favore dell’attacco ad personam, che denuda l’avversario, incarnazione del Potere,
trascinandolo nei giochi cattivi dei rituali carnevaleschi, in una sorta di irridente e
impietosa confessione pubblica dei peccati,
che coinvolge nel confronto politico la totalità della persona, il carattere, la moralità,
i vizi privati, le anomalie familiari, e perfino
le caratteristiche fisiche e la fisiognomica.
Alle spalle di queste performances c’è un
mutamento radicale del costume, di cui essi
sono gli interpreti più o meno inconsapevoli,
che comunque contribuiscono a incrementare.
Sono anch’essi, come i trickster di ogni tempo e
luogo, violatori di tabù (con fisionomie diverse,
corrispondenti alle diverse culture o fazioni in
cui è divisa la società), ma sono o aspirano ad
essere, al tempo stesso, i salvatori, e, in quanto
tali, eroi culturali, capaci di riscrivere i linguaggi
dello scambio sociale, cavalcare le trasformazioni e governare le contraddizioni. Era questo,
dopotutto, il compito del trickster originario.
21
Q
uaderni
L’impunità, che la gente accorda ai trickster (a volte indipendentemente dal giudizio
dei tribunali o in contrasto con essi), nasce
dal riconoscimento implicito di questa importante funzione. Dei politici-comici già
ricordati Berlusconi è stato quello più vicino
al modello statunitense del politico intrattenitore, di cui però ha prospettato un rischioso scavalcamento, senza che questo per parecchio tempo abbia comportato una perdita
di consenso popolare (se addirittura non l’ha
fatto crescere). Il caso Berlusconi è stato definito “un paradosso demoscopico”, ma paradosso, a ben vedere, non è stato. Un lettore
intelligente ha scritto nel maggio 2008 a un
giornale; “Berlusca ama raccontare barzellette, i colpi di teatro, le pacche sulle spalle, fare
le corna, corteggiare deputate belle e giovani che potrebbero essere sue nipoti, scrivere
loro deliziosi bigliettini … insomma pare un
giocherellone assatanato. È forse per tutto
ciò che gli italiani lo hanno votato”?7.
Il fenomeno Berlusconi e il fenomeno
Grillo, anche se in politica diversamente
orientati, sono accomunati dall’idea (che
potrebbe non essere nella loro testa, ma è
come se ci fosse) che bisogna sfidare i tabù
per acquisire i poteri che consentono di influenzare e controllare la realtà; ma sono,
ancora, accomunati dall’impunità e dal successo che la gente ha accordato ad entrambi,
riconoscendo nella loro eccentricità e nei
loro eccessi i segni di aspettative e bisogni
collettivi. In più, soprattutto Berlusconi aggiungeva al potere che la trasgressione gli
conferiva i vantaggi e l’autorevolezza delle istituzioni e del potere che ufficialmente
7
22
“Libero”, 20 maggio 2008.
rappresentava, creando un miscuglio che
lo rendeva ancora più forte e impunito, col
risultato che la contaminazione di potere e
antipotere ha rischiato di distruggere la vera
essenza della comicità.
Se per un verso il comico è portatore di
disordine, per un altro egli svolge una importante funzione di rifondazione e di rafforzamento dell’ordine sociale. Il trickster delle
mitologie primitive è un eroe civilizzatore,
che compie azioni di grande utilità per gli
uomini e fornisce loro i mezzi per migliorare
la vita. I buffoni sacri di tutti i popoli svolgono una importante funzione equilibratrice
soprattutto in relazione alle tensioni interne
e ai rapporti con l’esterno. Anche se questa
connotazione è diventata opaca nella percezione moderna della comicità, è significativo
che ancora oggi i comici godano di grande
popolarità e vengano considerati altamente
rappresentativi della vita dei popoli, pur non
incarnando il meglio dei caratteri nazionali.
In effetti il personaggio comico media il rapporto con il mutamento; l’esperienza comica può essere contro le innovazioni, quando
esse minacciano di mettere in crisi la vita della comunità, e può a sua volta promuoverle,
quando i sistemi culturali si vanno sclerotizzando. I comici non colpiscono nessuna
delle classi sociali, ma bersagliano di ognuna
di esse gli eccessi e le debolezze, che ne ostacolano il loro ruolo e la loro funzione sociale.
In quest’ottica acquista trasparenza la risata
comica: nell’universo della comicità si ride
al tempo stesso per includere o escludere,
per accettare o respingere; la comicità non
si identifica mai interamente con la derisio-
antropologia e storia
ne, che costituisce soltanto uno dei suoi poli
dialettici: l’altro polo è quello dell’accoglimento: si (de)ride per escludere ciò che non è
compatibile con le domande di vita collettive
e col proprio sistema culturale e si ride per
integrare ciò che può integrarlo o arricchirlo.
L’esperienza comica promuove e sollecita il
confronto col nuovo e al tempo stesso difende dalle minacce dell’ignoto.
Il comico è ancora il capro espiatorio, il
“buffone che prende le botte”? Anche se il
successo di alcuni attori sembra aver sconvolto lo schema arcaico del trasgressore
come “peccatore per tutti”, che fa il bene
della collettività pagando di persona con i
suoi scacchi e con la malizia o violenza della
persecuzione, del ridicolo e della beffa, non
sfugge a nessuno che quasi tutti i comici
diventati politici in diversi modi e con esiti
differenti hanno sfidato il potere vengono da
esperienze di emarginazione e di sofferenza,
che appaiono strutturalmente connesse con
la loro storia di trasgressori e di ribelli. Sono
di norma ridicolizzati e sbeffeggiati per la
loro grossolanità e stravaganza, minacciati
e fatti oggetto di persecuzioni giudiziarie,
di violenza verbale e perfino fisica. Victor
Trujillo era noto come “il pagliaccio losco”,
Trump “pagliaccio da rodeo”, e così via.
La televisione è il luogo in cui più facilmente si esercitano le tecniche di emarginazione e di esclusione che colpiscono i comici antisistema e si fanno tacere o espellere
le voci autonome o ribelli della satira. Una
delle strategie è quella di non aprire le porte
dei media pubblici e privati ai talenti troppo
liberi, far invadere le televisioni da programmi e intrattenitori di sicura fedeltà, abili, al
più, nelle innocue caricature, in modo da
non lasciare spazio a voci autonome e compromettenti. L’assenza dalla RAI di autori
/ 2 – comicità e politica
come Daniele Luttazzi, Beppe Grillo, Maurizio Crozza è l’effetto di operazioni censorie,
ispirate da precisi orientamenti politici e da
interessi di parte. A differenza degli intrattenitori e dei comici di regime e addomesticati,
la loro comicità si fonda su una ricerca e una
documentazione rigorosa, ed è ispirata da
principi morali prima che da idee politiche.
Questo li rende invisi ogni volta che affrontano situazioni sgradevoli, costringendoli a
rinunciare al loro successo e scegliere il rifiuto con la conseguente emerginazione. Grillo,
come Santoro, Biagi, Luttazzi sono alcuni
dei grandi esclusi dall’universo dell’informazione televisiva italiana a cominciare 1993,
quando Grillo denunciò i socialisti come
ladri e lasciò la televisione per continuare liberamente a fare satira furiosa nelle piazze.
Luttazzi fu mandato via dalla Rai per la sola
colpa di avere intervistato Marco Travaglio
nel 2001. Il destino dei politici che abbiamo
etichettato un po’ superficialmente come
“comici” è stato, ovviamente, determinato
da ragioni diverse e perfino divergenti, ma,
tra esse, un qualche peso può avere avuto la
loro tendenza a contrastare il modo corrente
e consolidato di fare politica e spavaldamente ignorare lo stile dominante nel comportamento e nell’uso della comunicazione. Un
destino, che ha contribuito a fare di Berlusconi il bersaglio di attacchi giudiziari che lo
hanno forse definitivamente travolto. Trump è per il momento un trickster vincente,
ma le élite economiche, politiche e culturali
che lo hanno avversato sono tutt’altro che
rassegnate alla sconfitta. Su un versante diverso Grillo sembra sul punto di vincere
definitivamente, ma su entrambi sembra addensarsi un orizzonte di attese che aggrega
alle certezze utopiche dei loro fedeli le interessate previsioni del loro scacco finale.
23
Gli ossimori di Trump as trickster
Patrizia Del Barone
A
lmeno fino alla metà del
Novecento, notoriamente,
la politica era in sostanza la
Weltanschauung, la visione del mondo per eccellenza, lo strumento
attraverso il quale esercitare il governo di
una comunità, mezzo di pedagogia sociale
e di partecipazione collettiva. Oggi, in una
società in preda all’incertezza e allo spaesamento, al rancore e alla solitudine, alla paura di modelli di vita non negoziabili, che si
sente insidiata e minacciata nella propria
sicurezza, il paradigma dominante è l’antipolitica, che esplode, non di rado, con forza
“mitologica” e con la quale prendono il sopravvento le maschere della post politica1.
In questa prospettiva un fenomeno tutto
moderno, e non solo americano, è il “trumpismo”, che è già entrato nell’immaginario
collettivo delle popolazioni del globo. In Italia, alcune sue connotazioni si ritrovavano
nella “rottamazione”, ormai passata di moda
e quasi dimenticata come un’esperienza
mendace, e nel “grillismo”, che invece ha subito una felice metamorfosi da movimento
1
2
3
4
vincente, avviando una normalizzazione che
supera i timori iniziali del salto purificatore
nel buio. Il trumpismo nel modo in cui ha
già conquistato il potere nella nazione più
potende del mondo rappresenta un ritorno
prepotente alla virilità esibita, ad una governance testosteronica esercitata da una figura
demiurgica, il “trumpista” appunto, che irrompe in scena e, con un linguaggio che non
conosce mezze misure, si dichiara in grado
di metter mano e di risolvere le perversioni
della modernità2.
L’istrione, per eccellenza, dell’anti-politica è, dunque, Donald John Trump Sr, per
alcuni “the tycoon”, per altri semplicemente
“the Donald”, il magnate americano che ha
associato al ruolo di imprenditore quello di
politico trasgressivo ed eccentrico senza rinunciare alla sua vocazione di intrattenitore
pagliaccesco, diventando per molti l’uomo
di punta di quella tendenza globale definita
dai più come una forma di reazione al “declinismo” occidentale3.
Donald Trump è un uomo poliedrico:
facoltoso investitore immobiliare4, latin lo-
Ved. M. Nardelli, Trumpismo, le maschere della post politica, su www.michelenardelli.it/articolo/3686/.html.
Ved. G. Giglio, Trump e il “trumpismo” alla conquista dell’Occidente, su www.effemeride.it/trump-e-il-trumpismo-alla-conquista-delloccidente/.
Ved. G. Giglio, Trump e il “trumpismo” alla conquista dell’Occidente, su www.effemeride.it/trump-e-il-trumpismo-alla-conquista-delloccidente/.
Le sue proprietà sono in diverse parti del mondo: da New York a Chicago, da San Francisco a Los Angeles, da
Washington DC a Philadelphia, da Porto Rico ad Aberdeen in Scozia.
25
Q
uaderni
ver5 e personaggio televisivo di successo grazie ad un reality show da lui stesso prodotto
e condotto per oltre dieci anni6. Ha scritto
numerosi libri, alcuni dei quali sono diventati dei best sellers7, si è fatto conoscere nel
mondo del wrestling8; è blogger, proprietario di alberghi, di un’agenzia di modelle, di
campi da golf e casinò. Ha avuto dei camei
in diversi film e telefilm e ha interessi nella moda, nell’arredamento, nei prodotti di
bellezza, nello sport. Dalle origini familiari
modeste è diventato presto icona del sogno
americano dell’abbondanza, dell’autonomia
e dell’autorealizzazione.
Eppure il suo stile appare decisamente
savonaroliano. Trump usa una dialettica inquietante ed una retorica impulsiva e graffiante: prima di diventare Presidente degli
Stati Uniti ha parlato dei messicani come degli stupratori, si è dichiarato favorevole alla
tortura, all’uso delle armi da fuoco e alla costruzione di muri di frontiera; ha propugnato l’isolazionismo, fomentato crociate anti
islamiche, lanciato grotteschi insulti personali e minacciato di dare alle fiamme trattati
commerciali internazionali anche a costo di
innescare una guerra planetaria. Ha giustificato l’uccisione delle famiglie dei terroristi ed esaltato l’uomo bianco, eterosessuale,
duro e le forme di una dittatura neoliberista.
C’è, dunque, una sorta di “nonsense” forte,
diretto, anche violento, che, chiaramente,
lo “scomunica” sul piano morale, etico ed
7
estetico. Tuttavia non lo allontana o lo condanna. Al contrario, riscuote applausi e consensi. Trump piace, non a dispetto delle sue
sparate e dei suoi atteggiamenti stupefacenti,
ma proprio grazie a questi.
Piacciono le strategie della comunicazione pubblica, apocalittiche ed assertive.
Come in uno show televisivo, in una coreografia holliwoodiana, le parole sono sempre
forti e i toni fieramente sboccati. Gli elettori
non pensano più in termini ideologici e appaiono come i telespettatori leali alla star, accomunati tra loro dal gusto per i politici-intrattenitori – vuoi politici-pagliacci o comici
prestati alla politica – che, a differenza dei
politici tradizionali, puri, detestano l’idea
di compromesso. Mescolano argomenti sia
di destra che di sinistra e non parlano né il
linguaggio cifrato dell’accademia né quello
paludato dei professionisti. Con rude sincerità e con riferimenti alla portata dell’uomo
della strada, si rivolgono direttamente alla
loro “pancia”, puntano agli istinti più bassi,
mettendo a nudo le pulsioni recondite e l’anima oscura dell’America. “Pensa in grande
e manda tutti al diavolo nel lavoro e nella
vita!”9 è la loro filosofia di vita. Nel confronto politico privilegiano l’attacco personale,
“che denuda l’avversario trascinandolo nei
giochi cattivi dei rituali carnevaleschi, in
una sorta di irridente e impietosa confessione pubblica dei peccati”, delle sconvenienze
e dei vizi privati10. Questo è un cambiamento
Si è sposato tre volte e ha cinque figli.
Il programma televisivo è The Apprentice, un reality show prodotto e condotto dal 2004 al 2015.
The Art of the Deal, la sua autobiografia del 1987, ha venduto oltre tre milioni di copie. Tra gli altri: How to Get Rich,
Crippled America, Time to Get Tough, The Art of Comeback, The America We Deserve, The Way to the Top, Think
Like a Billionaire, Never Give Up, ecc.
8
Trump, rappresentato dall’atleta Bobby Lashley, vinse nel 2007 la Battle of Billionaires, contro Vince McMahon/Umaga.
9
Questo è il titolo di un suo libro, scritto con Zanker Bill e pubblicato da Etas nel 2008.
10
Ved. Domenico Scafoglio, Comicità e politica al tempo di Grillo, su www.la rete-associazione.it.
5
6
26
antropologia e storia
generazionale, antropologico. La scena della
politica contemporanea riporta alle forme
primigenie del divino burlone quale incarnazione comportamentale di un eroe culturale che è, ossimoricamente, trasgressore
ordinatore e vittima salvifica. L’ascendente
dell’anti-politico e/o post-politico affonda
le sue radici in un contesto umano turbato,
ferito proprio dai mali della politica, che mal
sopporta la sua involuzione cancerosa, che
non riesce ad appartenere e per il quale questi rappresenta un’appartenenza. Come sottolinea l’antropologo Domenico Scafoglio,
l’impunità che la gente gli accorda nasce
proprio dal riconoscimento dell’importante
funzione che questi ha11: un “utile idiota” che
consuma un rito liberatorio e salvifico con
una trovata buffonesca, che ha dimostrato di
pagare in politica quanto un impero.
Quando le istituzioni politiche sono
screditate e screditabili, quando non c’è più
una progettualità condivisa ed ogni prospettiva futura è mendace e fallace, ecco che arriva Trump a salvare il mondo, l’unico uomo
sulla Terra in grado di sconfiggere questa
subdola minaccia aliena12.
Lo stile della comunicazione politica,
oggi, ha una nuova veste, si colora di termini e atteggiamenti che appartengono ad
una sfera – quella della comicità – che è
nella dimensione opposta e tanto più colpisce perché inaspettato. Il politico è uno
showman. Silvio Berlusconi e Mike Pence13
– governatore dell’Indiana, candidato alla
/ 2 – comicità e politica
vicepresidenza di Trump – ne sono l’esempio. Il mescolamento dello statuto comico
con il codice politico, e viceversa, porta alla
ribalta i trump del mondo, i “trickster contro”: Beppe Grillo in Italia, Victor Trujillo in
Messico o Pim Fortuyn nei Paesi Bassi. Victor Trujillo, ad esempio, è un comico televisivo, noto come “Bozo il pagliaccio losco”,
ma è anche il più influente commentatore
politico messicano; Fortuyn, invece, era un
politico omosessuale, che prima di essere
ucciso in modo violento, mostrava un vero
talento per lo scandalo e le sue apparizioni
pubbliche erano una chiara forma di intrattenimento provocatorio14. Alla stregua di
Trump, poi, Beppe Grillo, con il gusto della
provocazione, a furia di lazzi e irriverenze,
ha fondato il secondo partito italiano, che
si candita a governare l’Italia. L’espressione
“seriously funny” (“seriamente divertente”)
è forse l’espressione più congeniale ad esprimere la vocazione e la disposizione artistica
“liminale” di questi “buffoni demagogici”,
priva di inibizioni, indifferente ad ogni tabù
e capace di trasgredire ogni tipo di confine.
Donald Trump è un politico trickster,
uno strano personaggio – come quello che
compare nelle mitologie di molti popoli –
irriverente, osceno, triviale e blasfemo, che
mostra attraverso la sua denuncia-derisione
bricconesca come non esista realtà inaccessibile e impenetrabile che non possa essere
svelata, ed è così che induce in uno stato di
ampliamento della coscienza15.
Ved. in questo numero dei “Quaderni” Domenico Scafoglio, Comicità e politica al tempo di Grillo.
Ved. la storia a fumetti Martin Mystère, in particolare Condominium, ovvero come Donald Trump salvò la terra
pubblicata nell’Almanacco del Mistero 1990, Sergio Bonelli Editore.
13
Pence fu conduttore radiofonico del Mike Pence Show dal 1993 al 1999. Si dice che la sua carriera politica – dopo
la sconfitta alle elezioni del 1988 e poi a quelle del 1990 – sia decollata proprio grazie allo show.
14
Ved. “Un pagliaccio da rodeo” su www.DagoSpia.com.
15
Ved. P. Radin, C.G. Jung, K. Kerenyi, Il briccone divino, Milano, Bompiani, 1965, p. 20.
11
12
27
Q
uaderni
Ian Buruma definisce Donal Trump “un
pagliaccio da rodeo”16 e, di certo, anche nella
fisiognomica, con la sua acconciatura di color
arancio, cotonata e con il riporto, ha un’aria
bislacca. Lo stesso nome rivela un aspetto comico burlesco. Infatti la parola inglese trump
può significare: briscola, carta vincente, oppure sconfitta, inganno, ma anche “scoreggia”.
Nomen est omen dunque e subito qualcuno,
ripensando alla sua carica eversiva, si è chiesto
– prima che egli diventasse il capo della più
grande potenza del pianeta – se sarebbe stata,
forse, proprio una “scoreggia” che avrebbe travolto le difese della civiltà17. Ma molti americani ora più che mai pensano che il pagliaccio
da rodeo cambierà la storia del mondo.
Forse per la prima volta seriamente preoccupati se non spaventati, le élite, i poteri
occulti, la grande stampa, gli intellettuali, gli
artisti hanno fatto di tutto per fermare il ciclone Trump, facendo leva perfino sui suoi
comportamenti scandalosi verso le donne,
non considerando che la gente è indifferente all’illecito sessuale quando sono in
gioco questioni di vitale importanza, come
la sopravvivenza, la sicurezza, il benessere.
Questo vogliono da Turmp i trenta milioni di poveri della nazione più potente del
mondo, il ceto medio impoverito, i contadini e gli agricoltori delle immense province americane, le categorie non protette dai
guasti della globalizzazione, gli operai cogli
stipendi bassi che non hanno tratto vantaggi
dalla ripresa economica degli Stati Uniti. Su
questi ceti arrabbiati, rancorosi, che ancora
una volta individuano le cause del loro disagio negli immigrati, nelle minoranze, negli
stranieri, nei furti e nei privilegi e sprechi
delle caste Trump ha costruito il suo successo, prendendo le distanze dalle grandi istituzioni internazionali e dalla loro retorica,
promettendo misure protezionistiche, la difesa delle frontiere, il disimpegno americano
all’estero, e, in economia, il taglio delle tasse
a lavoratori e imprenditori, un incremento
degli investimenti. Un pugno allo stomaco, alla coltre di conformismo della società
americana.
Ved. “Un pagliaccio da rodeo” su www.DagoSpia.com.
Ved. Franco Berardi Bifo, L’era Trump. Una scoreggia ci seppellirà?, su www.alfabeta2.it.
16
17
28
Per una riscrittura del brigantaggio
postunitario. Il problema delle fonti
Simona Piera De Luna
Tra lacune e censure. Il silenzio delle fonti
I
l problema delle fonti è cruciale per
una visione innovativa della guerra
civile denominata convenzionalmente
brigantaggio del periodo 1861-1870. È
stato già rilevato che “i numerosi documenti
schedati, molti dei quali assolutamente inediti, non rappresentano certamente tutto
quanto è accaduto in quegli anni”1. Se ad impossibilia nemo tenetur, perché ciò che non
è documentato non è raccontabile, rimane,
oltre il problema degli inediti, la possibilità
che anche il silenzio possa essere oggetto di
utili riflessioni. Intanto lo storico deve mettere nel conto che anche le vicende e vite che si
presumono meglio documentate presentano
vuoti, abrasioni e semplificazioni minimaliste, che possono essere indagati e spiegati
come sintomi e segni di una selezione partigiana o di una sottovalutazione dovuta a limiti cognitivi, e l’una e l’altra si leggono nelle
fonti prima che nelle interpretazioni. Molte
cose non sono state dette o non sono state
osservate con la giusta attenzione e lucidità.
In altri termini, molti fatti e personaggi sono
1
2
assenti dalle fonti per occultamento involontario o casuale e per la dispersione spontanea
delle carte e delle prove; altri ne sono stati
esclusi palesemente dalle varie forme di censura politica, etica, religiosa; altri infine sono
presenti, ma è come se non lo fossero, per
essere stati condannati a una irrilevanza che
confina con la non esistenza. A queste forme
di censura ed autocensura che si registrano
nelle fonti si sovrappongono poi quelle degli
interpreti, che moltiplicano il silenzio e le deformazioni originarie. Valga un esempio, che
abbiamo illustrato in un nostro precedente
studio2: il fenomeno della presenza attiva e
militante delle donne all’interno delle bande,
certificata, sia pure in maniera esigua, da una
quantità di testimonianze inoppugnabili, ma
quasi interamente ignorata dagli storici di
professione, rinvia a questo ordine di considerazioni. Che si tratti di un fenomeno più
sottile di una semplice sottovalutazione e
distrazione sembra dimostrato dal fatto che,
pur ignorate nelle loro ricerche, l’esistenza
delle brigantesse non era sconosciuta agli storici e agli antropologi, perché aveva costituito
un tema artistico e letterario molto frequen-
G. Clemente (a cura di), Il brigantaggio in Capitanata. Fonti documentarie e anagrafe (1861-1864), Roma, Archivio
Guido Izzi, 1999, p. 14.
D. Scafoglio - S. De Luna, Le donne col fucile. Brigantesse dell’Italia postunitaria, Università di Salerno, CUES, 2008.
29
Q
uaderni
tato dagli scrittori e dal pubblico, dall’Ottocento ad oggi.
Ma di che cosa si sono autocensurati, nel
caso specifico, gli storici, in questa sottovalutazione di fonti, di cui è ormai difficile negare l’importanza? il loro comportamento,
nel caso delle brigantesse, coincide, in parte,
con quello dei tribunali che giudicarono le
compagne dei briganti: sia gli uni che gli altri hanno la responsabilità di non avere visto
altro nelle brigantesse che delle povere donne rapite dai fuorilegge e diventate bandite
per coazione, e pertanto innocenti, perché,
in quanto donne, incapaci di non sottostare alla forza bruta. Le nostre precedenti indagini, che hanno dimostrato il contrario,
pur nella complessità delle situazioni, che
rendevano problematiche per le donne le
possibilità di scelta, hanno rappresentato
più probabilmente il trionfo di alcune verità
contro le rimozioni dell’inconscio e le simulazioni dell’ideologia. Gli storici tuttavia
sono andati oltre rispetto ai giudici, perché
hanno eliminato il problema, escludendo
interamente le donne dalla storia del brigantaggio postunitario.
Un altro aspetto che condiziona l’attività di ricerca sul brigantaggio è costituito dal
carattere frammentato e settorializzato delle
fonti cui è affidata la testimonianza dei fatti,
che sono o possono essere culturali, sociali,
economici, militari, giudiziari ecc. Questa
frammentazione delle fonti ha condizionato le pratiche di ricerca (notoriamente
già di per sé separate se non scisse in una
molteplicità crescente di discipline e subdiscipline), incoraggiandole ad affrontare
settorialmente i fatti storici e i problemi sto-
3
30
F. Trapani, Le brigantesse, Roma, Canesi, 1968.
riografici, nella direzione di una specificità
poco espansa e soverchiamente monolineare. In altri termini, questa specializzazione
convenzionale era nelle fonti prima di essere
nella metodologia, e la teoria, invece di correggerla operando connessioni e aperture
transdisciplinari, si è limitata a legittimarla,
pressoché ignorando il problema. In questa
specializzazione convenzionale gli archivi
hanno conservato gli atti dei processi e/o le
carte dei militari, che sono rimasti mondi
lontani e non facilmente accessibili agli interpreti dei modelli culturali delle popolazioni, la psichiatria criminale ha utilizzato la
storia per dimostrare le sue teorie, di fatto
inventandosi una caricatura della ricerca sul
terreno, la memorialistica militare è uscita
a volte dal proprio orto solo per introdurvi elementi della letteratura d’invenzione, la
letteratura popolare ci ha restituito testimonianze autentiche della civiltà delle campagne, che gli storici hanno a volte sprezzantemente lasciato ai folkloristi, e così via. Tutto
questo ha reso difficile la rappresentazione
unitaria della guerra civile postunitaria al
tempo del brigantaggio, già aggravata dalla
mancanza di pratiche consolidate di lavoro
transdisciplinare e dai condizionamenti del
conformismo politico ed ideologico.
Forse la più vistosa, se non la più grande
lacuna della storia del brigantaggio concerne
– come abbiamo anticipato – la presenza delle donne combattenti nelle bande. Su di esse
ha indagato invece più di mezzo secolo fa la
scrittrice Francamaria Trapani, che ha dedicato un volume ad alcune delle compagne dei
briganti prima e dopo l’unità d’Italia3. Pur
essendo l’operazione tutt’altro che irrile-
antropologia e storia
vante come scoperta di una realtà pressoché
inedita in sede storiografica, rimase priva di
credibilità scientifica sia per la qualità eccessivamente letteraria della scrittura, sia per
l’impianto narrativo, che mimava più del
giusto la struttura del romanzo, sia per la
scarsa utilizzazione delle fonti primarie, soprattutto archivistiche, sia, infine, per aver
messo sullo stesso piano e mescolato fonti
scritte e orali, documenti e narrazioni, senza tenere conto della differente natura e del
diverso valore delle une e delle altre. Eppure
quel saggio di storia romanzata poneva un
problema, in quanto ipotizzava l’autonomia
della storia della componente femminile
delle comitive, anche se lo separava nettamente dalla storia delle bande, facendo delle
brigantesse le antesignane del movimento
femminista. Ma non si può fare la storia
delle brigantesse ignorando la storia dei briganti, di cui essa è parte4.
Non c’è da stupirsi allora se l’interesse
per le brigantesse abbia trovato spazio, sia
pure in pochi casi e superficialmente, soltanto in qualche pagina dei cosiddetti storici locali, notoriamente attenti alle domande
di conoscenza della comunità del paese e
alle memorie su cui essa fonda la sua prima
/ 2 – comicità e politica
identità, di cui frequentemente la storia dei
briganti e delle brigantesse fa parte integrante. Maurizio Restivo, autore di una ventina
di brevi e scarni profili biografici di alcune
delle brigantesse più note, è stato tra i primi
a raccogliere informazioni da alcune fonti
archivistiche5, ma rimaneva da fare il lavoro
interpretativo e allargare il campo dell’indagine. Al termine di una ricerca condotta su
più fronti, Domenico Scafoglio e Simona
De Luna alle brigantesse hanno dedicato,
nell’anno accademico 2006-2007, corsi e attività di laboratorio all’Università di Salerno,
poi condensati in saggi, che disegnavano un
primo quadro interpretativo del fenomeno,
oltre a realizzare un documentario e curare mostre, che hanno suscitato un nuovo
interesse per il tema6. Quasi contemporaneamente Valentino Romano forniva altre
notizie biografiche su altre brigantesse, lavorando anch’egli su materiali archivistici7.
Ma le brigantesse non sono la sola lacuna da addebitare alle fonti e all’uso che se ne
è fatto: ci sono altri aspetti del brigantaggio,
diversamente importanti, che concernono – sono per ora solo esempi – l’organizzazione delle bande, alcuni tratti aberranti
della repressione (come l’uso intensivo della
Sulla scia della Trapani si collocano le pagine di T. Maiorino (Storie e leggende di briganti e brigantesse. Sanguinari
nemici dell’Unità d’Italia, Casale Monferrato, Piemme, 1997) e altri testi giornalistici, come quelli di Giordano
Bruno Guerri.
5
Ritratti di brigantesse, Manduria, Lacaita, 1997.
6
D. Scafoglio - S. De Luna, Le donne col fucile, cit.; S. De Luna, Per forza o per amore, Catalogo della mostra, Cava
de’ Tirreni, Marlin Editore, 2007; Le donne col fucile, documentario a cura di D. Scafoglio e S. De Luna, 2007; S. De
Luna, Donne in guerra: il brigantaggio femminile postunitario, in “Quaderni di antropologia e scienze umane”, a. II,
n. 1 (2014), pp. 49-79.
7
Brigantesse. Donne guerrigliere contro la conquista del Sud (1860-1870), Napoli, Controcorrente, 2007. Notizie sulle
brigantesse, attinte da fonti archivistiche, e accompagnate da qualche buona considerazione, si trovano marginalmente in P. Varuolo, Il volto del brigante. Avvenimenti briganteschi in Basilicata (1860-1877), Galatina, Congedo,
1955; D. Chieffallo, Cilento. Contadini, galantuomini, briganti, Sarno, Edizioni dell’Ippogrifo, 2002; M. Di Cugno,
Storia del brigantaggio in Basilicata, Potenza, 2000 e nell’ottimo volume di L. Sangiuolo, Il brigantaggio nella provincia di Benevento, Benevento, De Martini, 1975.
4
31
Q
uaderni
tortura, la deportazione delle popolazioni
sospette o “ree di parentela co’ brigranti”, la
distruzione dei villaggi degli insorgenti, l’incendio delle case dei fuorusciti, la modalità
dell’eliminazione dei prigionieri), i rituali di
iniziazione maschili e femminili, la vita quotidiana alla macchia, la religiosità, i rapporti
familiari nelle bande e nei paesi, gli aspetti
economici, ludici, magici, le strategie e tecniche di combattimento, i rituali e le forme
della giustizia nelle bande, la struttura gerarchica e la disciplina dei comportamenti. La
ricognizione attenta e l’assunzione critica di
queste tematiche, imponevano un diverso
modo di scrivere la metodologia della ricerca, a cominciare dalla scelta e dal trattamento delle fonti.
I silenzi e le insidie nei documenti di archivio
Le carte di archivio normalmente erano
ritenute i documenti più importanti per la
storia del brigantaggio, soprattutto gli atti
processuali8. Da essi si ricava l’elencazione
dei reati e la condanna dell’imputato alla
pena, oltre i dati anagrafici e altre informazioni che illustrano sobriamente la sua storia. Del suo passato emergono frammenti
che servono a documentare le imputazioni
e legittimare la condanna, mentre rimane
fuori quello che resta della sua vita. Fredde
e asettiche, le carte di archivio non aiutano
a ricostruire la personalità del brigante né,
8
32
da sole, a svelare il senso pieno della guerra civile. La loro lettura presenta non pochi
problemi. Innanzitutto, non ci restituiscono
il linguaggio e la cultura dei briganti e delle brigantesse, che, quasi tutti analfabeti, si
esprimevano in un italiano stentato e incomprensibile o nel loro dialetto, diverso da
paese a paese e diversamente lontano dalla
lingua italiana e dal suo stesso registro regional-popolare. Nei colloqui i meridionali
che parlavano i loro dialetti e i settentrionali
che parlavano in italiano o nei dialetti del
Nord non si capivano o non si capivano interamente, e frequentemente negli interrogatori dei militari si era costretti a ricorrere
all’interprete. Non sempre il mediatore era
presente, e nei dibattimenti il compito di
tradurre toccava di solito ai giudici e ai cancellieri, i quali suggerivano essi stessi i termini italiani con cui mettere per iscritto le
dichiarazioni degli imputati, o traducevano
dal dialetto senza consigliarsi con loro. Non
erano due linguaggi che si confrontavano,
ma due culture, e l’una si poneva come l’interpretazione dell’altra, non preoccupandosi eccessivamente di non ridurre l’altra a se
stessa. Poteva accadere addirittura – è solo
uno dei tanti esempi possibili – che gli uomini del tribunale indicassero la compagna
del brigante con il termine italiano “druda” carico di connotazioni negative e che
questo termine venisse ripetuto dalle stesse
brigantesse, che finivano così per parlare il
linguaggio dei loro inquisitori, o perché non
Queste carte oggi possono essere più facilmente studiate dopo il paziente lavoro di L. De Felice (Fonti per lo studio
del brigantaggio postunitario conservate nell’Archivio Centrale dello Stato. Tribunali Militari Straordinari, Roma,
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1998), di G. Clemente (Il
brigantaggio in Capitanata. Fonti Documentarie e anagrafe 1861-1864, Roma, Archivio Guido Rizzi, 1999; di R.
Dentoni-Litta (Guida alle fonti per la storia del brigantaggio postunitario conservate negli Archivi di Stato, 3 voll.,
Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1999-2001).
antropologia e storia
sospettavano lo stigma che le parole imprimevano, o perché inconsapevolmente lo introiettavano, accettando masochisticamente
la loro menomazione morale e sociale.
Inoltre gli imputati sconoscono quasi
sempre la sincerità: la loro facoltà di liberamente parlare viene sacrificata all’intenzione di compiacere i giudici, perché è processualmente utile conformarsi a quello che i
giudici pensano, sentono e dicono. L’interrogatorio dei giudici, non molto diverso da
quello effettuato dai militari dopo l’arresto,
mirava ad un duplice obiettivo: verificare i
capi d’imputazione e conoscere i nomi dei
manutengoli delle bande. Per quanto concerne il primo obiettivo, i briganti negavano
finché potevano i reati addebitati, e le donne
andavano oltre – come abbiamo dimostrato
nei nostri studi precedenti – adducendo una
serie di spiegazioni mendaci, come il ratto
violento, che miravano all’ottenimento di
una riduzione di pena. Per quanto riguarda
il secondo aspetto, briganti e brigantesse si
rifiutavano di fare testimonianze e rivelazioni che potessero nuocere ai loro compagni e
complici fidati, oppure facevano rivelazioni
parziali, a volte in modo che venissero eventualmente puniti i manutengoli infidi o i nemici personali.
Neppure le dichiarazioni dei testimoni
aiutano a ricostruire con certezza la verità
dei fatti: alcuni mentivano perché favorevoli
ai briganti o per una generica omertà o perché legati ad essi da rapporti di parentela o
di amicizia o di complicità; altri erano avversi ai briganti, perché stavano della parte
9
/ 2 – comicità e politica
opposta o per inimicizia personale, ma evitavano spesso di impegnarsi in testimonianze che avrebbero potuto scatenare le vendette e le rappresaglie dei parenti ed amici degli
imputati. Neppure i giudici riuscivano a sottrarsi all’influenza delle logiche territoriali e
delle ideologie correnti: abbiamo prove certe che alcune assoluzioni o pene molto blande furono comprate, corrompendo a volte i
giudici ma più frequentemente i testimoni.
Perfino le testimonianze dei sequestrati per
ragioni analoghe appaiono a volte insincere.
Dunque, un groviglio di fatti, in cui riesce
difficile mettere ordine.
I dati che si ricavano da altre carte (rapporti, relazioni dei comandi militari, ecc.)9,
concernono soprattutto la storia militare,
ma anche informazioni anagrafiche e biografiche sui briganti, sulle brigantesse e sul
loro contesto. Anche questi documenti non
contengono tutta la verità: una parte di essa,
certamente quella più scomoda, rimane sepolta in fogli che ancora non si conoscono
e che è auspicabile che finalmente vedano la luce. A proposito del brigantaggio in
Capitanata, lo storico Clemente non esita
ad esprimere “l’impressione che gli archivi
militari nascondano ancora carte utili a far
luce su certi aspetti poco chiari. Infatti, oltre
quanto abbiamo prima rilevato in proposito, non c’è traccia in essi delle persecuzioni cui vennero spesso sottoposti i parenti
dei briganti, denunciate con coraggio dalla
Commissione Parlamentare d’inchiesta sul
brigantaggio da un proprietario di Ascoli, e
dell’abitudine di alcuni ufficiali senza scru-
La preziosa Guida al fondo “Brigantaggio” di P. Crociani (Roma, 2004) consente ora di studiare il carteggio conservato presso l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, in Roma. Le indicazioni del curatore non concernono più, come in passato, soltanto la parte operativa della storia militare, ma anche la storia locale e gli aspetti
sociali del brigantaggio, con una costante attenzione alla presenza delle donne nelle bande.
33
Q
uaderni
poli di far bottino, spogliando i cadaveri
dei briganti. Come pure, a nostro avviso, i
militari caduti nella lotta al brigantaggio, i
cui corpi erano assai spesso orribilmente
mutilati, sono senza dubbio più numerosi
di quelli riportati dalle fonti formali. È impensabile che i vari Comandi Militari non
stendessero dettagliate relazioni su episodi
così rilevanti”10.
I testi degli interrogatori che seguivano
gli arresti, stesi dagli stessi militari, sono
tra le carte più interessanti. A parte alcuni
elementi di imprevedibilità, anticipavano
di solito il comportamento che l’imputato avrebbe tenuto durante il processo per
quanto riguarda le informazioni che egli
forniva e le strategie che metteva in opera.
Gli interrogatori si svolgevano in forma stereotipata, perché gli inquisitori facevano le
domande previste da un canovaccio sempre
uguale a se stesso. Questo consentiva ai briganti di sapere in anticipo quello che i militari avrebbero chiesto, e di prepararsi a dire
quello che era utile ai loro scopi e a tacere
quello che poteva essere per loro stessi nocivo o pericoloso. Bisogna però tenere conto
del fatto che la stereotipia era più nei verbali
che nello svolgimento dell’interrogatorio,
normalmente tramato di pressioni, violenze
fisiche, torture di ogni genere, per essere poi
restituito in narrazioni pacate.
Logiche analoghe si ritrovano nei documenti di archivio depositati da imputati o da
cittadini in forma di esposti, suppliche ecc.
È lecito dubitare della loro autenticità assoluta, dal momento che in queste circostanze
la gente comune si rivolgeva al curato o a un
“galantuomo” del paese, che in quei documenti lasciava il segno del suo pensiero e del
suo linguaggio.
Gli Atti di stato civile e l’anagrafe dei
briganti si consultano agevolmente presso i comuni di nascita e di residenza o che
sono stati teatro delle loro gesta, ma molti
sono andati distrutti. Negli archivi comunali e parrocchiali si trovano i registri dei
battesimi, dei matrimoni e delle morti e se
ne possono ricavare notizie utili sull’età dei
briganti, sulla data e sulle circostanze della
loro morte, sui genitori e i bambini proietti. Queste carte si prestano a considerazioni
che vanno anche oltre l’aiuto che ci può dare
l’analisi demografica. In alcuni casi questi
dati hanno dato vita a nuove affabulazioni,
per lo più romanzesche, non prive di interesse11.
Conclusivamente, l’utilità della documentazione archivistica è troppo scontata e
riconosciuta, perché non venga qui ribadita.
Semmai si tratta di riconoscerne i limiti e
saper coglierne gli aspetti veramente significativi. Queste carte, per esempio, usate con
la giusta attenzione ad alcuni particolari apparentemente marginali, ci aiutano a ricostruire l’atteggiamento dei militari, ufficiali
e semplici soldati, nei confronti della popolazione e dei briganti e verificare se l’esercito
fosse “diffidente se non ostile”, e suggeriscono che quasi certamente i pregiudizi sulla
popolazione meridionale si sono formati
subito dopo l’unificazione nazionale, quando gli italiani del Nord e quelli del Sud per
la prima volta si sono incontrati e conosciuti
ma non si sono piaciuti12. La considerazio-
G. Clemente, Il brigantaggio, cit., p. 21.
R.S. Caligiuri, Cotronei dalla preistoria al brigantaggio postunitario, Laruffa Editore, s.d., p. 387.
12
Cfr. P. Crociani, Guida, cit., p. 13.
10
11
34
antropologia e storia
ne negativa del Sud si è formata negli anni
del brigantaggio, tra i massacri della guerra
civile e si è condensata nelle forme stereotipate del pregiudizio antimeridionale, cui
l’antropologia lombrosiana avrebbe successivamente conferito la veste pseudoscientifica del razzismo.
Ma fino a che punto la visione dell’alta
ufficialità era condivisa dai soldati semplici? I soldati italiani erano contadini “impossidenti” e pastori nella stragrande maggioranza, ma questo non bastava a portarli
a solidarizzare con i braccianti e i contadini
senza terra meridionali: l’identità di classe
non compensava interamente la differenza
etnica e religiosa (i soldati italiani non si
toglievano il cappello e addirittura ridevano al passaggio delle processioni sacre ed
erano invisi per questo), e, forse soprattutto, era decisivo il fatto di trovarsi a combattere dalla parte opposta. La scelta della diserzione (che in qualche caso è dimostrata
dalle carte, in altri è stata fatta passare sotto
silenzio) richiedeva troppo coraggio, troppa convinzione, che essi non avevano. I soldati passati dalla parte dei briganti furono
pochi, e lo fecero per salvare la pelle. Rimane isolato, almeno fino a questo momento,
il caso di Antonio Castaldi, un selciatore
nomade del biellese, soldato delle forze di
repressione, ma ribelle per temperamento, che passò dalla parte dell’esercito del
Sergente Romano, e con fierezza scrisse al
padre di appartenere ai soldati di Francesco II, in malafede – a suo dire – “spacciati”
per briganti. Caso emblematico, ma insuf-
/ 2 – comicità e politica
ficiente a farci meglio conoscere quello che
succedeva nelle menti e nei sentimenti degli
uomini semplici, diventati soldati dell’esercito italiano per combattere e distruggere
spietatamente i briganti, perché la censura
cui era sottoposta la loro corrispondenza ce
lo ha impedito. Tra le deboli tracce che è
possibile oggi trovare, c’è la notizia di una
lettera filoborbonica di un soldato calabrese, intercettata dai militari13.
A parte alcuni casi particolari, non contengono altra vita le carte degli archivi, nella loro asetticità burocratica e oggettività
menzognera. Confermano la convinzione
che, nell’Orfeo negro di Marcel Camus e Vinicius de Moraes, ha efficacemente espresso il disarmante custode dell’Archivio di
Rio, che la notte di Carnevale ammonisce
Orfeo a non cercare la sua Euridice viva
tra i faldoni delle carte da lui custodite, che
appartengono ai morti. Utili per la storia
militare e politica delle insorgenze e delle
repressioni, i documenti archivistici risultano meno preziosi per una antropologia
del brigantaggio che cerca la vita degli uomini in quella dei soldati. Fuori della metafora, sicuramente nelle carte archiviate c’è
molto poco della vita interiore dei briganti, e poco altro ne sapremmo, se – impresa
non facile – si riuscisse a mettere insieme e
ordinare i diversi fascicoli e faldoni disseminati o dispersi nei vari archivi. La lacuna
assoluta concerne infatti la personalità degli imputati. Come se i (presunti) colpevoli
non avessero diritto ad essere conosciuti o
compresi, oltre che combattuti.
Archivio dello Stato Maggiore dell’Esercito, Guida di P. Crociani, cit., Busta 14, Calabria 1861, Comando della
Brigata Pisa, p. 397; G. Buratti, Carlo Antonio Gastaldi. Un operaio biellese brigante dei Borboni, Vibo Valentia, Jaca
Book - Qualecultura, 1989, pp. 43-45.
13
35
Q
uaderni
Le fonti giornalistiche
In genere i giornali nazionali e locali
sono considerati non molto affidabili come
fonti del brigantaggio. Un atteggiamento
che si può condividere, se si pensa al quadro ideologico, rigorosamente patriottico e
filogovernativo, in cui si collocano gli articoli, siano essi cronache o analisi o racconti
paraletterari, quasi tutti costruiti sulla base
di informazioni attinte dalla questura o dai
municipi. Si ripete ancora oggi che i giornali
di Torino e Firenze avevano avuto uno sviluppo maggiore di quelli di Napoli, come “ll
popolo d’Italia”, “Il Pungolo”, “L’Omnibus”,
“Il Giornale di Napoli”, espressione di un
“esasperato provincialismo culturale”, e per
questo erano più diffusi. Indipendentemente da questi tipi di valutazione, i difetti dei
giornali meridionali non erano diversi, per
quello che interessa la storia del brigantaggio, da quelli settentrionali, come ha spiegato già in quegli anni un giornalista bene informato: “Delle relazioni militari e di polizia
che giungono al nostro comando generale,
solo centro da cui traggono queste notizie,
una parte rimane infatti naturalmente segreta, come materia dell’alta polizia militare;
e da un’altra parte vanno ad attingere quello
che credono, il che è sempre una scarsissima
parte del vero, i giornali, compreso il Giornale di Napoli. Quindi a questo comando, di
fatti briganteschi o di scontri militari delle
provincie, giungono ogni dì da sessanta a
cento relazioni, delle quali i giornali non
possono o non vogliono naturalmente pubblicare più di quelle quattro o sei o dieci, che
così sole si diffondono poi per la stampa”.
Nonostante questi fondatissimi rilievi,
gli scritti giornalistici possono essere utilizzati per i nostri scopi, per non poche ragioni.
36
Oltre a prendere notizie sul brigantaggio dai
rapporti delle forze dell’ordine, non pochi
giornali ricevevano corrispondenza dalle
aree in cui imperversava la guerriglia, da parte di semplici cittadini o da cronisti che dei
briganti e delle azioni brigantesche riferivano quello che si diceva – vero, falso o alterato
che fosse – nei paesi. Perciò essi erano – soprattutto quelli delle province meridionali
– almeno in parte il racconto popolare del
brigantaggio e delle narrazioni popolari sembrano in parte conservare lo spirito, le idee,
gli umori e le emozioni, affidati a cronache,
resoconti, lettere anonime e firmate, accuse, proteste, raccomandazioni, insinuazioni,
pettegolezzi. Tutto questo materiale veniva
ovviamente rielaborato secondo le esigenze
politiche e letterarie del direttore del giornale. Inoltre in una situazione, in cui la guerriglia si frantumava in una miriade di conflitti
locali (regionali, paesani) ad opera di bande
largamente o completamente autonome,
fortemente legate al loro territorio, i giornali
locali si avvantaggiavano spesso su quelli nazionali per una più articolata conoscenza dei
fatti e personaggi locali, che nasceva dal fatto
che tutti conoscevano tutti, con la possibilità di attingere informazioni da fonti diverse
da quelle ufficiali. Infine, frequentemente
la lontananza dal potere centrale favoriva
l’autonomia di intellettuali periferici che nei
giornali locali o regionali trovavano la possibilità di manifestare con maggiore libertà la
critica e il dissenso, pur all’interno della solita impostazione patriottica, fornendo narrazioni del brigantaggio più ricche di dettagli,
che potevano rispecchiare una molteplicità
di punti di vista e ideologicamente diverse
dal conformismo imperante nei quotidiani e
periodici nazionali. Alcuni di questi giornali
hanno rappresentato esperienze di ottimo li-
antropologia e storia
vello. Il “Bruzio” di Padula, ad esempio, che
si pubblicava a Cosenza, era per molti aspetti
più interessante del suo probabile modello,
“L’indipendente” di Alessandro Dumas, che
si pubblicava a Napoli ed era diffuso soprattutto nel Mezzogiorno14.
Le rappresentazioni letterarie colte,
artistiche, fotografiche
Ad una dilatazione della coscienza storiografica avrebbero potuto giovare gli scritti
in prosa e in versi dello stesso periodo, restituendo alle rappresentazioni del brigantaggio una parte ignorata della sua complessità
insieme al calore dell’esistenza. Invece la letteratura italiana, che nel precedente periodo
romantico si era innamorata di briganti immaginari, cessò drasticamente di interessarsi ad essi nel decennio postunitario, quando
sulla scena della storia irruppero i briganti
reali in guerra con l’esercito italiano.
Risultano comunque interessanti per uno
studio antropologico sul brigantaggio opere
letterarie di altra ispirazione, che testimoniano la crisi morale e religiosa che accompagnò
il trauma della perdita del Regno. Questa
letteratura ci restituisce il fondo morale, il
conflitto di culture in cui prese forma il disagio prodotto dalla delusione postunitaria: lo
/ 2 – comicità e politica
scontro tra la cultura laica dei conquistatori
e quella religiosa dei vinti si trova affidato a
prose e versi di piccoli intellettuali periferici,
come il canonico calabrese Antonino Martino, diventato all’indomani dell’unificazione
filoborbonico dopo un passato di carbonaro, perché scandalizzato e irritato dei metodi coloniali dei “piemontesi”: sentimenti e
risentimenti che dovettero trovare un’ampia
condivisione non solo negli ambienti clericali
e legittimisti. Il retroterra umano e psicologico di un borbonismo vissuto dal punto di
vista delle masse piuttosto che da quello dei
legittimisti reazionari si ritrova soprattutto
nei poemetti di Ferdinando Russo ‘O luciano
d’‘o Rre e ‘O surdate ‘e Gaeta, che Pasolini disse “grondanti di colori e di miseria, dell’epica
plebea di questo Stato meridionale primitivo
e decrepito, incallito nella saggezza almeno
quanto ardente nell’innocenza”15.
Una ricerca che si propone di restituire
ai contadini della guerriglia postunitaria e
alle donne delle bande la complessità dell’esistenza e il senso della loro esperienza non
potrebbe non prendere in considerazione le
visioni della pittura ottocentesca, che, se pure
condizionate da schemi di maniera, influenzati dal gusto neoclassico e dalla sensibilità
tardoromantica, e a volte da finalità commerciali, ci hanno consegnato una memoria degli
uomini alla macchia e delle loro compagne
Le informazioni sopra riportate si leggono in una corrispondenza napoletana alla “Perseveranza” di Milano, riprodotta da F. Molfese in Storia del brigantaggio dopo l’Unità, Milano, Feltrinelli, 1966, p. 250. Le pagine sul brigantaggio di Vincenzo Padula, prete antropologo e scrittore calabrese, uscirono sul “Bruzio”, giornale cosentino degli
anni 1864-1865, quasi interamente scritto dallo stesso autore. Sono state raccolte in volume con titolo Cronache del
brigantaggio in Calabria (1864-1865) a cura di Domenico Scafoglio (Napoli, Athena, 1974).
15
Questa letteratura non è stata ancora adeguatamente indagata. Lo meriterebbero testi come quello di Giuseppe
Buttà, Edoardo e Rosolina, Brindisi, Edizioni Trabant, 2011 (or. 1880). Su autori filoborbonici, come Antonino
Martino, già prete carbonaro, e Ferdinando Russo si possono leggere le annotazioni di D. Scafoglio in L’ identità
minacciata.La poesia dialettale e la crisi postunitaria, Firenze, D’Anna, 1977. Di P.P. Pasolini ved. La poesia dialettale del Novecento, in Passione e ideologia, Milano, Garzanti, 1973 (ed. or. 1952), pp. 29-30.
14
37
Q
uaderni
diversa da quella solitamente associata al ribellismo astorico e alla devianza comune. Al
di là di ogni altro tipo di valutazione, non si
può non riconoscere a queste opere il merito
di avere oggettivamente svolto, in maniera
vicaria, una funzione di supplenza documentale, che ereditava e insieme ribaltava in senso negativo gli elementi figurativi e ideologici
che romanticamente avevano strutturato
l’immagine del brigantaggio “endemico” del
periodo preunitario. In particolare le rappresentazioni delle brigantesse, che si articolano nel doppio registro dell’angelizzazione
e della demonizzazione, hanno tenuto vivo
l’interesse per la componente femminile delle
bande, ignorata dagli storici, ma, alla fine, costituiscono poco più che una rivelazione dei
sogni, dei desideri e delle paure che il mito
delle donne del Sud in guerra ha sollecitato
nell’immaginario collettivo degli italiani. I
nostri interessi più forti sono andati ovviamente al di là di queste rappresentazioni, pur
nella convinzione che questa “domanda di
mito” fa comunque parte della storia e come
un fatto storico va assunta col sussidio degli
strumenti delle scienze sociali16.
Tra le fonti iconografiche le fotografie
rivestono un’importanza particolare, non
solo perché restituiscono i veri volti dei briganti e delle brigantesse, ma anche per l’uso
sociale e politico che di esse è stato fatto. Le
fotografie di briganti – uomini e donne –
consentirono allo Stato Maggiore dell’esercito italiano di accreditarsi come strumento
provvidenziale di restaurazione dell’ordine
minacciato dalla guerriglia antiunitaria, di
documentare la sconfitta del brigantaggio nei
suoi effetti politici di rassicurazione sociale e
di fare accettare la durezza della repressione,
presentando i nemici come selvaggi e criminali. I fotografi al servizio dei militari, quali
che fossero le loro intenzioni e la loro poetica,
secondarono solo in parte le aspettative della
committenza e la loro accondiscendenza alle
direttive impartite, perché quelle foto, concepite come una macabra autocelebrazione
del potere, ed esibite trionfalmente in mostre
volute dal governo e dalle autorità militari,
grazie all’ambivalenza costitutiva propria dei
costrutti simbolici, testimoniavano al tempo
stesso l’orrore della repressione e la tracotanza odiosa dei vincitori. Sono una scellerata
pornografia della guerra civile e della morte,
che arriva a mostrare corpi uccisi, massacrati,
denudati, ai piedi dei loro uccisori, come fiere
abbattute da cacciatori vittoriosi.
Alle donne invece, rivestite alla meglio
da brigantesse e riarmate di armi ovviamente
scariche, si fa recitare davanti alla macchina
fotografica la pantomina della loro avventura,
facendo dimenticare che sono combattenti
sconfitte e in prigione, in attesa di essere giudicate e condannate. Finita la messa in scena,
la vera esistenza delle brigantesse diventa una
sopravvivenza puramente cartacea, affidata
alla ritrattistica manipolata o alla prosa genericamente impersonale e formulaica dei documenti di archivio17.
Le rappresentazioni psichiatriche
Fino a che punto i testi di psichiatri che si
sono occupati del brigantaggio possono es-
Per la pittura si rinvia al Catalogo della Mostra (Per forza o per amore, cit.).
Anche per la fotografia ved. immagini e commenti al Catalogo della Mostra.
16
17
38
antropologia e storia
sere usati come fonti? Il brigantaggio, come
è noto, diventò uno dei campi privilegiati
dell’osservazione dei fenomeni di devianza all’interno della psichiatria criminale di
Cesare Lombroso e dei suoi seguaci ed epigoni. La prima generazione di lombrosiani
ed il loro caposcuola hanno avuto almeno il
vantaggio sulla psichiatria successiva di conoscere direttamente alcuni briganti, di cui
frequentemente raccolsero testimonianze
autobiografiche e studiarono la fisiognomica e la psicologia18, e le loro analisi, affidate
a una saggistica che assume frequentemente
le caratteristiche della prosa narrativa, nonostante lo specchio deformante delle loro
teorie, conservano, a volte, la pregnanza e
freschezza delle cose personalmente esperite.
Le ambiguità di questi scritti accostano la
psicoantropologia dei lombrosiani alla letteratura, di cui non a caso essa mutua forme e
tecniche: biografie, autobiografie, interviste,
narrazioni ecc. Anche per essa valgono perciò le considerazioni che possiamo fare sui
prodotti letterari utilizzati come fonti scientifiche19. Ed è anche questo gusto letterario della narrazione, con la relativa libertà che questi tipi di scrittura consentono, che alimenta
nelle migliori di queste pagine l’interesse per
le persone della guerriglia e per il loro mondo interiore. Non infrequentemente, l’indagine, affinata a volte dall’uso di strumenti
comparativi, riesce a produrre ritratti etnici
più approfonditi della demologia del tempo,
rimasta ferma a un descrittivismo povero di
/ 2 – comicità e politica
spessore teorico e psicologico: si prenda ad
esempio lo splendido racconto della morte
del brigante Coppa, raccolto dall’antropologo
Cascella dalla bocca del comandante Crocco.
Tuttavia molte potenziali scoperte e innovazioni di questa antropopsichiatria ci
appaiono oggi compromesse dalla convinzione che il brigantaggio fosse un fenomeno
di devianza e dall’idea, fondata sull’osservazione dei corpi e in particolare della forma
del cranio, che briganti si nasce, in virtù di
una predisposizione naturale o di una eredità genetica, che poi si sviluppa per l’influenza
del contesto sociale e familiare degenerato.
La stessa cifra interpretativa i lombrosiani
adoperarono per le donne militanti nelle
bande, con un’aggiunta peggiorativa: le brigantesse non solo sarebbero geneticamente
delinquenti, ma supererebbero gli uomini in
ferocia, come tutte le altre donne che delinquono. In realtà, prima di saltare il fosso le
brigantesse nella maggioranza dei casi avevano una esistenza non molto diversa dalle
altre contadine povere e marginali dei loro
paesi, e quelle sopravvissute ai lavori forzati condussero per il resto dei loro giorni
una sana vita familiare tra la loro gente. I
lombrosiani sbagliavano anche nel rilevare
un surplus di violenza nelle donne – tema
molto presente nella giovane psichiatria criminale, perché confondevano le brigantesse,
che militavano in gruppi organizzati e disciplinati, con le donne che prendevano parte
ai moti popolari spontanei e privi di regole20.
Le idee degli antropologi lombrosiani sul brigantaggio si trovano sparse nei loro numerosi scritti sulla devianza,
che è superfluo qui ricordare. Ved. pure qui la nota 20.
19
Sull’uso della letteratura come fonte ved. gli scritti di D. Scafoglio, in particolare Passé, présent et futur de l’anthropologie littéraire en Italie, in “Ethnologie francaise”, 2014/4, “Ethnologie(s) du littéraire”, pp. 699-707.
20
Per la rappresentazione della donna deviante (alla quale veniva disinvoltamente assimilata la brigantessa nelle
pagine dei lombrosiani) è utile leggere soprattutto C. Lombroso - G. Ferrero, La donna delinquente, Bocca, Torino,
18
39
Q
uaderni
Nonostante questi limiti, gli psichiatri cercarono di dipanare il mistero della violenza
femminile, scavando nel punto in cui l’efferatezza si salda col desiderio, spiegando, per
esempio, che “la trista celebrità di briganti,
ed il romanzesco di quella vita nomade, piena di avventure e di pericoli, esercitavano
sulle donne una grande attrattiva, specie su
quelle di costituzione degenere, o moralmente depravate, che nelle emozioni della
vita brigantesca trovavano l’esistenza adatta al loro temperamento”21. Ma il problema
era un altro, e i soldati, che di briganti e brigantesse avevano una conoscenza diretta, lo
spiegavano dando prova di una diversa sensibilità antropologica: “Il brigantaggio per
tradizione antica è considerato dalla plebe
non tanto un’infamia, quanto una speculazione, un mestiere di uomo forte e coraggioso; così, quando questo ritorna al casolare,
egli non è solo temuto, ma rispettato, e le più
belle ragazze vanno orgogliose di avere un
amante, le donne un marito che abbia fatto
il brigante”22.
La psichiatria di stampo lombrosiano
esercitò una notevole influenza anche sugli
studi giuridici e storici di fine secolo fino ai
21
22
23
24
25
40
primi decenni del ’900. Ad essa non si sottrasse il napoletano Quirino Bianchi, che nel
1903 dedicò un saggio a Ninco Nanco, con
qualche attenzione alle donne delle bande23.
Il punto di vista dei criminologi, con i suoi
errori e pregiudizi, costituisce anche il quadro interpretativo del lavoro di Jacopo Gelli, colonnello del Regio Esercito italiano24
In ogni caso il contributo di questi studiosi
alla conoscenza dei briganti diminuisce soprattutto quando utilizzano informazioni
indirette, che si contaminano negli osservatori minori con una tendenza narrativa non
sempre felice che, come accade al campano Cascella, sacrifica al racconto le ragioni
dell’interpretazione.
Gaetano Salvemini ha fatto giustizia
sommaria di questa antropopsichiatria:
“Degli sciocconi, camuffati da antropologi,
vanno nel Sud, misurano un centinaio di
nasi, contano le rughe dei polpastrelli, delle dita destre, studiano le forme dei coccigi
e ne ricavano la inferiorità della razza meridionale di fronte alla settentrionale”25. In
effetti, anche se le considerazioni che abbiamo fatto possono legittimare in qualche
modo l’uso di questi testi come fonte per lo
1915 (1 ed. 1892); C. Lombroso, L’uomo delinquente, Milano, Hoepli, 1876; Id., Il brigantaggio, Aversa, s.n.t., s.d.;
S. Sighele, La coppia criminale, Torino, 1893.; Id., Il mondo criminale italiano meridionale, Milano, 1893; P. Mantegazza, Fisiologia della donna, Milano, 1893; A. Niceforo, L’Italia barbara contemporanea, Milano, 1898. Sulla tesi
dell’inferiorità della donna ved. spec. G. Sergi, Basi della classificazione umana, in “Atti della Società Romana di
Antropologia”, I, 1893, pp. 167-82, ora riprodotte in S. Puccini, L’uomo e gli uomini. Scritti di antropologi italiani
dell’Ottocento, Roma, CISU, 1991, pp. 323-28. Sul tema ved. S. Puccini, Antropologia positivista e femminismo.
Teorie scientifiche e luoghi comuni nella cultura italiana italiana fra ‘800 e ‘900, in “Itinerari”, n. 3, 1980, pp. 217-44;
n. 1-2, 1981, pp. 187-238.
F. Cascella, Il brigantaggio. Ricerche sociologiche ed antropologiche, Aversa, Noviello, 1907.
Anonimo (ma: C. Melegari), Briganti, arrendetevi!, Prefazione di F. Mirizzi, Venosa, Osanna Venosa, 1996 (ed. or.
1897), p. 116.
Q. Bianchi, Vita di Ninco Nanco, Manduria, Lacaita, 2001, pp. 150-53 (ed. or. Il brigante Ninco Nanco dal punto di
vista storico ed antropologico, Napoli, Tip. Gaz. Diritto e Giurispr. trib., 1903).
J. Gelli, Banditi, briganti e brigantesse dell’Ottocento, Firenze, Bemporad, 1931.
Rerum Scriptor (Gaetano Salvemini), La questione meridionale, Milano 1900, p. 16.
antropologia e storia
studio del brigantaggio, essi mostrano come
la rappresentazione che il mondo scientifico
dava del fenomeno fosse condizionata e influenzata da un conformismo etico-politico,
oltre che dai quadri concettuali psichiatrici
implicitamente razzisti, che sono perdurati,
mutatis mutandis, fin quasi ai nostri giorni.
Il loro razzismo apparentemente è il prodotto di convinzioni scientifiche, e si presenta
come legittimato da una visione etico-politica di segno progressista e socialista, ma,
a ben vedere, il razzismo “scientifico” era
anche l’effetto di una lontananza emotiva e
culturale, se non addirittura di un disprezzo
viscerale per forme di vita e linguaggi radicalmente diversi. È su questa ambiguità che
bisogna lavorare, perché è essa che ci dice
molto non tanto sui briganti, quanto sugli
occhi che li hanno osservati.
L’anello di Memnone.
Le narrazioni dei militari
Il feticismo del documento di archivio,
che domina tuttora nelle ricerche sul brigantaggio, ha impedito di prendere in considerazione altre fonti documentarie o di
conferire ad esse la giusta importanza. Dopo
averne vagliato attentamente e criticamente l’attendibilità, questi documenti possono
risultare di grande utilità, se si pongono ad
essi le domande giuste.
I militari in veste di storici possono risultare carenti da un punto di vista ideologico e metodologico, ma sugli storici di ieri e
di oggi si avvantaggiano del fatto che le loro
scritture sono il frutto di una conoscenza
diretta dei briganti, che essi hanno esperito sul campo, per averli cercati, contrastati,
interrogati e combattuti, mentre gli storici
/ 2 – comicità e politica
li hanno conosciuti solo sulle carte. Anche
per questo essi possono dirci molte cose,
per esempio, sui comportamenti concreti e
sui pensieri dei militari nei confronti della
popolazione, la considerazione che essi avevano dei guerriglieri, il loro shock prodotto
dalla scoperta della diversità meridionale,
alcuni aspetti poco noti delle pratiche repressive e di quello che i soldati pensavano
di esse, le tecniche, le strategie e gli usi di
guerra delle bande.
Si tratta di memorie di ufficiali e soldati
che raccontano le loro esperienze di guerra,
frequentemente romanzandole. In primo
piano c’è sempre la soggettività del memorialista, con la sua storia emotiva, il suo
protagonismo e frequentemente il narcisismo di chi pensa di essere dentro vicende
memorabili. Anche se non sono frequenti le
invenzioni e le esagerazioni, le persone e i
fatti che essi raccontano sono reali, e vengono rappresentati attraverso le tecniche della
letteratura, più precisamente, della narrativa, come dialoghi (costruiti o ricostruiti, se
non inventati), intrecci sofisticati, sequenze
politiche e ideologiche. Si sente il bisogno di
condividere col lettore emozioni, non solo
patriottiche, comunicando le impressioni di
straordinarietà vissuti nell’avventura della
guerra insieme alla meraviglia stimolata dalla scoperta dei costumi di un popolo “altro”.
Il numero di queste testimonianze autobiografiche del brigantaggio ha una relativa
consistenza. Le informazioni che possiamo
ricavarne sono di valore disuguale, imprecise se non erronee a volte, altre volte attendibili e preziose, specie quando sono frutto di
conoscenze dirette. Il metodo, che consente
di farne un buon uso, deve tenere conto della difficoltà di distinguere tra fatti realmente
accaduti e manipolazioni, tra il vissuto reale
41
Q
uaderni
dell’autore e la costruzione della propria immagine attraverso esperienze di comando e
di lotta, tra le motivazioni autentiche delle
sue scelte, inespresse, nascoste o camuffate,
e la razionalizzazione più o meno ideologica
che ne dà.
Di questi militari amanti della scrittura,
quelli che appartenevano all’alta ufficialità
erano molto interessati alla politica e alla
strategia militare, mentre gli ufficiali subalterni e i soldati semplici erano più attenti ai
lati umani e agli aspetti insoliti della guerra,
come la presenza delle brigantesse: ufficiali
e soldati sono stati nei loro territori, le hanno combattute, le hanno conosciute direttamente e/o ne hanno sentito parlare dalla
gente, dai prigionieri e da altri soldati, tra i
quali le donne col fucile, come tutti i fatti inconsueti, erano già diventate leggenda. Leggenda che in parte ci hanno conservato, ma
che hanno anche contribuito a creare, perché, pur essendo militari, si comportavano
da scrittori, a volte dotati – come l’ufficiale
De Witt – di un sorprendente gusto affabulatorio. Alcuni rappresentanti dell’alta ufficialità, come, secondo alcuni, Govoni a Gaeta
e Brunetta d’Esseaux in Calabria, mostrano
una comprensione, a volte profonda, per il
comportamento dei briganti e della gente
del Meridione; ma alla stragrande maggioranza dei militari “il cafone appare come un
uomo appartenente ad un altro mondo, ad
un’altra realtà, che non si cerca neppure di
esplorare, di conoscere. È un estraneo, parte
integrante di una natura e di un territorio
ostili. Rappresenta una presenza, si potrebbe
dire collettiva, non individuata: non sembra
esistere il singolo. In queste carte, soltanto
se è chiamato alle armi o se diventa brigante
il cafone acquista una sua fisionomia individuale, una sua identità. In tutti gli altri casi
i cafoni costituiscono, nel loro insieme, un
mondo a parte, che alimenta il brigantaggio.
Il cafone è quindi, almeno potenzialmente,
un nemico”26. Più complesso l’atteggiamento dei militari nei confronti delle brigantesse: è ambivalente, oscilla tra l’ammirazione
per fatti e personaggi di cui non si poteva
non cogliere l’eccezionalità, e la palese disapprovazione di un fenomeno che rovesciava radicalmente il modello femminile
dominante nella cultura del tempo.
Tra i testi più interessanti si colloca
quello di Giuseppe Bourelly27, un ufficiale
dei Carabinieri Reali, che dal 1862 al 1865
combattè i briganti, imparando a conoscerli
e raccontandone le vicende in un’ottica decisamente patriottica, e tuttavia largamente
rispettosa della verità. Bourelly è l’incarnazione sincera del patriota venuto a combattere nel Sud una guerra di civiltà: la sua
ammirazione concerne le capacità prevalentemente militari dei meridionali, sulla cui
arte del guerreggiare ci ha lasciato notizie
e riflessioni importanti, ma non certamente la loro cultura: scende nel Meridione con
l’opera del protoantropologo i J.F. Lafitau
in testa (Moeurs des sauvages amériquains
comparées aux moeurs des premiers temps)
(1724), convinto di avere a che fare con
una specie di Irochesi e Uroni, e, persuaso
com’è che “la bigotteria, la superstizione, i
pregiudizi, le vendette sono le brutte e male
qualità morali” del popolo meridionale, non
P. Crociani, Guida, cit., p. 13.
G. Bourelly, Il brigantaggio dal 1860 al 1864, Venosa, Osanna Venosa, 2004 (ed. or. 1865).
26
27
42
antropologia e storia
gli rimane che concludere, con divertita
cattiveria: “Cercherò di scrivere questo paragrafo, come operò Ismania ambasciatore
di Tebe presso Artaserse Memnone re di
Persia, il quale lasciò cadere a terra l’anello,
per cui fece vedere di inchinarsi piuttosto
per raccoglierlo che prosternarsi per adorare il gran re, mostrando così il dovuto rispetto alle usanze del paese ed alla dignità
dell’uomo”28. Proprio così: ostentazione di
rispetto formale, ma non intimo riconoscimento né stima, nello spirito di Lafitau, che
praticava il distanziamento dal materiale
etnografico come condizione prima dell’analisi scientifica. Tuttavia delle brigantesse
diede un giudizio in cui la condanna morale si associava a un disorientato stupore e
all’apprezzamento del loro coraggio, e, nonostante l’impianto politico rigorosamente
e onestamente filounitario, antiborbonico,
anticlericale e antisanfedista, l’opera di Bourelly è quanto di meglio sia stato scritto sul
brigantaggio nel suo periodo. Il suo metodo,
che indagava il contesto geografico, storico,
economico, miliare, sociale e culturale era
una proposta troppo coraggiosa per i suoi
tempi, nei confronti della quale il mancato
riconoscimento delle tradizioni storiografiche, ancora perdurante (distrazione?), non
può non suscitare stupore.
Notizie non sempre inutili ritroviamo in
altri resoconti in chiave più scopertamente
autobiografica, limitate ai territori nei quali i loro autori operarono, ed utili perciò
per una storia regionale del brigantaggio.
A non pochi di essi si può riconoscere un
/ 2 – comicità e politica
certo rigore, come quello del maggiore dei
bersaglieri Carlo Melegari, che nel 1861 per
alcuni mesi si distinse per il suo patriottico
zelo nella guerra contro il brigantaggio (10),
andando a massacrare spietatamente gli
insorti di Casadduni e a distruggere il loro
paese29.
Altri si cimentarono in un genere esemplato dall’opera dall’ufficiale Angiolo De
Witt, che pretese di scrivere la Storia politico-militare del brigantaggio nelle provincie
meridionali d’Italia30, mescolando pubblico
e privato, con buone informazioni e spesso
con intuizioni di qualità, ammettendo alla
fine di aver scritto un “romanzo”, che – precisa – “in gran parte si basa su avvenimenti
verificatisi me presente, me cronista fedele”.
È difficile perciò dire quanto, per esempio,
della storia di Filomena, possente capobanda, amante di Caruso, alla quale sono dedicate parecchie pagine dell’opera, appartenga
alla cronaca veritiera e quanto all’invenzione romanzesca.
Il male, che questi militari, fedeli esecutori degli ordini dei superiori, arrecarono
alle popolazioni su cui si abbatté la repressione, generava frequentemente forme di
ripensamento critico, che tuttavia nei casi
migliori non andava oltre la compassione e
la disapprovazione morale degli eccessi della
lotta alla guerriglia. Raccontò le sue vicende di giovane garibaldino, anch’egli con la
consapevolezza di aver vissuto un’avventura straordinaria, degna di restare nel ricordo dei posteri, Gaetano Ferrari, lodigiano.
I suoi ricordi, rimasti inediti, sono stati da
G. Bourelly, op. cit., p. 28-29.
Anonimo, cit.
30
A. De Witt, Storia politico-militare del brigantaggio nelle provincie meridionali d’Italia, Firenze, Coppini, 1884.
28
29
43
Q
uaderni
poco pubblicati col titolo Memorie di guerra
e di brigantaggio31. Soggiornò in Calabria, a
Corigliano e a Bocchigliero, per combattere
le ultime bande della Sila. Fa il suo dovere di
ufficiale, senza ombra di ripensamenti, ma
manifesta disappunto e orrore per le efferatezze dei militari, che non esita a descrivere,
denunciare e disapprovare, e sincera pietà
per le condizioni della popolazione vittima
delle rappresaglie, pur in una incomprensione di fondo per la superstizione e il fanatismo dei calabresi.
Meno interessanti, dal nostro punto di
vista, risultano gli scritti dei militari delle generazioni successive, che di fatto svolgono il
lavoro degli storici, avvantaggiati dalla loro
familiarità con la materia e con la documentazione in possesso dell’esercito (per lunghi
decenni rimasta per i non militari di difficile consultazione), non sempre però da essi
sottoposta al vaglio critico. Qualche storia di
brigantesse, rapidamente disegnata, si trova
negli studi del colonnello Cesare Cesari: ma
non corrisponde al vero, per esempio, la notizia (inventata per attutire lo scandalo delle
donne combattenti, negando la loro identità e identificandole con le malefemmine)
secondo cui prima della fine del 1863 non
sono esistite brigantesse, ma soltanto ma-
nutengole; le prime avrebbero fatto la loro
apparizione successivamente, “nel momento in cui cominciava a scemare la reazione
politica e subentrava un’epoca di vero e proprio malandrinaggio”. Anche questo autore
si distingue per la sua ambivalenza: a volte
riferisce, non senza una punta di irritazione,
che “ogni capo banda aveva generalmente
con sé la moglie o una amante, quasi sempre
arditissima, e nella immaginazione popolare diveniva un’eroina, anche quando le sue
gesta non erano molto diverse da quelle di
ogni volgare malfattrice”, e a volte si lascia
catturare quasi suo malgrado da quelli che
chiama i frequenti “romanzi d’amore e di
morte”, scrivendo, per esempio, di Maria
Oliverio, che i suoi delitti “l’avevano elevata fra le popolazioni della Calabria ad una
fama assai superiore di quanto realmente
valesse. La mala educazione ricevuta, l’esuberante vitalità fisica ed anche una grossolana ma indiscutibile bellezza di cui la natura
l’aveva dotata, ne avevano fatto una creatura
da romanzo, avvalorandone le gesta talvolta
generose e talvolta crudeli con episodi di ardimenti selvaggi”32.
Sembrano formare una categoria a sé, i
militari che combatterono il brigantaggio
nelle formazioni paramilitari, come guar-
G. Ferrari, Memorie di guerra e di brigantaggio. Diario inedito di un garibaldino (1860-1872), Novara, Interlinea
Edizioni, 2011.
32
C. Cesari, Il brigantaggio e l’opera dell’esercito italiano dal 1860 al 1870, Roma, Ausonia, 1928, p. 152. Tra i più
interessanti degli altri scritti di militari basti qui ricordare Genova Tahon di Revel, Da Ancona a Napoli. Miei
ricordi, Milano, Dumolard, 1894 (prezioso per la conoscenza dell’esercito italiano); Alessandro Bianco di Saint
Jorioz, Il brigantaggio alla frontiera pontificia dal 1860 al 1864, Milano, Daelli, 1864; Giuseppe Pasolini, 18151876, memorie raccolte da suo figlio, Torino, Bocca, 1886; Fisiologia del brigantaggio. Studi di un ufficiale italiano,
Firenze, Ripamonti-Ottolini, 1868. Per F. Molfese “gli studi militari sul brigantaggio, sia monografici che raccolti
in opere generali, sono di scarso valore, in specie se rapportati agli ingenti fondi archivistici conservati dall’Ufficio
Storico dello Stato Maggiore” (Storia del brigantaggio dopo l’unità, Milano, Feltrinelli, 1966, p. 446). Molfese si
riferisce agli scritti degli ufficiali subalterni, tra i quali salva solo Bourelly e Saint Jorioz, mentre ritiene che quelli
dei capi militari abbiano “maggiore interesse politico”.
31
44
antropologia e storia
die nazionali e squadriglieri: il loro sguardo
dall’interno rende spesso diversi i loro scritti
da quelli dei militari venuti da fuori. Uno di
loro fu Tommaso La Cecilia, nato a San Severo nel 1807, agrimensore, dapprima guida
dei soldati e poi egli stesso comandante di
squadriglie a cavallo. L’opera di La Cecilia,
scritta dopo il 1867 in un italiano popolare molto agrammaticale, è pubblicata ora
in una buona edizione critica da Giuseppe
Clemente. La Cecilia detesta i briganti, ma
il suo odio è, per così dire, orizzontale, e
sembra spesso uno di loro, con in più una
voglia narcisistica di protagonismo, che lo
porta frequentemente a esagerare o inventare, come quando narra il suo scontro con
Filomena Pennacchio e gli altri capibanda
nella battaglia di Croce di Magliano33.
La pubblicistica cattolica e filoborbonica
Tra le fonti del brigantaggio postunitario dovrebbe essere restituito uno spazio adeguato alla pubblicistica cattolica e a
quella filoborbonica, emanazione, la prima,
degli ambienti cattolici critici nei confronti dell’unificazione se non palesemente antiunitari, e la seconda dei legittimisti delle
province meridionali o di ambienti stranieri
favorevoli ai Borboni.
/ 2 – comicità e politica
Lo spirito di parte – peraltro legittimo –
può limitare il valore documentale di queste
fonti, ma non al punto di farle disprezzare
come mentecatte o completamente ignorare. Anche in questo caso occorre, come suggeriva William I. Thompson, evitare che la
ricerca scientifica si bendi gli occhi da sola,
selezionando i fattori che considera dotati
di senso e non tenendo conto degli altri, per
poi sostenere che ciò che ha eliminato non
è mai esistito. I giornali cattolici associano
allo spirito di parte informazioni che fanno
da contrappunto alla stampa patriottica, che
aveva la funzione di legittimamente rafforzare l’unità nazionale, ma lo faceva anch’essa con spirito di parte e modalità censorie,
e riempiono i suoi vuoti, documentando
gli umori e i valori di una parte consistente e sicuramente maggioritaria della società
nazionale e – sono cose che contano – del
modo in cui essa guardava o viveva il brigantaggio. Purtroppo da qualche lustro è invalsa la tendenza a utilizzare queste fonti per
una immediata e riduttiva strumentalizzazione politica, che ha finito per sovrapporre
ad esse la lente deformante di una controstoria filosanfedista, contrastata ideologicamente dagli antirevisionisti patriottici, laici
e unitari34.
Anche sugli scritti filoborbonici non è stata mai fatta una riflessione approfondita e nep-
T. La Cecilia, Brano dell’istoria del brigantaggio di Capitanata e di Basilicata dal 1861 al 1864, Foggia Edizioni del
Rosone, 2008, pp. 139-46.
34
La stampa cattolica delle province italiane è ancora poco studiata come fonte per ricostruire il clima culturale del
Paese nel periodo postunitario. Si è cominciato invece a lavorare sulla “Civiltà Cattolica” (Brigantaggio legittima
difesa del Sud. Gli articoli della “Civiltà cattolica” (1860-1870), introduzione di Giovanni Turco, Napoli, Editoriale
Il Giglio, 2000). La rivalutazione della rappresentazione cattolica dell’Italia delle rivoluzioni nazionali e dell’unificazione è stata strumentalizzata da Comunione e Liberazione, che ha organizzato nell’agosto del 2000, nell’ambito
del “Meeting dell’amicizia tra i popoli”, la mostra Il Risorgimento italiano. Un tempo da riscrivere, che ha suscitato
le reazioni altrettanto ideologiche di E. Scalfari, I. Montanelli, A. Galante Garrone, G. Cesana.
33
45
Q
uaderni
pure un censimento completo, specie dei quelli
delle province. A parte qualche riconoscimento generico, si attende ancora una valutazione
e un uso sereno della utilità dei testi noti. Uno
dei più interessanti di essi è quello di Giacinto
De Sivo, che Molfese, poco tenero con il legittimismo borbonico, definisce “tendenzioso,
anzi fazioso, però preciso e documentato nella
indicazione dei fatti di brigantaggio, il che fa
pensare che i borbonici in esilio (in particolare
la corte di Roma) avessero buoni canali d’informazione dalle province meridionali”. Analogo riconoscimento Molfese riserva alla due
opere di Oscar De Poli (“interessanti, se non
altro per le minuziose documentazioni dei fatti del brigantaggio”35.
La memoria dei sequestrati
È stato sottovalutato, ai fini della conoscenza del brigantaggio maschile e femminile, il contributo fornito dagli scritti di alcuni
sequestrati che raccontarono la loro permanenza, di norma durata parecchi mesi, tra i
briganti, in attesa del riscatto. Erano per lo
più persone istruite, e alcuni di loro avevano anche ambizioni scrittorie e cercarono di
dare una forma letteraria alle loro narrazioni; tutti però coltivavano più o meno segretamente il desiderio di far conoscere la loro
storia consegnandola alle stampe, anche se
poi pochi lo fecero. Alcune di queste memorie sono state rese note in tempi recenti.
Costretti a seguire i sequestratori nelle loro continue fughe, da un nascondiglio
all’altro, incessantemente braccati dalle forze dell’ordine, tra stenti e patimenti di ogni
genere, i sequestrati ebbero la possibilità di
osservare dall’interno ed esperire la vita dei
briganti, lasciando una messe di dati utilissima per una etnografia storica del brigantaggio. È da essi che abbiamo notizia di alcune brigantesse e dei loro comportamenti
all’interno delle comitive: si tratta di dati a
volte significativamente contraddittori, perché influenzati dal diverso stato d’animo dei
sequestrati e dal diverso rapporto con i loro
sequestratori, ma soprattutto dalle coordinate culturali che orientavano la loro percezione dei fatti: così, per l’inglese Moens,
rapito dalla banda Manzo nel maggio 1865,
ogni brigantessa era considerata “proprietà
del suo uomo”36, mentre per lo svizzero
Lichtensteiger, che fu sequestrato dalla stessa banda nel successivo ottobre, le brigantesse “sono membri autonomi della banda,
come gli uomini, e non di rado mostrano
più coraggio e tenacia di questi”37. La circostanza in cui si può meglio verificare il peso
delle singole soggettività nella narrazione
degli stessi fatti si ha quando due diversi memorialisti si trovano sequestrati dalla stessa
banda nello stesso periodo, e realizzano simultaneamente, ognuno per conto proprio,
questa singolare ricerca sul terreno.
Friedli, un altro sequestrato dello stesso
gruppo, è forse la più preziosa, anche se non
Ved. Storia delle Due Sicilie dal 1847 al 1861 (Trieste, 1861) di Giacinto De Sivo; Oscar De Poli, Voyage au Royaume
de Naples en 1862 (Paris, Dupray, 1863) e De Naples à Palerme (Paris, Dupray, 1865). I giudizi di F. Molfese sono
nell’op. cit., p. 444.
36
W. Moens, Briganti e viaggiatori inglesi, a cura di M. Merlini, tr. it., Milano, TEA, 1997 (or. 1866), p. 94.
37
J.J. Lichtensteiger, Quattro mesi fra i briganti, a cura di U. Di Pace, tr. it., Cava de’ Tirreni, Avagliano, 1984 (or.
1894), p. 41.
35
46
antropologia e storia
la più brillante, di queste fonti38, indispensabili per chi cerca una porta d’accesso alla vita
quotidiana dei briganti delle bande piccole e
medie, osservando gli effetti di una vicinanza non breve e coatta, che mette alla prova
sequestrati e sequestratori, vittime e carnefici, modificando in qualche modo gli uni e gli
altri, con la scoperta a volte reciproca della
propria umanità, con esiti a volte imprevisti
da sindrome di Stoccolma. Sono le occasioni
che rendono possibile la conoscenza diretta
dell’organizzazione dei rapporti tra capi e
gregari, la loro cultura e la gestione del tempo libero, l’importanza del gioco, il rapporto
col denaro, il legame con la famiglia e il paese, le forze coesive e le spinte disgregatrici, i
rapporti tra briganti e pastori, la convivenza
con le compagne.
Il 1° settembre 1860 un possidente cilentano, Giuseppe Di Marco, fu sequestrato
insieme al nipote Francesco Di Biase dalla
banda Parra. Quest’ultimo raccontò la sua
disavventura in un manoscritto rimasto fino
ai nostri giorni inedito39. Scritto nell’italiano
letterario delle persone istruite di provincia,
il diario, oltre a restituire la freschezza delle
esperienze dolorosamente vissute, ci fa dono
di non poche informazioni utili sulla vita dei
briganti. Si colloca con una sua singolarità
in questa categoria di fonti Briganti alla
/ 2 – comicità e politica
Caccia, documentatissima ricostruzione su
fonti inedite del sequestro di nove possidenti acresi del 1863, ad opera del discendente
di uno dei sequestrati, Vincenzo Feraudo40.
A diverse strategie comunicative si ispirano le deposizioni dei briganti incarcerati.
Sono confessioni rigorosamente guidate
dalle domande dei militari e dei giudici e
risultano, perciò, assai meno libere delle
memorie personali sopra descritte, anche
perché orientate da strategie difensive e dal
bisogno di compiacere i giudici per avere
sconti di pena. A volte, tuttavia, le dichiarazioni sono influenzate dai sentimenti e risentimenti del momento, dalla paura o dalla
vendetta, dall’amicizia o dalle pressioni delle
famiglie e delle parti in lotta.
I briganti si raccontano
Accrescono il numero delle pagine pressoché non utilizzate, se non come fonte di
notizie, le autobiografie in cui i briganti
narrano liberamente di se stessi, senza che
qualcuno li obblighi a farlo e senza controlli
o censure. Queste narrazioni, oltre a rappresentare la guerriglia dal punto di vista dei
protagonisti, ci consegnano altri aspetti inediti della vita brigantesca.
Isacco Friedli, Vier Monate under den Briganten in Suditalien, pubblicato nel 1866 (tr. it. Quattro mesi tra i briganti
del Sud Italia, in A. Caiazza - E. Locatelli, La banda Manzo tra i briganti campani e lucani nel periodo postunitario,
Napoli, Tempi Moderni, 1984, pp. 107-196. Meno interessante il resoconto di un sequestrato italiano della stessa
banda, Ricordi briganteschi di Giuseppe Olivieri, Cava de’ Tirreni, Avagliano, 1994.
39
Il diario è ora pubblicato in D. Chieffallo, Cilento. Contadini galantuomini briganti, Sarno, Edizioni dell’Ippogrifo,
2002, pp. 180-2001.
40
Vi sono utilizzati per la prima volta: una Storia di famiglia, in cui il sequestro è raccontato da Antonio Feraudo,
figlio del sequestrato, sulla base dei ricordi del padre; le lettere scritte in occasione del sequestro dei briganti, conservate nell’archivio di famiglia, o provenienti dalle carte del palazzo Falcone; appunti scritti dal nipote di un altro
sequestrato. Lo stesso avvenimento è narrato dal sequestrato Michele Falcone in Un doloroso episodio della mia
vita (s.l., 1868). È ricco di informazioni, nonostante la prosa eccessivamente letteraria.
38
47
Q
uaderni
A parte la grande eccezione di Carmine
Crocco, che durante la lunga prigionia si
scoprì memorialista e scrittore, noi possediamo poche altre biografie dei capi del brigantaggio, perché quasi tutti morirono alla
macchia. Nonostante si disponga in alcuni
casi dell’aiuto di fonti indirette, il più delle
volte rimane un mistero l’idea che questi uomini avessero di se stessi, le ragioni profonde
delle loro scelte, cosa realmente pensassero
di realizzare, per cui dobbiamo accontentarci di come li hanno visti quelli che li hanno
seguiti ed amati e gli altri che li hanno avversati, combattuti o uccisi. L’importanza di
queste autobiografie è nella possibilità che
esse aiutino a fornire qualche risposta a queste domande, almeno di quelli che riescono
ad entrare nel mondo dei briganti, e a comprendere e parlare il loro linguaggio.
Le narrazioni autobiografiche di Carmine Donatelli Crocco rappresentano la
migliore documentazione concernente
l’organizzazione delle bande, a cominciare
dalla struttura gerarchica e dall’intreccio
di legami amicali e rapporti di potere, che
a distanza ravvicinata risulta assai più complessa di quello che comunemente si crede.
Costituiscono una descrizione della guerriglia dall’interno, con le categorie che appartengono in parte alla mentalità del brigante,
in parte alla cultura del soldato dell’esercito borbonico. Rendono ragione di quello
che già sappiamo della vita alla macchia,
ma mostrano altresì aspetti poco noti e lati
oscuri su cui non si è riflettuto abbastanza.
Le informazioni sulla strategia e le tattiche
delle bande e dei singoli luogotenenti integrano abbondantemente le preziose annotazioni di Bourelly sul modo di combattere dei briganti, sulle loro leggi di guerra,
le pratiche di giustizia, i comportamenti in
guerra e in pace, con una ricchezza di dettagli di quella “guerra d’astuzia” che ispirava
la sapienza militare di un esercito di contadini e di ex soldati dell’esercito borbonico.
A Crocco dobbiamo qualche altra notizia
sulle donne del suo esercito, ma soprattutto
il delicato racconto dell’arresto e dell’incontro successivo di Filomena Pennacchio col
suo uomo, il capobanda Schiavone, prima
della sua fucilazione, e quello, già ricordato
come altrettanto struggente, della sepoltura
dell’amico Coppa41. Per quanto scarsi possano essere, questi brevi ritratti restituiscono
in parte alle donne e agli uomini delle bande
quei tratti di umanità, che contrastano con
la tendenza criminalizzante della letteratura
sul brigantaggio.
Dopo l’autobiografia di Crocco, le memorie di Di Gè, brigante leale, specchio
fedele del codice d’onore delle bande, che
rifiutò di tradire i suoi compagni in cambio
di riconoscimenti e privilegi, è forse la più
interessante delle autorappresentazioni della guerriglia. Nella sua visione interna al brigantaggio Di Gè mostra, in una prosa di una
C. Crocco, Come divenni brigante, introduzione di T. Pedio, Manduria, Lacaita, 1964 (or. Melfi, Tipografia Grieco
1903, a cura di Eugenio Massa). Più autentico il testo di un manoscritto poco noto di Crocco trovato nel bagno
penale di Portoferraio dove Crocco morì, pubblicato dallo psichiatra Francesco Cascella nella sua opera Ricerche
sociologiche ed antropologiche, Aversa, Fratelli Noviello, 1907,e più recentemente ristampato come Memorie in cui
si racconta del brigante Coppa e di Ninco Nanco, Introduzione di C. Conte, Lavello, Pianetalibroduemila, 2001. Per
la biografia di Crocco occorre anche tenere conto del Verbale di interrogatorio reso da Carmine Donatelli Crocco
nelle carceri giudiziarie di Potenza il 3 e il 4 agosto 1872, ora pubblicato nel testo curato da T. Pedio sopra ricordato.
41
48
antropologia e storia
essenzialità “primitiva”, immune da pietismi
e infingimenti, la capacità delle bande di vivere, nell’orrore di una guerra combattuta
senza esclusione di colpi, con lealtà e pietà,
tolleranza e compassione, nonostante le seduzioni maligne della violenza in libertà. Di
Giuseppina Gizzi, che faceva parte della stessa comitiva, ci ha lasciato un ritratto42 notevolmente diverso non solo dall’immagine
della donna che emerge da altre testimonianze, ma anche dalle poche pagine autobiografiche trascritte dallo stesso Di Biase, in cui la
brigantessa racconta la sua vita al cilentano
sequestrato dalla sua banda43. Il possidente
e il brigante sembrano parlare di due personaggi e raccontare storie diverse, che sono
invece le stesse, ma appartengono a mondi
incommensurabili. Diverso anche il racconto
della donna da quello del brigante, essendo
preoccupata, la Gizzi, di tessere la storia della sua vita di brigantessa secondo una sottile
strategia di implicita deresponsabilizzazione,
mentre Di Gè nella sua prosa pacata sembra
voler salvare l’onore del suo mondo, pur testimoniando con una delicatezza impagabile
la sua violenza e il suo orrore.
Una forte componente intellettuale rende invece diverse dalle altre memorie brigantesche, soprattutto per la tendenza ad
esaltare in chiave tradizionalista e legittimista i valori della guerriglia, le Memorie di un
ex Capo-Brigante, di Ludwig Richard Zimmermann44. Ignorato da Franco Molfese
ma non da Benedetto Croce, l’autore era un
ufficiale dell’esercito austro-ungarico, venu-
/ 2 – comicità e politica
to come volontario ad aggregarsi alle bande
dei briganti, con i quali combattè col grado
di capitano e poi di maggiore dall’agosto del
1861 all’ottobre dell’anno successivo. Era
perfettamente consapevole di avere fatto
una scelta romantica in favore di un mondo destinato a un non inglorioso tramonto:
“I montanari conducevano la battaglia della
disperazione contro le grandi idee dei tempi
moderni, perché non le capivano ancora, e,
sotto la danza delle spade della nuova dominazione, non potevano nemmeno cominciare a capirle”.
La memoria orale e il folklore
Diversa importanza riveste per noi la
tradizione orale sui briganti, che occorre distinguere in: a) testimonianze dei loro stessi contemporanei, raccolte e conservate in
scritture dello stesso periodo o dei periodi
successivi, in forma di racconti, aneddoti,
proverbi, ed altri formalizzati orali; b) testimonianze della generazione a noi contemporanea su quello che rimane della memoria
del brigantaggio; c) le testimonianze sulla
cultura popolare e la vita sociale e religiosa
dell’Italia postunitaria.
Gli storici non hanno fatto alcun uso
della letteratura di tradizione orale di ispirazione brigantesca, data la loro diffidenza
per le opere di immaginazione, preferendo
costruire della vita alla macchia una rappresentazione asettica, priva di dettagli signifi-
Ved. la Vita di Michele Di Gè nato a Rionero, Melfi,Tipografia Insabato, 2011, ristampata in N. De Blasi, “Carta,
calamaio e penna”. Lingua e cultura nella “Vita” del brigante Di Gè, Potenza, Il Salice, 1991, pp. 11-15.
43
Chieffallo, Cilento, cit., cit., pp. 186-88.
44
L. R. Zimmermann, Memorie di un ex Capo-Brigante, trad. di E. De Biase, Napoli, Arte Tipografica Editrice, 2007
(or. 1868).
42
49
Q
uaderni
cativi, che impoverisce la narrazione della
guerriglia, privandola della sua forza psichica coinvolgente che si affida proprio alla letteratura. Particolarmente impoveriti risultano i momenti epici, religiosi, magici, che
solo un linguaggio simbolico come la letteratura riesce a rendere nella loro pienezza
e pregnanza. Sotto l’aspetto storiografico la
letteratura del brigantaggio rimane perciò
una fonte preziosa, ancora poco utilizzata.
Man mano che ci si allontana dal primo
decennio dell’unificazione, la memoria del
brigantaggio subisce abrasioni e cancellazioni e la storia cede il passo al mito, fino ad
esserne quasi interamente assorbita. Questi
testi letterari possono perciò essere utilizzati
non tanto per le loro informazioni, quanto
per via della sostanza mitica che contengono e che apre spiragli importanti sul mondo
spirituale delle bande. Non è detto tuttavia
che le testimonianze più vicine al tempo dei
briganti o ad essi contemporanee siano sempre aderenti alla realtà. I miti e le leggende si
formavano quando i briganti erano ancora
vivi e in azione, e le loro imprese eccitavano
l’immaginario dei contemporanei, suscitando emozioni intense.
Non appartiene (o non appartiene interamente) alla letteratura epica popolare
del brigantaggio la cosiddetta letteratura
di colportage, originariamente prodotta da
persone semistruite per quei i ceti “inferiori” che partecipavano in qualche modo
della scrittura e diffusa da venditori ambulanti nelle campagne, dove, tra le masse
non alfabetizzate, c’era sempre qualcuno
capace in qualche modo di leggerla agli altri che non sapevano di scrittura e lettura.
Questa produzione, quasi sempre scritta in
un italiano regional-popolare, con elementi
linguistici e tematici colti, variamente con50
taminati e deformati, esercitò una influenza
sull’epica di più autentiche radici popolari,
che si esprimeva nel dialetto dei paesi e si
diffondeva e tramandava quasi sempre oralmente. Con queste significative riserve può
essere collocata tra le fonti letterarie del brigantaggio, anche perché contadini e pastori,
nel momento in cui leggevano o ascoltavano
questi testi “da due soldi”, li interpretavano
autonomamente, traducendo i racconti nella loro cultura. In ogni caso, occorre tenere
presente che il referente di questa letteratura,
a parte qualche importante eccezione, non
è tanto il brigantaggio postunitario, quanto quello endemico. Pur con questo limite,
queste narrazioni trasmesse oralmente o per
mezzo della scrittura aiutano a capire come
le vicende brigantesche venissero vissute e
interpretate dalla gente comune, secondo
codici morali autonomi e modalità fantastiche proprie, che non coincidevano, se non
in parte, con quelli dei ceti possidenti e della
cultura ufficiale, mentre erano più vicine al
mondo della guerriglia e del brigantaggio,
senza identificarsi interamente, sempre e
comunque, con esso. Le informazioni che ci
forniscono su eventi e personaggi possono
essere invece utilizzati solo quando trovano
conferma in altri riscontri.
L’importanza di questa letteratura è
soprattutto nel suo configurarsi come costruzione mitica: un mito o una leggenda
non è vacua fantasticheria, perché riscrive
la realtà secondando l’onda delle emozioni
e dei desideri suscitata dalla pressione dei
valori comunitari, senza prendere in carico
le domande sulla verità di vicende sempre
più sospese sul fiume dell’oblio, e affidandosi soltanto al consenso collettivo. Per
questo complesso di ragioni vanno tenute
rigorosamente distinte da queste tradizioni
antropologia e storia
i documenti scritti e in modo particolare le
fonti archivistiche; su queste ultime soprattutto deve fondarsi la ricostruzione dei fatti,
mentre le fonti orali, insieme alle tradizioni
letterarie colte e semicolte, ci possono servire prevalentemente per la ricostruzione del
mondo morale della guerriglia45.
Le emozioni più forti i poeti contadini
o pastori vicini al mondo della guerriglia o
briganti essi stessi le affidano a una produzione epica e lirica fatta di versi in dialetto
solitamente accompagnati dal canto. Ma anche i canti sono tramati di una grammatica
culturale che rende diverso, e non sempre
comprensibile ai nostri occhi, un modo originale di vivere la realtà, sentire la passione,
la gelosia, la rivalità, l’onore, la vendetta46.
La (parziale) incomprensibilità nasce dalla lontananza del contesto etnografico, che
non si riesce a ricostruire se non a costo di
vuoti e abrasioni nelle quali si percepisce
debolmente il misterioso pulsare di una vita
diversa.
La memoria odierna del brigantaggio
sopravvive debolmente nelle campagne
dell’hinterland, ad opera soprattutto di contadini e pastori che a volte avevano un rapporto di parentela con i briganti e narravano
sulla base di ricordi familiari, che già mescolavano esperienze vissute, labili memorie
e invenzioni. In queste narrazioni non c’è
traccia dell’ideologia legittimista e filoborbonica, che ha svolto innegabilmente un
/ 2 – comicità e politica
ruolo nella storia del brigantaggio. La retorica dei gruppuscoli autonomisti, separatisti e
neoborbonici è estranea a queste tradizioni
orali, e risulta comunque di origine libresca,
ed elaborata da persone istruite. La simpatia
della gente delle campagne e dei paesi per
i briganti ha origini diverse, e il successo
odierno, limitato ma in espansione, delle
interpretazioni legittimiste deve essere considerato un fenomeno di induzione, che fa
leva su un risentito orgoglio meridionale.
La sensibilità popolare in queste narrazioni si affida invece quasi interamente
al mito: briganti e brigantesse sono esseri
eccezionali particolarmente generosi e valenti, secondo il modello del bandito ideale,
ma anche a volte malvagi e crudeli. Questa
ambiguità appare costitutiva dell’epos brigantesco originario, e riflette in parte una
lacerazione del mondo popolare, tra i più
che stavano dalla parte della guerriglia e gli
altri che invece la avversavano. Secondo il
modello popolare i briganti si immaginano
partecipi del mondo magico e soprannaturale, per rendere ragione del loro carattere eccezionale, e le loro apparizioni dopo la loro
morte servono a confermare implicitamente
il motivo arcaico dell’eroe che non muore.
Molto sviluppato risulta il motivo dei tesori nascosti dei briganti, che ha un minimo
fondamento ed è addotto per spiegare gli arricchimenti improvvisi prodotti da presunti
ritrovamenti fortunati e spesso si contamina
Questa letteratura popolare e semipopolare del tempo del brigantaggio e dei decenni successivi è stata reperita
e studiata la prima volta da D. Scafoglio, Terre e briganti. Il brigantaggio cantato dalle classi subalterne, Firenze,
D’Anna, 1977; L’epos brigantesco popolare nell’Italia meridionale, Salerno, Gentile, 1994; La gloria del patibolo.
Lettura antropologica della “storia” di un brigante santo, in “L’immagine riflessa”, n. 1-2 (2007), pp. 225-40.
46
Canti briganteschi di difficile reperimento sono stati rinvenuti da D. Scafoglio e pubblicati in Terre e briganti, cit.;
L’identità minacciata, cit. Della letteratura di tradizione orale sulle brigantesse si possono leggere alcuni testi pubblicati in D. Scafoglio - S. De Luna, Le donne col fucile, cit., pp. 150-54.
45
51
Q
uaderni
ancora più fantasticamente con le leggende
plutoniche. Leggende e storie si addensano
su alcuni luoghi particolari (grotte, fortificazioni, porte, boschi, montagne, luoghi di
morte e di sacrificio, ecc.), che diventano
ancoraggi dell’immaginario collettivo, che
disegna una geografia fantastica delle scene
del brigantaggio.
Conclusivamente, le fonti orali di cui
stiamo parlando, tenute in scarsa considerazione dagli storici, sono un serbatoio di
dati reali, trasfigurati secondo le modalità e
le risorse dell’immaginario contadino e pastorale, che hanno perso abbondantemente
il loro valore meramente referenziale, per
caricarsi di valori simbolici che possono arricchire la conoscenza del mondo popolare
dell’Italia unita, sconvolto dalla rivoluzione
liberalnazionale e dalla guerra civile durata
circa un decennio, che ha lasciato una eredità di violenza alle generazioni successive.
Queste fonti non sono sufficienti a consentire una ricostruzione “altra” della storia degli
anni 1860-1870: il loro carattere di costrutti
simbolici ce lo impedisce. Più che di conflitti
tra due storiografie bisognerebbe parlare di
conflitti tra due immaginari. È stato scritto
che i personaggi di queste sbiadite memorie
orali sono gli ambigui eroi della storia narrata dal popolo, mentre è significativo il fatto che nessuno degli eroi del Risorgimento
(a parte, per certi periodi e in certi luoghi,
Garibaldi) sia entrato nella memoria collettiva dei paesi del Sud, guadagnandosi uno
spazio comparabile con quello dei brigan-
ti. Pur nella loro significativa ambivalenza,
che li rende oggetto di stupefacente paura
e ammirazione, gli eroi popolari di cui ancora oggi si raccontano le gesta sono Ninco
Nanco, Maria Oliverio, Carmine Crocco,
Maria Brigida, Lucia di Nella, Pietro Bianco. A parte ogni altra considerazione, queste
narrazioni significano che la società italiana
conosce due mitologie di fondazione, quella
degli eroi risorgimentali e quella dei briganti, la prima consegnata alla scrittura, ai monumenti bronzei, alla storiografia ufficiale e
la seconda affidata alla memoria collettiva
delle popolazioni meridionali: due storie –
conclude Scafoglio – due mitografie che non
si sono ancora integrate, e che costituiscono il segno forte di una lacerazione più che
secolare, e rendono diversa la nostra storia
culturale da quella di altre nazioni civili,
come l’Inghilterra, che del brigante Robin
Hood ha fatto un simbolo di identificazione
collettiva, e come l’Argentina, dove il gaucho disertore Martin Fierro è diventato il
protagonista di una grande epopea47.
Prese sul serio e lette attentamente, le
fonti orali nella loro interezza, che si è cercato di descrivere, surrogate dai racconti dei
militari, dei briganti stessi, dei sequestrati,
fermo restando, fin dove è possibile, l’obbligo della verifica e la necessità del confronto
con le altre forme cartacee di documentazione, partendo da una molteplicità di punti
di osservazione, può contribuire ad arricchire e perfino modificare in non poche parti
la percezione tradizionale del brigantaggio
Sulle fonti orali di cui qui si parla il Laboratorio antropologico dell’Università di Salerno aveva avviato e in parte
realizzato ricerche specifiche: ved. D. Scafoglio - S. De Luna, Le donne col fucile, cit., pp. 146-53; A. M. Musilli,
Memoria orale del brigantaggio ad Avigliano e a Missanello, in AA.VV. “Quaderni del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione 2008-2009”, Lecce, Pensa Editore, 2009, vol. III, p. 383-404; V. Santoro, Narrativa brigantesca di
tradizione orale, una amplissima e preziosa raccolta di testi non ancora pubblicati.
47
52
antropologia e storia
postunitario, lasciando affiorare elementi
decisivi dello sfondo storico-etnografico,
dell’affresco meraviglioso e tragico, in cui
si consuma la distruzione di una antica nazione, l’esplosione violenta della guerra civile, la lacerazione delle strutture familiari,
cittadine, sociali, la nascita contrastata e vacillante di un nuovo Stato unitario, la crisi
radicale di una cultura, che nel suo dissolversi ritrova forme arcaiche di resistenza e
inventa modalità moderne di confrontarsi e
lottare con le forze materiali e morali di una
inquietante e discussa modernità. Un affresco sommerso da un pulviscolo di esistenze
bruciate, che conferisce senso a una infinità
di storie uguali e diverse.
Restituire a questo sfondo tutta la sua
complessità, a cominciare dalla sua natura
di conflitto di ragioni, di uomini e di passioni, oltre che astrattamente di valori, è la sola
scelta che può impedire di sottrarre l’interezza della loro umanità ad uomini e a donne
delle campagne meridionali, finora trasformati in semplici combattenti di una guerra
perduta ed iniqua, come tutte le guerre.
Il contesto etnografico e le sue fonti
La grande lacuna delle ricostruzioni storiche del brigantaggio è costituita dalla aleatorietà del suo contesto etnografico. Esse ci
consentono di conoscere adeguatamente la
storia economica, civile, militare, filosofica,
letteraria di quegli anni, ma ci forniscono
conoscenze limitate se non inesistenti della
cultura popolare in cui era immerso il mon-
/ 2 – comicità e politica
do dei briganti e della popolazione che li sosteneva. Del contesto etnografico degli anni
1860-1870 bisogna tenere nel giusto conto
una doppia specificità. La prima è quella di
essere una società tradizionale con caratteristiche largamente preindustriali e precapitalistiche, in cui la “plebe” delle campagne si
fa carico di un protagonismo che – a parte il
sanfedismo antigiacobino – ha pochi precedenti storici, sostenendo una guerra popolare di resistenza e di difesa durata quasi un
decennio. Questo contesto comprende non
solo le forme di vita, le abitudini normali e le
istituzioni di lunga durata (struttura e valori
familiari, religione, magia, ecc.), ma anche
quelle irregolari, eccentriche o devianti: forme di trasgressione e di violenza individuale
e collettiva, privata e pubblica, ideologia e
pratica della vendetta, brigantaggio endemico, furto campestre, concubinaggio, trasgressioni sessuali, ecc. Questo contesto va
ricostruito, perché è in questa totalità che
affondano le loro radici i comportamenti individuali e di gruppo.
È ancora un problema di fonti, che sono
ancora fonti folkloriche. Abbiamo ribadito
l’utilità della letteratura di tradizione orale,
ma, per esempio, il materiale paremiologico
può essere utilmente utilizzato per ricostruire
i quadri normativi e le regole di vita della gente della campagne, tenendo conto che queste
norme servono a legittimare comportamenti
piuttosto che suggerirli o determinarli, e al
tempo stesso rispecchiano per lo più oscuramente pulsioni ed emozioni, affidate all’uso
di forme poetiche (non a caso la loro struttura formale li assimila alla poesia)48.
Per questi concetti ved. D. Scafoglio, Fare frasi. Paremiologia e poetica, in Le “forme semplici” dell’espressività
popolare, a cura di S. Barillari, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2001.pp. 63-70.
48
53
Q
uaderni
La seconda specificità è costituita dal­
l’impatto di questa società tradizionale con
la storia di quel decennio, causa di trasformazioni repentine e violente, che sconvolsero l’assetto tradizionale e la vita delle
campagne meridionali: l’unificazione nazionale percepita come un’invasione straniera,
il trauma della perdita del Regno, l’ambigua
liberazione garibaldina, la nascita dello Stato moderno e il trionfo delle libertà liberali,
la trasformazione degli apparati statali in
senso centralista, con l’indebolimento delle autonomie locali, l’impoverimento economico del Meridione, lo scatenamento di
una disastrosa guerra di resistenza con le
caratteristiche di una guerra civile, destinata
a durare quasi un decennio e a finire tragicamente. In un certo senso, il brigantaggio
fu l’espressione di una frizione dolorosa tra
il contesto etnografico e i fatti nuovi portati
dalla storia del decennio postunitario, tra le
forme di vita del Meridione e le concezioni e
regole che si ispiravano a un modello culturale più vicino alle caratteristiche degli Stati
moderni europei. Anche se sarebbe riduttivo e forviante parlare di conflitto di civiltà
senza altre specificazioni, le tensioni di origine culturale ebbero un loro peso nel conflitto e ne plasmarono in qualche modo le
forme e i contenuti, con esiti sorprendenti.
Il quest’ottica occorrerà rendere conto della violenza della collisione prodotta
dall’impatto del nuovo su un consolidato
passato: come accadeva in tutte le rivoluzioni giacobine del secoli XVIII e XIX, il
modello di trasformazione della società
meridionale in senso liberal-nazionale fu
imposto dall’esterno e dall’alto, senza la
maturazione delle forze locali, e senza uno
sforzo reale che la favorisse, rendendo visibili i vantaggi della nuova condizione, che lo
sviluppo dell’economia moderna e la nascita
delle libertà democratiche avrebbero potuto
determinare.
In risposta, sul versante opposto al nuovo che disordinatamene e violentemente
avanzava, la reazione delle masse contadine
fece appello alle risorse che l’esperienza tradizionale della vita metteva a disposizione:
una reazione autoctona, con una straordinaria capacità di riscrivere quelle risorse
morali e materiali per adattarle alla nuova
situazione. “Il brigantaggio liberò straordinarie energie, mostrando le capacità di mutamento di una cultura immaginata come
immobile nella sua arcaica solidità: quegli
anni terribili videro l’emergere di giovani
strateghi analfabeti di grande talento, capaci di assicurare alle loro bande un consenso popolare notevolmente più vasto e più
complesso di quello che le classi popolari
avevano tradizionalmente offerto ai banditi;
come videro l’assunzione da parte di contadine povere di un nuovo potere, che ad esse
conferivano il rapporto con le armi e i nuovi
ruoli e funzioni che furono chiamate ad assolvere nelle bande e fuori di esse”49.
Nasce allora per lo storico l’esigenza di
rannodare elementi di novità come questi
con le potenzialità prima inespresse della
società meridionale tradizionale, alle sue
strutture fondamentali e alla sua storia.
Molti elementi nuovi degli anni 1860-1870
potrebbero allora apparire – mutuando
un’espressione dalla linguistica – forme creative insospettate di “reazione del sostrato
D. Scafoglio, Un invito a riscrivere l’identità nazionale, in S. De Luna (a cura di), Per forza o per amore, cit., p. 7.
49
54
antropologia e storia
etnico”, se si approfondissero, per esempio,
le connessioni del brigantaggio femminile
per un verso con il matriarcato “emotivo”
delle strutture familiari meridionali e, per
un altro, con la “selvaggia libertà dei campi”
del mondo rurale precapitalista50; se si desse la giusta importanza alla omologia tra il
modo di vivere e il modo di combattere contadino-pastorale; se, superando la visione statica del mondo rurale, si parlasse finalmente
della sua storia e dell’eredità di esperienze
che il brigantaggio endemico, il sanfedismo
e i moti contadini per la rivendicazione delle
terre lasciarono alle insorgenze degli anni postunitari, senza peraltro identificarsi con esse.
I limiti delle rappresentazioni storiche
del brigantaggio vanno con qualche fondamento addebitate alla carenza di informazioni sulla cultura antropologica e la vita
popolare profonda del suo tempo. Si tratta
perciò di ricostruire in maniera storicamente credibile un contesto culturale lontano
nel tempo, per molti versi diverso e perfino
esotico. Una via è partire da quello che è rimasto fino ad oggi degli effetti tragici della
conquista e dei processi di modernizzazione
sbagliati e ricostruire quello che non c’è più,
affidandosi alle rischiose procedure del metodo deduttivo, mentre risultati importanti
si possono raggiungere utilizzando, come
abbiamo anticipato, la vastissima documentazione etnografica consegnata alle discipline demoetnoantropologiche, che proprio
nel periodo postunitario hanno conosciuto
uno sviluppo senza precedenti, sollecitato
dalle tensioni e illusioni riformiste e dalla
/ 2 – comicità e politica
preoccupazione della estinzione del patrimonio culturale tradizionale.
Indubbiamente la persistenza all’interno
degli studi etnografici della tendenza a leggere le tradizioni popolari con lo sguardo
rivolto al passato può avere incoraggiato gli
storici ad assumere atteggiamenti di diffidenza e di rifiuto, ma questo non giustifica
tutto, perché – insegnava già E.P. Thompson –”utilizzando in modo nuovo le fonti
folkloriche, si trasformano informazioni
che erano soltanto antiquarie ed inerti in
un ingrediente attivo della storia sociale”51.
Il problema è esattamente questo: ritrovare
nella cultura etnografica di un determinato
periodo presente o passato gli “ingredienti
attivi” della sua storia sociale, mobilitando
le nuove risorse e opportunità offerte dalle
scienze sociali. Tanto più che in questa direzione sono andate in parte da decenni alcune esperienze di ricerca, a volte altamente
significative, tra la storia, l’etnografia storica, l’antropologia, l’etnostoria.
Questa metodologia impedisce agli storici sul brigantaggio di separare fatti e personaggi dal reticolo culturale ed etnico dal
quale ricevevano vita. Perché isolare i fatti
dai fattori che ad essi conferiscono significato, confinando questi fattori nell’irrilevanza
o fingendo la loro inesistenza, significa togliere senso allo studio della storia. La coscienza antropologica può collaborare a evitarlo, perché l’antropologia è, forse prima di
tutto, una “disciplina del contesto”.
Queste riflessioni sulle fonti hanno
accompagnato la preparazione dei primi
Su cui ved. G.H. Taylor, Report on the Employment of Childre, Young Person and Women in Agricolture, 1967, p.
204, che con questa locuzione sintetizzava le libertà e il rilassamento dei costumi, anche sessuali, nel mondo rurale
tradizionale.
51
E.P. Thompson, Società patrizia e cultura plebea, tr. it., Torino, Einaudi, 1981, p. 264.
50
55
Q
uaderni
contributi alla storia antropologica del brigantaggio, frutto della collaborazione con
Domenico Scafoglio, e hanno orientato i
lavori successivi52, in cui crediamo di avere
ulteriormente approfondito le ragioni delle
nostre scelte. Seguendo i briganti con attenzione partecipe nella complessità delle situazioni e degli eventi che hanno attraversato la
loro breve esistenza, nella durezza e abilità
del guerreggiare, nella capacità di risolvere
i casi minuti e difficili della vita quotidiana alla macchia, di conservare e ricreare in
mezzo alla precarietà estrema la vita nella
pienezza delle sue passioni, di muoversi con
intelligenza e rigore nel loro piccolo universo e adattarsi alle novità del mondo moderno, i protagonisti della guerriglia contadina ci sono apparsi come gruppi strutturati
con regole, codici, principi, in forme molto
simili alle comunità di guerra, e abbiamo
imparato a conoscerli come esseri umani e
non solo come combattenti irregolari di una
guerra perduta.
Due modelli antropologici e le loro fonti
Gli studi di Carlo Tullio-Altan hanno il
merito di essere stati l’unico tentativo italiano di leggere il brigantaggio in una chiave
che è al tempo stesso antropologica e politica, anche se lo schema politico non è derivato dall’esperienza antropologica, ma dal
pensiero politico della tradizione progressista italiana e – a nostro giudizio – si pone
come una chiave di lettura ideologica largamente forviante.
La documentazione decisiva su cui si
fonda l’interpretazione di Tullio-Altan è
costituita dai dati statistici forniti dalle carte dei processi, peraltro elaborati da altri,
che dimostrerebbero che al brigantaggio
parteciparono quasi tutte le classi sociali,
e che esso non “esprimeva esclusivamente
il ‘mondo contadino’, bensì l’intera società
meridionale del tempo, in quelle che erano le
sue strutture sociali portanti e i gruppi che la
componevano”. La mancata conoscenza diretta delle fonti ha impedito allo studioso di
comprendere che se, effettivamente, buona
parte della società meridionale fu coinvolta
nel brigantaggio, le singole classi sociali lo
furono in maniera radicalmente diversa, dal
momento che 1) la presenza dei ceti “civili” nella guerriglia antiunitaria fu pressoché
inesistente: la lotta sul campo fu opera dei
soli contadini, pastori e, in misura minore,
artigiani che potevano contare sull’assenso,
sull’aiuto e sulla connivenza di altri contadini, pastori e artigiani, e sulla protezione
e complicità, assolutamente strumentale e
opportunistica, di elementi dei ceti “superiori”, sia filoborbonici che filounitari; 2)
nella maggior parte dei casi e comunque nei
casi più importanti gli insorti operarono in
piena autonomia dalla classe dei possidenti e dai circoli borbonici, ed espressero capi
propri, pur nel riconoscimento formale del
progetto legittimista della restaurazione
dell’antico ordine; 3) è comunque esistito
un legittimismo dei popoli notevolmente
diverso dal legittimismo delle classi aristocratiche e della corte borbonica; 4) le ragioni del sostegno dei possidenti alle bande
Iniziato come una ricerca, durata alcuni anni, sulle brigantesse, il lavoro di Domenico Scafoglio e mio è diventato
negli anni un ponderoso volume di antropologia del brigantaggio, che presto sarà dato alle stampe col titolo L’altra
metà della banda.
52
56
antropologia e storia
erano il più delle volte radicalmente diverse
da quello che le bande volevano, dal momento che il loro scopo, a seconda dei casi
e dei momenti, era quello di arricchirsi alle
spalle dei briganti, salvare le loro proprietà e
le loro vite dalle rappresaglie, eliminare con
l’aiuto dei briganti i loro nemici personali o
nemici delle loro famiglie o avversari politici, mediante un intreccio perverso di doppi
giochi, di ribaltamenti opportunistici di alleanze e tradimenti.
Convinto invece che l’insorgenza meridionale sia stata un fenomeno interclassista,
Tullio-Altan ritiene – ancora senza alcun
riferimento diretto alle fonti – che “il ribellismo spontaneo del mondo contadino sfruttato si combinò con la reazione di una larga
maggioranza della popolazione del Sud alla
violazione dei miti tradizionali da parte dei
‘piemontesi’ apportatori di un ordine diverso e di una diversa concezione politica, quella liberale costituzionale”.
La “ragione principale” e il senso ultimo
dell’esperienza brigantesca sarebbe allora
stata “la arretratezza socio-culturale della
società meridionale, impreparata a un tipo
di gestione autonoma degli interessi collettivi, come quella prevista dalla nuova costituzione”, sicché la causa “radicale” e “di
fondo” dell’insurrezione e della resistenza
popolare sarebbe data “dal dramma dell’incontro violento di due diverse Italie, diverse
in ragione delle loro caratteristiche culturali,
economiche, e sociali, profondamente differenti fra di loro, nonostante l’uso di un comune linguaggio”.
53
/ 2 – comicità e politica
Ci saremmo aspettati a questo punto che
l’antropologo affondasse lo sguardo nella
diversità culturale responsabile prima del
rovinoso “scontro di civiltà”; invece questo scontro è sinteticamente restituito con
le categorie obsolete della cultura politica
della sinistra italiana: il brigantaggio esplose
perché “i pilastri della società meridionale
erano la monarchia borbonica da un lato,
e il fideismo cattolico papalino dall’altro,
assieme al sistema feudale della proprietà
fondiaria assenteista e parassitaria, che nel
loro insieme formavano un’entità organica,
un sistema sociale ben preciso e caratterizzato” (p. 45, 46). La conclusione è l’invito
a considerare il brigantaggio “una guerra
civile antiunitaria, di carattere reazionario,
tradizionalistico e rurale, strumento, come
sempre, della politica padronale ed ecclesiastica” (p. 44, 46): una proposta interpretativa che per un verso enfatizza più del giusto
la contraddizione etnica, senza descriverla e
approfondirla, per un altro fornisce di essa
una lettura schematica riduttivamente politica, non confrontata con le fonti primarie,
interamente ignorate, confinando nelle forme di una anacronistica resistenza culturale
un evento che aveva cominciato a modificare profondamente la vita degli uomini e
delle donne meridionali53.
Semmai – se lo studioso non avesse abdicato al compito dell’antropologo – il problema era quello di porsi il quesito: a) quando
e perché le culture diverse, incontrandosi,
possono non piacersi e confliggere; b) quanto la diversità culturale e la differenza etnica
Le riflessioni di C. Tullio Altan sono contenute in Populismo e trasformismo. Saggio sulle ideologie politiche italiane,
Milano, Feltrinelli, 1989; Il brigantaggio postunitario, lotta di classe o conflitto di civiltà, Milano, Banca Nazionale
del Lavoro, 1982, vol. I, Dall’Unità al nuovo secolo; La nostra Italia. Arretratezza socioculturale, clientelismo, trasformismo, e ribellismo dall’Unità a oggi, Milano, Feltrinelli, 1986.
57
Q
uaderni
contano nella determinazione dei conflitti,
nel loro svolgimento e nella loro forma; c)
quali sono le condizioni che determinano
l’assorbimento delle tensioni economiche,
sociali, politiche, dentro un contenitore culturale, ideologico e religioso che finisce col
dilatare le sue funzioni acquistando un ruolo e una funzione totalizzante, da “guerra di
civiltà” e/o “di religione”; d) perché questo
contenitore culturale, quando non prende la
forma criminale del sacrificio salvifico, riesce ad riattivare insospettate energie latenti
negli strati più profondi della storia culturale di un popolo.
Le condizioni, dunque, prima di tutto.
La storia insegna che, quando si incontrano,
due culture possono non piacersi, perché – è
una delle ragioni fondamentali, ma non l’unica – l’una paventa o sospetta il dominio
dell’altra, e comunque questo non impedisce di operare negoziazioni, prima che maturi una reciprocità negativa ed esploda la
tragedia. Nel caso specifico che è oggetto del
nostro studio, l’esito tragico dell’incontro fu
dovuto – come abbiamo in parte anticipato
– al carattere elitario della costruzione statale unitaria, responsabile di scelte politiche
e militari che fecero apparire l’unificazione
nazionale alla stragrande maggioranza dei
meridionali come il risultato di una invasione straniera, con l’instaurazione successiva
di un regime di occupazione e la scellerata
repressione di una insurrezione in cui, agli
albori della nostra storia nazionale, si compì
il crimine di fare la guerra agli insorti senza
lasciare prigionieri, incendiare paesi, prati-
care la tortura, deportare le famiglie, invece
di intercettare la domanda locale di giustizia e di autonomia, graduare le innovazioni,
promuovere la maturazione delle forze locali, rispettare le autonomie territoriali, integrare i militari borbonici sconfitti nel nuovo
esercito nazionale. La deriva sanfedista del
“grande brigantaggio” trova la sua spiegazione, almeno in parte, in tutto questo.
Un grande storico, aperto ai metodi
dell’antropologia, come Hobsbawm, è stato tra i primi a fare un uso scientifico del
folklore per lo studio dei fenomeni di ribellismo sociale, come il brigantaggio su scala
planetaria, usando il metodo comparativo,
per disegnare il modello ideale del brigante,
rintracciabile in tutte le culture. Nei due libri
preziosi dedicati all’argomento54 ha fondato
la sua analisi su materiali letterari popolari,
miti e leggende di molte nazioni, accanto ad
abbondanti testimonianze offerte dalla vasta e varia letteratura sull’argomento. Ne è
venuta fuori una accurata descrizione delle
costanti psicologiche e culturali che hanno
dato vita alla rappresentazione del brigantaggio nelle diverse culture, associata al problema – non sempre in verità felicemente
risolto – del suo rapporto con la realtà del
fenomeno. Con questi studi inizia una lettura antropologica del brigantaggio, di grande
respiro, che purtroppo in Italia non ha lasciato tracce negli studi successivi.
Per la prima volta il fenomeno è collocato sullo sfondo della cultura popolare, con
un’analisi che rivela sostruzioni psichiche
profonde e codici culturali latenti, e rende
Gli studi di E.I. Hobsbawm sono I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale, trad. it. Torino, Einaudi, 1966 (or.
1959); I banditi. Il banditismo sociale nell’età moderna, tr. it., Torino, Einaudi, 1971 (or. 1969). In questi studi le
donne sono pressoché assenti.
54
58
antropologia e storia
comprensibili insospettati tratti enigmatici
del brigantaggio, restituendo spessore conoscitivo, significati e funzioni a materiali
ottusamente ritenuti irrilevanti. Con maggiore profondità, perspicacia e passione, il
russo Bachtin aveva già imboccato questa
strada nello studio antropologico della letteratura, carnevalesca in particolare55. È infatti
proprio nella poesia epica brigantesca che il
brigantaggio dispiega nella sua pienezza, accanto al suo orrore, la sua vita interiore più
profonda, i suoi valori morali e il suo ideale
eroico.
Le nostre annotazioni critiche a Hobsbawm sono anche di altra natura, e rendono ragione di una metodologia diversa:
tralasciando il problema – che qui non ci interessa – dell’assenza di fonti primarie, quali
i documenti di archivio, rileviamo che:
1) I nove elementi costanti, individuati
da Hobsbawm, che strutturano il racconto
atemporale del brigantaggio (in realtà occorrerebbe integrarli con altre serie di tratti
permanenti), e che sono unità narrative e
insieme nuclei ideologici, come le funzioni
del racconto di magia indicate da Propp,
compaiono tutti nel modello ideale, non
nelle storie singolarmente considerate, che
perciò rispetto al modello astratto presentano scarti e scelte significative, che le rendono autonome nella struttura e nel significato
rispetto al modello generale.
2) L’indistinzione tra fonti letterarie e
folkloriche e fonti documentarie dà luogo a
molti inconvenienti. Hobsbawm sa benissi-
55
/ 2 – comicità e politica
mo che la leggenda è la proiezione mitica di
aspirazioni profonde che non sempre hanno
fatto i conti con la realtà degli avvenimenti
e sono in parte fondate su rimozioni, quali,
per esempio, il fatto che non sempre i briganti hanno goduto il favore delle popolazioni delle campagne, ma questo non gli impedisce troppo frequentemente di utilizzare
le fonti letterarie come documentazione di
fatti reali.
3) Nel trattamento dei materiali letterari sarebbe stato necessario, riconosciuta preliminarmente la loro natura di fonti
speciali, analizzarli con strumenti specifici.
Per esempio, le convenzioni e le regole dei
generi letterari, i topoi dell’epos possono
aver avuto un peso (di cui Hobsbawm non
ha tenuto conto) nella determinazione delle
invarianze tematiche delle rappresesentazioni del brigantaggio (che apparterrebbero, allora, non più alla realtà, ma alla sua
trasfigurazione letteraria). Inoltre, nel tutto
indifferenziato su cui ha lavorato lo storico,
si possono individuare tracce di specifiche
vicende letterarie, per esempio, “storie” che
riproducono la leggenda contadina (cioè
le modalità attraverso cui il brigantaggio è
stato vissuto, alterato, trasfigurato dalla coscienza e dall’immaginazione delle masse
contadine tra le quali è nato e con cui esse
hanno largamente consentito), e “storie”
che invece esprimono l’immagine che del
banditismo rurale s’erano fatta ceti diversi
(come parte degli artigiani, i proletari e la
plebe delle città), che, anche se non erano ad
Di M. Bachtin ved. spec. Scienze della natura e scienze umane, tr. it., in “Scienze umane”, 1980, 4, pp. 7-14; ma il suo
modello metodologico, per quello che ci interessa, rimane il suo capolavoro, L’opera di Rabelais e la cultura popolare, tr. it., Torino, Einaudi, 1979 (or. 1965). Ved. però anche Dostoevskij. Poetica e stilistica, tr. it., Torino, Einaudi,
1968 (ed. or. 1963). Nell’analisi degli scritti di Hobsbawm sono sviluppate le riflessioni di D. Scafoglio, contenute
in particolare in L’epos brigantesco popolare e Terre e briganti, citati.
59
Q
uaderni
esso estranei, vivevano a distanza il dramma delle campagne. È ancora possibile, e in
qualche caso dimostrabile, che la letteratura del brigantaggio (ossia espressa dai ceti
ideologicamente omologhi al brigantaggio,
anche se ad esso non del tutto assimilabili,
come la plebe cittadina e metropolitana) sia
stata influenzata dalla letteratura sul brigantaggio, cioè dalla cultura dei ceti superiori.
Sono differenze importanti, che anche nella
costruzione di una tipologia astratta, peraltro legittima, avrebbero dovuto contare.
4) Infine, l’avere sistemato la ricognizione dei dati in una struttura coerente ha
comportato non solo un eccesso di astorica
generalizzazione, ma anche lo smarrimento
della contraddittoria complessità del fenomeno e della sua stessa trasfigurazione letteraria. Anche se negli ultimi decenni si è
cercato di recuperarla nelle analisi e conclu-
sioni di Domenico Scafoglio, con particolare riferimento all’ambivalenza degli eventi e
del loro racconto, e con un’attenzione specifica alle strategie comunicative e alle motivazioni che determinano il gioco del dire
e del tacere e all’altalena del consentire e del
condannare.
In ogni caso, va riconosciuto ad Hobsbawm che l’avere costruito con i metodi
dell’antropologia il modello del brigante presente in tutti i tempi e sotto tutti i cieli rimane
un contributo preziosissimo anche per chi,
muovendosi anche nella direzione opposta,
ritiene la conoscenza storica un costante andirivieni, reversibile, dal particolare al generale, dallo specifico all’universale, che per un
verso conferisce completezza e concretezza
alle generalizzazioni, per un altro consente di
ritornare sulle situazioni specifiche con un’altra, più ampia e matura consapevolezza56.
A parte gli studi di C. Tullio-Altan e i contributi di chi scrive e di Domenico Scafoglio, l’antropologia del brigantaggio postunitario non ha interessato i ricercatori italiani. Degli studi concernenti altre aree si possono leggere
utilmente J. Brogger, Conflict Resolution and the Rose of Bandit in Peasant Society, in “Anthropological Quaterly”,
Bd. 41; J.A.G. Alcantud, Bandidos Mediterraneos: analogias etnograficas entre los bandolerismos contemporaneos de
Andalucia y Tif-Yebale, in C.L. Tolosana (a cura di), Anthropologia: horizontes comparativos, Editorial Universidad
de Granada, 2001. Concetti essenziali ma importanti si trovano in J. Pitt-Rivers, Il popolo della Sierra, tr. it., Torino,
Rosenberg & Sellier, 1976 (or. 1971), pp. 180-83; Per alcuni aspetti particolari si vedano F. Egmond, Bandits and
“Savages”: a Bourgeois Stereotype and the Cases of some late 18th-Century Robberbands in Western Europe, Paper
Prepared for the Workshop Violence in the Atlantic and Mediterranean World since the later Middle Ages: from
Above and Below, Maastricht, 17-19 May, ms.; A. Blok, The Peasant and the Brigand, in “Comparative Studies in
Society and History”, 1972, 14, preceduto da P. Ugolini, Briganti e pastori nel Mezzogiorno d’Italia, in “Itinerari”,
1961, n. 52-53.
56
60
L’opera lirica, la lingua e l’unità nazionale
Appunti su Verdi e Wagner
Helga Finter
N
el prologo all’Ariadne in
Naxos di Riccardo Strauss
e di Ugo von Hofmansthal,
il mecenate ricco, committente di un’opera seria, Ariadne, seguita da
un’opera buffa di guitti, esige la sera stessa
della festa, mediante il suo maggiordomo
arrogante che le due opere siano recitati simultaneamente. Guadagnare tempo per i
fuochi artificiali che chiudono la serata, ecco
la spiegazione. La ragione profonda di questa decisione curiosa si rivela invece essere il
desiderio di rallegrare col gioco del buffone
la scena tragica di un’isola desolata. L’uomo
più ricco di Vienna enuncia così una disposizione dell’amatore di teatro non tanto raro
verso un pubblico che resiste alla verità tragica cercando nel teatro dappertutto distrazione e piaceri facili. Quest’opinione, presentata dagli autori come quella del melomane
medio all’inizio del secolo scorso – la prima
versione del dramma musicale è del 1912 ‒
non era però condivisa dal pubblico di ogni
paese europeo. Almeno l’italiano faceva fiera
eccezione, se si segue Antonio Gramsci, che
1
2
scriveva per esempio, nell’inizio degli anni
trenta: “Il melodramma è il gusto nazionale,
cioè la cultura nazionale”1.
La storia del Risorgimento e ‒ secondo
alcuni critici2 ‒ il suo mito vogliono pure
che sia proprio il gusto popolare per il melodramma tragico e eroico ad avere contribuito all’unità del paese. Fra i melodrammi di
compositori come Bellini, Donizetti, Rossini
eccelle soprattutto l’opera di Giuseppe Verdi,
considerato come interprete privilegiato di
una resistenza popolare contro il potere austriaco o borbonico; e il nome di questo repubblicano convinto sarà inoltre identificato
col regno nuovo dei Savoia, quando “Viva
Verdi” è letto, come lo vuole l’uso, come la
sigla dell’esclamazione: “Viva Vittorio Emanuele Re d’Italia”. La cronaca di oggi sembra confermare questa importanza politica,
storica o mitica, del melodramma italiano,
nutrita anche largamente dal cinema: dal
Senso di Luchino Visconti del 1953, in cui
l’inizio del terzo atto del Trovatore di Verdi
dà luogo a una manifestazione anti-austriaca, fino al recente Noi credevamo di Mario
Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere, edizione critica, Torino 2007, vol. III, p.1739, citato in futuro con la sigla QC.
CF. Birgit Pauls, Giuseppe Verdi und das Risorgimento: ein politischer Mythos im Prozeß der Nationenbildung, Berlin: Akademie Verlag, 1996.
61
Q
uaderni
Martone del 2010, che assegna alla musica
operistica un ruolo di contestazione. Infatti,
nella primavera scorsa, il mito si propose di
nuovo come la realtà con la manifestazione
di protesta contro la politica culturale berlusconiana, avvenuta alla prima di Nabucco di
Verdi, il 12 marzo 2011, all’Opera di Roma:
di fronte a un pubblico, di cui facevano parte il presidente della Repubblica e quello del
Consiglio nel palco reale, dopo che il sindaco di Roma Alemanno aveva lanciato un
appello al governo dal palcoscenico per la
revoca della riduzione dei fondi per la cultura, anche il maestro Riccardo Muti prendeva
prima dell’inizio dello spettacolo la parola
dicendo: “Il 9 marzo 1842 Nabucco debuttava come opera patriottica tesa all’unità ed
all’identità dell’Italia. Oggi 12 marzo 2011,
non vorrei che Nabucco fosse il canto funebre della cultura della musica”. Questa esortazione fu seguita non solo da applausi, ma
inoltre, secondo La Repubblica del 13 marzo,
“da una pioggia di volantini dalla balconata,
che dicevano: ’Italia risorge nella difesa del
patrimonio della cultura’, e ancora, in una
versione diversa, ‘Lirica, identità unitaria del
mondo’”. Un evento ancora più stupendo accadeva alla fine del coro degli schiavi ebrei
del terzo atto – “va’ pensiero!” –, conosciuto
come canto di raduno del Risorgimento: un
applauso tremendo salutava la performance
dei cento coristi, e Muti, volgendosi al pubblico accordava un bis con queste parole:
“Sono molto addolorato per ciò che stava
avvenendo, non lo faccio solo per ragioni
patriottiche, ma noi rischiamo davvero che
la nostra patria sarà ‘bella e perduta’, come
dice Verdi. E se volete unirvi a noi, il bis lo
facciamo insieme.” Quello che capitava allora, mi pare un momento straordinariamente
sublime di affermazione della forza repub62
blicana del canto operistico. Cito di nuovo
La Repubblica: “E come a un commando tacito tutti gli spettatori si sono alzati in piedi e
hanno cantato insieme ai cento coristi, rimasti sul palcoscenico. Un fatto assolutamente
inedito, arricchito ulteriormente da un nuovo lancio di volantini pseudo risorgimentali,
che dicevano:’Viva Giuseppe Verdi’, oppure
‘Viva il nostro presidente Giorgio Napoletano’, ma anche ’Riccardo Muti senatore a
vita’”.
Questo singolare episodio, trasmesso dai
telegiornali anche all’estero – io l’avevo visto
in Francia –, e poi reso visibile su Youtube, fu
seguito alcuni giorni dopo, dalla trasmissione integrale di Nabucco il 17 marzo, da RAITRE e Arte, come replica del 15 marzo: il
bis si ripeteva di nuovo con Muti spiegando:
“Non vorrei che le celebrazioni per l’Unità
d’Italia fossero semplicemente qualche manifesto, il tricolore e dopo aver fatto la festa,
torna tutto come prima. Serve altro. Quindi, se noi facciamo ‘Va’ pensiero’ insieme, è
perché non vorremmo che domani passando qui davanti, troviate un cartello ‘Teatro
chiuso’” (La Repubblica del 18 marzo 2011).
Tornando al pubblico, Muti dirigeva allora il
coro cantato insieme dalla sala in piedi e dal
palcoscenico. Questo momento straordinariamente commovente provocava le lacrime
di commozione non solo tra i presenti, ma
anche dagli spettatori lontani, come me davanti allo schermo. Perché?
Una prima riposta sarebbe che questo
momento del cantare insieme cristallizzava
come metafora in actu una resistenza culturale contro un governo di mediacrazia che
finalmente sarebbe caduto alla fine dell’anno. Una seconda è che questa performance
proponeva in un contesto di discussione
sull’identità nazionale, un concetto d’identità
antropologia e storia
nazionale e culturale diverso, aldilà della politica, riassunto inoltre anche dallo striscione
portato alla fine dagli operai tecnici sul palco
che diceva: “Nel 150o dell’unità d’Italia salviamo un’identità nazionale: l’opera lirica”.
Propongo alcune riflessioni su questo
concetto d’identità minima, un’identità
nazionale di cultura: interrogando il suo
impatto a partire dal confronto di questa
nozione in Germania e in Italia, si tratta
di delineare la funzione della musica e del
canto come legame sociale. Infatti, per me,
venuta da un paese con un’altra tradizione
musicale, la Germania, questo evento lirico
inedito è memorabile per diversi aspetti: Prima c’è l’importanza popolare del teatro lirico, spesso dichiarato già morto o solo passatempo per melomani apolitici, e anche la sua
forza civile di protesta; in secondo luogo, c’è
la partecipazione ad hoc di un pubblico che
canta a memoria tutte le parole di un’aria di
melodramma, fatto impensabile in altri paesi; e in terzo luogo, c’è la forza performativa
di quel cantare insieme del palco e palcoscenico creando un’identità italiana culturale
effimera, sfidando la politica della società attuale dello spettacolo. Perché un tale evento
è soltanto possibile in Italia? Perché l’opera
lirica sarebbe sua identità nazionale?
Teatro e opera in comparazione
Questa domanda implica una seria di
problematiche già discusse nel secolo scorso per esempio da Antonio Gramsci nei suoi
Quaderni del carcere intorno alla questione
3
/ 2 – comicità e politica
della lingua e della letteratura italiana popolare. Rileggendo oggi questi testi nell’edizione critica, mi rendo conto che ponono, in
un modo straordinariamente odierno, tutto
il problema della funzione del teatro in una
società moderna e di mass-media. Il problema del dialetto e della lingua italiana è enunciato giustamente riferendosi a quello della
letteratura drammatica e del dramma lirico,
il quale è per Gramsci il melodramma, modello popolare per la lingua, la letteratura, il
teatro3.
Cos’è questa forza popolare del melodramma italiano ? Perché non la troviamo
in Germania, dove giustamente Riccardo
Wagner aveva teorizzato col suo Gesamtkunstwerk, l’opera d’arte totale, un impatto popolare che però è restato utopico, almeno a
suo tempo, nonostante una seria di analogie
storiche paragonabili? Nei due paesi la prefigurazione della loro unità si proietta prima,
al livello culturale, come unità spirituale ideale attraverso la letteratura e il teatro. Per la
letteratura, i nomi emblematici sono Dante,
Petrarca, Boccaccio da una parte, e Lessing,
Goethe e Schiller dall’altra, mentre che per il
dramma musicale i nomi di Verdi e di Wagner cristallizzano l’idea di un’opera lirica
nazionale, produttrice di coesione nazionale.
Il ruolo del teatro e dell’opera lirica differisce
invece nei due paesi, come il ruolo dei poeti per la formazione della lingua nazionale.
In Italia il melodramma sembra aver avuto
l’importanza che in Germania prefigurava
già il teatro di prosa. Che è allora l’impatto
del teatro o dell’opera come operatore del legame sociale di una lingua comune?
QC, 806-07; 969; 1136-1137; 1193-1194; 1195-97;1923; 1932-35.
63
Q
uaderni
La lingua
La lingua italiana è proposta come volgare sublime dai poeti a partire del Trecento
e resta per questa ragione per lungo tempo
limitata ai ceti colti e alfabetizzati. In Germania, il modello della lingua nazionale
e letteraria è quello della traduzione della
Bibbia fatta da Martin Luther del 1545, che
aveva invece una più larga portata perché
toccava anche il popolo dei ceti bassi con
il primo testo udito e insegnato in chiesa.
Questa lingua sarà poi quella della musica
sacra, cantata dai fedeli in chiesa, è quella di Schütz, di Bach. Nonostante i dialetti
si parlassero in ambedue paesi4, il tedesco,
lingua della Bibbia, trovava, dalla metà del
settecento, col teatro di prosa una diffusione
che un sistema teatrale, voluto dai cittadini
delle città libere o dai principi e re dei tanti principati e regni, favoriva. Ancora oggi
la Germania ha 924 teatri con un totale di
305455 posti, di cui 66 sono teatri statali con
24 teatri studio, 250 sono teatri municipali
con 56 teatri studio e 12 teatri di parecchi
municipi. Tutti questi teatri sono sovvenzionati dal contribuente, in tutti sono impiegati
complessi per la prosa, per l’opera e per la
danza. L’idea di un teatro nazionale di lingua tedesca, prima proposta da Lessing nella
sua Hamburger Dramaturgie, e poi elaborato
da Goethe a Weimar, è già stato realizzato in
Vienna col Burgtheater nel 1776. Questo teatro, legato alla borghesia colta, contribuiva
così a promuovere il concetto di un’identità
4
5
6
64
nazionale di cultura – Kulturnation –, che
gli scrittori ma anche i filosofi diffusero fino
al Novecento. Visto che i testi drammatici
erano insegnati nelle scuole, si può dunque
ipotizzare che il teatro era nell’Ottocento
uno degli strumenti principali per superare
il particolarismo delle regioni5.
Il progetto di riforma wagneriano
Quando Riccardo Wagner si dedica alla
riforma del teatro lirico, nella metà dell’Ottocento, il teatro di prosa ha già la funzione
di legame sociale e culturale proponendo la
lingua tedesca della Bibbia e della letteratura,
diventata lingua comune per tutti i paesi di
lingua tedesca. Il suo progetto di un dramma
della parola e del suono – Wort-Ton-Theater – mira ad allargare la funzione di questo teatro al canto e alla musica, integrando quello che la prosa, ma anche la lingua
parlata esclude: la voce, il canto e la musica
e dunque il rapporto col corpo. Rifiutando
la separazione del teatro in teatro di parola, di danza e di lirica, Wagner sviluppa le
sue idee di un’opera d’arte totale negli anni
1849-52 dopo il fiasco della rivoluzione del
48, cui aveva partecipato. L’opera d’arte del
futuro del 1849, Opera e dramma del 1852 e
Musica del futuro del 18606 ripensano la funzione del dramma musicale a partire da una
diagnosi altrettanto dell’individuo che della
società civile: la necessità del Gesamtkunstwerk risiede in quello che Wagner chiama
Ancora oggi un tedesco del nord non capisce tutto di un tedesco della Baviera, della Svevia, dell’Alemannia.
Hermann Kindermann, Theatergeschichte Europas, vol. VI, Salisburgo 2 1977, 119. Cf. Richard Wagner, Oper und
Drama, edizione critica da Klaus Kropfinger, Stoccarda 1984; Richard Wagner, Ausgewählte Schriften,edizione da
Dietrich Mack, Francoforte 1974.
La risonanza con il concetto di Sorge di Heidegger pare ovvia.
antropologia e storia
Not – disagio, mancanza –7, vissuto sul piano
e individuale e collettivo del popolo tedesco.
Questo termine esprime il disagio di una separazione che è simultaneamente quella del
corpo dall’anima, quella dell’uomo dalla natura, quella dei tedeschi fra di loro e quella
delle regioni e città dallo Stato e insomma
di tutti i tedeschi dalla loro nazione. La Not
consiste dunque nella mancanza di un’unità
e del soggetto, del cittadino e del collettivo.
Wagner si riferisce così a una crisi generale
d’identità. L’opera d’arte totale avrà il compito di rimediare a questo disagio riunendo
le arti del corpo e dell’anima per produrre –
grazie alla riunione di poesia, musica, canto,
gesto e danza sul fondo di pittura del paesaggio – un mito inconscio che sarà simultaneamente quello del soggetto e del collettivo.
Lo scopo di Wagner è chiaramente comunitario e civile: l’opera d’arte totale deve
creare, mediante un messaggio al quale
concorrono tutte le arti della scena, questa
totalità – Gesamtheit – identitaria che la totalità delle arti – Gesamtkunst – prefigura
in nell’unione e fusione delle arti. Il Gesamtkunstwerk fa dunque parte di un progetto
politico-culturale che troverà la sua realizzazione nel dispositivo spazio-temporale
del festival di Bayreuth con suo teatro sulla
collina verde: un periodo di festa ispirato
dalle Dionisie greche – ancora oggi il mese
di agosto di ogni anno – radunerà un pubblico che realizzerà, mediante il vissuto affettivo audiovisivo dell’opera, una comunione
dell’inconscio fra sala e palcoscenico, la quale risveglierà il sentimento d’unità nazionale,
7
8
/ 2 – comicità e politica
all’epoca ancora utopica, come unità politica. Questa creazione, performativa nel senso
Austiniano, di un’unita personale e collettiva
che genera il sentimento dell’unità nazionale, è favorita dalla nuova architettura d’anfiteatro wagneriano, che abolisce con la fossa
d’orchestra anche la barra del palcoscenico,
per riunirlo alla sala: immerso in un bagno
di suoni che avvolge il pubblico, ciascuno si
trova così in un rapporto egalitario rispetto
alla scena, le differenze di classe e ceti spariscono. Questo dispositivo teatrale proto-sacrale, dagli accenti nazionalisti, tiene del
mito inconscio, altrettanto del soggetto che
del collettivo: un mito culturale, effetto del
melodramma, che si suppone produca nel
momento della rappresentazione l’identità
nazionale come certezza emotiva.
Wagner impone così al teatro musicale
un compito che la religione non assolve più:
dare una figurazione all’eterogeneo singolare
proiettato come simbolizzazione audiovisiva
per una comunità. Nello stesso tempo Wagner esige dall’arte la produzione di un vissuto d’identità nazionale più effettiva di quella
proposta dai discorsi e simboli politici. Un
compito culturale doppio è allora attribuito
da Wagner all’opera lirica. Rivela d’una parte
la funzione sacrale dell’arte e dall’altra parte
quella dell’arte dello Stato, come analizzati
da Georges Bataille8: si tratta della sua funzione di mediazione e continuità, riempita
prima dalla religione cristiana e poi dalla sovranità del re o dalla monarchia. Il dualismo
sempre più accentuato fra corpo e anima,
fra individuo e società, fra uomo e natura
Georges Bataille, Theorie de la religion, Paris 1978 e anche La part maudite, Paris 1967.
Cf. le ricerche di Matthieu Schneider sul Jodel da Wagner in : « La Suisse vue par les compositeurs romantiques»,
Analyse musicale, vol. 54 (novembre 2006), p. 65-75.
65
Q
uaderni
che Wagner mira a superare col Gesamtkunstwerk, indica anche il crollo di tali sistemi
di mediazione proposti dalla religione e dai
diversi discorsi politici. L’artista del futuro
ha in conseguenza per Wagner una missione
doppia che è simultaneamente quella di dio
e del sovrano: l’artista totale è maestro del
verbo pieno e nello stesso tempo maestro di
quello che in lui è eterogeneo – la musica e
il canto. È il maestro di un verbo impossibile
che la musica e il canto fanno sentire come
quello del corpo, reso visibile dal gesto. L’artista sarà il sovrano della memoria collettiva
e del mito inconscio che trasforma i soggetti
scissi in membri integrati di un corpo immaginario, quello della nazione.
Questo progetto wagneriano assegna
alla musica e al canto il compito di provocare l’affetto per unirlo a un immaginario
collettivo prodotto dal melodramma. Il testo
del libretto è per questo scritto in una lingua
nazionale proto-arcaica con un verso germanico di allitterazioni e la musica che deve
colpire l’alma, attingendo fra l’altro alle melodie popolari tedesche9. Tutta la polemica
di Wagner contro il melodramma italiano o
francese ripete una sua pretesta mancanza di
radici musicali popolari e pretende dunque
anche la loro improprietà per l’opera lirica
tedesca.
Paragonando la fortuna popolare dell’opera di Wagner con quella di Verdi, l’effetto
del suo programma estetico è lontano di es-
ser riuscito per il suo impatto popolare. La
fortuna nazionalista di Wagner è, secondo
alcuni studiosi10, tardiva; promulgata dal
messaggio nazionalista-razzista dei Bayreuther Blätter, dopo la morte di Wagner fu
iniziata dal 1878 con la stampa della rivista
in caratteri germanici e gotici, e con una tematica anti-civilizzazione germanica, recuperata più tardi dal nazismo. Bayreuth come
luogo di raduno della nazione tedesca era
all’inizio un’impresa piuttosto fragile11, perché il gruppo di patronati tedeschi non era
abbastanza grande e Wagner doveva aprirsi
a un pubblico internazionale. Secondo le parole del critico Hans H. Stuckenschmidt, nel
gennaio 1933, “Il valore internazionale del
festival è oggi più garantito che quello tedesco”. Il solo momento in cui Bayreuth trovava un pubblico popolare era, infatti, durante
l’ultima guerra, quando i soldati feriti spediti dal fronte raggiungevano il festival come
ricompensa dei loro meriti guerrieri12. La
musica di Wagner che presidiava ai raduni
del partito nazista, non era però riuscita vincere il cuore delle masse del partito13. Il mito
wagneriano invece trovava la sua fortuna
popolare attraverso immagini di pubblicità
– dell’estratto di carne Liebig per esempio –
o il cinema di Fritz Lang e la letteratura della
quale testimoniano scritti di Thomas e Heinrich Mann o Robert Musil.
La fortuna della musica wagneriana resta
così confinata a un gruppo di artisti e melo-
Cf. Hartmut Zelinsky, Richard Wagner 1876-1976, ein deutsches Thema, Frankfurt 1971; Udo Bermbach, Richard
Wagner in Deutschland. Rezeption, Verfälschungen, Stuttgart 2011.
10
Cf. Hans H. Stuckenschmidt, Bayreuth 1933, in: Anbruch, Zeitschrift für moderne Musik, gennaio 1933.
11
Cf. Brigitte Hamann, Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth, München 2003, 401 s.
12
Pure i Meistersinger, messo in scena in ogni raduno annuale del partito nazista dal 1933, trovano con pena un pubblico fra i membri del partito, cf. Siegfried Zelnhofer, Die Reichsparteitage der NSDAP in Nürnberg, Nurembergo
2002, 187-190.
13
Cf. Michel Poizat, Vox populi, vox Dei, Paris 1996, 154-227.
9
66
antropologia e storia
mani colti. Rispetto al suo successo popolare, Wagner non riusciva in quello che Verdi
aveva realizzato: la sua musica non sarà cantata dal popolo – per il popolo era troppo
difficile. E come il suo mito non è mai un
dramma che enfatizza la resistenza contro
una forza ingiusta politica – a eccezione del
Rienzi –, non poteva neppure servire da metafora di rivendicazioni politiche. È un mito
in cui la pulsione di morte richiede l’abnegazione e la dissoluzione del soggetto in un
sentimento oceanico della comunità che va
alla morte e in questa chiave fu utilizzato
dal nazismo14. Come riportato da Gabriele
D’Annunzio in un articolo nella Tribuna del
3 agosto 1893, Wagner è un’artista della rinuncia quando scrive a Liszt: “Posseggo ora
un calmante che aiuta a trovare il sonno ed è
un ardente e profondo desiderio della morte. Piena incoscienza, dissolvimento di tutti
i sogni, annientamento assoluto: – ecco la
liberazione finale”15.
La forza del canto
Wagner potrà invece, assistito da Gramsci, darci alcuni accenni per capire l’effetto
e la funzione popolare della musica di Verdi. Ancora oggi tenuta come una dei media
/ 2 – comicità e politica
maggiori dell’unità e del Risorgimento dagli
storici italiani16, questa ricezione della sua
musica è altrove anche messa in questione17.
Preferisco però di prestare fede a un conoscitore del popolo italiano come Gramsci, per il
quale il gusto popolare per il melodramma
sostituisce quello del romanzo in altri paesi:
secondo lui Verdi ha per la cultura popolare italiana lo stesso ruolo che la letteratura
popolare di Eugène Sue aveva in Francia18.
Il melodramma ha sostituito per lui nel popolo la cultura libresca, il libretto dell’opera
lirica funziona da modello al gusto sociale e
sentimentale del popolano italiano, il melodramma influisce persino sul suo modo di
scrivere19. Il melodramma preforma e forma
dunque attraverso il canto la relazione alla
lingua italiana e al corpo. Unisce in un certo
senso quello che è separato quando si deve
parlare l’italiano – che è il caso del popolano
– come una lingua straniera. Il melodramma
lega nel canto la voce della lingua con una
figura della voce inconscia perduta, la voce
prima della lingua, la voce fantasmatizzata
della madre. È la voce dei primi mesi della
vita che dà l’involucro sonoro in cui si imprimono l’espressione delle passioni, del piacere
e del disagio. L’opera lirica propone col canto
un legame sociale affettivo che unisce il simbolico a questo semiotico sonoro delle pul-
Citazione da: Valentina Valentini, La tragedia moderna e mediterranea. Sul teatro di Gabriele D’Annunzio, Milano
1992, 71.
15
Cf. Giovanni Gavazzeni, Armando Torno, Carlo Vitali, O mia patria, storia musicale del Risorgimento, tra inni, eroi
e melodrammi, Milano 2011.
16
Così in una tesi del 1996, Birgit Pauls cit. nega per esempio la fortuna popolare della musica Verdiana prima
dell’unità e vuole interpretarla come una riscrittura mitica ulteriore. Questa tesi mi pare incorretta perché troppo
influenzato da un’analogia col sistema teatrale tedesca e anche colla situazione del teatro tedesco odierno.
17
QC, Quaderno 9, 1136-1137.
18
QC 969.
19
Cf. Michel Poizat, L’opéra ou le cri de l’ange, Essai sur la jouissance de l’amateur d’opéra, Paris 1986.51-155.
14
67
Q
uaderni
sioni20. È per questo – come nota giustamente Gramsci – che l’emozione del canto lirico
è per un italiano non la stessa di quella per
uno straniero, anche se l’opera italiana ha
avuto una fortuna internazionale, perché “al
di sotto […] c’è una più profonda sostanza
culturale più ristretta, più nazionale-popolare”21. Il popolano coglie e sente dunque questo strato del linguaggio musicale italiano.
Lo storico di musica Carlo Vitali rileva del
resto l’effetto pedagogico dell’opera italiana
per una lingua comune22. Come, al contrario della lingua normativa parlata, l’italiano
del libretto è avvolto in un canto che proietta
affetti, tocca la pelle e il cuore, la memoria di
questa prima voce, oggetto di desiderio, può
ritornare cantando. Mobilitando la memoria di un paradiso sonoro perduto, il canto
e soprattutto il cantare insieme è capace di
realizzare in modo performativo l’illusione
del recupero di questa prima voce. In questo
risiede la forza emotiva e quella politica, ma
anche il pericolo politico dell’opera. Verdi
sta per la prima, Wagner, come fu utilizzato dai nazisti, per la seconda. La reificazione
dell’oggetto voce, come la praticavano Hitler
e i suoi sulla scena politica, escudendo ogni
separazione del soggetto e dunque anche
la castrazione simbolica, aveva trovato nel
dramma musicale di Wagner il modello23.
Postscriptum
Da alcuni decenni, questa reificazione
della voce incontra sulle scene tedesche
e anche su quella di Bayreuth la volontà
di decostruzione dell’opera d’arte totale,
del Gesamtkunstwerk. Dis-articolando la
fusione delle arti in un parallelismo dei
linguaggi scenici, lo scopo dei direttori attuali è di aprire per lo spettatore fra occhio
e orecchio uno spazio per la sua memoria
e per il suo immaginario. Tale fu il lavoro di Wieland Wagner, di Robert Wilson
o Heiner Müller. Altri mirano a restituire al dramma di Wagner la sua memoria
storica e culturale. Dopo il Ring di Patrice
Chéreau nel 1976 a Bayreuth, il Parsifal
da Stefan Herheim del 2008 mi pare il più
paradigmatico per una tale visone: la sua
messinscena s’ispira per questo al metodo allegorico di Hans Jürgen Syberberg,
il quale aveva già esplorato in alcuni film,
a partire degli anni settanta, l’impatto di
Wagner, della sua scenografia e della sua
musica sull’immaginario tedesco24. La fortuna popolare dell’opera di Wagner ne ha
potuto trovare oggi un bell’inizio25.
QC, II, 1193-94. Gramsci, per chi importa dappertutto l’aspetto sociale, aggiunge: “ Non basta: i gradi di questo
‘linguaggio’ sono diversi: c’è un grado ‘nazionale-popolare’ (e spesso prima di questo un grado provinciale-dialettale-folcloristica), poi un grado di una determinata ‘civiltà’ che può determinarsi dalla religione (per esempio
cristiana, ma divisa in cattolica, protestante e ortodossa ecc.) e anche del mondo moderno, di una determinata
corrente culturale-politica.”.
21
Cf. Carlo Vitali, Opera, affare di Stato, in: Gavazzeni et altri cit., 185-196.
22
Cf. Michel Poizat, Vox populi, vox Dei, cit.
23
Per esempio: Ludwig, Requiem für einen jungfräulichen König (1973), Hitler, ein Film aus Deutschland (1977),
Parsifal (1983), cf. Cahiers du cinéma, Syberberg, hors série, février 1980.
24
Questa messinscena fu trasmessa l’11 agosto 2012 da Arte.
20
68
La ricerca delle origini
L’invenzione delle feste dopo l’Unità
vincenzo m. spera
L’
argomento proposto riguarda
la re-invenzione di un rituale
molto antico messo in scena
nelle Marche e in Molise. A
seguire è presentato un altro cerimoniale
inventato di sana pianta e senza alcun collegamento con antichi rituali. I primi due
riguardano la reinvenzione del Ver Sacrum
dei Piceni, il primo, dei Sanniti il secondo1.
Il terzo riguarda la rappresentazione della
cultura etrusca proposta come nucleo festivo in un moderno quartiere di Perugia.
Le evocazioni di arcaici miti e antiche
culture hanno assunto, in questi esempi (e
nei tantissimi altri che sarebbe possibile
esaminare osservando quanto similmente è
accaduto e accade nelle altre regioni), nelle
specifiche motivazioni locali, il significato di
festa di paese, cioè di azione con cui e in cui
una comunità intende presentarsi, a se stessa
e a chi è chiamato ad assistervi, esibendo una
sorta di credenziale storica ripescata nel passato più lontano. I tre esempi proposti sono
solo una sorta di campionatura di quanto dalla fine del XIX secolo ad oggi è stato
1
re-inventato e continua a essere inventato
come espressione di antiche tradizioni che
permangono nella cultura popolare che, proprio per questo è diventata degna della nuova
attenzione che, a volte cresciuta a dismisura,
genera una sorta di ipertrofia folclorica.
Prima di procedere nell’esposizione è
necessario fare alcune considerazioni. La
necessità è posta dall’attuale attenzione per
le tradizioni popolari e la nuova definizione dei relativi temi e problemi, così come si
vanno configurando alla luce della loro riutilizzazione nella cultura contemporanea,
con una forte accentuazione di promozione
di una nuova e più soddisfacente immagine turisticamente appetibile e produttiva.
Temi e problemi utili per inquadrare meglio il fondamento teorico-metodologico
e l’indirizzo interpretativo su cui andrebbe
ricalibrata almeno una parte della ricerca
demo-antropologica.
Negli anni successivi al secondo dopoguerra continuano a essere attive le implicazioni politiche dell’utilizzazione del folklore
come strumento di ridefinizione non solo di
Sulla reinvenzione del Ver Sacrum, rilevato nei due centri indicati, rimando a quanto in parte già pubblicato negli
atti del XXème Atelier Eurethno, tenuto presso l’Università di Braga (Portogallo) dal 31agosto al 3 settembre 2066,
sotto la direzione dei professori di etnologia Jocelyne Bonnet (Università di Montepellier III) e José Da Silva Lima
(Università cattolica di Braga) (Spera, 2007; 2011).
69
Q
uaderni
appartenenza culturale, locale e nazionale,
ma anche di appartenenza sociale e ideologica. Le connotazioni di genuinità e autenticità dell’evento popolare sono correlate a
una concezione secondo cui il documento
folclorico riattivato o riscoperto è direttamente proveniente dal passato. Il folklore,
inoltre, è recepito e posto come attestazione
di una storia culturale minore e marginale
che deve essere recuperata. L’operazione di
“recupero” è condotta spesso con modalità
e fini piuttosto ambigui quanto politicamente confusi. Il “recupero” avviene sempre in
maniera selettiva e precostituita da chi tale
“recupero” pone in essere, il quale, spesso,
non appartiene interamente alla cultura su
cui interviene. Ogni evento o documento
folclorico, qualora possa essere nobilitato
da caratteristiche ritenute arcaiche o semplicemente antiche, è assunto e proposto
come elemento fondativo di un’intera comunità che dal quel momento si vuole debba in esso riconoscersi. Ecco allora che un
qualsiasi documento o “ricordo” può essere
individuato e assunto quale elemento su cui
una comunità (in genere gli intellettuali e gli
storici locali, i vai amministratori, le associazioni culturali, le organizzazioni turistiche,
le proloco e simili) ricorda e sceglie di accettare, di “riscoprire” i propri miti fondativi.
Si mette in moto il contagioso meccanismo
favolistico del “come eravamo una volta”.
Il riconoscimento è compiuto sempre
con lo scopo di legittimare e di ridefinire, in
una presunta autonomia e supposta unicità,
la nuova realtà e l’immagine di una comunità, così com’è nel momento del recupero.
Un siffatto atteggiamento, tuttavia, non è
nuovo; compare, sia pure con motivazioni
e utilizzazioni ideologiche storicamente diverse, dopo l’unificazione nazionale (1860).
70
Si tratta di un atteggiamento che definisce
la concezione e le modalità di approccio alle
tradizioni popolari, che si mantiene fino ai
nostri giorni, pur nelle contrastanti proposizioni politiche. Caratteristica, questa, che
è dato rilevare in moltissimi esempi di feste
ormai ritenute e presentate come “autenticamente tradizionali”. La definizione di “tradizionale” rivela tutta la sua ambiguità semantica, duttilità ideologica e adattamento
socio-culturale. In forza di quest’ambiguità,
un evento ridefinito “tradizionale”, in senso
antiquariale, è utilizzato per l’attuale rifondazione mitica di una comunità, che percepisce il rischio dell’anomia, della perdita
d’identità e d’immagine, confluendo in un
conteso di forte omogeneizzazione. Grazie
all’inventio dell’arcaico si attuano operazioni
di rivisitazione del folklore che vanno dall’affermazione della «memoria di classe» degli
anni Sessanta e Settanta del secolo scorso,
all’assunzione del dato folclorico come nucleo rifondativo delle “antiche radici” delle
“identità locali”. Azione che va ampliandosi
sempre più, aderendo a quanto l’UNESCO
ha proposto circa la riappropriazione, potenziamento ed utilizzazione delle culture
locali, materiali e immateriali, cui è riconosciuta la dignità di patrimonio culturale comune. Su questa operazione la nuova società
contemporanea rielabora una nuova idea di
cultura popolare e tradizionale, finalizzata
all’impresa turistica ed economica, secondo
le esigenze di una realtà moderna, borghese
e, di fatto, non più tradizionale in cui sempre maggiore spazio è dato a tutto quanto sia
possibile identificare o far convergere nella
qualificazione del “turismo culturale”.
L’origine di molte feste di paese, o di alcune loro parti spettacolari che caratterizzano parecchie manifestazioni popolari, è
antropologia e storia
sempre presentata come talmente antica che
«affonda le radici nella notte dei tempi». In
questo modo è proposto un atteggiamento
arcaistico e di fondazione identitaria ampiamente diffusi e alimentati dalle varie organizzazioni turistiche e culturali. Proprio su
questa concezione e sulla relativa resa in immagine poggia il senso con cui prende ogni
volta corpo la riscoperta della «autenticità» e
«antichità» della tradizione locale.
L’attività di recupero e reinvenzione è
esercitata sul plastico contenitore di comportamenti e attività mitico-rituali delle
feste religiose, che ogni comunità possiede
tradizionalmente. Spesso si tratta di eventi
e feste documentate storicamente o anche
d’introduzione moderna. Se l’aspetto formale e gli elementi messi in gioco contraddicono l’affermazione di antichità o rimandano
alla realtà contemporanea, vi sarà sempre
qualche erudito che ne affermerà la provenienza antica e perfino arcaica2. L’auto-legittimazione si compie attraverso meccanismi tra i più vari e fantasiosi, compresa la
citazione di episodi storici locali «riscoperti
in antichi statuti dimenticati», o in qualche
frammento di cronaca poco o affatto nota, o
completamente inventata, secondo i meccanismi e le motivazioni evidenziati da Hobsbawm (1987:6-9). L’auto-legittimazione si
afferma anche attraverso indagini compiute
nella memoria degli anziani, i quali, indicati
ed utilizzati come fonti di riferimento, quasi sempre appartengono a una o più generazioni passate. Le loro informazioni sono
spesso difficilmente controllabili, oltre l’en-
2
/ 2 – comicità e politica
fasi e la sollecitazione della citazione di chi
ha effettuato la ri-scoperta e la riscrittura
della memoria. Anche in questo caso gli autori delle indagini, specie tra la fine del XIX
secolo e gli inizi del successivo, sono prevalentemente gli eruditi, gli storici e i folcloristi locali; oggi sono anche i vari assessori
(comunali, provinciali regionali), le Pro-loco, gli imprenditori turistici e gli operatori
culturali. Attività che, secondo una moda
affermatasi in Italia già alla fine del XIX secolo, si affianca alle attività professionali degli eruditi locali, spesso anche politicamente
significative. Condizione di preminenza e di
autorevolezza che conferisce loro, specialmente nei piccoli centri, particolare visibilità e credito. Un altro aspetto del problema, a
monte dei fenomeni prima indicati, chiama
in causa direttamente i demologi, gli antropologi e quanti, a vario titolo, sia pure con
molta passione, compiono ricerche e indagini specifiche.
Molto spesso nelle comunità nelle quali
è condotta la ricerca demo-antropologica, la
cultura e le tradizioni locali sono poco considerate o addirittura vissute come espressione di attardamento e di sottosviluppo.
In queste realtà l’intervento di estranei, o
di persone riconosciute appartenenti all’alta
cultura, conferisce nuova dignità alle espressioni delle tradizioni locali, che possono essere accettate come documenti dei tempi e
passati. Iniziano, così, operazioni di «riscoperta delle proprie radici» che sono sempre
supposte «antiche e lontane», indefinito «retaggio dei secoli passati».
Così come ho avuto modo di rilevare nell’analisi di una festa patronale in un paese della Basilicata, conosciuta
come “Il Maggio di Accettura” (Spera, 1987; 1996; 1998; 2014) assurta a emblema identitario locale, e anche nello
studio di un Carnevale pugliese ricondotto al Medioevo e, da alcuni storici e folcloristi locali, addirittura ai Fasti
di Ovidio (Spera, 2004).
71
Q
uaderni
Nelle ricerche di questo tipo, in genere,
si trova sempre ciò che si cerca, grazie alla
complicità inconsapevole delle fonti e del
modo con cui vengono consultate. In una realtà come quella italiana, ancora a forte suggestione classicistica e antiquaria, l’antico,
l’arcaico sono utilizzati quali parametri attestativi di credibilità, di dignità culturale. La
patina mitica e storica ridefinisce più compiutamente la dignità culturale di qualsiasi
evento, documento, gesto o consuetudine di
cui sia possibile individuare o solo supporne la provenienza «dalla notte dei tempi».
Questo avviene in un’ottica che schiaccia il
tempo arcaico, mitico e indistinto del primitivo, sul tempo “antico” e “degli antichi”. Il
tempo, in cui agisce la re-inventio grazie al
duttile significato di “antico” e di “storico”,
di “primigenio” e di “arcaico”, è configurato
come tempo lontano, come tempo dell’inizio, del ricordo, del “come eravamo”. Il tempo passato, nella vaghezza mitica e letteraria,
diventa il luogo privilegiato di ogni possibile
invenzione in cui agisce il controllo della
mutevolezza del tempo presente. Le notizie
e i frammenti, recepiti come provenienti da
un passato vago quanto ipotetico, pur contenenti frammenti di realtà storica, sono riferiti alla cultura preclassica e classica, dalla
quale assumono una veste di credibilità e di
dignità. Gli elementi ritrovati e reinventati
si fondono con quelli di età medievale e rinascimentale, o di qualche secolo fa, o addirittura di alcuni decenni precedenti l’epoca
della riscoperta, presunta o reale che sia. Le
operazioni di recupero e di antichizzazione
delle tradizioni si configurano come occasioni di riscatto sociale e culturale dei piccoli
centri periferici rispetto alle città e, di conseguenza, enfatizzano le tradizioni locali presentate come unicum. Si tratta d’interventi
72
di facile radicamento che tendono a trasformare e riconsiderare, ora positivamente e
nell’ottica della ricostruzione del documento
culturale e folclorico “tipico”, “originario” e
“locale”, le condizioni di marginalità vissute in passato come discriminanti negative e
indice di arretratezza. La stessa condizione
di marginalità, in tal modo, è assunta come
una sorta di privilegio ed è condivisa come
causa e vettore di conservazione di autenticità, di genuinità; quindi come deposito di
«tradizione antica».
Il documento folclorico, riclassificato come patrimonio culturale importante,
è acquisito, rielaborato e riproposto come
una sorta di emblema del paese nel quale si
compie la riscoperta e la riappropriazione.
La riscoperta della tradizione paesana, in
cui la condizione di marginalità ne legittima
la “autenticità”, acquista anche le valenze di
una vera e propria panacea per una terapia
economico-sociale e di rifondazione identitaria. La nuova immagine, subito condivisa e
socialmente trasversale, è utilizzata per promuovere e difendere la visibilità del paese,
di ciascun singolo paese o piccola comunità
che si scopra e si proponga come unicum in
un conteso tendente, prima, all’omologazione nazionalistica, ora, all’omologazione della
globalizzazione.
Interessante e indicativo della portata del
problema è quanto ho avuto modo di verificare dopo la pubblicazione di alcuni saggi, in cui avevo descritto e analizzato alcune rappresentazioni di Carnevale osservate
in Basilicata. I testi di quei saggi sono stati
utilizzati come una sorta di sceneggiatura e
base interpretativa per il Carnevale di Cirigliano, di Tricarico, di San Mauro Forte, di
Allano (in provincia di Matera), di Satriano
di Lucania e di Teana (in provincia di Poten-
antropologia e storia
za). La stessa cosa è avvenuta per il rituale
del “Battesimo delle bambole” di Barile, della “Passata” di Pescopagano e di Baragiano
(in provincia di Potenza).
Si trattava di azioni, ormai sganciate dal
senso che aveva consentito la trasmissione,
che in forza del riconoscimento loro attribuito con la pubblicazione di saggi specifici o
con la realizzazione di documentari televisivi
stimolati da quei saggi, hanno riguadagnato
l’attenzione di quanti ritenevano si trattasse
di manifestazioni di poco conto. A distanza
di qualche anno ho trovato che quelle azioni,
prima realizzate in forma spontanea e non
strutturata, erano proposte come “uniche ed
autenticamente popolari”, organizzate dai
locali circoli culturali e dalle Pro-Loco, con
finanziamenti erogati dalle Amministrazione e dagli Enti locali, provinciali e regionali.
I risultati delle relative pubblicazioni
demo-antropologiche, indicati come “scoperte”, assumono un ruolo centrale nell’immagine e nell’immaginario che una data
comunità rielabora di se stessa. Le scoperte,
in cui si cerca ciò che si vuol trovare, sono
sempre più esibite come testimonianze della
permanenza di antiche e arcaiche tradizioni
che acquistano maggior valore nella ridefinizione delle identità ed economie locali e
dunque sono degne di riattivazione e invenzione perché «affondano le radici nella notte
dei tempi», lì dove il passato è il luogo della
legittimazione culturale del presente.
/ 2 – comicità e politica
Il “Ver Sacrum” dei Piceni a Monterubbiano
Il primo esempio riguarda una festa che
ho avuto modo di osservare direttamente alcuni anni fa a Monterubbiano, piccolo
centro di quattromila abitanti in provincia
di Ascoli Piceno. La festa vuol essere l’evocazione dell’arcaico rituale del Ver Sacrum
dei Piceni3; contiene elementi di particolare
interesse che rimandano a cerimoniali religiosi e a momenti storici diversi. Il tutto è
fuso in un impasto cerimoniale di buon effetto. La festa, conosciuta come Sciò la pica
(scaccio del picchio) è stata re-inventata il
1896, dopo la sospensione che sarebbe avvenuta, secondo alcuni eruditi locali, alcuni
anni prima dell’unificazione nazionale. Luigi
Mannocchi (1896: 126-127; 1911: 19-21), un
appassionato di studi storici di un paese vicino a Monterubbiano, pubblica nel 1896 una
descrizione della festa secondo quanto dice
di aver trovato in un antico statuto comunale. È lo stesso anno della reintroduzione
della festa avvenuta per iniziativa di Cesare
Lucchetti, erudito personaggio di Monterubbiano «assai amante e geloso delle patrie
memorie», il quale costituì un’associazione
con «lo scopo di far rivivere una buona volta
le antiche feste paesane, segnatamente quella
di Pentecoste, andate in disuso». La festa era
collegata a un’importante fiera che avrebbe
incluso, nelle sue edizioni antiche, anche lo
Sciò la pica. Nel 1903 una seconda descrizio-
Il Ver Sacrum, Primavera Sacra, è un rituale degli antichi abitatori dell’Italia centrale (Sanniti, Sabini-Sabelli, Piceni, Latini e le locali articolazioni territoriali in tribù). I primi nati dopo una calamità (carestia, pestilenza, guerra)
erano dedicati a Marte. Il voto veniva espresso, originariamente, con il sacrificio dei consacrati, animali e umani;
successivamente con l’allontanamento dalla comunità dei giovani al raggiungimento della maggiore età. Gli espulsi, secondo cerimoniali particolari di cui parlano Festo, Strabone, Livio, Varrone, Macrobio, Seneca, Plinio ed altri,
seguivano uno degli animali sacri a Marte. Il picchio, il toro, il lupo erano considerati teofanie di Marte. Nel luogo
in cui questi animali guida (Donà 2003: 25-35) si fermavano erano sacrificati e fondati i nuovi insediamenti.
3
73
Q
uaderni
ne è pubblicata da Luigi Centanni (1903:7480), storico di Monterubbiano. La descrizione, ripresentata in seguito da Giuseppe C.
Pola Falletti Villafalletto (1942, III: 306-308)
è più precisa e fornisce anche alcuni riferimenti relativi alla consuetudine, già allora
scomparsa, di portare in chiesa l’alberello
di ciliegio cui era legato un picchio: nucleo
centrale dell’arcaico rituale del Ver Sacrum
dei Piceni.
La rappresentazione dello Sciò la pica,
che ho rilevato nel 1993, ha luogo il giorno di Pentecoste e non si discosta da quella
descritta nel 1896. Quella descrizione costituisce una sorta di sceneggiatura piuttosto
rigida, fedelmente rispettata ancora oggi. In
un foglio volante, a uso celebrativo e turistico, è scritto che «il rito antichissimo dello Sciò la pica vanta una continuità storica
praticamente ininterrotta» (Foglio volante,
1993). La continuità è solo enunciata e non
documentata. In queste circostanze, in cui è
stuzzicato l’amor proprio e l’enfatizzazione
dell’immagine pubblica e culturale di una
piccola comunità, una tal enunciazione è assunta al pari di un’attestazione storica.
Centro rituale dell’azione festiva è un alberello di ciliegio che ha ancora i frutti attaccati ai rami. È sorvegliato da alcuni uomini
che indossano il guazzarò (o guazzarone,
da “guazza”, rugiada). L’antico abbigliamento dei contadini marchigiani (Pierangelini,
Scotucci, 1989:4-17) è diventato una sorta di
emblema della locale civiltà contadina.
L’interesse per questo capo d’abbigliamento, povero ed essenziale che ricorda
il saio di s. Francesco, si è diffuso dopo la
pubblicazione delle inchieste napoleoniche
(Tassoni, 1973:342). Nell’anno della mia
rilevazione il guazzarò era proposto come
souvenir con copie di altri oggetti utilizzati
74
nella festa. Dalle vie di accesso alla piazza
confluiscono giovani che indossano costumi rinascimentali da paggio. Alcuni recano
i vessilli delle corporazioni, altri trombe,
tamburi, alabarde. A piccoli gruppi arrivano persone di ambo i sessi con costumi che
riproducono quelli dei dipinti medievali e
rinascimentali. Il Capitano dell’Armata di
Pentecoste, i nobili, i gruppi delle quattro
corporazioni si dispongono in ordine di
fronte alla loggia del Palazzo del Comune.
Dalla loggia, annunciato da trombe e rullio
di tamburi, il Podestà legge le modalità dello
svolgimento della festa. Subito dopo i gruppi si compongono in corteo. Inizia la sfilata
processionale accompagnata dal rullo dei
tamburi, dal suono stridulo delle chiarine e
dall’esplosione di fuochi d’artificio. Il corteo
procede dalla Collegiata di s. Maria dei Letterati verso la chiesetta campestre di s. Maria
del Soccorso. La Madonna, sotto quest’ultima denominazione, un lontano giorno di
Pentecoste avrebbe miracolosamente liberato Monterubbiano da una non ben precisata
soggezione a un tiranno.
Il corteo è aperto da un battistrada a cavallo seguito dal gruppo di sbandieratori e
tamburini, dal gonfalone del Comune sorretto da alcuni valletti, dal sacerdote con la
croce astile seguito dalle confraternite, dal
capitano degli armigeri con la castellana,
quindi da cortigiani, da paggi, da scudieri,
dai nobili e dai rappresentanti dei quattro
gruppi delle corporazioni: Artisti, Mulattieri, Bifolchi, Zappaterra. Ciascun gruppo di
figuranti è preceduto dal labaro con le insegne della corporazione, da un alfiere che
regge una costruzione lignea, il cero, alta più
di un metro e mezzo. Sul cero degli Artisti
è riprodotta una casetta con un pupazzo e
alcuni attrezzi. I Mulattieri mostrano un
antropologia e storia
bambolotto su di un calesse e un quadretto
con l’immaginetta del Santo protettore della corporazione. Sul cero dei Bifolchi c’è un
pupazzo con la pariglia di buoi. Un altro pupazzo vestito con il guazzarò è sul cero degli
Zappaterra. Segue, infine, un carro agricolo
decorato con frasche e fiori, trainato da due
buoi e condotto da altri individui che indossano il guazzarò, cappello di paglia e fazzoletto rosso al collo. Sul carro vi sono alcune
donne in costume tradizionale che mostrano i prodotti locali. Un secondo gruppo di
uomini in guazzarò chiude il corteo. Uno di
loro, aiutato da altri due, regge un piccolo albero di ciliegio. Tutti gli altri recano attrezzi
agricoli che fingono continuamente di utilizzare come se fossero nei campi.
La pianta di ciliegio, con i frutti se Pentecoste cade nel periodo adatto, è stata tagliata
abusivamente in un luogo segreto. Il proprietario non può lamentarsene; così come
avveniva e avviene ovunque per le feste del
“Maggio”, come rilevato in Basilicata, Calabria, Lazio, Umbria, Marche. L’alberello,
inoltre, ancora alla fine del XIX secolo, era
«decorato di tutte le primizie della stagione
e di fiori» (Mannocchi, 1896:126). Questo
tipo di decorazione oggi è assente. Come
nella prima descrizione, una ghiandaia è
ospitata in una gabbia legata ai rami più alti
e non legata con lo spago.
Il trasporto dell’alberello di ciliegio e le
azioni degli uomini in guazzarò costituiscono il centro spettacolare più vivace della festa, in contrasto con la seriosità del corteo
storico. Si tratta, a mio avviso, di una rappresentazione collegabile ai rituali del “Piantamaggio”, ancora attivi nelle regioni dell’Italia
centrale. Il senso rituale dell’azione drammatica è accentuato dagli “zappaterra” i quali possono insolentire chiunque, attivando
/ 2 – comicità e politica
un comportamento di tipo carnascialesco.
La celebrazione della festa di Pentecoste nel
Medioevo comprendeva una grande fiera
che consentiva ampia libertà per tutti. Si attuava e si attua, così, una sorta di rovesciamento dei ruoli che consente non solo le aggressioni, ma anche comportamenti di tipo
carnevalesco; comprese le rappresentazioni
mimate delle operazioni relative alle varie
attività agricole. Ogni tanto il gruppo si ferma, l’alberello è poggiato a terra e gli uomini
mimano l’operazione della piantagione e del
rincalzo. L’uomo con la canna, gridando ripetutamente «sciò, sciò» (vai via), percuote il
ramo e la gabbia della pica; poi, all’improvviso, agitando sempre la canna aperta in cima
in modo che faccia più rumore, si rivolge
agli spettatori e ne percuote alcuni. Un altro “zappaterra” beve ripetutamente da una
trufa (fiasca di terracotta a forma di ciambella) e spruzza il vino di cui continuamente si riempie la bocca. Si rivolge per lo più
verso le donne e compie veloci puntate nelle
strade laterali bagnando di vino chi vi trova.
L’uomo con la zappa fa improvvise incursioni fra la gente: spinge l’attrezzo in avanti
facendolo strisciare sull’asfalto. Un altro individuo del gruppo, azionando l’apparecchio
che serve per irrorare lo zolfo sulle viti, fa
il gesto di voler irrorare quanti gli capitino
a tiro. A volte gli “zappaterra” fingono di
zappettare fin sotto i piedi degli spettatori.
Tutto il gruppo, ogni tanto, lascia il corteo
per ripetere queste azioni dinanzi alle case
o nelle piazzette dove si raccoglie un po’ di
gente, o dove abitano amici cui offrono qualche ciliegia.
Queste azioni sono ripetute continuamente, nel tragitto di andata e al ritorno
nella piazza centrale. Qui l’attività dello
“spruzzatore” di vino e degli altri uomini in
75
Q
uaderni
guazzarò si fa più intensa e aggressiva, con
veri e propri inseguimenti dei passanti o
di chi resta ad assistere alle loro esibizioni.
Il gruppo ripete gli stessi comportamenti
anche il martedì successivo, giorno turisticamente dedicato alla degustazione della
gastronomia locale. Giunti dinanzi alla chiesetta della Madonna del Soccorso i quattro
ceri, benedetti dal sacerdote, sono disposti a
formare un quadrilatero davanti all’ingresso
della chiesetta dove è allestito l’altare per la
messa. L’alberello di ciliegio e il gruppetto
di uomini in guazzarò restano a distanza;
a volte si fermano sulla strada, oppure nei
pressi del palco, ai bordi dello spazio in cui
il pomeriggio ha luogo la Giostra dell’Anello,
introdotta nel 1965 a imitazione della Quintana di Foligno, reinventata nel 1946 dopo la
lettura di antiche carte e statuti comunali. Le
Quintane, le Giostre dell’Anello, i cortei storici aggiungono potenzialità turistiche alle
feste contemporanee di carattere religioso.
In un foglio volante diffuso dalla Pro
Loco e dal Comune, la festa è presentata
come «un’antica Sagra dei Piceni» ed è avallata l’origine arcaica del paese. L’introduzione
della nuova definizione è più comprensibile
per una festa che voglia essere riconosciuta
nella sua unicità. Il messaggio, inoltre, afferma l’origine etnica richiamando il collegamento con i Piceni, da cui discenderebbero
gli abitanti di Monterubbiano. La nuova definizione di Sagra dei Piceni è turisticamente
più comprensibile di quella più dotta di Ver
Sacrum. Il collegamento con il Ver Sacrum,
tuttavia, è mantenuto dalle organizzazioni
4
76
culturali che continuano a proporlo come
un reperto fossile sopravvissuto a oltre duemila anni di storia. La probabile connessione
del trasporto e piantagione dell’alberello di
ciliegio, con la sopravvivenza del rituale del
Ver Sacrum, è solo accennata da Mannocchi
che, a conclusione del suo articolo del 1896,
ricordando la festa di Pentecoste, lo statuto
comunale del 1574, Festo e Plinio scriveva:
«Ora questa costumanza dello Scaccio alla
Pica mi fa nascere il sospetto che essa altro
non sia se non una reminiscenza delle feste
antichissime, che, in onor della Pica, la nostra guida nel Piceno, celebravano i nostri
popoli primitivi».
Nel primo numero del periodico «Il Picchio», pubblicato proprio a Monterubbiano nel 1892, era stata avanzata l’idea che il
termine “Pica” sarebbe la volgarizzazione di
“Picchio”, come propone lo stesso Mannocchi sei anni dopo (1904: 20). Quel giornale
deve essere stato letto da Cesare Lucchetti,
che può aver subìto il fascino del collegamento proposto tra il “picchio” (picus), e
la “pica” (pica), la gazza o ghiandaia legata
tra i rami dell’alberello di ciliegio4. La gazza e la ghiandaia competono con l’uomo
nel cibarsi di ciliegie. Da qui, probabilmente, l’azione rituale dello suo scaccio, del suo
allontanamento, il cui senso è coerente con
quello della piantagione nelle strade e, un
tempo, in chiesa dell’alberello di ciliegio,
dello zappettare il selciato, dell’irrorare le
vigne e spruzzare vino sulla gente. La pica,
oggi protetta da una gabbia, un tempo era
legate ai rami dell’alberello dal quale un
La derivazione del termine “pica” dal latino “picus” sarebbe inesatta; a Monterubbiano è accettata per i riferimenti
mitici proposti da Mannocchi. Ovunque con “pica” (pica) è indicata sia la gazza, sia la ghiandaia; inoltre con “pica
è indicato qualsiasi uccello o individuo fastidioso che gridi con insistenza.
antropologia e storia
contadino continuamente faceva mostra di
scacciarla, le dava lo sciò, appunto. Comportamento opposto, quindi, a quanto riferito
nel mito fondativo dei Piceni, i quali, come i
Sanniti, sacrificavano l’animale nel luogo in
cui si fermava. Quello era il luogo indicato
dalla divinità per la fondazione della nuova
città (Donà 2003: 25-48). Il picchio, picus,
animale caro a Marte e sua manifestazione,
infatti, posandosi sulla lancia di chi guidava
il gruppo (come figurato in alcune antiche
monete), o sugli alberi dai quali non si sarebbe mosso, avrebbe indicato il luogo in cui
i giovani, allontanati dal luogo di origine in
adempimento del Ver Sacrum, dovevano fermarsi per fondare un nuovo villaggio.
Il gesto degli uomini in guazzarò, invece, il trasporto processionale dell’alberello
di ciliegio un tempo decorato, l’azione di
“scaccio” della “pica” possono avere un altro
significato. Tutti rimandano direttamente
alle feste del “Maggio” e del “Piantamaggio”,
ancora molto diffuse nel folklore dell’Italia
centro-meridionale. Il loro comportamento,
inoltre, è molto vicino a quanto è rievocato
con la sfilata delle corporazioni e con l’offerta del cero alla Madonna. Sono cerimoniali
interni ai rituali delle feste del “Maggio”, variamente assorbiti nelle feste cristiano-cattoliche, in particole nei cerimoniali della festa
di Pentecoste. Azioni sceniche sono presenti
altrove, in particolare nelle regioni dell’Italia
centrale e meridionale, come rilevato nella
festa di s. Michele nel bosco di Montefogliano, nel Comune di Vetralla, nel Lazio (Spera,
2004: 236-371).
Il legame con i rituali relativi alle feste del “Maggio”, inoltre, evidenzia come la
gazza, la ghiandaia, e con esse il cuculo, siano uccelli legati alla previsione del futuro,
quando, a maggio, si fermano sui ciliegi, se-
/ 2 – comicità e politica
condo quanto conosciamo dalla letteratura
folclorica europea. La battitura dei rami per
scacciare questi uccelli ne fa cadere i frutti:
dal loro numero si predirebbe il numero degli anni da vivere.
Un’altra considerazione riguarda l’uso
del guazzarò che ha assunto valore connotativo dell’identità locale negli ultimi decenni,
in particolare dopo la pubblicazione delle
Inchieste Napoleoniche che ne danno ampia
notizia. Il suo uso attuale, staccato dal lavoro, va posto in relazione con l’enfatizzazione
ideologica, negli anni Sessanta-Settanta del
secolo scorso, del folklore come strumento
di autocitazione. In questa riproposizione
l’abbigliamento dei contadini e dei più poveri è anche diventato uno dei riferimenti
centrali e segnaletici delle manifestazioni di
Carnevale (Spera, 1979: 75).
A Offida, sempre nelle Marche, il guazzarò o guazzerone costituisce ormai l’elemento distintivo del locale mascheramento
di Carnevale. Il costume tradizionale locale, in origine limitato ai contadini e ai ceti
più poveri, diviene a Monterubbiano, come
altrove, emblema e icona di una comunità che lo assume come propria immagine,
riproponendolo come mascheramento o,
meglio, travestimento che individua il tipo
locale, lo “zappaterra”. Queste osservazioni
rendono solo in parte il senso del perché un
mito arcaico, abbinato a un abbigliamento
povero, sia stato riconsiderato e riproposto,
a Monterubbiano, come espressione del Ver
Sacrum e quindi come “Sagra dei Piceni”.
Una considerazione possibile è che nelle riutilizzazioni e reinvenzioni dell’antico e
dell’arcaico la dimensione cronologica è assorbita nella concezione di un tempo in cui
l’arcaico e l’antico sono equivalenti. L’antico
e l’arcaico non sono tempi storici, cronolo77
Q
uaderni
gicamente distinti. Sono entrambi assorbiti
nel tempo mitico, nel tempo delle origini.
Entrambi sono unificati in un tempo schiacciato nel passato non definito, in cui tutto
può essere assorbito e da cui ogni riferimento può riaffiorare liberamente, senza ordine.
Il riferimento mitico e la rappresentazione
medievale sono utilizzati nella medesima
messa in scena. Sono emblemi, segni di
un’appartenenza etnica ormai lontanissima,
interamente ripresa in ambito colto e letterario; appartenenza subito acquisita e condivisa da tutti.
Il “Ver Sacrum” dei Sanniti a Bojano
Un esempio di re-invenzione di un rito
arcaico, che ha avuto luogo in età contemporanea, riguarda la rappresentazione che da
qualche anno si svolge a Bojano, cittadina di
oltre ottomila abitanti in provincia di Campobasso in Molise. L’azione, tra l’evocazione mitico-storica e la festa paesana, è stata
introdotta da un gruppo di donne della locale sezione della F.I.D.A.P.A. (Federazione
Italiana Donne Arti Professioni Affari). La
sfilata e la rappresentazione sono presentate,
dalla prima edizione, come Corteo storico e
rappresentazione del Ver Sacrum e di alcuni
rituali dei Sanniti.
L’iniziativa, sostenuta dalle amministrazioni locali e regionali, si è sviluppata grazie alle condizioni particolari maturatesi
nel corso degli ultimi anni. All’origine c’è un
evento politico e amministrativo risalente al
1963, quando il Molise diventa regione separata dall’Abruzzo di cui era parte. L’interesse principale, a livello regionale e locale
diffusamente avvertito, è l’elaborazione di
un’immagine autonoma e specifica. Su que78
sta linea si sono indirizzate quasi tutte le
pubblicazioni riguardanti gli aspetti storici,
culturali e turistici. Prende corpo, così, la
costruzione di un immaginario comune per
la coesione identitaria e autonoma della regione. L’operazione si sostanzia con il ricorso
ai miti e agli eventi della storia. I riferimenti
al passato remoto sono tra i più gestibili e
nobilitanti; come rilevato in una ricerca che
analizza l’immagine della regione attraverso
le pubblicazioni locali che illustrano le caratteristiche specifiche della regione (Giacalone-Gili; 1999). La riappropriazione del mito
delle origini sannite è diffusa, attraverso i
mass-media e le attività scolastiche, in tutti
gli strati e le componenti sociali. La rappresentazione di Bojano è stata anche sollecitata dalla mostra “Samnium - Archeologia del
Molise”, del 1991, promossa dal Comitato
Nazionale per gli Studi sul Sannio (Capini-Di Niro, 1991). Alla mostra è aggiunta la
narrazione radiofonica del mito delle origini
e della fondazione delle comunità molisane
per opera dei Sanniti-Pentri, secondo il testo
di Strabone, adattato dalla giornalista molisana Titta Sassani. Le origini arcaiche, dunque, risalenti a oltre duemila e cinquecento
anni, sono riscoperte dal grande pubblico.
Origini arcaiche che, nel nuovo contesto
sociale, culturale ed economico molisano,
si fondono con tutto quanto ruota intorno
ai tratturi, alla transumanza e alla loro riutilizzazione turistica, folclorica e naturalistica.
La motivazione turistica e di rielaborazione di un’immagine forte che identifichi il
paese e il territorio molisano, sui volantini
pubblicitari della kermesse di Bojano è così
espressa: «Il fato che ha portato i Sanniti nelle terre bagnate dal Biferno, sembra ancora
pesare sulla nostra gente. Ma il valore, il coraggio, lo smisurato amore per la libertà, la
antropologia e storia
dignità e le doti intellettuali hanno distinto
gli eredi dei Sanniti in tutto il mondo e in
ogni tempo». Il ricorso alla cultura e storia
dei Sanniti, con quanto attiene alla transumanza, non costituisce il mito fondativo
esclusivo di Bojano, ma di tutto il Molise che,
come rileva Fiorella Giacalone (1999:25), su
di esso fonda la propria immagine. Un movimento politico autonomista molisano di
recente formazione, la “Lega sannita”, ha nel
logo un guerriero, la cui sagoma è tratta dalle decorazioni dei reperti esposti nel Museo
di Campobasso.
La rappresentazione del Ver Sacrum a
Bojano non è legata a una scadenza rigidamente fissata; ha luogo, in genere, con l’arrivo della bella stagione. Nel 2010, la XIV edizione si è svolta il 18 agosto, nel periodo di
maggior presenza dei turisti e degli emigrati
tornati in paese per le vacanze estive. L’azione inizia con un corteo ricco di figuranti
che rappresentano i vari personaggi di una
comunità sannita, organizzati nelle varie categorie sociali, religiose, civili e militari. Alcuni storici locali, docenti nelle locali scuole,
hanno curato la documentazione di base attingendo dai classici e dai testi degli specialisti e, in particolare, dal catalogo della mostra
Samnium, per quanto riguarda l’abbigliamento, le armi, i monili. Il corteo è aperto
dal vessillo comunale seguito da quelli delle
province molisane e dei paesi che rivendicano la stessa origine. La sfilata, cui partecipa
qualche centinaio di figuranti, è guidata da
Comio Castronio, eroe mitico che, secondo la leggenda riferita da Strabone, avrebbe
fondato l’antica Bovianum seguendo un toro
nel corso di una Primavera Sacra promessa
a Marte in occasione della guerra contro
gli Umbri (VII-VI secolo a.C.). Il capo del
drappello è accompagnato da un soldato che
/ 2 – comicità e politica
reca un rotolo di pelle d’agnello. Nel corteo
sono compresi: il Meddix tudicus (sommo
magistrato), vari sacerdoti, il consiglio degli
anziani, soldati armati a piedi e a cavallo con
corazze e scudi, giovani donne e ragazzi. Seguono le spose e le madri, gruppi familiari,
pastori con greggi, contadini con i loro prodotti, artigiani con i loro manufatti, un carro
trainato da un asino con bambini, gabbie con
animali da cortile. Anche il carro è “travestito”: ha le ruote con i raggi nascosti da teli
di sacco perché sembrino piene. Un gruppo
di ragazze in tunica scura segue una giovane
coppia. Il maschio, con tunica corta bianca e
cinturone di bronzo, reca la riproduzione di
una statuetta di Marte. La ragazza, in tunica bianca, mantello arancione e una corona
di fiori, reca un’anfora: sono Marte e Kerrès.
Un altro gruppo di ragazze in tunica bianca
segue il drappello dei soldati. Tutte recano
una torcia e al collo hanno la riproduzione
di un gioiello sannita composto di una serie
di spirali di bronzo. Uno dei fulcri principali
del corteo è costituito da un uomo che conduce un giovane toro con una fune legata alle
corna. L’uomo veste una tunica corta, calza
gambali di stoffa e regge un bastone. Il corteo sfila nelle strade del paese. Nella piazza
principale (nelle ultime edizioni il luogo di
raduno è il campo sportivo) è rappresentato
il rituale votivo del Ver Sacrum, seguito da
scene di genere. Nel corteo sfilano anche alcuni adolescenti che reggono uno striscione
su cui è scritto: «Bovianum Caput Pentrorum
Samnitium. Livio IX. 31. 4». La citazione ha
la funzione di attestazione storica del ruolo
riconosciuto a Bojano.
Ogni azione, oltre ad essere recitata dai
vari protagonisti, è spiegata e commentata
da una voce fuori campo. Nella prima scena
l’azione si svolge su un altare di cartapesta
79
Q
uaderni
dove due sacerdoti consacrano un bambino
e un agnellino. Dalle interiora dell’animale
è divinata la sorte dei giovani consacrati, i
quali guidati da Comio Castronio e seguendo il torello partono per fondare la nuova città: Bovianum alle falde del monte Tifernus.
La rappresentazione evoca cerimoniali attribuiti ai Sanniti-Sabelli; come quello del matrimonio sannita, in cui le donne sono date
in sposa ai soldati più valorosi. Poi interviene
un vecchio saggio che incita i giovani guerrieri a essere valorosi e virtuosi. In ultimo c’è
la rappresentazione del cerimoniale del giuramento dell’esercito sannita. I giovani sanniti recitano la formula con cui era invocata
la maledizione divina se non si fossero comportarsi da valorosi in battaglia. Chi rifiutava era è ucciso. Alcune rappresentazioni del
Ver Sacrum sono state tentate in altri centri
della medesima area geografica e culturale,
ma con scarsi risultati e alterne fortune. A
Forchia, in provincia di Benevento, dove i
Sanniti sconfissero i romani nel 321 a.C. piegandoli al disonore delle “Forche Caudine”,
è stato organizzato un “Raduno dei Sanniti”.
Gli Etruschi del fiume e la “Sfilata Velimna”
a Perugia
La “Sfilata Velimna” da circa un decennio
è realizzata nelle strade di Ponte San Giovanni, popoloso rione di Perugia di recente
formazione (Giacalone 2014:95-97). La kermesse si svolge in una settimana di agosto
e termina con un corteo processionale di
qualche centinaio di figuranti in costume.
All’evento aderiscono diverse città dell’Umbria, della Toscana e del Lazio che vantano
origini etrusche. Ogni edizione della sfilata è
dedicata a un tema: la donna, il cibo, il vino,
80
lo sport, i cari e le armi, la donna e la casa, gli
dei e la volta celeste.
La sfilata del 2010 ha celebrato il centosettantesimo anniversario del ritrovamento
della tomba ipogea della famiglia dei Volumni. La scoperta è avvennuta nel 1840 durante i lavori di sistemazione della strada
che collega Perugia ad Assisi. La sfilata, per
celebrare quell’evento, presenta un gruppo di
operai con carriole, picconi e vanghe, alcuni
muli e loro conduttori che aprono il corteo.
Dietro di loro vi sono alcune dame e gli “studiosi” interessati al ritrovamento; due gendarmi e popolane recanti cesti con prodotti
agricoli. Tutti i figuranti, in base al ruolo e al
ceto, sono vestiti secondo la moda del tempo della scoperta. Un numeroso gruppo di
danzatrici, velate e precedute da portatori
di torce, apre la serie delle riproduzioni delle urne cinerarie rinvenute nella necropoli.
Seguono alcuni personaggi in costume etrusco, donne e uomini con vino, pane e vari
prodotti agricoli; l’allegoria della porta degli
inferi, con le relative divinità; gli aruspici, i
sacerdoti e le sacerdotesse; altre donne con
serti di fiori. Il corteo prosegue con le rappresentazioni delle principali divinità, indicate tutte con il nome etrusco, attorniate da
ancelle e figuranti. Numerosi bambini con le
nutrici precedono la Mater Matuta. Dietro,
tra Ercole e Marte sulla biga e con un gruppo di soldati, procedono i componenti della famiglia Velimna. Apollo, alcune ancelle,
musici e sacerdoti precedono una copia, alta
circa tre metri, della tomba monumentale,
“Arnth Velimnia Aules”. Alla base della copia
del monumento vi sono due ragazze vestite
da angeli che ripropongono le sculture nel
monumento originale. In ultima posizione
seguono le sagome di urne cinerarie, i componenti della famiglia Cai Cutu, altre ancel-
antropologia e storia
le, un corteo nuziale e un gruppo di nobili.
Il corteo è chiuso da uno striscione su cui
sono riportate figure di angeli e demoni alati
tratte da affreschi etruschi. Un personaggio
vestito da etrusco segue il corteo con un microfono: è la voce narrante, come rilevato
anche a Bojano, che presenta e commenta
i vari gruppi di figuranti, con annotazioni
storiche, archeologiche e citazioni letterarie.
Lungo il percorso sono disposte alcune ricostruzioni giganti di anfore, oggetti e immagini tratte dalle documentazioni iconografiche delle tombe del luogo e degli altri centri
coinvolti nella kermesse. Il corteo termina
nel moderno anfiteatro dove tutti i figuranti
e il pubblico assistono a un “ballo etrusco”, la
cui coreografia prevede l’accensione dei profili delle urne cinerarie e della tomba dei Volumni. La rappresentazione dopo una serie
di manifestazioni culturali, è conclusa con
una “cena etrusca” sul ponte romano-medievale, interamente ricostruito di recente.
Il ponte, da cui prende il nome la contrada,
è un altro riferimento storico fondante del
rione.
La volontà di coinvolgere la popolazione
nella riscoperta delle antiche radici segue un
disegno ben articolato, la cui regia è condivisa alla pari tra le associazioni e le istituzioni locali. In uno dei volantini pubblicitari
è scritto: «L’obiettivo è quello di radicare la
tradizione nel territorio, coinvolgendo la popolazione nella scoperta e nella valorizzazione delle proprie radici storiche».
L’operazione della reinvenzione e, dunque, della riappropriazione del passato,
che per diventare degno di attenzione deve
essere preferibilmente il più antico possibile, diventa espressione di una volontà di
affermazione di esistenza in relazione con
lo spazio occupato e riconosciuto proprio.
/ 2 – comicità e politica
L’esigenza di affermazione è sollecitata dalla
competizione che può sorgere tra una città,
il cui spazio storico è già consacrato, e una
sua parte ormai più ampia e produttiva, più
moderna, ma meno “storica” e, quindi, non
consacrata dai passati vissuti storici riconoscibili, che le conferiscano la dovuta legittimità. La sfilata, nella perentorietà della
citazione filologicamente corretta, perde il
carattere di mera rappresentazione per diventare una sorta di “presentazione” mitica
e laica. In essa e con essa la comunità di Ponte San Giovanni cita se stessa nella ricostituzione di un immagine che è rivolta, prima
di tutto, proprio a se stessa. Gli abitanti del
rione per un giorno diventano l’evocazione
vivente di quegli etruschi “nobili”, dei quali
la storia locale ha riacquistato non solo memoria, ma dei quali, in immagine e presenza
ne ha preso possesso. In tal modo entra in
azione un meccanismo assimilabile a quello
che, dal punto di vista demo-antropologico,
conferisce senso alle mascherate tradizionali. Chi è mascherato, chi gira “in” maschera
cioè “dentro” la maschera, aderisce al significato della maschera indossata: in quella
maschera, e dunque in quella personificazione, chi la indossa vi s’identifica. Di quella
maschera la collettività, che l’ha prodotta e
in cui è “presentata”, ne conosce il significato culturale e la funzione evocativa e rituale.
La rifondazione, mitica e storica, si compie
a posteriori con l’inclusione del sito archeologico nel nuovo spazio urbano del rione in
espansione.
Alcune considerazioni
La rappresentazione, nel senso di ri-presentazione, allora, definisce e ri-fonda il
81
Q
uaderni
nuovo abitato di Ponte San Giovanni come
uno spazio laicamente consacrato dal riconoscimento, in esso, di antiche radici. La
sfilata in costume assume una connotazione
profonda; così come l’assumevano le mascherate nei Carnevali tradizionali o nelle
Sacre Rappresentazioni sempre più numerose nella regione. Attraverso una tale messa in
scena, assimilabile a una processione, il sacro, ancora tutto laico, intellettuale e astratto
della citazione storica, archeologica e filologica, diviene concreto e riconoscibile nella
figurazione degli ipotetici antenati etruschi
richiamati in vita dall’evocazione. Il mentale-culturale, condiviso nel riconoscimento e
nell’accettazione sociale, diventa fisico-corporeo, individuale e tangibile, dunque attendibile e vero, perché entra a far parte dei
vissuti “festivi” degli abitanti del rione. Così
come vere sono le reliquie e le immagini dei
Santi e delle Madonne esibite nelle processioni; così come sono riconosciuti reali i personaggi delle varie Sacre Rappresentazioni,
nei corpi e nei travestimenti di chi li ripresenta nella scena della periodica resurrezione rituale e festiva. In questa prospettiva
potrebbe essere inquadrato il caso umbro. Il
nuovo quartiere, ormai del tutto autonomo,
si misura con l’immagine della vicina città
di Perugia, più ricca di storia e di riferimenti religiosi consacrati. L’origine etrusca della
città madre è ampiamente documentata, la
sua identità è implicita già nel nome, che ne
legittima la presenza storica e mitica, dalle
origini a oggi. Il rione di Ponte San Giovanni, fino a prima della riappropriazione dell’ipogeo, è stato solo una periferia, senza storia
e priva di un’immagine propria.
Da questa evidenza, solo recentemente
oggetto di attenzione, ritengo che sorga la
volontà di autocitazione nobilitante, con82
divisa a tutti i livelli. La reinvenzione può
compiere una sorta di legittimazione di ciò
di cui, oggi, la comunità intende appropriarsi per non rischiare di perdersi nell’omologazione del processo della globalizzazione.
In questo processo, infatti, anche le città
che, senza una forte connotazione mitica e
storica, possono entrare in una sorta di processo di omogenizzazione della dispersione,
in cui tutte le periferie, già tra loro simili o
addirittura uguali, cadrebbero nel più grigio
anonimato. Monterubbiano, Bojano, Ponte
San Giovanni e gli altri tanti centri che compiono operazioni simili, cercano di limitare
il rischio attraverso questa sorta di travestimento, ormai uno dei tanti che, indicati
come cortei storici in costume, sono messi
in scena in Umbria, nelle Marche, in Toscana, già dai decenni a cavallo fra il XIX e il
XX secolo. Tale fenomeno, non nuovo, è stato ripreso durante il fascismo e subito dopo
la seconda guerra mondiale. Le rappresentazioni in costume, con cortei storici e sfilate
urbane, si sono affermate, in particolare, nei
territori un tempo sedi di forti autonomie
comunali e di Signorie.
Tutti i cortei e le sfilate del genere ora descritto sono improntati a una struttura che
richiama le processioni religiose in onore
dei Santi Patroni, come più chiaramente visibile a Monterubbiano dove la reinvenzione
è stata collegata alla festa patronale.
Le feste, le processioni e le espressioni
della cosiddetta pietà o religiosità popolare,
che ne sono il terreno naturale di coltura e di
trasmissione, sono assenti o drasticamente
ridotte ormai da moltissimo tempo, e solo
di recente riattivate in dimensione laica e
limitatamente alla forma, dai cortei politici
o di affermazione di alcuni principi fondamentali condivisi, come quello della pace: il
antropologia e storia
corteo ch ogni anno collega Perugia con Assisi attraversa Ponte San Giovanni. Le feste
popolari in cui è espressa la “devozione”, la
“religiosità” popolare, come le conosciamo
nelle forme diffuse nel resto della regioni e
d’Italia, a Perugia sono ormai da molto tempo del tutto assenti. Fenomeno che riguarda Perugia, dove forte è stato il potere dello
Stato Pontificio. Ciò che ancora sopravvive
è aderente alla formalizzazione del dettato cerimoniale ecclesiastico ufficiale; come
dimostrano le numerose antiche e nuove
rappresentazioni della Passione, in numero
ogni anno crescente in molte città umbre.
Nell’edizione del 2010 la “Sfilata Velimna” è assimilata nello schema di una processione religiosa, proprio per il tono celebrativo ed evocativo che ne sostanzia l’inventio:
il ritrovamento dell’ipogeo. L’evento primo,
nella sua casualità, può essere acquisto alla
stregua delle varie inventiones sacre, in cui
l’oggetto del ritrovamento è costituito da
un’immagine divina, subito assunta al culto.
Con la Sfilata Velimna a Ponte San Giovanni
è stato riattivato, sia pure nell’accezione moderna dei termini, una sorta di culto degli
antenati illustri e nobili, le cui tombe sono
state ritrovate, secondo la concezione popolare comune, non “per caso”, ma come se
un disegno del destino lo avesse voluto. In
questo caso i componenti della famiglia dei
Volumni diventano le figure cui agganciare
un fondamento rituale da porre al centro
dell’attuale comune storia collettiva (Gueusquin, 1992: 13). Ritrovamenti del genere, di
cui è ricca la tradizione popolare cristiana,
sono di norma acquisiti come eventi voluti
dalla volontà divina. Nella cultura religiosa tradizionale e popolare in particolare,
il ritrovamento di un’immagine sacra non
avviene mai per caso. Lo stesso concetto di
/ 2 – comicità e politica
casualità non ha senso nelle culture a fondamento mitico-rituale.
Il ritrovamento è interpretato come
espressione dell’entità divina che segnala il
luogo in cui vuole essere rinvenuta e in cui
diventare oggetto di venerazione. Ritrovamenti del genere sono, di norma, affidati a
persone umili. Nel caso di Ponte San Giovanni gli autori materiali del ritrovamento
sono gli operai che lavorano al tracciato della strada Perugia Assisi, due riferimenti urbani simbolicamente e culturalmente molto
forti. Gli umili sono i mediatori attraverso
cui il divino indica dove vuole che sia edificata una cappella, un santuario in proprio
onore. I mediatori con il divino sono anche
i giovani piceni e sanniti, che sciamano lontano espulsi dalle loro città e villaggi, che rispettano e realizzano il voto del Ver Sacrum.
A quei giovani, senza più radici e famiglia,
Marte, sotto forma di picchio o di toro, indica il luogo prescelto per edificare il nuovo
villaggio, la nuova città; dopo che in quel
luogo la rappresentazione del dio, picchio o
toro, sia stata sacrificata.
Il luogo del sacrificio è anche il luogo
della sua sepoltura, dunque è sacro. Il luogo del ritrovamento di un’immagine sacra è
anche considerato il luogo in cui quell’immagine è stata sepolta. Il luogo in cui risiede la divinità, o la sua immagine, è ritenuto
particolarmente protetto e adatto non solo
per edificare un’edicola, una cappella o una
chiesa, ma anche un borgo, un paese, una
città. Quel luogo è sotto la protezione e il patronato di chi lo ha indicato e vi è sepolto.
Le analogie e coincidenze sono accentuate
nel ritrovamento dell’ipogeo del Volumni,
in cui il principale reperto monumentale,
quello riprodotto nella sfilata, è posto nella
tomba come fosse un altare. La raffigurazio83
Q
uaderni
ne di coloro che sono ritenuti i nobili abitatori del luogo è costituita da un’imponente
figura sdraiata sul coperchio del sarcofago,
alla cui base sono disposti due angeli in
tutto identici alle raffigurazioni cristiane.
In questo modo il ritrovamento e l’oggetto
ritrovato possono essere assimilati, almeno
nella mentalità comune, a quanto accade
nel cattolicesimo popolare. Il ritrovamento
dell’ipogeo, allora, è come automaticamente
assimilato a un evento se non proprio divino, stante l’attuale processo di laicizzazione,
almeno a un episodio emblematico con forte
componente emotiva a sollecitazione sacrale. È per questo che l’Arnth Velimna Aules è
il simulacro centrale della scena ed è esibito
al centro del corteo, come lo è l’immagine di
culto di un Santo patrono.
Nel caso di Monterubbiano e di Bojano,
invece, per quanto in entrambi sia presentato il Ver Sacrum, ci troviamo dinanzi a due
esiti distinti di modalità e concezioni con cui
è utilizzato il riferimento all’arcaico. A Monterubbiano la denominazione della festa di
Pentecoste, ripresa alla fine del XIX secolo,
rientrava in un problema politico e ideologico specifico di quel periodo, che riguardava
la volontà dei piccoli centri della provincia
italiana di mantenere ed esibire una propria
dignità culturale entro la nuova definizione
nazionale che tutte le doveva comprendere
in unica “comune” nazione. La dignità di
unicità è ripescata nella storia e mitologia
locale per opera di un personaggio colto che
ha elaborato la nuova immagine della festa
del paese, attivando una sorta di riconoscimento dell’uccello, al centro dell’azione del
locale rituale di Piantamaggio-Pentecoste,
con il picus dei Piceni. La festa ha conservato le caratteristiche di festa tradizionale
collegata a un evento cristiano (Pentecoste).
84
L’operazione ha consentito la trasmissione di
azioni alquanto complesse cerimonialmente
e ancora relativamente ben collegate al contesto religioso e socio-culturale locale.
Nel caso di Bojano si assiste all’introduzione di un’azione rappresentativa di semplice connotazione spettacolare e teatrale. In
questo caso il riferimento religioso e sacrale è molto tenue se non del tutto assente, in
senso tradizionale e popolare.
L’azione, però, ha senso all’interno di una
lettura secolarizzata della storia e dei miti locali in cui questi riferimenti possono essere
assorbiti nell’arcaico esibito nella spettacolarizzazione di una reinvenzione, che è anche
rivendicazione di autonomia e di identità.
Bojano ha un problema simile a quello
vissuto un secolo prima da Monterubbiano:
la definizione di una propria specifica unicità che deve essere affermata in una nuova
realtà locale e globalizzata. In epoca di profonda secolarizzazione e globalizzazione, il
compito di supporto sacrale è sostituito e
sostenuto dalla citazione colta. Da qui, dunque, il ripescaggio del rito del Ver Sacrum
operato da una componente attiva della cittadina Molisana che chiede visibilità. Il ripescaggio e la citazione sono già ampiamente
condivisi in tutta la realtà regionale, che trova la motivazione di base nella “consacrazione” della costituzione del Molise in regione
a se stante.
Su questa base, oltre al ricorso agli antichi e arcaici miti fondativi, poco controllabili e quindi luogo di libera reinvenzione, vi è
anche un altro fenomeno che si va affermando, in particolare nelle regioni meridionali.
Questo fenomeno prolunga e imita quanto,
alla fine del XIX secolo e a metà del secolo
scorso, ha caratterizzato l’invenzione di nuove feste, come nel caso di Monterubbiano.
antropologia e storia
Il fenomeno ha interessato in particolare le regioni dell’Italia centrale, dove molto
forte è sempre stato il richiamo al Medioevo
e al Rinascimento. Due epoche storiche, due
trascorse e perdute età dell’oro della cultura nazionale che costituiscono l’immagine
di un passato forte. Si tratta di frammenti
di storia e di miti, spesso decontestualizzati, che è possibile manipolare con grande
leggerezza interpretativa e traspositiva. Nel
Cilento e nella contigua Basilicata, ormai da
alcuni anni, si ripetono azioni teatrali simili;
anche se riferite a eventi storici e mitici più o
meno arcaici e antichi o addirittura dell’epopea risorgimentale. Lo stesso accade in tutta
la Campania, in Puglia e in Calabria, oltre
che nel Molise; solo per restare nell’ambito
delle regioni meridionali che meglio e direttamente conosco.
Queste azioni drammatiche “stradali” sono sempre presentate come attrazioni
spettacolari da esibire con cortei e sfilate in
costume. In diversi paesi sono rievocate storie locali, più o meno famose, di condottieri, di briganti o di eroi. Tutte queste azioni
sceniche, sempre proposte nel periodo estivo, sono strutturate come “feste” corredate
dagli immancabili cortei storici, gruppi di
sbandieratori, ormai centro e base esibitoria
di moltissime azioni di festa in cui i protagonisti sono anche spettatori della propria
esibizione.
Un altro caso, fra i tanti, in cui l’identità è
riproposta attraverso la citazione di antichissimi miti, riguarda Velia, in provincia di Salerno, dove la rappresentazione de “La notte
dei Focesi”, evoca lo sbarco dei fondatori
provenienti dalla Focide. La stessa volontà
di esibire la propria presunta ascendenza antica e arcaica è rilevabile, per esempio, nella
rievocazione de “La Rivolta di Sicone” messa
/ 2 – comicità e politica
in scena dal 1990 ad Acerenza, in Basilicata.
E così via in un elenco ogni anno più lungo e
nutrito, impossibile da seguire e documentare nel dettaglio. In tutti questi casi è possibile rilevare alcuni elementi interessanti da un
punto di vista demo-antropologico.
Dalla seconda metà del secolo scorso,
in molti centri, in particolare delle regioni
dell’Italia centrale e settentrionale, sono state introdotte diverse feste, o meglio, azioni di
festa a volte agganciate alle locali celebrazioni dei Santi patroni, di cui diventano le manifestazioni ludico-competitive più rilevanti.
Tutte indicate come “popolari” riecheggiano
gli splendori e le immagini delle realtà locali,
così come si pensa che fossero nel Medioevo
e nel Rinascimento. Fenomeno che inizia ad
affermarsi soprattutto in Umbria, Toscana e
Marche, con qualche esempio evocante l’età
barocca. In questi termini e con queste riattivazioni di antichi cerimoniali e giochi,
sono ripresentati quei periodi della storia in
cui maggiore è stata l’affermazione delle autonomie locali e comunali.
Per lo stesso motivo vengono riprese leggende di fondazione di città, come nel caso
di Monterubbiano e di Bojano. Particolare,
poi, la reinvenzione delle origini messa in
scena a Monterubbiano, dove il riferimento
è duplice. Nella stessa festa, il cui impianto
principale è religioso, il locale culto mariano, coesistono l’evocazione a riferimento
storico medievale e rinascimentale più riconoscibile, e l’evocazione mitica che mette in
scena, secondo esigenze spettacolari, il Ver
Sacrum dei Piceni, i cui attori vestono l’abito
dei contadini medievali. Nella sovrapposizione e mescolanza di tempi e di eventi non
sembra trasparire la poca congruità della coniugazione paratattica delle reinvenzioni. Il
tutto, invece, si fonde perfettamente nella di85
Q
uaderni
namica del farsi stesso della festa, in quanto
azione in cui il tempo cronologico e storico
viene sospeso, secondo la funzione propria
dell’azione rituale che trova senso nella dimensione mitica.
Le reinvenzioni medievali (in particolare
in Umbria) sono rappresentate quasi sempre attraverso gli aspetti ludici ed estetici,
edulcorati da riassunzioni oleografiche di
facile acquisizione formale. Come rilevato,
per esempio, nel caso di Bevagna (Umbria)
dove con le “Gaite”, che non sono più semplici e limitate azioni di festa, ma immersioni totali, per diversi giorno in un Medioevo
minimale, contadino e artigianale. Tutta la
cittadina e i suoi abitanti si mettono in scena riproponendo l’immagine del paese, così
come si pensa sia stato nel Medioevo. Negli
esempi proposti riguardanti Monterubbiano, Bojano, Ponte San Giovanni, o in quelli
citati relativi al Cilento, e per quanto a oggi
mi è dato conoscere anche nelle altre situazioni di reinvenzione delle altre regioni, è
interessante notare come in nessun caso sia
rievocato qualcosa che abbia a che fare con
la cultura e l’immagine della romanità. Nei
casi presentati e in quelli citati, le epoche
storiche di riferimento riguardano il mondo
preromano e il Medioevo.
I motivi dello scavalcamento del mondo
romano, in particolare di quello imperiale
– che rivive solo nelle citazioni della Sacre
Rappresentazioni della Passione – sono due.
Il primo riguarda l’utilizzazione fattane dal nazi-fascismo che, nelle sue mire di
espansionismo e affermazione ideologica, ha
adottato un riferimento, quello delle immagini della grandezza dell’impero romano, in
cui non ci sono possibilità di identificazioni territoriali e culturali locali. Tutti coloro
cui è riconosciuta l’appartenenza, qualun86
que sia la loro provenienza, prima di tutto
sono cittadini romani. Le immagini relative
a quell’età della storia sono acquisite in una
definizione ideologica che, con terminologia
moderna, potremmo dire che rimandino a
una sorta di vera e propria globalizzazione
ante litteram, in cui tutti gli appartenenti
sono garantiti dagli stessi diritti e legati agli
stessi doveri.
Ne scaturisce un’identità, che è meglio
definire appartenenza, molto forte; sia pure
formalmente definita e anche di apparato.
Inoltre, si tratta di un periodo storico ampiamente studiato in cui le immagini e le
connotazioni delle realtà locali sono assorbite nella stessa storia e mitologia romana. In
quella storia il “locale” non esiste a se stante, e se esiste è difficilmente re-inventabile,
ma ha senso solo entro il più ampio disegno
della romanità. In quella condizione e definizione di un passato potente e altamente
significativo non può esserci ri-scoperta e
re-invenzione. Tanto meno può esserci invenzione di alcun mito fondativo particolare, autonomo e locale, che valga solo ed
esclusivamente per un piccolo centro e non
per altri, anche se contigui e in tutto simili.
Sulla base di questa considerazione, allora, è meglio comprensibile il secondo motivo, direttamente connesso a quanto accaduto
e accade a partire dall’Unità a oggi. La piccola globalizzazione, in senso nazionalistico
limitata alla nuova immagine unitaria, e la
globalizzazione attuale, sono vissute come
riorganizzazione dei rapporti culturali, sociali, economici ed esistenziali, in cui società
e realtà distanti restano in gran parte ciò che
sono e, se più forti, condizionano e assorbono le più deboli. In questa nuova visione del
mondo, le singole specificità locali, come nel
caso dei centri periferici, non riescono a ri-
antropologia e storia
conoscersi, possono perdersi. Da qui, allora,
come in precedenza accennato, il ricorso alla
ridefinizione dei localismi culturali e territoriali, espressi sia attraverso la reinvenzione
di azioni di festa, sia attraverso la promozione del prodotto locale tipico, cioè diverso e
non confondibile con tutti gli altri. Solo così,
definendosi come espressione di un luogo
ben riconoscibile e definito, da sempre e
miticamente legato al territorio, all’ambiente con cui esiste da sempre, “dalla notte dei
tempi”, il legame di reciproca appartenenza,
è possibile non perdersi e annullarsi nel processo di globalizzazione. Processo del resto
poco compreso e accettato a livello locale,
come in passato è stato il più ridotto processo di unificazione nazionale.
Il luogo in cui tutto ciò può essere rifondato, riconosciuto e ridisegnato nella mappa delle appartenenze deve essere quello in
cui è possibile individuare una ristretta e
circoscritta realtà umana entro la quale si
può entrare e operare senza troppi controlli della storia. In questi termini il passato, il
più lontano possibile, ma riconosciuto come
proprio, e il Medioevo dei Comuni e delle
Signorie, ancora ritenuto età buia, ma la cui
riscoperta storica lascia intravedere ampie
possibilità di assunzione fantastica, diventano i luoghi ideali in cui poter reinventare nuove prospettive. Sulla mitizzazione del
passato e sulla sua assunzione mitica, si può
inventare il futuro, secondo le urgenze del
presente.
Bibliografia citata
Capini, S. - Di Niro, A., 1991, (a cura di), Samnium Archeologia del Molise, Roma, Quasar.
Centanni, L., 1903, «Bollettino Storico Monterubbianese», fasc. 5.
/ 2 – comicità e politica
Cousin, S., 2008, L’Unesco et la doctrine du tourisme culturel. Généalogie d’un «bon» tourisme,
«Civilisation», Vol. LVII, nn. 1-2, pp.41-56.
Donà, C., 2003, Per le vie dell’altro mondo. L’animale guida e il mito del viaggio, Soveria Mannelli, Rubettino.
Foglio volante, 1993, Monterubbiano. Una antichissima tradizione picena, foglio volante
stampato a cura dell’Amministrazione Comunale e Provinciale, dalla Pro Loco, dall’Archeoclub d’Italia e dall’APT di Fermo.
Fournier, L. S., 2005, La fête en héritage. Enjeux
patrominiaux de la sociabilité provençale,
Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence.
Galasso, G., 1997, L’altra Europa. Per un’antropologia
storica del Mezzogiorno d’Italia, Lecce, Argo.
Giacalone, F., 1986, La Quintana tra guerra, gioco e potere. Un’analisi storico-antropologica,
«Quaderno della Commissione Storica», n.
2-3, Foligno, Ente Giostra della Quintana.
Giacalone, F., 1991-1992, Nuove feste e memoria
storica, «Annali della Facoltà di Scienze Politiche», Università di Perugia, Quaderni dell’Istituto di Studi Sociali.
Giacalone, F., Gili, G., 1999, Dov’è il Molise? Promozione turistica e identità regionale, «Quaderni di Studi Sociologici», 9, Campobasso,
Università degli Studi del Molise.
Giacalone, F., Rinaldi, R., Percorsi giovanili e luoghi dell’accoglienza a Ponte San Giovanni, in
Santambrogio, A., (a cura di), Giovani a Perugia. Vissuti urbani e forme del tempo , Perugia, Morlacchi, pp. 93-119.
Gueusquin,M-F., 1992, Introduction, in Cités en
fête, Paris, Musée National des Artes et Traditions Populaires,
Hobsbawm, E.J., Come si inventa una tradizione,
in Hobsbawm, E.J., Ranger, T., (a cura di),
L’invenzione della tradizione, Torino, Einaudi,
1987 (Cambridge, 1983).
Mannocchi, L., 1896, Lo scaccio alla pica in Monterubbiano, «Vita Popolare Marchigiana», I,
n. 15, 2.
87
Q
uaderni
Mannocchi, L., 1904-1911, Alcune feste e costumanze caratteristiche nel circondario di Fermo
(estratto da «Folk-Lore della provincia di Ascoli
Piceno», 1904), Petrioli, Tipografia Foliani.
Pierangelini, P., - Scotucci, W., 1989, “Lu guazzarò”. Un costume popolare marchigiano,
Monterubbiano, Archeoclub e Comune di
Monterubbiano.
Pola Falletti Villafalletto, G.C., 1942, Associazioni
giovanili e feste antiche, Torino, Comitato di
Difesa del Fanciullo, vol. III.
Spera E. (V.M.), 1979, Il Carnevale in Puglia e in
Basilicata, «La Scena Territoriale», II, 5-6.
Spera, V.M., 1986, Appunti e campionature in immagine del selvatico in Basilicata, in B. Premoli (a cura di), L’uomo selvatico in Italia, Roma,
Museo delle Arti e Tradizioni Popolari.
Spera, V.M., 1996, Italia no Gogatsu Hashira Maturi, in F. Kuramochi (a cura di), Europa no
Shiukusai, Tokyo, Kawade Shiobo Shinshia.
Spera, V.M., 1998, Le bois et la statue sur la place publique. Le “culte des arbres” dans l’Italie
méridionale et centrale, in M-F. Gueusquin
(éd.), Fête et identité de la ville, «Tradition
Wallonne»,15,Bruxelles, Ministère de la Culture Française de Belgique.
Spera, V.M., 2004, Il sarmento e l’edera. Metamorfosi di un Carnevale contadino. Le “Propag-
88
gini” di Putignano fra arcaismo e televisione,
Perugia, Gramma.
Spera, V.M., 2007, A festa da aldeia e o espectáculo
da sua imagen. A reinvençã do Ver Sacrum em
Monterubbiano e em Bojano, in J. Da Silva
Lima (Coordenator), A festa da aldeia. Patromonio festivo europeu, Braga, Universitdade
Catòlica Portuguesa- Alcaà, pp. 164-180.
Spera, V. M., 2011, La fête du village et le spectacle
di son image: la réinvention du «Ver Sacrum»
à Monterubbiano et à Bojano (Italie), in L. S.
Fournier (sous la direction de), La fête du village. Continuités et reconstructions en Europe
contemporaine, Paris. L’Harmattan, pp. 245270.
Spera V.M., 2014, L’ambiguë et séduisante «inventio» de l’origine archaïque des fêtes populaires.
Le cas du Mai d’Accettura, in: Senka Kovac-Miloš Milenkovic (Urednici), Les traditions en Europe : modification, invention et
instrumentalisation des traditions, Problèmes d’ethnologie et d’anthropologie – Monographies no. 7, pp. 121-145
Tassoni, G., 1964, Le inchieste napoleoniche nei dipartimenti delle Marche, «Lares», XXX, III-IV.
Tassoni, G., 1973, Arti e tradizioni popolari. Le inchieste napoleoniche sui costumi e le tradizioni
del Regno italico. Bellinzona, La Viscontea.
Voci strozzate.
Nota sulla lingua dei migranti
Anna Maria Musilli
La globalizzazione e i diversi
L
e condizioni della diversità –
come d’altra parte, dell’intera
condizione umana – presentano tratti permanenti e tratti che
portano invece i segni dei tempi storici. Non
mi fermerò sulle costanti atemporali, che
son state peraltro brillantemente studiate da
autori come Simmel1, Ricoeur2, Habermas3,
ma prenderò in considerazione la condizione della diversità nell’era della globalizzazione, attraverso un’angolazione particolare, quella del linguaggio.
Notoriamente la globalizzazione è segnata da un fenomeno che è più che una linea di
tendenza: l’indebolimento dello Stato nazionale, che ha comportato un aggravamento
delle condizioni dei diversi. Lo Stato nazionale nella forma democratica aveva infatti garantito un pluralismo politico-economico e
sociale, in cui convivevano e dialetticamente
si confrontavano libero mercato e diritti eco-
3
1
2
nomici e sociali, iniziativa individuale e solidarismo: caratteristiche che, non senza contraddizioni, tendevano a conferire allo Stato
nazionale il carattere di Stato sociale.
La globalizzazione ha comportato un
trasferimento di sovranità dalle istituzioni
democratiche alle imprese transnazionali e al
mercato, e, in assenza di istituzioni democratiche transnazionali, vengono meno le forme
di garanzia e di protezione dei ceti deboli e
dei diversi (e quindi, in primo luogo, degli
immigrati, che sono normalmente una cosa
e l’altra). In altri termini, l’assolutizzazione
dell’interesse privato, come valore universale
nell’era della globalizzazione, misconosce il
valore del legame sociale e delle forme tradizionali di solidarietà e cooperazione, col risultato di rendere ognuno straniero all’altro.
Pertanto, si moltiplicano i processi di esclusione e di discriminazione nei confronti della
diversità culturale, etnica, sociale; si rafforzano le tendenze all’omologazione dei diversi e
alla loro assimilazione mediante l’adattamen-
Georg Simmel Excursus sullo straniero, in Simmel G., Sociologia, Milano, Edizioni di Comunità, 1989, pp. 580-584.
Paul Ricoeur, Sur la traduction, Paris, Bayard, 1984.
Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen HandeIns. Bd. I.Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Bd. II Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1981, trad. it. Teoria
dell’agire comunicativo. Vol. I. Razionalità nell’azione e razionalizzazione sociale. Vol. II. Critica della ragione funzionalistica, Bologna, II Mulino, 1986.
89
Q
uaderni
to alle culture forti che li ospitano, quando
non è possibile fermare il loro ingresso erigendo muri e costruendo recinzioni e barricate. Con apparente paradosso, a questi processi contribuiscono a volte i localismi, che
per certi versi rappresentano una reazione al
processo di globalizzazione, per altri invece
diventano la loro inevitabile conseguenza e il
loro necessario complemento, quando la difesa del territorio e delle sue risorse culturali
locali degenera nella forma di fondamentalismo tradizionalista. Il localismo è dunque,
nel bene e nel male, una reazione ai processi di globalizzazione che rendono gli uomini stranieri agli altri, ma anche stranieri alla
propria patria e a se stessi. I localismi sono
una difesa della propria economia regionale e
della propria cultura etnica come difesa della
propria identità, ma nelle forme estreme questa volontà di contrastare gli aspetti negativi
della globalizzazione diventa ostilità verso
tutto ciò che sembra costituire una minaccia
per la propria cultura (e la propria economia)
e approda spesso a forme di razzismo, di integrismo e di fondamentalismo: e questi comportamenti contribuiscono a incrementare
le forme di estraneità che la globalizzazione
produce su scala planetaria4.
Traduzione, tradimento
Per prima cosa, la società di accoglienza (lo Stato, la nazione, il datore di lavoro)
4
5
6
90
chiede allo straniero di adoperare la lingua del paese che lo ospita. Le leggi, quando esistono, variano da Stato a Stato, ma la
tendenza pare ormai che sia questa, per cui
rinunciare alla propria lingua diventa una
condizione necessaria negli usi pubblici se
non per ottenere l’accoglienza. In altri termini, lo straniero deve tradurre la propria
lingua nella nostra. Ora, noi sappiamo che
la traduzione, anche la migliore possibile, è
sostanzialmente infedele, perché la lingua è
indissociabile dalla cultura e le culture conservano sempre un tasso più o meno elevato
di irriducibilità5, sia perché le parole veicolano inevitabilmente giudizi di valore che
variano da cultura a cultura, sia perché solo
la lingua materna è in grado di restituire pienamente gli strati più sottili di sensibilità che
in essa si sono, per dirla sinteticamente con
una metafora, incarnati. Il termine “poligamia” ad esempio, nella lingua italiana indica,
oltre una struttura familiare particolare6, un
vero e proprio reato, secondo la logica che
è completamente estranea ai gruppi che la
praticano.
Il relativismo linguistico ha marcato più
del giusto l’intraducibilità delle lingue, obbligandoci a contrapporgli la constatazione
che gli uomini, dopo tutto, comunicano,
creano rapporti e perfino convivono, nonostante le differenze. Ma se escludiamo le
sue conclusioni estreme, rimane comunque
un accertamento di fondo: che non esiste
la conoscenza assoluta, e che un fondo di
Domenico Scafoglio, Vecchi Stati e nuove nazioni, in “Quaderni di Antropologia scienze umane” Napoli, Guida
editori, nn. 2-3, settembre 2015, pp. 15-16.
Talal Asad, Il concetto di traduzione nell’antropologia britannica, in James Clifford – George E. Marcus (ed), Scrivere le culture. Poetiche e politiche dell’etnografia, Roma, Meltemi, 2005, p. 199-230; Patrizia del Barone, Antropologia
e linguistica in B. Malinowski, Tesi di laurea, Università di Salerno, Laboratorio antropologico, a.a. 1995-1996.
Philip K. Bock Antropologia culturale moderna, trad. it. a c. di Francesco Remotti, Torino, Einaudi 1978, pp. 489502 (ed.orig. Modern Cultural Anthropology, New York, Alfred A. Knopf Inc., 1969).
antropologia e storia
incomunicabilità resiste ad ogni forma di
traduzione di una cultura e di una lingua in
un’altra7.
Esistono dunque più semantiche, che
possono creare problemi a tutti, a cominciare dai medici, come hanno dimostrato Colasanti e Geraci: “in somalo kili vuol dire reni,
ma kili in somalo identifica l’area cutanea
addominale antero-laterale, mentre in italiano per reni si intende, nel linguaggio quotidiano, l’area dorsale latero-rachidea. (…) Un
italiano quando dice che ha mal di reni vuol
dire che ha una lombagia. In somalo può
voler significare un dolore della regione del
colon ascendente o discendente”8.
La comunicazione e convivenza diventa
possibile quando si approda ad una condivisione reciproca dei significati mediante la
negoziazione. In caso contrario, la traduzione linguistica e culturale diventa strumento
e specchio della sopraffazione e del dominio
di una cultura su un’altra. Un solo esempio:
le brigantesse dell’Italia postunitaria, quando vivevano alla macchia diventavano le
compagne, quasi sempre innamorate e spesso fedeli, dei loro uomini. Fatte prigioniere,
tendevano a definirsi “spose” dei briganti, ma
i cancellieri dei tribunali scrivevano “drude”,
termine che indicava la condizione di amante in senso fortemente spregiativo. Prevalse,
alla fine, il linguaggio del tribunale, e le stesse brigantesse finirono per qualificarsi autonomamente come “drude”, introiettando il
disprezzo di cui il termine marchiava i loro
affetti e la loro passione9.
7
8
9
/ 2 – comicità e politica
Un codice ristretto
La categoria di diversi di cui ci occupiamo, gli immigrati, vengono fatti parlare nella
lingua italiana. Il loro italiano (mi riferisco
in modo particolare ai testi delle badanti
ucraine e rumene), imparato da manuali ridottisimi, da pagine scaricate da internet,
ascoltando la radio e vedendo la televisione,
mediante corsi acceleratissimi per imparare
solo quanto serve per sopravvivere al primo
impatto con la terra straniera e durante la loro
odissea lungo la penisola, infine arricchito (si
fa per dire) nei luoghi di lavoro, è un italiano
dalla grammatica estremamente semplificata,
segnato da interminabili ellissi (dell’articolo,
delle coniugazioni verbali, ecc.); è costituito da una batteria di vocaboli molto povera,
che restituiscono, in forma sintetica, gli assilli
quotidiani più immediati, quelli del lavoro,
del denaro, del cibo, della malattie e delle
cure, delle minacce e delle aggressioni subite.
Tutto estremamente essenzializzato, ridotto
ad un livello quasi etologico.
Questo linguaggio è assolutamente inadeguato a dare voce alle dimensioni più profonde e complesse della vita interiore: è un
linguaggio buono per parlare, ossia per comunicare dati empirici, e non per discorrere,
ossia per colloquiare narrando: il colloquio
richiede un’attenzione incondizionata all’altro, una comprensione che pretende complicità, un trasporto empatico senza barriere;
ma richiede al tempo stesso il possesso del
linguaggio dei pensieri profondi, della razio-
Domenico Scafoglio, Introduzione alla ricerca antropologica, Fisciano, Cues, 2005, pp. 34, 36-37.
R. Colasanti e S. Geraci, I livelli di incomprensione medico-paziente migrante, in Geraci, Approcci transculturali per
la promozione della salute, Caritas diocesana, Roma, 2000, p. 85.
Simona De Luna, Amazzoni contadine, in “Per forza o per amore. Brigantesse dell’Italia postunitaria, Cava de’
Tirreni, Marlin 2008, p. 10.
91
Q
uaderni
nalità e delle emozioni, che rende possibile il
colloquio e per certi aspetti lo produce. Questo vale per tutte le lingue, perché tutte hanno, in maniera diversa, una loro particolare
modo di esprimere il loro universo interiore.
Il linguaggio delle badanti strozza le voci
che vengono dal profondo; solo alcune impennate improvvise lasciano intravedere
appena un fondo segreto che preme sull’imperfezione delle parole facendo emergere
immagini illuminanti: “Non c’è Dio in nostro
paese”10; “al mio paese ci sono solo i morti”;
“quando tu vieni dal Turkestan, dall’Armenia, dalla Crimea, dalla Siberia, tutto si confonde e non sai a chi appartieni”; non ho
paura della vita, della vecchiaia sì, ma non ci
penso”. Acquista importanza, allora, il parlare senza parole: l’illuminazione del sorriso,
lo splendore dello sguardo, o la parola stessa
ridotta a flusso sonoro e musica.
Cos’è intervistare?
Dopo le lunghe e approfondite discussioni nell’antropologia classica sull’uso della
lingua nelle interviste, il problema linguistico del rapporto tra nativi e ricercatori non
è stato preso abbastanza in considerazione
nelle nuove condizioni determinate dalle ultime massicce migrazioni e dal peso che esso
ha nei risultati delle indagini, che dovrebbero avere lo scopo, ovviamente, di far crescere
in profondità la conoscenza del fenomeno
migratorio. L’intervista agli immigrati presenta un paradosso, costituito dal rovescia-
mento di una situazione classica della ricerca
etnografica: tradizionalmente si raccomandava all’intervistatore di parlare la lingua
dell’intervistato; ora (a parte le eccezioni) ci
si accontenta che l’intervistato farfugli nella
lingua dell’intervistatore, senza che questo
costituisca un problema per l’etnografo. Tutto questo condiziona i risultati della ricerca e
limita fortemente la possibilità di conoscere
non superficialmente l’immigrato, perché
– lo abbiamo anticipato – l’intervistato è attrezzato a parlare nella lingua straniera, non
senza difficoltà, il linguaggio dei bisogni elementari e della sopravvivenza11.
In altri termini, la situazione su cui stiamo riflettendo è una situazione invertita
rispetto a quella in cui il ricercatore intervista il nativo nella sua terra d’origine. In
quest’ultimo caso il nativo ha il pieno controllo dei suoi strumenti linguistici ed è in
grado di comunicare sentimenti ed emozioni, trasmettere le sue sensazioni, muoversi
su più registri espressivi, mentre il ricercatore fatica sia a trasmettere nella lingua indigena mal conosciuta la complessità delle
sue domande, sia a collocarsi dentro un sistema linguistico altro, in certa misura impervio alle facili traduzioni in un’altra cultura. Nelle situazioni di immigrazione invece
il sistema linguistico dell’extracomunitario,
se non ha subito abrasioni e cancellazioni,
mantiene potenzialmente la sua capacità di
interloquire pienamente con l’interlocutore,
ma rimane bloccato dalla consapevolezza
che l’interlocutore non è interessato alla sua
vita interiore, che i sentimenti e le emozioni
Ved. Annalisa di Nuzzo, Appendice, La morte, la cura, l’amore. Donne ucraine e rumene in Campania, Roma, CISU,
2009. Le frasi successiva sono frutto di un mio colloquio con una bielorussa.
11
Domenico Scafoglio, Prefazione, in Annalisa di Nuzzo, op. cit., pp. 19-20.
10
92
antropologia e storia
sono un lusso che non si può consentire e
che sono i problemi concreti di sopravvivenza fisica a disegnare il circuito del suo
campo semantico. Il resto lo fa la sua imperfetta padronanaza o addirittura l’ignoranza
della lingua del paese di accoglienza, il codice ristretto che gli consente una difficile e
grama sopravvivenza, votando il suo mondo
interiore al silenzio e all’oblio.
L’antropologo, quindi, non conoscendo
la lingua dell’intervistato, dovrebbe coprire lo spazio della mediazione culturale, per
rendere intellegibile il linguaggio scarno
degli immigrati. Potrebbe servirsi di procedimenti intuitivi e analogici, per tentare di
rendere palese la vita interiore degli intervistati. Sarà quindi necessario che siano messe
in campo strategie che agevolino la comprensione del linguaggio. L’antropologo dovrà puntare, oltre che su una maggiore educazione della sensibilità, sull’ampliamento
dei suoi orizzonti disciplinari, utilizzando i
/ 2 – comicità e politica
suggerimenti e le tecniche delle scienze della
comunicazione, della linguistica e della psicologia.
Per questa via, in un quadro di reciprocità e di vicendevoli scambi tra intervistatori ed intervistati, si può pensare ad una
antropologia dialogica che faccia emergere
il vissuto inespresso di chi, tra le difficoltà e
disagi di un esilio penoso, riesce a fatica ad
usare la lingua straniera della sopravvivenza.
Operazione difficile (ma, come sempre, val
la pena di scommettere), perché non è semplice far “parlare” con un gergo straniero approssimativo una interiorità che ha perso il
suo linguaggio (interdetto, negato, nascosto,
dimenticato), e il rischio che si corre è che,
poiché si confrontano asimmetricamente
due linguaggi (che sono al tempo stesso due
culture), l’una si ponga come l’interpretazione delle ellissi, delle oscurità e dei vuoti dell’altra, col rischio di ridurre l’altro a se
stesso.
93
Antropologia del brigantaggio
domenico scafoglio - simona de luna
I. La banda e le sue regole
I caratteri originali
del brigantaggio postunitario
N
ell’organizzazione
come
nel­l’azione delle bande convergono le espe­rienze della
lunga storia del brigantaggio
postunitario, mescolate ad elementi culturali, saperi e pratiche di diversa provenienza.
Vi si riconoscono infatti inequivocabilmente
un lascito esperienziale della vita militare del
periodo borbonico, sapientemente adattato
alla situazione inedita della guerriglia, grazie
anche all’adozione di elementi di un sapere militare radicalmente diverso, quello del
brigantaggio endemico preunitario e, sotto
il profilo ideologico e della pratica militare,
quanto ancora rimaneva nella memoria collettiva dell’eredità della controrivoluzione
sanfedista degli anni 1799-1800 e della resistenza all’occupazione francese del decennio
napoleonico. Al tempo stesso, a queste componenti di legittimismo, xenofobia e sanfedismo il brigantaggio postunitario aggiunge
un elemento nuovo, nel suo essere antiunitario e antipiemontese per difendere la nazione napoletana dall’invasione straniera, come
prima l’aveva difesa dai francesi.
Certamente i contadini in rivolta assunsero alcune modalità di comportamenti
illegali e di lotta violenta in parte mutuati
dal brigantaggio endemico, che era l’unica
esperienza militare assolutamente originale e autonoma che contadini e pastori
conoscessero. Era naturale perciò che essi
assumessero alcuni tratti del loro codice
non scritto di guerra (tecniche e tattiche di
combattimento, modalità di finanziamento
mediante sequestri, razzie, ricatti, rappresaglie, punizioni, esecuzioni, ecc.): sono
comuni ai due fenomeni il brigantaggio
stagionale e, più in generale, la tendenza a
praticarlo temporaneamente, occasionalmente o per necessità; alcuni aspetti tattici,
come disaggregarsi in momenti difficili per
riaggregarsi per nuove scorrerie in momenti migliori; sconfinare in altri territori
per sfuggire a inseguimenti e persecuzioni;
l’esistenza di cacciatori di teste e di “pentiti”; la pratica dei sequestri; alcune forme di
rappresaglia, come bruciare i raccolti, fare
strage di animali ecc.
Alle soglie dell’età contemporanea, che
vede le masse popolari irrompere nella storia, il brigantaggio endemico diventa brigantaggio di massa, con il coinvolgimento
di vaste categorie sociali: contadini senza
terra, pastori e, in minor numero, artigiani,
95
Q
uaderni
passando, in Italia, prima attraverso l’esperienza sanfedista del 1799 e poi della guerriglia antifrancese del periodo napoleonico.
La prima trasformazione avviene tra la fine
del Settecento e i primi anni dell’Ottocento, pilotata dagli aristocratici legittimisti,
plasmata ideologicamente dal clero reazionario, incoraggiata e favorita dagli inglesi,
alimentata dal patriottismo xenofobo e dalla
difesa della vita tradizionale e della religione (trono e altare) nonché dal mito e dal
sentimento palingenetico della “resurrezione dei poverelli”. Tra il 1821 e il 1848 i più
modesti e frammentati movimenti di massa sono fondamentalmente moti contadini
per la rivendicazione e l’occupazione delle
terre comuni, sostenuti anche dalla piccola
borghesia e solo in alcuni casi confusi con
il brigantaggio, anche se nelle rappresentazioni ufficiali vengono frequentemente fatti
passare per tali, solo perché sono considerati
fuori della legalità. Il brigantaggio postunitario degli anni 1861-70 è un movimento di
massa con elementi nuovi e originali e una
struttura complessa. In sostanza si tratta
delle agitazioni contadine che, fondendosi
con la resistenza all’occupazione “piemontese” ed estendendosi geograficamente e
ingrossandosi a dismisura, si confondono o
assorbono il brigantaggio tradizionale, che
storicamente conduceva un’esistenza almeno in parte separata, parallela e marginale
rispetto al mondo contadino, che non si era
mai confuso interamente con esso.
Le bande sono però organizzate e guidate
in moltissimi casi da ex soldati ed ex sottufficiali del disciolto esercito borbonico, che
portano nelle bande brigantesche una solida
1
96
Bura: 29.
esperienza militare di diversa ispirazione,
insieme a un sistema di convinzioni e comportamenti (onore e fedeltà alla monarchia
borbonica, disciplina, rispetto della gerarchia, coscienza nazionale meridionale, ecc.)
che erano il frutto dell’indottrinamento militare. In altri termini, molti dei principali e
più brillanti capi della guerriglia provenivano
dai ranghi dell’esercito borbonico, in cui avevano militato con una ferma di parecchi anni
come soldati, raggiungendo anche il grado di
sottufficiali. Sergente era diventato Pasquale
Romano, pastore di Gioia del Colle: nell’esercito aveva completato la sua formazione
nell’arco di un decennio, imparando a leggere e scrivere e meritandosi il diritto di essere
l’alfiere della I compagnia del V di linea1.
Capi carismatici e gregari
Le piccole bande avevano quasi sempre
soltanto un capo, e, a volte, un vice; quelle
più grandi, intorno ai cento uomini, presentavano di solito una struttura gerarchica,
con gradi e funzioni segnalate dalla divisa
o da segni particolari. Ecco come una brigantessa descrive la gerarchia della banda
Cannone: “Cannone ha assunto il grado di
capitano e porta un frisio d’argento, un altro
brigante a nome Antonio Prefeta di Atessa
è sergente, un terzo a nome Filippo de Martino di Pagliata è caporale, e questi due non
portano alcun segno. Policarpo Romagnoli
ha il grado di tenente e porta il berretto da
militare con due frisi d’oro, e veste gli abiti
dell’ufficiale ucciso a Casalcassinese”. Non
tutti i capi avevano bisogno di titoli e segni
antropologia e storia
di distinzione: nella stessa area geografica
“Fuoco si fa chiamare fra’ Diavolo e non
ha gradi, così Cedrone e gli altri”2. Il tipo di
struttura gerarchica che i briganti si davano
mostra come essi tendessero ad organizzarsi prendendo a modello l’esercito, ispirati e
facilitati in questo dal fatto che alcuni di essi
erano ex ufficiali o ex soldati borbonici. La
tendenza gregaria non era però soltanto un
lascito del servizio militare: era anche il prodotto della struttura sociale, che plasmava
la famiglia e la totalità dei rapporti sociali.
Grandi bande erano, nel Meridione, quelle
di Crocco e del Sergente Romano. Quando
raccoglieva i suoi 2.000 uomini con 300 cavalieri, Crocco poneva a capo di ogni drappello di 200 uomini un capitano, che aveva
alle sue dipendenze sottocapi e sergenti
maggiori; ogni gruppo minimo di 10 uomini
aveva un caporale3. Quanto ai rapporti con
i vertici borbonici, anche quando dichiaravano di dipendere dai loro generali, i capi
delle grandi aggregazioni, come Crocco e il
Sergente Romano erano di fatto totalmente
autonomi.
La selezione dei capi avveniva in maniera naturale, sulla base di meriti riconosciuti da tutta la banda. Il merito principale
era quello di condurre la banda al successo,
conseguire dei risultati sul campo, procurare bottino e vettovaglie. E in una situazione
difficile, segnata dall’aleatorietà delle prospettive e dei progetti di lunga durata, in cui
gli uomini aspirano innanzitutto a sopravvivere, il capo deve avere le qualità giuste
2
5
3
4
/ 2 – comicità e politica
per assicurare alla banda la sopravvivenza.
Di solito queste capacità le possiedono i briganti più intelligenti (soprattutto astuti) e
più forti, avveduti e decisi, tali “per istinto,
ma anche per capacità innate, affinate nel
corso della lotta”4, ma anche per l’arte della
guerra che, in veste di militari e sottufficiali
avevano acquisito nell’esercito borbonico.
La fisiognomica del capo è mutevole.
Meglio se è un soggetto forzuto, aitante, dalla statura imponente, ma sono esistiti capi
con difetti fisici e menomazioni. Questo
significa che le qualità del capo che contano vanno al di là della prestanza fisica, e si
fondano piuttosto sull’intelligenza, l’astuzia,
l’esperienza e la durezza al momento giusto.
Il capobanda ha una centralità assoluta
nella comitiva brigantesca: è lui che di solito fonda la banda, o ne eredita il comando
quando il capo viene ucciso, sempre che gli
altri lo riconoscano come tale; è da lui che
i gregari si attendono di essere ben guidati;
che prenda le decisioni giuste e sia al tempo
stesso coraggioso, forte e spietato; che curi
i rapporti della banda con l’esterno: manutengoli, alleati, mediatori nei sequestri, negoziatori, messaggeri, capi militari, autorità
civili ecc. Non diversamente nel Nordest del
Brasile Limpião “aveva rapporti ed affari
personali con ‘colonnelli’ e uomini politici,
affari che conduceva privatamente e di cui
nessuno, neppure i suoi più fidi, era a conoscenza”5. Al capo spetta la conduzione
della guerra, che richiede ovviamente capacità tattiche e strategiche. Egli ha un potere
ASI, Sottoprefettura d’ Isernia, Atti di Polizia, Brigantaggio 1867, gennaio-dicembre, b 6, fasc. Brigantaggio del
mese di aprile 1867.
Cro2: 81.
Croci: 22.
Fio: 23.
97
Q
uaderni
notevole, ma non deve abusarne, perché sa
che non sarebbe seguito dai suoi gregari, ma
soprattutto non deve sbagliare, perché i suoi
non glielo perdonerebbero. Spetta al capo
gestire i sequestri nel modo migliore: deve
scegliere le persone giuste da sequestrare,
fissare i turni di guardia delle sentinelle, far
lavorare i gregari alla costruzione di capanne e giacigli per la notte, stabilire chi deve
provvedere a trovare l’acqua, chi invece deve
essere mandato a procurare il cibo; deve saper governare le tensioni, frenare le risse.
I capibanda maggiori dovevano il loro
succcesso alle loro capacità militari associate
quasi sempre alla paura che destavano di sé,
ma anche al loro carisma. Non è facile per
noi farlo emergere da carte che non parlano,
dal momento che la parola e la voce sono ingredienti fondamentali della comunicazione carismatica. Weber ha aperto una strada
alla comprensione del fenomeno: il carisma
è “una certa qualità della personalità di un
individuo, in virtù della quale egli si eleva
sugli uomini comuni ed è trattato come uno
dotato di poteri o qualità soprannaturali,
sovrumane, o quanto meglio specificamente eccezionali. Questi requisiti sono tali in
quanto non accessibili alle persone normali, ma vengono considerati di origine divina o esemplari, così come basati sui poteri
magici”6. Si rappresentano i capi carismatici
come figure forti, imponenti, virili. Questa
era l’immagine che Crocco suggeriva di sé,
e in questo caso la rappresentazione era in
gran parte specchio della realtà. In molti casi
però i capi erano immaginati e perfino visti
così, senza esserlo veramente. I capi poteva-
6
7
98
Web: 181.
Hob2: 50; cfr. Tur; Lindh.
no perfino essere bassi, balbuzienti, fragili o
con qualche menomazione. Il carisma nasceva allora dalla loro capacità di trasformare nell’immaginario collettivo la mancanza
in eccedenza, col supporto delle credenze
popolari, che attribuiscono poteri magici
alle persone segnate da difetti e menomazioni. Il che avveniva quando riuscivano ad
avere successo per la loro intelligenza, il coraggio, la tenacia, la determinazione. Inoltre
la loro condizione di debolezza e di sofferenza li rendeva simili alla media degli uomini,
i quali si identificavano con loro, perché essi
trasmettevano alle persone comuni la possibilità di cambiare il loro destino o almeno di
condividere un sogno. Il mito getta luce su
queste realtà: il brigante Angiolillo era immaginato orfano, il che faceva scattare meccanismi di identificazione, che consentivano
alle classi oppresse di vivere, attraverso la
storia del personaggio, una vicenda di umiliazione e di riscatto. Il lucano Ninco Nanco
era balbuziente, ma questo non gli impedì
di diventare un abilissimo stratega e un comandante di successo, riconosciuto come
tale dallo stesso Crocco e da tutti i suoi: il
suo successo era opera della sua astuzia,
ma nel contesto culturale in cui operava si
riteneva che le doti eccezionali fossero una
prova del favore divino, il che conferiva un
carattere carismatico ai suoi poteri. Sotto
questo aspetto i briganti dell’epos non sono
diversi dai briganti reali. Se essi appaiono deboli o addirittura inadeguati, la logica implicita è che “il Signore ha voluto che
chiunque sia povero, umile e intimorito può
fare grandi cose, se Dio così vuole”7. Insom-
antropologia e storia
ma l’aspetto seducente di queste situazioni
vissute o narrate era che anche gli uomini
comuni, col loro carico di debolezze e paure,
sono capaci di grandi cose, di ribellarsi e riportare vittorie8. Non sempre il carisma nasce ed opera spontaneamente, perché il più
della volte è un’abile costruzione del leader,
prodotta dalla sua capacità di trasmettere e
far condividere il suo sogno; ma è anche una
costruzione dei suoi seguaci, per i quali il
capo carismatico è “uno di noi”, che sa coinvolgerli nel fascino di un’avventura, in cui
investono speranze e illusioni.
Il capo aveva alcuni dei privilegi che
spettano alle autorità, per esempio non fare
cose troppo ordinarie o di routine, come fare
la guardia di notte. Nella banda di Manzo
questa che era la decisione di un momento
diventò per volontà di tutta la banda una
regola9. Esistevano altri segni di distinzione,
che concernevano il cibo, il vestiario, e altro:
il capobanda Barone e Luisa Mollo, che comandavano un centinaio di uomini, mangiavano in piatti d’argento i pasti raffinati che
mandavano i manutengoli10. Erano, questi,
vantaggi materiali, che avevano una forte
pregnanza simbolica. Più intenzionalmente
il capo ostenta il suo potere attraverso altri
segni e simboli: oltre gli ori e i gioielli, si dota
di armi particolarmente efficaci e di pregio.
Chiavone “nella fusciacca teneva un grosso
revolver a sei colpi ed una delle sue guide lo
seguiva dappertutto con una magnifica dop-
8
9
12
13
14
15
10
11
/ 2 – comicità e politica
pietta intarsiata, di cui una canna era caricata
a palle e l’altra con schegge di piombo11.
Nelle bande numerose come quelle di
Crocco e del Sergente Romano c’era il Consiglio dei capi12. Nelle riunioni prevaleva la
maggioranza. In genere il capo fa in modo
che si discuta anche intensamente, ma minaccia di sciogliere la seduta quando la discussione rischia di degenerare in rissa13. Il
capo è di solito responsabile e cosciente dei
suoi doveri: nei momenti particolarmente
importanti, come la programmazione di un
sequestro, la decisione di mutilare i sequestrati ecc., egli convoca il Consiglio, formato dalla totalità della banda, che si svolge in
modo formale e regolare14. Dopo la presa di
Stigliano, Crocco, davanti al rischio di un
movimento avvolgente della truppa e dei
militi cittadini convoca i vertici dell’esercito: “Si tiene consiglio tra i capi e prevale
l’idea di evitare lo scontro guadagnando la
boscaglia della montagna”. Crocco consultava di preferenza gli ex ufficiali e sottufficiali dell’esercito borbonico diventati briganti.
Nella più complessa delle sue operazioni
militari, dopo aver fortificata Toppacivita,
egli sceglie di consigliarsi, tra i capi, “col
vecchio capitano Antonio Bosco, col luogotenente Francesco N., col sottotenente Luigi
Siciliano e coi vecchi sottufficiali dell’esercito borbonico”, e da essi ha la conferma
che le proprie posizioni “erano formidabili”15. Il capobanda calabrese Pietro Bianco,
Sca2: 110.
Fri2: 144.45.
Cimm: 84.
Zimm: 69.
Cro2: 117; Luc2: 42.
DBia: 193.
DBia: 193.
Cro2: 117, 81.
99
Q
uaderni
prima di andare a trovare la sua Generosa,
consapevole del fatto che la sua cattura o uccisione sarebbe una perdita grave per i suoi
compagni, ritiene doveroso riunirli e informarli delle sue intenzioni16: la situazione è
un po’ ambigua, perché non si capisce bene
se egli comunica decisioni già prese, o attende l’assenso, sia pure non convinto, dei suoi
compagni: ma conta il fatto che ritenga suo
dovere ascoltarli.
Crocco sostenne in tribunale di essere stato agli ordini del francese Langlois, e
che soltanto dopo la sua partenza assunse,
per ordine suo, il comando del più vasto
conglomerato di bande lucane. In realtà il
capobanda, nel corso del processo, per alleggerire le sue responsabilità soprattutto
in relazione agli eccessi e alle efferatezze dei
capibanda, aveva accentuato per un verso
la sua dipendenza da Langlois, per un altro
l’indipendenza nei suoi confronti delle numerose bande che lo riconoscevano come
capo dei capi. Quarantatrè bande medie e
medio-piccole riconoscevano in lui il loro
capo supremo. Non esisteva alcun legame
formale tra queste formazioni, oltre la possibilità, ampiamente sfruttata da Crocco, di
libere aggregazioni in vista di operazioni
particolarmente importanti. Al processo il
capo dei capi dichiarò che egli, finché rimase agli ordini di Langlois, non comandava
alcuna banda, ma “era in relazione con tutti
i capi”. In realtà, Crocco aveva anche un nucleo di persone che dipendeva direttamente
da lui: “Fra le varie bande che infestavano la
Basilicata, posso affermare senza tema di essere smentito, che la mia era la più ordinata
e la meglio organizzata”. Questa banda peSca1:159.
Cro2: 162, 138, 178.
16
17
100
riodicamente si ingrossava grazie all’aggregazione di una parte, ogni volta mutevole,
delle quarantatrè bande, i cui capi normalmente obbedivano ai suoi ordini: “Coppa,
Ninco Nanco, Caruso, Tortora, Serravalle
e molti altri che ebbero il comando di bande, furono tutti miei dipendenti, ed ebbero
in seguito sempre un sentimento di rispetto
per il loro generale”. Il rapporto delle comitive con Crocco era fondamentalmente di
tipo carismatico, e si alimentava nei casi più
importanti di una profonda e salda amicizia
e stima, con cui teneva stretti a sé i luogotenenti. Grandi amicizie furono soprattutto quelle che lo legavano a Ninco Nanco,
Coppa, Schiavone, Sacchetiello, Michele
Caruso. Per Crocco il capo deve al tempo
stesso “farsi amare, ubbidire e temere”, lasciando ai subordinati larga autonomia,
e al tempo stesso pretendere il rispetto di
poche regole ineludibili. Era questo lo stile
del comandante Crocco: “I miei gregari mi
amavano e mi ubbidivano senza bisogno di
mezzi coercitivi, qualche severo esempio,
dovuto dare per disciplinare le orde, mi fu
strappato direi quasi a forza dalla necessità
del momento, ma fui sempre con tutti affabile ed amico, anziché superiore. Ogni mio
desiderio era ordine per i miei gregari”. Al
processo Crocco insistette più del giusto
sull’autonomia dei suoi luogotenenti, per
prendere le distanze dalle loro efferatezze.
Lo fece anche con Ninco Nanco, che amava profondamente. Accusato di avere ucciso
Salvatore Mongelli, attribuì questo delitto
al suo luogotenente, aggiungendo: Ninco
Nanco “non prese, né era solito prendere da
me gli ordini, quando voleva esercitare qual-
antropologia e storia
che vendetta”17. Riconobbe tuttavia di avere
trasmesso il suo stile di comando a Ninco
Nanco e a suo fratello, che egli considerva
suoi allievi: “Voi avete saputo il sito dove
nacquero questi due fratelli, da chi avevano essi apprese l’arte di comandare uomini,
farsi amare, ubbidire, e temere, dove attinsero queste tre sublimi virtù, tanto difficile a
godersi, quanto difficile a possedersi, eppure
uno rozzo contadino, senza conoscere neanche la z, tartaglione, rozzo, e selvaggio, era
temuto ubbidite ed amate da una banda formidabile, cui riponeva la fiducia in lui per la
loro salvezza e non restavano mai delusi”18.
Disciplina
Tutti i militari riconobbero che “la disciplina che regnava nelle bande era ferrea,
basata soprattutto sul prestigio personale e
sul timore che ispirava il capo e che da essi
‘veniva mantenuta mediante un continuo
sistema di terrore’19, fondato, secondo lo
stesso generale Pallavicini, su “esemplari repressioni”20. Non tutti e non sempre i capibanda fondavano il loro potere sul terrore.
Più frequentemente questo accadeva nelle
piccole bande, isolate ed esposte alla deriva
criminale. La sapienza dei capi era anche nella capacità di modulare il rigore sulla maggiore o minore gravità delle trasgressioni,
disobbedienze o irregolarità. La regola era
quella ereditata dai romani: “de minimis non
curat pretor”. Questo valeva soprattutto per
chi era a capo di grandi bande, più responsa-
20
21
18
19
/ 2 – comicità e politica
bilizzato a tenere conto della diversità delle
situazioni. Anche in questo Crocco era un
maestro, mentre i suoi luogotenenti si distinsero soprattutto per valore, capacità militari
e ferocia: “Padrone di un paese – egli narra
– imponevo ai ricchi onerose taglie impensabili pel vettovagliamento dei miei uomini, né
pretendevo di più; non avevo per altro tanta
autorità sui numerosissimi compagni da imporre ad ognuno il rispetto della proprietà e
della famiglia, onde più di una volta è successo che i signori, dopo aver dato a me la metà
dei loro averi, dovettero dare l’altra metà ai
sottocapi, e vedersi per di più violate le donne senza poter reagire, pena la vita”. Dunque, una indulgenza senza condivisione, non
infrequente nella storia degli abusi militari di
tutti i tempi. Crocco cercherà poi di giustificarsi, a spese dei suoi stimati compagni: “Io
ero alla testa di uomini che appartenevano
alla feccia della società. Io dunque non potevo frenare il loro istinto di commettere furti
e rapine senza badare al colore politico delle
persone che venivano depredate”21.
Per tutti però il mantenimento dell’ordine era una priorità assoluta, da perseguire con durezza e determinazione, anche
brutale. Le pene, anche estreme, erano lo
strumento più efficace. Il colonnello Caruso
puniva con la morte chi non eseguiva i suoi
ordini o esitava a farlo. Eseguiva lui stesso
la sentenza, perché le regole di guerra imponevano che fossero i capi a farlo. Non era
il solo. Nel regolamento trovato addosso al
capobanda Andreozzi si legge: “Durante il
combattimento qualunque atto d’insubordi-
Cro4: 68-69.
Bour: 68-69.
Molfese in Desi: 827.
Cro2: 108; Appendice, 166.
101
Q
uaderni
nazione o disobbedienza deve essere punito
dal capobanda in persona con una schioppettata o pistolettata nella testa”22. A differenza di Caruso, davanti alle disobbedienze
Ninco Nanco “dissimulava, ma non tardava
a trovare un’occasione propizia per punire
chi gli aveva disobbedito o in qualunque
modo mancato”. Coppa fece fucilare suo
fratello, colpevole di avere saccheggiato una
masseria di sua iniziativa23. Barone faceva
fucilare chi si rifiutava di prendere parte alle
operazioni di guerra o di razzia24. Manzo,
che non commise altri omicidi, fece fucilare
un gregario che si era rifiutato di eseguire un
suo ordine, e i suoi briganti erano convinti che lo avrebbe fatto ancora. Questo però
prova solo il timore che i gregari avevano di
Manzo, perché normalmente “chi non taceva quando arrivava l’ordine, incassava solo
una bastonata”25.
Era punita con la morte la defezione o
semplicemente chi pensava di farla, perché
chi lasciava la banda diventava pericoloso per
la banda stessa, potendo diventare collaboratore delle forze dell’ordine e fornire ad esse
informazioni preziose. Chiavone fece fucilare Basile, capo di una banda minore di Campobasso, aggregata alla sua comitiva, perché
aveva deciso di abbandonare insieme ai suoi
uomini la truppa brigantesca, non sopportando di stare “sotto un comandante vigliacco ed incapace”26. Negli ultimi tempi della
24
25
26
27
28
29
30
22
23
102
In Barto: 56-57.
Bour: 95.
BaB1:19, 21-22; Cimm: 79.
Moe3: 112.
Zimm: 123-124.
Bour: 95.
Luc2: 41.
Fri2: 172.
Cro2: Appendice, 188.
sua vita alla macchia Ninco Nanco capì che
alcuni della banda tramavano per costituirsi
alle autorità, ma finse di non saperlo, finché
qualche giorno dopo con i suoi uomini più
fedeli li uccise durante il riposo27. La specificità di alcune situazioni complesse poteva
comportare delle deroghe a questa pratica: il
Sergente Romano convocò il Consiglio dei
capi per condannare a morte tre fratelli briganti per avere sparato senza autorizzazione
a un giovane che tentava di abbandonare la
banda28. Nella comitiva di Manzo i briganti maltrattano sistematicamente Guancio;
dopo avere a lungo sopportato, la vittima
minaccia di volere andar via e costituirsi. I
compagni minacciano di ucciderlo, lo trattengono e lo pestano29. I codardi erano puniti con la morte nelle formazioni del Sergente
Romano. Di solito anche il furto all’interno
della banda era punito con la pena capitale.
Nella banda di Crocco due prostitute andandosene avevano rubato un portamoneta,
i briganti le raggiunsero e, dopo che esse lo
ebbero restituito, le uccisero30.
Il capo che non rispetta le regole, che
nelle bande piccole e medie prevedono l’eguale ripartizione del denaro, dei beni e del
cibo, può essere deposto, di solito senza
drammi eccessivi: è capitato a Cerino, capo
di una banda di una dozzina di uomini del
salernitano, che fu deposto per avere favorito nella spartizione del cibo la sua donna e se
antropologia e storia
stesso31. Poteva essere deposto anche il capo
che pensava in maniera troppo diversa dalla
sua banda, a giudizio dei più, sbagliando. A
Pontelandolfo, poco tempo prima della distruzione compiuta dall’esercito, “le bande
là radunate, sospettando del Pica, ch’aveano
saputo facesse fuggire i liberali, lo deposero;
poi garrirono pel comando: chi vuole Cosmo Giordano, chi Leone, ambi ex sergenti;
questi è ferito, e si ritira, quegli resta; ma i
più scontenti si vanno diradando, e ritraggonsi al Matese”32. Quando si rivelavano incapaci, i capi potevano essere perfino uccisi.
Se non accadeva spesso, dipendeva dal fatto
che la selezione naturale, da cui essi emergevano, era rigorosissima: ne andava della vita
di tutti. Quando la disciplina all’interno della banda si allentava, era segno che il potere
del capo cominciava ad entrare in crisi ed il
suo declino lo esponeva al rischio del declassamento, della deposizione o dell’uccisione.
Come accadde in una squadra della banda
di Cosimo Giordano, in cui i “frequenti contatti con altri capibanda, ammirati per l’ordine e la tempestività con cui sottraggono le
comitive all’inseguimento della truppa, sminuiscono il prestigio del caposquadra Gennaro Puzella di Paupisi, che viene ucciso dai
suoi stessi gregari il 12 settembre 1862, nella
convinzione che per incapacità di condurli
in salvo attraverso i monti, possa farli cadere
in mano dei piemontesi”33.
Michelangelo Fortunato (Coppa), quando era gregario di Giuseppe Girardi, si di-
/ 2 – comicità e politica
chiarò contrario alla decisione del capobanda di eliminare un contadino di Muro.
Girardi cercò di ucciderlo, ma Coppa fu più
pronto di lui e lo stese al suolo34. L’episodio
dimostra che c’era comunque un limite al
potere del capo, che ci si poteva opporre alle
sentenze, quando fossero ritenute ingiuste.
Nei casi più gravi era inevitabile la sfida tra il
capo e il ribelle, e il duello funzionava come
un arcaico giudizio di Dio, perché la banda
accettava il vincitore, anche perché era garantita dal fatto che, per avere ucciso lealmente un comandante, egli stesso doveva
essere all’altezza di un capo. Si confermava
insomma il modo di pensare tradizionale,
sia pure in forma retroattiva, secondo cui
solo un (potenziale) capo può uccidere un
capo. Nel Cilento il capobanda Tranchella,
per ragioni che ci sfuggono, aiutato da due
gregari uccise due capibanda35.
Le situazioni di crisi potevano essere
all’origine di altre situazioni pericolosamente sfavorevoli ai capi: per esempio, la volontà di alcuni della banda di consegnarsi alle
autorità. Come abbiamo visto, in questi casi
c’era da aspettarsi o che il capobanda uccidesse i gregari, come pare richiedesse il codice non scritto delle bande, o che i gregari
eliminassero il capo per poi presentarsi con
un altro titolo di merito alle autorità. Sembra questo il caso di Giuseppe Mele, che il
20 febbraio 1864 si consegnò in Avigliano,
dopo avere ucciso il capobanda Andreozzi e
un suo gregario36.
Moe3: 94, 212.
DeSi: 74.
33
Sang: 316; Museo Biblioteca Archivio Storico del Sannio, Benevento, Elenco nominativo dei briganti fucilati o
uccisi in conflitto, Cerreto, Brigantaggio 1862.
34
ACS, Tribunale Militare per la repressione del Brigantaggio nelle Province Meridionali, c. 158 - 52.
35
Fri2: 117.
36
Bour: 220.
31
32
103
Q
uaderni
Fuori da queste logiche rimane il caso
dell’omicidio su commissione, eseguito da
briganti traditori al soldo delle autorità o dei
proprietari, che spesso erano manutengoli
pentiti. Due gregari prezzolati dall’esercito
uccisero il capobanda silano Pietro Monaco
e ferirono al braccio sua moglie, la brigantessa Maria Oliverio37. Il capobanda abruzzese
Domenico Di Sciascio fu ucciso sulla Maiella
da un colpo di pistola all’orecchio. Lo uccise
mentre riposava, per intascare la taglia, uno
della sua banda38. Queste uccisioni facevano
orrore nella banda. L’attentato alla vita del
capo per impadronirsi dei suoi beni o per intascare la taglia o il denaro promesso dai nemici era un’azione delittuosa da punire con la
morte: quando tre briganti della piccola banda
di Rosario Nunziante, attiva nel bosco di Persano, si aggregarono alla banda Manzo, “nella
comitiva si diffuse il sospetto, non del tutto
infondato, che i nuovi arrivati avessero ucciso il loro capo per depredarlo delle sue cose.
Rimase sempre un sospetto, perché se Manzo
si fosse convinto che essi si erano macchiati
di un simile delitto, nel rispetto della legge dei
briganti, li avrebbe senz’altro uccisi”39.
Conclusivamente, quello delle bande
era una sorta di egalitarismo di guerra, non
necessariamente eretto a filosofia di vita. La
controsocietà dei briganti mutuava, tra l’altro, dalla società regolare il rispetto delle differenze sociali: tra i sequestrati della banda
Manzo a quelli che “erano conosciuti come
impiegati della fabbrica, e perciò non erano
visti come galantuomini, né trattati come
39
40
41
37
38
104
tali, non gli veniva dato neanche il titolo di
don, bensì venivano chiamati semplicemente
col nome di battesimo; essi dovevano anche
collaborare alla costruzione delle capanne
ed alimentare il fuoco, procurare legna e
neve ecc.”: obblighi dai quali erano esentati
i sequestrati ritenuti nobili. Le decisioni fondamentali della banda venivano comunque
prese collettivamente. Per esempio, quando
non veniva pagato per intero il riscatto, gli
ostaggi potevano essere liberati soltanto per
decisione unanime di tutta la banda40. Solo il
merito differenziava i membri della comitiva,
ma non costituiva una ragione per accumulare privilegi, era però la condizione per salire
nella gerarchia militare di un piccolo esercito che nel suo interesse premiava le persone più capaci di assicurare la sopravvivenza
della banda. Il familismo era presente, ed era
accettato, perché i legami familiari compattavano il gruppo, ma non potevano essere lo
strumento per acquisire riconoscimenti non
meritati: il prestigio di Barone nella banda era
indebolito dal fatto che favoriva due persone
incapaci, soltanto perché erano il padre e il
fratello della sua amante Luisa Mollo41.
II. La vita alla macchia
Uomini e lupi
I briganti si autorappresentavano come
lupi, secondo una immagine diffusa tra pastori e contadini. Il prestigio di cui essi go-
AUSSME, Divisione Militare Territoriale di Catanzaro, cc. 1-54.
Archivio di Stato di Lanciano, in Mont: 85, 132.
Lich: 91, n. 44.
Lich: 59, 72.
Cimm: 68.
antropologia e storia
devano nasceva anche dal fatto che “usavano tali vendette da far drizzare i capelli sul
capo ai più intrepidi”, e anche per questo
erano “riguardati come esseri superiori e
con superstizioso terrore”42. Era il potere di
garantire la vita o dare la morte. Era l’omicidio spaventoso, nella sua valenza arcaica
di violazione del tabù del sangue, a rendere
soprannaturale, “fatato” il brigante.
Esisteva una complessa mitologia sul
lupo nella cultura folklorica. Per i briganti
incontrare un lupo è segno di buona fortuna, perché essi “si considerano paragonabili
ai lupi”. Era, insomma, una epifania totemica. Quando briganti e sequestrati della banda
Manzo ne vedono uno, battezzano il luogo,
“nel loro barbaro dialetto”, Lup’ a lup’, ossia
“lupo a lupo”43. L’identificazione simbolica è
confermata dal fatto che quando si chiamano
tra loro, senza farsi capire dai nemici, i briganti imitano l’ululato del lupo44. Quando ritornano nel loro rifugio ripetono: “Ce ne siamo tornati al nostro palazzo di frasche, quello
dei lupi”45. Ma tutta la vita del brigante è un
doppio della vita del lupo:
A vita de u lupu vogliu hare,
giacché ccussì bò lla sorta mia!
U iuornu mi nde vaiu a mme mboscare,
lla notte mi nde vaiu ppe lla via:
hazzu a guardia duv’ è lu pecuraru,
mu me scarta n’aniglia a boglia mia,
e si ppe casu abbaianu li cani,
iettu nu sautu e mme truovu a la via46.
44
45
46
47
48
42
43
/ 2 – comicità e politica
(“Voglio fare la vita del lupo/ perché così vuole il
mio destino./ Il giorno mi nascondo nel bosco, /
la notte me ne vado per la strada; / sorveglio dove
sta il pecoraio, / che mi scelga un agnello a piacer
mio, / e se per caso abbaiano i cani, / faccio un
salto e mi trovo sulla strada”)
Nell’immaginario contadino e pastorale
la vita del lupo è legata sia all’idea del branco,
che a quella della solitudine; in quest’ultimo
caso il brigante è un “lupo solarino”, ossia
solitario47. All’epoca del grande brigantaggio domina incontrastato nei boschi il branco; ma il lupo solitario ha lasciato un segno
che ancora dura. In tutto il folklore europeo
l’immagine del lupo è ambivalente: come il
brigante, è un maledetto, incarnazione del
disordine e dell’asocialità, ma al tempo stesso
è una figura d’eccezione, tanto forte da vivere
libero dai vincoli e dalle ristrettezze sociali.
Rappresenta lo stato selvaggio, di cui conserva la forza e la destrezza; per questo è temuto
e ammirato. Sognare un lupo è di buon augurio. In quanto portatore di fortuna, il lupo è
un animale sacro e nelle tradizioni popolari
anche il brigante, come il suo totem, è figura magica, capace di prodigi48. I fuggiaschi
e i proscritti erano dai popoli indoeuropei
chiamati lupi. Ancora nelle leggi di Edoardo
il Confessore, intorno al 1000 d.C., si stabilisce che il proscritto deve portare una maschera di lupo. Nel mondo classico questa
connotazione animalesca è presente, come
attributo, nelle divinità protettrici degli esi-
Bart: 47.
Moe3: 190-91.
Moe3: 121.
GiG2: 22.
In Sca1: 138.
DiG2: 12, 22, 30.
Sca2: 60-64.
105
Q
uaderni
liati49. Le divinità che proteggevano gli esiliati
e i fuorusciti avevano gli attributi del lupo,
come Zeus Lucreio e Apollo Liceo. Come
Gengis Kan, dai lupi i briganti, soprattutto i
briganti pastori, hanno imparato l’arte di vivere, di predare e di combattere. Gli uni e gli
altri sono guerrieri dignitosi, che si nutrono
con le loro forze. Sono pazienti, organizzati,
intelligenti. Aspettano che le loro prede si
gonfino mangiando, così si appesantiscono.
Ma sanno sempre aspettare il momento giusto. La donna mongola è un lupo, forse anche
le brigantesse, e lo erano, in genere, le donne
forti e ribelli.
Dai lupi i briganti sembrano avere imparato molti comportamenti, a cominciare
dal forte senso di appartenenza che fa loro
preferire nella predazione e nell’attacco il
lavoro di squadra. Grandissima l’attenzione per i cuccioli. I lupi hanno due tane: in
caso di pericolo mettono al sicuro i loro
cuccioli in una di esse e si fanno inseguire nella seconda tana. Se si uccidono i loro
cuccioli, i lupi diventano furiosi, e attaccheranno con maggiore violenza. Reagivano in
questo modo soprattutto le brigantesse. Se
si fa prigioniero un cucciolo, i lupi andranno a liberarlo, se lo riconoscono come loro;
se non sa cacciare come loro, perché è cresciuto cogli uomini, non lo riconoscono e
lo uccidono. Analogamente i briganti sono
spietati con i compagni e i paesani passati
dall’altra parte.
Il lupo è molto legato anche alla sua compagna: le forze dell’ordine sapevano che, se
vuoi il brigante, devi prendere la sua donna,
come i cacciatori fanno con la compagna del
lupo, perché presto verrà a cercarla. Molto
Eli2: 12.
49
106
altro i briganti hanno imparato dai lupi: la
loro tana ha spesso due uscite come quella
dei lupi, e, come i lupi, entrano nel loro rifugio strisciando. Esistono i sentieri dei lupi,
come esistono i sentieri dei briganti: lupi e
briganti non si muovono mai a zig zag.
Il lupo e l’Altro
Chi ha conosciuto veramente i briganti,
a parte i militari, che li hanno combattuti,
uccisi, carcerati, sorvegliati, deportati? Oltre
le loro donne brigantesse, i soli che siano
vissuti per settimane, mesi e perfino anni
con i briganti allo stato libero, condividendo
con loro difficoltà, pericoli, malattie, digiuni,
spazi angusti, fughe interminabili, nascondigli, sudiciume, orge alimentari improvvise e
insperate, furono i sequestrati. Una singolare convivenza forzosa di due opposte condizioni umane, quella dei carcerieri e dei carcerati, che ribaltava radicalmente le normali
condizioni dell’esistenza, che vuole i primi
tra gli oppressori e i secondi tra gli oppressi;
ma anche di opposte culture, che in alcuni
casi vedeva convivere e confrontarsi la cultura dei briganti meridionali e quella degli
stranieri, inglesi, svizzeri, tedeschi, francesi.
I sequestri furono perciò un incontro estremamente ravvicinato di culture, che, nonostante la situazione eccezionale di coazione
in cui l’incontro avvenne, approdò a forme
di conoscenza reciproca, che fanno di questi
episodi della guerriglia brigantesca delle vicende esemplari e delle fonti preziose.
Per il sequestrato Friedli, che ebbe tutto il tempo di studiare sul terreno la banda
antropologia e storia
Manzo, “in genere si deve riconoscere ad
alcuni di questi briganti una certa bellezza
romantica”. Manzo “è un uomo di statura
media piuttosto che piccola, quasi snello,
ma con un largo petto completamente sviluppato; già da lontano si può scorgere l’agilità della sua figura fisica; la sua testa mostra
quasi un profilo greco; il naso elegantemente
scolpito, ma forte, è un po’ curvo; la fronte
è quasi piccola, le grosse sopracciglia curve;
i begli occhi marroni, il cui sguardo appare
molto penetrante, hanno perduto in seguito
alla sua vita di brigante la nobile pace; una
meravigliosa, media, bionda barba circonda
la nobile bocca elegantemente scolpita e il
quasi forte mento; i fini, lucidi, biondi capelli egli porta quasi fino alle spalle. Il suo
portamento e la sua andatura sono fieri, direi quasi nobili; solo a tratti si mostra felino.
Ha circa 28 anni”50.
Non si tratta di un caso isolato. Il capobanda calabrese Domenico Palma, visto da
un sequestrato che lo aveva in simpatia, è
detto “di statura mezzana e tarchiato, mancava nel volto di quell’orrida e selvaggia
impronta, che ordinariamente caratterizza
questa nomade genìa di malfattori”51. In tribunale Palma così viene descritto: “Egli era
un uomo di bassa statura, ma tarchiato e ben
forte sulle gambe. Distinguevasi nel volto
abbronzato la caratteristica di un tipo non
volgare; il lampo dei suoi occhi lo dimostrava furbo, audace, impetuoso; il sorriso che
erravagli di frequente sulle labbra lo diceva
di buon umore contento di se stesso”; era un
52
53
54
50
51
/ 2 – comicità e politica
uomo di 40 anni, con un “portamento maestoso” e una “virile bellezza”52.
Ecco come un sequestrato svizzero rappresenta il ritorno di alcuni briganti della
banda Manzo: “La sfilata dei sopraggiunti offrì una rara scena romantica. Con un
cappello di forma bizzarra sul capo, la doppia-canna in spalle, il mantello gettato addosso trascuratamente, tradivano non solo
a prima vista il loro pericoloso mestiere; il
loro superbo portamento, la loro placida,
oserei dire nobile andatura rispecchiavano
quella pittoresca eleganza che così spesso
contrassegna il più volgare napoletano. Sarebbe stato senz’altro un magnifico tema per
un pittore di genere”53.
Dimenticando i maltrattamenti subiti, i
sequestrati sembrano a volte affascinati dai
loro sequestratori. Quasi una forma imprevedibile e inedita di sindrome di Stoccolma.
Questo il ritratto di un brigante della banda
Parra disegnato da un prigioniero: “Tra gli
altri che io osservavo ve n’era uno che destava la mia attenzione e simpatia. Erano in
lui riuniti in accordo perfetto, una maschia
bellezza fisica, una distinzione, una forza
eccezionale. Il suo volto bianco, regolare,
era abbellito da due piccoli baffi biondi e da
una lunga barba che, sebbene fosse incolta,
lo rendeva più simpatico ancora. Due occhi
azzurri, due occhi da slavo, pieni di irresistibile incanto, denotavano in modo non
dubbio un giovane buono, leale, espansivo,
che forse per tristi avventure fatali trovavasi
sulla via dell’errore”54.
Fri2: 131.
Falc2: 163.
Gradi: 829.
Fri2: 159.
DBia: 183.
107
Q
uaderni
Dopo essersi per mesi reciprocamente
detestati e contraddittoriamente apprezzati, compresi, tollerati, briganti e sequestrati
svizzeri si ritrovano radicalmente cambiati
alla fine dell’esperienza. La liberazione degli stranieri e il congedo dai loro carcerieri rappresenta uno di quei momenti, in cui
la positività dell’incontro emerge con tutta
la sua forza e profondità: “Nel congedarci
da Matteo Stiusi non mancammo di esprimergli i nostri affettuosi ringraziamenti per
l’amicizia che ci aveva dimostrato, durante
quello che speriamo sia il più triste capitolo
della nostra vita. Egli si scusò di non averci
potuto regalare anelli ecc. come aveva fatto
Giacomo Parra, perché proprio non ne aveva, ma noi lo rassicurammo che anche senza
ciò lo avremmo ricordato con gratitudine.
Quindi ci baciò come vecchi amici e ci separammo, ma spesso ci voltavamo ancora per
guardare di nuovo sull’altura dalla quale,
con sguardo malinconico, ci accompagnò
fino a quando infine gli alberi lo nascosero
ai nostri occhi. Come ci dispiaceva di non
poter ricondurre quest’uomo con noi alla
vita pacifica; come più dovevamo piangere
il suo destino e incolpare il suo corruttore
che lo aveva indotto, mentre forse avrebbe
potuto essere uno dei migliori cittadini, ad
armarsi la mano criminale contro la legge
e l’ordine. Anche Giacomo sembrò giù di
morale per la nostra partenza. Quando ci
strinse la mano per l’addio, disse soltanto: –
Non ci giudicate troppo! – […] Manzo ed
alcuni altri briganti ci regalarono poi ancora
anelli; Manzo diede al signor Fritz quindici
napoleoni d’oro ai quali più tardi aggiunse
Fri2: 187-193.
DBia: 200.
55
56
108
altri cinque, il tutto ‘per prendere un caffè ad
Acerno’. Il regalo fu dato con la dignità e l’affabilità di un grande”. Inoltre Manzo ordinò
ai sequestrati di lavarsi per bene, perché non
voleva che lo facessero ‘scomparire’, cioè lo
mettessero in cattiva luce. Infine, “al nostro
congedo, tutti ci strinsero la mano, alcuni ci
baciarono persino e ci chiesero scusa se non
si erano comportati con noi come avrebbero
dovuto e come avremmo desiderato”55.
Aanaloghe le memorie del sequestrato
della banda Parra-Meola: dopo che il capobanda Cerino ebbe anticipato il denaro del
riscatto, i sequestrati vengono liberati; allora
“ci baciammo col Cerino e cogli altri briganti, e fummo accompagnati da tutti fino alla
vetta del monte. Avemmo da essi un napoleone e mezzo con cui avessimo far fronte alle
spese di viaggio. Io ebbi ancora un regalo dal
Meola, un orologio d’oro che ancora serbo
in memoria di quel tempo tristo. Giunti alla
vetta del monte ci fu indicata la via da percorrere, e fummo lasciati liberi”56.
Il lato nomade e avventuroso
Anche se il brigantaggio postunitario è qualcosa di diverso dal brigantaggio
tradizionale, il modello rappresentato da
quest’ultimo, nelle forme in cui si era radicato nella mente della gente, pesava nella
rappresentazione dei nuovi briganti e nella
stessa organizzazione della loro vita, come
struttura mentale preesistente e precostitui­
ta. Così, agli occhi di chi rimane nel paese il
brigante è un nomade, che ha la vita ramin-
antropologia e storia
ga dei senza dimora e senza proprietà. In
larga misura il brigante è realmente questo,
e se ha un luogo per nutrirsi, riposare, dormire, sarà quasi sempre un luogo (capanna,
mensa, dormitorio), momentaneo e per lo
più collettivo.
Ma il brigante è un nomade (anche se in
maniera diversa) anche ai suoi stesso occhi,
e come tale si comporta: Maria Maddalena
De Lellis, prima di darsi alla macchia, vende la propria abitazione, perché il briganti
non hanno casa. Nei suoi canti il fuggiasco
dà per scontato che morirà come un cane e
la sua casa da morto sarà nella valle invece
che nel cimitero del paese57. La condizione
del nomade poteva essere l’effetto di una
condanna, più che di una libera scelta. Ma
il brigante ci metteva dentro assai più della
sua disperazione di ramingo. Egli non spezza
i suoi legami col paese, ma al tempo stesso
sembra molto preso dalla sua vita di nomade. È un’occasione per soddisfare un bisogno
ancestrale, che si è strutturato nel cervello
del cacciatore preistorico, quello stesso forse
che è nelle motivazioni del pellegrino, dell’emigrante, del turista. Tutti amano la sorprendente varietà di luoghi, la novità dei paesaggi, di odori, di cibi, gli incontri con genti
nuove, le forme di vita e i modi di pensare
diversi, in territori che facevano pensare per
la loro diversità all’abito di Arlecchino. Francesco Saverio Nitti nel linguaggio del tempo
aveva anticipato queste osservazioni: “Le
genti dell’Italia meridionale, risultato delle mistioni di razze sì varie, hanno forse da
tanti incroci, forse più ancora dalla rapidità
loro nell’ideare, una vaga tendenza alla vita
/ 2 – comicità e politica
di avventure. Vi è, soprattutto nelle genti di
Basilicata e di Calabria, un senso di misticismo inconscio, un misticismo rozzo e quasi
selvaggio”. I luoghi sacri sono quasi sempre
lontano dai paesi, e la gente li visita in continue processioni: “nei lunghi pellegrinaggi
il misticismo si trasforma; diventa qualche
volta desiderio di avventure. Il pellegrino è
ora più che non si pensi il precursore dell’emigrante; in altri tempi era il precursore
del brigante. Nulla di più naturale che, nelle lunghe notti vegliate, nelle lunghe vigilie,
nell’incontrarsi con genti nuove, sorga un
bisogno di andar lontano e di espandersi.
La terra maligna, che dà la febbre e uccide,
discaccia. La razza sabellica ama l’intraprendenza e l’ignoto; la Basilicata, che non ha la
quarta parte della popolazione di Toscana,
manda fuori di Europa assai più del doppio
di emigranti all’anno. Senza dubbio la causa
più profonda e più generale è la miseria; ma
io non oserei dire che non vi sia in molti casi
un bisogno di tentare e di cercare”58. Nella
sua vita errabonda per necessità il brigante
non rinuncia a volte a viaggiare come un turista: nella banda Manzo, assillata dal problema di nascondersi con i sequestrati, Giacomo [Parra], ancora convalescente, si concede
una pausa dalle risse e dalla noia dell’inoperosità, intraprendendo un viaggio “col quale
egli si riprometteva di distrarsi”59. Alla fine,
i briganti sono una parte di quell’“oscura e
sconcertante folla di fatalisti attivi”, il cui impulso verso l’ignoto, rappresentato dall’avventura del brigantaggio e dell’emigrazione,
costituisce “un sentimento di obbedienza
incondizionata a una fatalità esterna sovru-
Sca1: 134-39.
Nitt: 50.
59
Fri2: 172.
57
58
109
Q
uaderni
mana che li conduce, attribuendo alla volontà divina i meriti di quella indomita, tenace
eroica volontà di vivere e di lavorare, a cui
devono la sopravvivenza della propria razza
attraverso millenni”60.
Il riposo del diavolo
I sequestrati della banda Manzo credevano di trovare conferma nel comportamento
dei briganti della rinomata pigrizia gaudente
e colpevole degli italiani: “L’italiano parla del
‘dolce far niente’, e può poltrire fiaccamente per giorni interi; tuttavia anche per lui la
noia è una cattiva consigliera, e può indurlo a qualche stoltezza o a qualche crimine,
mentre il nostro proverbio dice, ed è vero,
che l’ozio è il banco di riposo del diavolo, e la
pelle d’orso su cui poltrisce lo sfaccendato ne
è un avanzo infestato di orribili insetti”61. Se
le generalizzazioni degli svizzeri prigionieri
sono per lo meno discutibili, le loro osservazioni empiriche sono quasi sempre attente e
perspicaci, e correggono i loro stessi stereotipi etnici, come quando rilevano la resistenza dei loro sorveglianti ad andare a fare
provvista d’acqua lontano dal loro covo: “Il
napoletano, come l’italiano in generale, non
è di solito fannullone dalla nascita. Solo uno
della banda, Antonio Maluomo (Antonio
Luongo da Acerno), aveva affermato di essere diventato brigante per pigrizia”62. Erano
le condizioni di vita dei briganti, incessantemente braccati dalle forze dell’ordine, spiati
62
63
64
60
61
110
G. Salvemini in DiG3: 18.
Lich: 46.
Lich: 60.
DiPr: 97.
DeWi: 71.
ogni momento da potenziali delatori, cercati
avidamente dai cacciatori di taglie, a rendere “oziosa”, ossia inoperosa, la loro esistenza
nei boschi. Dagli interrogatori emerge che i
briganti passavano gran parte del giorno a
nascondersi, per sottrarsi alla vista delle pattuglie che li cercavano63. Ma effettivamente
l’ozio era anche il banco di riposo del diavolo, perché, come scriveva un ufficiale dell’esercito italiano, “quei devoti masnadieri,
quando siansi costituiti in disciplinata banda
esigono dalle soggette popolazioni di quei
boscarecci paesi le vergini più belle, le più
rilevanti somme di denaro, le migliori armi
e cavalcature, i frutti più squisiti dei giardini,
i più grassi agnelli dell’ovile, i vini prelibati delle cantine dei ricchi, e talvolta gli amplessi delle loro mogli. Solo a tali condizioni
lasciano vivere i benestanti, e rispettano le
loro proprietà, in caso diverso, incendio delle case e sterminio delle persone”, “sempre
rapaci come aquila alpina, quando spicca il
volo dalla rupe altiera e si avvia a far preda
nella convalle”64. Tutto questo poteva generare un delirio di onnipotenza. Il capo banda
Ciardullo diceva ai suoi squestrati: “Quante
volte, dinanzi ai caffè, avete sparlato dei briganti e di volerne far questo e quello, ed ora
siete nelle nostre mani? E siamo più potenti
noi del Re! ché dov’egli ha bisogno di giudici e tribunali per far festa ad uno, noi più
spicci diciamo: inginocchiatevi”; e, continua
il testimone, “vedendo che noi si stava lì impalati a udire il gentil predicozzo, ci obbligò
a piegar le ginocchia, e ci puntò la pistola alla
antropologia e storia
fronte. Poi, rabbonendosi, ci fece entrar nella
capanna”65.
Nonostante le sue rodomontate, il brigante vive una fragile precarietà. È immerso
in una temporalità propria: sa che ogni giorno può essere l’ultimo, allora cerca di attaccarsi alla vita che fugge da tutte le parti. Per
i prigionieri diventati loro acuti osservatori i
briganti “erano stufi dei boschi e soprattutto
di quella vita errrabonda e pericolosa”66. Si
abbandonavano anche per questo a quelle reazioni che l’antropologia psichiatrica del tempo classificava come “eccessi psicomotori”,
propri delle genti delle campagne. Ecco come
reagisce un brigante della banda Coppa al
quale è stato ucciso il fratello in uno scontro
con i soldati: “restava mo il fratello del morto,
il quale piangeva il suo fratello, ma fatto anima dai compagni, si poso a raccogliere legna
per bruggiare il corpo del morto fratello, fatto
ridurre tutto in cenere, se ne andarono in una
montagna inacessibile, qui piangeva sempre,
ma confortato dai compagni, risposo cosa
mi giovò il vivere a me senza di mio fratello, uccidetemi voi e fate sapere a mia madre
che siamo caduto entrambo”67. Commentano i sequestrati: “I meridionali sono eccessivi nel piacere come nel dolore. Il fanciullo
settentrionale sa sopportare la sofferenza più
dignitosamente che non l’uomo di qui. Una
volta uno dei briganti, lottando, andò a finire
troppo vicino alla brace e si ustionò un poco
l’alluce. A ciò levò alte grida, come se lo avesse morso un serpente velenoso. Si rotolò per
67
68
69
70
65
66
/ 2 – comicità e politica
terra, si inginocchiò e pregò la Madonna, balzò in piedi e maledisse lei e tutti i santi perché
la preghiera non aveva avuto effetto; in breve,
si comportava non come un bambino, ma
come un matto”68. Un altro sequestrato svizzero fornisce una versione in parte diversa
delle reazioni del brigante: “Giacomo [Parra]
sopportò tuttavia il dolore con la più grande
calma, e anche se ogni tanto se ne lamentava,
faceva tuttavia altre volte i più vivaci scherzi.
Era sotto questo aspetto molto diverso dalla
maggior parte dei suoi compagni, come pure
dalla maggior parte dei napoletani; tu sai
come essi di solito si abbandonano molto al
loro dolore, in un modo che noi svizzeri siamo volentieri inclini a chiamare vile”69.
Attaccati da due squadriglie, i briganti di
Pietro Monaco hanno la peggio. “Era un bel
vedere al chiaro di luna quei Rodomonti per
l’innazi millantatori e gonfi di se stessi, allora
inviliti e gementi dal dolore delle ferite lanciare imprecazioni e bestemmie contro gli
assalitori, e soprattutto contro lo Scrivano
loro acerrimo ed instancabile nemico”. Ma i
briganti conoscono anche la commozione e la
pietà: Pietro Monaco fa leggere le lettere di addio dei sequestrati che ha deciso di uccidere,
si commuove con tutta la banda, e desiste dal
massacro: “Carlo Baffi scrisse il primo e lesse
la sua lettera, la quale espugnò per dir così i
cuori dei nostri carnefici, e li commosse fino
al pianto; una furtiva lacrima irrigò puranco
la gota bruna del capobanda, il quale per celarla ai circostanti volse indietro lo sguardo”70.
Oliv: 52.
Lich: 61.
Croa4: 54.
Lich: 72.
Fri2: 168.
Fal2: 164 165.
111
Q
uaderni
Per quanto fosse un uomo indurito
nell’esercizio di un potere difficile da conquistare e più ancora da mantenere, Crocco
nelle sue memorie alterna frequentemente
all’orgoglio del misero pastore diventato un
grande generale le lamentazioni e le forme
intenerite di autocompatimento proprie
dell’uomo nato sventurato e perseguitato
dal destino. Tutto questo era nella realtà
dei comportamenti diffusi, e si ritrova nelle
rappresentazioni epiche degli eroi popolari.
I quali si differenziano dagli eroi dell’epos
colto, che non sembrano conoscere l’avvilimento della paura e le cadute della debolezza, perché, a differenza di questi ultimi, incarnano non solo le aspirazioni ideali della
collettività, ma anche i suoi assilli quotidiani
e il suo lato oscuro.
La paura
“Non v’è bugia più grande di quella dei
briganti quando si definiscono gli ‘uomini
liberi del bosco’. Colui che è consapevole
della propria colpa non è libero in alcun
posto. Sua compagna fedele è la paura. Chi
deve dormire col fucile in braccio, vive
una vita miserevole, e fossero almeno le
sue ore di veglia piene dei più grandi piaceri! Ma ai briganti mancano anche questi
piaceri”71. Così un sequestrato. In quanto
già contadino o pastore, il brigante conosceva la “paura del previsto”, ossia la paura della siccità, della grandine, del freddo,
delle alluvioni, paure gravi, ma non solitamente devastanti e distruttive; ma ora che
Lich: 49.
Capa: 152; DBia: 51.
73
Fri2: 141.
71
72
112
vive alla macchia conosce anche la paura
dell’imprevedibile e dell’ignoto: la vittoria
improbabile, il futuro incerto, il rischio
costante di finire colpito o fucilato72. Nella solitudine assoluta, la paura comporta
il rischio della disintegrazione psichica e
dell’annientamento di sé.
“Stiusi si allontanò per andare a prendere
cibo in qualche masseria e doveva essere di
ritorno alla sera dello stesso giorno. Poiché
non tornava, gli altri briganti incominciarono subito a diventare impazienti e ansiosi,
poiché la più grande inezia li metteva sempre in sospetto. In questo caso, dissero che
forse era andato in un ‘posto’ nei paraggi, e
sarebbe tornato con i soldati per coglierci di
sorpresa”73. Ossessiva la paura del tradimento. Il brigante sa che le forze dell’ordine e gli
stessi amici/nemici possidenti hanno investito per eliminarlo ingenti somme di denaro, premi e taglie favolose, promozioni e
carriere, e che dietro l’angolo o al suo fianco
ci può essere la spia, il delatore, l’assassino,
l’avvelenatore. È questa ossessione che fa del
brigante un sanguinario sadico nei confronti di chi lo tradisce.
Il timore di essere avvelenati rendeva
più angosciante la paura della morte. Come
quasi tutte le guerre, anche quella del brigantaggio fu guerreggiata con mezzi leciti
e illeciti: oltre lo spionaggio e il tradimento,
l’avvelenamento era all’ordine del giorno.
Quando riusciva difficile vincere i briganti
con le armi, i militari cercavano di eliminarli
col veleno, corrompendo i manutengoli che
li foraggiavano. Lo stesso facevano i possidenti, se dovevano eliminare i briganti loro
antropologia e storia
amici quando diventavano scomodi. Sappiamo, per esempio, che Fuoco ricevette da
S. Elia delle armi insieme a dolci e bottiglie
di liquori, ma per fortuna al tempo stesso
qualcuno lo avvisò che le bottiglie erano
avvelenate74; nel novembre 1863 il sindaco
di Craco incaricò un massaro di avvelenare Cappuccino e qualche gregario75. Il vino
avvelenato ovviamente di solito uccideva;
quello oppiato serviva ad addormentare. I
briganti non erano da meno. Quando erano
costretti ad abbandonare frettolosamente
il pasto per il sopraggiungere della truppa,
avvelenavano i cibi, sapendo che i soldati li
avrebbero mangiati.
Per persone che vivono nascondendosi,
la paura dominante è forse quella di essere
scoperti: una paura a volte spropositata, che
contrasta col coraggio altre volte dimostrato: un sequestrato della banda Ciardullo così
racconta il comportamento dei briganti nel
momento in cui un cacciatore passò davanti
alla grotta in cui erano nascosti: “Come allibivano i briganti! e non vedevano che un
tranquillo cacciatore! che eroi!”. I briganti
non avevano paura dei soldati, ma dei carabinieri e dei bersaglieri. Lo testimonia
un dotto sequestrato che visse alcuni mesi
come loro prigioniero: “Come tremavano
loro, come se la facevano nei calzoni alla vista ancora della lucerna (= il luccicare delle
armi) d’un carabiniere!: gli altri li chiamavano ‘cappottoni’ e facevan vista di non curarsene: ma bersaglieri e carabinieri, salcisia (=
salvo mi (ci) sia)!”76.
76
77
78
74
75
/ 2 – comicità e politica
Ma la paura, al tempo stesso, “costituisce l’apparente unità di un corpo sociale”77.
Perché “l’uomo in preda al panico regredisce fino al bambino che egli fu, quello che, in
caso di pericolo, si precipitava nelle braccia
della madre. Corre ad unirsi agli altri. I briganti non agiscono mai da soli ma cercano
di accompagnarsi ad altri, formando piccoli
gruppi in una comunanza di vita alla macchia. La paura infatti è un elemento di coesione fra più soggetti che ne sono tormentati, giacché dividere la paura tra più soggetti
equivale in un certo modo a diminuirne l’intensità individuale”. Si determina al tempo
stesso una ambivalenza affettiva, perché il
bisogno di proteggere la propria vita e sottrarsi alla devastazione della paura produce
a sua volta una forma di panico latente che si
libera nell’aggressione e in “molte altre forme di intensità erotiche”: “l’organizzazione
della protezione del corpo e dei beni è anche
lo specchio del desiderio di aggressione”78.
Serse in fuga è “vile e feroce” per Leopardi,
che ha colto nella maniera più semplice il
nesso tra paura e crudeltà.
Il piacere dell’andare e del correre
La vita della banda è straordinariamente segnata dal movimento. Gli spostamenti
fanno parte dello stile di vita dei briganti, e
creano abitudine e assuefazione: “Una marcia lunga e faticosa – notavano i sequestrati
stranieri, che erano costretti a seguirli – reca
ASC, Deposizione di Giocondina Marino alla Delegazione di Pubblica Sicurezza in Mignano. …
Coni: 64.
Oliv: 46,77.
Jeud: 25.
Cfr.: Capa: 15.
113
Q
uaderni
loro meno fastidi che a noi”79. In effetti “le
bande possiedono una straordinaria mobilità: espertissime di tutti i più intimi recessi
delle foreste e dei terreni frastagliati, coadiuvati dalla gente di campagna, non solo
con facilità sfuggono alle ricerche e agli inseguimenti delle truppe, ma riescono, non
di rado con fortuna, a tender agguati, a sorprendere in modo fulmineo con superiorità
di forze, specie i piccoli drappelli in marcia,
ed infliggere loro perdite più o meno considerevoli”80.
Il brigante è un guerrigliero, che ha l’obbligo di combattere conciliato col bisogno
di salvare la pelle. Conosciamo le sue tattiche: non fermarsi a lungo nello stesso posto
per non fare scoprire i suoi nascondigli, per
rendere difficile, confondere, depistare le
ricerche dei nemici; correre all’attacco se si
è certi di vincere, ma battere in precipitosa ritirata in caso contrario; come scriveva
l’intendente, le bande, “disfatte in un luogo,
vanno a disperdersi, ma quindi riunisconsi
e piombano altrove”; oppure “la condotta
de’ briganti è sciogliersi, quando la forza
si avvicina; riunirsi, quando la forza si sia
allontanata”81. Vere odissee erano i sequestri: bisognava spostarsi continuamente,
spesso per molte settimane e a volte per
molti mesi, attraverso luoghi impervi, dirupi, sentieri pericolosi, sotto la pioggia o
nella neve, per disorientare gli inseguitori,
trascinandosi dietro i sequestrati, di solito
incapaci di adeguarsi ai ritmi delle marce.
Le stazioni brigantesche (grotte, masserie,
81
82
83
79
80
114
Lich: 49.
Mari: 18; in Grec: 211.
In Luc: 46n.
Bart: 46.
Molf: 137.
ecc.) servivano solo per dormire, giocare,
proteggersi dalle intemperie, nascondersi:
da lì si partiva continuamente, tutti o una
parte, per fare la guerra, rimediare provviste, fare proselitismo.
La rapidità con cui i briganti sapevano
muoversi consentiva loro di attaccare di sorpresa e cogliere impreparato il loro bersaglio.
Questo creava uno stato permanente di tensione e di ansia tra la gente: poiché il briganti potevano comparire in ogni momento, i
proprietari tendevano a non uscire dal paese,
e veniva meno ogni forma di controllo sulla
proprietà. “I briganti avevano a loro grande
vantaggio la celerità nei movimenti e la rapidità delle marce; essi arrivavano a percorrere
delle distanze enormi, impegnandovi una
metà, e talvolta due terzi in meno del tempo
che sarebbe occorso ad una colonna di soldati, per quanto abituati alle aspre marce delle
montagne”82. Nei loro spostamenti le bande
in una sola giornata potevano percorrere
fino a trenta chilometri. Secondo il colonnello Chevilly arrivavano a percorrere 50 miglia
in una sola notte83. L’ufficiale dei carabinieri
Giuseppe Bourelly colse subito l’effetto che
questa rapidità di movimenti aveva sulla popolazione: “Crocco scorazzava la campagna
con una audacia incredibile, portando da
una provincia all’altra, da un paese all’altro,
eseguendo marce lunghissime. Egli nella
notte del 26 giugno (1865) si trovava tra Spinazzola e Minervino. La sera del 27, unitosi
a Tortora, forte di sessanta briganti a cavallo,
riappariva nel territorio di Melfi e quivi as-
antropologia e storia
saliva la masseria Manna; e dopo aver messo ogni cosa a ruba, partiva prendendo la
direzione del tratturo di Venosa. La grande
conoscenza dei luoghi che ormai avevano i
briganti ed il sistema da loro adottato di lunghe e inaspettate marce, rendeva assai difficile garantirsi dalle sorprese”84.
Non era solo una questione di tattica.
La corsa i briganti l’avevano nel sangue,
era la pura gioia del camminare e del correre, che apparteneva in parte allo stile
di vita contadino, ma soprattutto era un
effetto della liberazione sensoriale che la
vita libera nelle campagne e nei boschi
produceva nel brigante, un’ebbrezza tormentata dall’inquietudine e dalla disperazione del fuoruscito braccato. È quello
che emerge dalle autorappresentazioni
brigantesche:
Curru valli, timpuni, terra, rina,
sècutu Stagliurante e Marchisatu,
sautu alla Poverella llà vicina
e pigliu pue de Pusiniello l’autu;
de Mesuraca curru alla marina,
passu hiumare e mminu ppe l’Amatu,
Panettieri e Garruopoli a ppendino
vaiu fuiendu cuomo disperatu85.
(“Corro per valli, burroni, terra, rena, / vado in
giro per Stagliurante e il Marchesato, / faccio un
salto alla Poverella là vicina / e prendo poi l’alto
di Pusiniello; / corro alla marina di Mesoraca, /
passo fiumare e vado verso l’Amato, / Panettieri e Garruopoli in discesa / vado fuggendo come
disperato”).
86
87
88
84
85
/ 2 – comicità e politica
Si sapeva che briganti erano più veloci
di chiunque nei percorsi brevi, specie su terreni scoscesi e nelle discese, nelle quali procedevano con grandi balzi, come le capre86.
Era quasi uno stereotipo, influenzato forse
dai miti briganteschi diffusi in tutto il mondo. In un documento di archivio del brigante pugliese Matassa si dice che “più rapido
di un baleno scorre in poche ore le nostre
campagne”; secondo l’uomo che lo uccise, il
capobanda Andreozzi era un “camminatore infaticabile”, che correva sulle balze più
scoscese e saltando le più larghe frane al pari
di un camoscio”. Rapidità e agilità potevano
dipendere dall’equipaggiamento leggero e
“da calzari non ingombranti e fastidiosi, che
aderivano magnificamente alle estremità”87.
Cavalcare i cavalli è perciò per i briganti
come volare. “Come selvaggi, abbassando il
loro corpo sul collo del cavallo, fuggono a tutta corsa gridando come belve feroci per sentieri strettissimi, tortuosi, inceppati da roveti,
da spine, da arboscelli, da fogliame secco, da
stecchi, da ciottoli, da rottami; si spingono
audaci e veloci sul ciglio di burroni spaventevoli, sui limiti dei fossati, sopra stretti arginelli, entro il letto dei torrenti, entro acque che
scorrono incassate tra ripe vicinissime ed erte
e inceppate da siepi di virgulti di spine, ovunque fino a che una palla li coglie o arrivano a
fuggire alla diligenza e all’inseguimento della
truppa, nascondendosi sotto qualche cespuglio o entro qualche caverna88.
I maschi erano per lo più preparati dal
loro stesso abituale stile di vita ad affron-
Bour: 238.
Canto brigantesco, in Bilo, poi in Sca1: 138.
Moe3; 165, 78, 183, 191.
In Luc3: 46n.; Bart: 65; Varu: 129.
Bour: 90.
115
Q
uaderni
tare le difficoltà e i disagi dei continui spostamenti, le donne di meno, e i loro sforzi
e patimenti erano perciò maggiori. Maria
Giovanna Tito si lamentò in tribunale delle
continue fughe da un bosco all’altro, “osservando una vita raminga piena di stenti e di pericoli”. Il difensore di Maria Rosa
Marinelli dichiarò, esagerando, sulla base
della confessione del brigante Masini, che
“le donne camminavan presso quei briganti
come cammina il somiero, elle andavano innanzi con le battiture”, ossia venivano “sovente maltrattate e battute, in specie quando
non avean forza di camminare”89. Ma anche
gli uomini subivano questo tipo di sollecitazioni, specie se si trattava di sequestrati.
Nel mito la rapidità dei movimenti si rannoda in qualche modo al dono dell’ubiquità,
che le rappresentazioni collettive solitamente
riconoscono ai briganti, e ne costituiscono
per un verso il completamento e per un altro
un sostituto simbolico di segno laico. Ubiquità e rapidità di movimento sono trasposizione fantasmatica di un dato reale, il controllo
del territorio, che il brigante, re della strada,
realizza pienamente. Se Dick Turpin da Londra raggiungeva York in un solo giorno, Angiolillo attraversa continuamente un vasto
territorio tra la Puglia, la Lucania, e il salernitano, sollecitando l’immaginazione del vento
e del volo demoniaco90.
Saperi del corpo
I briganti dell’Italia postunitaria utilizzavano trovate tattiche e strategiche ereditate
dal brigantaggio endemico delle campagne
meridionali, e, più in generale, mettevano
a frutto, in una logica di sopravvivenza, i
saperi contadini concernenti la conoscenza
dei luoghi e delle modalità in cui muoversi in essi, le forme tradizionali di controllo
del territorio, i modi della comunicazione
simbolica, la capacità di affrontare situazioni difficili con risorse minime: un insieme
di cose che hanno strutturato le coordinate
contadine dello sguardo, dell’udito, oltre che
i ritmi e i modi del movimento. Questo non
esclude che ci fosse anche un sapere militare
venuto da fuori, una capacità di organizzazione e di uso delle armi che non può non essere
fatta risalire in parte al precedente servizio militare dei contadini e in parte al contributo dei
soldati sbandati dell’esercito borbonico, semplici militi e sottufficiali, che hanno svolto nel
brigantaggio un ruolo non trascurabile, di cui
ancora non conosciamo le esatte dimensioni,
ma sicuramente non decisivo.
Di solito i briganti operavano di sera, fino
a notte inoltrata; poi ritornavano alla base, e
vi rimanevano fino alla sera successiva, per
nascondersi, dormire e riposare, riempiendo
le ore che rimanevano con giochi e affabulazioni. A meno che “non abbiano ricevuto avviso di qualche movimento della truppa, o siano da questa inseguiti, o debbano perpetrare
qualche delitto, o ricevere qualche ricatto, o
riunirsi ad altre bande, o finalmente abbandonare per più sicurezza il loro covo”.
I militari che hanno combattuto i briganti ci hanno lasciato le migliori informazioni sui loro movimenti: “Quando entrano
nei luoghi si dividono in piccoli drappelli di
ACS, Roma, Tribunale Militare di Guerra per la repressione del brigantaggio nelle provincie meridionali, b. 14
(Avellino), fasc. 168 e b. 19 (Avellino), fasc. 230; Poli: 34, 35.
90
Sca2: 62, 0tt. XXII, XXIV, XXVII, XXXIV.
89
116
antropologia e storia
quattro o sei e per diverse viuzze accedono
e si riuniscono poi ad un punto convenuto,
quando si muovono hanno tutte le precauzioni a non lasciare orma del loro passaggio.
Viaggiano fuori dei sentieri, perché non si
vedano le pedate dei cavalli; deviano dal
cammino per alcun tratto per riprenderlo
ad altro punto onde lasciare incerti sulla direzione presa”. “Quando non hanno informazioni sicure sulle mosse della truppa, se
costretti a muoversi, prima di porsi in marcia, mandano spioni, che sono o fanciulli, i
quali con un fascio di legna fingono d’essere stati al bosco a legnare, oppure carbonai,
pastori, taglialegna. Assicurati che la truppa
non è nelle vicinanze, si mettono in cammino; però non fidandosi ancora mandano
avanti loro un contadino, il quale pian piano
osserva se nella via vi sono impronte di scarpe di soldato, che si conoscono per la forma
speciale, e se vede delle frasche schiacciate
attraverso al sentiero, o finalmente se ode
calpestio. Qualora vengano avvisati che una
forte pattuglia viene alla loro volta, se lo permette la località e il tempo, si nascondono,
lasciano passare e poi con tutta precauzione
e cautela ribattono la via fatta da quella”91.
Per far perdere le tracce facevano in
modo che quello che seguiva calcasse la pedata di quello che precedeva. Nella banda
di Cosimo Giordano si camminava in fila,
notevolmente distanziati, e chi era in coda
aveva l’obbligo di cancellare con un ramo i
segni del passaggio. I briganti sapevano leg-
93
94
95
96
91
92
/ 2 – comicità e politica
gere le tracce del nemico, per capire se i militari erano passati in un posto e da quanto
tempo92.
I briganti della banda Cerino-Manzo
“erano capaci di vedere al buio come se fosse giorno”; “abituati sin dall’infanzia ad affrontare le insidie della montagna, a parte la
loro straordinaria agilità, vedevano al buio
come i gatti; per loro non cambiava se era
notte o giorno”93. Lo stesso i briganti abruzzesi: “Immediatamente, gli occhi di uno dei
miei uomini scoprirono ciò che io, senza
cannocchiale, non avrei mai potuto individuare”94. Il capobanda Luigi Andreozzi,
trentenne, “era nittalopo e di notte ci vedeva distintamente, come di giorno chiaro”95.
Perché questa vista ampia e acuta? Un ufficiale intelligente ha cercato di spiegare che i
briganti sono “assuefatti a vivere in campagna, per cui l’occhio ha sempre un orizzonte
estesissimo”, al punto che discernono dal
portamento, dall’andatura, dal complesso
più o meno oscuro della figura di lontano la
truppa”96. Ma la vista del brigante ha anche
un senso estetico, elementare, ma forte: i
suoi canti dimostrano che egli ammira il paesaggio, gli alberi, le acque “imbalsamate”:
sensazioni che sembrano ricordi della più
lontana preistoria, quando la vita del cacciatore plasmò il suo cervello.
Notoriamente, la struttura e la funzione
del nostro cervello fa sì che vengano trascurati i suoni inutili per il nostro organismo,
mentre favorisce il transito di quelli che
Bour: 90.
DiBi: 182; Sang:318; Moe3: 166.
Moe3: 73, 78.
Zimm: 101.
Bart: 65.
Bour: 92.
117
Q
uaderni
vengono recepiti come necessari alla nostra sopravvivenza. Così, i consueti suoni
ambientali vengono trascurati, ma si presta un’attenzione straordinaria a quelli che
consideriamo minacciosi o pericolosi. Questo rende i briganti “vigili e accorti”, per cui,
“è difficilissimo sorprenderli. Odono il più
piccolo rumore, distinguono il passo del
soldato da quello del contadino e indovinano il nemico come il cane annusa la lepre.
Abituati ai boschi, distinguono il fruscio, il
tintinnio del fogliame scosso dal vento dal
rumore che fa la foglia assecchita, schiacciata sotto i piedi di chi cammina”97. Tutte le
testimonianze concordano: il senso dell’udito dei briganti “era acutissimo, al punto che,
come ai pellerossa, non sfuggiva loro il minimo fruscìo”. Il riferimento agli amerindi
non è inutile: anche i briganti appoggiando
l’orecchio sul terreno, sentivano la marcia
dei nemici, e calcolavano il tempo in cui
sarebbero arrivati98. Un sequestrato inglese,
che li osservò sul campo per mesi, vivendo
insieme a loro, testimonia che “la vista e l’udito dei briganti erano acutissimi: era in gioco infatti la loro vita. Sentivano l’avvicinarsi
di una persona quando era ancora molto
distante”99. I soldati prendevano le loro contromisure, che non sempre funzionavano.
Per sorprendere i briganti il generale Pallavicini proibì ai soldati l’uso delle trombe e
dei tamburi, ma lasciò quello dei fischietti.
Già il prete antropologo Padula ne rideva:
“Hemsal, dice la mitologia scandinava, ave-
Bour: 91-92.
Moe3: 79; Zimm: 107.
99
Moe3: 106.
100
Pad: 114.
101
Moe3: 193.
102
Linch: 49.
97
98
118
va così fino l’orecchio che udiva crescere la
lana sul dorso delle pecore; ed i briganti calabresi discendono da Hemsal”100.
Quando non devono agire di notte i briganti tornano al loro “palazzo di frasche”,
come i lupi. Durissimi i pernottamenti,
specie in inverno. Si dormiva di solito all’aperto, sotto gli alberi o nelle caverne, sulla
nuda terra, avendo per materasso uno strato
di paglia, per guanciale un sasso o una zolla e per coperta l’ampio mantello o il cappotto. A volte il terreno era in pendio, ma
i briganti sapevano dormire lo stesso, senza
scivolare101. I sequestrati si stupivano: “Essi
riposano altrettanto bene sul duro terreno,
quanto noi su un morbido giaciglio”102. Non
sempre era possibile accendere il fuoco per
riscaldarsi o per preparare un boccone caldo. Non erano quasi mai sonni tranquilli,
perché in qualsiasi momento poteva sopraggiungere la notizia dell’arrivo dei soldati o
degli squadriglieri, e occorreva rinunciare al
sonno e riprendere la fuga.
III. Una guerra crudele
La crudeltà raccontata
L’ufficiale dell’esercito De Witt racconta
che, prima di essere condotto alla fucilazione, un brigante gli confessò che “in vita sua
non aveva provato soddisfazione maggiore di quella che in lui produceva il sentirsi
antropologia e storia
bagnare le mani del caldo sangue delle sue
vittime”103. La letteratura sull’efferatezza dei
briganti maschi è in parte nota. Presenta i
difetti della letteratura di propaganda, volta a fare accettare la ferocia della repressione e al tempo stesso a liberare i militari dei
loro complessi di colpa, ma, nonostante le
esagerazioni, sarebbe ingiusto considerarla
costantemente mendace. La conoscenza approfondita dei fatti di sangue e di crudeltà
ci consente di fare un po’ di luce anche sulle
efferatezze reali o presunte delle brigantesse,
che secondo alcune opinioni diffuse sarebbero state analoghe alle gesta crudeli dei briganti maschi, e in alcuni casi peggiori. È tuttavia grazie unicamente a questa letteratura
che le brigantesse, escluse dalla storia, sono
entrate nell’immaginario collettivo degli italiani nei primi decenni dell’unità nazionale.
Una giusta dose di durezza era richiesta
per poter essere rispettati nella banda, e le
brigantesse in questo non furono da meno
degli uomini. La loro durezza era già diventata leggenda mentre esse erano alla macchia, ma le rappresentazioni che di essa ci
sono state lasciate dai contemporanei appaiono esagerate e non sempre in buona fede.
Un contributo importante alla creazione del
mito popolare della terribilità delle brigantesse dovettero darlo i cantastorie, che erano
a loro modo una sorta di cronisti oltre che
cantori epici del brigantaggio. L’epos popolare, normalmente affollato di briganti maschi,
conosce poche significative eccezioni, come i
versi dedicati a Maria Oliverio, di cui hanno
raccolto qualche lacerto Francamaria Trapani e Otello Profazio.
/ 2 – comicità e politica
Le cronache giornalistiche del tempo
sono tra le pagine che più di altre tendono a
esagerare i comportamenti efferati delle donne brigante, sia perché la crudeltà femminile
fa più notizia di quella degli uomini, sia perché esse intercettavano gli umori e il modo di
sentire diffuso, influenzato dalla letteratura
di appendice, che proprio in quegli anni riproponeva immagini di donne fatali, perversamente crudeli. Secondo i giornali Rosaria
Ottobuono ebbe “quasi celebrità di ferocia”,
e per la stessa caratteristica era “conosciutissima” Rosaria Rotunno. Il primato della ferocia veniva attribuito a Maria Oliverio, che
nelle cronache “per le sue atrocità era il terrore di tutto il contorno”: la letteratura poi
avrebbe fatto il resto, trasformandola in un
essere demoniaco. “Feroce” è detta Filomena
Cianciarulo, che “non rifuggiva dai misfatti”.
Di Giuseppina Gizzi, compagna di Giacomo
Parra, il brigante del Cilento responsabile di
quarantacinque omicidi, oltre furti, sequestri e grassazioni, i giornali scrissero che “la
donna era feroce quanto il suo uomo. Vestita di abiti maschili e armata di tutto punto,
scorreva la campagna, sempre a fianco del
suo compagno, senza tremar mai dinanzi al
sangue umano, e senza vacillare dinanzi ai
più atroci misfatti. Maria Giovanna Tito fu
definita da un cronista “la iena”104. A volte
l’immagine popolaresca del brigante cattivo
si incontrava con il gusto, diffuso nella letteratura dell’Italia postunitaria, del racconto
dell’orrore e con le più recenti immagini della donna fatale. Secondo una favola che circolava tra i soldati, Filomena [Pennacchio],
quando la banda festeggiò la sua unione con
DeWi:74.
Gio: 8/6/1865; Pol: 13/6/1865; Om:10/6/1865; Pu: 11/1/1865; Gio: 13/1/1867.
103
104
119
Q
uaderni
Caruso, bevve vino mescolato a sangue nel
teschio di un bersagliere da poco massacrato
e “alla prova di tanta crudeltà, ciascun gregario della banda di Caruso le prodigò tutte
le cure immaginabili”105. L’ufficiale De Witt
raccontò di aver ricevuto queste informazioni da un soldato, che, essendo rimasto qualche giorno prigioniero tra i briganti, le aveva
avute dai briganti stessi. Qualcosa di simile si
dice dello stesso Caruso in un foglio volante
popolare, e anche del brigante Coppa si raccontava che bevesse in un teschio il sangue
dei suoi nemici: in realtà si trattava di una
etimologizzazione popolare del suo nome.
Costruiti secondo un modulo immemorabilmente arcaico, questi racconti dovettero
avere un certo effetto sull’immaginario della
società italiana postunitaria. Ma erano solo
favole.
Queste favole contribuirono a crearle le
stesse scritture influenzate dal lombrosianesimo. Secondo Gelli, che tardivamente
si avvaleva di cifre e concetti lombrosiani,
“i più accaniti e brutali tormentatori degli
sventurati, che cadevano nelle mani delle
bande brigantesche, erano le donne e i ragazzi”. A suo dire Filomena Pote e Rosa Tardugno, amanti di Schiavone, “si uguagliano
nella crudeltà, nella temerarietà senza pari e
nell’odio contro i nostri soldati”; se qualcuno
dei militari “cadeva nelle mani di quelle due
malefemmine, era certo di finire i suoi giorni
tra le sofferenze più oltraggiose e atroci”. Egli
aggiunge che Maria Capitanio, amante del
brigante Antonio Luongo, è “rinomata per
la sua risolutezza nell’attaccare e svaligiare le
persone e la crudeltà nell’eseguire le decisioni del capobanda Ciccone o per soddisfare
la propria libidine di sangue, la cui vista la
esaltava”. Ferocissima sarebbe stata Cristina
Cocozza, donna del capobanda Colamattei,
già brigante della banda Fuoco, che operava
nella zona di confine con lo Stato Pontificio.
Gelli, influenzato dalla ritrattistica lombrosiana, era convinto che brigantesse si nasce
e che le donne devianti erano più depravate
degli uomini106. Molti giudizi e valutazioni
dei lombrosiani nascevano dalla confusione,
che essi facevano, tra le rivolte popolari e il
brigantaggio: anche se nel periodo postunitario i due fenomeni potevano incrociarsi e
perfino in qualche caso confondersi (come
nelle rivolte e nei massacri di Carbonara del
1860, di Pontelandolfo e di Melfi del 1861,
di Gioia del Colle, pure del 1861, in cui le
donne del popolo commisero eccessi nefandi), essi hanno sempre costituito, nella genesi, nelle modalità, negli scopi e nei risultati,
nonostante le somiglianze, due fenomeni
diversi: le donne delle bande fanno parte
di un’organizzazione, seguono regole che
disciplinano anche i loro comportamenti
eccessivi, e la “crudeltà” di tutti i membri
della comitiva è, come cercheremo di capire, di tipo funzionale, laddove nelle rivolte
la violenza delle donne esplode in maniera
convulsa e senza freno. La confusione nelle pagine della letteratura di cui parliamo è
invece totale: “Nelle bande brigantesche, in
cui l’elemento femminile era più largamente
rappresentato, abbondavano gli atti di ferocia e di crudeltà. Le sevizie che inventarono
DeWi: 296.
Gell: 219, 222, 246. Uno psichiatra lombrosiano, storico dilettante, come Cascella ebbe a scrivere (poi ripreso da
Enrico Ferri) che la brigantessa Antonina, interrogata del perché avesse commesso tante azioni efferate, rispondesse: “Oh! voi non sapete che piacere si prova a piantare un pugnale nel petto di un uomo” (Casc: 94).
105
106
120
antropologia e storia
le brigantesse della Basilicata, di Palermo e
di Parigi, nota il Lombroso (I, p. 460), non
si possono descrivere”107. La letteratura sul
brigantaggio ricapitola erroneamente tutti i
luoghi comuni che la scienza del tempo aveva accumulato sulla crudeltà delle donne nelle rivolte popolari: “È infatti assodato che le
donne commettono minor numero di delitti
che gli uomini; ma, quando li commettono,
sono più crudeli e ostinate nella recidiva, e si
ravvedono meno dei più feroci delinquenti
maschili. Lo Spenser dice che nei paesi dove
vi è il costume di torturare i nemici, le donne
sorpassano gli uomini in crudeltà”108.
Anche le testimonianze rese ai processi
sono da prendere con le pinze, perché a volte erano occasioni per esprimere simpatie o
rancori e realizzare vendette private. Nella
deposizione di Maddalena Cioffi, che non
amava, forse per gelosia, Brigida Marino,
quest’ultima è dipinta a tinte fosche: avrebbe ideato e fatto realizzare alla banda il se-
/ 2 – comicità e politica
questro di due dei suoi cugini, che riteneva
ricchi, e ne avrebbe fatto uccidere uno (l’altro riuscì a fuggire) perchè la madre rifiutava il riscatto (avrebbe detto: “se fusse anche
mio padre che avesse denaro, lo farei anche
sequestrare”)109. Si raccontava ancora la sua
partecipazione al massacro di otto contadini, che furono uccisi perché tre di essi erano
Guardie Nazionali110. Di fatto però, a parte
alcuni casi particolari, i processi confermano solo in misura minima le efferatezze attribuite alle brigantesse, anche perché non
era facile trovare testimoni che in tribunale
potessero attestarle.
Veritiere risultano invece le testimonianze dei sequestrati, che vissero con i briganti
per settimane e anche per mesi. Nelle loro
deposizioni hanno frequentemente riconosciuto l’atteggiamento tra consolatorio e
protettivo adottato nei loro confronti delle
brigantesse, alle quali per parecchie settimane e mesi rimanevano affidati. Atteggiamen-
I, 460; Sig2: 61. Si legge ancora nello stesso testo: “Furono le donne, che strapparono le lingue agli uccisi, ne prolungarono l’agonia, e che fecero mangiare alle vittime le proprie carni arrostite; e furono esse che vendettero a rotoli
la carne dei carabinieri, ed infilzarono su picche le viscere umane”.
108
Sig2: 59-60. La letteratura sul brigantaggio registra che durante la rivolta di Melfi, nell’aprile del 1861, “le donne
erano più inferocite degli uomini; una vecchia di sessant’ anni, vestita da soldato, minacciava di trucidare tutti.
Era ubriachezza e furore” (Monn: 69); durante il massacro di Pontelandolfo del 1861 due ufficiali, legati nudi agli
alberi, furono costretti ad assistere all’eccidio dei loro soldati e poi torturati; “le donne, furibonde, conficcavano
loro ferri negli occhi, e tutte le membra del corpo erano barbaramente flagellate e mozzate” (An67: 29); durante le
stragi di Carbonara, nell’ottobre 1860, “– oggi la carne deve andare a tre grani al rotolo – urla una furia in forma
di donna” (Bour: 119); gli atti dei processi attestano che a Gioia del Colle, durante la rivolta del 28 luglio 1861, le
donne furono “furenti eccitatrici di rovine”: Marianna Semeraro, a capo di “una frotta di scarmigliate megere”, incita gli uomini agitando un borbonico fazzoletto bianco; Rosa Surico brandisce tra i rivoltosi una falce minacciosa;
Maria Modugno, diciassettenne, prepara la stoppa per i fucili; Angela Rosa Angiolillo “con urla selvagge incita la
folla alla strage; Margherita Giannico e Caterina Colacicchio incitano i maschi ad assalire le case (Luc2: 45-46);
nell’insurrezione di Gioia del Colle del 28 luglio 1861 Caterina Colacicco, dopo l’uccisione ad opera della folla
inferocita del garibaldino Vincenzo Pavone, che il giorno precedente aveva arrestato il marito, il bandito Nicola
Lillo, “ebbra di vendetta inzuppa il pane nel sangue e se ne ciba alla vista della turba plaudente”. Un’altra donna,
Margherita Giannico, “intinge le dita nel sangue che scorreva a fiotti dalle ferite, e se le porta alle labbra, forbendole con ferocia cannibalesca (Luc2: 47, da fonti processuali).
109
ACS, Roma, Tribunale Militare Speciale, b. 160, f. 1807, Interrogatorio del 1 luglio 1864 di Filomena Pote.
110
ACS, Roma, Tribunale Militare di Guerra per la repressione del brigantaggio nelle provincie meridionali, b. 192
(Salerno), fasc. 2312 (1865), sentenza 427.
107
121
Q
uaderni
to che trova conferma nelle memorie scritte
dagli stessi sequestrati, come quella di William Moens, in cui si legge che le brigantesse
della banda Cerino “non dimostravano affatto il temperamento selvaggio e sanguinario”
che ad esse comunemente si attribuiva111.
Conclusivamente, le efferatezze dei briganti e soprattutto delle brigantesse non
risultano adeguatamente documentate, ma
questo non implica necessariamente che esse
fossero una totale invenzione della gente o
degli scrittori e giornalisti. Furono parte di
un universo estremamente violento, quale
poteva essere quello di una guerra senza regole, anche se la gestione di tanta violenza fu
opera soprattutto dei maschi delle bande. Si
tratta perciò di liberare i nuclei di verità dalle
sovrapposizioni fantastiche o propagandistiche. Come accade nelle guerre civili, gli eccessi si commettono da tutti gli schieramenti, ed il torto di chi li racconta è spesso quello
di rovesciare la violenza, con le esagerazioni
istintive che l’orrore produce o che il bisogno di demonizzare il nemico suggerisce,
interamente sulla parte opposta. È indubbio
che non solo la durezza, ma anche la crudeltà
rientrava tra le qualità che si richiedevano a
un guerrigliero, e in modo particolare ai leader, e le donne in genere poterono mostrare in non pochi casi di averne abbastanza. Il
difetto di chi l’ha in qualche modo testimoniata è stato quello di presentarla unicamente come un eccesso irrazionale se non come
una patologia derivata da tare ereditarie, sicché tocca a noi cercare di comprendere la logica di questi comportamenti, sia pure senza
disgiungerla dalla loro irragionevole deriva.
Moe3: 9.
Fio: 51.
111
112
122
Radici culturali della crudeltà
A parte le differenze individuali, a volte
notevoli, gli insorgenti, come i gangaceiros
brasiliani, “erano timidi e gentili, induriti
dalla vita, resi feroci dall’abitudine e dalla
necessità. Imboccato il cammino della macchia, non si poteva tornare indietro: cambiavano solo certi parametri, certe misure.
La spietatezza e l’estrema crudeltà facevano
parte della loro esistenza, dei loro principi:
non erano casuali, ma rientravano nel quadro delle loro leggi”112.
Nel postrisorgimento, che per la realtà
in cui vivono i briganti non è ancora l’inizio dell’età moderna, il peso dei quotidiani
supplizi pubblici dei rei o presunti tali, che
ha segnato le abitudini e l’immaginario collettivo per secoli, è ancora forte nella sensibilità e negli atteggiamenti della gente. L’antica
familiarità dei vivi con la morte, che segna
tutte le civiltà preindustriali, ha sempre avuto un risvolto violento e sadico, che si trasferisce, pressoché inalterato, in una situazione
altamente critica come quella del Meridione
postunitario. Molti modi e atti di crudeltà
precedentemente previsti e prescritti hanno cessato di essere permessi o tollerati o
obbligatori, ma “dormono” ancora dentro i
saperi accumulati da secoli, se non da millenni. I condannati a morte fino alle soglie
dell’età moderna erano esseri diabolici che
dovevano essere messi alla gogna, decapitati, impiccati, bruciati, squartati, affogati,
“rotti” (ossia slegati e spezzati), scuoiati,
impalati, crocefissi, castrati, e l’esecuzione
era uno spettacolo pubblico al quale era per
antropologia e storia
molto tempo obbligatorio assistere, con una
sequela di atti, anteriori e successivi all’eliminazione, ulteriormente punitivi o raccapriccianti, quali esporre la vittima al dileggio e
al ludibrio mediante la cavalcata sull’asino,
raccogliere e leccare il sangue del giustiziato, negare la sepoltura cristiana, disperdere
i resti corporei (ceneri o arti mutilati), ecc.
Stato e Chiesa collaboravano e prosperavano in questa scuola di violenza e crudeltà,
mentre questa eredità di inaudita ferocia
metteva nelle popolazioni salde radici. Molti atti crudeli dei briganti e dei soldati che li
combattevano appaiono, a ben vedere, una
prosecuzione mimetica dei supplizi tradizionali e trovavano nel loro ricordo non solo le
modalità dell’esecuzione, ma anche la legittimazione a compierli. Lo dimostra anche il
diverso trattamento riservato agli uomini e
alle donne: come nei supplizi, gli uomini potevano essere torturati, squartati ecc., ma le
donne colpevoli di delazione o di tradimento
venivano dai briganti semplicemente uccise,
spesso, dopo essere state stuprate. Come di
solito accade nelle culture religiose e in quella cattolica in particolare, la maggiore indulgenza nei confronti delle donne non era una
forma di rispetto, ma discendeva dall’idea
diffusa dell’inferiorità naturale della donna, che la rendeva meno responsabile degli
uomini: un atteggiamento che ritroveremo,
pressoché identico, nei giudizi dei tribunali
nei confronti delle brigantesse113.
Le maggiori efferatezze dei briganti sono
quelle che si abbattono sui traditori o su
coloro che essi alla luce dei loro valori consideravano tali. Anche presso i gangaceiros
/ 2 – comicità e politica
“il traditore (sempre esterno al gruppo, ché
tra di loro i traditori non ci sono mai stati)
doveva essere sgozzato e dissanguato come
un maiale per servire da esempio”114. Anche
tra i briganti erano pressoché inesistenti i
traditori, ma essi consideravano tali le spie,
le guide e soprattutto i militi della Guardia
Nazionale e gli squadriglieri, perché ai loro
occhi erano traditori della propria gente, e
andavano puniti come tali, secondo la legge del taglione. Questi supplizi briganteschi
dei traditori sono una replica delle più feroci
pratiche ancora vive nelle nazioni civili nel
secolo XVIII e nella metà del secolo successivo, quando il reo di tradimento si suppliziava con “il ventre aperto, e gli intestini
strappati fuori in fretta, perché abbia il tempo di vedere, con i suoi occhi, che vengono
gettati sul fuoco, e in cui alla fine viene decapitato e il suo corpo diviso in quarti”115. La
storia ha le sue perversioni, che nessuna pietas può costringerci ad accettare. Ma quello
che maggiormente stupisce è l’anacronismo
storico, la persistenza o la rinascita di forme canoniche di violenza in un momento in
cui l’Italia pretendeva di essere entrata nella modernità, che situa in una sinistra luce
di barbarie, prima dei briganti, un esercito
moderno, “piemontese”, ossia largamente
rappresentativo della parte dell’Italia che si
presumeva più evoluta e civile. In fatto di efferatezze i briganti non furono da meno, ma
essi vivevano in un diverso orizzonte, in cui
la violenza legale, che fondava la redenzione
dei supplizi, faceva parte del loro sistema di
vita, era il passato che non passa e che non
muore.
Stie: 47.
Fio: 35.
115
Fouc: 14.
113
114
123
Q
uaderni
Senza indulgere a un giustificazionismo
assoluto, occorre innanzitutto riconoscere
che alcune pratiche efferate dei briganti appartenevano a molti degli eserciti che operavano in tempi di guerra, non esclusi i militari regolari e irregolari che combattevano i
briganti, anche se all’epoca del brigantaggio
erano di solito proibite: tali erano, per esempio, l’eliminazione dei prigionieri, la decapitazione dei cadaveri, lo stupro delle donne
del nemico.
Certamente l’eccesso di violenza obbediva anche alla logica della deterrenza, lucidamente programmata e perseguita anche
dalle bande oltre che dall’esercito, ma era
scatenato anche dall’impulso primordiale
della vendetta, che trovava peraltro una legittimazione nella legge, popolarmente condivisa, del taglione. Come accade in tutte le
guerre civili, molti dei briganti avevano perduto parenti e amici, avevano visto distruggere i loro paesi, fucilare i loro compagni
di lotta, perseguitare, deportare, incarcerare, torturare i loro familiari, e tanto orrore
faceva assumere alla guerra la deriva della
vendetta più feroce. L’efferatezza dei briganti era spesso una risposta all’efferatezza delle forze di repressione, soldati, carabinieri,
guardie nazionali, squadriglieri: a tutti costoro i briganti non perdonavano i compagni presi con le armi in pugno fucilati senza
pietà e i loro cadaveri esposti nelle piazze dei
paesi d’origine; le teste tagliate per farne un
trofeo e fatte portare dagli stessi compagni
dell’ucciso116, le donne della banda costrette
a portare la testa recisa del proprio uomo o
di altro brigante: “dopo le selvagge repressioni di Pontelandolfo e Casalduni specialmente – testimonia un memorialista antiunitario – si riaccesero le reazioni popolari e
lo spirito di vendetta, e la guerra di sterminio
contro gli oppressori e traditori della patria.
Onde che, proclamata la guerra civile a tutta
oltranza, oppressi ed oppressori bruttarono
di rapine, d’incendi, di azioni nefande e di
sangue questo nostro un dì felice Reame”117.
Ma c’era un altro spirito di vendetta, che
si trasmetteva, muto, da una generazione
all’altra, in attesa di poter gridare le sue parole di sangue. Vito di Gianni, ossia Totaro,
dichiarò dopo la sua costituzione: “Fummo
calpestati, noi ci vendicammo”, con le uccisioni, le grassazioni, i sequestri, le stragi di
animali, gli incendi e la distruzione dei beni
dei possidenti. C’era, prima di tutto, da vendicare l’onore offeso. “Nei piccoli centri il
potere del feudatario o del borghese, del funzionario o del padrone era usato non di rado
per attirare le donne dei contadini: quando
non cedevano volontariamente erano persecuzioni lunghissime ai mariti, ai fratelli, ai
padri. Era il disonore sotto altra forma; era
Per volontà dei militari la testa del brigante Nicola Langerano rimase esposta nella piazza di Picerno per due giorni
(ASP, Atti e Proc. di Val. Stor., cartella n. 243/4; cfr. Varu: 45); il generale Franzini cattura tre briganti presso Lagopesole, e in Ripacandida li fa uccidere e mozzare la testa. Peggio le Guardie Nazionali: il capitano di Santarcangelo
recide la testa del brigante Moliternese e la manda al sindaco (ASP, Atti e Proc. di Val. Stor., cartella n. 325/3; cfr.
Varu: 59). L’8 aprile 1864 ai briganti della banda di Rocco Scerra rimasti sul terreno dopo lo scontro con la Guardia
Nazionale nel territorio di Tricarico sono tagliate le teste, che vengono portate in trionfo nel paese (ASP, Atti e
Proc. di Val. Stor., cartella n. 285/86; PanR: 545; cfr. Varu: 77). Anche nelle bande, ovviamente, c’erano i tagliatori
di teste: per esempio, Carmine Crocco fece troncare il capo del figlio del sindaco di Ruvo e lo portò in trionfo, con
accompagnamento musicale (ASP, Atti e Proc. di Val. Stor., cartella n. 242/124; Varu: 43).
117
Butt: 81.
116
124
antropologia e storia
la miseria; era la sopraffazione quotidiana.
Come resistere in una lotta così impari? Le
nature deboli si avvilivano e tolleravano; ma
gli uomini risoluti si davano alla campagna,
si facevano briganti; si ribellavano insomma nella sola forma che era loro possibile.
La gioia di uccidere dopo aver sofferto l’oltraggio supremo; la suprema gioia di vendicare e di vendicarsi dopo aver tanto penato,
tentavano anche le nature meno cattive. La
religione avea indulgenze per i forti; e ne
aveano ancor più i funzionari dello Stato. Il
brigantaggio diventava un mezzo di salvezza e un mezzo di riabilitazione. Al marito
oltraggiato, all’uomo perseguitato rendeva
quasi sempre la stima del pubblico, qualche
volta la tranquillità dello spirito, la gioia di
vivere. Le persone aut laws hanno avuta
sempre una certa attrazione: maggiore essa
dovea essere in una società, in cui le leggi
erano pessime”118.
Alcuni capibanda dei più feroci sono
proietti, e il più sanguinario di tutti, secondo una vulgata scarsamente controllata, è Coppa, figlio naturale di un possidente della ricca famiglia Fortunato, di
Rionero in Vulture. Difficile la situazione
dei figli naturali. Per la gente sono cavalli
mancati, “muli”. Per la Chiesa essi sono i
figli della colpa, meritevoli di aiuto caritatevole; per i genitori biologici i “muli”
non possono accampare diritti ereditari, ma devono essere aiutati senza essere
riconosciuti; per la gente la madre è una
“malafemmina”, perciò i figli della colpa
non possono amarla senza riserve, ma
odiano soprattutto il padre, responsabile
della loro menomazione sociale. La loro
/ 2 – comicità e politica
guerra è contro l’ordine morale del padre,
contro la società dei possidenti.
Il fatto che queste violenze avvenissero
secondo le regole della guerra e i principi che
governavano la vendetta in contesti “primitivi”, se per un verso legittimava e scatenava
la violenza, per un altro evitava le sue forme
più cieche e disperate che accompagnano
l’espulsione dal gruppo sociale e la disintegrazione delle forme culturali. Tuttavia la
violenza del brigante ha anche a che fare con
la sua sindrome da stress post-traumatico.
Al momento della sua uscita in campagna
egli si ritrova “forbandito”, espulso dalla società e privato di ogni diritto; nomade senza
casa né averi né fissa dimora; possibile preda
di cacciatori di taglie e di premi; esposto ai
pericoli del freddo, della fame, della notte e
dell’inverno; soggetto al rischio di progressiva deculturazione, per la perdita dei modelli, dei maestri, degli amici, delle regole del
gruppo; privato di identità sociale e culturale. E rischia il destino della mala morte, della perdita della sepoltura e della perdizione
eterna, della distruzione del cadavere o dello
strazio del corpo che condanna la memoria
all’abominio.
Quello che maggiormente angoscia il
brigante è la paura del tradimento. Sa che
non tutti i conoscenti gli sono amici fino
in fondo, che la taglia che pende sulla sua
testa può fare gola a qualcuno, che portare
la sua testa mozzata alle autorità può fare
ricco l’assassino, che la libertà, garantita
dalla legge, di uccidere in qualunque modo
i briganti può risvegliare odi assopiti e rancori e vendette non consumati. Perturbante,
quanto la mano assassina di un familiare,
Nitt: 54.
118
125
Q
uaderni
il tradimento inquieta i giorni e le notti del
brigante e alimenta un odio senza limiti e
misura. A questo si aggiunga la memoria
remota del cumulo dei torti e delle violenze
subite e quella più recente della carcerazione
della propria famiglia e degli stupri inflitti
alle proprie donne e della disgregazione del
tessuto familiare e sociale. Il trauma, mai superato, e semmai costantemente dormiente
e sempre pronto a riemergere, provoca il
disordine esistenziale in cui rischia di affondare la vita del fuorilegge, e rende ragione
delle forme abnormi di violenza, della sua
crudeltà e delle sue efferatezze.
L’integrazione del brigante nel gruppo
dei fuorusciti, che è comunque un gruppo
formale, retto da principi nuovi ma congeniali alla cultura del villaggio, non comporta
il totale superamento della crisi, ma rappresenta la subordinazione della violenza ad
un mondo di regole, dotate di funzionalità
e di misura nella loro durezza. Sotto questo
aspetto il gruppo forbandito rappresenta il
superamento, mai definitivo e totale, della
crisi da stress post-traumatico.
Il potere dello spavento
Violenza e crudeltà erano gestite anche
in vista degli effetti che provocavano, innegabilmente favorevoli alla guerriglia: la crudeltà suscitava sia nei soldati che nella popolazione spavento e terrore, che potevano
essere utilizzati per gli scopi che i briganti
si prefiggevano: ottenere l’obbedienza dei
gregari, guadagnare sovvenzioni e vettovaglie, scoraggiare i filogovernativi; atterrire i
complici e alleati infedeli. L’immagine di un
capo terribile rafforzava il suo potere sui subordinati. I grandi capi sapevano però che,
126
per ottenere questo risultato occorreva associarlo all’amore, preoccupandosi che l’amore non venisse scambiato per debolezza,
che avrebbe comportato il rischio di perdere
l’appoggio dei gregari.
In un certo senso e fino a un certo punto,
le efferatezze erano inevitabili: per tenere in
piedi la guerriglia, i briganti dovevano assicurarsi quanto era necessario alla propria
sopravvivenza, garantendosi viveri, vestiti
e munizioni mediante generose elargizioni,
che servivano anche a creare una fitta rete
di cointeressenze, complicità e connivenze;
ma, non disponendo di mezzi finanziari,
era inevitabile che essi facessero richieste e
imposizioni alla popolazione, e, in caso di
resistenze e dinieghi, ricorressero a rappresaglie, sequestri e stragi di animali, ferimenti
e uccisioni. Queste operazioni obbedivano a
una logica elementarissima, ma di grande
efficacia, quella della “mors tua, vita mea”:
era giusto tagliare le orecchie ai sequestrati,
maltrattarli e in qualche caso ucciderli, perché il pagamento del riscatto rendeva possibile la vita alla macchia. In fondo, quelli che
diventavano le loro vittime appartenevano
al ceto dei loro persecutori.
Nel codice brigantesco era indispensabile conservare il favore della popolazione,
non commettendo abusi e prevaricazioni
nei confronti di essa, ma al tempo stesso era
obbligatorio punire in maniera esemplare
quelli che stavano dalla parte dell’esercito e
dei liberali unitari. L’efferatezza delle punizioni nei loro confronti aveva una funzione
di deterrenza e si abbatteva soprattutto su
soggetti della propria comunità di appartenenza, che venivano considerati traditori
della propria gente. Più odiati dei soldati
erano perciò i volontari della Guardia Nazionale locale, gli squadriglieri e i “patrioti”
antropologia e storia
antilegittimisti. Allo stesso modo venivano trattati le guide dell’esercito e tutti gli
altri collaborazionisti. Come ha scritto un
osservatore di quegli anni, “i briganti non
amano attaccarsi con la truppa, che sanno
essere chiamata al dovere e perseguitarli,
bensì con le cosiddette squadriglie, che stimano come genti mercenarie e più triste di
loro”119.
Nella maniera più atroce venivano giustiziati i traditori in senso stretto, ossia quelli che appartenevano alle bande o avevano
un rapporto di fiducia con esse e che invece
tradivano i briganti. Il modo più frequente
era la condanna al rogo, come gli eretici e
le streghe, come i presunti traditori della
fede. Venivano spesso punite anche le donne
dei traditori. Il rogo non era l’unica forma
di supplizio. Ai traditori si inchiodavano
le mani al suolo, ma potevano anche essere
squartati, come nel supplizio del porco, oltre che decapitati, con l’aggiunta del sasso in
bocca, e perfino impalati. In effetti quasi tutti i supplizi, che esamineremo, concernono,
significativamente, i traditori, che erano la
categoria più consistete delle persone esposte a questi rituali punitivi.
Le bande non facevano prigionieri, e uccidevano i soldati catturati, perché non erano in condizione di tenerli. Tuttavia questa
regola, come tutte le regole non scritte, non
era seguita da tutti. Crocco, per esempio,
faceva importanti distinzioni: “Cosa faremo
dei prigionieri? Se attaccati saremo costretti a fuggire, chi è vivo ha per dovere, prima
/ 2 – comicità e politica
della fuga, uccidere quanti più ne può, almeno i morti non parleranno; all’opposto,
se non saremo oltre molestati, domanderò
il cambio di essi con l’unico nostro”. Stranamente, in questa terribile guerra, mentre
soldati e guardie nazionali non facevano prigionieri, i briganti, grazie anche all’intercessione delle loro donne, spesso liberavano i
militari caduti nelle loro mani, specie se non
erano piemontesi. Nessuna pietà, invece,
per squadriglieri, traditori e spie. Sappiamo
di due soldati in licenza catturati dai briganti, che prima pensano di ucciderli, poi li lasciano liberi, a condizione che facciano dire
una messa120.
Se le donne erano pietose, Crocco, comandante di un temutissimo esercito di
duemila uomini e trecento e più cavalieri,
era per un uso moderato della violenza, e
riteneva perciò eccessivo il timore suscitato
dalla sua presunta crudeltà: “Concorrevano
ad aumentare la paura le esagerate asserzioni di atti ferocissimi da noi compiuti. Non
nego che il Coppa, il Ninco Nanco, il Caruso
stesso, abbiano qualche volta commessi atti
feroci sui feriti, e qualche altra fatto scempio
dei cadaveri dei caduti, ma nego che da me
non si sia mai dato ricovero ad alcuno, e che
vigesse in conseguenza l’ordine di uccidere
borghesi, ufficiali, soldati che cadevano nelle mie mani; (…) io, quando ho potuto, ho
fatto mettere in libertà tutti coloro che capitavano in mezzo ai briganti, a qualunque
colore appartenessero, sia cioè che fossero
stati liberali, sia che fossero stati reaziona-
Sto3: 53. Vincenzo Padula, attento osservatore del brigantaggio postunitario, osservava: “I briganti non dimenticano nulla, e se perdonano al soldato, non la perdonano agli squadriglieri, perché dicono: ‘Il soldato è nel dovere di
perseguitarci; ma uno squadrigliere, che per quattro carlini al giorno viene a darci la caccia, è un assassino’. Questa
logica parrà strana, ma è quella dei nostri briganti” (Pad: 118).
120
Zimm: 286; Cro2: 86; Croci: 336.
119
127
Q
uaderni
ri”121. Mentre negli eserciti regolari il lavoro
sporco spettava ai semplici subordinati, tra
i briganti i più duri e spietati dovevano essere i capi: era, per esempio, costume che,
emessa una condanna a morte, spettasse ai
capibanda eseguire la sentenza122.
Una spiegazione funzionale si riconosce, pur nella presenza di una cifra intensamente emotiva se non nevrotica, ispirata
dalla vendetta, anche nell’accanimento dei
briganti sui corpi dei militari uccisi, che venivano seviziati e spogliati. Il regolamento
di Andreozzi sopra ricordato spiega che lo
scempio dei corpi va fatto, “in modo da impressionare i soldati quando li troveranno.
Il soldato quando si batterà, penserà sempre
alla fine che lo aspetta se cade ferito o prigioniero, e quando vedrà le brutte scapperà”123.
La somiglianza con le pratiche analoghe dei
soldati è soltanto apparente: i briganti spogliavano i militari anche per impadronirsi
dei loro vestiti, mentre i soldati spogliavano
i cadaveri dei briganti per dileggio.
C’erano, dunque, elementi di ordine
emotivo e culturale, che attraverso il rito
consentivano la degradazione estrema
dell’avversario, la sua mutilazione, la sua riduzione a carne inanimata, a cenere, e questo annientamento di ogni forma residua di
umanità rendeva a sua volta possibile il massacro senza rimorsi. Oltre la rappresentazione dei nemici locali come infami traditori,
nei confronti dei nemici esterni, i soldati, si
operava una sorta di razzismo alla rovescia,
123
124
125
126
121
122
128
che restituiva, maggiorato, ai “piemontesi”
il senso di inferiorità con cui questi ultimi
percepivano i briganti, i borbonici e i meridionali in generale.
Il fondamentalismo religioso, l’idea della
guerra santa collabora a questo risultato. Lo
rilevava già un perspicace ufficiale dell’esercito incaricato della repressione: “Il brigante
nel sangue che versa, nelle vittime che sgozza, tranquillizza la sua coscienza non solo,
ma si circonda di una frenesia di delirio, di
orgoglio, ritenendosi strumento della divinità, martire della fede”124. Forse va in questa direzione la risposta che un gangaceiro,
ormai ritirato a vita privata, diede a un giornalista che lo intervistava “su quanti uomini
esattamente avesse ucciso”: il bandito a riposo rispose: – Ma, dottore, chi uccide è il
Padreterno: io ho fatto solo il forellino”125.
Il brigante non ha esitazioni o rimorsi, perché si sente punitore collettivo, delegato da
Dio e/o dalla comunità a compiere il crimine nella forma spietata consacrata dal rito e
dalla tradizione. Nella sua esaltazione quasi
religiosa egli “tranquillizza la sua coscienza”, perché “si vede benedetto da preti che
gli offrono amuleti e immagini sacre, che
lo salvano dal ferro nemico; incoraggiato
da ricchi signori; protetto da innumerevoli
amici e parenti, onde con coraggio degno di
miglior causa affronta i pericoli di una vita
travagliata e infame, e si tiene con ardita e
rara ostinatezza fedele fino all’ultimo momento al suo capo ed ai suoi compagni”126.
Cro2: 107; Cro2: Appendice: 167.
ASSU, Fondo giudiziario, busta 27, fasc. 210, 14 gennaio 1868, Corte d’ Appello degli Abruzi; Tor1: 67.
Bart: 39. ?
Bour: 86-87.
Fio: 28.
Bour: 87.
antropologia e storia
In questa logica rientra la spettacolarizzazione del crimine: l’annientamento del
nemico è manifestazione e segnale di potenza, ostentazione della forma suprema della
sovranità, quella di disporre della vita e della
morte degli altri, di avere la signoria assoluta
del loro corpo, che potrà essere frantumato
e lacerato, rinnovando l’azione di forza che
ha spento la vita. L’euforia della vittoria, del
potere e del possesso si trasforma in un osceno banchetto carnevalesco, con lo scempio
gioioso dei corpi: il massacro del corpo distrugge l’umanità della vittima, cancellando
il rimorso e trasformando l’azione crudele
in un “atto dovuto”, e l’effervescenza che lo
accompagna è rafforzata dalla comune condivisione. Così facendo si è convinti “di aver
contribuito al raggiungimento dei fini – in
positivo o in negativo – per i quali la banda
si era costituita”127.
Senza ridurre interamente la crudeltà a
una modalità culturale, oltre che alle logiche di una psicologia di guerra “arcaiche”,
si può pensare a una combinazione di pulsioni e di pratiche di guerra consolidate e
culturalmente tollerate, se non del tutto approvate. Questa crudeltà va capita, più che
negata. Lo stesso Crocco contestò le “esagerate asserzioni di atti ferocissimi” compiuti
dai briganti, ma dovette ammettere, sia pure
minimizzando, che “qualche volta” Coppa,
Ninco Nanco, Caruso avevano “commessi atti atroci sui feriti”128. Si trattava dello
scempio del corpo del nemico, con smembramenti e mutilazioni dei corpi ancora vivi,
secondo le modalità della legge del taglione; dell’uso di esporre i pezzi del corpo in
/ 2 – comicità e politica
vari luoghi, cavare gli occhi ai vivi, evirare,
tagliare il naso, strappare la barba e i baffi,
tagliare il pizzo piemontese, decapitare e poi
mettere il sasso in bocca, trascinare il corpo
del nemico, seppellirlo da vivo, mettere al
rogo, specialmente i traditori, inchiodare le
loro mani al suolo, praticare il “supplizio del
porco” (ossia scannare e appendere come si
fa con i maiali), impalare (molto raro), bruciare i resti dei corpi nemici, bere il sangue e
mangiare parti del corpo. […]
La ferocia della repressione
Nella propaganda dell’esercito gli eccessi
dei briganti servirono a coprire la repressione dei militari, che andò oltre ogni possibile limite etico-giuridico, verso una sorta
di guerra di sterminio. Gli ordini erano di
non fare prigionieri, e valeva non solo per
i briganti trovati con le armi in mano, (ma
frequentemente senza armi e senza combattere), e si applicava, spesso a dispetto degli
ordini ufficiali, ai parenti, ai conniventi e ai
manutengoli, ma anche alle persone sospettate di brigantaggio e perfino, a volte, agli
“indifferenti”, ossia a coloro che non prendevano le armi per combattere i briganti.
Si effettuarono per rappresaglia distruzioni
e incendi di paesi, si distrussero le case dei
briganti, si adottarono torture e supplizi sui
prigionieri (la tortura dei pollici, dei ferri
corti, il digiuno, le bastonate); si fucilavano i
briganti catturati sul campo o dopo averli riportati nei loro paesi, senza fare ad essi nessuna concessione; furono assassinati degli
LeBo: 202.
Cro2: 107.
127
128
129
Q
uaderni
innocenti fatti passare per briganti, si spogliavano i morti e i vivi, con la mutilazione
dei corpi, non si risparmiavano i minorenni
né le donne, si facevano evadere i prigionieri
per ucciderli mentre fuggivano o li si uccidevano nelle carceri stesse. […]
Militari e militi locali non solo non rispettavano i vivi e i morti, ma negavano la
compassionevole assistenza ai feriti. Il 9 settembre 1863 la banda di Nicola Napolitano
(Caprariello) fu circondata dai bersaglieri
nella masseria Taglia. Dopo una furiosa sparatoria, caduti alcuni briganti, Napolitano rifiutò di arrendersi e si sparò alla gola. Il colpo gli spaccò la mascella, ma non lo uccise.
I bersaglieri formarono subito il Tribunale
militare, che lo fece fucilare all’istante insieme al brigante Nappi, sebbene fosse morente129. Quando i legittimisti presero Scurcola
al comando dell’ex garibaldino Piccione, i
feriti furono collocati sulle panche del corpo
di guardia della Guardia Nazionale; di notte i
soldati occuparono di sorpresa il paese, uccisero quei feriti e insultarono e sputarono sul
chirurgo e il cappellano, prima di fucilarli130.
Nel dicembre 1865 i carabinieri circondano
la casa dove si trova Cappuccino. Il capobanda si butta dalla finestra, storpiandosi. Viene portato in paese e fucilato in quello stato pietoso131. Nel 1862 la Legione Ausiliaria
Ungherese cattura un brigante gravemente
ferito e lo fucila. Subito dopo è fucilata sua
moglie, una brigantessa accusata di efferatezze durante la reazione di Ruvo132.
131
132
133
134
129
130
130
ASC, Roma, Gabinetto Prefettura, b. 250, f. 2567.
DeSi: 78; in Grec: 178.
Mian: 57.
AUSSME, b. 34, pp. 5, 11.
Butt: 83.
Pro1: 99; in Deja: 317.
Come sappiamo, le persone arrestate dai
militari erano costrette a raggiungere a marce forzate carceri e luoghi di raccolta distanti
decine di chilometri Quelli che non tenevano
il passo venivano bastonati e persino uccisi.
Padre Tofano dei Passionisti di Caiazzo, arrestato dai soldati di Pinelli, fu mandato legato
a Caserta. “Quel buon religioso, stanco ed abbattuto anche a causa degli strapazzi e sevizie
che gl’infliggevano, cadde sopra un mucchio
di pietre, divenuto impotente a proseguire la
marcia. Però i satelliti di Pinelli se ne sbarazzarono da valorosi moschettandolo”133.
I militari non aiutavano i nemici feriti a
vivere, ma nemmeno a morire. Né la cura,
né il colpo di grazia: quando catturavano un
brigante ferito, lo tenevano in carcere senza
curarlo, affinché la ferita degenerasse in tetano e il prigioniero si spegnesse tra atroci
sofferenze134.
La punizione dei soldati andava oltre l’esecuzione capitale. Si voleva che il presunto
reo perdesse l’anima, negandogli i conforti religiosi e la possibilità di confessarsi. Il
maggiore Franchini in Somma, “arrestò sei
persone nelle proprie abitazioni in mezzo
alle loro famiglie, cioè un Mauro ottuagenario e suo nipote, don Francesco Persico, uno
Scatena mercante di vino, un giovanetto,
certo Scozio de’ più ricchi del paese, ed un
Romano possidente, tutti sei designati dal
capitano de’ nazionali. Li fece condurre in
piazza, e dopo di aver negato a’ medesimi il
confessore, li fucilò, facendoli gettare in un
antropologia e storia
immondezzaio”. Soldati piemontesi conducono al supplizio i prigionieri negando loro
“i supremi conforti della fede”. Quando corsero a Paduli che si era ribellata, “issofatto
cinque persone, lor negando il confessore,
fucilarono”. Presso Pozzuoli “un altro uffiziale, richiesto d’un prete dal paziente, risponde: – Ti confesserai sotterra”. Furono
inutili le proteste di un sacerdote135.
Per vincere i briganti i militari non ebbero scrupoli a ricorrere all’assassinio dei
loro capi, servendosi di traditori o di donne
di piacere prezzolate o pagando le donne da
essi abbandonate e desiderose di vendetta. Il
mezzo più efficace sembrava essere il veleno.
Il vino che i briganti ricevevano in seguito a
loro richiesta o come dono di manutengoli,
amici, alleati ecc. poteva essere avvelenato
o “oppiato”, che nel linguaggio del tempo
e del luogo significava trattato con qualche
sonnifero. In questo secondo caso serviva ad
addormentare il brigante e facilitare il suo
arresto. Se raramente i briganti cadevano
nell’inganno, questo è dipeso dal loro uso di
far assaggiare il vino agli stessi messaggeri
che lo portavano.
Lo stesso può dirsi del cibo. Pare che i
capibanda Monaco e Franco collezionassero il numero maggiore di tentativi di avvelenamento, tutti andati a vuoto, anche
perché molti briganti si cucinavano da soli
o si affidavano per il pranzo a fidatissime
brigantesse. Si diceva che Monaco, che assai raramente beveva, non corse il rischio di
morire avvelenato, perché per lui cucinava
Maria Oliverio. Era la guerra dei veleni, antica quanto la guerra stessa.
/ 2 – comicità e politica
Torce d’uomini
In un proclama di Fucino, comandante
della Capitanata, si leggeva: “Vi lascio, ma
v’avverto che se ritornano i briganti, io pure
ritornerò, e vi arderò a’ quattro angoli”136.
Senza possibilità di equivocare, la minaccia
era sia per i briganti che per la gente che li
avesse accolti, magari subendoli come “indifferenti” e probabilmente contrari. Bruciare briganti e assimilati era anche un rito
di purificazione, oltre che di punizione, analogo all’incendio delle loro case: tutto, del
brigante, doveva essere ridotto in cenere.
Il rogo dei briganti non era solo un’idea
dei combattenti più crudeli o degenerati,
ma piuttosto (o anche) una pratica bellica
e sociale, ereditata dal passato. In Roma venivano bruciati vivi gli omosessuali passivi,
i maghi e gli incendiari, responsabili dei
reati più infami. Dal Medio Evo venivano
bruciati ritualmente gli eretici, le streghe, i
sacrileghi, i parricidi, i sodomiti, gli incendiari, dopo averli coperti di paglia fino alla
testa. Queste esperienze segnarono l’immaginario collettivo, e si ritrovano fin nel
sapere guerresco sia dei militari italiani che
dei briganti. La vivicombustione aggiungeva alla peggiore morte che si potesse immaginare una pena accessoria, la riduzione del
corpo in cenere e la dispersione di quest’ ultima, che privava il morto della possibilità
della ricostituzione del corpo nel giorno del
Giudizio Universale. Già prima del cristianesimo il rogo “condannava oltre al corpo
l’anima del condannato”, che diventava
un’anima vagante”137.
Butt: 58; Pro1: 101; in Deja: 317; DeSi: 63 in Grec: 192, 191; AUSSME, b. 7, pp. 215-16.
Butt: 46.
137
Canta: 225.
135
136
131
Q
uaderni
Un forte concentramento di truppa assedia una masseria presso Lavello in cui sono
asserragliati ventidue briganti della banda
Carbone: gli assediati si difendono “feroci
quasi tigri” rifiutandosi di arrendersi e alla
fine, per evitare altre perdite di soldati, i
militari decidono di bruciare vivi i briganti
lanciando sul tetto materiale infiammabile.
Nelle ceneri della casa si troveranno corpi
bruciati di uomini e cavalli138. Nel bosco di
Montemilone diciannove briganti pugliesi
si difendono aspramente in un pagliaio assediato dalla truppa e muoiono bruciati vivi139.
Il 12 dicembre 1862 cavalleria e guardie nazionali assaltano nella tenuta di Polcano una
banda e uccidono 4 briganti; altri 4 si chiudono nella masseria e si rifiutano di arrendersi.
Gli assedianti appiccano il fuoco e i briganti muoiono tra le fiamme140. Il 20 dicembre
1862 cavalleggeri di Saluzzo, soldati e guardie
nazionali e carabinieri nel territorio di Venosa assediano una masseria dove gozzoviglia
una comitiva. Il comandante fa appiccare il
fuoco ai due pagliai vicini, le fiamme invadono e presto avvolgono la casa. Due ore dopo
i briganti erano sotto le macerie, inceneriti141.
A bruciare i briganti i militi indigeni non
erano da meno dei militari “piemontesi”.
Nel gennaio 1862 la Prefettura della Provincia di Basilicata incaricò Luigi Franchi,
importante proprietario terriero minacciato
dai briganti, di costituire la prima delle due
compagnie di Guardia Nazionale Mobile del
circondario di Matera. A capo di questo pic-
140
141
142
143
138
139
132
Neg2: 105; in DeJa: 253.
ASB in Luc: 47n.
Bour: 181.
DiTe: 136.
Coni: 85, 86.
Bour: 221, 222.
colo esercito Franchi fece una sorta di guerra personale ai briganti della zona, senza
regole e senza esclusione di colpi. Superò se
stesso quando, scoperti tra Scanzano e Policoro dei mandriani che avevano collaborato con i briganti, li fece chiudere in alcuni
pagliai, che poi vennero dati alle fiamme e i
mandriani furono bruciati vivi. Non molto
tempo dopo Franchi arrestò altri mandriani del territorio di Pisticci che avevano rapporti frequenti e intensi col brigante Pietro
Angerame di Montemurro (Occhio di Marrone): tenne consiglio con i suoi ufficiali,
quindi rinchiuse i mandriani nei pagliai e li
fece bruciare vivi142.
In molti casi i briganti per sottrarsi all’atrocità della vivicombustione rifiutavano la
resa, che essi sapevano essere l’anticamera
della fucilazione, e preferivano suicidarsi. Gli ultimi tre briganti della banda Lapia
Sacchetta che operava nel territorio di Candela, dopo la distruzione della loro comitiva
si erano chiusi in un casolare per l’estrema
resistenza; l’ufficiale dei bersaglieri, dopo un
duro scontro a fuoco, fece appiccare il fuoco
alla casa; i briganti prima di rimanere bruciati o prigionieri si suicidarono con i loro
revolver. Il 27 aprile 1865 i bersaglieri assediano il capobanda Marciano di Frigento
insieme a due gregari in un Casone del territorio di Candela. Poiché i briganti non si
arrendono, appiccano il fuoco e i tre prima
di essere raggiunti dalle fiamme si sparano
alla testa con le pistole143.
antropologia e storia
Simboliche politiche della morte
Le forme e gli strumenti della repressione
assumono frequentemente la veste di riti arcaici, con l’utilizzazione di elementi derivati
dai riti patibolari e dai repertori derisori carnevaleschi. Questi riti miravano a distruggere l’aura di eroismo che avvolgeva il brigante
nell’immaginario collettivo, nascondere l’efferatezza dell’esecuzione capitale o della punizione esemplare agli occhi stessi di chi la
compie, esorcizzare l’orrore della violenza,
trasformare il guerriero nemico e il nemico
politico in un capro espiatorio, convogliando su un personaggio reale l’ingente volume
di violenza tradizionalmente destinato alle
figure mitiche del male: l’avversario diventa la fonte dell’infezione che minaccia la
comunità, e l’esecuzione/punizione si configura come un rito crudele di purificazione: deresponsabilizzazione della crudeltà e
legittimazione della violenza di Stato, che
creano le condizioni per il massacro senza
rimorsi. La realtà inedita della repressione
ha imposto al rito un nuovo contenuto, e
il rito ha dato a sua volta la sua forma alla
repressione, riplasmandola e modificandola
nella ricezione del pubblico.
L’esecuzione capitale nelle intenzioni delle forze dell’ordine doveva essere uno spettacolo cui bisognava guadagnare il massimo
dell’audience, per sortire un effetto propagandistico e deterrente. In aggiunta, per celebrare la vittoria totale del potere e l’annientamento assoluto dell’antipotere, occorreva
infliggere il massimo dell’umiliazione agli
sconfitti, per evitare che essi acquistassero la
fisionomia di martiri e di eroi. Lo spettacolo
/ 2 – comicità e politica
si articolava in tre momenti: la parata, la messa a morte e l’esposizione del cadavere.
Quando era possibile, i condannati venivano portati nel paese dì origine per l’esecuzione, per accrescere l’effetto deterrenza
attraverso l’esposizione pubblica. Questa
prevedeva innanzitutto – quando era possibile – un percorso processionale dal carcere
fino al luogo in cui avveniva la fucilazione.
Quando era presente il fotografo, l’esposizione pubblica si ripeteva per un tempo illimitato. Sebbene non fosse previsto dalle regole
dell’esercito, la parata dei condannati poteva
assumere alcune forme violentemente arcaiche ancora vive nell’immaginario patibolare
della gente e a volte proprio da esse richieste e
sollecitate. Uno di questi modi era la cavalcata finale sull’asino. Vi fu sottoposto un capo
prestigioso, come Michele Caruso, durante il
percorso dal carcere al luogo della fucilazione. I militari di Benevento accolgono la domanda della gente di “farlo vedere” mentre
vanno a fucilarlo alla schiena; ma “sul cavallo
no, sul mulo un tantino meno; meglio metterlo su di un asino, strettamente legato”144.
Si tratta di una forma semplificata della “cavalcata sull’asino”, pena disonorante diffusa
in Europa già nel Medioevo, in cui i rei, uomini e donne, specialmente adultere e prostitute, venivano portati in giro per la città in
groppa ad un asino. Le scena si ripeteva nelle
forme violentemente giocose degli charivari
durante il Carnevale, con i personaggi puniti
in effige. L’asino era considerato un animale
demoniaco, maligno o benigno, ma in questo rito era identificato col diavolo. Il reo di
norma era seduto alla rovescia, posizione che
rispecchiava l’ordine dell’inferno. Un altro
Sang: 201.
144
133
Q
uaderni
capobrigante, Taccone, al tempo del generale francese Manhés, ebbe in Potenza la stessa
condanna, in forma più sofisticata.
Per convincere gli increduli, che non
volevano credere che il capobanda era stato
ucciso, perché immortale, “il corpo del Romano era stato caricato su di un asino e portato sulle piazze e di masseria in masseria,
come usano i cacciatori dopo aver abbattuto
il lupo. Lo portarono fin sotto la finestra della madre e della sorella. Il cadavere rimase
per una settimana esposto al pubblico. Era a
pezzi. Il volto irriconoscibile”145.
Questa l’esecuzione capitale di un brigante avvenuta in Sora, descritta dal capobrigante tedesco Zimmermann: “Il giorno
precedente, a Sora e dintorni, era già stata
resa nota l’ordinanza affinché i presenti
all’esecuzione fossero quanti più possibile.
Verso le dieci cominciarono a rullare alcuni
tamburi davanti alla prigione e comparvero
i condannati, a capo scoperto, con le mani
legate davanti e accompagnati da un religioso. Quando gli infelici giunsero sul luogo del
supplizio, i loro sguardi vagavano come se
cercassero tra le schiere dei loro compaesani; desideravano, probabilmente temevano,
di vedervi parenti ed amici e – cosa più spiacevole – di perdere all’ultimo la forza. Tuttavia andavano cercando i loro cari, inutilmente: erano stati incarcerati, per motivi di
prudenza, già da molti giorni. Sul lato aperto del quadrato dell’esecuzione, a distanza di
tre passi l’una dall’altra, si trovavano quattro
sedie di legno dove si portarono i prigionieri
147
148
149
145
146
134
Bour: 49.
Zimm: 81.82.
Zimm: 82.
Butt: 58.
Butt: 92.
dopo che ebbero pregato col loro sacerdote.
Furono fatti sedere a cavalcioni e li si legò
saldamente alla seggiola. Il plotone d’esecuzione si fermò alle loro spalle, perché “in tal
modo si dimostra che il brigante ha vissuto
senza onore e merita di morire ignominiosamente”146, come è scritto nelle circolari di
Cialdini. “In silenzio ed immobile, la rabbia
e il dolore nello sguardo, il popolo stava a
guardare tutti quei preparativi. (…) Ad ogni
sedia si avvicinarono quattro uomini, con i
fucili già pronti. Il comandante del plotone
sollevò in silenzio la spada, esplosero sedici colpi, e da uno di quegli scanni di morte
rimbalzò un breve ed intenso grido di dolore, che trovò cento volte eco tra la folla”147.
I corpi dei fucilati venivano lasciati sul
posto dell’esecuzione, prima della sepoltura. I fucilati di Sora “poi furono gettati su
un carretto e sotterrati lontano, fuori città,
in un punto nascosto della Valle di Roveto.
Nessuna croce, nessuna lapide indica il luogo in cui marciscono quatrro cuori leali e
coraggiosi. I piemontesi hanno, forse, già da
tempo dimenticato quel posto, ma il popolo
se lo ricorda e lo tiene in gran considerazione”. Il maggiore Franchini in Somma fucilò
sei persone e fece gettare i loro corpi “in un
immondezzaio”148. Nell’assalto al castello
dell’Isoletta i briganti di Chiavone, prima
vittoriosi, sono alla fine respinti. Il maggiore piemontese Savini fa fucilare i prigionieri, tra i quali è il giovane volontario Alfredo
Trazenies di Namur, e fa gettare i cadaveri in
un fosso149. Nell’invasione di Moschiano nel
antropologia e storia
Vallo di Lauro, tra la Terra di Lavoro e l’avellinese, restarono uccisi quattro moschianesi,
che furono sepolti, e due briganti, di cui non
si seppe mai che fine avessero fatto i loro cadaveri150.
La negazione di Antigone
Un soldato udinese ha saputo descrivere gli effetti della “misura immensamente
persuasiva” di “lasciare insepolti i fucilati”: prima i soldati seppellivano i briganti
dopo averli fucilati e “qui finiva tutto”; ma
quando, cambiata la pratica, le popolazioni “videro nei sagrati o nelle piazze i corpi
dei fucilati, paesani o non paesani, rimanere
esposti al sole ed alla pioggia, le cose cambiarono ad un tratto.Il castigo aveva servito di salutare esempio ai cattivi, di fiducia e
incoraggiamento ai buoni che diventarono
trattabili, perfino espansivi”151. Ma non era
sempre così. Spesso i luoghi dell’esecuzione
o del seppellimento diventavano sacrari nella memoria collettiva.
Secondo disposizioni ufficiali i cadaveri
dei briganti caduti in combattimento o fucilati venivano portati in paese, dove venivano
esposti nella pubblica piazza o nel quartiere
dove essi erano cresciuti. Era un atto dovuto, che consentiva di procedere all’identificazione formale del brigante, anche in funzione del pagamento delle taglie, dipendente
anch’esso dal riconoscimento ufficiale del
brigante ucciso e dell’uccisore. Era però al
152
153
154
150
151
/ 2 – comicità e politica
tempo stesso un rito orrendo, che aveva la
funzione di deterrenza, ma i cui effetti sulla popolazione andavano ben oltre. Nella
sua Istruzione teorica alle truppe il generale
Pallavicini aveva raccomandato: “I cadaveri
dei briganti caduti in uno scontro saranno
sempre trasportati nei paesi ad oggetto di
convincere maggiormente le popolazioni,
incredule sempre quando trattasi di vantaggi ottenuti dalle truppe”152.
Per i cacciatori di briganti però portare
il cadavere del nemico nel paese significava celebrare il proprio trionfo, oltre che riscuotere la taglia. Il trasporto dei cadaveri e
la loro esposizione nei paesi d’origine aveva
per le autorità anche il vantaggio di farli
recuperare e seppellire dai parenti; quando
questo non accadeva, i cadaveri, dopo giorni
di esposizione, venivano inumati dalle forze
dell’ordine153.
Per moltiplicare gli effetti orrifici e di
deterrenza, ai briganti e – quello che è più
scandaloso – alle brigantesse, venivano tolti i vestiti: consegnare i corpi alla loro impudica nudità, significava privarli dei segni
che ne facevano persone con l’attribuzione
di ruolo e decoro. Il corpo della brigantessa
Michelina Di Cesare fu portato straziato e
nudo nella piazza di Mignano come monito154: si soleva farlo per gli uomini, ma era
pressoché inedito per le donne. Oltre la lacerazione delle forme sociali, il denudamento
pubblico della donna innalzava a dismisura
il livello dell’oscenità, inserendo una componente morbosamente erotica, che equiva-
Mosc: 90.
Nove: 71; per altri casi interessanti di esposizione del cadavere dei briganti ved. Sait: 76, 98, 105.
DeWi: 296; anche in Mont: 59-60.
Fri2: 156.
Cro4: 107.
135
Q
uaderni
leva a una sorta di stupro, segno allucinato
di una rivincita e di una vendetta sulla totalità delle donne. Il denudamento delle vittime era un rito al quale non si voleva a tutti i
costi rinunciare. L’ispettore di P.S. di Foggia
fece disseppellire il cadavere di Coppolone
che, lavato e disinfettato, fu portato a Ginosa, il paese natale del capobanda155.
Nel luglio 1867 il tenente Carlo Bartolini, infiltratosi nella banda di Luigi Andreozzi, terrore della Terra di Lavoro, tra
Lazio e Abruzzo, elimina quattro briganti,
compreso il capobanda, che era diventato
suo amico. I cadaveri furono lasciati insepolti per 48 ore, ufficialmente in attesa del
riconoscimento ufficiale, ma intanto cominciavano a putrefarsi per le ferite ed il caldo,
per cui si decise di seppellirli. Il clero però
non volle occuparsene, perché, evidentemente filounitario, considerava i briganti
colpevoli di sacrilegio, ed ai sacrileghi la
Chiesa aveva sempre negato i conforti e la
sepoltura religiosa. L’autorità civile a sua
volta “se ne lavò le mani, i paesani spaventati, malgrado minaccie e promesse di ricompensa, si rifiutarono di scavare le fosse”.
A quel punto il Bartolini, “annoiato”, fece
bruciare i cadaveri: “la cremazione riuscì incompleta, e gli avanzi informi dei cadaveri
terminarono coll’essere pasto di numerosi
cani di pastori, che attratti dall’odore della
carne bruciata discesero al piano e ne fecero banchetto”. Effetto di una mescolanza di
dinieghi religiosi, di tattiche di deterrenza e
di paura diffusa, questo allucinato episodio
rimarrebbe in parte incomprensibile, se non
ci fosse, al fondo, una oscura volontà di in Mian: 60.
Bart: 85.
157
Coni: 48.
155
156
136
fierire su miseri resti umani, per annientare,
insieme al corpo, il resto immateriale che
gli sopravvive, la memoria. Poiché la civiltà
di un popolo si misura anche dal modo in
cui esso rispetta e accudisce i resti materiali
dell’esistenza, da più parti si gridò a questa
“efferata barbaria” (sic!), ma il tenente ebbe
una importante onorificenza dal governo156.
Cacciatori di teste e feste crudeli
I soldati, ma soprattutto le guardie nazionali e gli squadriglieri, di solito troncavano la testa ai briganti uccisi e qualche volta
ancora vivi. La si esibiva come trofeo, conficcata in un palo, che si portava in processione per il paese, e la si lasciava esposta per
alcuni giorni. La testa era il sostituto nobile
del corpo, che riusciva più difficile portare in
paese. Il resto del corpo veniva miseramente
ed anonimamente sepolto, come abbiamo
visto, e perfino bruciato. In non pochi casi
poteva essere fatto a pezzi, che venivano
trascinati negli altri luoghi che erano stati il
teatro dei suoi eccessi157.
Anche se probabilmente come tagliatori
di teste i meridionali, sia briganti che militi
locali e perfino gente comune, tenessero il
triste primato, sorprendentemente i soldati in alcuni casi mostrarono di superarli in
efferatezza. Nel luglio 1870 una pattuglia di
bersaglieri uccide in uno scontro a fuoco sui
monti della Sila il capobanda Talarico, e il
sergente “acciuffa pei capelli il morto, estrae
la sua sciabola baionetta poco tegliente,
mentre i bersaglieri lo tengono sollevato per
antropologia e storia
le braccia, mena replicati colpi sul collo per
staccarlo imbrattando di sangue la sua tunica e gli abiti dei soldati con qualche schizzo
nel viso di essi. Si fa aprire il suo tascapane
e vi ripone la testa sanguinolenta che durante la marcia gli arrossa i pantaloni di tela”.
Giunto a S. Giovanni in Fiore, il sergente
“estrae la testa e la infilza sulla baionetta
che tiene innastata sulla carabina tenuta a
Spallarm, ed entra colla pattuglia trionfante
in paese. A quell’orribile vista, la gente terrorizzata si mette a gridare Madonna dello
Carmine – la capa di Talarico”. Nel bar il
sergente è festeggiato dai galantuomini del
paese, ed egli “dopo aver deposto sul tavolo
la brutta testa, si mise a raccontare il fatto
impressionando gli astanti che ogni momento esclamavano Bravo Sergente”. La testa
viene portata al comando di Rossano, dove
viene fotografata. Il sergente tagliatore di teste fu premiato con la medaglia d’argento158.
La truppa del generale Franzini cattura a
Lagopesole tre briganti, che vengono portati
a Ripacandida e decapitati, forse vivi. Il 20
marzo 1864 Egidio Pugliese è sconfitto e ucciso da carabinieri e guardie nazionali presso Stigliano, la sua testa viene staccata dal
corpo e portata nella Prefettura di Craco. Il
comune di Pisticci la pretende e, ottenutala,
la porta in processione come trofeo, infilata
su un palo, per le principali vie del paese159.
Al brigante Giacomo Madeo, ucciso dopo
la disgregazione della banda Monaco, dagli
abitanti di Acri (CS) fu spiccata dal busto la
160
161
162
163
158
159
/ 2 – comicità e politica
testa, che restò per molto tempo appesa nel
luogo in cui era avvenuto il celebre sequestro ad opera della stessa comitiva, “siccome
spettacolo di terrore e d’obbrobrio”160. Nel
maggio 1864 presso Tricarico la cavalleria di
Mennuni si scontra con una comitiva, uccide sei briganti e ne porta le teste sanguinanti
in città161. Quando la banda calabrese di Gaetano De Rose di Acri (CS), che operava tra
la Lucania e la Calabria, fu distrutta in uno
scontro con la Guardia Nazionale, nell’inverno 1862, ai briganti si tagliarono le teste,
per esporle nella piazza di Acri162.
Pressoché ignorata è tuttavia la decapitazione delle donne della banda: sappiamo
però di Maria Giuseppa Gizzi (“Peppinella”), colpita – come abbiamo visto – a tradimento insieme al suo compagno Giacomo
Parra: le loro teste furono tagliate e contese
come trofeo dai comuni di Muro Lucano e
di Bracigliano. Non sappiamo quante brigantesse abbiano subito lo stesso destino.
Queste orrende decapitazioni godevano del plauso dei cosiddetti ceti civili. Nel
marzo 1864, il giorno prima dell’uccisione
di Ninco Nanco, Napoli fece festa quando
giunse la notizia che gli ussari di Piacenza e i
bersaglieri stanziati in Ripacandida avevano
portato in paese le teste di tre briganti uccisi
nel bosco di Lagopesole163. Le reazioni della
gente del posto dovettero essere molto diverse dai lettori metropolitani del “Pungolo”.
La decapitazione aveva un non trascurabile risvolto pratico. La presentazione della
Fert: 51, 52.
Coni: 48.
Fal2: 167.
Bian: 134; Varu: 142.
Ri-L: 119.
“Pu”: 16/3/1864; Bian: 134.
137
Q
uaderni
testa attestava l’uccisione di un brigante e
consentiva di riscuotere la taglia o il premio. I tagliatori di teste venivano premiati
con denaro dalle amministrazioni comunali. Il comune di Pisticci eccitava a tagliare il
capo al brigante Cappuccino, promettendo
un premio in denaro ed altri privilegi164. Le
teste mozzate si conservavano sotto sale.
I cacciatori di taglie esistevano già nei
secoli precedenti, e in modo particolare
durante la dominazione spagnola, quando
esisteva perfino una precisa procedura per
la ricognizione e la presentazione della testa mozzata per riscuotere la taglia: dopo il
riconoscimento, il giudice decretava: “recipiatur et ponatur in palo”. Erano spesso dei
criminali, che, incapaci di uccidere i briganti, assassinavano a volte persone innocenti
e portavano dentro delle ceste e conservate
sotto sale le loro teste alle autorità, che le
riconoscevano come teste di briganti. Accadeva soprattutto nel brigantaggio endemico
dei secoli precedenti. Si otteneva un premio
in denaro o un salvacondotto165. I pali venivano poi portati in giro e infine piantati nei
paesi dei briganti. Si tratta di un uso bellico
e sociale che ha una lunga storia. Già per i
romani “la testa decapitata di un nemico era
un trofeo, anch’ essi amavano esibire la loro
gloria infiggendo la macabra preda su un
palo o sollevandola alta in una mano, mentre tornavano al galoppo da un’impresa vittoriosa”166. In America nella fase finale della
guerra di secessione i sudisti, ormai organizzati in bande di fuorilegge, tagliavano le
teste ai nemici abbattuti e le usavano come
166
167
164
165
138
Coni: 107.
Rovi: 409;
Cant: 161.
AUSSME: b.60, fasc. 19, c. 300.
trofei. Qualcosa di simile è accaduto più recentemente durante le guerre balcaniche.
Ottenere la testa e portarla in processione era un diritto del paese di nascita del
brigante. Un diritto conteso dalle squadre
che uccidevano il brigante, soprattutto ai
fini della riscossione del premio, dando luogo frequentemente a contese tra il paese di
nascita del brigante, il paese degli uccisori e
perfino il paese nel cui territorio il brigante
era stato ucciso.
Nell’esercito la decapitazione dei briganti ufficialmente era proibita167, ma era
tuttavia praticata, con la giustificazione che,
risultando difficile, a causa della distanza,
portare in paese il corpo del brigante ai fini
dell’identificazione, ne se portava soltanto la testa. Il generale Giuseppe Sirtori era
indignato di questi usi, a proposito dell’uccisione di Pietro Monaco (“barbara usanza,
che io non volli permettere mai, avanti che
contrariassi un desiderio delle popolazioni
meno colte di questa Provincia”), ma non
pare che li abbia rigorosamente proibiti. Il
gusto della decapitazione poteva essere tollerato ma non condiviso dall’alta ufficialità
dell’esercito, ma era gradita a buona parte
dei quadri più bassi e ai soldati, e molti ufficiali preferivano secondarli.
La decapitazione e la processione successiva erano una festa crudele. Destavano l’effervescenza della parte della popolazione ostile ai
briganti, perché attestavano visibilmente che
ce n’era uno di meno, e il ludibrio cui veniva
esposta la sua testa li ripagava selvaggiamente
delle paure e dei danni subiti. Soprattutto delle
antropologia e storia
paure. Nella disgustosa deriva della guerra civile squadriglieri e soldati facevano ai loro nemici quello che da essi si aspettavano e paventavano. Le parti si sono rovesciate, ora sono
gli altri a dileggiare e spaventare gli amici dei
briganti e a godere del loro terrore.
Ma portare in paese la testa del nemico
era un trofeo, una esaltante prova di valore,
che i tagliatori si teste sapevano quanto veniva ricompensata dall’esercito e dalle amministrazioni locali. Era, però, prevalente il rito
di dileggio del nemico. La testa privata del
corpo aveva nell’immaginario tradizionale
anche una valenza grottesca; non a caso si ricorre a questa fantasia in molte scenette pulcinellesche. Questo non esclude una segreta
componente di sadismo e di antropofagia: si
“mangiava cogli occhi” il corpo del nemico168.
L’uso della testa tagliata si prestava ad altre forme di violenza e di oltraggio. Ne erano protagonisti anche i soldati. Nell’area di
S. Gregorio Matese, nel Vallone dell’Inferno, il 4 maggio 1864 in uno scontro a fuoco
tra la truppa e la banda di Libero Albanese
fu arrestata insieme a due suoi cognati la
brigantessa Maria Carmine Valente, venticinquenne, sposata. I soldati credettero che
un brigante ucciso fosse il capobanda e gli
tagliarono la testa: era, invece, il soldato disertore Gerardo Autunnale, amante della
brigantessa. I militari costrinsero la donna a
portare la testa fino al Corpo della Guardia
Nazionale di Piedimonte. È questo uno dei
casi più sconcertanti della storia del brigantaggio: secondo le carte processuali la donna
sostenne di essersi trovata per caso in mez-
/ 2 – comicità e politica
zo al combattimento, e a dimostrazione di
ciò si prestò a lavare la testa troncata del suo
uomo, non cessando “di ballare e scherzare dinanzi ai soldati per tutta la via, facendo ballonzolare quella testa per i capelli”169.
Non le servirà molto, perché avrà 20 anni
di lavori forzati. Data l’inaffidabilità, in casi
come questo, dei testimoni, è più probabile
che i militari siano i soli responsabili del turpe spettacolo. Secondo la tradizione popolare
costringere una donna a ballare significa possederla. Anche Maria Oliverio fu costretta a
portare la testa tagliata del cognato Antonio
Monaco, caduto nell’ultimo scontro170. Le teste tagliate si portavano mettendole nel tascapane o avvolgendole in un panno, oppure afferrandole per i capelli. Era, quest’ ultimo, un
gesto di grande pregnanza simbolica, perché
impugnare la capigliatura del proprio nemico “è segno di vittoria su tutta la persona che
si tiene in pugno”, dal momento che i capelli
sono l’emblema della forza fisica della persona. In molte culture tirare i capelli è l’equivalente di un gesto di sfida.
Una pratica di guerra che ritroviamo
qualche volta tra i briganti e adottata dalla
parte opposta, soprattutto da squadriglieri e
guardie nazionali era il massacro del corpo e
il suo spezzettamento: si cercava di prendere
vivo il nemico, e lo si squartava e mutilava: i
pezzi venivano mandati nei paesi ai quali il
giustiziato era legato da fatti infamanti, e/o
venivano infilati dalle baionette e portati in
trionfo dai briganti. La rottura del corpo apparteneva alle esecuzioni capitali dei secoli
passati, con cui si punivano i delitti più atro-
Cant: 161.
Nota 81; Sang: 321-22.
170
Nota 82.
168
169
139
Q
uaderni
ci, ancora vive in alcune parti dell’Europa
all’epoca del brigantaggio postunitario, ma
non è certo che l’abbiano praticata i soldati
italiani. La praticavano però i loro coadiuvanti, guardie nazionali e squadriglieri, culturalmente affini ai briganti che combattevano, per i quali il macabro rito conservava
i significati forti che sempre aveva avuto:
quando fu ucciso Egidione “il sindaco Rogges fu invitato dalla Prefettura a prelevare
la testa di Egidio per portarla a Pisticci, dove
fu prima condotta in ‘processione’, conficcata su di un palo aguzzo, per le principali vie
del paese, a mo’ di macabro trofeo, e quindi
esposta per tre giorni nella piazza, mentre le
rimanenti parti del corpo furono trascinate
nei diversi luoghi, dove aveva compiuto i suoi
misfatti”171. L’uso era riservato ai criminali da
tempi immemorabili. “Possiamo comprendere la natura dell’oltraggio provocato da
simili punizioni, se consideriamo anche che
la mutilazione del cadavere (il divieto delle
esequie cristiane) era di fatto un inasprimento del terrore, dato che le autorità deliberatamente colpivano i tabù popolari più vivi. Per
capire la natura di questi tabù – il rispetto,
impregnato di superstizione, per l’integrità
del cadavere – occorre evocare le consuetudini mortuarie testimoniate dal folklore”172.
Effetti nel breve e lungo periodo
Nell’immediato l’incancrenirsi delle misure repressive non produsse effetti positivi
173
174
175
171
172
140
Coni: 48.
Thom: 320.
Rov: 408.
Pad1: 42.
Rovi: 437.
per l’esercito. Accadde invece quello che in
situazioni simili era accaduto in passato nella storia del brigantaggio endemico. Dopo
l’emanazione dell’editto De exulibus nel
1563: “molti piccoli delinquenti, spaventati, s’erano dati alla macchia; la criminalità
maggiore, ‘posta in disperatione’, s’era fatta
più feroce e temeraria; molti capibanda, nemici tra loro, venuti a conoscenza delle leggi
straordinarie, avevano cessato le ostilità”, e
si erano uniti tra di loro173. Si chiedeva Vincenzo Padula tre secoli dopo: “Che frutto
hai colto tu della legge Pica? Si è cresciuta
la sicurezza pubblica? No. Si è distrutto il
brigantaggio? No. Si è dato sfogo ad odii
privati, ed in virtù di notizie vaghe, raccolte
in fretta da chi ignorava i luoghi e somministrate da chi intendeva vendicarsi, si sono
mandate a domicilio coatto molte, e assai
molte persone o innocenti o inoffensive”174.
La modalità in cui la repressione fu teorizzata, costruita giuridicamente e concretamente effettuata “ebbe conseguenze deleterie anche sul lungo periodo, conferendo al
sistema penale dell’Italia un imprinting di
cui non si è forse ancora liberata”175. Come
nota Mario Sbriccoli, “nelle questioni che riguardavano l’ordine pubblico e la sicurezza
politica, avrebbero prevalso i criteri dell’opportunità e della convenienza, dettati dalle
esigenze dello Stato (che poi sarebbero state
regolarmente quelle del governo). La straordinarietà degli interventi sarebbe stata giustificata con l’eccezionalità delle situazioni; il
sospetto avrebbe avuto lo stesso valore della
antropologia e storia
prova, la certezza morale avrebbe rimpiazzato quella giuridica, le polizie avrebbero
finito per contare più dei giudici”176. Insomma, “un’inclinazione della penalistica italiana alla compulsione dei diritti, giustificata
dall’emergenza”177: quando al brigante delle
campagne si sostituirà la criminalità cittadina, “il nesso di continuità tra la vecchia e
nuova criminalità è evidente nell’idea di una
statualità ‘altra’, nel modus operandi e nelle
gerarchie, nell’ambiguo rapporto di opposizione/compenetrazione con le istituzioni
e con i poteri forti. Ritorni, insomma, che
sono da leggere nel segno di una modernità
mancata o che ha appena lambito le strutture
sociopolitiche178”.
IV. La morte e il lutto
Come muoiono i briganti
Come si comportavano i briganti davanti alla morte? Abbiamo pochi dati certi
concernenti le donne, ma copiosi quelli sulla morte dei briganti in generale. In tutti è
rilevabile l’assenza della paura di morire, e a
riconoscerlo sono in primo luogo i militari,
che per ovvie ragioni dobbiamo considerare
i più attendibili, almeno per i loro riconoscimenti e le attestazioni positive, essendo
i nemici dei briganti: il maggiore Pieri, il
generale Franzini e il colonnello-brigadiere
/ 2 – comicità e politica
Mazé de la Roche, il sotto-prefetto di Ariano Irpino Lucio Fiorentino dovettero prendere atto del coraggio e dello “stoicismo”
dei briganti dinanzi al plotone di esecuzione e il Fiorentino capì che il pericolo della
fucilazione non costituì mai un deterrente
per i contadini, briganti o amici dei briganti, per i quali essa costituiva soltanto una
“chance de la guerre”179. Molti briganti preferirono farsi torturare e uccidere piuttosto
che tradire. A Catalano fu inutilmente ripetuta la minaccia della fucilazione, se non
avesse parlato, e fu fucilato180. L’idea che
il mondo contadino fosse indifferente alla
morte è stata notata da tempo immemorabile, per esempio, da Maupassant: “nella periferia parigina, colma di una popolazione
di provincia, si ritrova questa indifferenza
del contadino verso la morte, fosse anche
quella di suo padre e di sua madre, questa
indifferenza, questa forza inconsapevole
tanto comune nelle campagne e così rara a
Parigi”181. Tra i briganti meridionali questa
tendenza contadina era rafforzata dall’idea
della guerra santa e dalla fede legittimista:
“Comprendono che – spiegava un ufficiale
dei loro nemici – se capiteranno fra le unghie della giustizia o sommaria o istruttiva,
saranno fucilati, ciò non cale loro; – Una
volta si deve morire – dicono, e la gloria
del Paradiso, che sentono essersi acquistata
con le pratiche religiose, è l’unica speranza,
l’unica ricompensa che si riprometteranno
Bri: 174.
Rovi: 427.
178
Rovi: 428; cfr. Gros: 256.
179
Molf: 132-33.
180
Paso: 42; in DeJa: 304.
181
Contes et nouvelles, Bibliotèque de la Pléiade, Paris, 1974, vol. I.
182
DeWi:74.
176
177
141
Q
uaderni
dopo una lunga vita di stenti”182; e l’ufficiale Paolo Negri conferma che: “i briganti da
noi fucilati andavano alla morte con passo
fermo fumando e bevendo al grido di ‘Viva
Francischiello’”183, ma si trova davanti il
problema, non facile, di doverlo spiegare,
senza ammettere che si tratta di eroismo.
Questo il suo commento all’episodio dei
briganti della banda Carbone che si lasciano
bruciare vivi o si suicidano in una masseria per non cadere nelle mani dei militari:
“Noi non ascriveremo ad eroismo (come
in quel tempo fu detto) il lasciarsi bruciare piuttosto che arrendersi; no di certo. Lo
chiameremo invece un fanatismo, una falsa
credenza. ‘Chi muore combattendo contro i nemici della religione e del nostro re
Francischiello va al godimento del regno
dei cieli’. Con questa fede troppo vecchia
e inconcussa si affronta con disprezzo profondo la morte e lo abbiamo più volte veduto nel cinismo dimostrato dai briganti
che, fatti prigionieri con le armi in mano,
erano fucilati nella schiena”. Questi comportamenti disorientavano in effetti i militari piemontesi, abituati a immaginare che
gli eroi che sfidano la morte fossero figure
ideali da cartolina: “Che curioso miscuglio
di carattere! Morire piuttosto che svelare un
complice! E questa virtù eroica in chi si trova? In uno che ha, poco tempo fa, bruciata
viva una donna incinta, che ha disonorate
ventiquattro giovani”184.
Nessuno si pose il problema che sono
proprio le rappresentazioni collettive a
185
186
183
184
142
Negri: 36; in DeJa: 253.
Paso: 53; in Deja: 304.
Papa: 107; Sca1: 136.
Bat: 162.
produrre le forze morali che alimentano la
guerriglia. Non tanto la religione, la fiducia
e la lealtà al “re buono”, quanto l’imitazione
del padre morto e la benedizione/maledizione della madre: una educazione alla morte
che iniziava dal tempo della Ninna nonna:
Lu sangu chi t’ abbivara lu cori
È di cui si criscìu dintra la Sila;
tu fatti guappu, nsonduvè si mori
spezza a cui avanti a tia stendi la fila.
Oh! oh!, oh!
Briganteiu ninna nò.
Si a patrita mu agguali no si griju,
si timisci di voscura o surdatu,
ieu mo ti jestimu, o piccirju:
vipara mu ti ntossica lu hijatu185.
(“Il sangue che ti abbevera il cuore /è di chi crebbe dentro la Sila; / tu fatti guappo, dovunque si
muore, / spezza la vita a chi ti contrasta. // Se non
sei capace di imitare tuo padre, / se hai paura dei
boschi o dei soldati, / io adesso ti bestemmio, piccolino: / che una vipera ti intossichi il fiato”).
La trasgressione che fonda il potere del
brigante chiama la morte, perché essa è fondamentalmente una sfida alla morte; la sua
sovranità è “il potere di innalzarsi, nell’indifferenza della morte, al di sopra delle
leggi che assicurano il mantenimento della
vita”186. Nell’orizzonte del brigante ci sono
dunque il modello del padre e l’investimento della madre con la sua ansia di sciogliersi
nella gloria del figlio. L’uno e l’altro prefigurano e determinano le scelte e il destino
dell’uomo sin dai primi anni.
antropologia e storia
Riti di morte. Sepoltura dell’eroe
Il senso brigantesco della morte, del
lutto, dell’amicizia e della pietà ha trovato
la sua espressione più alta nel racconto che
il semianalfabeta capo dei capi ha scritto,
senza mediazioni, per evocare la sepoltura
del suo luogotenente Giovanni Fortunato detto Coppa: il capobanda più fedele a
Crocco e da lui più amato viene ucciso da
uno della comitiva che gli si è ribellato. I
compagni lo portano a Donatello. “Il giorno dopo – racconta il grande capo – cioè sul
fare del giorno la compagnia mi consegnò
il ferito il quale dava poche fioche parole,
mi riconobbe, gli feci sentire raccondare il
fatto come era successi, e udite la fina dissi
colla testa si, domandate se voleva vendetta da qualchje suo compagno, raddoppiò il
no, no colla testa, finalmente alla stesora,
dopo 24 ora che aveva ricevuto i due colpi,
spirò, quando vide che il polso non dava
più battito, subito gli strappai tutt’ i panni,
lo chiuso bene gli occhi, lavai bene bene il
cadavero, taffetai bene le ferite, asciucato
bene gli posi una camicia di lino, motente
(= mutande) e calzette, una scolla di seta incanna, gli pettinai bene i capelli, e lo poso
sopra una coverta un’altra sopra lo lasciai
dormire. La notta scelso il luogo, desegnai
la fossa e sei dei suoi più fidi cavarono alla
profondità di 8 palmi un fosso in cui dovevo tumulare il compariello di mio padre, il
figlio della malafemmina, alla quale col mio
debbole e rozzo scritto chiamo a vedere suo
figlio (…) Appena fatto giorno prendemmo
nuovamente a contemplare il cadavero, egli
/ 2 – comicità e politica
dormiva perfettamente, lo prendemmo bello bello, e lo ponemmo all’impiedi si reggeva
perfettamente. Cammina Giovannino, cammina meco all’ultima baronia, la tua furtuna
è bella ed assicurata, non temere più, tutto
hai pagato, vi resta solo il debito con la madre antica, viene da essa. La quale pietosamente v’aspetta. E prendendolo senza farlo
smuovere lo portammo alla preparata fossa,
quivi giunte lo ravvolgemmo in due coverte
e il calammo giù, poi fatti a pezzi tutte le sue
arme, compresi gli speroni, ed il morso della
briglia del suo cavallo, lo coprimmo di terra
facendo scomparire ogni menoma traccia,
finite il tutto dissi”187.
Gli usi funebri dei briganti solo in parte
erano gli stessi dei pastori e contadini. Appartenevano per il resto alle pratiche e credenze del brigantaggio endemico, e avevano
per questo secoli di storia alle loro spalle.
La decapitazione del morto, la cremazione
del cadavere, il seppellimento anonimo, il
nascondimento della testa erano in parte
residui arcaici, in parte erano forme di adattamento alle condizioni di vita alla macchia.
I briganti bruciavano i compagni morti o
uccisi o rendevano irreperibili i loro corpi
sepolti anche per evitare che fossero riconosciuti e identificati dalle forze dell’ordine188.
La cremazione dei corpi era notoriamente
proibita dalla Chiesa, ma essi la ritenevano
dolorosamente necessaria. Maria Oliverio si
attenne a quest’ uso, quando, prima dell’arrivo dei soldati, diede alle fiamme il cadavere di suo marito. Filomena Pennacchio e
Michele Caruso dopo la battaglia vittoriosa
di Santa Croce di Magliano fecero lo stesso
Cro4: 50-57.
DeWi: 246n.
187
188
143
Q
uaderni
dei compagni caduti: “Pochi morti in quel
fatto d’armi ebbero i briganti, e quei pochi
furono messi in una pagliaia, ed ivi cremati,
– scrive un militare – all’oggetto sempre che
non fossero da noi riconosciuti”189. Ma i militari non capivano tutto. La cremazione serviva anche ad evitare l’abominio dell’esposizione del cadavere nel paese e l’esibizione
della testa tagliata come trofeo. Forse Maria
Oliverio bruciò il corpo di Monaco dopo
aver troncato la testa per portarla via190.
Nell’assalto della banda Franco alla colonna
dei possidenti di Senise il brigante Novelli è
colpito a morte; i compagni lo portano via,
e quando si accorgono che è morto o è in
fin di vita, gli staccano la testa “per non farlo
conoscere”191.
Quando potevano, e avevano il tempo
per farlo, i briganti preferivano seppellire i
loro morti, con l’accortezza di far scomparire ogni traccia192: il seppellimento doveva
avvenire in un luogo sicuro, sconosciuto ai
nemici e di non facile reperibilità, perché i
soldati potevano anche disseppellire il cadavere e identificare il brigante, come spesso
è accaduto. Con la cremazione dei cadaveri e con la sepoltura anonima si rendevano
irreperibili i corpi e veniva meno la prova
della loro morte. I due briganti traditori che
uccisero il capobanda Boffa ad Avota seppellirono il corpo in un luogo che solo essi
conoscevano, ma successivamente per ac-
quistare meriti presso le autorità e forse per
intascare la taglia lo fecero sapere ai soldati,
i quali dissotterrarono il cadavere e, dopo il
riconoscimento formale, lo trasportarono
in città193. Diverso il caso di Parri e Boffa,
che bruciarono i loro compagni Pechirillo
e Vito dopo averli uccisi, per far perdere le
loro tracce194.
Dopo aver fatto uccidere con ordine del
Tristany il capobanda Chiavone di Sora, i
comitati reazionari di Roma fecero credere
che fosse ancora vivo e lo sostituirono con
un secondo Chiavone, “per nascondere la
morte del vero Chiavone la cui morte accertata avrebbe gettato nello scoramento
i suoi amici, e indispettita contro il nuovo
capo e la reazione quella buona popolazione
di Sora, che in Chiavone spera e in lui vede
il campione della causa borbonica, un generale di senno, una indigena celebrità”195.
Secondo un’altra versione lo stesso generale
Tristany non era interessato a che la morte
del brigante fosse conosciuta, dato il prestigio di cui egli godeva ancora tra le bande, e
lo fece seppellire segretamente in un bosco.
Invece il governo italiano aveva ovviamente
un interesse di segno opposto, e fece cercare la sepoltura, che fu trovata una sera da
alcuni bersaglieri, i quali, non riuscendo a
trasportare il cadavere, rinviarono l’operazione al mattino seguente. Tristany, saputa
la cosa, spedì sul posto una persona di fidu-
DeWi: 320. Un brigante della banda Coppa brucia il cadavere del fratello in Cro4:54.
L’episodio è descritto nel dramma di Stocchi: “Almen la testa del mio Piegtro voglio / gettar nel fuoco ed ardere. /
La testa sua recisa, / che a spettacolo vil saria mostrata / arsa tra breve / non vedrà nessuno” (Sto3: 46-47). Questo
autore calabrese attinge a fonti non ufficiali, ed è di solito ben documentato.
191
Ri-L: 168.
192
Vedi il seppellimento di di Coppa ad opera di Crocco, in Cro4: 55-57.
193
Dam1:463; Dami2: 504.
194
DiG2: 12-13.
195
Binc: 65.
189
190
144
antropologia e storia
cia, la quale bruciò il cadavere, e fece gettare
sulle ceneri le ossa bruciate e la testa di un
montone196.
Quando dovevano risolvere frettolosamente il problema di rendere inidentificabile
il brigante morto, i suoi compagni lo decapitavano e seppellivano la testa in un posto
più lontano. L’uso apparteneva alle tradizioni
brigantesche dei secoli precedenti197.
Miti di santificazione
Ai briganti leggendari di tutti i tempi
la gente attribuiva poteri soprannaturali.
Limpião prevedeva gli attacchi delle forze
dell’ordine dal volo degli uccelli. Probabilmente il capobanda non lo credeva, ma riteneva importante che i suoi lo credessero,
perché l’attribuzione di poteri soprannaturali lo rendeva superiore ai comuni mortali
e accresceva il mistero che lo circondava198.
C’erano anche altre, più forti e oscure motivazioni a bruciare o a nascondere il cadavere dei briganti: “la presa di coscienza della
morte di un altro può essere impedita ancora più facilmente se non si vede il corpo che
si decompone. Sembra che gli antenati che
non furono visti morire e le cui tombe rimasero di conseguenza vuote, fossero spesso considerati spiriti di potenza inaudita”199.
Pare che, dopo aver bruciato i cadaveri dei
compagni, i briganti facessero credere che
198
199
200
201
202
203
196
197
/ 2 – comicità e politica
essi non si vedevano in giro, perché imprendibili, invulnerabili, invisibili200. Una
sottile consapevolezza antropologica faceva
comprendere ai capi che si poteva utilmente
operare su un immaginario collettivo restio
ad accettare l’idea primordiale che le persone amate siano uscite per sempre dalla nostra vita, per un non ritorno che annienta le
ragioni della speranza201.
Il brigante silano Domenico Straface
detto Palma, ferito da un guardiano del barone Guzzolini, e poi finito il giorno dopo
da un carabiniere, era creduto fatato, invulnerabile e invincibile. Secondo un giornaletto di Catanzaro, uscito pochi giorni dopo la
sua morte, era creduto tale per le continue
elargizioni fatte alla sua gente e per il suo stile di vita “parco e temperato”. La credenza
nasceva spontaneamente tra la gente, ma i
briganti spesso facevano di tutto per rafforzarla e a volte erano realmente convinti di
essere tali. Ninco Nanco si considerava invulnerabile202.
I profeti degli oppressi si comportavano
allo stesso modo. Thomas Münzer fermava
le palle di cannone con le maniche del suo
vestito; si credeva che i profeti di Linguadoca fossero tutti invulnerabili e protetti da
minuscoli angeli bianchi203. Sono storie anche dei nostri giorni: il taumaturgo congolese E. Epichiupikili rendeva i suoi seguaci
invulnerabili ai proiettili europei. Questa
certezza o speranza era alimentata nei capi-
Bart; 99.
Rovi: 404.
Fio: 27.
MoK: 53.
Cfr. Croci: 19.
Mo-K: 53.
Bour: 216.
LeR: 358.
145
Q
uaderni
banda non solo dal loro narcisismo megalomane, ma anche dalla loro fede religiosa:
la gente del Sud era convinta che “il morto
della Vallata non sarebbe stato il Romano,
ma un altro bandito che gli somigliava”, dal
momento che credeva che il sergente fosse
invulnerabile grazie ad una medaglia avuta in dono dal Papa: era lo stesso comandante a raccontarlo”204. Nell’epos popolare
dell’Italia meridionale possiede una grande
pregnanza simbolica il motivo ricorrente
dell’eroe bandito che si sottrae alla morte
perché invulnerabile. Il brigante di Solopaca
Antonio Del Sanzo era assai noto ai briganti
salernitani di Manzo, che narravano il suo
potere di afferrare con le mani le palle che
gli sparavano addosso205. Limpião mediante
alcune fatture era riuscito a diventare invulnerabile sia pure non in senso assoluto,
perché si sapeva che era stato ferito sei volte,
ma non era morto. Realisticamente, il topos
nasce come riflesso fantasmatico della sicurezza di cui godono i briganti tra la gente
che li protegge e le campagne che offrono sicuro rifugio, “prova dell’identificazione dei
banditi con la classe contadina” e metafora
condivisa della speranza che l’eroe popolare non possa soccombere206. Ma si lega anche al tema dell’invisibilità. È più probabile
che questi miti nascessero spontaneamente,
sulla base di un retaggio archetipico immemorabilmente arcaico: il brigante, in quanto eroe popolare non si vede, non perché è
206
207
204
205
146
morto, ma perché è invisibile, e che sia tale
è dimostrato dal fatto che di tanto in tanto
si fa vedere nei posti più insospettati e nei
modi più strani207. A molti briganti entrati
nella leggenda si attribuiva il dono dell’ubiquità. La credenza nasceva dall’impressione
che destavano i loro spostamenti continui
e fulminei e la loro capacità di sparire e riapparire. Questi motivi si legano al tempo
stesso al travestitismo e al trasformismo del
brigante, ed entrambi i temi hanno come
punto di partenza l’idea immaginaria della
sua invincibilità e invulnerabilità.
Una ragione per la quale i briganti erano
considerati immortali era la loro capacità di
sopravvivere fortunosamente in situazioni
difficili e pericolose, nonché di godere di
uno stato di salute eccellente, nonostante le
ferite ripetutamente riportate negli scontri.
È questa la storia, per esempio, di Limpião.
Gli eroi briganti purtroppo morivano, ma
per la gente delle campagne essi si erano soltanto nascosti. L’idea della loro scomparsa e
la fede nel loro ritorno si sposano col modello dei re buoni e degli eroi amati dal popolo, che – secondo uno schema, che riproduce la vicenda di Cristo – creduti morti e
scomparsi per qualche tempo, ritornano per
riportare la giustizia e fare la felicità della
gente; insomma esprime la speranza “che il
campione del popolo non possa essere sconfitto, che non è realmente morto, perché la
sconfitta e la morte del brigante è anche la
Luc 2: 133; Bura: 49.
Fri 2: 115.
Hob2: 45-46.
È quello che si raccontava del brigante campano Angiolillo, della fine del secolo XVIII: sarebbe stato visto in Muro
Lucano in veste di conciacaldaie con grattuge e imbutilli in mano; in una fiera, travestito da acquaiolo, avrebbe
distribuito ai paesani l’acqua fresca che si dava solo ai forestieri; in un’altra fiera, quella di Gravina di Puglia,
avrebbe venduto nastri e fettucce, e in un’altra ancora si sarebbe presentato come venditore di tela a basso prezzo,
e così via (Sca2: 53).
antropologia e storia
sconfitta del suo popolo, e quel che è peggio,
è la fine della speranza. Gli uomini possono vivere senza giustizia, e generalmente ci
sono costretti, ma non possono vivere senza
speranza”208. Nel Medioevo si credette che
molti re non erano morti veramente e che
sarebbero ritornati per salvare i loro popoli quando versassero in gravi difficoltà209.
Come altri eroi popolari, nell’immaginario
della gente i briganti scomparsi erano fuggiti lontano o si nascondevano, come il bandito andaluso Pernales, che sarebbe migrato
nel Messico, o come Jesse James, che sarebbe fuggito in California. Lo stesso si può dire
del brigante di Solopaca Antonio Di Santo,
ritualmente evocato nelle performance dei
briganti del salernitano: il capobanda e i
suoi compagni vincono i nemici e la morte, e poi misteriosamente scompaiono: “né
si sa ancora dove siano andati, /o pure dove
sien ritirati”210. Si raccontava che il Sergente
Romano non era stato ucciso, ma errava per
i boschi e le campagne del suo paese. In un
racconto popolare la brigantessa Maria “a
Pastora”, creduta catturata e uccisa, compare vestita di nero e sparisce col suo cavallo
nel bosco211. Immortalità e resurrezione si
confondono in molti riti: si raccontava che
il terribile capobanda di Terra di Lavoro,
Tommasini di Tuoro di Sessa, ucciso in uno
scontro a Galluccio, fosse resuscitato e si aggirasse ancora nelle campagne212.
Morti che non sono morti o morti che
ritornano sono alcune forme narrative del
complesso rapporto con i defunti, che ha una
210
211
212
208
209
/ 2 – comicità e politica
sua centralità nel mondo popolare meridionale. In una cultura in cui “fanno i vivi e i
morti una famiglia”, i morti attraverso il culto, il sogno, la trance, le danze delle maschere
carnevalesche ispirano la vita dei vivi e gesti,
parole, atti paiono l’eterna replicazione di un
rito religioso, un déjà vu che rannoda l’esistenza dei vivi a quella dei defunti, e ripropone incessantemente il loro “ritorno” a fianco
dei vivi per moltiplicare le loro forze.
Non diversamente da quanto avviene
nella cultura intellettuale, la cultura popolare ha un doppio rapporto con la storia: da
un lato, la consapevolezza, più o meno fondata, degli accadimenti reali; dall’altro l’abbandono alle esaltazioni e alle consolazioni
del mito. I contadini non potevano ignorare
una realtà che era sotto gli occhi di tutti, che
cioè i guerriglieri venivano braccati e uccisi,
ma al tempo stesso non riuscivano a distaccarsi da un immaginario che della tragedia
forniva una spiegazione che lasciava aperte
le porte della speranza e del sogno. Le credenze e le pratiche magiche contribuivano a
sorreggere questo polo della contraddizione.
Come spiegare, allora, la caduta dell’eroe,
quando si è a lungo creduto che l’eroe è imprendibile e invincibile? Le spiegazioni, che
si ritrovano in tutte le parti del mondo che
hanno conosciuto i briganti, sono sempre le
medesime o molto simili: le fatture avevano
fatto ottenere al capo dei gangaceiros l’invincibilità, rafforzata poi dagli “abitini” che
portava addosso, ma l’acqua stagnante attenuava o cancellava questo potere, e Limpião
Hob2: 46; ved. pure Sca1: 52-54.
Frazer: cap. II in Mo-K: 54.
Rom: 16; Fri2: 115.
Lev: 67.
Borr: 35.
147
Q
uaderni
fu ucciso dalla polizia proprio dopo aver
dormito nel letto di un fiume prosciugato213.
Storie analoghe si raccontano sulla cattura o
uccisione di molti altri briganti.
I creduti poteri eccezionali derivati dal
rapporto col soprannaturale, la violazione
dei tabù, la dismisura della violenza costituiscono le condizioni di base per la sacralizzazione dell’eroe popolare. Ma perché
questa si compia è necessario che la gente si
identifichi in qualche modo con lui e si riconosca almeno in parte nel suo operato, ed è
quello che accade al alcuni grandi briganti,
non solo nella letteratura epica, ma anche
nella realtà. Molti briganti nell’epos popolare sono diventati santi, secondo un modello
incarnato dal brigante Nino Martino assimilato a San Martino214. Il brigante è “homo
sacer” quando è ancora vivo nel bosco: lo è
per i meriti acquistati da fuorilegge, secondo
il modo di sentire e pensare del popolo, nel
cui immaginario gli eroi banditi tendono ad
acquisire tratti e comportamenti dei santi e
questi ultimi non sono alieni dall’assumere
comportamenti trasgressivi: protettori della comunità, hanno aiutato i poveri, difeso
i deboli, combattuto l’ingiustizia, associando alla valentia la forza miracolosa dei poteri magici, e la grandezza e il prestigio che
l’infrazione della legge e il disprezzo della
morte sempre fondano. Lo scacco finale e
la fine tragica non rappresentano l’interruzione del processo di sacralizzazione, ma lo
confermano e lo completano: è uno schema
magico-religioso immemorabilmente antico, che il modello del Cristo morto sulla
215
216
213
214
148
Fio: 27.
Ved. Sca1; Sca2; Sca5.
DePo2: 57; Levy: CLXXVI; DeWi: 73.
Dewi: 73.
croce ha radicato negli strati più profondi
della psicologia collettiva. Il corpo del sergente Romano fu fatto a pezzi dalle sciabole
dei cavalieri piemontesi sulla strada di Mottola e portato a Gioia del Colle, per essere
esposto per tre giorni al pubblico dileggio.
Ma “tutti gli abitanti del paese vollero contemplare un’ultima volta gli avanzi irriconoscibili dell’eroico ‘brigante’; si andava come
a un pellegrinaggio santificato dal martirio.
Gli uomini si scovrivano il capo, le donne
s’inginocchiavano, quasi tutti piangevano: egli portava nella tomba il rimpianto e
l’ammirazione dei suoi conterranei”215. È la
santificazione dell’eroe, che trasforma il dileggio dei soldati in oltraggio. Quando Giuseppe Nardella della banda Del Sambro fu
fucilato, si disse che “erano scesi gli angeli
dal cielo per portarne in trionfo l’anima”216.
Il cordoglio della popolazione per la
morte del brigante tuttavia non è unanime.
È un sentimento ambivalente nelle stesse
persone che lo piangono, che non possono
non prendere atto dell’onnipotenza del potere costituito e dell’inanità della rivolta, nel
momento in cui devono riprendere la vita di
sempre. Il colonnello Caruso e il capobanda
Giuseppe Schiavone si appellano, andando
al luogo dell’esecuzione, al popolo, rimanendo inascoltati. Nell’epos popolare, nel
momento in cui le imprese del brigante si
concludono tragicamente, la sua storia viene
riscritta a partire dal suo esito, all’interno di
una ambivalenza che emerge nella forma di
una contraddizione insolubile: per quanto
possano sembrare difensori dei diritti degli
antropologia e storia
oppressi e incarnazione degli ideali di giustizia, alla luce livida della sconfitta i capi delle
bande diventano i violatori di tabù, che hanno sparso sangue e portato scompiglio nella
vita ordinata di tutti i giorni. Il brigante è
un trasgressore, e, in quanto tale, al momento della catastrofe può fare affiorare la consapevolezza che il suo destino era già stato
scritto (“Così fu dei guappi la lor morte / ché
guapparia non val contro la Corte”217). È la
sconsolatezza dei vinti: l’immaginario collettivo assimilava la sconfitta della guerriglia
contadina a una colossale opera di castrazione di un popolo e di una cultura:
Guarda la Curti quantu è pussenti,
quandi si leva pari nu punenti,
cà ti distruggia ssi beddi pianti;
pua li minta dintra na gravigghia
e pua cumu viteddazzi ti li magghia.
(“Guarda la Corte quanto è possente / quando si
alza sembra un vento di Ponente, / ché ti distrugge
queste belle piante (= i briganti); / poi li mette dentro una inferriata / e poi come vitelli te li castra”.
Il brigante rivela ora la sua natura di figura del proibito, delegato dalla comunità
a trasgredire in sua vece, e ad assumere nel
suo tragico epilogo il ruolo del capro espiatorio, eroe di una catastrofe annunciata e in
qualche modo accettata, in quanto liberazione dalle tentazioni dell’impossibile e dalla fascinazione dell’abisso.
Le parti II e III di questo saggio sono di
D. Scafoglio, I e IV di Simona De Luna. Esse
anticipano l’uscita imminente del volume che
porta lo stesso titolo
/ 2 – comicità e politica
Fonti e testi di riferimento
ACS: Archivio Centrale dello Stato, Roma
ASB, Archivio di Stato di Bari
ASC, Archivio di Stato di Caserta
ASI, Archivio di Stato di Isernia
ASP, Archivio di Stato di Potenza
AUSSME, Archivio dello Stato Maggiore dell’Esercito, Roma.
Museo Biblioteca Archivio Storico del Sannio,
Benevento.
An67: Anonimo 1897 (ma: C. Melegari), Briganti, arrendetevi! Ricordi di un antico bersagliere, Venosa, Osanna Venosa, 1996 (or. 1897)
Bat: G. Bataille, La letteratura e il male, tr. it., Milano, SE, 1987 (or. 1957).
Bart: C. Bartolini, Il brigantaggio nello Stato Pontificio 1860-1870, Roma, Felziani, 1897.
Bian: Q. Bianchi, Il brigante Ninco Nanco, Manduria, Lacaita, 2001 (or. 1903).
Bilo: V. Bilotti, Canti briganteschi di Carlopoli, in
“Calabria”, Monteleone, a. IV, n. 9, 15 maggio1892.
Binc: A. Bianco di Saint Joroz, Il brigantaggio alla
frontiera pontificia, Milano, 1864.
Borr: N. Borrelli, Episodi del brigantaggio reazionario nella campagna sessana in Terra di
Lavoro, S. Maria Capua Vetere, Di Stefano,
1927.
Bour: G. Bourelly, Il brigantaggio dal 1860 al
1864, Venosa, Edizioni Osanna Venosa, 2004
(or. 1865).
Bri: La brigantessa. Fatto vero, foglio volante, Biblioteca Nazionale di Napoli.
Bura: G. Buratti, Carlo Antonio Gastaldi. Un operaio biellese brigante dei Borboni, Vibo Valentia, Jaca-Book-Qualecultura, 1989.
Butt: G. Buttà, Edoardo e Rosolino le conseguenze del 1861, Brindisi, Trabant, 2011 (or.
1880).
Pietru Biancu, in Sca2: 17.
217
149
Q
uaderni
Caia: A. Caiazza, La banda Manzo tra i briganti campani e lucani nel periodo postunitario,
Napoli, Tempi Moderni, 1984.
Capa: A. Capano, Gli sfoghi della paura. Il brigantaggio nel decennio francese, in AA.VV.,
Il potere delle paure, Basilicata editrice, 1985.
Casc: F. Cascella, Il brigantaggio. Ricerche sociologiche ed antropologiche, Aversa, Noviello,
1907.
Chie: D. Chieffallo, Cilento. Contadini, galantuomini, briganti, Sarno, Edizioni dell’ippogrifo,
2002.
Coni: C. Coniglio, Il brigante Cappuccino Giuseppe Padovano 1832-1874, Lecce, Capone,
2003.
Croc1: C. Crocco, Come di venni b rigante, introduzione di T. Pedio, Manduria, Lacaita, 1964.
Cro2: C. Crocco, Come divenni brigante, Potenza, Nicola Bruno Editore, s.d.
Cro4: C. Crocco, Memorie, in cui si racconta del
brigante Coppa e di Ninco Nanco, Possidente,
Pianetalibroduemila, 2001.
Croci: P. Crociani, Guida al Fondo Brigantaggio
(dell’Archivio Storico dello Stato Maggiore
dell’Esercito), Roma, 204.
Dam1: A. D’Ambra, Il brigantaggio postunitario
in Terra di Lavoro, s.n.t.
DAm2: A. D’Ambra, Viva il re, abbasso la Nazione, Battipaglia, Repostes, 2010.
DBia: O. De Biase, Brigantaggio ai piedi del Terminio, Comune di Serino, 2006.
Deja: A. De Jaco, Il brigantaggio meridionale,
Roma, Editori Riuniti, 2005 (or. 1969).
DePo1: O. De Poli, Voyage au Royaume de Naples
en 1862, Paris, Duparay 1863.
DePo2: O. De Poli, De Naples à Palermo, (186318649, Paris, 1865.
DeSi: G. De Sivo, Storia delle Due Sicilie, Trieste,
1868.
DeWi: A. De Witt: Storia politico-militare del brigantaggio nelle provincie meridionali d’Italia,
Firenze, Coppini, 1884.
DiBi: F. Di Biase [Diario del sequestro] in Chie:
180-201.
150
DiG2: M. Di Gè, Vita di Michele Di Gè nato a
Rionero, Melfi, Fratelli Insabato, 1911.
DiG3: M. Di Gè, L’autobiografia di un brigante, a
cura di G. Salvemini, Roma, Loescher, 1914.
Dipr: P. Di Prospero, Dove osarono i briganti. Le
vicende di Colaiuda, Viola, Zeppetella e di altri ribelli in Abruzzo e nel Lazio, Napoli, Controcorrente, 2004.
DiTe: P. Di Terlizzi, I carabinieri e il brigantaggio
nell’Italia meridionale (1861-1870), Bari, Levante Editore, 1997.
Eli2: M. Eliade, Da Zalmoxis a Gengis Khan, tr.
it., Roma, Astrolabio, 1975.
Fal1: M. Falcone, Un doloroso episodio della mia
vita, s.l., 1868.
Fal2: M. Falcone, Un doloroso episodio della mia
vita, in V. Padula, Il brigantaggio in Calabria
(1864-18659), Roma, C.M. Padula, 1981.
Fert: G. Ferrari, Memorie di guerra e brigantaggio. Diario inedito di un garibaldino, Novara,
Interlinea Edizioni, 2011.
Fio: M. Fiorani, Gangaceiros: ballata tragica, Conegliano, Quadragono, 1978.
Fouc: M. Foucault, Sorvegliare e punire, tr. it.,
Torino, Einaudi, 1976 (or. 1975).
Fraz: J. Frazer, Il ramo d’oro, tr. it., 1965 (or. 1922).
Fri2: I. Friedli, Quattro mesi fra i briganti del Sud
d’Italia, tr. it., in Caia: 107-97.
Gell: J. Gelli, Banditi, briganti e brigantesse
nell’Ot­tocento, Firenze, Bemporad, 1931.
“Gio”: “Giornale Officiale di Napoli”, 1861-1867.
Gradi: A. Gradilone, Storia di Rossano, Cosenza,
1967.
Grec: L. Greco, Piemontisi, Briganti e Maccaroni,
Napoli, Dick Peerson, 1993.
Gros: P. Grossi, Scienza giuridica italiana. Un
profilo storico (1860-1950, Milan o, Giuffré,
2000.
Hob2: E.I. Hobsbawm, I banditi. Il banditismo
sociale nell’età moderna, tr. it., Torino, Einaudi, 1971 (or.1969).
Jeud: H.P. Jeudy, Panico e catastrofe. La cultura
del disastro e l’estasi del riscbio, tr. it., Genova,
Costa & Nola, 1997.
antropologia e storia
LeR: E. Le Roy Ladurie, I contadini di Linguadoca, tr. it., Bari, Laterza, 1970 (or. 1969).
Lev: C. Levi, Cristo si è fermato ad Eboli, Milano,
Mondadori, 1981 (or. 1945).
Lévi: B.Lévy, La Cour de Rome. Le brigandage et
la Convencion franco-italienne, Paris, 1865.
Lich: J.J. Lichtensteiger, Quattro mesi fra i briganti 1865/66, tr. it., a cura di U. Di Pace,
Cava de’ Tirreni, Avagliano, 1984 (or. 1894).
M.C. Lindholm, Charisma, Blackwell, 1990.
Luc1: A. Lucarelli, Il Sergente Romano, Bari, Palomar, 2003 (or. 1922)
Luc2: A. Lucarelli, Il brigantaggio politico delle
Puglie dopo il 1860, Bari, Laterza, 1846.
Luc3: A. Lucarelli, Risorgimento, brigantaggio e
questione meridionale, a cura di V.A. Leuzzi e
G. Esposito, Bari, Palomar, 2010.
Mari: T. Mariotti, Una pagina del brigantaggio
in Capitanata negli anni 1862-1865, “Rivista
Militare Italiana”, 1914.
Mo-K: R. Money-Kyrle, Il significato del sacrificio,
tr. it., Torino, Bollati Boringhieri, 1994 (or.
1930).
Moe3: W.J.C. Moens, Briganti italiani e viaggiatori inglesi, a cura di M. Merlini, tr. it., Milano, TEA, 1997 (or. 1866)
Molf: F. Molfese, Storia del brigantaggio dopo l’Unità, Milano, Feltrinelli, 1979.
Monn: Monnier, Notizie storiche documentate
del brigantaggio nelle provincie napoletane
dai tempi di Fra Diavolo sino ai nostri giorni
(1862), aggiuntovi l’intero giornale di Borjés
finora inedito, Firenze, Barbera, 1862.
Mont: E. Montanari, L’arma dei carabinieri e i
briganti, Cerchio, Adelmo Polla, 2003.
Mosc: P. Moschiano, Il brigantaggio postunitario
nel Vallo di Lauro, Marigliano, Pro Lauro, 1989.
Neg1: G. Negri, Alla caccia dei briganti, Salerno,
2002 (or. 1905).
Neg2: G. Negri, Alla caccia dei briganti, in Scherillo, Gaetano Negri alla caccia dei briganti,
Milano, 1905.
Negr: P. Negri, Storia del 40° reggimento fanteria
- Brigata Reggio, Imola, 1905.
/ 2 – comicità e politica
Nitt: F.S. Nitti, Scritti sulla questione meridionale,
Bari, Laterza, 1958.
Nove: E. Novelli, Il diario del nonno: cinquant’
anni dopo, in “La Patria del Friuli”, poi Diario
di guerra 1860-1861, Udine, Del Bianco, 1961.
Oliv: G. Olivieri, Ricordi briganteschi. Storia che
pare romanzo, Cava de’ Tirreni, Avagliano,
1994 (or. 1897).
“Om”: “L’Omnibus”, 1862-1865.
Pad: V. Padula, Cronache del brigantaggio in Calabria, a cura di D. Scafoglio, Napoli, Athena, 1974.
PanR: E. Pani-Rossi, La Basilicata, Salerno, Libr.
Ant. Cassari, 1972 (or. 1868).
Paso: E. Pasolini, Memorie raccolte da suo figlio
Giuseppe Pasolini, Torino, 1887.
“Po”: “Il Popolo d’Italia”, 1862-1866.
Pro1: M.F. Proto, La verità sopra gli uomini e le
cose del Regno d’Italia, Napoli, 1862.
Pro2: M.F. Proto, Mozione d’inchiesta del duca di
Maddaloni deputato al Parlamento italiano,
Nizza, 1862.
“Pu”: “Il Pungolo”, 1862-1865.
Rom: A. Romano, Istoria della vita, uccisione ed
imprese di Antonio Di Santo, s.n.t.
Roma: V. Romano, Brigantesse. Donne guerriere
contro la conquista del sud (1860-1870), Napoli, Controcorrente, 2007.
Rov: P.L. Rovito, Il viceregno spagnolo di Napoli,
Napoli, Arte Tipografica, 2003.
Sang: L. Sangiullo, Il brigantaggio nella provincia
di Benevento tra il 1860 e il 1880, Benevento,
De Martini, 1975.
Sca1: D. Scafoglio, Terre e briganti. Il brigantaggio cantato dalle classi subalterne, prefazione
di A. Piromalli, Messina-Firenze, D’Anna,
1977.
Sca2: D. Scafoglio. L’epos brigantesco popolare nell’Italia meridionale, Salerno, Gentile,
1994.
Sca5: D. Scafoglio, La gloria del patibolo, Un santo/brigante dell’epos popolare, in “L’immagine riflessa”, 2007, pp. 225-40.
Sig1: S. Sighele, La coppia criminale, Torino,
1893.
151
Q
uaderni
Sig2: S. Sighele, Il mondo criminale italiano meridionale, Milano, 1893.
Stie: Sacro e profano: note sulla prostituzione nella Germania medievale, in “Nuova dwf”, n. 3,
aprile-giugno 1977, pp. 34-50.
Sto1: L. Stocchi, Ciccilla o i briganti calabresi,
novella in versi, con annotazioni, in Dolori e
speranze, Cosenza, 1865.
Sto3: L. Stocchi, Ciccilla o i briganti calabresi,
dramma storico tragico-comico, col ritratto
della protagonista, Reggio Calabria, Tipografia Caruso, 1873.
152
Thom: E.P. Thompson, Società patrizia e cultura
plebea, tr. it., Torino, Einaudi, 1981.
Turn: J.C. Turner, Social influence, Open Univbersity Press, 1991.
Web: M. Weber, La politica come professione, tr. it., in
Scritti politici, Roma, Donzelli, 1998, pp. 175-230.
Varu: P. Varuolo, Il volto del brigante. Avvenimenti briganteschi in Basilicata (1860-1877),
Galatina, Congedo, 1985.
Zimm: L.R. Zimmermann, Memorie di un ex capo-brigante, tr. e note di E. De Biase, Napoli,
Arte Tipografica Editrice, 2007 (or. 1868).
L’antropologia poetica di Vincenzo Padula
Storia e testo della Notte di Natale
Rosa Troiano
L
a versione a noi nota del poemetto dialettale di Vincenzo
Padula, La notte di Natale, è il
punto d’arrivo di un lungo processo di elaborazione, testimoniato non solo
da stesure differenti del testo, una rimasta
manoscritta e l’altra consegnata alla stampa,
ma anche dalle notevoli varianti che contrassegnano il passaggio dalla seconda alla terza
edizione, rispettivamente del 1858 e del 1878.
La prima redazione è rimasta a lungo
sepolta, manoscritta, nell’Archivio della famiglia Julia, in Acri; solo alcuni decenni addietro è stata segnalata da Giuseppe Julia sul
periodico «La Calabria» (a. xii, n. 2, 28 febbraio 1979), pubblicata successivamente per
intero sul giornale di Acri «Confronto» (a.
ix, n. 11, dicembre 1983). Di questa stesura
l’Archivio Julia conserva due testimoni manoscritti, di mano diversa ed entrambi privi di
data. La copia più antica, probabilmente risalente come vedremo al 1846 (anno che lo stesso Padula indica come data di composizione
del poemetto), scritta in una grafia sottile ed
elegante, consta di cc. 2 r-v; reca sul recto della prima carta, in alto a sinistra, la seguente
dichiarazione: «1a lezione del Natale rinvenuta fra le carte di mio Padre», firmata «Antonio
Julia». Dopo il titolo originario del poemetto
Rumanza, seguono le strofe disposte in dop-
pia colonna e numerate: 27 sestine di ottonari
per la prima parte, 15 quartine saffiche con
adonio quinario per la seconda parte, distinta
con il titolo di Ninna; ed infine 7 ottave per la
terza parte, la Conchiusione. Consta, dunque,
complessivamente di 278 versi, numero inferiore rispetto ai 294 della redazione definitiva.
In calce, il nome dell’autore e l’indicazione del
luogo di nascita che ricorreva frequente nella
firma del poeta: «Vincenzo Padula di Acri».
Si tratta quasi certamente, come ha sostenuto
Giuseppe Julia, di un autografo paduliano per
la somiglianza quasi perfetta dei suoi caratteri
grafici con quelli di altri autografi del poeta,
sebbene il testo presenti alcuni versi che dovranno essere meglio strutturati sintatticamente e metricamente (I 12, v. 1; II 4, v. 2), ed
inoltre c’è un errore di numerazione tra la 6a
e la 7a strofa dell’ultima parte, numerate erroneamente 7 e 8, poi corretto da mano diversa.
L’altro testimone di questa prima versione
del poemetto è una trascrizione di Vincenzo
Julia; il manoscritto reca in alto sul recto del
primo foglio la seguente dedica: «Alla nobile Signora / Da Raffaella Fusaro. / In segno
di stima / Vincenzo Julia». Segue poi il titolo
ampliato: Rumanza di Vincenzo Padula supra
u Natali. Sostanzialmente simile alla prima,
la copia di Vincenzo Julia ha il merito di una
lettura più scorrevole e chiara di quei versi
153
Q
uaderni
imperfetti, segnalati prima, oppure illegibili
(iii 2 2-3; 3 2), che si riscontrano nel supposto autografo paduliano. Ma il trascrittore, nel
redigere la copia, non è sfuggito, quasi certamente, alla tentazione di intervenire su certe
scelte fonetiche cui l’autore rimane fedele nelle redazioni successive (per esempio «ppi» in
luogo di «ppe», ‘per’; «cusiri» in luogo di «cusari» ‘cucire” (ii); «cannacca» in luogo di «jannacca», ‘collana’; «addurusu» per «ordurusu». Inoltre non mancano, in questa copia,
disattenzioni o errori di lettura (per esempio,
«Form’ d’uocchiu» per «For-mal’uocchiu» (I
3, v. 4), che è formula di scongiuro; «s’a vivia»
per «t’a vivia» (i 6 6), qualche intervento arbitrario: «si la sonnu» per «si lu sonnu» (i 8 5),
intervento accolto dal figlio Antonio e passato come vedremo nella edizione del 1894, e
da essa nella vulgata novecentesca; infine, «ci
’mmuttaru ccu lu vetti» in luogo di «cci battirunu lu vetti» (i 19 5).
Il titolo primitivo del poemetto è stato
dunque quello di Rumanza; una voce, vale
qui la pena di ricordare, attestata nella tradizione folklorica e linguistica calabrese e
specializzatasi per indicare generi narrativi
popolari, quali la narrazione di tipo fiabesco
e la leggenda sacra in versi e in prosa. Il racconto della Natività è affidato, com’è noto,
ad un narratore popolare anonimo, che si
qualifica nel ruolo del cantastorie esordendo
con una formula canonica d’inizio dei racconti di tradizione orale: « E na vota (mo v’
’u cuntu) / di dicembri era na sira», ed ha già
la sua articolazione nel polimetro dialettale
che conosciamo, suddiviso in tre parti.
1
154
La prima parte di tipo descrittivo-narrativo, ispirandosi alla leggenda popolare e ai
Vangeli apocrifi, sviluppa il tema della rievocazione del viaggio di Maria e Giuseppe
verso Betlemme, ostacolato, come accade in
altri racconti della Natività (si può ricordare
a tal proposito la Cantata dei pastori di Andrea Perrucci), da una tempesta apocalittica
(«lu Levanti s’era juntu [attaccato] / a Punenti e tira tira / si scippavanu [si strappavano] ’i
capilli / e cacciavanu li stilli»; segue l’episodio
della ricerca dell’ospitalità e del ritrovamento
della capanna; infine la scena del parto della
Vergine, rappresentata nei modi dell’immaginario religioso popolare, fusi senza dissonanze con i concetti del prete-teologo. La
Madonna, effigiata come nell’arte dei presepi
meridionali, nella leggenda popolare si addormenta e sogna di andare in paradiso sollevata dagli angeli sino all’altezza del Signore;
il Signore si strappa dal petto il proprio figlio
e «cun amuri / lu dunau cumu nu milu / e
li dissi: Ti<e>nitilu!»: un’interpretazione ingenua e sublime dove l’autore giunge, com’è
stato detto da Carlo Muscetta, a una quasi
pagana e orfica «teogonia di Cristo»1. La similitudine della mela è ricca, infatti, di implicazioni simbolico-religiose, perché si collega
al peccato di Adamo e alla venuta di Cristo
redentore dell’umanità.
In questa prima parte il poeta adotta la
sestina di ottonari piani e tronchi, destinata
comunque ad affinamenti futuri. La presenza
delle rime e delle assonanze interne evidenzia il legame con la metrica popolare: la strofa
paduliana, tuttavia, si stacca da quella popo-
Cfr. C. Muscetta in V. Padula, Persone in Calabria, a cura di C. M., Milano, Milano-Sera editrice, 1950, p. 99: «Eva
si converte in Maria e il demonio in Padreterno, e il melo non è il pomo del peccato ma la grazia della redenzione
che ha fruttificato presso il cespuglio fiorito: albero del riscatto in sostituzione dell’albero della scienza. Ma tutto
ciò è calato nelle immagini e il Padula [discretissimo artista] non aggiunge alcun commento».
antropologia e storia
lare per la regolarità del ritmo (accenti fissi
sulla 3a e sulla 7a) e delle rime canoniche; inoltre, a differenza di quanto accade nella strofa
popolare, che si frammenta ritmicamente e
semanticamente in maniera rigida nei singoli
versi, la strofa paduliana è più fusa e compatta, spezzando con il ricorso all’enjambement
l’ossessiva monotonia degli ottonari.
La seconda parte, di tipo lirico, contraddistinta con il titolo di Ninna, è occupata per
intero dalla ninna nanna che la Madonna
intona per addormentare il Bambino: « tenero preludio alla visione drammatica della missione terrena di Gesù»2. Il canto della
Vergine si svolge, infatti, lungo due assi fondamentali: quello dell’esultanza della Madre
e l’altro del presentimento della passione e
morte del Figlio. Quest’ultimo tema per ora
è solo adombrato: «Ma noni, sciolla mia!
[sventura mia!] perché spaccari / mi vuogliu
’u piettu, e là ti ci ammucciari [nasconderti], / ca quannu vistu l’uomini ti avrannu /
T’ammazzirannu» (13); ma esso acquisterà
un’intensità lirica maggiore nelle versioni
successive, allorché i versi della ninna nanna
saranno collegati alla poesia drammatica dei
canti popolari religiosi della Passione. Nelle
redazioni successive, il numero dei versi si
dilaterà per accogliere infatti motivi più intensamente drammatici: Padula finirà per
riverberare nella prefigurazione del dramma
sacro i valori e l’universo emotivo della sua
gente, insieme a una condizione di vita ritmata dalla violenza e dalla paura, su cui si
stende, rassicurante, l’ombra protettiva della Madre: «Ah! nu’ chiangiari, no! Pecchì, o
Bomminu, / mi triemi cumu na rìnnina ’n
2
3
/ 2 – comicità e politica
sinu? / Pe mo duormi scuitatu [tranquillo]:
tannu pua / c’è mamma tua».
La metrica della ninna nanna ha una più
forte impronta popolare, per via dei versi
semanticamente e ritmicamente autonomi,
degli endecasillabi divisi nettamente da una
forte cesura in due emistichi e, infine, della
tendenza ad accoppiarli in modo da formare distici saldati dalla rima. La frequentazione dei testi popolari delle ninne nanne
sacre e profane, che costituivano un filone
consistente della poesia di tradizione orale
calabrese, aveva lasciato nella memoria del
poeta un deposito di elementi strutturati, un insieme di schemi ritmico-sintattici
che tendevano a sopravvivere indipendentemente dalle parole, o unitamente a esse:
«Dormi lu mari e dormi la timpesta, / dormi
lu vientu e dormi la furesta» (3 1-2) sono
versi modellati su schemi popolari quali «Beddu è lu mari e beddu è la marina»3;
oppure: «Riposa l’acqua e riposa lu vientu /
riposa campaniellu mia d’argientu; / riposa
l’acqua e riposa lu mari / ripuosu la Madonna ti vò dari». La prima strofa: «Duormi,
billizza mia, duormi e riposa, / chiudi la
vucca tua cumu na rosa / Duormi sicuru ca
ti guardu iu / zuccaru miu», riformulata per
la redazione finale in «Duormi, bellizza mia,
duormi e riposa, / chiudi ’a vuccuzza, chi
pari na rosa / duormi scuitatu, ca ti guardu
iu / zuccaru miu», è contenuta integralmente nel canto sacro monostrofico raccolto a
Vibo Valentia da Raffaele Lombardi Satriani: «Dormi, bejizza mia, / dormi e riposa, /
chiudi ’ssa vucca chi pari na rosa, / Dormi
squetatu [tranquillo], ca ti guardu io, / Ti te-
L. Reina, Dalla fucina di Partenope: Vincenzo Padula, Nicola Sole, Ferdinando Russo, Napoli, ESI, 1996, p. 54.
Cfr. R. Lombardi Satriani, Canti popolari calabresi, Napoli, De Simone, 1933, vol. III, p. 113, n. 2316.
155
Q
uaderni
gnu ’n brazza, zuccaru mio. / E tegnu e sentu
na paura, / ca tu si’ Dio ed eu su’ criatura» (e
si vedano ancora questi altri versi riportati
da Luigi Accattatis: «Duormi, giojuzza mia,
duormi e riposa, / Duormi, giojuzza mia,
duormi ch’èd ura»)4. Ma, in questa ninna
nanna tramata di interi versi, emistichi, stilemi della poesia orale, Padula spezza il pigro andamento e la musica monotona della
versificazione popolare dialettale attraverso
l’adozione della strofa saffica (tre endecasillabi con adonio quinario di schema ABAb),
un metro di chiara impronta classica; tuttavia la saffica paduliana corrisponde ai primi quattro versi di una strofa popolare, cui
è stato tolto il primo emistichio del quarto
endecasillabo, come risulta dalla comparazione con le fonti orali.
Nelle ultime sette strofe, che costituiscono la Conchiusione, Padula adotta invece
l’ottava: anche questa strofa è da mettere in
rapporto con l’ottava della tradizione popolare, con cui ha in comune la struttura ritmica degli endecasillabi, la tecnica descrittiva
e narrativa: «Cussì cantava ’a Vergini Maria
/ ed annacannu chillu quatrariellu: / ’u Cielu vasciu vasciu si facia / nasuliannu chillu
cantu biellu»5 (iii 1 1-3). Padula se ne serve per trattare un tema caro alla tradizione
popolare6, passato nella tradizione letteraria
d’ispirazione folklorica sul Natale, quello dei
miracoli della Notte Santa:
4
5
6
7
156
Ugne jumi portava na chinera,
chi d’uogliu, chi de latti e chi de vinu.
Meli e farina escia d’ ’i cerzi, ed era
carricu ’e juri ogni arburu, ogni spinu.
E tornata paria la primavera
portannu rose e viole intra lu sinu:
’a viti fici l’uva, ’u granu ’e spichi
ed ogneduna tanta eranu ’i fichi7.
(iii, 2 1-8)
Il motivo della natura che sconvolge l’ordine delle sue funzioni e delle stagioni, producendo beni in una maniera innaturale, apparteneva infatti all’immaginario simbolico
popolare e colto; lo si ritrova anche nella Pastorale di sant’Alfonso de’ Liguori, che costituisce
un precedente immediato del polimetro paduliano: «Quanno nascette Ninno a Betlemme / era notte e pareva miezo juorno […] Co
tutto ch’era vierno, Ninno bello, / nascettero a
migliara rose e sciure. / Pe ’nsì ’o ffieno sicco
e tuosto/ che fuie puosto sott’a Te se ’nfigliulette, / e de frunnelle ’e sciure se vestette. / A
no paese che se chiama Ngadde, / sciurettero
le bigne e ascette l’uva». Nella tradizione religiosa popolare il motivo si caricava di attese
palingenetiche e millenaristiche, accogliendo
anche elementi simbolici ed iconografici di
altre tradizioni rituali e mitiche appartenenti
al mondo precristiano: prima di tutto quelle
del rimpianto (o dell’attesa) dell’età dell’oro e
dell’avvento del Fanciullo divino, mescolandosi ad altri motivi tipici del presepe meridionale,
Cfr. L. Accattatis, Vocabolario del dialetto calabrese (casalino-apriglianese), Castrovillari, Nigro 1895-98, (rist.
anast., Cosenza, Pellegrini, 1977), s. v. ninna.
«Così cantava la Vergine Maria, cullando quel bambinello: il Cielo si abbassava, porgendo l’orecchio a quel canto
bello».
Cfr. L. Accattatis, Vocabolario, cit., s.v. Natale.
«Ogni fiume portava una piena quale d’olio, quale di latte, e quale di vino. Miele e farina usciva dalle querce, ed era
carico di fiori ogni albero, ogni rovo. E sembrava ritornata la primavera portando rose e viole in grembo; la vite
fece l’uva, il grano le spighe ed ogni fico era tanto grosso».
antropologia e storia
come quello dell’offerta dei doni. Quest’ultimo
consente all’autore di intervenire direttamente
nella narrazione e di siglarla con una chiusa
scherzosa, da cantastorie povero in canna, superando il rischio della morale edificante delle
formule delle canzoncine religiose sul Natale:
«iu sulu non avia li comprimenti. / Li sacchetti
mi jiva scaliannu / ma mera sutta e supra, ’un
c’era nenti! / Chi fici poca? Fici na canzuna / e
’u Bomminu mi dezi na curuna»8.
Non soddisfatto di questa prima stesura,
per l’ordine e la qualità della narrazione e la
forma linguistica raggiunta, Padula prepara
una nuova redazione, di cui sono conservati
due esemplari diversi a stampa, che fanno pensare a due diverse edizioni. La prima, di tiratura quasi certamente limitata, è costituita da un
modesto libretto, di cui una copia è conservata
presso la Biblioteca Nazionale di Napoli (segn.
B.C. Misc. 127). Si tratta di un opuscolo di pp.
11, privo di copertina e di frontespizio, per cui
la numerazione inizia da pag. 3 e termina a pag.
13. Sulla prima pagina si legge, in alto, la scritta
ad inchiostro: «Il Natale di Vincenzo Padula».
Il nome del poeta è ripetuto anche alla fine del
poemetto (p. 13). Le pagine cucite sono raccolte in un foglio di carta di colore azzurrino
su cui è trascritto il titolo seguito dal sottotilo
Poesia in dialetto calabrese di V. Padula.
Quasi sicuramente il poeta dovette preparare subito una seconda ristampa del testo, più accurata. Un esemplare di questa, in
buone condizioni, ora si trova presso l’Archivio Padula di Acri. È un opuscolo completo
di copertina e frontespìzio, su cui si legge:
Canzone calabrese / sopra / La Notte di Natale / di / Vincenzo Padula (Cosenza, Tipogra-
8
/ 2 – comicità e politica
fia di Giuseppe Migliaccio, 1858, pp. 13). Il
testo è sostanzialmente identico a quello della prima edizione, di cui, quasi certamente, il
tipografo ebbe una copia con alcune correzioni probabilmente fatte in fretta dall’autore. Risultano corretti alcuni refusi come «arrinsinatu» con «arrisinatu»; «arrobari» con
«arrobbari»; «zampugna» con «sampugna».
Anche i caratteri e la disposizione delle strofe sono leggermente diversi.
La «rumanza», in queste prime due
stampe, si trova notevolmente modificata in
tutte e tre le parti, nonché arricchita di quattro strofe saffiche, per cui sale a 294 il numero complessivo dei versi. I ritocchi non sono
solo di ordine linguistico, fatti tentando di
ricercare nella lingua dialettale il giusto
correlativo espressivo (ad esempio, «e cacciavanu li stilli», della prima strofa, che diventa «e sbrittavanu li stilli», ‘e scappavano
le stelle’, con un cambiamento nella struttura
sintattica e semantica dell’operatore verbale – su questo luogo ci saranno comunque
altri interventi del poeta –), ma si tratta di
sostituzioni più complesse, qualitativamente
più rilevanti. Un confronto tra la redazione
rimasta manoscritta e queste prime edizioni
del testo rinvia a due tempi diversi, di cultura e di stile, dell’attività poetica di Vincenzo
Padula: i rifacimenti migliorano sia l’orditura della fabula sia il livello sintattico e metrico delle strofe; accentuano l’aura sacrale
della rappresentazione, con l’eliminazione
di particolari figurativi e descrittivi troppo
ridondanti o realistici, frutto di un virtuosismo linguistico che appesantiva le immagini. Si veda come vengono ridistribuiti i par-
«Io solo non avevo doni. Andavo rovistando nelle tasche, ma guardo sotto e sopra, non c’era niente! Che feci allora?
Feci una canzone e il Bambino mi diede una corona».
157
Q
uaderni
ticolari della raffigurazione di San Giuseppe,
presentato secondo i caratteri fissati nella
leggenda e nei canti popolari, nella condizione di vecchio (calvo, stanco, intirizzito
dal freddo, arrisinatu) garante, presso la tradizione popolare, del dogma dell’Immacolata Concezione:
Quannu stancu e arrisinatu
di Sionne ppe la via
jia nu viecchiu, chi spinnatu
ha la capu, e si tenia
intra ’i mani nu bastuni
chi paria nu viscigliuni.
(i, 2 1-6)
Quannu scavuzu e spinnatu
’e Sionni pe la via
jia nu nu viecchiu arrisinatu;
avia n’ascia alla curria:
muortu ’e friddu, e povaru era
ma omu ’e Diu paria a la cera.
(i, 3 1-6)
Nell’immagine riproposta del padre putativo di Cristo viene fatto cadere il particolare
del bastone con la connessa similitudine, che
è solo una ripetizione di significato: certo, si
perde un lemma inconsueto, viscigliuni (accres. di viscigliu, propriam. ‘pianta giovane di
quercia o castango’, che vale anche per ‘bastone nodoso, frusta’, da correlare all’antico
‘querciolo’), ma sono recuperati altri aspetti
cari sia alla tradizione popolare (la condizione di povero falegname, protettore dei miseri
e degli oppressi), sia alla Chiesa e al prete colto, ovvero dell’‘uomo eletto da Dio’.
Anche i particolari figurativi presenti
nell’immagine della Vergine saranno ridotti e affinati attraverso «il lavoro attento sulle varianti»9. Nella prima stesura, secondo
il canone dell’arte popolare, il poeta punta
non solo alla rappresentazione delle bellezze del volto ma anche a quelle dei capelli,
divisi nel mezzo della testa e cadenti sulle
spalle a boccoli, come un mannello di spighe d’oro. Superando la pretta nomenclatura e il rischio della ridondanza, Padula,
nella seconda versione, serra la descriptio
figurae della Madonna in un’unica strofa,
intorno a due parti del viso: le guance e la
bocca, scegliendo per il gioco delle similitudini e delle metafore, ancora una volta,
figuranti specializzatisi nella poesia colta e
popolare, assimilati a un linguaggio reso tenero e sensuale dalla grazia espressiva degli
ipocoristici:
(Manoscritto)
’N faccia avia na rosicella,
na vuccuzza ch’era aniellu,
nu labbruzzu a zagarella,
lisciu lisciu ’u varbariellu;
si ridiva lu mussillu
paria justu nu jurillu.
Ccu na scrima e ’ndrizzatura
’ncannulata e a manna d’oru
l’arrivava alla cintura
di capilli lu trisoru.
Viata Illa, a diri ’u veru
T’ ’a vivia ccu nu bicchieru10.
(i, 5 1-6)
R. Librandi, La Calabria, VII, La letteratura dialettale, in Dialetti italiani. Storia, struttura, uso, a cura di M. Cortelazzo, C. Marcato, N. De Blasi, G. P. Clivio, Torino, UTET, 2002, p. 819.
10
«Una rosellina aveva sul viso, una boccuccia che era un anello, un labbruzzo di seta rossa, liscio liscio il piccolo
mento; se rideva il musino sembrava proprio un fiorellino. Con una scriminatura e intrecciatura, inanellata e a
mannello d’oro, le arrivava alla cintola il tesoro dei capelli. Beata Lei! a dire il vero, te la bevevi con un bicchiere».
9
158
antropologia e storia
(Prime stampe)
’N faccia avia na rosicella;
’a vuccuzza era n’aniellu;
ti paria na zagarella
russa ’e sita ’u labbriciellu,
scocculatu e pittirillu
tali e quali nu jurillu.
(i, 5 1-6)
Un’ultima considerazione sull’episodio
della ricerca dell’ospitalità, un tema che appartiene alle sacre rappresentazioni e alle
leggende popolari sul Natale: nel poemetto
paduliano acquista una forte tensione populistica, facendo emergere, accanto ai sentimenti egalitari e cristiani, i motivi della
lotta politica di cui Padula aveva caricato più
esplicitamente il componimento in lingua,
La Notte di Natale, con versi di questo tipo:
«Godi, o popolo, esci dal sacro sonno», versi
che gli erano costati l’arresto e il carcere:
Nu palazzu c’è vicinu,
illi currunu alla porta.
Circu’ alloggiu, e fannu ’a posta
ed aspettanu ’a risposta.
Cannaruti li padruni
stau mangiannu, e nnu’ rispunnu:
c’è n’orduri ’e maccaruni,
li piatti vanu ’ntunnu,
e si senti finu a basciu
d’ ’i bicchera lu fragasciu.
«Tuppi! tuppi! » – Chini è lluocu?
«È nu povaru stracquatu,
senza liettu e senza fuocu,
chi la mugli teni allatu;
11
/ 2 – comicità e politica
ha li dogli e figlierà:
si ci fati ’a carità.
<N’>ugne ’e v<r>asci e de jacina
ppe passari chissa notti
pua dumani de mattina
c’impisammu, e buona notti!
Per amuri di Mosè,
pocu luocu ccà ci n’è?»
Ohi! figlioli, lu criditi!
Chillu riccu (chi li pozza
lu Diavulu ’i muniti
li squagliari intra la vozza!)
l’adissau li cani ’ncuollu
e scapparu a rumpicuollu.
(i, 9 3-6; 10-13 1-6)
Nu palazzu c’è vicinu,
s’arricettanu a la porta;
pua (e tremavanu li manu)
trocculianu chianu chianu.
Cannaruti! li ricconi
cancarianu, e nu’ rispunnu’;
c’è n’orduri ’e cosi boni,
’i piatti vanu ’n tunnu,
ed arriva lu fragasciu
d’ ’i bicchera finu a basciu.
«Tuppi! tuppi!» – Chi n’è luocu?
«È nu povaru stracquatu,
senza liettu, senza fuocu,
cu la mugli a bruttu statu.
Pe Giacobbi e pe Mosè,
nu riciettu cà ci n’’è»
O figlioli, lu criditi?
Chillu riccu (chi li pozza
’u diavulu ’i muniti
Manoscritto: «C’è vicino un palazzo, essi corrono alla porta. Ingordi i padroni, stanno mangiando e non rispondono: c’è un odore di maccheroni, i piatti vanno in giro, e si sente fino a giù il fracasso dei bicchieri. Toc! Toc! “Chi è
là?” “È un povero pellegrino, senza letto e senza fuoco, con al fianco la moglie, ha le doglie e partorirà: se ci fate la
carità. Un po’ di brace e di giaciglio, per passare questa notte, poi domani di mattina ce ne andremo, e buona notte!
Per amore di Mosè, c’è un po’ di posto qui”. O, figlioli, lo credete!, quel ricco (che il diavolo gli possa squagliare le
159
Q
uaderni
’ncaforchiari dintro ’a vozza!)
a nu corsu, chi tenia,
dissi: «Acchiappa! Adissa! A tia!»11.
(i, 9 3-6; 10-12 1-6)
Si noti come la sostituzione di padruni
con ricconi non attenua la rabbia popolare
contenuta in questi versi, di cui il poeta si fa
portavoce, perché lo scontro di classe finisce
per essere rappresentato nei termini primordiali della contrapposizione frontale tra «ricchi» e «poveri»: tipica della ideologia delle
classi subalterne, questa visione emerge nella
poesia dialettale calabrese, d’origine o d’ispirazione popolare, del periodo postunitario.
Non soddisfatto ancora della forma raggiunta, Padula rivedrà per l’ultima volta il
testo apportandovi delle notevoli modifiche,
frutto di un approfondimento della ricerca
lessicale e di forme dialettali che lo portano
a ripensamenti nella resa di fatti fonetici e
morfologici caratterizzanti il dialetto della
Calabria settentrionale. La revisione linguistica non avviene sempre a favore del dialetto più autentico, come «schioppatu» per
«calatu» (ii, 14 3), «cumprimienti» in luogo
di «cumprimenti» (iii, 8 4); «ma l’autri avianu pisi» che diventa «ma chilla jia ’ncollata»
(iii, 8 3); può accadere anche l’inverso, ovvero che parole dialettali vengano sostituite da
forme più vicine alla lingua, o propriamante
di ascendenza letteraria, come «sbrittavanu»
corretta con una variante più alta «’nfugavanu» ‘mettevano in fuga’, di migliore resa
fonica e di maggiore coerenza semantica e
stilisica. Altro esempio significativo è fornito dal caratteristico attributo pizzutella (i
15 2), lemma così commentato dal Padula,
nel Vocabolario calabro, saltando la semantica di base: «aggettivo di donna bellina. È na
pizzuttella. 2 Mesta, scornata. A luna pizzutella [malinconica] la fa stari»12. Con questi
tratti polisemici, vale a dire di ‘graziosa’, ed
insieme ‘mesta, pietosa’, aveva composto un
sintagma molto poetico nelle prime versioni: «’a luna pizzutella», che scompare, però,
a vantaggio di una suggestione, si può dire,
leopardiana: «’a luna virginella».
Nella realizzazione di una forma più sorvegliata e sciolta si trovano ristrutturate intere strofe. È molto probabile che nella strofa
19 (1-3) la riformulazione sia partita da una
svista iniziale: il mantello dei contadini non
si sbottona ma si sgancia: «San Giuseppi lu
mantiellu / si sbuttuna ’nfretta ’nfretta, / pua
lu spanni biellu biellu», luogo corretto in
«San Giuseppi, c’ha lu mantu, / si lu sgancia
’nfretta ’nfretta, / ci lu spannidi a nu cantu»
Poco più avanti è eliminato molto opportunamente il riso degli angeli e il riferimento
alle ali, spostando l’attenzione sullo splendore del volto della Madonna, rendendo così
più mistica e sacrale una delle scene più intense del poemetto: il miracolo degli angeli
che sollevano in sogno la Vergine in Paradiso, affinché riceva in dono il frutto divino.
Questo lavoro di revisione approda all’edizione per il volume Poesie varie, del 1878
monete nel gozzo!) gli aizzò i cani addosso che scapparono a rompicollo ». Prime stampe: «C’è vicino un palazzo,
s’accostono alla porta; poi (e tremavano le mani) bussano piano piano. Ingordi! i ricconi s’ingozzano e non rispondono; c’è un profumo di cose buone, i piatti vanno in giro e arriva fino a giù il fracasso dei bicchieri. Toc! Toc!
“Chi è là? “È un povero pellegrino, senza letto, senza fuoco, con la moglie in brutto stato. In nome di Giacobbe e
di Mosè, c’è un alloggio qui per noi?” O figlioli, lo credete?, quel ricco (che il diavolo gli possa stipare nel gozzo le
monete!) disse a un cane corso, che aveva: “Acchiappa! Addosso! A te!”».
12
V. Padula, Vocabolario calabro, m.s., c. 250, s. v.
160
antropologia e storia
(Napoli, Tipografia Pansini). La canzone sul
Natale occupa le pp. 26-34. Leggermente
modificato si trova il titolo, che per la prima
volta viene accompagnato dalla data e dal
luogo della prima ideazione del poemetto:
La Notte di Natale / Canzone in dialetto Calabrese / Sammarco Argentano – 1846. Considerando il lungo arco di tempo tra la prima
stesura e l’ultima revisione sembra valere
per il Padula ciò che è stato detto del Parini,
a proposito della lunga fase elaborativa del
Giorno: «a nessuno è mai concesso di staccarsi dalla propria pagina come da qualcosa
di perfettamente oggettivato»13. Certo, l’accostamento può apparire per molti versi incongruo, ma non si può negare che il lavorio di
rifacimenti e di ritocchi abbia contribuito a
conferire al componimento paduliano la forma di capolavoro della letteratura dialettale
calabrese dell’Ottocento; per Umberto Bosco il poemetto paduliano rappresenta, anzi,
«una delle cose più squisite del romanticismo
italiano, non solo di quello calabrese»14.
Dopo questa revisione, accertata da una
stampa curata dall’autore, non abbiamo
per ora altra documentazione che ci attesti
che il poeta abbia avuto motivo, o occasione, di ritornare sul suo testo. Le condizioni
di salute si aggraveranno sempre di più a
partire dal 1884: Padula muore nei primi
di gennaio del 1893, un anno prima che il
polimetro venisse ripubblicato in appendice
al suo volume di versi, Poesie (Napoli, Morano e Veraldi, 1894, pp. 253-71) con una
breve premessa e con note di traduzione di
Antonio Julia. Questa edizione postuma del
poemetto è certamente più accurata, sotto il
/ 2 – comicità e politica
profilo editoriale e nei criteri di trascrizione
del dialetto, in quanto sono segnalate con
il segno dell’apostrofo tutti i fenomeni di
aferesi, apocopi, elisioni, ma presenta delle
divergenze rispetto al testo del 1878, che sia
pur minime, sono molto discutibili. Innanzitutto essa manifesta una tendenza in contrasto con l’usus scribendi dell’autore, che si
manifesta sul livello grafico e fonomorfologico, nel rappresentare la preposizione ‘in’
unita alla parola che segue, quando non si
tratta di assimilazione fonosintattica (per
es., ’n cammisuottu > ’ncammisuottu), nonché ad univerbare le preposizioni articolate
scisse e scempie (ad esempio a la > alla, cu
la > culla). Accanto a questi ci sono poi due
interventi, espressamente dichiarati da Julia
nelle note al testo, su fatti grafico-fonetici
caratterizzanti il dialetto calabrese: ovvero il
trattamento relativo allo sviluppo del gruppo consonantico fl, per esempio nella base
latina afflare, reso da Julia con il simbolo dell’aspirata mediopalatale «tu l’acavi»:
l’esito dal Padula era stato percepito nella
forma di una palatalizzazione più spinta e
quindi reso con l’allungamento della semiconsonante palatale -jj-, fenomeno comune
peraltro al Cosentino15; ed ancora, fatto minimo questo e legittimo, la riduzione grafica
del segmento schio- adoperato dal Padula
per rendere, ogni qual volta essa ricorre, la
pronuncia palatale della sibilante davanti
a consonante velare [š], con sc- (scamava),
indicando in nota il corrispondente valore
fonico. Sono poi corretti alcuni refusi, ma
l’edizione non è esente da altri errori: «e
Sionni» al posto di «’e Sionni» (I, 3 2), «e
Cfr. D. Isella, Le carte mescolate. Esperienze di filologia d’autore, Padova, Liviana, 1987, p. 93.
Cfr. U. Bosco, Pagine calabresi. Saggi e testi di letteratura calabrese, Reggio Calabria, Ed. Parallelo, 1975, p. 43.
15
Cfr. C. Grassi-A.A. Sobrero-T. Telmon, Introduzione alla dialettologia italiana, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 72.
13
14
161
Q
uaderni
Diu» in luogo di «’e Diu» (I, 3 6). Di particolare rilievo sono due varianti che potrebbero
sembrare ripensamenti dell’autore, ma con
molta probabilità non lo sono: esaminiamo
prima il caso di nasuliannu ‘porgendo l’orecchio’, ovvero ‘stando ad ascoltare’ (iii 1 4). La
forma, presente in tutte le stesure, si trova
corretta nell’edizione postuma del 1894, in
asuliannu, vale a dire con la variante fonetica
più corrente, dall’infinito asuliare, probabile
oscismo: «*a u s u l a r e [a sua volta] dall’osco *a u s i s ‘orecchio’»16. Padula, però, nelle
carte 11 e 207 del suo Vocabolario calabro,
registra sia asuliari, con traduzione ‘origliare’, sia nasuliari, forma ridotta di annasuliari 17; per quest’ultima fornisce i corrispondenti in uso nel tempo, ‘usolare’ ed ‘osolare’:
nel selezionare per la propria lingua poetica
una forma escludendo l’altra si esprimevano
anche i suoi gusti filologici.
Un’altra variante, che costituisce un’evidente corruzione, è la sostituzione nella
strofa 8, della prima parte del polimetro, del
pronome neutro lu in funzione cataforica,
ovvero che anticipa un’intera proposizione e
non un singolo referente, attestato da tutte le
versioni paduliane: «E la bella furracchiola,
/ chi camina appriessu ad illu / pe v’ ’u diri
’un c’è parola, / sugnu mutu pe lu trillu…/
mo de vua chi si lu sonna? / Si chiamava la
Madonna.» (chi si lu sonna: ‘chi può immaginare ciò che sto per dire’), con il pronome
femminile la: «mo di vua chi si la sonna? /
Si chiamava la Madonna». Questa edizione
del 1894, che per i dati in nostro possesso
non ha alcuna autorevolezza, comunque ha
costituito il testo di riferimento per tutti i
curatori delle edizioni successive, le quali,
peraltro, non sono prive ancora di ulteriori
alterazioni, sia nella veste dialettale sia nella
sostanza del testo18.
Per le ragioni esposte, nel riprodurre qui
di seguito il polimetro paduliano, corredato di traduzione e di note linguistiche e di
commento, è stato adottato come testo-base
l’edizione del 1878, rispettando nella trascrizione le scelte grafiche dello scrittore, che
ci risultano abbastanza coerenti e moderne
sotto il profilo dell’ortografia dialettale. Gli
interventi, pertanto, sono stati limitati a disaccentare la forma cà (‘che’, ‘perché’) riducendola in ogni caso a ca e differenziandola
dall’avverbio ccà ‘qui’, che si è preferito rappresentare con l’iniziale raddoppiata insie-
G. Rohlfs, Nuovo dizionario dialettale della Calabria (con repertorio italo-calabrese), Ravenna, Longo, 1977, s. v.
Cfr. anche G. Rohlfs, cit., 1977, s. v. annasulià; ma la forma è diffusa anche in Irpinia, vd. S. La Vecchia, Bonidizio.
Dizionario bonitese, Grottaminarda (AV), Delta 3, 1999; D. M. Cicchetti, Un’isola nel mare dei dialetti meridionali.
Prefazione di T. De Mauro, Cautillo-Vallesaccarda. 1988, s. v. annasolà / annasulà.
18
La Notte di Natale, a cura e con note di Antonio Julia, in Appendice al vol.V. Padula, Poesie varie e dialettali.
Seconda parte (Appendice al 1° volume), Editore: Giovanni Padula, Acri, 1930, pp. 69-87; La notte di Natale, in
Vincenzo Padula, con prefazione e note di Giuseppe Julia, Cosenza MIT, 1967, pp. 29-50; La notte di Natale, in
Poesia dell’Ottocento, a cura di Carlo Muscetta e Elsa Sormani, Torino, Einaudi, 1968, vol. II, pp. 1581-92 (il testo
è seguito dalla traduzione a piè di pagina); La notte di Natale, in V. Padula, Due componimenti poetici dialettali,
con traduzione a fronte, introduzione e note di Franco di Benedetto, Cosenza, Pellegrini, 1975, pp. 13-41; La notte
di Natale, in G. Abbruzzo, Le poesie dialettali di Vincenzo Padula, Cosenza, Edizioni Orizzonti Meridionali, 1993,
pp. 48-75. Il curatore del volumetto pubblica anche la versione manoscritta del poemetto, ripresa dal numero di
«Confronto», cit., accompagnando i testi con note filologiche. Per ultimo, si veda anche il testo riprodotto nell’antologia di componimenti dedicati al tema del Natale, Il Natale nella poesia calabrese, a cura di Angela Ferraro-Egle
Lucente, Cosenza, Pellegrini, 2002, pp. 77-101.
16
17
162
antropologia e storia
me all’avverbio cchiù ‘più’; si è provveduto
a indicare sempre con il segno diacritico
dell’aferesi (’) le forme ridotte degli articoli
e delle preposizioni semplici, segnalate da
Padula con l’accento circonflesso, riservando questo soltanto ai casi di contrazione
(es., ’a, ’e ‘la’, da’, ‘di’ in luogo di â, ê; ma â per
‘alla’); anche le forme apocopate dei verbi
sono state segnalate con l’apostrofo; è stato
adottato l’accento grave per le forme sincopate: sì, ‘sei’; pò, ‘può’; infine si è provveduto
a separare, nei pochi casi in cui non avvie-
/ 2 – comicità e politica
ne, la preposizione ’n (‘in’) dalla parola che
segue. Sono stati corretti i pochi refusi, ed
infine si è preferito trascrivere la formula di
scongiuro For mal uocchio! con la grafia Fore
maluocchio!, rappresentando così la vocale
finale (avvertita nella pronuncia come centralizzata) in fore e univerbando la sequenza successiva. L’interpunzione è stata lievemente ammodernata, le maiuscole sono
state mantenute solo quando lo richiede il
moderno uso grafico, sopprimendole all’inizio di ogni verso.
163
Q
uaderni
LA NOTTE DI NATALE
Canzone in dialetto calabrese
(Sammarco Argentano -1846)
I
1. E na vota, mo’ v’ ’a cuntu,
’e decembri era na sira,
’u Levanti s’era juntu
cu Punenti; e tira tira
si scippavanu ’i capilli,
e ’nfugavanu li stilli.
I
1. E una volta, ora vi racconto, era una sera di
dicembre, il Levante si era attaccato con il
Ponente e, tira tira, si strappavano i capelli e
mettevano in fuga le stelle.
2. Niuru cumu na mappina
’u cielu era, e spernuzzati
cumu zinzuli ’e cucina
jianu ’i nuvi spaventati;
e lu scuru a fella a fella
si facia cu li curtella.
2. Il cielo era nero come uno straccio, e sparpagliate come cenci di cucina se ne andavano le
nuvole spaventate; e il buio si poteva tagliare
a fette con i coltelli.
3. Quannu scavuzu e spinnatu
’e Sionni pe la via
jia nu Viecchiu arrisinatu;
avia n’ascia alla curria:
muortu ’e friddu e povaru era,
ma omu ’e Diu paria a la cera.
3. Quand’ecco scalzo e con la testa calva, per la
strada di Sion, se ne andava un vecchio intirizzito: aveva un’ascia alla cintura, era morto
di freddo e misero, ma dall’aspetto appariva
come uomo di Dio.
Metro – Poemetto polimetro diviso in tre parti: la prima, di ventisette strofe di sei versi ottonari rimati ABABCC; la
seconda, di diciannove strofe saffiche di schema ABAb; la terza, di sette ottave narrative di endecasillabi ABABABCC.
I-1.1 E na vota: formula canonica d’inizio dei racconti di tradizione orale che definisce in maniera indeterminata il
tempo della vicenda; singolare è l’uso della congiunzione E come segnale discorsivo che apre la narrazione; mo v’ ’a
cuntu: cioè ‘ora vi racconto la rumanza’; 6 ’nfugavanu: ultimo esito lessicale, come è stato già detto, di un processo di
revisione, tra manoscritto e prime stampe, che va da cacciavanu a sbrittavanu, a ’nfugavanu; la selezione, agendo sulla
struttura fonica del verso, ne aumenta la tonalità lirico-espressiva.
2.1 mappina: dal lat. m a p p a ‘tovagliolo’, la voce è passata a indicare lo strofinaccio (sporco) della cucina; 2 spernuzzati: part. pass. del verbo spernuzzare, variante regionale dialettale dell’italiano ‘sparnazzare’ che appartiene al gergo
contadino e vale per ‘spargere di qua e di là; sparpagliare’ (ma vd. anche V. Padula, Vocabolario calabro, ms., cc. 303,
306, 347).
3. 1-3 Quannu … arrisinatu: rappresentazione tipica, della leggenda e dell’iconografia popolare, del padre putativo di
Cristo; arrisinatu: «intirizzito dal freddo» (A. Julja, Note a V. Padula, 1930, pag. 70, n. 4); 4 avia …curria: la condizione
di povero falegname ha fatto eleggere San Giuseppe presso la tradizione popolare a protettore dei miseri e degli oppressi; 6 omu ’e Diu: cioè, ‘uomo eletto da Dio’.
164
antropologia e storia
/ 2 – comicità e politica
4. Tocca-pedi a lu vecchiottu
pe la strata spara e scura
caminava ’n cammisuottu
(fore maluocchiu!) na Signura
cussì bella, cussì fatta
chi na stilla ’un si ci appatta.
4. Sulle orme del vecchietto, per la strada erta e
buia camminava in camiciotto (via il malocchio!), una Signora così bella, così ben fatta
che una stella non può mettersi a pari.
5. ’N faccia avia na rosicella;
’a vuccuzza era n’aniellu;
ti paria na zagarella
russa ’e sita ’u labbriciellu,
scocculatu e pittirillu
tali e quali nu jurillu.
5. Sul viso aveva una rosellina; la boccuccia era
un anello; ti pareva un nastrino rosso di seta
il labbruzzo, sbocciato e piccolino tale e quale
un fiorellino.
6. Era prena ’a povarella,
prena rossa; e ti movia
tunna tunna ’a trippicella,
chi na varca ti paria
quannu carrica de ranu
va pe mari chianu chianu.
6. Era pregna, grossa pregna; e muoveva tondo
tondo il pancino che pareva una barca quando carica di grano va per mare piano piano.
7. O figlioli, chi ’mparati
ssa divota mia canzuni,
via! ’i cappella vi cacciati,
7. O figlioli, che imparate questa mia canzone
devota, via! toglietevi i cappelli, mettetevi in
4. 1 Tocca-pedi: locuzione avverbiale, cioè, ‘di seguito, immediatamente dopo’; cammisuottu: «Sarebbe camiciotto: La
Nencia dice gonnello» (V. Padula, Vocababolario calabro. Laboratorio del Dizionario Etimologico Calabrese, a cura di
John B. Trumper, Roma-Bari, Laterza, 2001,s. v.); il camiciotto propriamente è la veste di colore rosso che le donne
maritate un tempo portavano in Acri; 4 fore maluocchiu!: formula di scongiuro per difendere dal malocchio una donna
bella e in questo caso anche incinta, pertanto più esposta, secondo la tradizione popolare, al potere malefico della jettatura o del malocchio (vd. anche D. Scafoglio, La jettatura. La difesa dall’invidia e il codice del saper vivere, Id., Contesti
culturali e scambio verbale a Napoli, Salerno, Gentile, 1995, pag. 109).
5. 1-6 ’N faccia … labbriciellu: metafore e similitudini della bellezza femminile molto correnti nella poesia di tradizione
orale; zagarella: voce supposta di origine araba (< zahar, ‘fior d’arancio’), diffusa nei dialetti di area meridionale.
6. 2 prena rossa: si dice della donna gravida degli ultimi mesi; qui, ovviamente, sul punto di partorire; 4-6 chi na varca
… chianu: l’immagine, che appartiene al linguaggio della poesia popolare, aveva particolarmente colpito il gusto e la
sensibilità di Padula, il quale, nel commentare i seguenti versi di un canto d’amore di braccianti: «Intra ssu llettu e ricamati panni / Ci sta na varca cu tricientu ’ntinni: / È na figliola di quattordici anni, / Calata da lu cielu ’n terra vinni», così
scriveva: «La bella, che si spoglia, a lui [bracciante] sembra una barca con trecento antenne. Che immagine graziosa!
Il poeta aristocratico, ed ignaro della vita, paragona una bella donna alla farfalla variopinta, alla tortorella che geme,
alla pallida luna, alla rosa ricca di minio che pompeggia nel prato; ma il nostro bracciante ha miglior gusto, non ha
che farsene né di farfalle, né di rose, né di luna; e vuole una barca con trecento antenne, una donna dal collo torto, dalle
spalle larghe, dai fianchi arditi, dai polsi d’acciajo, vigile, diligente, infaticabile massaia; e siffatta donna si chiama barca
tra noi, barca che porta grano e ricchezza, barca con la quale il povero uomo spera solcare lieto le onde tempestose
della vita » («Il Bruzio», 6 luglio 1864).
7. 1 O figlioli: invocazione con funzione prevalentemente fàtica; il poeta-cantastorie prende contatto con il suo pubblico (di giovani ascoltatori), a cui demanda, tra l’altro, il compito di ritenere a memoria la canzone per immetterla nel
165
Q
uaderni
vi minditi ’nginocchiuni.
Chillu viecchiu…e chi ’un lu seppi?,
si chiamava San Giuseppi.
ginocchio. Quel vecchio – e chi non lo ha capito – si chiamava San Giuseppe.
8. E la bella furracchiola,
chi camina appriessu ad illu…
pe v’ ’u diri ’un c’è parola,
sugnu mutu pe lu trillu…
mo’ de vua chi si lu sonna?
Si chiamava la Madonna.
8. E la bella giovinetta, che cammina dietro di
lui – non c’è parola per dirvelo, sono muto
per la gioia –, ora chi di voi se lo sogna? Si
chiamava la Madonna.
9. Pe lu friddu e lu caminu
’a facciuzza l’era smorta.
Nu palazzu c’è vicinu,
s’arricettanu a la porta;
pua (e tremavanu li manu)
trocculianu chianu chianu.
9. Per il freddo e il cammino, la faccina era
smorta. C’è vicino un palazzo, s’accostano
alla porta; poi (e tremavano le mani) bussano
piano piano.
10. Cannaruti! li ricconi
cancarianu, e nu’ rispunnu’;
c’è n’orduri ’e cosi boni,
’i piatti vanu ’n tunnu,
ed arriva lu fragasciu
d’ ’i bicchera finu a basciu.
10.Ingordi! I ricconi s’ingozzano e non rispondono; c’è un profumo di cose buone, i piatti
vanno in giro, e arriva fino a giù il fracasso
dei bicchieri.
11. «Tuppi! tuppi!» - Chi n’è ’lluocu?
«È nu povaru stracquatu,
senza liettu, senza fuocu,
cu la mugli a bruttu statu.
Pe Giacobbi e pe Mosè,
nu riciettu ccà ci n’è»
11.«Toc! Toc!» «Chi è là?». «È un povero pellegrino, senza letto, senza fuoco, con la moglie
in brutto stato. In nome di Giacobbe e di
Mosè, c’è un alloggio qui per noi?»
solco della tradizione orale della propria comunità; 4 vi minditi: 2a pers. plur. dell’imperativo di mìntere, con fenomeno
di sonorizzazione della occlusiva dentale sorda in posizione postnasale interna (t<d) e con il pronome atono vi in
posizione proclitica.
8. 1 furracchiola: nei dialetti calabresi furracchia / -ola è la contadinella giovane e graziosa (V. Padula, Vocababolario
calabro., cit., c. 98: «Furracchia: Giovinetta»).
9.4 s’arricettanu: ovvero ‘trovano riparo’; arricettari vale qui per ‘alloggiare’, nel senso di ‘ricoverare’ (vd. anche V. Padula, Vocababolario calabro, cit., c. 8; ma vd. anche avanti, 11. 6, riciettu, lat. r e c e p t u s ‘rifugio, ricovero’).
11. 1 Tuppi! Tuppi!: onomatopea che imita i colpi dati alla porta; 2. stracquatu: propr. ‘fuggiasco, ramingo’; ma vd. anche
A. Julia, Note, cit., p. 73, n. 3: «Cittadino d’altro paese, uscito dalla propria patria, e che vive miseramente»; 5 Giacobbi… Mosè: noti personaggi biblici, l’uno fu patriarca degli Ebrei, l’altro fu liberatore del popolo d’Israele dalla schiavitù
egiziana, nonché capo e legislatore al quale Dio affidò il testo dei Dieci Comandamenti.
166
antropologia e storia
/ 2 – comicità e politica
12. O figlioli, lu criditi?
chillu riccu (chi li pozza
’u diavulu ’i muniti
’ncaforchiari dintra ’a vozza!)
a nu corsu, chi tenia,
dissi: «Acchiappa! Adissa! A tia!».
12.O figlioli, lo credete?, quel ricco (che il diavolo gli possa stipare nel gozzo le monete!),
a un cane corso che aveva disse: «Acchiappa!
Addosso! A te!».
13. ’A Madonna benadissi
chilla casa; e a lu maritu:
«Jamuninni fora – dissi –.
Mina ’i gammi e statti citu».
Si ligau lu muccaturu
E si misi pe lu scuru.
13. La Madonna benedisse quella casa; e al marito disse: «Andiamocene in campagna. Mena
le gambe, e sta’ zitto». Si legò il fazzoletto e si
mise per il buio.
14. Ma spattarunu la via,
e cadianu ’ntroppicuni;
mo’ na sciolla si vidia,
mo’ na trempa e nu valluni:
era l’aria propriu chiara
cumu siettu de quadara.
14.Ma sbagliarono la strada, e cadevano spesso
inciampando; ora si vedeva un burrone, ora
una rupe e un vallone: l’aria era chiara proprio come un fondo di caldaia.
15. Ni sentiu nu pisu a l’arma
tannu ’a luna virginella,
quannu viddi chilla parma
de Signura cussì bella
intra ’a zanca ’mmulicata,
senza mai trovari strata.
15.Sentì un peso al cuore allora la luna verginella, quando vide quella palma di signora
così bella avvolta nel fango, senza mai trovare
strada.
12. 1-4 O figlioli … vozza!: altro momento che appartiene allo stile della narrazione orale, in cui il poeta interrompe
il racconto prendendo contatto con il suo pubblico di giovani ascoltatori, con lo scopo di trasmettere loro il proprio
giudizio e indurli alla riflessione. L’invettiva del poeta acquista i toni della maledizione dei poveri contro l’eterna avidità
dei ricchi; così anche il rifiuto dell’ospitalità prende nel poemetto una carica populistica; ’ncaforchiari: la voce, particolarmente espressiva, è un denominale di caforchia, ‘tana, buca’.
13. 3 Jamuninni fora: per il significato che è stato dato alla locuzione si rinvia a G. Rohlfs, Nuovo dizionario dialettale
della Calabria, s. v. fore; 4 statti citu: in Ms, P 1 e P2 statti arditu ‘sii ardito’; 5 muccaturu: fazzoletto con cui le donne del
popolo si coprivano il capo; la voce risale al catalano mocador (vd. G.L. Beccaria, Spagnolo e Spagnoli in Italia. Riflessi
ispanici sulla lingua italiana del Cinque e del Seicento, Torino, Giappichelli editore, 1985, pag. 5, n. 15; ma vd. anche
Rohlfs, s. v., che per mocador presuppone un lat. * m u c c a t o r i u s da m u c c u s ‘moccio’).
14. 1 spattarunu: come antonimo di ’mpattari, variante dialettale dell’italiano ‘impattare’, che vale per ‘pareggiare nel
gioco delle carte’, spattari ha il significato suo proprio di ‘non far patta nel gioco’; 4 trempa: var. fonetica del prelatino
*timpa, ‘voragine, precipizio’; 5-6 era … quadara: similitudine costruita con la tecnica dell’inversione di tipo antifrastico: il fondo della caldaia, si sa, è annerito dal fuoco e dal fumo.
15. 3. parma: attributo di donna bella che appartiene al linguaggio della poesia lirica di tradizione orale; 5 ’mmulicata:
per G. Rohlfs, Nuovo dizionario dialettale della Calabria, cit., (s. v. mbolicare, -ri) il verbo ’mmulicari / ’mbulicari deriva
da i n v o l v e r e attraverso * i n v o l i c a r e per * i n v o l v i c a r e .
167
Q
uaderni
16. E cacciannu ’a capu fora
de na nuvi, chi lu vientu
fici a piezzi, la ristora,
cielu e terra fu n’argientu;
l’alluciu tutta la via
e li dissi: Avi Maria.
16. E cacciando il capo fuori da una nuvola, che
il vento fece a pezzi, la ristora, cielo e terra
s’inargentarono; le illuminò tutta la strada e
le disse: Ave Maria!
17. Pe lu cielu a milli a milli
a na botta s’appicciaru,
s’allumarunu li stilli,
cumu torci de n’ataru;
e si n’acu ti cadia,
tu l’ajjavi ’n mienzu â via.
17.Per il cielo a mille a mille si accesero di colpo, si illuminarono le stelle come torce di un
altare; e se ti fosse caduto un ago, l’avresti ritrovato in mezzo alla via.
18. C’era là, ma a lu stramanu,
fatta ’e crita e de jinostra
na casella de gualanu,
ch’ a lu lustru s’addimostra:
spuntillarunu lu vetti
e la porta s’apiretti.
18. C’era là, ma fuori mano, una casetta di bifolco, che si vede apparire alla luce: spuntellarono il palo e la porta si aprì.
19. San Giuseppi, c’ha lu mantu,
si lu sgancia ’n fretta ’n fretta,
ci lu spànnidi a nu cantu,
’a Madonna si ci assetta;
e li scuoccula vicinu
d’ugne juri nu vurbinu.
19. San Giuseppe, che ha il mantello, se lo sgancia in fretta in fretta, glielo stende in un angolo, la Madonna vi si siede; e le sboccia vicino
un’aiuola d’ogni fiore.
20. Supra ’u cori na manuzza
si tenia, pecchì era stanca;
appoggiava la capuzza
chianu chianu supra ’a manca;
pua, stenniennu li jinuocchi,
quieti quieti chiusi l’uocchi.
20.Sul cuore si teneva una manina, perché era
stanca; appoggiava lievemente la testolina
sulla sinistra; poi stendendo le ginocchia,
chiuse gli occhi chetamente.
17. 3 s’allumarunu: noto prestito dialettale dal francese allumer.
18. 3 na casella: casipola costruita con pietre legate con creta unita a paglia; il tetto era fatto di ginestra coperta con
terra; gualanu: termine molto diffuso nei dialetti meridionali, passato anche nell’italiano regionale, indica in genere il
giovane addetto a vari servizi nei campi e soprattutto alla cura degli animali (per lo più è il guardiano dei buoi); la voce
è fatta derivare dal prov. galan ‘giovane inserviente’, ma per le varie ipotesi avanzate dai linguisti sul suo etimo si rinvia
a F. Sabatini, L’italiano merid. “gualano”, in «Lingua nostra», a. XXV, fasc. 2 1964, pp. 43-48.
20. 1-4 Supra ’u … manca: la grazia dell’immagine contenuta nei versi rinvia a quella espressa dall’arte dei presepi meridionali nella raffigurazione della Vergine.
168
antropologia e storia
/ 2 – comicità e politica
21. Era aperta, e nu granatu
â vuccuzza assumigliava,
ordurusu escia lu jatu,
chi lu munnu arricriava;
cu lu corpu illa dormia,
ma cu l’arma ’n cielu jia.
21. Era aperta, e a una mela granata assomigliava la boccuccia; il fiato usciva profumato, che
ricreava il mondo; con il corpo Ella dormiva,
ma con l’anima andava in cielo.
22. Cu la menti Illa si sonna
d’arrivari ’n Paravisu;
senti diri: «È la Madonna!
Chi sbrannuri c’ha allu visu!»
Santi ed Angiuli li pari
ca s’ ’a vuòlunu ’mpesari.
22. Con la mente Ella sogna di arrivare in paradiso; sente dire: «È la Madonna! Che splendore
ha sul viso!» Le pare che santi e angeli la vogliono sollevare.
23. E la portanu vicinu
d’ ’u Signuri; e lu Signuri
si scippava da lu sinu
propriu ’u figliu, e cud amuri
ci ’u dunau cumu nu milu,
e li dissi: «Tienitilu!»
23. E la portano vicino al Signore; e il Signore si
strappò dal proprio seno il Figlio, e con amore glielo donò come una mela, e le disse: «Tienilo!».
24. Ma tramenti chi si sonna,
pe lu prieju e pe lu trillu,
si risbiglia la Madonna
e si guarda, e lu milillu
va trovannu, chi l’ è statu
intra suonnu rigalatu.
24.Ma mentre sta sognando, per la gioia e l’allegrezza, si risveglia la Madonna e si guarda
intorno, e va cercando la piccola mela che le è
stata regalata nel sogno.
25. Eccutì ca biellu biellu
’ncavarcatu supra ’a gamma
si trovau lu Bomminiellu,
chi schiamava: «Mamma! Mamma!»
Viata Illa, affurtunata!
Intra suonnu era figliata;
25.Ecco qui che bello bello, a cavalcioni di una
gamba, si trovò il Bambinello, che gridava:
«Mamma! Mamma!». Beata Lei, fortunata!,
aveva partorito nel sonno;
26. ca cumu esci na preghiera
de la vucca de li Santi,
cussì ’u figliu esciutu l’era
senza dogli, a chillu ’stanti,
cumu orduri ’e rosi e midi
esci, ed èsciari ’un si vidi.
26.perché, come una preghiera esce dalla bocca dei Santi, così il figlio le era uscito senza
doglie in quell’istante, come spira profumo di
rose e di miele, e spirare non si vede.
22. 5-6 li pari … ’mpesari: l’immagine si avvicina a quella dei fedeli che sollevano sulle spalle la statua della Madonna
durante le processioni; ’mpesari vale infatti per ‘addossarsi un peso sulle spalle’.
169
Q
uaderni
27. Illa ’u guarda, e ’nginocchiuni
tutt’avanti li cadia;
l’adurau; pua na canzuni,
chi d’ ’u cori li venia,
pe lu fari addurmentari
’ngignau subitu a cantari.
27. Ello lo guarda, e gli cade davanti ginocchioni;
l’adorò, poi per farlo addormentare incominciò subito a cantare una canzone che le veniva
dal cuore.
II
1. Duormi, bellizza mia, duormi e riposa;
chiudi ’a vuccuzza, chi pari na rosa;
duormi scuitatu, ca ti guardu iu,
zuccaru miu.
II
1. Dormi, bellezza mia, dormi e riposa; chiudi
la boccuccia, che pare una rosa; dormi tranquillo, che ti guardo io, zucchero mio.
2. Duormi e chiudi l’occhiuzzu tunnu tunnu,
ca quannu duormi tu, dormi lu munnu,
ca lu munnu è de tia lu serbituri,
Tu sì ’u signuri.
2. Dormi e chiudi l’occhietto tondo tondo; perché quando dormi tu, dorme il mondo; perché il mondo è il tuo servitore, Tu sei il Signore.
3. Dormi lu mari e dormi la timpesta,
dormi lu vientu e dormi la furesta,
e puru intra lu ’nfiernu lu dannatu
sta riposatu.
3. Dorme il mare e dorme la tempesta, dorme il
vento e dorme la foresta, e pure nell’inferno
sta riposato il dannato.
4. Ti tiegnu ’n brazza e sienti na paura,
ca Tu sì Diu, ed iu sugnu criatura;
e mi sguilla a lu sinu, e vò ’nfassatu
Chi m’ha criatu.
4. Ti tengo in braccio e sento una paura, perché
Tu sei Dio e io sono creatura, e mi grida al
seno, e vuole essere fasciato chi mi ha creato.
5. Occhiuzzi scippa-cori, jativinni!
’Un mi guardati, ca fazzu li pinni.
Na vuci ’nterna, chi la sientu iu sula,
mi dici: «Vula!»
5. Occhietti strappa-cuori, andatevene! Non mi
guardate, ché metto le ali. Una voce interna,
che la sento io sola, mi dice: «Vola!».
27. 3 na canzoni: ovvero una ninna nanna, che le donne del popolo cantavano sulla culla dei loro bambini.
II 1. 1-4 Duormi … miu: questa prima strofa saffica è contenuta integralmente in un canto sacro fanciullesco, di tipo
monostrofico, raccolto a Vibo Valentia da Raffaele Lombardi Satriani: «Dormi, bejizza mia, dormi e riposa, / Chiudi
’ssa vucca chi pari ’na rosa, / Dormi squetatu, cà ti guardu io, / Ti tegnu n brazza, zuccaro mio. / E tegnu e sentu ’na
paura, / Cà tu sì Dio ed eu su’ criatura» (R. Lombardi Satriani, Canti popolari calabresi, Napoli, De Simone, 1933, vol.
III, p. 48, n. 2878); si vedano ancora questi altri versi riportati da L. Accattatis, Vocabolario del dialetto calabrese (casalino-apriglianese), Castrovillari, 1897, s. v. ninna: «Duormi, giojuzza mia, duormi ch’ ed ura».
3. 1-2 Dormi … furesta: si vedano ancora questi altri versi di una ninna nanna popolare: «Riposa l’acqua e riposa lu
vientu, / riposa, campaniellu mia d’argientu; / riposa l’acqua e riposa lu mari, / ripuosu la Madonna ti vò dari» (G.
Abbruzzo, Duormi, bellezza mia…in «Quaderni silani», a. IV, n. 10, 1986).
4. 1-2 Ti tiegnu … creatura: vd. sopra, II 1-4; 3 sguilla: propr. sguillare è ‘squillare’, per estensione ‘gridare’; ma vd. anche
in V. Padula, Vocabolario calabro, cit., c. 299, sguillu, ‘grido’.
5. 2-4 ’un mi … Vula!: allusione al rapimento mistico che la dolcezza dello sguardo divino può provocare nella Madre di Cristo.
170
antropologia e storia
/ 2 – comicità e politica
6. ’A ninna ’e ss’uocchi tua m’ardi e m’abbaglia;
tutta l’anima mia trema e si squaglia:
canta cumu ’u cardillu, e asciri fori
mi vò lu cori.
6. La pupilla di questi occhi tuoi mi arde e mi
abbaglia; tutta l’anima mia trema e si scioglie:
canta il mio cuore come il cardellino e vuole
uscire fuori.
7. Ti viju dintra l’uocchi n’autru munnu,
ci viju n’autru Paravisu ’n funnu:
sientu na cosa, chi mi fa moriri,
né si pò diri.
7. Ti vedo negli occhi un altro mondo, ci vedo
un altro paradiso in fondo: sento una cosa
che mi fa morire, né si può dire.
8. Chiudili, biellu, pe pietà, e riposa;
chiudi ’a vuccuzza, chi pari na rosa:
duormi scuitatu, ca ti guardu iu,
zuccaru miu.
8. Chiudili, bello, per pietà, e riposa; chiudi la
boccuccia, che pare una rosa: dormi tranquillo, che ti guardo io, zucchero mio.
9. ’U suonnu è jutu a cògliari jurilli,
pe fari na curuna a ssi capilli,
e ssa vuccuzza ’e milu cannameli
t’unta cu meli.
9. Il sonno è andato a raccogliere fiorellini, per
fare una corona a questi capelli, e questa boccuccia di miele cannamele ti unge con il miele.
10. Cu n’acu ’n manu è jutu supra â luna
a cùsari li stilli ad una ad una;
pua ti li mindi ’n canna pe jannacca,
e ci l’attacca.
10.Con un ago in mano è andato sulla luna a
cucire le stelle a una a una; poi te le mette al
collo per collana, e ve le attacca.
11. Chi siti mo venuti a fari ’lluocu,
Angiuli ’e Diu, cu chilli scilli ’e fuocu?
Mi voliti arrobbari ’u figliu miu,
Angiuli ’e Diu?
11. Che siete ora venuti a fare qui, Angeli di Dio,
con quelle ali di fuoco? Mi volete rubare il figlio mio, Angeli di Dio?
8. 1 Chiudili … riposa: cfr. L. Accattatis, Vocabolario del dialetto calabrese (casalino apriglianese), cit., s. v. ninna, «Chiudi ss’occhiuzzi tua, chi sunu bielli, / Funtane chi cci vivenu li santi»; 3-4 chiudi … miu: si tratta di una ripetizione di versi
tipica della tecnica di composizione della poesia folklorica (vd. anche sopra, II 1. 2-4).
9. 1-2 ’U suonnu … capilli: altre varianti di questo distico si possono riscontrare nella tradizione delle ninne nanne
calabresi: «Lu suonnu è ghiutu a cogliri pruniddi; / Mo vene e ti nni porta ’na juntidda» (cfr. N. Leonardis, Canti di
Rossano. Ninne-nanne, «La Calabria», a. VIII, n. 11, 1895, p. 88); «Lu suonnu, biellu miu, è jutu a jurilli / E ppi l’amuri
tua ndi cozi milli; / Lu suonnu, biellu miu, è jutu a violi, / E ppi l’amuri tua ndi cozi novi» (cfr. R. Lombardi Satriani,
Canti popolari calabresi, cit., vol. III, p. 120, n. 2337); 3 milu cannamèli: varietà pregiata di mela; cannamèli dal lat.
c a n n a m e l l i s , ‘canna del miele’, ‘zucchero di canna’.
10. 2 a cùsari … ad una: verso coniato su un motivo presente in un’ottava popolare registrata dal Padula nel «Bruzio»,
utilizzato anche in un frammento del poemetto lasciato incompiuto, Sigismina (I, 11. 1-2): «Tesi da terra al cielo un
laccio d’oro / per piglirvi le stelle ad una ad una» (cfr. V. Padula, Poesie inedite, a cura di A. Piromalli, D. Scafoglio,
Napoli, Guida, 1974, p. 36).
11. 1-2 Chi siti … fuoco?: il presentimento della morte del Figlio, che fa avvertire alla Madre come minaccia la stessa
venuta degli Angeli, con le loro ali di fuoco, accanto al motivo dell’esultanza della Madonna per la nascita del Bambino
costituisce l’altro asse lungo cui si svolge questa ninna nanna paduliana.
171
Q
uaderni
12. Cantati, sì; ma ’n cielu ’un v’ ’u chiamati:
aduratilu, sì; ma ’un v’ ’u pigliati;
e tu, bellizza, ’un fujari cu loru,
si no, ni muoru.
12.Cantate, sì, ma non ve lo chiamate in cielo:
adoratelo, sì, ma non ve lo prendete; e, Tu,
bellezza, non scappare con loro, se no ne
muoio.
13. Statti, trisoru miu, cu mamma tua;
mo chi ti tiegnu, nenti vuogliu cchiùa;
cu Tia vuogliu lu munnu caminari
sempri, e cantari,
13.Stai, tesoro mio, con mamma tua; ora che ti
ho, nulla voglio più; con te voglio camminare
sempre per il mondo, e cantare,
14. e diri a tutti: «Chissu è Figliu miu;
’a mamma è povarella, ’u figliu è Diu:
d’ ’u cielu m’ è schioppatu ssu Bomminu
dintra lu sinu».
14. e dire a tutti: «Questo è il Figlio mio; la mamma è poverella, il figlio è Dio: dal Cielo mi è
caduto in seno questo Bambino».
15. Ma ch’haju dittu? E nun sacciu iu lu riestu?
T’ammucciu ’n piettu, o Figliu mia, cchiù priestu:
’u munnu è malandrinu, e si t’appura,
o chi sbentura!
15. Ma che hai detto? E non conosco il resto? Ti
nascondo in seno, o Figlio mio, piuttosto: il
mondo è malandrino, e se ti scopre, oh che
sventura!
16. Pe ssi capillu tua criscinu spini,
e pe ’nchiovari ssi jidita fini
piensu c’ ’a forgia mo vatti, e nun sa
chillu chi fa.
16.Per questi tuoi capelli crescono spine, e per
inchiodare queste dita fine penso che ora batta la forgia e non sappia quello che fa.
17. ’A sienti dintra ’u vuoschiu Tu ssa vuci?
Nun è lu vientu no, chi si ci ’nfuci:
è la cerza chi grida: «’U lignu miu
cruci è de Diu!»
17.La senti Tu questa voce nel bosco? Non è il
vento no, che vi si caccia: è la quercia che grida: «Il mio legno sarà croce di Dio!».
18. Ah! nu’ chiangiari, no! Pecchì, o Bomminu,
mi triemi cumu na rinnina ’n sinu?
Pe mo duormi scuitatu: tannu pua
c’è mamma tua.
18. Ah! Non piangere, no! Perché, o Bambino, mi
tremi in seno come una rondine? Per ora dormi tranquillo: allora poi ci sarà mamma tua.
15. 2 t’ammucciu: nel commentare la voce ammucciare, registrata dal Padula nel suo Vocabolario calabro, confrontandosi con le ricerche già fatte sul lemma, John B. Trumper dà come forma di partenza per questo verbo il «norm. mucher
(fr. mod. se musser), da un [gallolatino] *muciare ‘nascondere’ di origine celtica» (V. Padula, Vocabolario calabro. Laboratorio del Dizionario Etimologico Calabrese, a cura di J. B. Trumper, Roma-Bari, Laterza, 2001, s. v.).
16. 3 forgia: apparecchio usato dal fabbro (cal. forgiaru) per lavorare il metallo; la voce è comune all’italiano, deriva dal
francese forge (lat. f a b r i c a).
172
antropologia e storia
/ 2 – comicità e politica
19. Supra li vrazza mia, supra ’i jinocchia
zumpa, aza ’a capu, ed apirelli l’uocchi.
Quantu sì bielli! Chi jurilli spasu!
Dami nu vasu.
19. Sulle mie braccia, sulle ginocchia salta, alza il
capo ed aprili gli occhi. Quanto sei bello! Che
fiorellino sbocciato! Dammi un bacio.
III
1. Cussì cantava ’a Vergini Maria,
e nazzicava chillu quatrariellu.
’U cielu vasciu vasciu si facia
nasuliannu a chillu cantu biellu:
abballava la terra, e si movia
mustrannu tuttu virdi lu mantiellu,
e lu vientu si stava accappottatu
gridannu dintr’ ’u vuoschiu: «È natu! È natu!»
III
1. Così cantava la Vergine Maria e cullava quel
bambinello. Il cielo si abbassava porgendo
l’orecchio a quel canto così bello: la terra ballava e si muoveva mostrando tutto verde il
mantello, e il vento se ne stava incappottato
gridando nel bosco: «È nato! È nato!».
2. Ugne jumi portava na chinera,
chi d’uogliu, chi de latti e chi de vinu.
Meli e farina escia d’ ’i cerzi, ed era
carricu ’e juri ’n sinca a diri ’u spinu;
e tornata paria la primavera
scotuliannu tuttu ’u vantisinu;
’a viti fici l’uva, ’u ranu ’i spichi,
e li schiattilli si facieru fichi.
2. Ogni fiume portava una piena, chi di olio, chi
di latte e chi di vino. Miele e farina uscivano
dalle querce, e perfino il rovo era carico di
fiori; e sembrava ritornata la primavera scuotendo tutto il grembiule; la vite fece l’uva, il
grano le spighe, e i fichi appena spuntati divennero maturi.
3. ’U portuni d’ ’u cielu spalancaru
e cu nu strusciu forti e cu nu vientu
quattru truoppi d’Arcangiuli calare
’e na bellizza, ch’era nu spavientu:
a leghe a leghe supra lu pagliaru
teniennusi pe manu a cientu a cientu
3. Spalancarono le porte del cielo e scesero con
un frullio forte d’ali, e con un vento, quattro
stuoli d’Arcangeli di una tale bellezza ch’era
una cosa straordinaria: a schiere a schiere sopra il pagliaio, tenendosi per mano a cento a
19. 2 aza: la forma verbale azare mostra la caduta della - l – dinanzi a consonante; nella stessa posizione, sempre in area
calabrese, si può avere la velarizzazione della - l – (auzare).
III 1. 2 quatrariellu: dimin. di quatraru, voce dall’origine variamente discussa: per G. Rohlfs (Nuovo dizionario dialettale
della Calabria, cit., s. v.) l’etimologia è «* q u a d r a r i u s ‘ragazzo quadrato, cioè robusto’»; per Antonino Pagliaro,
l’origine del nome quatraru è qu i nqu at r ar ius, qualifica, per il linguista, data a Roma al ragazzo al di sotto dei diciotto
anni, che partecipava alle gare (lusus Troi a e) della festa delle Q u i nqu at r us, solennità dedicata alla consacrazione
delle armi (A. Pagliaro, Cal. quatraru, in «Ricerche linguistiche», a. I, 1950, fasc. 2, pp. 264-268); 3 ’U cielu … si facia: è il
motivo del cielo che si abbassa per partecipare all’eccezionalità di un evento; 4 nasuliannu: propr. ‘origliando’; nasuliari
è variante di ausiliari, e di osolare ed usolare, tutte forme registrate da Padula nel Vocabolario Calabro (ms., cc. 11, 207).
La più comune è, però, asuliari, supposta dal latino volgare * a u s u l a r e, a sua volta dall’osco *a u s i s, corrispondente
del lat. a u r i s ‘orecchia’ (vd. V. Padula, Vocabolario Calabro. Laboratorio del Dizionario Etimologico Calabrese, cit., s.
v.); verso quest’ultima forma, come si è già detto, si sono orientati i vari editori del poemetto paduliano, a cominciare
da Antonio Julia.
2. 8 schiattilli: frutti ancora immaturi del fico.
173
Q
uaderni
si misiru a cantari cu lu suonu:
«Sia grolia ad Illu, e paci all’omu buonu!»
cento cominciarono a cantare con la musica:
«Sia gloria a Lui, e pace all’uomo buono!».
4. A chillu forti gridu, a lu sbrannuri,
chi l’Angiuli spannianu a lu paisi,
subitu si scitarunu ’i pasturi,
’i massari, ’i curatili, ’i furisi.
Vidunu li campagni no’ cchiù scuri,
supra li munti vidunu ’i lucisi;
sientu sonari suli ’i ceramelle
e ballari muntuni e pecurelle.
4. A quella forte voce, allo splendore che gli Angeli spandevano sul paese, subito si svegliarono i pastori, i massari, i capi dei mandriani,
i pecorai. Non vedono più le campagne nel
buio, sui monti vedono i fuochi; sentono suonare soltanto le ciaramelle e ballare montoni
e pecorelle.
5. E ognunu si restava ’ncitrulatu
e cu la manu l’uocchi si spracchiava:
ma n’Angiulu passannu dissi: «È natu,
è natu chillu Diu, chi s’aspettava».
Allura chi vidisti? ’Mpaparatu
ognunu pe la via s’azzummulava.
Chi canta e balla, e chi senza pensieru
facia cu la sampugna: Leru! Leru!
5. E ognuno restava incantato e con la mano si
stropicciava gli occhi: ma un Angelo passando disse: «È nato, è nato quel Dio che si aspettava». Allora che vedesti? Confuso ognuno si
accalcava per la strada. Chi canta e balla, e chi
spensierato faceva con la zampogna: Leru!
Leru!
6. Chi porta na sciungata, o na fiscella,
chi nu rinusu e chini nu capriettu:
scammisata fujia la furisella
cu quattru cucchia d’ova dintr’ ’u piettu;
e appriessu li curria la figlicella,
chi ’n culinuda si jettau d’ ’u liettu:
pe l’allegrizza li schioppa lu chiantu,
e porta nu galluzzu ’e primu cantu.
6. Chi porta una giuncata o una fiscella, chi una
caciotta e chi un capretto: scamiciata correva
la pastorella con quattro paia d’uova in petto; e dietro correva la figlioletta, che si gettò
nuda dal letto: per la gioia scoppia a piangere,
e porta un galletto di primo canto.
4. 3-4 ’i pasturi … ’i furisi: rappresentazione della gerarchia relativa alla società pastorale tradizionale calabrese che,
secondo quanto riferisce lo stesso Padula nel «Bruzio» (a. I, [n.13 luglio], 1864), era così strutturata e denominata:
«Diciamo massaru il mandriano, curàtulu il cascinaio, furisi i pastori e capufurisi il vergaro». Il curatolo era colui che
attendeva alla preparazione dei formaggi e di altri prodotti del latte; 4 ’i lucisi: i fuochi, che si accendono sui monti
e illuminano la campagna, costituiscono un antichissimo simbolo di purificazione; il fuoco esprime appieno il senso
originario di festa di rinnovamento, di inizio di un nuovo ciclo annuale. Qui Padula lo riproduce come motivo del
presepe meridionale; ma si ispira anche alle antiche costumanze delle “focare”, i grandi falò delle giornate natalizie.
5. 1 E ognunu … ’ncitrulatu: l’immagine richiama la figura dell’ “incantato” del presepe, che stupito e attonito assiste
all’evento prodigioso; 2 si spracchiava: lett. ‘si staccava’, ovvero ‘si stropicciava gli occhi per la meraviglia’; 5 ’mpaparatu:
si dice di chi, stordito all’annuncio di un fatto, alla vista di una cosa, ecc., non riesce a camminare speditamente; 8 facia
…leru!: esempio efficace ancora una volta di ristrutturazione di un verso popolare: «culla sampogna lleru lleru a fari»,
con il verbo coniugato all’imperfetto, che apre la struttura del verso, e l’onomatopea sistemata alla fine
6. 1 sciungata: prodotto ottenuto con latte ovino o caprino rappreso, non salato; fiscella: metonimia; la fiscella è propr.
una cestella fatta di giunchi in cui i pastori mettevano il cacio fresco o la ricotta; 2 rinusu: forma ridotta di arinusu,
nome di un piccolo cacio ottenuto con i residui della pasta; chini: forma con epitesi di –ni.
174
antropologia e storia
7. Ed iu, belli quatrari, iu puru tannu
’nfrattari mi volia cu l’autra genti:
ma chilla jia ’ncollata, ed iu, malannu!
Iu sulu nun avia li cumprimienti.
Mi jivi ’a mariola scalïannu,
ma avia voglia ’e merari! ’un c’era nenti.
Chi fici poca? Fici sta canzuna,
e Jesullu mi dezi na curuna.
/ 2 – comicità e politica
7. Ed io, cari ragazzi, io pure allora volevo unirmi alla gente, ma quella andava carica, ed io,
mannaggia!, io solo non avevo doni. Andavo rovistando nella tasca, ma avevo voglia di
guardare! Non c’era niente. Che feci allora?
Feci questa canzone e Gesù Bambino mi diede una corona.
7. 1-8 Ed iu … curuna: l’ultima strofa contiene il motivo dell’excusatio, ripreso dai canti popolari natalizi, che consente
all’autore di intervenire direttamente nella narrazione, personalizzando il proprio canto. Anche nella Pastorale di Alfonso de’ Liguori c’è l’intervento dell’autore, ma è risolto in chiave di edificazione religiosa e morale: «Io puro songo
niro peccatore, / ma no’ ammoglio esse’ cuoccio e ostinato. / Io no’ ammoglio cchiù peccare, / voglio amare – voglio
sta’ / co Ninno bello / comme nce sta lo voje e l’aseniello»; ’nfrattari mi volia: lett. ‘volevo nascondermi, imboscarmi’;
’ncollata: participio pass. di ’ncollare, ‘portare sul collo, ovvero addosso un carico’; mariola: ‘tasca interna della giacca,
ladra’; scaliannu: per il verbo scaliare, con il significato di ‘frugare’ e ‘razzolare’, G. Rohlfs, Nuovo dizionario dialettale
della Calabria (s. v.), indica l’etimo greco σχαίλζω; curuna: scherzosa allusione alla corona dei poeti e probabilmente
anche a quella dei santi.
175
Pulcinella come trickster
Domenico Scafoglio
Scritto nel 1997. Pubblicato la prima volta in
“Annali d’italianistica, Anthropology & Literature”,V, 1997; poi selzionato autonomamente per The
Free Dictionary by Farlex e per High Beam Research.
Una storia locale che è anche universale La storia di Pulcinella Cetrulo, la maschera più importante del teatro popolare e
semipopolare napoletano, d’ arte e di strada, una delle più rilevanti della commedia
dell’Arte, della “ridicolosa” romana, dell’opera buffa, degli intermezzi comici, dei Carnevali italiani, è stata tradizionalmente letta
come una storia locale, quasi unicamente
napoletana, e solo negli ultimi lustri si è
guardato oltre i confini regionali, prestando qualche attenzione alla vita e alla scena
della maschera fuori dell’area campana, dal
momento che la cifra critica dominante era
rimasta da sempre quella del “tipo del napoletano in commedia” nella tradizione romana e veneziana (mentre altre tradizioni sono
rimaste per altro poco conosciute). Tuttavia,
l’avere allargato lo sguardo oltre i confini nazionali alla ricerca dei “cugini” di Pulcinella
1
in Francia, Inghilterra, Germania, Olanda,
Spagna, Russia e cosi via non ha comportato
grandi novità, giacché tutto l’impegno conoscitivo si è risolto nella ricerca dei prestiti
e delle specificità locali, oppure, al più, nella
vaga nozione del carattere “europeo” della
maschera. Dal versante della ricerca etnografica e
della storia delle religioni sono venuti invece negli ultimi decenni importanti contributi teorici attraverso studi accurati sui
trickster delle popolazioni etnologiche, i
buffoni sacri degli stessi amerindi, i “pazzi
sacri” dell’Islam, le buffonerie sacre cristiano-medioevali1. Quegli studi ripropongono
in un’ottica prevalentemente antropologica
(e molto spesso utilizzando cifre psicanalitiche) il problema della natura e della funzione del comico, all’interno di una teoria
generale della cultura e della società. La
comparazione interculturale e la tendenza
alla generalizzazione li rendono particolarmente utili ai fini del superamento dell’angusto localismo, e insegnano che, se per un
verso ogni storia è una storia locale, per un
altro ogni storia non si può comprendere se
non alla luce di un’altra storia. In quest’ot-
Nell’impossibilità di richiamare questa ormai vastissima letteratura, mi limito a ricordare quella più importante,
sopra ricordata, per i suggerimenti, impliciti o espliciti, che può dare sotto il profilo teorico: M. Augè; A. Bausani;
N. R. Crumrine; E. E. Evans Pritchard; J. Heers; C. Levi-Strauss; L. Makarius; G. Mazzoleni; P. Radin, C. G. Jung,
K. Kerenyi. 177
Q
uaderni
tica – che è quella dentro la quale ci siamo
mossi – lo studio della maschera del Pulcinella napoletano può fornire elementi importanti per l’elaborazione di una teoria del
comico dal punto di vista antropologico. Figura dell’identità In quanto incarnazione storicamente determinata di un archetipo universale,
Pulcinella Cetrulo è, inequivocabilmente,
Napoli, sia nel senso che attraverso la sua
maschera i napoletani nell’arco di oltre tre
secoli – dai primi anni del Seicento fino alla
fine dell’Ottocento e, residualmente, fino ai
nostri giorni – hanno elaborato la più completa immagine di se stessi, sia nel senso che,
storicamente, la maschera è stata assunta dal
resto dell’Italia e dall’Europa per conoscere
e rappresentare i tratti socio-antropologici
di Napoli. E, qualunque fosse il valore di
queste rappresentazioni e auto-rappresentazioni, è innegabile che esse poggiassero in
qualche modo su un fondamento reale, dal
momento che in Pulcinella si individuano
immediatamente alcuni tratti fondamentali
della cultura napoletana: il barocco popolaresco associato al patetismo e alla sua controparte ironica, la parodia e lo sberleffo; la
carnalità ossessiva e un po’ ambigua; la familiarità col mistero e col sacro; lo logorrea
astratta e il suo becero controcanto, il doppio senso scatologico e osceno; la gestualità
vivace e pittografica; la fascinazione del nuovo e del diverso, governata dalla parodia; il
2
3
178
rapporto d’ intimità col potere, diviso tra il
rispetto e la protesta, la sottomissione e la
rivolta. La rappresentatività di figure come
Pulcinella – cioè, sostanzialmente, degli eroi
comici, dei buffoni rituali, dei “buffi” teatrali, dei “bricconi” (tricksters) universalmente
presenti nelle mitologie primitive – è più
ampia di quella delle figure positive e degli
eroi “seri”, perché questi ultimi incarnano le
aspirazioni ideali dei popoli, mentre gli eroi
comici rappresentano anche la dimensione
quotidiana e il loro lato oscuro, gli impulsi
trasgressivi e le tentazioni dell’illecito. In quanto mito d’identificazione collettiva e simbolo dell’identità individuale2,
Pulcinella è il guardiano della casa e della
bottega3: capita frequentemente di ritrovarlo ancora oggi nelle dimore popolari di
Napoli (ma anche, sia pure con minore frequenza, in quelle della borghesia), statuina
di gobbo portafortuna, con in mano – chiari
simboli scaramantici – la scopa o il corno o
il ferro di cavallo, e spesso in atto di “fare le
corna” con l’altra mano. Sul finire dell’Ottocento fu addirittura notato sul terrazzo di
una villa un bellicoso Pulcinella tra due batterie di cannoni. Statue del Cetrulo, spesso
di dimensioni naturali, si possono ancora
oggi vedere nelle botteghe degli antiquari
napoletani, per lo più collocate sull’uscio, e
costituiscono i soli oggetti “non in vendita”;
un tempo, però, era facile trovarle anche in
altri tipi di negozi. Ma Pulcinella, in quanto
figura dell’identità, è anche il difensore della
comunità: veniva collocato, non a caso, in
cima ai campanili, simboli per eccellenza
Per queste categorie ved. anche lo studio di M. Augè sul “piccolo dio” africano, Legba, che ricorda molto da vicino
Pulcinella (Il corpo del feticcio). Alla presenza di Pulcinella nel folklore napoletano è dedicata una nostra specifica indagine,Tradizioni regionali-popolari (in D. Scafoglio e L. Lombardi Satriani 271-34). antropologia e storia
dell’identità cittadina e della protezione della città dalle minacce esterne. L’uso odierno
di utilizzare l’immagine del Cetrulo come
elemento di richiamo e garanzia di napoletanità, specie per certificare la pizza napoletana doc, ha importanti e più significativi
precedenti nella tradizione, dal momento
che per secoli i tavernieri, ad esempio, hanno usato Pulcinella come insegna, e lo stesso
facevano i mellonari, che lo mostravano in
atto di uscire da un melone spaccato. Ma Pulcinella è, al tempo stesso, il guardiano e il messaggero della casa e della città,
tramite prezioso dell’interno con l’esterno e
simbolo dello scambio culturale: egli è, per
eccellenza, il messo, che media l’interazione verbale e sociale in un’infinità di ruoli:
latore di notizie, “referendario” più o meno
sciocco o astuto, servizievole servo, ruffiano,
losco mandatario, guida e battistrada, prologo teatrale, banditore di strada, portatore
di verità e di chiacchiere facete: come tale,
egli è raffigurato nell’Ottocento con le ali
mitiche del messaggero e in atto di suonare il corno; anche sotto questo aspetto egli
è identificato, come vedremo, col gallo, il
biblico messaggero. E in veste di mediatore
(tra il soprannaturale e il naturale) compare
come pastore nel presepe napoletano, spesso sistemato, in formato piccolissimo, tra i
trastulli che si offrivano a Gesù, e perfino
nelle chiese, in veste di portacandele; ma al
tempo stesso egli media il rapporto cogli inferi, in veste di diavolo o associato ai diavoli
come suoi aiutanti magici, collaboratori, antagonisti. Non a caso Pulcinella è (venditore
4
5
6
/ 2 – comicità e politica
ambulante, comico itinerante, predicatore,
capopolo, imbonitore, ecc.) il re della piazza,
lo spazio deputato all’incontro con l’esterno, dove il nuovo e l’estraneo sono soggetti
alla censura o all’approvazione collettiva,
prima di essere incorporati nella vita delle
case senza residuo di angoscia. Buffone nazionale, Pulcinella fu visto, non a caso, fino
a tutto l’Ottocento come “ligio fino alla superstizione alle consuetudini del suo paese
nativo, amante de’ suoi, dileggiatore di ogni
uso straniero”4; allo stesso modo in cui i buffoni sacri di quasi tutte le culture difendono
la comunità dalle minacce degli estranei e
dai pericoli che vengono dalle innovazioni
dall’esterno5, Pulcinella si fa selvaggio idolatra, quacquero, ebreo, turco, zingaro, e
attraverso le sue metamorfosi parodiche la
cultura locale si confrontava con le diversità
culturali che da sempre avevano esaltato, nel
segno della curiosità e della paura, l’immaginario collettivo, prendeva coscienza dei
propri limiti e rafforzava le sue certezze: non
si proponevano, le pulcinellate di Cerlone,
di “rappresentare i difetti di alcune nazioni
barbare e selvagge”?6 Ma in questo teatro
degli altrove più o meno immaginari, in cui
si compie questo incessante lavorio di riduzione dell’ignoto al noto, il confronto con la
diversità, in cui si riconosce la comune natura dell’uomo e la sua irriducibile alterità, si
estende anche alle realtà meno lontane e più
familiari: francesi, tedeschi, spagnoli sono
da sempre gli antagonisti per eccellenza di
Pulcinella, ed entrano nel suo teatro per essere studiati, compresi o derisi: è il teatro
C.T. Dalbono, Pulcinella e la maschera napoletana, in De Bourcard, Usi e costumi di Napoli e contorni, 528. Su questo aspetto si vedano le osservazioni di Mazzoleni (specialmente 76-77; 89-91) su una realtà etnografica
geograficamente lontana ma per molti versi straordinariamente affine. F. Cerlone, dedica premessa al vol. 7 delle Commedie. 179
Q
uaderni
dell’etnicità, in cui sotto le forme del comico
si articola il confronto etnico nel segno di
una tolleranza senza illusioni, consapevole
e guardinga. L’integrazione della differenza Pulcinella media dunque il rapporto con
la diversità culturale, e può farlo nella misura in cui è parte di essa. Ogni cultura notoriamente si fonda su un sistema di scelte,
il quale a sua volta comporta un complesso
di esclusioni: l’insieme dei contenuti esclusi
costituisce l’orizzonte oscuro che preme sui
confini della cultura, come minaccia e allettamento. Ma le culture hanno altresì inventato i meccanismi per allacciare un rapporto
ininterrotto con la diversità, attraverso l’invenzione di personaggi emblematici, deputati alla funzione di mediatori culturali, tra i
quali i personaggi comici occupano un posto
di rilievo: figure di confine, tra natura e cultura, disordine e ordine, illecito e lecito, esse
si fanno carico della volontà diffusa di un
allargamento dell’esperienza verso i territori interdetti; in esse si compie vicariamente
un abbassamento della soglia del controllo
ideologico; in esse si consuma, nel bene e nel
male, l’incontro con le realtà escluse, pagando esse stesse, col ridicolo e l’accanimento
persecutorio di cui sono fatte oggetto, il senso della vergogna che la trasgressione comporta.
Non a caso Pulcinella, maschera urbana per eccellenza, prodotto e specchio della
cultura metropolitana di Napoli, è fatto na-
7
180
scere, nei miti di fondazione, ad Acerra o,
in alcune tradizioni di minor peso, a Ponteselice (ma anche in luoghi meno vicini,
Giffoni e Benevento): la maschera dei napoletani si fa dunque venire da quella periferia da sempre immaginata come luogo di
demenza e sanità, di infezione e di portenti,
perché l’extraterritorialità consente alla cultura urbana di distanziare la parte di sé che
inquieta e disturba, entificandola in una diversità né troppo lontana né troppo vicina,
in modo che possa in essa negarsi e al tempo
stesso riconoscersi. Secondo un mito d’origine Pulcinella era un buffone contadino di
Acerra che una compagnia di attori cittadini, dopo aver variamente cercato di sopraffarlo nelle schermaglie comiche, integrò nel
gruppo, trasformandolo in una maschera
teatrale, e per secoli il pubblico ha visto i
segni di queste origini rustiche nella sua fisionomia (il volto caricato, il naso lungo, la
faccia annerita dal sole), nell’abbigliamento
(camicia e calzone a braca di tela bianca) e in
alcuni tratti caratteriali e comportamentali
(la ghiottoneria, la sensualità accentuata, la
maniera spropositata di parlare, la goffaggine associata all’arguzia e alla lepidezza).
L’acerranità ha conferito alla maschera
la natura di figura del confine ed è stata la
condizione della sua liberta; il configurarsi
insieme come familiare e estraneo, l’essere
collocato idealmente in una marginalità in
cui la citta trovava ancora la conferma della
sua identità ma anche l’inizio della diversità,
ha rappresentato per Pulcinella la radice di
ogni ambivalenza e il fondamento della sua
funzione di mediatore7. I miti d’origine della maschera di Pulcinella sono analizzati da D. Scafoglio, Mitologie, in D. Scafoglio-L. Lombardi
Satriani. antropologia e storia
Pulcinella dunque è il familiare e l’estraneo,
l’interno e l’esterno, e la dialettica tra questi
estremi si articola nelle forme del comico: se
Pulcinella è l’insieme dei contenuti che la cultura esclude dal proprio universo e identifica
con l’orizzonte che preme sui propri confini,
il riso, che costituisce l’essenza del teatro della
maschera, media questo rapporto con la diversità, ed è, al tempo stesso, riso d’accoglimento, che seconda l’assorbimento del diverso,
nelle forme compatibili col sistema culturale,
liberando dall’ansia e dall’angoscia, e riso di
esclusione, che consegue il medesimo effetto
liberatorio attraverso il dileggio del “residuo”
irriducibile. Per questo la maschera comica
presenta un doppio statuto, configurandosi al
tempo stesso come la diversità integrabile, e
perciò arricchente e gioiosa, e la diversità non
del tutto integrata, e perciò repellente e sinistra. Se come acerrano Pulcinella si colloca
al confine tra la citta e la campagna, la sua
condizione di servo, con la quale si è emblematicamente identificato in tutta la sua
storia teatrale8, conferma la sua natura di
figura liminale, tramite prezioso tra l’interno e l’esterno. La maschera napoletana conserva in vario modo le qualità amorali dello
schiavo della commedia antica, connesse
alla condizione di marginalità, comune ad
entrambi9. Meno esposto, grazie proprio alla
sua liminarità, ai rigori della norma sociale,
questa figura di servo è fatta oggetto di un
investimento simbolico, che la trasforma in
un doppio irriverente e ribelle della plebe, e,
al tempo stesso, in un doppio perverso del
padrone. Emblematico di questa situazione è il duplice travestitismo; quello del pa
8
9
/ 2 – comicità e politica
drone, che nelle feste carnevalesche e, non
infrequentemente, nelle stesse pulcinellate
teatrali vestiva i panni di Pulcinella, assumeva la sua figura deforme e oscena e imitava i
suoi eccessi sessuali e alimentari; e quello di
Pulcinella-servo, che in oltre tre secoli di teatro si è costantemente travestito da padrone,
fingendosi principe, mercante, conte, donna, accademico, avvocato, dottore, poeta,
cavaliere e cosi via. Il travestimento consente a Pulcinella di introdurre comportamenti
eccentrici dentro ruoli codificati, portando
lo scompiglio in un universo che si credeva
ordinato; quello che emerge non è tanto l’inadeguatezza del servo al ruolo del padrone
(da cui i teorici conformisti già a partire dal
secolo XVII vedevano scaturire l’essenza del
comico), quanto, più sottilmente, l’inadeguatezza di quel ruolo e dei comportamenti
di chi quel ruolo rivestiva. Questo travestitismo è l’ultima forma di quella attitudine
alla metamorfosi, che le mitologie di tutti i
popoli riconoscono ai loro trickster; ed è una
abilità di segno trasgressivo, perché implica
l’infrazione al divieto di metamorfosi, su cui
si fonda la separazione delle classi sociali,
dei ruoli, delle classi d’età (Canetti: 461-62).
Tutto questo rende Pulcinella simile agli eroi
della letteratura picaresca, coi quali ha in comune la vita errabonda, l’assillo del bisogno
e l’inclinazione al furto e all’inganno; anche
questo eroe del mondo marginale si muove a
suo agio dentro una identità fittizia e sempre
diversa, con la quale attraversa, impostore
impenitente, i più diversi spazi sociali. Almeno fin verso la fine del secolo XIX
Pulcinella ha sempre richiamato intorno a sé
Il teatro di Pulcinella è studiato, lungo un arco di oltre tre secoli, in D. Scafoglio - L. Lombardi Satriani 607-870. Lo studio del servo in commedia è stato approfondito soprattutto in alcuni studi francesi; tra essi il saggio di J.
Emelina si sottrae più decisamente degli altri ad un approccio riduttivamente sociologico. 181
Q
uaderni
un pubblico transclassista, formato di popolani e signori, senza che peraltro gli uni e gli
altri in questo teatro cercassero e trovassero
le medesime cose e il medesimo modo di
divertirsi. È stato innanzitutto il teatro della
plebe, di cui costituiva una forma ritualizzata di rivalsa nella dimensione dell’immaginario, con più o meno impliciti elementi
di critica sociale: nella sua lunga storia teatrale Pulcinella ha predicato ai sovrani che
il potere non può fondarsi sull’arbitrio, ha
mostrato la miseria della boria militare, ha
avanzato il dubbio che la medicina fosse
“merdicina”, ha mostrato gli oscuri grovigli del potere, ha denunciato l’iniquità della
giustizia, ha resistito con l’incomprensione
e la derisione alla violenza quotidiana dei
suoi padroni, ha riso dei miti e dei riti della
letteratura dominante, ha proclamato il suo
diritto a dire liberamente i suoi desideri, a
scoprire le sue paure e la sua fame. Ma questo teatro è stato, al tempo stesso, il
teatro del padrone, per il quale vedersi in Pulcinella o farsi pulcinella ha significato un alleggerimento rituale dei sensi di colpa connessi
con l’esercizio del dominio, la liberazione per
procura (attraverso l’assunzione della licenza servile) dal peso del ruolo e della rigidezza
della norma e dell’etichetta aristocratica. In tal
modo peraltro le classi superiori operavano
una sorta di superamento en bas della propria
limitatezza, allargavano la propria esperienza
del mondo attraverso la sperimentazione di
forme di vita “altre” e l’assorbimento della cultura delle classi inferiori; infine, accettando e
godendo di farsi deridere nella farsa pulcinellesca, davano spettacolo della loro capacita di
contemplare la loro negazione e davano una
conferma della loro universalità. Il travestitismo, ultima forma della metamorfosi, un tempo prerogativa soprattut182
to degli dei minori e dei demoni, accomuna
Pulcinella al Diavolo. Nella cultura tradizionale il trasgressore ha origini aliene, e, d’altra parte, la violazione dei tabù (che caratterizza i personaggi comici come Pulcinella)
gli conferisce ulteriormente grandezza, associata a un alone di poteri soprannaturali: il
mondo comico è un mondo all’incontrario,
un mondo di rovesciamenti e di trasgressioni, e non ci sorprende allora che gli “histriones” nei secoli passati siano stati condannati
dalla Chiesa e considerati “stregoni” dalla
gente comune. Secondo un altro mito di fondazione il
Cetrulo nasce dalle viscere del Vesuvio, da
sempre considerato emblema della napoletanità, ma anche bocca dell’inferno e luogo
di portenti, uscendo dal guscio di un uovo
comparso per volere di Plutone sulla sommità del vulcano, grazie a un impasto fatto
da due fattucchiere, che avevano chiesto
un soccorritore per sanare situazioni di ingiustizia e di oppressione: le formule delle
donne sono importanti per comprendere
l’essenza diabolica del Cetrulo:
Dragoncina:
Per formar dell’impasto il gran vigore
Vi pongo le bestemmie scellerate
Di tutti i giocator, ch’ hanno perduto,
L’ira, la rabbia ed il velen vi getto
Di brutta donna non curata al mondo,
E ridotta a implorar da impiastri e veli
Chi del suo bello alla conquista aneli.
Colombina:
Pe finire lu impasto io mo nce metto
Lo grasso de na crapa maumettana,
l’uocchio deritto de no jocatore,
Che na sera jocanno a zecchinetto
Co mico lo perdette nietto nietto.
(Gl’incanti delle maghe: 528).
antropologia e storia
I caratteri diabolici del Cetrulo trovano
ampia conferma nella sua fisiognomica e
nel suo abbigliamento: la maschera nera col
naso lungo, gibboso e affilato, il cappello biforcuto del secolo XVII, il neo sulla fronte,
simile a un corno miniaturizzato; al diavolo
fanno inoltre pensare la voce nasale, stridula e fessa, specie se ottenuta con la pivetta,
ed il seno femmineo, segno vistoso dell’ambivalenza sessuale; il Cetrulo inoltre ha un
rapporto costante, non sempre di ostilità,
col cane e il gatto, animali inequivocabilmente diabolici, e si accompagna a un suo
doppio animalesco, l’asino, animale ctonio,
dotato di misteriosi poteri. Si tratta di elementi probabilmente originari, o acquisiti
nel passaggio della maschera dal teatro al
mondo del Carnevale; ma è singolare che
queste connotazioni considerate “arcaiche”
abbiano accompagnato la storia plurisecolare del Cetrulo, riaffiorando in epoche recenti: maschere cornute di Pulcinella e Pulcinellessa compaiono nel teatro di Antonio
Petito, e l’identità demoniaca è ancora attestata in una statuina lignea in mio possesso
dalla forma particolare del coppolone, che,
con un incavo nel mezzo, forma un copricapo diabolico bicorne. Diabolico è anche il
comportamento di Pulcinella, “spirito pazzariello”, maestro di beffe, burle, capricci,
bizze, piccoli divertimenti crudeli, dispetti
ridicoli, scherzi pazzi e buffonerie di ogni
tipo, esperto, come il diavolo, nel discorso alla rovescia, nel doppio senso, nel linguaggio escrementizio e pronto a ricorrere
alla risorsa estrema del “vernacchio”, caro,
anch’esso, al Diavolo. Certo, Pulcinella incarna innanzitutto il demone della lussuria,
dal momento che egli è figura fallica e alla
lussuria sono state conferite per molto tempo connotazioni diaboliche. Tutto questo si
/ 2 – comicità e politica
legge, tra l’altro, in un bastone ricurvo da me
collezionato, che rappresenta, da un lato, un
enorme fallo, che si articola, sul lato opposto, in una fiamma, da cui emerge, demone
ghignante, la testa del Cetrulo.
Ma, oltre a incarnare la potenza della
sessualità, figure come queste hanno anche
(proprio per questo) una funzione apotropaica e profilattica; difendono dalla malasorte e dal malocchio, in coerenza con la
loro fondamentale funzione salvifica. Pulcinella ripete le fantasie, immemorabilmente
radicate nella cultura popolare, del diavolo
giocosamente priapico, del “diavolo ridicolo”, del “diavolo dabbene”, che esprimeva
il bisogno di conferire una qualche legittimità ai diritti della vita istintiva contro la
sessuofobia apocalittica della predicazione
religiosa e di integrare in qualche modo
nella norma l’anormale. In tutto l’arco della
sua vita teatrale, ma soprattutto nel teatro
dell’Ottocento, Pulcinella è il diavolo capriccioso e bizzarro, irriverente e vendicativo,
che semina confusione e scompiglio, quasi
parodia dell’intelligenza progettuale degli
uomini, ed è frequentemente strumento di
salvezza per i perseguitati e gli ingiustamente ostacolati. Ottavio Feuillet, che forse più
di ogni altro ha accentuato, nello spirito del
tempo, le sue connotazioni di difensore dei
deboli e nemico dei potenti malvagi, trasformandolo in una figura angelica, gli ha lasciato i suoi poteri diabolici, facendolo nascere
mentre “un grosso gatto, color fuliggine,
uscì di sotto dal letto, e un uccellino, nascosto tra le pieghe delle cortine, spiccò il volo
in camera, e fischiò dolcemente”; il gattone
nero, interpretò sua madre, “era il Diavolo, o un suo stretto parente, ma l’uccellino
veniva certo da Dio” (Feuillet: 19). Il senso
ultimo di queste mitologie (che illuminano
183
Q
uaderni
il significato e la funzione della maschera
teatrale) suggerisce che, se il diavolo è l’anomalia angosciante, il ritorno perturbante
del rimosso, la diversità radicale, la minaccia
dell’ignoto, la paura della morte, il teatro di
Pulcinella, allacciando, per oltre tre secoli, un dialogo ininterrotto con gli elementi
oscuri della coscienza, ha domesticato la sua
“ombra”10, trasformando in forze benefiche
le sue energie distruttive, e risolvendo le
suggestioni inquietanti dell’alterità in immagini rassicuranti e salvifiche. Per questo
in Pulcinella il ghigno malefico del demone
si coniuga col sorriso benevolo del salvatore. Lacan identifica Pulcinella col fallo, ossia
col pene simbolico, vedendo segnalata questa dimensione del Cetrulo a partire dal piano fonematico, giacché “al di là della voce
in falsetto e delle anomalie morfologiche di
questo personaggio erede del Satiro e del
Diavolo, sono proprio le omofonie quelle
che, condensandosi in sovrimpressioni, al
modo del tratto di spirito e del lapsus, denunciano nel modo più sicuro che ciò che
simbolizza è il fallo. Polecenella napoletano,
tacchinello, pulcinella, pollastrello, pullus,
parola tenera trasmessa dalla pederastia romana alle modiche effusioni delle piccinine
delle nostre primavere, eccolo passato nel
punch dell’inglese, per, divenuto punchinello, ritrovare la daga, il tassello, il tozzo strumento che dissimula, e che gli apre la strada
per cui discendere, piccolo uomo, nella tomba del tiretto, dove gli inseguitori, seguaci del
pudore delle Colombine, fingeranno di non
veder nulla prima che ne risalga, risuscitato
nella sua valentia” (Lacan). Attraverso condensazioni, figure e ammiccamenti, Lacan
Nell’accezione junghiana: P. Radin et al. 175-202. 10
184
recupera alcune illuminanti acquisizioni che
Jones aveva espresso in maniera meno affascinante e barocca, ma più perspicua: “La
parola Punchinello è una ‘contaminazione’
inglese della parola napoletana Pol(l)ecenella (Pulcinella in italiano moderno), anche
essa diminutiva di Pollecena, giovane tacchino (la parola poussin in francese corrisponde all’italiano moderno pulcino, che ha per
diminutivo Pulcinello); proprio come il gallo
domestico, il tacchino è un simbolo fallico
riconosciuto sia dal punto di vista della rappresentazione che da quello linguistico. La
radice latina è pullus, parola che serve a indicare in generale i cuccioli di un animale.
Per ragioni evidenti, il fallo è spesso identificato all’idea di un bambino maschio, di un
fanciullo o di un piccolo uomo” (Jones:124).
La fisiognomica di Pulcinella, che riteniamo
a torto sottovalutata da Lacan (dal momento
che per secoli il teatro di Pulcinella è stato
fondamentalmente un teatro del corpo), si
accorda perfettamente con questa interpretazione, essendo palesemente simboli fallici
il naso priapico, grande e adunco, il mento
aguzzo, anch’esso satiresco, il ventre dilatato
e prominente, comune ai demoni della fecondità, il berretto arrotondato o appuntito,
che ricorda analoghe figure falliche delle mitologie e del folklore europeo. All’universo
del sesso rinvia quasi interamente il corredo
degli oggetti di cui Pulcinella appare fornito, dal bastone al cordone, alla foglia di aloe,
al corno, e di figure falliche è costituito il
bestiario cui egli si accompagna, dall’asino,
suo alter ego animale, alla scimmia e alla tartaruga, associata con lo stesso significato al
feticcio africano (Collezione Scafoglio). antropologia e storia
D’altra parte la natura fallica del personaggio era presente, in modo più o meno
esplicito, nelle codificazioni della maschera costruite, a partire dal secolo XVII, sulla
base della conoscenza dell’uomo elaborata
dalla psicologia, dalla caratterologia, dalla
medicina e dalla fisiognomica, che in molti
casi ripetevano i percorsi di una immemorabile sapienza popolare, che ha lasciato tracce
vistose nei lessici europei: l’identità di Pulcinella e del fallo è presente nel linguaggio
erotico francese (“Papa, mon époux abuse /
De ce titre solennel: / Croirais-tu qu’il me
refuse / Jusqu’à son polichinel”?/Guiraud,
s.v. Polichinelle), dove è anche ribadita l’identità Pulcinella=fallo=bambino, dal momento che l’essere incinta si denomina con
l’“avere il Pulcinella nel tiretto”11. Ed all’area
campana appartiene tutta una produzione
sotterranea di statuine di Pulcinelli fallici,
scoperta alcuni anni addietro da chi scrive,
che ne ha potuto salvare alcuni esemplari dalla dispersione cui materiale di questo
tipo è esposta: ad essa appartiene un bastone ligneo bifallico, nella cui parte centrale
sono incise, a rilievo, sette mezze maschere
pulcinellesche dagli enormi nasi priapeschi
a tutto tondo: i nasi sono sette, quanti sono
i giorni della settimana, con evidente riferimento alla costante attività sessuale del personaggio, e il manufatto offre un riscontro
visivo a un modo di dire campano, “tiene i
setti nasi di Pulcinella”, con cui si designa
un uomo particolarmente virile. Una seconda statuina rappresenta un Pulcinella
marionetta, con un coppolone adombrante
la punta del pene, che ricompare di nuovo
all’estremità inferiore. Il terzo oggetto – cui
11
/ 2 – comicità e politica
abbiamo già fatto riferimento – è un grosso
bastone ricurvo, in forma di fallo da un lato
e di demone dall’altro. Un altro manufatto
ligneo rappresenta un Pulcinella intero, con
maschera mobile, che esibisce un enorme
pene denudato. Ho rinvenuto infine altri
piccoli pulcinelli bronzei deformi, con un
grande fallo denudato, e un Pulcinella in
terracotta, anch’esso di piccole dimensioni, che cavalca una tartaruga (notoriamente simbolo vaginale) sul lungo collo che è,
al tempo stesso, un enorme fallo. Queste
rappresentazioni erano innanzitutto oggetti d’uso, nel senso che venivano esposti per
cacciare il malocchio, le streghe e la mala
sorte; e ancora oggi essi assolvono una – se
vogliamo – residuale funzione apotropaica e
profilattica, se ancora oggi la sessualità è una
forma efficace di recupero, che può salvare
dalla paura e dall’angoscia. Tuttavia il Pulcinella-fallo è una complessa costruzione culturale, la cui trama si
lascia cogliere solo se si confrontano questi
manufatti con tutta la vita secolare della maschera e delle figure analoghe, sulle scene e
nell’immaginario collettivo. Falliche erano
alcune divinità minori del mondo classico,
la maggior parte delle figure tricksteriche
delle popolazioni “primitive”, numerosi
personaggi del teatro popolare di tutti i tempi, dalle maschere fliaciche a quelle atellane
e della Commedia dell’Arte. In tutti i casi il
personaggio comico è fallico perché il fallo
è, per eccellenza – come ci si esprime ancora oggi nei dialetti meridionali d’Italia – “il
folle”, in quanto emblema dell’universo del
desiderio riluttante alla ragione, principio
di disordine e di vita. Di fatto la maschera
A. Delvau, Dictionnaire érotique moderne, Paris, Les Editions 1900 (ed. or, 1864, s.v. Polichinelle); E. Chambrey, 77. 185
Q
uaderni
fallica ha rappresentato, in tutta la sua storia
teatrale, il luogo “pedagogico” in cui le pulsioni umane vengono assunte senza ritegno,
per essere portate alla luce della coscienza e
dominate. Nella sua specificità partenopea
e mediterranea, Pulcinella-fallo ripropone l’archetipo del figlio ribelle, altamente
rappresentativo di una cultura meridionale
plasmata dal matriarcato, in cui le spinte
orgiastiche e la violazione degli interdetti
sono profondamente connaturati alla paura della donna e al timore della castrazione.
Pulcinella per un verso si configura come un
eroe della trasgressione, incarnazione di una
voglia di sessualità e di irregolarità diffusa,
con tutti gli attributi della virilità superiore;
per un altro verso questo fallo ingente è avvertito come un pericolo e perciò punito col
ridicolo, le corna e le botte; la punizione colpisce l’eccesso e ristabilisce l’equilibrio, conciliando la trasgressione col senso morale12. Caratteristica opposta e al tempo stesso complementare è l’ermafroditismo che
connota, sia pure non decisivamente, la
maschera. Segno della femminilità di Pulcinella può essere la sua stessa attitudine
ad accompagnarsi spesso al suo corrispettivo femminile, la Pulcinellessa, che non è,
come comunemente si crede, la compagna
del Cetrullo, ma la sua anima femminile,
lo stesso Cetrulo in veste di donna. Ma la
femminilità di Pulcinella è inscritta nel suo
corpo. Nonostante la massiccia prevalenza
di elementi fallici, alla sfera della femminilità rinviano i rigonfiamenti del petto (gob-
12
13
186
be o seni che siano), accentuati dalle ampie
pieghe della camicia; la pancia enorme, né
d’uomo né di donna soltanto, ma, come egli
soleva dire, “commune a dui” (comune a
entrambi); i glutei polputi e rotondeggianti
da efebo; la voce stridula e rotta di castrato; le maniche lunghe che tendono a coprire
le mani. Il mito, spesso ripreso dalla stessa
tradizione scenica, ma più frequentemente
testimoniato dalle rappresentazioni artistiche e letterarie, conferma ampiamente
queste impressioni, dal momento che, come
abbiamo visto, Pulcinella nasce dall’uovo,
come tante figure ermafroditiche della mitologia e del folklore, e può inoltre concepire, partorire, allattare, prerogative che
egli ha in comune con altre figure similari,
come lo Zanni della Commedia dell’Arte e
il trickster degli indiani d’America13. Queste
rappresentazioni costituiscono una ripresa
in chiave comica di materiali rituali e narrativi folklorici ed etnologici, quali i racconti
del “padre allattante” e del mito della couvade, di cui ripetono, nelle forme consentite
dalla cultura del tempo, alcuni significati.
Pulcinella partoriente e allattante faceva ridere come tutto ciò che e contro natura, ma
non senza una parte dell’interesse che i fatti
contrari all’ordine naturale hanno suscitato
da sempre, dal momento che consentono
l’attivazione di fantasie e desideri ancora radicati nell’immaginario collettivo. Al fondo
di tutto permaneva, più o meno inconsapevole, un bisogno di portare alla luce la parte
femminile della propria umanità. La forma
Il medesimo schema logico (e narrativo) si ritrova al fondo di gran parte della narrativa erotica di tradizione orale,
che sotto questo aspetto potrebbe essere considerata il corrispettivo di questo teatro comico (D. Scafoglio, I racconti erotici). Per qualche altro riscontro teatrale e narrativo moderno di questi motivi che afferiscono ad orizzonti mitico-rituali
arcaici, si veda D. Scafoglio, La Vecchia del carnevale e Maupassant 174-80. antropologia e storia
del comico rendeva questo bisogno rappresentabile, operando un compromesso tra il
desiderio e la vergogna. Nel teatro il motivo
affiora, pur camuffato, nel gioco dei travestimenti e degli scambi di persona, che consentono in qualche modo di rappresentare
la promiscuità sessuale sotto la copertura
dell’equivoco o della stolidezza, mentre il
bisogno diffuso di maternità si stempera nel
tema onnipresente della “famiglia di Pulcinella”. Tutte queste elaborazioni fantasmatiche e rappresentazioni letterarie e teatrali,
oltre a implicare la competitività maschile
nei confronti dell’altro sesso, conservano
un rapporto di complementarità con la natura fallica della maschera; in primo luogo,
perché un eccesso, l’esasperazione della virilità, si coniuga inevitabilmente all’estremo
opposto, la femminizzazione, per la curvatura della linea del desiderio (si pensi – ma
è solo un esempio – all’ermafroditismo del
Dioniso greco o del Diavolo cristiano); in
secondo luogo, perché la natura ermafroditica si configura come il rovescio punitivo
del principio fallico: l’attribuzione di caratteri femminili a Pulcinella serviva a degradare il personaggio, secondo la logica della
commedia dello sciocco, suscitando il consueto riso d’esclusione, sicché nello sciocco
effeminato si puniva il fallomane stolido. È
la logica che determina la femminizzazione
punitiva di Pahlavān Kačial, l’eroe fallico del
teatro dei burattini iraniano: “Non lo sapevi
che a chi guarda le donne altrui gli ficcano
un corno nel sedere?”14. Profittando ampiamente della libertà
che la società tradizionale riteneva diritto e
privilegio di chi – folle, sciocco, buffone –
/ 2 – comicità e politica
era fuori delle regole sociali, Pulcinella per
oltre tre secoli ha avuto come interlocutori
re, capitani, signori, padroni, giudici, dottori, sbirri, e di tutti se è fatto giuoco, lui, “pulcino” perennemente giocato. Tutto questo
attraverso un discorso obliquo, una petulanza aberrante, un chiacchierio confuso,
tramato di fraintendimenti reali o simulati,
di equivoci deliranti, di stravolgimenti verbali dissonanti, di lazzi buffoneschi sguaiati
e osceni. Il riso vestiva d’insensatezza il discorso della verità, generando le perplessità,
testimoniate già nel secolo XVII: “Questo
gustosissimo uomo ha introdotto una disciplinata goffagine… poscia che egli fa uno
assiduissimo studio per passare i termini
naturali e mostrar un goffo poco discosto
da un pazzo o un pazzo che di soverchio si
vuol accostare a un savio” (Cecchini: 32).
Nel corpo e nell’abbigliamento Pulcinella
porta i segni più vistosi che appartenevano
all’iconografia della “Stultitia”: la testa rasata, il bastone, la campana, il vestito bianco,
la simbologia ornitologica, il cappuccio a
punta, il bastone, il tamburello, la corda che
stringe il camicione, ed è associato al cane,
compagno del folle. Appartiene alle culture
tradizionali l’idea che l’apertura controllata
verso le forze oscure e misteriose dell’anormale e dell’irregolare potesse ridare sanità e
benessere a sistemi normativi corrosi dalla
crisi. Pulcinella è stato l’eccesso salutare, e
ha rappresentato una terapia d’insensatezza
per le logiche malate della realtà. “Perdonatelo, è sciocco”, solevano ripetere solleciti i cortigiani di ogni tempo, per
difendere il buffone napoletano dall’ira del
re padrone. È la fictio che ha consentito per
Il testo dell’“eroe pelato” iraniano è pubblicato in traduzione italiana da Mattioli 125-42. 14
187
Q
uaderni
secoli l’esistenza della scena del buffone.
Sostanzialmente estraneo alle logiche della
realtà, Pulcinella è colui che continuamente
non comprende o fraintende, e la sua distrazione o incomprensione causa a se stesso e
agli altri un’infinità di disastri. La pulcinellata è un aspetto dell’eterna commedia dello
sciocco, che ha consentito di ridere negli altri di ciò che in noi stessi costituirebbe una
sorgente di insicurezza e di angoscia. Ma
in questo teatro le sofferenze che Pulcinella sciocco infligge alle sue vittime appaiono
più significative di quelle che egli procura a
se stesso. Si tratta solitamente di personaggi
d’autorità e di figure del potere, re, aristocratici, capitani, dottori, avvocati, sbirri, che
le scempiaggini del Cetrulo, con il crescendo
di irritazione che determinano, costringono
a rinunciare alla loro ieratica prosopopea,
scoprendo la loro fragile umanità mascherata dal comportamento pubblico e dal ruolo. Lo sciocco è portatore di una maldestra
sincerità all’interno di codici tramati di
eufemismi, reticenze, silenzi; parzialmente
estraneo all’ordine del linguaggio, lo sciocco
stravolge la base lessicale del discorso, deformando, sovrapponendo, incrociando le
parole e inventando nuovi termini; intende
alla rovescia e parla all’incontrario; si smarrisce nei meandri delle figure, riducendo i
significati al senso letterale; fino ad affondare nel garbuglio incongruo e confuso e
nel farfuglio del non senso: segni vistosi di
ignoranza e di distrazione, inevitabilmente
colpiti dal riso che condanna ed esclude,
ma, al tempo stesso, maschera di una operazione che mette a nudo la convenzionalità e
l’innaturalità dei linguaggi formalizzati e gli
artifici dei gerghi professionali, menomando il potere di persuasione e di dissuasione
della parola “autorevole”, e che decompone
188
le ordinate simmetrie del discorso, ne evidenzia i limiti e ne prospetta, come disordine fecondo, un possibile allargamento. Ma è
altrettanto significativo che questo sciocco,
autentico o per finta, rimanga eternamente
vittima della sua distrazione e dei suoi errori
e della sua stessa furberia: in tal modo tutto
torna, perché nello sciocco deriso, beffato,
bastonato si potrà ravvisare la punizione
dello scaltro ingannatore e del trasgressore
vincente, e l’infrazione delle regole culturali
si concilierà, senza residui sensi di colpa, col
senso morale. La differenza irriducibile
e il capro espiatorio Pulcinella non ha mai suscitato meccanismi di immedesimazione incondizionata
e totale, perché c’è sempre in lui qualcosa
di noi che rifiutiamo, e che nella scena del
buffo si trasforma nell’alterità irriducibile.
Questa parte di noi che puniamo nel buffone trasforma, in qualche modo, Pulcinella in un capro espiatorio (Cecchini: 32).
L’ambivalenza del Cetrulo è quella di celebrare l’epopea del picaro e, al tempo stesso, incarnare la miseria della marginalità e
dell’esclusione; mentre proclama il suo sano
vitalismo e la sua liberta, egli discopre altresì
l’avvilente condizione del pigro vagabondo, la squallida fisiologia della paura e della
fame, la grave ossessione dell’amante fallomane, la balordaggine insulsa dello sciocco
confusionario. Era stata elaborata da un
grande napoletano la teoria che gli uomini
“ridicoli” fossero qualcosa di mezzo tra le
persone serie e gravi e le bestie (Vico: 21);
persuasione ribadita, con l’aggiunta di una
dose di acredine, in cui si specchiava il pun-
antropologia e storia
to di vista dei valori liberal-nazionali della
Napoli ottocentesca, da Giorgio Arcoleo:
“Pongo il suo carattere [di Pulcinella] tra
due nature, l’animale e l’uomo”15. Ma non
si trattava soltanto di deformazioni della
cultura colta; anche la cultura dei teatri frequentati dalla plebe, delle guarattelle, delle
scene carnevalesche, che di Pulcinella aveva
invece fatto il suo eroe, aveva rilevato, con
un suo autonomo linguaggio, l’ambivalenza
fondamentale del buffo in commedia: “Songo miez’ommo e tutto bestiale”, recitava
Scatozza, un personaggio affine al Cetrulo,
in una sacra rappresentazione settecentesca
(Politi: sc. 7): eco del buffone di Acerra, che
intanto proclama sulla scene: “Pe bestialità
no m’appassa manco na bestia”; “Su’ ciuccio, ed è ciuccio chi non me chiamma ciuccio” (Cerlone: a. 2, sc. 9). In Pulcinella la
carica aggressiva e l’estroversione giocosa è
controbilanciata da impulsi auto-flagellatori, alimentati dall’oscura percezione di essere “caduto in basso”. Dissacratore di valori
assoluti, Pulcinella sente al tempo stesso di
non appartenere a nessun mondo di valori,
ma solo a un cieco universo di bisogni, assillato da domande inevase e da esiti delusori:
“Io, Don Polecenella Cetrulo, nato a la Cerra ntra li ciuccie, e cresciuto, e ppasciuto a
Nnapole ntra li sartimbanche, sempe malato
de mente, e ssempe sano de cuorpo…”16; e
ancora: “Io so Polecenella, facchino di nascita, disonorato di costumi, vituperato da
le prete de la via, ma stimato da chi non
ha stima della reputazione” (De Petris: sc.
10). In questi casi Pulcinella sembra far-
/ 2 – comicità e politica
si riconoscere come “napoletano di razza,
di una grandiosa amoralità; qui sì, come la
plebe, che più di nascondere le sue piaghe
le mostra e vuole riceverne ammirazione e
premio, come credo non faccia alcun altro
popolo, Pulcinella diventa esemplare” (Rea:
25). In realtà Pulcinella ripete a Napoli, nel
linguaggio del luogo e del tempo, lo splendore e la miseria che accompagnano la scena
del buffone in ogni tempo e sotto tutti i cieli,
e il male che infligge a se stesso altro non è
che il complemento e il riflesso delle ferite
che infligge agli altri: “In verità, è proprio
per questo” – rifletteva il trickster pellerossa – “che la gente mi chiama walkundkaga,
il folle ecccentrico, e hanno ragione” (Radin
et al.: 25).
L’essenza di questo teatro comico è nel
fatto che noi possiamo vivere per interposta
persona tutto ciò che la follia della maschera
ci propone, col vantaggio di poter dire, alla
fine, che “è stato Pulcinella”. Ma non è stato Pulcinella, perché siamo stati noi. Intanto il buffone paga per tutti, con le botte, le
disgrazie, le umiliazioni e il ridicolo. Il che
rende ragione dell’intuizione scandalosa del
predicatore settecentesco, che, agitando il
Cristo in croce, gridava alle folle: “Questo è
il vero Pulcinella”17. Il corpo del buffone Non è senza ragione che quasi tutti i
tratti che siamo andati evidenziando si ritrovino nel corpo stesso della maschera. No-
F. De Sanctis, La scuola - Pulcinella 14 (con il saggio di Arcoleo). M. Zezza, Lo testamiento de Polecenella 10. 17
L’episodio è ora ricostruito e discusso da Scafoglio, Pulcinella e Cristo, in D. Scafoglio - L. Satriani 289-303. 15
16
189
Q
uaderni
toriamente il corpo è metafora della società,
il che è reso possibile dal fatto che l’uomo
ha plasmato culturalmente il corpo con le
stesse regole con cui ha costruito il sistema
sociale. Il tratto fondamentale delle figure
comiche tradizionali è la deformità: questa
caratteristica, pur nelle variazioni storiche,
che rispecchiano ogni volta i mutamenti
delle concezioni e dei gusti estetici, unifica
le figure comiche di tutti i tempi, dal teatro
greco alla commedia dell’Arte. Il teatro moderno ha apparentemente ricondotto questo
aspetto nei limiti della norma, ma ancora
oggi riesce difficile trovare un comico che
non riproduca in qualche modo un’anomalia o un’irregolarità corporea rispetto ai
canoni estetici dominanti. Tradizionalmente la bellezza è sentita come una “necessita
della natura”, laddove la bruttezza appare
piuttosto come una “violazione della norma” (Propp: 47). La deformità è la bellezza
all’incontrario, è la veste corporale dell’inversione morale, il corrispettivo corporeo
della deformazione linguistica, il riscontro
visivo del comportamento alla rovescia. Il
mito del trickster pellerossa, che nasce mostruoso perché frutto di un incesto, testimonia clamorosamente questa coincidenza
di valori estetici e principi morali. Inoltre,
la diversità corporea del buffone è segno e
specchio di una diversità connotata etnicamente, socialmente e moralmente; è – lo
abbiamo già visto – il corpo imperfetto, irregolare, deforme del contadino, del servo,
del folle. Ma più che rinviare a un ruolo sociale, il corpo e l’abbigliamento di Pulcinella
denunciano la sua estraneità ai simboli di
ogni stato e ruolo, e ne costituiscono la loro
esatta inversione e negazione. Col suo volto
di uccello o di verro, le sue sconcertanti protuberanze, con la sua testa rasata da taglia190
gola, Pulcinella contraddice un universo che
ama specchiare il suo ordine nella regolarità
e bellezza dei corpi, e proclama la sua natura
di figura del disordine; con i tratti femminei dell’abbigliamento, del corpo, della voce,
mette in crisi le rigide distinzioni dei sessi
e, buffone maschio ed effeminato, insinua
i fantasmi della promiscuità in una società
fondata sui valori eterosessuali; col suo abbigliamento spropositato, fuori uso e alla rovescia, affine al vestito del clown e del matto,
contrasta le regole fondamentali del vestire
secondo misura, morigeratezza ed eleganza. Questo corpo è altresì emblema del disordine liminale nel quale il buffone vive e che nel
buffone si esprime. Quanto più rigidamente una società è organizzata, tanto più essa
esercita la sorveglianza sui confini del corpo,
e in modo particolare sulle soglie e le entrate,
rafforzando la linea di demarcazione tra l’interno e l’esterno, il pulito e lo sporco (18): la
figura del buffone non solo rompe le ordinate simmetrie del corpo, non solo è un corpo
cangiante per via delle infinite metamorfosi (il
comico è per eccellenza un trasformista), ma si
associa a ciò che esce dal corpo (sputo, sangue,
urina, escrementi) o che è destinato allo spazio
dell’impuro. Il comico è escrementizio, fa ridere manipolando verbalmente gli escrementi, perché è nella natura operare nei confini,
come artefice di contaminazioni e produttore
di relazioni. Il comico media la relazione fondamentale tra il pulito e lo sporco, e da ciò trae
il suo stesso potere: “Un io completamente
pulito con nessun limite sporco non avrebbe
alcuna relazione con il mondo esterno o con
altri individui. In tal modo un ‘io’ sarebbe libero dal potere degli altri, ma sarebbe a sua volta
impotente… e da ciò deriva che il potere è situato nello sporco” (Leach: 87). Pulcinella afferisce altresì al mondo del
antropologia e storia
pennuti, e ripete tutte le connotazioni che i
sistemi simbolici tradizionali attribuivano ad
appartenenze di questo tipo; la simbologia
gallinacea ha caratterizzato in modo particolare, soprattutto nella cultura occidentale,
il mondo dei buffoni e delle figure della trasgressione e della follia. Nato dall’uovo, il
Cetrulo indica col suo stesso nome la sua natura gallinacea, la esplicita nel suo linguaggio
gestuale e nella sua voce, e la ricorda vistosamente negli elementi della sua fisiognomica
e del suo costume: il cappuccio a forma di
guscio d’uovo, la testa di volatile con l’occhio
pollino rotondo e il naso a forma di becco, il
camicione bianco con maniconi amplissimi a
forma di ali. I gallinacei erano emblema della
stolidezza, in sintonia con la cultura del tempo, che sentiva nella “stultitia” la regressione
nell’animalità, e Pulcinella Cetrulo vale “pulcino scervellato e ottuso”, non molto diverso
in questo dalle altre maschere, che amavano
vantare nomi, appellativi, qualifiche e ascendenze di questo tipo, come gloriosi blasoni
della loro follia. Tuttavia il significato più
forte del simbolismo gallinaceo è certamente quello fallico (il dimorfismo sessuale dei
pennuti ammicca peraltro all’ambivalenza
sessuale, e infatti Pulcinella non è soltanto il
possente gallo fallico, ma presenta anche –
come suona il suo nome, “gallinella” – una
inequivocabile componente femminile): il
gallo era emblema di “stolidezza”, lussuria e
promiscuità, e ancora nel secolo XVII la sua
mattanza rituale nei Carnevali europei aveva
il significato di una mortificazione della carne: le vicende di Pulcinella sulla scena, “gallo” stolido e lascivo sistematicamente beffato
e deriso, erano l’equivalente simbolico della
persecuzione e del sacrificio rituale del “gallo
di marzo”. / 2 – comicità e politica
Conclusioni per un’antropologia del comico Cercheremo, conclusivamente, di tracciare la linea di una teoria del comico dal
punto di vista dell’esperienza antropologica, a partire dalle acquisizioni che l’analisi
della figura di Pulcinella nella vita popolare
e nella scena teatrale ci ha consentito, e col
soccorso dei riscontri interculturali. Essa
potrebbe essere così articolata: 1. L’eroe comico viene da un altrove. Il
personaggio comico è in vario modo un
esterno alla cultura in cui opera. Pulcinella,
maschera napoletana per eccellenza, si faceva venire da Acerra, da Giffoni, da Ponteselice o da Benevento, ossia da contesti rurali o periferici, e tutta la sua storia secolare
potrebbe essere letta come un capitolo particolare della cosiddetta satira del villano,
che attraversa buona parte della letteratura
(…) il motivo della provenienza esterna è
indicativo innanzitutto del fatto che il teatro comico è il teatro dell’etnicità, in cui la
frizione citta/campagna, centro/periferia,
identico/diverso, gioca un ruolo importante nella genesi psichica e culturale del riso.
Anche ai nostri giorni i personaggi comici
sono collegati socialmente, culturalmente,
espressivamente a contesti regionali, dialettali, periferici, d’emigrazione, e sono portatori di una diversità che è, vistosamente, una
diversità etnica. La provenienza esterna allude altre volte
a un altrove sociale. Pulcinella è stato per i
ceti privilegiati di Napoli il portatore della cultura del “popolo minuto”; nel teatro
comico romano i personaggi comici erano
schiavi e in gran parte di quello europeo
dell’età moderna erano servi; il loro perfetto corrispettivo romanzesco era il popolano
furbo, il furfante intelligente, il picaro. Il
191
Q
uaderni
comico dunque riflette le tensioni interne a
una società, quelle che nascono dall’incontro, contaminazione e scontro tra i diversi
dislivelli di cultura, e sono, innanzitutto,
tensioni sociali. Il personaggio comico può provenire
miticamente dagli inferi. Questo motivo
rinvia più significativamente alla diversità
che preme sui confini interni della cultura,
alla parte oscura di ogni società. Le connotazioni diaboliche che troviamo in Pulcinella
si riscontrano altresì in altre figure comiche,
nelle mitologie che le riguardano e nei comportamenti che esse esplicitano: dall’aldilà
si immaginavano venuti i buffoni sacri delle
Americhe, un demone era Arlecchino e diabolico era l’universo delle maschere della
Commedia dell’Arte. L’origine esterna del
personaggio comico indica dunque la diversità culturale, che concretamente è, di volta
in volta, la cultura del mondo rurale, l’esperienza delle classi inferiori e il lato diabolico
dell’uomo, con la tendenza a confondere le
tre cose in una sola. 2. L’eroe comico è un trasgressore. L’esperienza comica introduce in maniera controllata elementi di disordine creativo dentro
una cultura, forzando la sua costellazione di
regole e valori entro limiti compatibili con la
tenuta complessiva del sistema. Sotto questo
aspetto il comico è trasgressione ordinata,
regolata licenza. In questa luce acquista più
senso e diventa meglio percepibile la provenienza esterna della figura comica. Il trickster degli indiani d’America è un violatore
di tabù, e in primo luogo del tabù del sangue (…): i buffoni sacri costituiscono il corrispettivo rituale del briccone divino delle
mitologie amerinde, dal momento che essi
evocano ritualmente l’infrazione dei tabù
192
(….) la comicità sotto tutti i cieli si dispiega
nel segno dell’eccesso, dell’inversione, dei
rovesciamenti. Importa invece notare come
la violazione delle regole costituisca un fatto fondante, dal momento che su di essa il
personaggio comico costruisce anche la sua
immagine. Fino alle soglie del mondo contemporaneo la trasgressione risulta notoriamente connessa col sacro, dal momento che
grazie ad essa il trasgressore acquisiva potere (originariamente, il potere magico insito
nel sangue). Ma anche in contesti desacralizzati, come i nostri, il personaggio comico
deve la sua forza e il suo prestigio alla capacità di andare all’incontrario, esercitare una
sorta di violenza bianca sui personaggi d’autorità, cimentarsi nell’esercizio della parodia
di costumi e dei miti collettivi. Tutto questo
sarebbe incomprensibile se non ipotizzassimo l’esistenza di una delega collettiva al
trasgressore a peccare, sbagliare, colpire in
nome di tutti. Le società cioè affidano alle
figure di confine il compito di rappresentare i loro desideri nascosti, e il loro successo
dipende dalla loro capacita di rappresentarli
nella maniera più efficace e, soprattutto, dal
coraggio di farlo. Il confronto con l’alterità è
una condizione della trasgressione comica,
ma al tempo stesso nell’esperienza comica
l’altro si rivela come lo stesso, la parte oscura
di sé. 3. L’eroe comico è un mediatore culturale. Se per un verso il comico è portatore di
disordine, per un altro svolge una importante funzione di rifondazione e rafforzamento dell’ordine culturale. Il trickster delle
mitologie primitive è un eroe civilizzatore,
che compie azioni di grande utilità per gli
uomini e fornisce loro i mezzi per migliorare la vita; i buffoni sacri di tutti i popoli
antropologia e storia
svolgono una importante funzione equilibratrice soprattutto in relazione alle tensioni interne e ai rapporti con l’esterno. Anche
se questa funzione è diventata, per così dire,
opaca nella percezione moderna della comicità, è significativo che ancora oggi i comici
godano di grande popolarità e vengano considerati altamente rappresentativi della vita
dei popoli, pur non incarnando il meglio dei
caratteri nazionali. In effetti il personaggio
comico media il rapporto con la diversità
culturale, consentendo l’assorbimento di
esperienze e forme di vita altre e impedendo
che le culture si chiudano in se stesse, impoverendosi; per un altro verso egli allontana
ciò che potrebbe minacciare l’integrità culturale della comunità e pertanto rafforza le
sue difese e consolida la sua identità (….). In
quest’ottica acquista trasparenza la dialettica interna alla risata comica: nell’universo
comico si ride al tempo stesso per escludere
e per includere, per accettare e respingere:
la comicità non va confusa con la derisione,
che costituisce soltanto uno dei suoi poli
dialettici: l’altro polo è quello dell’accoglimento: si ride per escludere ciò che non è
compatibile col nostro sistema culturale e si
ride per integrare ciò che può rinnovarlo e
arricchirlo. L’esperienza comica promuove
e sollecita il confronto con l’esterno e al tempo stesso difende dalle minacce dell’ignoto. 4. L’eroe comico è un capro espiatorio. In
quanto possessore di una delega collettiva a
violare i confini della norma, il personaggio
comico, come ha rilevato Laura Makarius,
non può essere condannato, ma neppure
può essere approvato; tuttavia egli porta
inscritto nel suo corpo e nella sua vicenda
i segni vistosi di una punizione esemplare:
i personaggi comici risultano sempre associati in vario modo all’idea della deformità
/ 2 – comicità e politica
corporea, dell’alterazione linguistica, della
vita sfortunata, delle disgrazie, della stolidezza, del ridicolo, delle botte. Certamente
in questo accanimento persecutorio poniamo nel buffone la parte di noi che inquieta
e disturba, ma solo ricomponendo in una
unità dialettica le contraddizioni della sua
figura si afferra pienamente il senso dell’esperienza comica; nella femminizzazione
del personaggio si punisce la sua virilità
indecorosa, le botte che egli prende sono il
prezzo di quelle che dà, le sue disgrazie sono
il contrappasso dei guasti che la sua dissennatezza produce. Il personaggio comico si
muove nel segno dell’eccesso e in quello della mancanza: nell’uno si compie la trasgressione, nell’altro la si punisce. In tal modo la
società può compiere per interposta persona l’incursione nei territori dell’irregolare,
dell’illecito e del proibito, allargando i confini della propria umanità, e al tempo stesso, attraverso la punizione del trasgressore
vicario, può riconciliarsi col senso morale,
rifondando l’ordine turbato. Opere citate Augè M., Il corpo del feticcio, “Uomo e cultura”,
37-40 (1986-87), 54-62. Bausani A., Note sul “pazzo sacro” nell’Islam,
“Studi e materiali di Storia delle Religioni”
29.1. Canetti E., Masse e potere,tr. it., Milano, Adelphi,
1981 (or. ted. 1980). Cecchini P. M., Frutti delle moderne comedie et
avisi a chi le recita, Padova, Guareschi, 1628. Cerlone F., “Il vassallo fedele”, Commedie, Napoli, Stamperie Rampe di S. Marcellino, 1828. Chambrey E., La poupée du diable, Paris, Fleuve
Noir, 1982. Crumrine N. R., Anomalous Figures and Liminal
Roles, “Anthropos”, 5-6 (1974), 858-73. 193
Q
uaderni
Dalbono C. T., Pulcinella e la maschera napoletana, in Usi e costumi di Napoli e contorni, a c.
di E. De Bourcard, Milano, Longanesi, 1997
(orig. 1858). De Petris F., Buovo d’Antona in Erminia, Napoli,
Tipografia della Sirena, 1836. De Sanctis F., La scuola - Pulcinella, Napoli, Morano, 1897. Dictionnaire érotique moderne, Paris, Les Editions, 1900; Payot, 1993 (orig. fr. 1864). Douglas M., Simboli naturali, tr. it., Torino, Einaudi, 1979 (orig. 1970). –, Purezza e pericolo, tr. it., Bologna, Il Mulino,
1975 (orig. ingl. 1970). Emelina J., Les valets et les servantes dans le theatre comique en France de 1610 a 1700, Cannes
Grenoble, Celpug, 1975. Evans Pritchard E.E., The Zande Trickster,
Oxford, Clarendon, 1967. Feuillet O., Vita e avventure di Pulcinella, tr. it.,
Firenze, Salani, 1897 (or. fr. 1846). Gl’incanti delle maghe per la nascita di Pulcinella
dalle viscere del monte Vesuvio, Napoli, Miranda, 1824. Heers J., La festa dei folli, tr. it., Napoli, Guida,
1990 (orig. fr. 1983) Jones E., La teoria del simbolismo, tr. it., in La
psicologia di Freud, La Spezia, Melita, 1982
(orig. ingl. 1916). Lacan J., Scritti, tr. it.,Torino, Einaudi, 1974 (ed.
fr. 1966).
194
Leach E., Cultura e comunicazione, tr. it., Roma,
Franco Angeli, 1981 (orig. ingl. 1976). Levi-Strauss C., Antropologia strutturale, tr. it.,
Milano, Il Saggiatore, 1966 (orig. fr. 1958). Makarius L., Le sacré et la violaltion des interdits,
Paris, Payot, 1974. Mattioli G., Il Paladin Pelato e il suo doppio,
“Quaderni” dell’Istituto Culturale della Repubblica Islamica d’Iran in Italia, 1 (1989),
125-42. Mazzoleni G., I buffoni sacri d’America, Roma,
Bulzoni, 1990. Politi N., La fortezza trionfante, Napoli, s.a. Propp W. J., Comicità e riso, tr. it., Torino, Einaudi, 1988 (or. russo 1976). Radin P., C. G. Jung e K. Kerényi, Il briccone divino, tr. it., Milano, Bompiani, 1979 (ed. ted.
1954). Rea D., Pulicinella e la canzone di Zeza, Napoli,
ESI, 1968. Scafoglio D. e L. M. Lombardi Satriani, Pulcinella. Il mito e la storia, Milano, Leonardo, 1992. Scafoglio D., I racconti erotici italiani, Roma,
Meltemi, 1996. Scafoglio D., La Vecchia del Carnevale e Maupassant, in Id., Antropologia e letteratura, vol. I,
Salerno, Gentile, 1996. Vico G. B., L’autobiografia, il carteggio e le prose
varie, Roma-Bari, Laterza, 1929. Zezza M., Lo testamiento de Polecenella, in “La nferta pe lo Capodanno de lo 1839”, Napoli, 1839.
Per Rocco Brienza
Mi sono recato da Rocco nel Friuli, nella
sua ultima estate, e poi qualche mese più tardi, nel momento conclusivo della sua storia.
Era il pellegrinaggio mesto dell’affetto e del
distacco, associato al proposito – auspicato
da alcuni degli amici più cari e laicamente
condiviso dallo stesso Rocco – di un comune lavoro di costruzione di tracce di memoria, cui affidare la sua identità. L’identità di
una persona che aveva incrociato la nostra
vita, lasciandovi il segno delle esperienze vivificanti.
La storia dei filosofi, letterati, scienziati
di solito viene costruita da altri uomini di
scienza e di lettere, ma il modo migliore di
restituire il senso della loro esistenza nasce
forse dal confronto, che può diventare negoziazione, tra quello che essi immaginano
di se stessi e quello che di essi gli altri – soprattutto gli amici che lo hanno conosciuto
– pensano o sentono. Il significato del proposito, condiviso da Rocco, era quello di
consegnare a noi la sua storia, perché noi,
suoi amici, a nostra volta la riscrivessimo e
raccontassimo. Mi sembrava e mi sembra la
scelta più giusta, perché sono convinto che
si capisce in profondità ciò che si ama – se
amore è anche conoscenza – e che tutto il
resto è gossip.
Io non aspiro ora a disegnare un profilo
intellettuale di Rocco Brienza, perché ocorrerebbe altro tempo e, soprattutto, altro stu-
dio. Il mio rapporto con Rocco si fondava su
una trama di condivisioni parziali ma significative, che ha lasciato allo stato latente una
più vasta possibilità di scambi e complicità
intelletuali. Questo peraltro rendeva anche
più intenso emotivamente il nostro legame, perché rimaneva un mistero una intesa,
quasi un reciproco affidamento, costantemente attraversato dal presentimento se
non dall’attesa di qualcosa di imprevedibile
e segreto. Era l’incanto, che nasceva dall’essere testimoni affascinati e partecipi di una
inedita contaminazione di lucida razionalità
e geniale dissipazione.
Allora, se non parlerò, se non per laconici accenni, di Rocco Brienza intellettuale,
delle sue scelte politiche, della sua antropopedagogia e delle sue idee filosofiche, riferirò
un’esperienza di segno forte. È come se, invece di cominciare dal principio, cominciassi dalla fine, quella con la F maiuscola. Devo
parlarne serenamente, di questo rapporto di
Rocco con la morte, perché anche lui avrebbe fatto serenamente e perfino giocosamente discorsi di questo tipo. Gli ultimi istanti
di Rocco contraddicono clamorosamente il
detto di Pulcinella napoletano, secondo cui
“altro è parlar di morte, altro è morire”. C’è
un passo di Hegel, forse il filosofo a lui più
caro, che sembra scritto apposta per questa
circostanza: “La vita dello spirito non è nella
vita che ha orrore della morte, perché questo
195
Q
uaderni
rende schiavi della distruzione, ma è nella
vita che sopporta la morte, che si regge in essa
e consente di ritrovare noi stessi in mezzo
all’assoluta dissoluzione”. Rocco è sempre
vissuto dentro questo orizzonte conoscitivo ed emotivo, ma non ha mai fatto considerazioni di questo tipo, a lui pienamente
congeniali, con le parole di Hegel. Uno degli
aspetti più interessanti della sua personalità
era la capacità di tradurre i sistemi filosofici
nelle forme dell’esperienza quotidiana, attraverso le mediazioni di una giocosa aneddotica popolare, che gli era cara, perché era
il mondo concreto di eventi, uomini e cose
che etnicamente gli apparteneva e che amava: capitava così che questo sovrano distacco
nei confronti della devastazione della morte
Rocco lo mettesse in bocca a una vernacolare Cecia, donna libera dei villaggi calabresi,
protagonista di un poemetto, la Ceceide, che
io, sorretto dalla sua complicità, ho sottratto all’immeritato oblio: quella Cecia che,
nell’attraversare il portello che separa la vita
dalla morte, grida ai sopravvissuti che festeggiano e piangono al suo pagano funerale
faraonico: “Io me ne infischio!”.
Era la locuzione che Rocco ripeteva frequentemente, nella sua greve versione dialettale originaria, nei momenti in cui la vita
ci minaccia o ci lusinga con la sua ineludibile illogicità e le sue regole incondivisibili.
Anche nei confronti dell’esperienza suprema, anche nel momento dell’orrore, conservò questo sereno distacco nei confronti della
morte. Quando ci siamo salutati, ci siamo
detti semplicemente che “è stato bello”. Lo
so che è incredibile, ma proprio perché è incredibile, è una cosa di Rocco Brienza.
Ma non c’era soltanto questo hegeliano
sentimento di controllo supremo del male
che incombe e della catastrofe che minaccia.
196
In Rocco c’era un’altra nota che fa pensare
più a Schopenhauer che ad Hegel: la compassione. Compassione verso gli amici, le
persone che amava. Compassione nel senso
etimologico del termine, ossia partecipazione al lutto, elaborazione comune della sofferenza, metamorfosi del dolore attraverso la
solidarietà, la condivisione, il riso e il gioco.
Questo era Rocco Brienza. E la compassione si sposava alla consolazione, perfino nella
forma di un paradosso che si ritrova difficilmente nelle pagine dei filosofi: davanti
alla prova definitiva. in cui si diventa deboli,
indifesi e nudi, non si nega in genere al morente l’attenzione compassionevole che doverosamente gli spetta, ma qui la situazione
è invertita: era Rocco che consolava i vivi
della perdita che li lasciava soli, e non erano
i vivi a consolare Rocco. Come se, da gran
signore qual era, chiedesse scusa per il fatto
che se ne andava. Questa nota di inverosimiglianza attraversa la personalità, la vita, la
storia di Rocco, ed è una delle ragioni più
forti del suo fascino.
Era un uomo che amava l’ordine, le
istituzioni, che voleva sane, incorrotte ed
efficienti; aveva fiducia nella civiltà dei rapporti e delle parole, a condizione che fossero
segno di lealtà e verità; il suo rispetto degli
avversari non era mai inquinato dalla vocazione “mediterranea” alle facili negoziazioni
e ai compromessi. Era, per questo, un diverso, e quando si è diversi si è più esposti alle
rappresaglie del mondo.
Io credo che la storia dell’ultimo Rocco
abbia avuto inizio dai primi mesi del duemiladodici. Lo desumo da una lettera che mi
scriveva e di cui riporto alcune sequenze. Lo
avevo invitato a un convegno sulla disgregazione della società italiana e sulla crisi degli
Stati nazionali: era un invito a nozze per lui,
antropologia e storia
ma mi rispose che ormai le condizioni fisiche e gli impegni di avvocato, ai quali non
poteva venir meno, non gli consentivano di
partecipare. Però aggiungeva pensieri di altra natura, che vale la pena di leggere e che
forse ci danno anche un’idea della sua scrittura “intima”, che è diversa dalla scrittura
di Rocco filosofo e antropologo: “Navigo a
vista, nella nebbia, con un solo faro acceso, di
luce via via più fioca. Non so che dire di più,
di me. Aggiungo, che navigare come un corpo
galleggiante sull’acqua ha le sue dolcezze e che
forse conserva viva la capacità di riflessione,
virtù che ancora conservo. Ma soprattutto
quando sono stimolato dagli amici”.
Rocco era un soggetto passionale ma
al tempo stesso traduceva tutto in lucide
riflessioni. Ora, la riflessione si compie attraverso il linguaggio ed il linguaggio ha le
sue relativamente autonome strategie che in
qualche modo stravolgono pensieri e sentimenti, nella misura in cui li subordinano al
principio della realtà. Anche Rocco plasmava le sue emozioni e calibrava le sue idee in
modo da non turbare l’interlocutore, ma, al
di là di questo minimo di strategia che salva
i rapporti di civiltà e conferma quelli di amicizia, il suo linguaggio era autentico. Aveva
bisogno di amici, perché questo tipo di comunicazione pretende una affinità che non
può non essere elettiva. Rocco amava parlare con gli amici e credo che abbia parlato
nella sua vita soprattutto agli amici; per gli
altri, al massimo, ha scritto. C’è da augurarsi
che abbiano letto.
Di Rocco rimane un ricordo vivido, affidato alla memoria di familiari e compagni.
Un patrimonio amorosamente custodito, e
tuttavia minacciato dall’implacabile scorrere
del tempo, ed esposto ai capricci e all’impre-
/ 2 – comicità e politica
vedibilità della memoria. Bisognerebbe passare da una fase di memoria involontaria, in
cui casualmente ricordiamo di avere amato,
vissuto, desiderato, ad una memoria volontaria, costruita dall’intelligenza e dalla volontà in funzione della durata e del progetto.
Era questo il senso del mio viaggio alla casa
di Elisa e di Rocco. Costruire la memoria di
Rocco Brienza significa recuperare il senso
e la forza di un’esperienza e, al tempo stesso, restituire al valore quello che merita. Io
non so quanto abbia giovato o che cosa abbia
ispirato ad altri l’intelligenza e la genialità di
Rocco, ma sono certo che si è fatto amare
dagli amici per la sua capacità di comprendere e alleggerire la loro fatica di vivere.
Credo che dovremmo cominciare a colmare non poche lacune nella conoscenza di
Rocco intellettuale e politico; per esempio il
suo rapporto giovanile con Olivetti. Rocco
parla di lui proprio nella lettera che ho ricordato, con considerazioni che ha ripreso
anche nei nostri ultimi colloqui. Per quanto
Rocco si dichiarasse marxista, non ho mai
visto in lui un militante del Partito Comunista, mentre l’esperienza dell’autonomismo
personalista di Olivetti si percepisce nel suo
pensiero e credo abbia costituito un elemento fondante della sua prima formazione.
Poi venne Carlo Levi, che ha esercitato una
grande influenza sugli intellettuali meridionali di quegli anni e quindi anche su Rocco.
Si trattò, come si legge in una sua lettera, di
un rapporto non sempre pacifico, segnato
anche da critiche e negazioni. Ma Rocco rifiutava non tanto quello che diceva e scriveva Carlo Levi, quanto quello che Carlo Levi
in Cristo si è fermato ad Eboli indicava come
la “sconsolatezza di Orlando”, l’intellettuale
meridionale di fatto bloccato e reso incapace
di operare, perché tormentato dal senso di
197
Q
uaderni
colpa, la colpa che nasceva dalla convinzione che i meridionali sono inferiori e sono
essi stessi i responsabili dei loro mali.
Rocco Brienza si muoveva in un altro
orizzonte, e andava oltre Carlo Levi, verso
i partiti di sinistra. Come studioso e ricercatore aveva bisogno di una teorica, ed Ernesto de Martino lo aiutò a costruirla. Ecco un
altro rapporto da approfondire. Apprezzava
de Martino perché lo storico delle religioni
aveva dato una risposta alta alla domanda
di un linguaggio per l’antropologia italiana, che nel migliore dei casi aveva toccato
livelli di elegante letterarietà con Alberto
Mario Cirese. De Martino nelle sue indagini
sulla cultura meridionale si era inventato un
linguaggio di indubbia complessità, largamente tributario della filosofia, e credo che
sia stata questa una delle ragioni principali
del suo successo tra gli intellettuali del Mezzogiorno e lo stesso Rocco. Ma, soprattutto,
de Martino gli mostrava i limiti della cultura
umanistica, con la percezione dell’entropia
interna alla vita della cultura e della società
italiana. Se la cultura italiana era segnata –
per usare la teminologia di quegli anni – da
dislivelli culturali, questo poneva un grosso
problema di carattere politico-pedagogico.
Credo che, anche per l’influenza di Raffaele La Porta, Rocco Brienza abbia impostato,
unico tra noi, il problema antropologico e
filosofico in chiave pedagogica. Ha restituito la pedagogia all’antropologia e questo in
quegli anni rappresentava una novità, dal
momento che noi non avevamo un’antropologia dell’educazione. In Italia si sarebbe
parlato di cose simili, e per certi versi identiche, solamente dopo il 1980, cioé dopo
l’arrivo delle prime ondate degli extracomunitari: allora, nella convinzione di avere fatto una nuova scoperta, si è inventata
198
l’intercultura, perché la società italiana da
monoculturale diventava multiculturale. In
realtà la società italiana è stata sempre multiculturale e Rocco Brienza, questo, lo aveva
capito e aveva posto negli anni sessanta gli
stessi problemi di integrazione culturale,
che avrebbero ispirato l’antropologia e la
politica soltanto trenta anni più tardi.
“Tutto ciò che l’uomo intraprende, sia
con l’azione che con la parola o altrimenti,
deve scaturire dall’unione di tutte le sue facoltà: tutto ciò che è separato è da ripudiare”.
Lo ha scritto Goethe nell’elogio di Johann
Georg Hamann quasi due secoli fa, e noi
potremmo ripeterlo in questa evocazione
di Rocco Brienza, perché ne rappresenta la
coerenza tra la parola e l’azione, il pensare
e il sentire, e insieme la tensione a una conoscenza che, per essere tale, non può almeno non aspirare ad essere totale. In questo
spirito si approdò, insieme a Luigi Lombardi
Satriani e me stesso, alla ideazione della collana “Ragioni di confine”, dove il “confine”
non è più la barriera che separa i campi del
sapere, ma il luogo in cui – come scrivemmo nell’epigrafe con le parole di Bachtin – “si
svolge la vita più intensa e produttiva della
cultura”.
Non ho dimenticato il rapporto di Rocco con Francesco Tassone e credo che sia
stata la relazione politicamente più intensa.
Quello che lo affascinava dell’esperienza del
fondatore dei “Quaderni Calabresi” era, prima di tutto, il fatto che egli dedicasse l’intera sua vita alle genti del Meridione, per “far
maturare consapevolmente nelle loro ‘comunitarie’ mani la loro vicenda civico-politica
e, per conseguenza, economico-sociale” (così
ha scritto in una delle sue ultime lettere, a
me indirizzata). Ma, se questo era il progetto, nella concretezza dell’esistere questo
antropologia e storia
comunitarismo si alimentava di una pratica
sociale che all’impegno della crescita civile
associava l’attenzione solidale all’altro, la riscoperta, antropologicamente consapevole,
della cultura meridionale ed il piacere della
familiarità e dell’amicizia. L’orizzonte comunitario di Francesco Tassone era anche,
sotto molti aspetti, quello di Rocco Brienza,
che affiorava incessantemente in mezzo alla
sue discussioni filosofiche e nelle sue divertite narrazioni, come figura di una umanità
da difendere o riconquistare, o come trama
di riposo e di gioco o esemplificazione veritiera dell’appaesamento del mondo.
/ 2 – comicità e politica
Io penso soprattutto a questo, quando
rifletto sulla necessità di fare un lavoro di
approfondimento su Rocco Brienza. Quali
che siano i risultati delle nostre ricerche e riflessioni presenti e future, Rocco Brienza rimane per noi una persona affascinante, che
molto ha dato e nulla ha chiesto, una persona verso la quale dobbiamo esprimere una
grande gratitudine per il suo essere diverso,
per il suo essere nei confronti di tutti, e degli amici in particolare, straordinariamente
generoso.
D.S.
199
Rassegna di studi
Pulcinella. L’eroe comico nell’area euroomediterranea, Università di Salerno, Edizioni libreriauniversitaria.it, Salerno 2016, pp. 430.
In questo volume sono raccolti gli Atti del
Convegno Internazionale: Pulcinella. L’eroe comico nell’area euro- mediterranea, organizzato dal
Laboratorio antropologico dell’università di Salerno, che si tenne a Fisciano e a Napoli nel 2009.
Il testo ripropone i saggi seguendo nell’organizzazione l’impostazione stessa del convegno,
questo contribuisce a far emergere con chiarezza
anche a distanza di tempo quelle che sono state
le linee guida e a confermarne la validità. I temi
affrontati si dispiegano tra più registri e più angolazioni disciplinari, che mirano da un lato a fissare i caratteri universali dell’eroe comico e/o del
buffone e dall’altro le connotazioni e le specificità
locali. Infatti, la prospettiva interdisciplinare con
cui questa tematica è affrontata, avvalendosi dei
contributi dell’indagine antropologica, storica
e filologica, consente di delineare un identikit
dell’eroe comico popolare e allo stesso tempo di
delineare le costanti dell’immaginario comico.
Come chiarisce Scafoglio nella presentazione,
la finalità di questo lavoro è “restituire in una luce
diversa, partendo da Pulcinella, le figure comiche
che godono di un successo popolare, che le trasforma in eroi culturali, incarnazione del genius loci,
del lato solare e di quello oscuro dei loro popoli:
insomma i trickster, discendenti dei “burloni divini”, dei trasgressori sacri cui i popoli riconoscono il
privilegio dell’immunità e che usano il loro potere
per migliorare la vita degli uomini”.
In tale tipologia rientra infatti Pulcinella, così
come appare da un lato nella sua caratterizzazione etnica, che ha dato luogo alla costruzione culturale della maschera, ripresa e rielaborata nel teatro, nell’arte, nel folklore, nel vissuto quotidiano
dei napoletani, cioè in quel determinato contesto
storico-sociale, nel quale acquisisce una sua fisicità e irriducibilità, dall’altro nella universalità dei
tratti che lo accomunano al personaggio comico e
al trickster quale archetipo universale. È intorno
a questa antinomia che si muovono i contributi
del libro a iniziare dalle relazioni di apertura di
Domenico Scafoglio e Luigi M. Lombardi Satriani e dalla postfazione di Simona De Luna.
Come sottolinea Scafoglio, Pulcinella è rappresentato nella Commedia dell’Arte come “il
cafone di Acerra”, esterno quindi all’humus cittadino. Questa sua caratterizzazione, tuttavia, non è
specifica di Pulcinella, ma al contrario è un aspetto ricorrente del personaggio comico, così come è
rappresentato in differenti contesti socioculturali,
questi, infatti, è una figura esterna alla comunità,
viene da fuori, da un altrove, è una figura di confine, ed è proprio questa sua caratteristica che lo
abilita alla trasgressione dell’ordine dominante e a
farsi interprete dei desideri nascosti delle società.
Nel teatro comico gioca un ruolo importante il
contrasto citta/campagna, centro/periferia, identico/diverso, da cui scaturisce la genesi psichica e
culturale del riso.
Sul riso quale elemento fondante del comico, si sofferma Lombardi Satriani, il quale ne
analizza il significato simbolico per sottolineare
come il comico apra alla sistematica irrisione dei
201
Q
uaderni
valori dominanti anche attraverso la funzione
liberatoria del linguaggio, come si realizza nella
pulcinellata. “Lo sciocco fa ridere perchè è figura
liminare, perchè è figura marginale rispetto alla
gerarchia dei ruoli: la figura dello sciocco, dello
stolto, per un verso è colui che mette in scacco i
valori dominanti, per un altro è figura portatrice
di un altro ordine di valori”.
In tale prospettiva, attraverso il riso, suscitato
da Pulcinella, si afferma la irrinunciabile volontà
di vivere e con essa l’ineludibile superiorità della
vita nei confronti della morte, trascendendo la
morte stessa.
Attraverso il comico non solo si ribadisce pertanto la superiorità della vita sulla morte, ma si
svelano anche le menzogne del quotidiano; alla
figura dello sciocco è attribuita questa funzione
disvelatoria, come pone in evidenza Antonino
Buttitta, il quale nel suo contributo, che apre la I
sezione del testo, si sofferma sulla figura del siciliano Giufà: “I personaggi comici e le situazioni
comiche di fatto fanno emergere e esibiscono l’illogicità di quanto riteniamo razionale, l’anomalia
di ciò che viviamo come normale, l’inganno consolatorio della menzogna del nostro quotidiano”.
In questo senso allora acquisiscono un significato
profondo non solo la figura del clown, ma anche la
stupidità di Giufà e soprattutto la simulazione di
alcune figure mitiche, le quali proprio attraverso
la menzogna affermano la verità ultima dell’essere
rispetto all’apparire. (p.33). Alle bipolarità già delineate dentro/fuori, vita/morte si aggiungono così
le altre due: menzogna/verità, apparire/essere.
I contributi che seguono, nel loro differente
articolarsi, risultano accomunati da queste linee
individuate. Si tratterà perciò in questa sede di
tracciare il percorso del testo, poiché non si può
fare menzione dei singoli saggi, se non in modo
sommario e incompleto, data l’ampiezza delle tematiche affrontate.
Il volume è diviso in cinque sezioni, nella prima, Burloni nel mondo, il tema dell’eroe comico
è affrontato ponendone in evidenza l’universalità
e illustrando gli ampi connotati del comico, che
202
non possono essere circoscritti territorialmente;
infatti, le affinità presenti nelle figure del buffone
o del trickster manifestano dei caratteri che vanno
al di là delle influenze e delle specificità storiche.
In questo contesto particolarmente significativi
sono i due saggi dedicati alla figura del personaggio iraniano Pahlavān kačal: Nascita, caratteri e
presenza nei rituali, nella letteratura e nelle arti
dello spettacolo del personaggio Pahlavān kačal di
Hamid Reza Ardalan, Università di Teheran e La
tradizione di Pahlavān kačal e Mobarak nei burattini e nelle marionette popolari in Iran di Poupak
Azimpour Ardalan, Università di Teheran.
Il comico, per le esigenze di carattere universale a cui soddisfa, si pone al di fuori delle coordinate spazio-temporali della civiltà occidentale,
come dimostra la presenza di figure comiche o di
trickster in altri continenti, con caratterizzazioni
che risentono dell’apporto di specifiche tradizioni culturali, come molti saggi evidenziano, tra i
quali, Gli eroi comici nel Mamulengo brasiliano:
Simao, Benedito e Cassimiro Coco di Izabela Costa
Brochado, Università di Brasilia (Brasile); o Paralleli, confronti e contatti tra Pulcinella e il mondo
delle maschere coreane di Kim Mun Young, Università di Daegu (Corea) o Chapayekas y Pascolas.
Imagenes del trickster entre los yoemem de Sonora,
Mexico di Maria Eugenia Olavarria, U.A.M. di
Città del Messico.
Nella II sezione del testo Pulcinelli euromediterranei i saggi delineano la presenza dell’eroe comico nella tradizione delle maschere e del teatro
italiano ed europeo, attraverso la individuazione
di figure nelle quali sono evidenti i rapporti e le
influenze con la maschera di Pulcinella, come nel
caso del francese Polichinelle o dell’inglese Punch (cfr. Punch di Cruikshank e di Collier di Anna
Maria Musilli, Università di Salerno), figure che
attestano dei legami consolidatisi o attraverso la
Commedia dell’Arte o il teatro di figure itinerante, o attraverso altri personaggi comici presenti
nei Carnevali e nelle tradizioni orali. (cfr. Giangurgulo calabrese di Ottavio Cavalcanti, Università della Calabria e Animare un inanimato
antropologia e storia
fantoccio. I ruoli di Pulcinella nel teatro di figura
meridionale di Alberto Baldi, Università di Napoli Federico II). Si delinea così un’area euro-mediterranea riconducibile a un comune archetipo
di tipo pulcinellesco, nella quale può essere compresa anche la maschera dell’iraniano Pahlavān
kačal, a testimoniare della circolazione culturale
di temi e motivi tra Europa, Nord Africa e Medio
Oriente.
Nella III sezione: Metamorfosi odierne del
trickster, è affrontata in modo originale questa
figura attualizzandola, e considerando come sia
presente non solo nell’immaginario fiabesco, ma
anche nei media della contemporaneità e in figure come Shrek o Joker (cfr. Il trickster e l’infinito.
Un esempio rom di Leonardo Piasere, Università
di Verona e Joker, ovvero il riso perverso di Annalisa Di Nuzzo, Università di Salerno).
In particolare è analizzato come la figura del
trickster in tempi dominati dall’antipolitica possa
assumere nuove valenze sino a esercitare un’influenza profonda nel rapporto dei cittadini con la
politica, come dimostra il moltiplicarsi di comici prestati alla politica e di politici che attraverso
comportamenti comici si presentano come violatori di tabù e con questi atteggiamenti ritengono
di manifestare la loro vicinanza al popolo. (Cfr.
Berlusconi as trickster di Francesco Bruno, Università di Salerno e Un trickster contro: Beppe Grillo di
Patrizia Del Barone, Università di Salerno).
Nella IV sezione Radici del comico risalta
come il comico, per le esigenze di carattere universale a cui risponde, sia presente sin nei testi sacri (Biblia ridens. Il comico nelle Sacre Scritture di
Angelomichele De Spirito, università di Salerno)
e in quelli dell’antichità: se ne possono, infatti, individuare tracce nella cultura italica preromana e
delineare percorsi ed esiti in prodotti letterari e
teatrali che attraversano la tradizione medievale,
il mimo, l’opera buffa napoletana, sino alla maschera moderna.
Nella V sezione La città divisa l’analisi ritorna su Napoli e la figura di Pulcinella, ma dopo
questo lungo viaggio la connotazione locale del-
/ 2 – comicità e politica
la maschera trova una nuova luce. Infatti è dopo
aver subito un processo di sprovincializzazione,
che la maschera viene ad acquisire un rinnovato
spessore etnico e si può analizzare come questo
personaggio sia divenuto oggetto di investimento
emotivo e di immedesimazione, da parte del popolo napoletano, ma anche di profonda ambivalenza e di negazione, in un’oscillazione di modelli
di napoletanità negativa e/o positiva. L’oggettistica è un ambito molto interessante per individuare
il modo in cui i napoletani raffigurano Pulcinella,
indulgendo tra stereotipi e temi innovativi (Nel
distretto dei Pulcinella: la maschera e l’immagine
di Napoli, di Gianfranca Ranisio, Università di
Napoli Federico II). A questo proposito Gian Luigi Bravo (Pulcinella in mostra) illustra la ricognizione con finalità didattiche che ha operato delle
sfaccettature materiali e immateriali di Pulcinella, così come si manifesta nel presente, nelle sue
espressioni teatrali, figurative e nell’oggettistica.
La postfazione di Simona De Luna riprende
le ipotesi teoriche sulla genesi della figura, le ridiscute ricollegandosi alle teorie di Dieterich, e alla
psicoanalisi di Jones, soffermandosi sulla teoria
del briccone divino di Kerenyi, Radin e Jung, sino
ai più recenti studi di Fontana. Questi, da artista,
attraverso l’intuizione, giunge a descrivere Pulcinella come l’anima segreta della società italiana,
riportando dentro l’analisi l’esperienza del vissuto, da cui la visione archetipica della psicoanalisi
si era distaccata, ridando così uno spessore etnico alla maschera, tuttavia, questa interpretazione,
per quanto suggestiva, rischia di operare delle
semplificazioni, come sottolinea l’antropologa,
riproponendo così la tesi iniziale dell’universalità
dell’eroe comico.
In questo modo le tematiche affrontate nella postfazione si ricollegano a quelle che erano le
prospettive teoriche iniziali, che appaiono convalidate e confermate dai saggi presentati nel volume.
Per questi motivi questo volume rappresenta
una tappa fondamentale nella riflessione teorica
sull’eroe comico e su Pulcinella quale prototipo
dell’eroe comico, così come si è venuto a conno-
203
Q
uaderni
tare in un determinato contesto storico-culturale.
In questo modo e secondo tale prospettiva si viene a creare una continuità tra queste elaborazioni
teoriche e le manifestazioni attualmente in corso
per la candidatura della maschera di Pulcinella,
nella lista dei Beni culturali Immateriali protetti
dall’Unesco.
Gianfranca Ranisio
G. Agamben, Pulcinella ovvero Divertimento per
li ragazzi, Roma, Nottetempo, 2016.
Indifferente agli orientamenti degli studi, che
negli ultimi lustri hanno rinnovato la percezione
intellettuale di Pulcinella e delle figure similari, il
filosofo Giorgio Agamben identifica l’eroe comico
con il messaggero che, seduto sulle macerie di un
mondo, annuncia l’avvento di una nuova stagione
della storia umana. Il motivo è antico, anche se ora
lo vediamo ritornare nella saggistica filosofica, con
esplicito riferimento a Pulcinella. Lo aveva enunciato già più di mezzo secolo fa un grande filosofo-mitologo come Kerényi, a proposito dell’ambivalenza incarnata dal trickster e riproposta nel suo
sdoppiamento nelle due figure che egli ricompone
al di là del tempo e della storia, il greco Ermes e
l’amerindo Wakdjunkaga: entrambi partecipano
della natura fallica e di quella di psicopompo e
guida dell’anima: ma ”I bricconeschi giochi di Ermes con la morte nell’ambito dello spettrale sono
una cosa, e la sua funzione tranquillizzante di guida dell’anima sono un’altra cosa. Un dio rappresenta l’origine di un mondo, e il mondo significa
ordine. Ermes apre le vie, Walkdjuncaga l’eterna
scena fliacica in mezzo alle strutture in mutamento delle civiltà in fase di estinzione”. Marx aveva
già preparato tutti alla giusta comprensione di
quest’idea che i pensatori sembrano aver rubata ai
poeti, che per riconoscimento unanime hanno il
dono della preveggenza: “L’ultima fase di una forma storica è la sua commedia. Gli dei della Grecia,
che già una volta erano stati tragicamente feriti
a morte nell’opera di Eschilo, dovettero una se-
204
conda volta morire comicamente nei dialoghi di
Luciano. Perché questo corso della storia? Perché
l’umanità si separi gioiosamente dal suo passato”
(K. Marx, Introduzione alla Critica della filosofia
del diritto di Hegel).
È più di un secolo che l’alta cultura occidentale si confronta con Pulcinella (o con quello che
essa immagina di Pulcinella), per strappargli il
segreto della vita e il senso della morte. Si può anche essere scettici sull’attendibilità di alcune analisi più recenti, spesso seducenti, seppure incerte
tra la fascinazione del profondo e la levità del divertissement, tra la riscrittura e la contraffazione,
l’immedesimazione e l’involontaria parodia, tra il
logorroico (pulcinellesco) argomentare sul vuoto
e prevaricazione dell’autobiografismo associato
alla disinformazione (inevitabile, se si pensa che
il confronto dovrebbe essere – ma non lo è stato quasi mai – con più di quattro secoli di storia
della pulcinellata napoletana, italiana ed europea, e la conoscenza almeno in casi come questo
non si costruisce soltanto sulla base di sintomi e
campioni ridottissimi). Intanto, non si può non
riconoscere che, per essere fatto oggetto di tanta
attenzione, qualche merito, oltre quello di ispiratore, il Pulcinella reale deve averlo avuto. Specie
quando di lui si sono occupati uomini di scienza
e di pensiero che hanno fatto la cultura europea
degli ultimi due secoli: Croce, Freud, Jones, Jung,
Lacan. Ma poi, come dissentire del tutto da questo modo di leggere Pulcinella, se la contaminazione con l’oggetto di studio non è solo un buio
“essere afferrati”, perché aggiunge alla riflessione su quello che la maschera ha rappresentato,
l’esperienza del vissuto personale e la possibilità
di conoscere la vita con la vita? Anche se questo
non basta a distrarci dal fatto che le riflessioni
dell’autore sembrano fondarsi quasi esclusivamente sulla conoscenza di un’unica opera, che
non appartiene neppure al teatro di Pulcinella
(che, insieme al Carnevale, è la vera casa della
maschera napoletana), ma alla storia dell’arte che
si è ispirata a Pulcinella, ossia al ciclo dei disegni
che Domenico Tiepolo gli ha dedicato.
antropologia e storia
Si legge nel risvolto della prima pagina di
copertina che, “come Tiepolo alla fine della sua
vita, così Agamben sembra annodare nella figura
enigmatica di Pulcinella i vari fili del suo pensiero
in una sorta di immaginaria autobiografia filosofica”. Non so quanto del pensiero di Agamben
ci sia nel volumetto (a parte – per sua esplicita
ammissione – le preoccupazioni dell’incipiente,
minacciosa vecchiaia e le delusioni dei quattro
amici al bar / che volevano cambiare il mondo),
ma so con certezza che di quello di Pulcinella c’è
poco, o, per lo meno, poco di nuovo, rispetto ai
luoghi comuni più scontati, ma rispetto soprattutto alle molte sorprese che una lettura rigorosa
e amorevole di oltre un migliaio di testi (“pulcinellate” di ogni genere) ancora può riservarci. La
lunga vita della maschera napoletana si conosce
attraverso i testi della sua storia teatrale, disseminati e dispersi in numerose biblioteche italiane
dal Seicento ai nostri giorni e attraverso quello
che rimane, ancora vivo, delle innumerevoli rappresentazioni teatrali e carnevalesche degli stessi
secoli. Di tutto questo non c’è traccia nello scritto del filosofo Agamben. Ci sono invece poche e
brevi sequenze testuali che non sono estrapolate
dai testi pulcinelleschi, ma risultano scritte in
italiano dallo stesso autore del volumetto e poi
tradotte in napoletano da un sodale.
Il Pulcinella di Agamben viene quasi esclusivamente dalle tavole di Tiepolo. Ma i disegni di
Tiepolo rimangono un enigma, se non si ricostruisce intorno a loro (ma anche intorno all’intera presenza di Pulcinella nella cultura e nella vita
di piazza della Venezia del tempo) il contesto etnografico, di cui sono totalmente privi, e se non si
possiedono altre informazioni storiche necessarie
per interpretarli, il che significa che un approccio
al “Divertimento” di Tiepolo implica una conoscenza approfondita dell’universo pulcinellesco e
della sua densità realistica e simbolica. Gli studi
storici almeno sono approdati a qualche buon risultato, di cui il filosofo si è servito per istituire la
connessione della genesi dei disegni con l’infamia
di Campoformio, che fornisce un prezioso sup-
/ 2 – comicità e politica
porto alla sua tesi secondo cui Pulcinella compare o sopravvive alla fine di un mondo.
Il problema allora è esattamente questo: si
conosce il Tiepolo del “Divertimento”, se si conosce Pulcinella, in caso contrario si finisce con
l’inventare l’uno e l’altro. Il filosofo ha appreso
alcune notizie dalla saggistica pulcinellesca, che,
a giudicare anche dalle opere elencate nella sua
bibliografia, conosce (e riconosce) in minima
parte, col risultato di avventurarsi senza le dovute conoscenze e competenze in un mondo complesso, di cui non possiede le chiavi di lettura. Lo
dimostrano alcuni errori clamorosi, che anche
un conoscitore superficiale della maschera napoletana avrebbe evitato: che il “camiciotto” bianco
indossato dalla maschera significhi che Pulcinella
non ha avuto un passato (p. 13) non trova nessuna conferma nelle tradizioni pulcinellesche; che
di Pulcinella non si veda il sorriso per via della
maschera (p. 13) è una clamorosa sciocchezza,
perché la maschera nera (il “lupo”) copre il viso
fin sotto il naso, ma lascia scoperta la bocca, che
è in grado di esprimere – lo ha dimostrato De Filippo in uno splendido filmato – non solo il sorriso, ma anche il pianto, la rabbia, la minaccia,
la fame. Come se non bastasse, l’autore arriva a
correggere Benedetto Croce, che era anch’egli filosofo (come era storico, letterato, filologo ecc.),
ma queste cose le conosceva: “la descrizione è
inesatta: in verità il coppolone non è a punta, ma
è un cono mozzato” (p. 58). Invece la descrizione
di Croce è esattissima, perché il coppolone rigido
tronco dell’apice è lo sviluppo di una tipologia
veneto-germanica di coppolone, forse influenzato dal Pulcinella Coleçon, venuto a Venezia dalla
Francia nei primi anni del Settecento, ed è raro
nel resto delle regioni italiane.
Ma gli azzardi non finiscono qui. Il filosofo scrive che “il gesto dell’attore moderno che,
come Eduardo De Filippo, dopo aver recitato
la sua parte, si toglie la maschera o la fa risalire
sulla fronte è, per Pulcinella, semplicemente impossibile” (p. 61). In realtà, la tradizione rigorosamente da sempre pretende, al contrario, che gli
205
Q
uaderni
attori si mostrino al pubblico col vero volto, una
volta finita la commedia: alla fine di ciascun atto
o a scena aperta, al momento del ringraziamento
o del congedo, l’attore avanzando al proscenio “si
toglie il cappello col consueto inchino e solo allora, al grido immancabile maschera, maschera, che
viene dalla platea, egli afferra il lupo per il naso e
lo lascia adagiare sulla calotta nera che riveste il
cranio, su ci è fissato da apposite molle”. Al filosofo è sfuggita la complessità del gesto di De Filippo,
il quale pone fine a questo rituale, perché nella sua
ottica la maschera, anacronistica menzogna, non
ha più diritto all’esistenza teatrale. Infatti egli “ad
applauso esaurito, invece di abbassarla per entrare poi nella finzione scenica, se la toglie completamente come per liberarsi di un oggetto che gli dà
fastidio” (Andersen 1931, p. 249).
Altre volte si dice che Pulcinella viene processato e condannato nella descrizione di un carnevale conservata in “un manoscritto di una farsa
calabrese” (p. 67). In realtà la notizia si trova non
in un manoscritto, ma in un libretto del folklorista Lumini, anche se il filosofo l’ha attinta da
qualche citazione. Infine si legge nel volumetto
che Pulcinella è “apolide” perché “senza città” (p.
72), laddove la maschera ha una città, Napoli, di
cui è diventato simbolo nella coscienza propria
e di tutta l’Europa (ne ha anche un’altra, Acerra,
ma questa è un’altra storia).
Ci fermiamo qui – ma potremmo continuare – perché già questi esempi ci sembrano sufficienti a dimostrare uno scarso dominio di una
materia di cui l’autore del volumetto ha sottovalutato le difficoltà. Quanto poi al suo pensiero,
che egli dichiara di condividere con Pulcinella,
l’idea che sembra attraversare il libretto è che
“nella vita degli uomini … la sola cosa importante è trovare una via d’uscita. Verso dove? Verso
l’origine. Perché l’origine sta sempre nel mezzo,
si dà solo come interruzione. E l’interruzione è
una via d’uscita” (p. 45). Poco prima il filosofo
aveva spiegato la parabasi della commedia antica
come “un’interruzione o una deviazione”, ossia
“un’interruzione in cui di colpo appariva l’origi-
206
ne … un’origine che si manifestava infrangendo
o scompaginando … lo svolgimento scontato
dell’azione” (p. 45). La parabasi infatti nella sua
dotta spiegazione “significa l’atto di camminare
di lato, deviare”. Ora, se la ricerca e la pratica
della via d’uscita sta ad indicare la ricomposizione di “ciò che era in origine: Komos, un allegro,
tumultuoso, insolente corteo dionisiaco” (p. 45),
il fondamento concettuale di tanto sfoggio di raffinata quanto scontata erudizione non aggiunge
nulla a quello che si è ripetuto da qualche secolo sulla natura dionisiaca dell’esperienza pulcinellesca. Altre volte però la via d’uscita sembra
essere piuttosto la rinuncia all’azione, che sarebbe la sostanza politica della figura di Pulcinella.
Secondo Agamben Pulcinella non è impolitico,
perché questa è la sua politica, nell’impossibilità
di agire altrimenti; egli “testimonia, ogni volta,
che non si può agire l’azione né dire la parola –
che, cioè, vivere la vita è impossibile e che questa
impossibilità è il compito politico per eccellenza”
(p. 72). Anche questo è un luogo comune delle
letture che oggi si dànno della condizione umana della Napoli contemporanea esemplate nella
figura di Pulcinella. Sinonimi della via d’uscita
sono l’“uscita di emergenza” e la “fuga dal mondo” che si ritrovano, con un ben altro senso della
frealtà, nelle opere di Manlio Santanelli, autore
dell’ultima, importante pulcinellata contemporanea: “I tempi, adesso, sono diventati troppo
duri, di una durezza incontrastabile. La fantasia
non permette più di sognare la felicità o il riscatto; lascia solo la possibilità di coltivare le proprie
frustrazioni” (“Poltronissima”, 12, p. 15).
(D.S.)
Domenico De Masi, Mappa mundi, Rizzoli, 2014
Anche se parte dalla ricognizione dei grandi modelli di civiltà che hanno fatto la storia del
mondo, la preoccupazione del sociologo è quella
di dare un senso al disagio, che è insieme paura
e disorientamento, che stiamo vivendo in questi
antropologia e storia
anni corrosi da una crisi che sembra inarrestabile.
Una crisi che scaturisce dal tramonto dei grandi sistemi teorici e politici degli anni più recenti. Se ci è
consentita una delle principali semplificazioni del
libro, il comunismo ha perduto, ma il capitalismo
non ha vinto. Il comunismo sa distribuire ricchezza, ma non la sa produrre; il capitalismo produce
ricchezza, ma non la sa distribuire. Conseguentemente il capitalismo accentra in poche mani i beni
del pianeta, ma questo accentramento produce
il crollo dei consumi, provocando la crisi che sta
cambiando le condizioni di vita in tutto il mondo.
Il problema centrale per lo studioso è l’assenza
di un nuovo modello organizzativo. Esso deve partire dalla necessità di ridurre le disuguaglianze, la
sola precondizione perché si possa realizzare una
inversione di tendenza. Tendenza che De Masi,
nonostante il suo ottimismo di fondo, descrive
in questi termini: nella società postindustriale, in
cui il lavoro materiale è affidato alle macchine, si
sono create le condizioni per sviluppare il lavoro
creativo, che a sua volta creerà le risorse per una
umanità finalmente affrancata dal lavoro e capace di realizzare l’aspirazione alla felicità collettiva.
In realtà nelle condizioni attuali e in quelle che si
vanno delineando il lavoro creativo è una prerogativa per poche persone, mentre si va formando
una massa sterminata di senza lavoro, spesso notevolmente acculturata, soprattutto nell’informatica
e nelle lingue, che tuttavia non è né borghesia, né
proletariato, né sottoproletariato, e il cui futuro è
drammaticamente a rischio.
Come uscire allora dalla crisi? De Masi condivide la teoria che attribuisce la causa del disastro alla decadenza delle rappresentanze, alla
inadeguatezza e alla corruzione del ceto politico,
ma aggiunge un elemento di novità che possiamo dire inedito: i politici hanno fallito, perché gli
intellettuali non hanno fornito alla politica delle
basi teoriche capaci di cogliere il senso delle trasformazioni, ed elaborare una nuova progettazione, un nuovo modello di vita, come è avvenuto nel
passato: De Masi individua alle spalle dei grandi
modelli di società dei secoli precedenti le idee e
/ 2 – comicità e politica
le elaborazioni teoriche di grandi intellettuali che
hanno orientato la storia, con il loro pensiero e
spesso col sacrificio della loro vita; laddove nel
pensiero “liquido” o “debole” dei nostri giorni
egli individua una confusa frammentazione, che
impedisce una visione critica della realtà e ostacola la progettazione di nuovi modelli di società.
Questa ci è sembrata l’ossatura etico-politica
dell’analisi, che attraversa la ricca e densa rassegna dei modelli di vita che la storia del pianeta
consente di registrare, quindici dei quali vengono da De Masi analizzati con un lavoro, che unisce il rigore e la compiutezza dell’analisi al colpo
d’occhio dello scrittore che opera sintesi limpide,
efficaci e coinvolgenti. Lo scopo di questa ricognizione è capire come i vari popoli hanno dato una
risposta al bisogno universale e legittimo di felicità collettiva, analizzare i mezzi e le risorse con cui
hanno organizzato la loro società, le soluzioni che
hanno saputo trovare, per scartare la parte obsoleta del loro modo di stare al mondo e far tesoro dei
risultati positivi che hanno conseguito: con questi
elementi accuratamente selezionati gli intellettuali, nell’auspicio di De Masi, elaboreranno un
modello nuovo, finalmente capace di assicurare il
diritto di tutti alla felicità. Il mondo nuovo che De
Masi vorrebbe realizzare, è quello che si desume
dalle sue domande, alle quali egli stesso risponde,
mescolando scienza e utopia, lucidità e passione, verità e bellezza: “Come vincere il dolore, la
malattia, la morte? Come debellare la miseria e la
fatica? Come eliminare l’ignoranza, la noia, la solitudine? Come liberarsi dai lacci della tradizione
e dalla violenza dell’autoritarismo? Come ingentilire la rozzezza e abbellire la bruttezza?
Anna Maria Musilli
“Il Bruzio” di Vincenzo Padula, nuova ristampa
anastatica, Cosenza, Rubbettino, 2011.
Una delle opere alle quali maggiormente è legata la fama di Vincenzo Padula è Il Bruzio, foglio
bisettimanale uscito nel biennio 1864/65, ideato,
207
Q
uaderni
curato e scritto quasi interamente dall’antropologo calabrese. L’edizione che qui viene presentata,
con saggi introduttivi di Giuseppe Galasso, Luigi
Maria Lombardi Satriani e Domenico Scafoglio,
è stata pubblicata dall’editore Rubbettino di Soveria Mannelli nel 2011, con il patrocinio della
Fondazione Vincenzo Padula. Non si tratta di
un’edizione critica, bensì di una ristampa anastatica, che tuttavia offre due strumenti di notevole
importanza per lo studioso di cose paduliane: un
indice dei nomi e un repertorio completo degli
argomenti trattati nel Bruzio. Entrambi questi
apparati sono a cura di Domenico Scafoglio, tra i
maggiori esperti dell’opera di Padula.
La ristampa anastatica di tutti i numeri de Il
Bruzio esce non casualmente in concomitanza
con il centocinquantesimo anniversario dell’unificazione nazionale italiana. Con questo giornale,
infatti, Padula intendeva dare il suo contributo
politico e intellettuale al consolidamento del neonato Stato unitario: pubblicato con il supporto,
più o meno esplicito, dell’allora prefetto di Cosenza, Guicciardi, Il Bruzio doveva avere, nelle
intenzioni del suo ideatore, il compito di stimolare una politica di rinnovamento e di riforma utile
a far uscire la Calabria e il Mezzogiorno dalla loro
condizione di miseria atavica. Proprio perché il
fine del giornale era lato sensu politico, lo sforzo
di Padula non fu di carattere meramente conoscitivo e/o intellettuale; allo stesso modo, tuttavia,
non bisogna pensare che si trattasse di uno sforzo
politico in un senso riduttivo: il progetto di riforma sociale immaginato da Padula doveva infatti
basarsi su un’indagine conoscitiva di alto livello,
capace di produrre una visione della cultura e
dell’economia del territorio di una complessità
tale da non poter essere, semplicemente, schiacciata sulle politiche del governo.
La ristampa de Il Bruzio, come si diceva in
apertura, è preceduta dai saggi critici di Giuseppe Galasso, Luigi Maria Lombardi Satriani
e Domenico Scafoglio. Val la pena ripercorrere
brevemente questi tre saggi, perché essi, ciascuno
dal suo peculiare punto di vista, restituiscono il
208
senso, non esclusivamente filologico, dell’impresa di una ripubblicazione del periodico curato da
Padula.
Il saggio di Galasso, intitolato Padula: «Il Bruzio» (pp. 7-21), tenta di ricostruire il quadro storico nel quale si inserisce il lavoro di Padula. Lo
scopo fondamentale perseguito da Padula con la
pubblicazione de Il Bruzio sarebbe stato definire
i problemi economici e sociali dell’Italia meridionale nell’ambito del nuovo Stato nazionale. Ciò
porta subito l’autore a sottolineare la vicinanza
di Padula alla politica seguita dal prefetto di Cosenza, Guicciardi, e dunque la sua contiguità al
progetto politico e culturale della destra al governo, che non fu comunque mai tale da provocarne
una perdita di indipendenza e di autonomia di
giudizio rispetto alle scelte del governo. Il Bruzio
poteva configurarsi, sotto questo riguardo, come
un ‘giornale delle buone cause’, a prescindere dalle etichette – progressismo, conservatorismo e
quant’altro – sotto le quali potessero essere rubricate le iniziative politiche sostenute dal periodico.
Proprio perché intenzionato a promuovere una
concreta azione di carattere politico-culturale, Il
Bruzio fu, certo, un giornale politicamente schierato, e tuttavia non fu soltanto questo, giacché suo
fine ultimo era quello di essere una sentinella per
contrastare l’arbitrio del potere nonché di costituire uno stimolo per la rinascita civica della Calabria e del Meridione: si avrebbe qui a che fare,
dunque, con una concezione pienamente moderna del giornalismo, inteso come luogo di costruzione della pubblica opinione e della coscienza
civica. Per questo suo carattere di ‘giornale delle
buone cause’, osserva Galasso, il Bruzio non ha
una vera e propria struttura tematica, ogni tema
essendovi trattato in maniera discontinua ed irregolare, anche se ciò non toglie che vi si possano
ritrovare nuclei tematici ricorrenti: la politica interna ed internazionale, la questione ecclesiastica,
le condizioni socioeconomiche della Calabria, la
parte letteraria, contenente le poesie e le prose
dell’acrese. In definitiva, Il Bruzio fu «un giornale
notevole per i suoi numeri tecnici e professionali
antropologia e storia
nel quadro non solo di un giornalismo minore o
provinciale» (pag. 15). Galasso tratta, infine, dei
motivi che condussero alla chiusura de Il Bruzio,
proponendo una serie di osservazioni e di congetture (motivi economici, interessi personali e
locali di cui non abbiamo contezza, il mancato
sostegno della Prefettura, ormai meno interessata
a sostenere un giornale che le aveva procurato, in
definitiva, più problemi che vantaggi), nessuna
delle quali pare però potersi ritenere dirimente
la questione. Il saggio si chiude (pp. 19-21) con
una sorta di ritratto delle idee politiche, religiose,
economiche, morali del Padula.
Il saggio di Luigi Maria Lombardi Satriani,
dal titolo Miseria e bellezza: lo sguardo antropologico di Vincenzo Padula (pp. 23-29), si concentra
sul Padula demologo, ascrivendo a merito dell’abate calabrese l’avere, per primo, rilevato come il
mondo popolare non fosse un blocco monolitico,
bensì un insieme al suo interno complesso, che
va colto nelle sue numerose articolazioni, elencando i mestieri, descrivendo analiticamente le
consuetudini, l’alimentazione, il bestiame. Questo sforzo conoscitivo non aveva solo una valenza
classificatoria e tassonomica, ma era, piuttosto,
propedeutico ad una comprensione profonda del
mondo popolare, che non può aver luogo senza
una indagine insieme di carattere sociologico
ed antropologico, nella quale includere perfino
argomenti insoliti o ‘scottanti’ per la morale del
tempo, come, per esempio, quello dell’eros popolare. Ed è proprio questa conoscenza approfondita, con il quadro ‘realistico’ che ne deriva, del
mondo popolare, a costituire la base per il riformismo politico di Padula, ben consapevole che
solo un miglioramento delle misere condizioni
di vita delle campagne avrebbe potuto dar luogo
ad un autentico progresso civile e morale della
Calabria. La cifra complessiva del pensiero di
Padula sarebbe, dunque, la «libertà di pensiero,
l’accettazione di qualsiasi avventura intellettuale
ovunque essa possa condurre» (pag. 29), tanto
che tutta la sua opera avrebbe un carica ‘eretica’.
Ciò spiegherebbe anche la sua difficoltà ad essere
/ 2 – comicità e politica
‘assimilata’ dalla demologia e dal meridionalismo
successivi, con l’eccezione – notevole – di Giustino Fortunato, tra i pochi a riconoscere il suo
debito nei confronti dell’antropologo calabrese.
Tale situazione non impedisce, tuttavia, a Lombardi Satriani di mostrare come l’opera di Padula
si inscrivesse in un clima nel quale trovarono origine operazioni culturali che si muovevano nella
medesima direzione, quali quelle di Francesco de
Boucard, Renato Fucini, dei fratelli Mastriani.
Il saggio di Domenico Scafoglio (Gli scritti
demoantropologici, pp. 31-58) si presenta come
il più consistente dei tre, non solo dal punto di
vista quantitativo, ma anche perché è l’unico a
disegnare a tutto tondo la figura del Padula intellettuale e politico. Scafoglio mostra come gli
interessi demologici di Padula risalissero agli
inizi della sua produzione intellettuale, e come
essi avessero rappresentato, per molti anni, il file
rouge della sua ricerca e del suo impegno politico. Sotto questo punto di vista, l’opera di Padula
negli anni de Il Bruzio segnò un momento eccezionale della demologia italiana, «perché, per un
verso, l’indagine paduliana sul mondo popolare
si subordinò a un ambizioso progetto di rinnovamento civile e morale, per un altro verso l’impegno civile conferì alla ricerca demoantropologica
un’ampiezza di prospettive e una tensione etico-politica che non avrebbe trovato riscontro negli studi demologici dei decenni successivi» (pag.
32). Il saggio di Scafoglio è poi anche quello che
presenta la risposta più articolata relativamente
ai motivi per i quali la battaglia de Il Bruzio si
avviò al riflusso dopo il 1865: le cause andrebbero cercate nel fallimento di quel progetto riformista che Padula propugnava e che egli si era
illuso di poter vedere realizzato grazie all’opera
del prefetto Guicciardi. In realtà, il riformismo
del demologo non trovava soverchie simpatie nel
governo, che ormai, sulla questione demaniale, si
andava sempre più orientando verso un accomodamento con i grandi possidenti e sempre meno
verso la redistribuzione delle terre auspicata dal
nostro. Inoltre, l’amministrazione procedeva
209
Q
uaderni
a tappe forzate verso un accentramento amministrativo al quale Padula non era favorevole.
L’unificazione nazionale, dunque, non solo non
risolveva gli atavici problemi delle campagne
calabresi, ma anzi ne acuiva alcuni, per esempio
quello del brigantaggio, da Padula visto come un
prodotto della miseria, dell’oppressione dei ‘galantuomini’ nelle campagne e della pratica degli
arresti facili: in un certo senso, il brigantaggio
era una conseguenza di una guerra che «i ricchi
facevano ai poveri e i reazionari al nuovo stato
liberale» (pag. 43). Scafoglio mostra allora come
il modello di Stato immaginato da Padula fosse
fondato sulle autonomie comunali piuttosto che
sull’accentramento dei poteri nelle mani dello
Stato centrale; le unità fondamentali di questo
tipo di Stato dovevano essere – più che le regioni
– le province, quali realtà relativamente omogenee «per struttura, cultura e lingua» (pag. 46). Il
saggio si chiude poi con un capitolo dedicato alla
Socioantropologia dei mestieri e dei paesi, dove
Scafoglio descrive con grande dovizia di particolari le analisi paduliane sui mestieri, gli usi, i
costumi e le tradizioni della Calabria. I mestieri,
in particolare, vengono indagati molto dettagliatamente, sia sotto un profilo socioeconomico che
sotto un profilo socioculturale ed etnografico: ne
vengono descritte tipologia, condizioni materiali del lavoro, condizioni di vita (alimentazione,
casa), condizioni culturali e struttura familiare. Ne deriva un affresco variegato e dettagliato
della realtà sociale dei paesi del cosentino, dove
grande centralità acquista la lingua del popolo,
che non solo è – vichianamente – poetica nella
sua vitalità e immediatezza, ma è anche rivelativa di un certo ordine culturale e di una certa
interpretazione del mondo vigente all’interno
di una determinata comunità. Tutto questo forma l’‘indole’ della comunità, che Padula collega
all’organizzazione sociale, talché l’analisi «tende
a spostarsi […] dalle persone e dalle categorie
sociali all’insieme dell’organizzazione del lavoro» (pag. 50). Queste osservazioni consentono
a Padula di interessarsi anche all’aspetto dei vil-
210
laggi calabresi, delle case, dei paesi e delle terre:
«Il taglio prevalente è storico-sociologico, con
una attenzione alla dimensione simbolica dello
spazio […] Una metodologia olistica, che induce a cercare relazioni significative perfino tra le
narrazioni mitologiche e la forma delle dimore»
(pag. 51). Il saggio di Scafoglio riesce, dunque, a
trattare temi diversi, il cui filo conduttore sembra
essere il legame posto da Padula tra conoscenza
del territorio e delle identità locali e possibilità
di varare politiche autenticamente riformiste:
«Nei suoi scritti calabresi Padula aveva creato
una felice sintesi di inchiesta sociale, indagine
antropologica e tematiche meridionaliste, cui la
dimensione operativa conferiva concretezza, forza e scottante attualità» (pag. 34).
A queste ultime parole di Scafoglio chi scrive
crede debba ricollegarsi il senso di una impresa
editoriale come quella della riedizione de Il Bruzio.
Il nesso, così lucidamente individuato da Padula,
tra dimensione politica e dimensione conoscitiva diviene, infatti, attualissimo, quando si pensi
alle divisioni che ancor oggi percorrono un paese
come l’Italia che, dai tempi della sua unificazione,
non ha ancora saputo elaborare una sintesi tale da
consentire uno sviluppo economico e culturale
omogeneo sull’intero territorio nazionale. La crisi attuale dello Stato/nazione, non solo in Italia,
così come quella delle istituzioni sovranazionali
(si pensi, in questo senso, alla crisi di consenso
da cui sono investite, un po’ ovunque, le istituzioni europee) riporta perciò decisamente in auge la
diagnosi paduliana, secondo la quale sarebbe stata
opportuna la costituzione di una nazione di popoli
e di uno Stato delle autonomie, piuttosto che quella di uno Stato accentratore, calibrato sul modello
burocratico francese e bonapartista. L’aver posto,
con intelligenza e tempismo, questi temi sul tavolo, rappresenta, mi sembra, il merito principale di
coloro che hanno reso possibile, con una nuova
edizione de Il Bruzio, una più ampia circolazione
delle idee innovative e, per certi versi, rivoluzionarie di Vincenzo Padula.
Luigi Imperato
Notiziario libri/eventi
Reseña del V Congreso Internacional de Mitos
Prehispánicos en la Literatura Latinoamericana
El “V Congreso Internacional de Mitos
Prehispánicos en la Literatura Latinoamericana.
Reflejos del pasado: visiones multidisciplinarias”
se celebró en Morelia, Michoacán, México, en los
días del 4 al 7 de noviembre del 2015. El evento
tuvo como sedes el Campus Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
y el Centro Cultural UNAM Morelia. En él se
dieron cita más de cincuenta distinguidos investigadores de distintos países como Argentina,
Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Francia,
Inglaterra, Perú, Suiza, entre otros. Las exposiciones se organizaron en cuatro conversatorios y tres
conferencias magistrales, diez mesas de análisis,
cuatro presentaciones de proyectos y cuatro
eventos culturales. Entre las personalidades más
prestigiadas que asistieron al evento estaban Jacques Galinier, Patrick Johansson, Alfredo López
Austin, Luis Millones, Martin Lienhard, Oswaldo
Chinchilla, Silvia Limón y Ástvaldur Ástvaldsson, entre otros.
El Congreso se inauguró en presencia de las
autoridades administrativas de las instituciones
participantes y posteriormente se rindió un homenaje a Librado Silva Galeana, distinguido investigador de la cultura y la lengua náhuatl. En
seguida tuvo lugar el primer conversatorio magistral, uno de los más esperados y con mayor
audiencia, titulado Mitos del norte, mitos del sur.
A continuación presentamos una breve reseña
de esta charla y de algunas otras que tuvieron
lugar en el Congreso. Cabe destacar que todos
los conversatorios, las conferencias y las mesas
se encuentran disponibles para su consulta en la
dirección electrónica: http://lmo.culturaspopulares.org/congresomitos/memorias.php
En el primer conversatorio magistral participaron Alfredo López Austin, investigador
emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y Luis Millones, Catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Perú. Como moderador participó el reconocido
antropólogo Jacques Galinier, del Centre National de la Recherche Scientifique, en Francia, quien
abrió la charla con palabras especiales dedicadas
a la antropología y a la base fundamental de esta:
la comparación. También alentó al público joven
a aprovechar la reunión de los dos expositores,
“dos personalidades, dos catedráticos, dos amigos que representan esos dos grandes polos de la
civilización de las Américas: Norte y Sur”.
Alfredo López Austin, el primero de los ponentes en hablar, puso sobre la mesa el tema de
partida: la literatura contemporánea basada en la
literatura oral de los pueblos andinos. Comenzó
con una referencia a su libro Los mitos del tlacuache. Habló de las críticas que recibió por el papel
que le dio a la literatura zapoteca, y de una pregunta problemática a la que se enfrentó: ¿cómo
tomar la literatura indígena para reintegrarla a la
literatura en español? Uno de los puntos fuertes
durante todas sus intervenciones fue la distinción
epistemológica entre la antropología y la literatura: el tratamiento distinto que cada una de estas
211
Q
uaderni
disciplinas da a sus datos, sus fuentes y referencias, y cómo cada cual se aproxima a la realidad
de manera distinta. A decir de López, la literatura
no se presenta como una fuente confiable para
la ciencia. Sin embargo, en el caso especial de la
poesía, ésta llega a dar luz sobre el mundo indígena, y nos conduce a una comprensión que, en su
libertad, “se escapa al alcance de las perspectivas
científicas”. En otras palabras, frente al discurso
científico, sometido a continuas restricciones, se
encuentra la libertad del discurso poético.
Lo anterior lo ejemplificó con un cuento-mito
sioux: los perros se reúnen en asamblea para decidir cuál de todos debe gobernarlos, y el método
que escogen para hacer la selección es olfatearse
las colas. Por otro lado, en la literatura oral de
los nahuas Veracruz se cuenta lo siguiente: una
asamblea de perros decide que para llevar un
mensaje a Tláloc es necesario que el mensajero se
lo guarde en el recto. Así lo hacen pero el mensaje
nunca llega, y es por eso que los perros se huelen:
están buscando al mensajero. El ejemplo más claro de que la literatura no es una fuente confiable
de datos antropológicos, lo dio con una anécdota
personal en la que se carteó con Eduardo Galeano. La conclusión fue tajante: “es algo que no se
puede consignar en un trabajo científico”.
El turno de hablar pasó a Luis Millones, que
prosiguió con el tema en la mesa: los conflictos
en las relaciones de la literatura y la antropología.
Presentó el caso emblemático de tales conflictos
personalizados en la figura de José María Arguedas, destacado autor latinoamericano del siglo
XX. Millones narró al público cómo conoció
a Arguedas durante un congreso, en el que este
había tenido una participación literaria contrastante con el tenor teórico del evento. Luego de
esto enfatizó: la oposición entre la literatura y la
antropología, entre el trabajo poético y el científico, es la libertad de uno y las restricciones del
otro.
López Austin tomó la palabra nuevamente y
discurrió sobre personalidades como Andrés Henestrosa, Miguel Ángel Asturias y Ricardo Pozas
212
Arciniega. Este último como caso contrario de
los anteriores. Arciniega escribió una etnografía
con importantes datos científicos, sin embargo,
fue tomada por los lectores como una novela sin
contemplar su valor científico. Sobre Henestrosa
apuntó que en su literatura interpreta los mitos
zapotecas en primer momento y al momento de
traducirlos al español les añade sus propias palabras. A pesar de esto, las raíces del mito indígena
se encuentran siempre presentes. Otra pregunta
quedó abierta sobre la mesa: ¿cómo tomar las
lecturas literarias que no proporcionan datos
fiables a la antropología?
Finalmente, los dos catedráticos cruzaron palabras sobre Arguedas y Juan Rulfo, enfatizando
el tratamiento que cada uno daba a la información que recibía del mundo y qué hacía con ella.
Palabras importantes de López Austin fueron
las siguientes: “La antropología no es solo traducción de palabras, sino una traducción más
allá de la lengua, de un pensamiento distinto,
no con el fin de interpretarlo, sino de adaptarlo
a otro público”. El etnólogo es un traductor, dice
Austin, que lleva su conocimiento a un lenguaje
productor de emociones dirigido a un público no
indígena. Además, resalta, es una ilusión el tratar
de penetrar el pensamiento indígena para trasladarlo tal cual a otro público.
La conversación concluyó con varias preguntas por parte de los asistentes y una ola de aplausos para los ponentes. Posteriormente tanto el
público como los expositores se trasladaron a las
instalaciones de la Escuela Nacional de Estudios
Superiores (ENES) dentro del Campus UNAM,
para dar pie a la primera mesa de trabajo, de la
que escribimos a continuación.
Durante la primera mesa, titulada Creación
y Destrucción, presentaron sus ponencias Élodie Dupey García e Ignacio Silva, de la UNAM, y
Gloría Cáceres Centeno de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
Por mencionar el contenido de una de las ponencias de la mesa, tomemos la de Dupey García, titulada Vientos de creación, vientos de destrucción:
antropologia e storia
el rol de los dioses del aire en las mitologías prehispánicas. Temas centrales de su exposición fueron los aspectos que adoptaba el viento y el lugar
de este en las cosmovisiones nahuas de la época
prehispánica.
En primer lugar el viento es un fenómeno atmosférico importante que tiende a parecer activo,
ya que genera el movimiento de nubes y cuerpos
de agua. Es el agente dinámico principal de los
sistemas meteorológicos y su importancia se
refleja históricamente en las cosmovisiones de las
sociedades humanas. Élodie partió de una cita de
López Austin sobre el concepto de cosmovisión:
“Es el sistema mediante el cual una entidad social
en un tiempo histórico determinado aprende y se
explica los mecanismos de su entorno y del universo, para luego actuar en forma específica en el
mundo”. De este modo se entiende que el viento
fue parte de la codificación de la naturaleza que
constituye una de las facetas de las cosmovisiones mesoamericanas en particular. Fue también
personificado en la cultura nahua como el dios
Quetzalcóatl: “El viento, la guía, el que varía el camino para los tlaloque, para los dueños del agua,
para los que traían la lluvia”. Así, el viento era una
figura divina, poderosa y antropomorfa.
Quetzalcóatl Ehécatl, según los documentos
coloniales, tuvo un rol enfático y activo en los mitos de creación. Estuvieron a su cargo las génesis
mayores del cielo, la tierra, el fuego y el maíz, y la
humanidad, entre otras. Además propició la fertilidad femenina, separó el cielo de la tierra, generó
el ciclo solar con su soplo divino, y promovió el
culto a los dioses a través de la música. El influjo
de la mitología nahua sobre la zona mesoamericana se percibe en la deidad mixteca Nueve Viento y en los dioses Bacabes mayas. Estas entidades
míticas comparten rasgos característicos creadores: tienen la tarea de garantizar la estabilidad
del cosmos, de sostener el cielo, y de propiciar
las lluvias; al mismo tiempo son responsables de
los cataclismos que periódicamente conducen el
mundo a su destrucción. Resulta entonces que,
en las cosmovisiones mesoamericanas, a las mi-
/ 2 – comicità e politica
smas deidades a las que se les atribuía el génesis del universo, se las acusaba también de haber
causado la destrucción del mismo.
“Los dioses del aire mesoamericano eran
concebidos como agentes que regían la marcha
del cosmos. Más allá de su rol en la sucesión de
las eras cósmicas, los dioses del aire desempeñaban un importante papel en el ciclo anual que veía
la alternancia en las temporadas de lluvias y secas”. Además de las lluvias para los cultivos se les
atribuían las sequías, el granizo y las tormentas.
Finalmente, la investigación de Dupey invita a
concebir el fenómeno del viento en la cosmogonía prehispánica como “el dinamizador del cosmos. Un papel que coincide con el dinamismo
que en la naturaleza el viento confiere a los sistemas meteorológicos”.
Durante ese primer día se presentaron
otras dos mesas en las que participaron alrededor de diez ponentes más y una conferencia
magistral impartida por Jacques Galinier. La
jornada concluyó con un concierto de música
tradicional purépecha y la degustación de comida típica mexicana. A continuación escribimos un poco sobre lo sucedido el segundo día
del Congreso.
En la segunda conferencia magistral, ocurrida por la mañana del segundo día del Congreso, se sentaron a la mesa Luis Millones
como moderador y como ponente Oswaldo
Chinchilla Mazariegos del Departament of Anthropology de la Universidad de Yale, EE.UU. El
título de su conferencia fue Metáforas sexuales
en el Popol Vuh. Chinchilla presentó un tema
interesante de una forma clarificadora basándose en un análisis comparativo del Popol Vuh,
documento de la literatura maya del siglo XVI,
con varios relatos míticos de la región mesoamericana.
El Popol Vuh, como muchas otras obras del
periodo colonial mesoamericano, fue escrito, en
alfabeto latino, con denotados esfuerzos para
legitimar la jerarquía política de ciertos linajes
indígenas. Además, sus autores también se esfor-
213
Q
uaderni
zaron en registrar narraciones pertenecientes a
la antigua tradición precolombina, aunque finalmente el texto fue filtrado por los frailes dominicos de la región. Tras la pérdida del documento
original, se cuenta actualmente como documento
de origen la copia y traducción del siglo XVIII realizada por Fray Francisco Jiménez.
Durante poco más de cincuenta minutos,
el arqueólogo guatemalteco, leyó, citó y explicó
para el público gran cantidad de ejemplos en
diversos pasajes de la travesía de los gemelos,
Hunahpú e Ixbalanqué, que habrían de convertirse en el Sol y la Luna. A modo de introducción a su charla, Chinchilla hizo mención
del libro favorito de López Austin, Los mitos
del tlacuache, ya que, a decir suyo, en este libro
se describen los planteamientos nodales de la
trama narrativa de los mitos mesoamericanos
en particular, y de las mitologías mundiales
en general: transgresión, muerte, descuartizamientos, fornicios e incestos. Todos estos actos
conforman una conducta antisocial que finalmente contribuye al establecimiento del orden
cosmogónico.
Estos aspectos de la vida sexual no se manifiestan directamente en el Popol Vuh, de hecho
“hay pocos contactos entre hombres y mujeres y
no hay encuentros sexuales explícitos”; sin embargo, están presentes a través alusiones eróticas sutiles expresadas en metáforas compuestas
con frases sencillas llenas de dobles sentidos. La
afirmación de Chinchilla es que “muchas de las
hazañas de los gemelos implican agresión sexual
con significados profundos para el entendimiento de la cosmogénesis Quiché”.
Resultado del análisis de Oswaldo Chinchilla,
salta la vista el papel de la sexualidad femenina: se
presenta en el documento con tonos oscuros, relacionada con el poder y como fuente de constantes riesgos para el hombre. Uno de los ejemplos
más ilustrativos que ofreció fue el del enfrentamiento de los gemelos contra el monstruo Zipacná, anotado mucho antes por Dennis Tedlock en
su traducción del Popol Vuh. El relato trata del
214
“forzudo que buscaba cangrejos durante el día y
por las noches movía las montañas a cuestas. Para
vencerlo los héroes confeccionaron un cangrejo
falso, lo colocaron al fondo de una barranca y lo
mostraron al goloso Zipacná”.
Según Andrés Xiloj, un especialista ritual
maya y colaborador de Tedlock, el cangrejo era
una alusión a los órganos sexuales femeninos.
Esto lo reafirmó Oswaldo al comparar la metáfora
del Popol Vuh con la de una versión actual del
mito en el pueblo de Cubulco, Guatemala. En
esta versión el monstruo Zipac es derrotado por
tres jóvenes mujeres que aceptan ser sus esposas
a cambio de que él les alcance un cangrejo debajo
de una gran roca. De tal manera lo enamoran y lo
engañan que le amarran los pies al monstruo bajo
pretexto de ayudarlo a salir de la barranca en que
debe entrar. Así, señaló Chinchilla, se emparejan
el apetito voraz de Zipac y su caída en la tentación
sexual.
Otro de los temas centrales en la exposición
de Oswaldo fue la transposición entre lo moral,
lo alimenticio y lo genital, tan común en Mesoamérica y el mundo: las relaciones entre el apetito sexual y el alimenticio, en especial el que a las
frutas se refiere, son expresadas metafóricamente en varios relatos míticos. Las comparaciones prosiguieron con mitos de la región nahua
y quiché, y con ellas Chinchilla dilucidó más
casos de violación, incesto, castración e incluso
el mito de la vagina dentada, presentes todos en
el Popol Vuh.
No es posible dar aquí una reseña completa
de cada ponencia del Congreso, así que sirvan
las anteriores como ejemplo de las bien logradas exposiciones que investigadores e investigadoras presentaron a lo largo de cuatro días.
Casi para concluir, y solo como mínimo resumen, mencionamos algunos otros de los temas
expuestos.
En la primera conferencia magistral Jacques
Galinier habló de las visiones sobre la creación
del mundo y de las nociones de centro y periferia
en la mitología otomí. En el tercer conversatorio
antropologia e storia
Martin Lienhard y Miguel Pastrana dialogaron
sobre la intrínseca relación entre la historia y el
mito. En la tercera conferencia magistral Patrick
Johansson expuso cómo las marcas lingüísticas
de ciertos códices prehispánicos develan las fases
del mito del nacimiento de Huitzilopochtli, y de
cómo estas se reflejan en la arquitectura mexica.
Los demás temas abordados en las mesas de
trabajo fueron desde los mitos y rituales en la
literatura andina, hasta la mitología prehispánica subsistente en el arte y la literatura de autor,
pasando por los estudios crítico-filosóficos y el
análisis de las figuras animales, las femeninas y
la importancia del paisaje en las construcciones
míticas actuales. También se presentaron los
proyectos académicos del Laboratorio Nacional
de Materiales Orales (LANMO), y de la Revista
de Literaturas Populares, ambos a cargo de profesores de la ENES Morelia. Engalanado cada
noche con presentaciones teatrales, proyecciones de documentales o conciertos, el V Congreso Internacional de Mitos Prehispánicos en
la Literatura Latinoamericana concluyó con
la inauguración, en el Centro Cultural UNAM
Morelia, de una exposición pictórica con el tema
de los nahuales.
Esta edición del Congreso fue posible gracias
al arduo esfuerzo del Comité Organizador en el
que participaron especialmente Berenice Granados Vázquez, Santiago Cortés Hernández, Sue
Meneses Eternod, Cecilia López Ridaura, Félix
Lerma Rodríguez y Mercedes Martínez González, todos ellos de la ENES Morelia, UNAM; gracias también al especial apoyo de los asistentes y
becarios del LANMO. Otras instituciones participantes fueron la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán, UNAM; el Instituto de Investigaciones
Filológicas, UNAM; el Instituto Nacional de Antropología e Historia; las Facultades de Historia y
de Filosofía de la UMSNH; la Universidad Indígena Intercultural de Michoacán y la Universidad
Autónoma de Querétaro.
Por último, cabe añadir que la próxima sesión
del Congreso Internacional de Mitos Prehispán-
/ 2 – comicità e politica
icos en la Literatura Latinoamericana se celebrará
en Roma, Italia, en fechas aún por decidir.
Quetzal Mata Trejo
Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Estudios Superiores,
Unidad Morelia
Presentazione del Pulcinella di D. Scafoglio e
L.M. Lombardi Satriani
Il filosofo Aldo Masullo ha presentato in Napoli, nell’atelier dello scultore Lello Esposito, che
è anche l’elegante Museo dei suoi Pulcinelli, la
seconda edizione dell’opera Pulcinella. Il mito e la
storia di Scafoglio e Satriani, già pubblicata da Leonardo Mondadori nel 1992. La nuova edizione,
fedele alla prima, voluta dall’editore Guida, presenta una introduzione di D. Scafoglio, che rende
ragone del significato dell’opera alla luce della proposta di una antropologia del comico che si avvale
degli strumenti delle scienze sociali oltre che della
storia. Masullo ha illustrato i fondamenti teorici
e metodologici del volume, concludendo con la
lettura di un sua prosa filosofica, dedicata alla maschera napoletana. La presentazione è avvenuta
all’interno della prima manifestazione pubblica a
favore della candidatura della maschera di Pulcinella alla lista UNESCO dei beni immateriali.
Presentazione degli Atti del Convegno sull’eroe
popolare
Nel 2008 l’Università di Salerno (Laboratorio
antropologico DISUFF), in collaborazione con
“La rete – Associazione per l’unificazione dei saperi antropologici, letterari e psicologici” ha organizzato nel Maschio angioino di Napoli il convegno L’eroe comico nell’area euromediterranea. Gli
Atti del convegno, recentemente pubblicati dalla
Libreriauniversitaria in una collana scientifica
dell’Università di Salerno, sono stati presentati da
Pietro Clemente e Vincenzo Padiglione nel Convento di S. Domenico, in occasione della seconda
manifestazione per la candidatura di Pulcinella
alla lista dei beni immateriali dell’UNESCO.
215
Revista de ciencias sociales
y humanidades
Inflexiones, órgano de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales
(UDIR), nace con el propósito de ofrecer a humanistas y científicos sociales una plataforma de
diálogo y debate multidisciplinario sobre el ser humano y su sociedad, la cultura y su historia, desde
perspectivas en que confluyan la reflexión teórica
y el trabajo empírico. De publicación semestral,
la revista busca convertirse en un foro estratégico
para poner a prueba los conceptos rectores de las
respectivas disciplinas y difundir los resultados de
sus investigaciones. Se trataría, en conformidad
con la metáfora que le presta nombre, de favorecer y acoger aquellos ensayos que constituyan un
punto de cambio o que den cuenta del momento
en que una trayectoria toma otra dirección. Dejar
constancia de la pluralidad de enfoques, irreducibles a una matriz única, se encuentra, por lo tanto,
entre sus objetivos principales.
216
Cómo se construyen representaciones que
convergen en la emergencia de imaginarios sociales, horizontes en que se inscriben las ideas
en torno a la identidad, constituye una de las
preguntas que orientan estas páginas. “Representaciones” concentra, en ese sentido, tanto los
sistemas de percepción y códigos compartidos
que articulan nuestra vida, como aquellas estrategias que permiten traducir la realidad vivida
en formas de experiencia, sean éstas de índole
política, intelectual, social o cultural. La imagen
del horizonte evoca igualmente un paisaje sonoro: pensamos las inflexiones no sólo como puntos
en que las curvaturas cambian de dirección, sino
también como instantes en que las voces varían.
La revista se propone abrir así una serie de ventanas para asomarse, desde distintos ángulos, a las
proyecciones y las resonancias que, al representarnos, nos construyen.