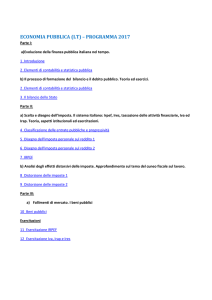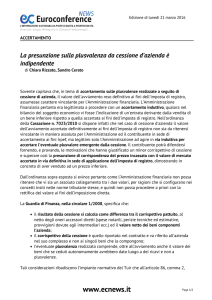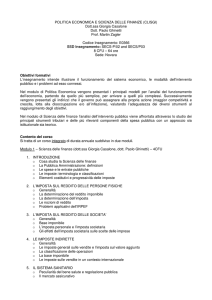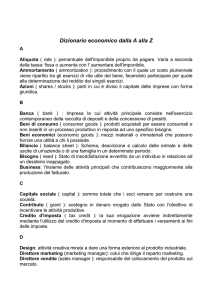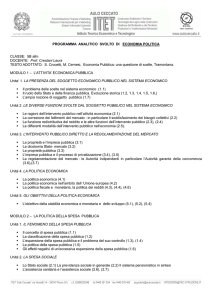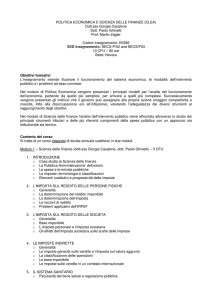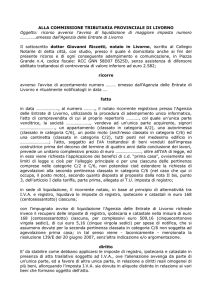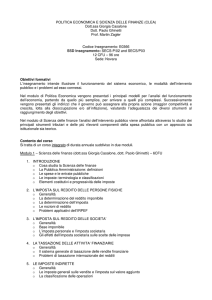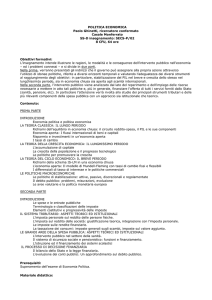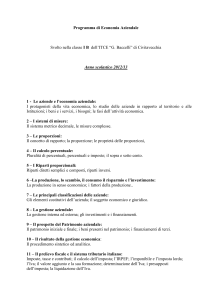7134
APPROFONDIMENTO
Lutilizzo del valore venale per
laccertamento delle imposte dirette
di Giampiero Guarnerio
La base imponibile per le cessioni dazienda o
di immobili ai fini dellimposta di registro è il
valore venale del bene trasferito. Ai fini imposte dirette rileva invece il corrispettivo percepito. In tale secondo contesto, il valore normale assume rilievo solo in particolari situazioni, generalmente laddove le parti contraenti siano correlate.
Partendo dalla constatazione empirica che il
valore normale dei beni è di difficile determinazione certa, lautore si domanda quanto sia
plausibile applicare il criterio del valore del
bene trasferito per accertare in via presuntiva
il reddito imponibile in presenza di operatori
non legati da rapporti di controllo.
La domanda è lecita, considerando che le linee guida dellOCSE in tema di prezzi di trasferimento per operazioni che intercorrono
tra parti correlate assumono come metro di
paragone prediletto proprio i prezzi pattuiti
tra parti non correlate, e non il valore dei beni trasferiti.
1. Premessa
Lutilizzabilità del valore venale definitivamente
accertato ovvero definito in contraddittorio, ai
fini dellimposta di registro, in occasione di trasferimenti di beni immobili o di aziende, anche
per laccertamento della plusvalenza imponibile
ai fini dellaccertamento della plusvalenza imponibile, ai fini delle imposte dirette, è stata oggetto di numerose sentenze di legittimità e di
merito di segno opposto.
Una sentenza recente (Cassazione, ord. 9 novembre 2010, n. 227931) si colloca nel solco dellorientamento favorevole alla sua utilizzabilità.
La Corte ha deciso che il valore venale determinato in sede di applicazione di imposta di registro può essere utilizzato quale presunzione
semplice per determinare la plusvalenza tassabile ai fini delle imposte dirette. Contro tale
presunzione la parte ha lonere di fornire la prova contraria.
Questa posizione è condivisa dallorientamento
favorevole della stessa Corte2, il quale, con varie
sfumature, sostanzialmente non sconfessa la circostanza che nellambito delle imposte sui redditi (art. 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
prima, art. 86 del D.P.R. n. 917/1986 ora) la plusvalenza originata dalla cessione a titolo oneroso debba essere determinata sulla base del
corrispettivo percepito, ma sopperisce a tale (limitativa?) previsione attribuendo al valore venale una valenza di praesumptio hominis contro
la quale il venditore deve fornire prova contraria.
La dottrina3 ha già evidenziato le lacune di questa posizione. In effetti, vi sono molti aspetti che
non convincono.
1
In banca dati fisconline. Cfr. A. Borgoglio, Il valore del
registro è valido anche per le imposte dirette, in il fisco
n. 43/2010, fascicolo n. 2, pag. 7051.
2
Ex multis: sentt. n. 16700 dell8 agosto 2005, n. 14581 del
20 novembre 2001, n. 14448 del 6 novembre 2000, tutte in
banca dati fisconline.
3
La norma di comportamento n. 171 dellottobre 2008 della
Associazione Dottori Commercialisti di Milano, in banca dati fisconline, esprimendosi sul caso della cessione
dazienda, nega tale possibilità posto che i principi relativi alla determinazione del valore di unazienda che viene
44/2011
fascicolo 1
7135
Accertamento APPROFONDIMENTO
Il più immediato è il passaggio in cui la Corte,
dopo aver sostenuto la valenza presuntiva del valore venale quale valore presumibilmente veritiero del reale corrispettivo delloperazione, osserva che le parti ben avrebbero potuto regolare in nero il maggior prezzo rispetto a quello
dichiarato nellatto notarile, e non poteva assurgere al valore di presunzione contraria quella insussistente di veridicità delle scritture contabili.
Ebbene, come già sostenuto da più parti, ed anzi
dalla stessa Corte di Cassazione, leventualità
che fosse convenuto un pagamento in nero è
senzaltro una possibilità, ma non un fatto certo,
e, per quanto si dirà, nemmeno presumibile. Invertire lonere probatorio in virtù della constatazione che il fatto ignoto (il pagamento in nero)
sia solo una possibile conseguenza del fatto noto (valore normale), in mancanza di altri elementi che corroborino la circostanza, non convince. Tanto più quando linversione dellonere
della prova richiederebbe al contribuente una
vera e propria probatio diabolica, quale è la
prova negativa. Detto semplicemente, come può
un contribuente che ha veramente incassato 100
dimostrare che ha incassato solo 100? E con
quale fondamento non si può riconoscere alle
scritture contabili regolarmente tenute una presunzione di correttezza di forza quantomeno
analoga a quella che si vuol riconoscere allequazione valore venale = corrispettivo, posto che il
codice civile assegna loro una indubbia valenza
probatoria4?
trasferita a titolo oneroso sono diversi a seconda dellimposta che si applica [
]: il valore di mercato in un caso
ed il prezzo convenuto dalle parti nellaltro.
Il ragionamento dellAssociazione era corroborato dalla novella normativa (successivamente abrogata) recata dal D.L.
4 luglio 2006, n. 223, che aveva introdotto espressamente la
possibilità di utilizzare il valore normale degli immobili trasferiti come prova riconosciuta del corrispettivo percepito
ai fini delle imposte dirette. Proprio la necessità di introdurre una previsione legislativa apposita era indice dellassenza di una presunzione legale in tal senso.
Altri autori (T. Carroli, Plusvalenze da cessione dazienda
e rilevanza del valore concordato ai fini dellimposta di
registro, in Rassegna Tributaria n. 4/2010, pag. 1143 a
commento della sent. n. 202/2010, A. Buscema, Art. 54 del
Tuir. Il valore venale può costituire presunzione?, in il fisco n. 9/2001, fascicolo n. 1, pag. 3613 a commento della
sent. n. 14448/2000 sopra citata) condividono tale visione,
constatando come i diversi contesti normativi non consentano di introdurre al caso della cessione a titolo oneroso di immobili o di aziende la valutazione a valore normale dei beni trasferiti che invece si applica nel contesto
dellimposta di registro.
4
Art. 2709 del codice civile. I libri e le scritture contabili
delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro
limprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può
Esiste anche un orientamento contrario a tale
impostazione, quantitativamente apparentemente inferiore nei giudizi di legittimità5, ma diffuso
nelle corti di merito6. Secondo tale orientamento, invece, non vi è spazio per introdurre nellambito delle imposte dirette il valore venale,
posto che la norma non ne fa cenno.
Quel che colpisce particolarmente in questa vicenda (come ahimè spesso accade) è che queste
situazioni non sono affatto episodi sporadici, né
di scarso valore, ma quotidiani e piuttosto rilevanti. E per di più vertono su principi e regole
tributarie sostanzialmente immutate da decenni.
Ciò nonostante la questione non sembra essere
definitivamente chiarita dalla giurisprudenza di
legittimità, che anzi sembra schierata prevalentemente su posizioni non condivise dalla dottrina, e, tra laltro, in modo poco sistematico.
Una linea interpretativa ragionevole, a parere di
chi scrive, dovrebbe tener conto non solo della
corretta esegesi delle norme interessate di diritto
interno, ma anche dei principi e delle esperienze
che si possono osservare in un contesto internazionale, e, in definitiva, della ragionevolezza delle regole stesse (o delle loro interpretazioni) e
con losservazione di essenziali quanto naturali
meccanismi microeconomici cui sono uniformati i comportamenti economici delle persone.
2. Esiste un valore venale certo?
Nelle norme di legge si possono riscontrare varie
modalità per definire legislativamente il concetto di valore7.
scinderne il contenuto.
Art. 2710 del codice civile. I libri bollati e vidimati nelle
forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono
fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti allesercizio dimpresa.
5
Cass., n. 7689 del 16 maggio 2003, in banca dati fisconline e n. 16700 dell8 agosto 2005.
6
Tra le tante, Comm. trib. prov. Milano, sent. n. 202 del 17
maggio 2010, in il fisco n. 35/2010, fascicolo n. 1, pag.
5709.
7
Per limposta di registro, cfr. art. 51 del D.P.R. n. 131/1986,
dove semplicemente si parla di valore venale in comune
commercio. Per le imposte sui redditi cfr. art. 9, commi 3 e
4, del D.P.R. n. 917/1986, ove si fa generale riferimento al
prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i
servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione,
in un certo tempo e luogo, e per alcuni beni particolari (ad
esempio, azioni) si dettano regole dettagliate (le medie dei
mercati borsistici). Ulteriori definizioni possono essere riscontrate nei principi contabili nazionali ed in quelli internazionali (nozione di fair value).
44/2011
fascicolo 1
7136
APPROFONDIMENTO Accertamento
Tutte le definizioni hanno comunque un tratto
comune: il valore non è un dato intrinsecamente
collegato alle caratteristiche del bene, ma è il risultato del punto di incontro tra domanda e
offerta in un mercato libero ove le parti hanno
tutte le informazioni rilevanti.
Quale prima osservazione va constatato come
nella realtà non vi sia alcuna garanzia che esista
nel mercato una completa e diffusa informazione
tra gli operatori. Anzi, si potrebbe tranquillamente ipotizzare che la simmetria informativa sia leccezione, e non la regola. Diversamente non si
spiegherebbe perché chi si accinge ad effettuare
unoperazione di vendita ad esempio la vendita
di un immobile non si limitasse ad offrire al
mercato il prezzo giusto, ma invece propone un
prezzo alto, sobbarcandosi lonere di defatiganti
quanto inutili trattative. Né si spiegherebbe perché chi si accinge ad acquistare un immobile dovrebbe offrire sistematicamente al venditore un
prezzo più basso di quello proposto.
Evidentemente, entrambe le parti temono che
la controparte non abbia dato tutte le informazioni complete (vizi del bene dal punto di vista
del compratore) ovvero di non essere totalmente
informate sulle condizioni reali del mercato
(possibilità che il valore di mercato sia più alto
di quello immaginato, dal punto di vista del venditore). Ciascuno avrà avuto la propria esperienza sul mercato immobiliare, e sfidiamo chiunque a confermare di aver mai accettato la prima
proposta della controparte in tali occasioni.
E, a ben vedere, non esiste nemmeno una norma
di legge che imponga alle parti di convenire
prezzi di mercato.
Quid iuris perciò se le parti pattuissero un prezzo diverso da quello di mercato? Niente, non vi è
attribuzione di responsabilità a carico della parte che ha concluso loperazione realizzando un
vantaggio superiore a quello che il mercato le
avrebbe garantito. La legge fissa soltanto obblighi di correttezza e di buona fede nel comportamento, ma non un obbligo di risultato.
Ben può essere, quindi, che il risultato di una
serrata trattativa commerciale sia la definizione
di un prezzo diverso da quello che il mercato
avrebbe altrimenti stabilito.
Daltra parte, se esistesse un valore venale preciso, per quale motivo le parti dovrebbero perdere
tempo in inutili e defatiganti trattative? Perché
non fissare subito il prezzo giusto? Evidentemente, il mercato non è così fluido. Lincrocio di
mille variabili fa sì che ogni trattativa di un certo valore si chiuda a prezzi probabilmente irripetibili.
Visto come funziona il mercato, già laffermazione contenuta nella sent. n. 14448/2000 della Cassazione, Sezione tributaria, giusta la quale non
si può ipotizzare (sic!) che un soggetto svenda a
prezzi di assoluto sfavore (rispetto al valore normale) per ragioni diverse da quelle economiche,
non sembra teoricamente corretta: ci possono
essere mille ragioni economiche che hanno portato ad accettare un prezzo più basso del valore
normale. Magari quel soggetto era semplicemente non perfettamente informato, oppure era in
difficoltà, o aveva una strategia di uscita da quel
mercato. Sul tema, le linee guida pubblicate
dallOCSE per le imprese multinazionali e per le
autorità fiscali in tema di prezzi di trasferimento aggiornate nel luglio 2010 offrono un
ampio ventaglio di ragioni e di variabili che influiscono sul prezzo di libera concorrenza
tutte di matrice economica nellambito di una
transazione commerciale. A questo sono dedicati in particolare il capitolo 1 (sul concetto del
principio di libera concorrenza o arms lengh
principle) ed il capitolo 3 (sul concetto di analisi di comparabilità, necessario per assicurarsi
che la transazione utilizzata quale termine di paragone per quella interessata sia effettivamente
comparabile). In particolare, le linee guida segnalano 5 fattori determinanti di natura economica che legittimamente influiscono sulla
determinazione del prezzo, dove le caratteristiche intrinseche del bene sono solo una
delle tante. Le altre sono: le funzioni svolte
dalle parti coinvolte, i termini contrattuali,
le circostanze economiche in cui si svolgono
le operazioni e le strategie aziendali.
E in effetti, quanto possa variare il valore dello
stesso bene anche in periodi di tempo limitati
per effetto di molteplici variabili ad esso non intrinsecamente imputabili, è facile constatarlo.
Si prenda ad esempio lindice del mercato borsistico del New York Stock Exchange. Tale indice
racchiude indirettamente landamento medio ponderato del valore di tutte le società incluse nel listino. Trattandosi della maggiore borsa mondiale
non dovrebbero esservi dubbi sulla sua effettiva
rappresentatività in termini di valore normale
delle aziende ivi listate.
Ebbene, nellarco di due anni, lindice ha oscillato
da un valore minimo di circa 5.700 (giugno 2009)
al massimo di circa 8700 (aprile 2010). Ciò significa che, nellarco temporale osservato, il valore
medio delle società quotate è oscillato del
53% rispetto al minimo di mercato.
Ebbene, posto che ciascuno di quei valori è nor
44/2011
fascicolo 1
7137
Accertamento APPROFONDIMENTO
male per definizione8, vogliamo quindi sostenere
che tutte le società quotate in quella borsa hanno
visto il loro valore effettivo intrinseco variare
mediamente di così tanto?
Esaminando i grafici delle singole società ivi
quotate si riscontrano oscillazioni decisamente
superiori. Nello stesso periodo, il titolo Fiat è
oscillato da un minimo di 2,83 a un massimo di 8,18, con una oscillazione pari al 189%.
Qual è dunque il valore normale della Fiat?
Che senso avrebbero quelle valutazioni che tengono conto, ad esempio, soltanto dei risultati di
bilancio degli anni pregressi? Se avessero fondatezza, non dovremmo osservare simili oscillazioni dei titoli in corso danno.
Tra laltro, una delle caratteristiche tipiche del
mercato borsistico è proprio quella della garanzia della circolazione uniforme delle informazioni rilevanti per evitare o limitare al
massimo le asimmetrie informative. Chi opera
in quel mercato è per definizione sufficientemente informato, tanto che le principali preoccupazioni degli enti vigilanti vertono proprio
sulla trasparenza informativa (bilanci corretti,
comunicazioni ufficiali tempestive, impossibilità
per gli operatori che dispongono di informazioni
privilegiate confidenziali di operare sul mercato,
sanzioni penali anche pesanti [aggiotaggio-false
comunicazioni sociali, eccetera] a tutela di tali
disposizioni).
Se in quel contesto si osservano oscillazioni di
valore così rilevanti, cè veramente da interrogarsi su come sia possibile assegnare ad una
qualsiasi azienda, ad un qualsiasi immobile (ma
oseremmo dire, a qualsiasi bene) che non abbia
un mercato altrettanto diffuso come quello delle
azioni quotate alla borsa di New York un valore
obiettivamente determinabile con un grado di
certezza tale da poter concludere che soltanto
un evasore (o uno sprovveduto) se ne discosterebbe.
Dopo queste osservazioni, riteniamo che, quale
che sia il valore venale attribuito ad un bene ai
fini delle imposte indirette, magari unico e
soggetto ad una sola operazione di compravendita in quellanno, presumere che questo valore
venale possa costituire un fondamento certo
(cioè una presunzione grave, precisa e concor8
Cfr. art. 9, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, laddove viene confermato che per i titoli quotati nei
mercati regolamentati il valore normale è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nellultimo mese.
dante) per equipararlo ad un corrispettivo percepito dal venditore salvo (diabolica) prova
contraria, non sia proprio sostenibile.
Sin qui abbiamo semplicemente fornito informazioni empiriche. Tuttavia gli andamenti così oscillanti delle quotazioni di borsa e, si ribadisce, gli altrettanto oscillanti andamenti dei valori di tutti i beni che non hanno un mercato
borsistico hanno precise spiegazioni teoriche,
come ben sanno gli studenti di un corso base di
microeconomia.
In sintesi, il prezzo è il risultato di una contrattazione durante la quale le parti valutano la rispettiva (stimata) utilità del bene. Utilità che varia in modo significativo in relazione alle circostanze.
Ad esempio, il prezzo che un normale consumatore sarebbe disposto a pagare per un panino in
una normale giornata lavorativa potrebbe essere
di 2 euro. Ma questo prezzo potrebbe essere diverso se, anziché un normale consumatore, si
trattasse di un consumatore benestante (3 euro?), o di una persona ricca (5 euro?).
Dallaltra parte cè un esercente che, volendo assumere un comportamento economico razionale
(che poi è quello sotteso nella assunzione che il
corrispettivo percepito non può essere diverso
dal valore venale), non può semplicemente
proporre il prezzo di mercato più basso (2 euro,
ammesso che sappia che il consumatore normale sarebbe disposto a pagare 2 euro), ma dovrebbe tendere a lucrare di più sul consumatore più
ricco.
Razionalmente, il venditore dovrebbe evitare di
esporre il prezzo e capire, volta per volta, quanto
sia disposto a spendere linterlocutore e chiudere la trattativa al più alto prezzo possibile.
Si avrebbero così tanti valori normali quanti
sono i panini venduti.
A tutela del consumatore, la legge impone che il
venditore faccia la prima mossa esponendo il
prezzo al pubblico.
Con questa norma che pilota la trattativa e,
in questo senso, altera il mercato il venditore
sarà costretto a proporre un prezzo che ottimizzi prospetticamente il suo risultato economico
in ragione delle probabili quantità vendute (e
delle conseguenti economie di scala) rinunciando potenzialmente ad un profitto superiore se
invece potesse avviare trattative singole. Il profitto rinunciato viene definito la rendita del
consumatore, vale a dire quel risparmio che il
consumatore realizza rispetto al prezzo che sarebbe stato disposto a pagare per il panino se il
44/2011
fascicolo 1
7138
APPROFONDIMENTO Accertamento
venditore non fosse stato costretto ad esporre il
prezzo.
Seguendo lesempio, ipotizzando che il venditore
abbia fissato un prezzo di 1,5 euro, il consumatore normale realizzerebbe una rendita di 0,5
euro, mentre il consumatore ricco realizzerebbe
una rendita di 3,5 euro.
Tutto ciò spiega anche la prassi per cui per fare un altro esempio i prezzi di listino delle
automobili sono sistematicamente più alti dei
prezzi veri.
Posto che la legge impone al venditore di fare la
prima mossa, questi, nellottica della massimizzazione del proprio profitto e quindi della minimizzazione della rendita del consumatore, propone
un prezzo elevato, ma non tale da scoraggiare
in partenza il compratore. Il gioco delle parti porta il compratore a chiedere lo sconto, e a quel
punto il venditore procederà per tentativi successivi fintantoché otterrà il consenso del consumatore a condizioni più favorevoli possibili.
Rientrando in tema, quanto sopra spiega perché
la conclusione del prezzo di una compravendita
complessa come quella di unazienda o di un immobile è ben difficilmente riconducibile ad un
valore normale, tali e tante sono le variabili
che possono condizionarne il valore, a partire
dalle asimmetrie informative alle utilità prospettiche, ma anche e molto banalmente da chi
fa la prima mossa nel proporre il prezzo.
nelle sue diverse articolazioni normative soltanto in alcune limitate circostanze, e mai nellambito delle operazioni che intervengono
tra parti non correlate. Questo corretto atteggiamento si spiega proprio perché è perfettamente conscio (forse in modo intuitivo) del fatto
che il prezzo concordato tra parti non correlate
è per definizione un valore normale. O, se si
preferisce, prende atto del fatto che è del tutto
inutile, in una transazione commerciale avvenuta tra parti non correlate, porre una verifica se il
prezzo definito sia o meno accettabile dal punto
di vista fiscale, posto che vi sono tali e tante variabili, oggettive e soggettive, che legittimamente
possono portare le parti a convenire un prezzo
più o meno alto, senza che ciò costituisca motivo di preoccupazione fiscale, tanto più nelle operazioni tra imprenditori, ove il ricavo tassabile delluno si risolve in un costo deducibile per laltro.
In parole semplici: che male cè se un panino
viene ceduto ad 1,5 euro o a 3 euro, posto che in
quella trattativa le parti hanno concordato un
valore piuttosto che un altro? E come potrei io,
Fisco, presumere in qualche modo che quel
prezzo sia genuino o meno?
È chiaro che, se si ritiene di non vivere in una
economia dirigista nella quale i prezzi delle operazioni sono pianificati centralmente, simili presunzioni non possono trovare spazio.
In definitiva, il valore venale o normale di un bene non è mai un dato certo né obiettivo, ma, tuttalpiù un valore stimato ed indicativo di
quanto forse il mercato apprezzerebbe quel bene. Lesperienza dimostra che tale valore necessariamente oscilla tra forchette di valore minimo e massimo (cfr. par. 3.57 delle linee guida
OCSE sopra citate).
Non è quindi un caso che, nellambito del reddito dimpresa, le ipotesi in cui il valore normale
sia concettualmente utilizzato come base imponibile sono soltanto quelle che non vedono coinvolte operazioni con economie terze, o riguardano soltanto aspetti valutativi di bilancio (rimanenze, crediti) o ipotesi di autoconsumo (destinazione di beni o servizi a finalità estranee allesercizio dimpresa).
Se mai fosse ipotizzabile definire per ciascun bene un valore obiettivo, non vi sarebbe più necessità alcuna di defatiganti trattative commerciali
tra gli operatori, e tante funzioni spesso strategiche ed essenziali delle aziende (direzioni commerciali, venditori, agenti, informatori, eccetera)
si renderebbero del tutto inutili.
3. Il valore normale e il reddito
dimpresa
Sebbene non sia mai espressamente spiegato il
motivo nei termini sopra soltanto accennati, il
legislatore nazionale ma anche quello sovranazionale utilizza il concetto di valore normale
E non è un caso che, anche in ambito Iva, lunica ipotesi di confronto col valore normale riguardi le operazioni infragruppo tra soggetti aventi regimi di detraibilità diversa (il progetto di
introdurre la valutazione a valore normale dei
corrispettivi di cessione degli immobili è stato
respinto dalla UE).
4. Rapporto tra valore venale
definito ai fini dellimposta di
registro, il valore normale ed il
corrispettivo percepito
Limposta di registro è unimposta datto. La sua
44/2011
fascicolo 1
7139
Accertamento APPROFONDIMENTO
applicazione si esaurisce sulla transazione effettuata e non comporta altre conseguenze nella sfera patrimoniale dellacquirente o del venditore.
Il legame tra tale imposta e il principio della capacità contributiva esclude in linea di principio
ogni considerazione sulla condizione soggettiva
dei partecipanti alloperazione: essi sono liberi
di effettuare o meno la transazione essendo loro
noto il costo complessivo della stessa. Essendo
liberi di non effettuarla, concludendola ammettono implicitamente di avere la capacità contributiva che la norma ricollega allatto.
In tal senso, unimposta di registro anche alquanto elevata potrebbe porre interrogativi di
opportunità politica o sociale, ma difficilmente
troverebbe ostacolo nel requisito della capacità
contributiva, essendo la sua applicazione una
conseguenza di una scelta volontaria.
È ben vero che alcune operazioni riguardano beni di prima necessità (ad esempio, la casa di prima abitazione), che meritano una certa tutela
costituzionalmente garantita (tutela del risparmio), ma guardando alle operazioni relative a
beni non essenziali, quale certamente è unazienda o una seconda casa, il limite che trova
il legislatore fiscale non è quello della capacità
contributiva quanto quello della razionalità o
della opportunità politica.
Un chiaro esempio è rintracciabile nel carico tributario applicato sui carburanti per autotrazione.
Attualmente, sul prezzo di vendita di circa euro
1,60 al litro, il Fisco pesa circa euro 0,92 tra imposta di fabbricazione, accise ed Iva, pari al 57,5%.
Di certo non si può dire che la benzina sia un bene di lusso, né che chi la acquista abbia una capacità contributiva da nababbo. Eppure un peso così
elevato del Fisco non rappresenta un problema
sotto questo profilo, potendo il contribuente evitarne lonere rinunciando allacquisto.
Ciò considerato, è accettabile che limposta di
registro sia quantificata per legge con un parametro anche forfettario quale può essere il valore normale, che prescinda pure dal prezzo effettivamente pagato dalle parti.
Come ad esempio si verifica nelle compravendite immobiliari con acquirente persona fisica non imprenditore, dove limposta si applica sul valore catastale indipendentemente
dal prezzo pattuito9. Ovvero in tutti i casi in cui
limposta è fissa, indipendentemente dal valore della transazione.
In tali contesti, la determinazione dellimposta a
carico delle parti legata ad un importo teorico,
9
Art. 1, comma 497, della L. n. 266/2005.
eventualmente anche presunto, che sia slegato
dal corrispettivo pattuito quandanche tale valore teorico venga calcolato sulla base di un ipotetico mercato di riferimento come accade applicando il valore normale rientra perfettamente nei meccanismi operativi di tale imposta e
non determina preoccupazione alcuna in termini di capacità contributiva.
Virtualmente, è accettabile che un atto riguardante un immobile che ha un valore teorico di
100, ma che il venditore ha ceduto per 30 perché
costretto da necessità improrogabili (o magari
per cogliere una diversa opportunità più redditizia) sia sottoposto a registro sulla base del valore
di 100, e non di 30. Le parti conoscono il valore del bene e sanno che il costo delloperazione
(che concludono volontariamente) sarà di 30 più
limposta di registro calcolata su 100.
Tutti questi ragionamenti non reggono più quando si entra nellambito delle imposte sui redditi.
In questambito, limposta è commisurata sul
reddito complessivo realizzato dal contribuente.
E tale reddito va determinato in modo ragionevole e non arbitrario.
Nel Testo Unico non cè spazio per le rettifiche di valore in presenza di operazioni tra
parti non correlate.
Ciò si spiega con lesistenza di un contrasto di
interessi tra compratore e venditore (tanto più
quando entrambi sono imprenditori) e con lesigenza di poter provare in giudizio i diritti che
derivano dal contratto.
Levidenza di ciò è tale che come già sopra anticipato anche nel contesto internazionale si
accetta comunemente il fatto che le imposte sui
redditi vanno applicate sui redditi effettivamente conseguiti. Lipotesi di sindacare nel
merito se limprenditore ha avuto un comportamento economicamente virtuoso è generalmente
esclusa dal Testo Unico, e laddove presente, si
tratta di situazioni espressamente previste, assai
limitate, e spiegate da possibili contiguità che
abbiano alterato il conflitto di interessi (si pensi
ad esempio alle norme che hanno interessato la
deducibilità dei compensi degli amministratori
art. 59 del D.P.R. n. 597/1973).
Il Testo Unico oggi non prevede espressamente
la tassabilità delle operazioni con parti non correlate sulla base di valori normali. Quindi lassunto di quelle sentenze che considerano applicabile anche a questi fini i valori determinati o
definiti ai fini delle imposte indirette non trova
fondamento giuridico. Ma neppure troverebbe
fondamento una rettifica fondata su presunzio44/2011
fascicolo 1
7140
APPROFONDIMENTO Accertamento
ni secondo unequazione valore = corrispettivo. La condizione di gravità che rende accettabile una presunzione verte sul grado elevato di
ragionevolezza che allevento noto (il valore)
consegua il valore ignoto (il prezzo). Ed abbiamo sopra dimostrato e constatato come tale legame non esista o sia decisamente flebile, al
punto che la legge stessa non ne prevede lutilizzabilità al di là dei rapporti economici tra parti
correlate.
Si potrebbe però ipotizzare che una simile tassazione sia consentita non già in quanto prevista
dal Testo Unico, quanto perché in sede di verifica o accertamento siano emerse circostanze tali
da lasciar presumere che il prezzo effettivamente conseguito sia pari al valore venale. E ci si
chiede se queste circostanze possano consistere
nella definizione di tale valore ai fini delle imposte indirette.
La risposta non può che essere negativa, per un
duplice ordine di motivi.
Intanto quello letterale: la base imponibile per i
trasferimenti delle aziende è il valore del bene
(art. 43, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131) e non il corrispettivo pattuito. Invece, ai fini
delle imposte sui redditi, la base imponibile è determinata per differenza tra corrispettivi conseguiti e spese sostenute (art. 109 del Tuir).
La differenza tra le due norme è evidente e codificata: il parametro per le imposte sui redditi è il
corrispettivo conseguito indipendentemente
dal valore mentre il parametro per limposta di
registro è il valore del bene indipendentemente
dal corrispettivo. Tali valori ben possono essere
diversi, avendo valenza in ambiti diversi.
Il secondo è quello di ordine procedurale e sistematico.
Posto che la norma di legge è diversa, e che in
particolare limposta di registro reca in sé il
seme dellincertezza (si è visto che non cè nulla
di più incerto del valore normale), è prassi comune che lAgenzia proceda a una revisione al
rialzo dei valori dichiarati dalle parti ai fini dellimposta di registro, slegandosi dal corrispettivo
pattuito (che, per queste transazioni, non è nemmeno il parametro legale). Simile accertamento
non troverebbe spazio sic et simpliciter nel campo delle imposte sui redditi, se non in presenza
di prove che dimostrino che il prezzo conseguito
è stato effettivamente diverso.
Orbene, il contribuente non può validamente difendersi dalla revisione al rialzo del valore ai
fini dellimposta di registro semplicemente dando la prova che quanto conseguito corrisponde
al dichiarato (ovviamente, il parametro non è il
corrispettivo, ma il valore). Né potrebbe darla:
è difficile ipotizzare un suo potere di accertamento che gli consenta di mandare richieste di
informazioni a tutte le banche ove opera lacquirente perché certifichino che non è stato eseguito alcun ulteriore pagamento a suo favore, o
che non sono stati eseguiti prelievi per contanti
nel periodo interessato.
Ben può essere quindi che, pur essendo il prezzo
da contratto quello vero ed anzi secondo lOCSE il prezzo fissato tra parti non correlate è certamente un prezzo vero al fine di eliminare lalea di tale determinazione, limprenditore decida
di definire con lufficio un valore accettabile, ovvero che tale valore venga stabilito dal giudice
sulla base di parametri più o meno accettabili
(raramente, o mai, si vede in tali contesti unanalisi di comparabilità paragonabile a quella richiesta dalla prassi OCSE in materia di prezzi di
trasferimento).
Assumere che tale valore possa essere utilizzato
anche ai fini reddituali significherebbe modificare le norme in materia di redditi dimpresa, introducendo un accertamento di valore generalizzato che ora non cè.
Bene, se la volontà del legislatore fosse quella di
ammettere la rettifica dei ricavi conseguiti sulla
base del valore di mercato delle operazioni effettuate non avrebbe nessuna difficoltà a farlo: basterebbe estendere la portata dellart. 110, comma 7, alle transazioni effettuate anche con parti
non correlate. Se ciò non accade, è perché il legislatore non ritiene opportuno introdurre tale
metodo di valutazione. Le incertezze sopra menzionate, nonché i diversi scopi che hanno le due
imposte, non consentono di utilizzare le rispettive basi imponibili nel contesto dellaltra.
44/2011
fascicolo 1